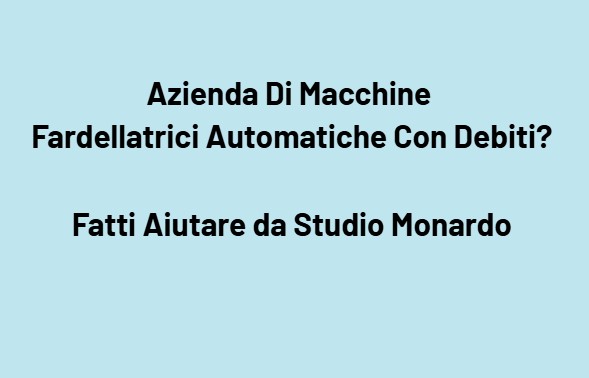Se la tua azienda produce, importa o distribuisce macchine fardellatrici automatiche, sistemi di imballaggio termoretraibile, avvolgitrici, confezionatrici industriali, ricambi e soluzioni per linee di packaging, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire rapidamente per evitare il blocco dell’attività.
Nel settore del packaging automatico, anche un piccolo ritardo può fermare intere linee produttive dei clienti, generare penali, ritardi nelle consegne e perdita di contratti strategici.
Perché le aziende di macchine fardellatrici automatiche accumulano debiti
- costi elevati per componenti elettronici, motori, sensori, PLC, inverter e materiali speciali
- rincari dei semiconduttori e dei componenti importati
- pagamenti lenti da parte di aziende alimentari, farmaceutiche, logistiche e manifatturiere
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzino complesso con ricambi, schede elettroniche e parti su misura
- investimenti continui in R&D, test, collaudi e aggiornamenti software
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di produzione
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera posizione debitoria da un professionista
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi o irrealistici
- richiedere la sospensione immediata di pignoramenti o procedure esecutive
- proteggere fornitori strategici e componenti critici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare, rinegoziare o ridurre i debiti
I rischi se non intervieni rapidamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di elettronica, motori, sensori e ricambi essenziali
- fermo di macchine, linee di collaudo e assemblaggi
- impossibilità di consegnare e assistere i clienti
- perdita di OEM, integratori e industrie committenti
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare subito pignoramenti e azioni esecutive
- ristrutturare o ridurre i debiti con strumenti normativi mirati
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, elettronica, attrezzature e continuità produttiva
- evitare la chiusura e rilanciare la tua azienda
Agisci ora
Molte aziende non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure in corso, ridurre i debiti e salvare realmente la tua attività.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua impresa di macchine fardellatrici automatiche.
Introduzione
Un’azienda che produce macchine fardellatrici automatiche – macchinari industriali per imballare e confezionare prodotti in pacchi o fardelli – può trovarsi in grave difficoltà finanziaria a causa di diversi fattori. Si tratta spesso di imprese manifatturiere ad alta intensità di capitale: richiedono l’acquisto di materiali costosi (acciai speciali, componenti elettronici, motori, sensori) e macchinari utensili avanzati per la produzione. In tempi recenti, aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia, uniti a eventuali calo di ordini o ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, possono erodere la liquidità aziendale. Inoltre, investimenti ingenti (es. sviluppo di un nuovo modello di fardellatrice automatica, automazione robotica della linea produttiva, certificazioni di qualità) spesso sono finanziati con mutui, leasing o linee di credito bancarie; se i ricavi attesi tardano a realizzarsi, le rate del debito diventano insostenibili. Anche la revoca improvvisa di affidamenti bancari (fidi di cassa, castelletto per sconto fatture) a fronte di un peggioramento del rating può precipitare la crisi di liquidità dell’azienda .
Per far fronte alle spese urgenti (stipendi, fornitori) l’imprenditore è talvolta tentato di rinviare i pagamenti fiscali e contributivi (IVA, ritenute su stipendi, contributi INPS), ma ciò comporta cartelle esattoriali con sanzioni e interessi che aggravano ulteriormente l’esposizione . Gli enti pubblici creditori – Agenzia delle Entrate-Riscossione per le imposte, e l’INPS per i contributi – dispongono di poteri esecutivi immediati (ad esempio il fermo amministrativo di macchinari o automezzi, l’iscrizione di ipoteca su immobili aziendali, pignoramenti dei conti) che possono mettere in ginocchio l’attività in breve tempo . Infine, non vanno trascurati possibili errori interni di gestione: un’organizzazione inefficiente dei costi, eccesso di scorte a magazzino immobilizzate, mancanza di controllo di gestione e pianificazione finanziaria possono impedire di accorgersi per tempo degli squilibri economici, ritardando gli interventi correttivi .
Tutti questi fattori, da soli o combinati, possono condurre rapidamente l’impresa in una situazione di crisi d’impresa o addirittura di insolvenza conclamata. Nel linguaggio del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), per crisi si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, mentre l’insolvenza è lo stato in cui l’azienda non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (ad esempio non paga fornitori e rate nei termini) . Un’azienda di macchine fardellatrici che accumula debiti ingenti e ritardi nei pagamenti si espone inevitabilmente ad azioni legali da parte dei creditori: decreti ingiuntivi, pignoramenti dei beni, istanze di fallimento (ora liquidazione giudiziale) presentate in Tribunale.
L’obiettivo di questa guida è fornire – dal punto di vista del debitore – un quadro avanzato ma pratico delle possibili strategie di difesa e risanamento per un’azienda indebitata, aggiornato a ottobre 2025. Verranno esaminati gli strumenti immediati per arginare l’emergenza, le soluzioni legali sia stragiudiziali che giudiziali per ristrutturare o liquidare l’impresa, le tutele e responsabilità che gravano sugli amministratori, nonché le peculiarità nella gestione dei diversi tipi di debito (fiscale, bancario, verso fornitori, previdenziale). Il tutto arricchito con normativa italiana aggiornata e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, con tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione Domande & Risposte per chiarire i dubbi più comuni . Il taglio è divulgativo ma rigoroso, pensato per imprenditori, privati e professionisti (avvocati, commercialisti) che affrontano queste situazioni complesse.
Cause comuni dell’indebitamento in un’azienda di macchine fardellatrici
Prima di passare alle soluzioni, è utile riassumere le cause più frequenti che possono condurre un’azienda produttrice di macchine fardellatrici automatiche ad accumulare debiti insostenibili:
- Aumento dei costi e calo dei ricavi: la produzione di macchinari complessi richiede materie prime (acciaio, alluminio, plastiche tecniche) ed energia: un forte rialzo di questi costi, non accompagnato da un aumento proporzionale dei prezzi di vendita, comprime i margini. Se contemporaneamente calano gli ordini (ad es. per una crisi nel settore imballaggi) o i clienti chiedono prezzi più bassi, l’azienda può iniziare a erosione di liquidità e a finanziare l’operatività corrente ritardando pagamenti di fornitori o imposte.
- Investimenti elevati finanziati a debito: per restare competitiva, un’azienda di questo settore investe spesso in nuovi impianti (es. linee automatizzate di assemblaggio, robotica) e ricerca e sviluppo. Tali investimenti vengono spesso finanziati con mutui bancari, leasing o scoperti di conto. Se i benefici economici attesi (maggiori vendite, efficienza produttiva) tardano a concretizzarsi, l’azienda si ritrova gravata da rate eccessive rispetto ai flussi di cassa disponibili .
- Revoca o riduzione degli affidamenti bancari: banche e società di leasing, se rilevano segnali di peggioramento finanziario (indicatori di rischio, bilanci in perdita, sconfinamenti di conto), possono revocare i fidi o chiedere il rientro immediato dalle esposizioni a breve termine . Ad esempio, la revoca di un fido di cassa necessario per pagare fornitori e stipendi può generare una crisi di liquidità repentina. Analogamente, la segnalazione a “sofferenza” in Centrale Rischi da parte di una banca può innescare un effetto a catena, inducendo anche altri istituti a chiudere le linee di credito.
- Debiti fiscali e contributivi non onorati: come accennato, in tempi di difficoltà l’imprenditore può essere tentato di posticipare i pagamenti di IVA, ritenute o contributi, sperando di “guadagnare tempo” . Tuttavia, questa scelta porta rapidamente a un accumulo di cartelle esattoriali per imposte e contributi omessi, appesantite da sanzioni amministrative e interessi di mora . Inoltre, gli enti creditori pubblici hanno mezzi di riscossione particolarmente efficaci: l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali o bloccare con fermo amministrativo i macchinari e veicoli indispensabili all’attività; può pignorare i conti correnti, le merci in magazzino o crediti verso i clienti, spesso senza passare dal giudice (è sufficiente la notifica della cartella e l’iscrizione a ruolo) . L’INPS, dal canto suo, può ingiungere il pagamento dei contributi dovuti e arrivare a richiedere il fallimento dell’azienda in caso di persistente insolvenza. Infine, bisogna considerare che alcuni di questi debiti, se non pagati, possono far insorgere responsabilità penali a carico degli amministratori (si pensi al reato di omesso versamento IVA oltre soglia di legge, o all’omesso versamento di contributi previdenziali oltre €10.000 annui – su cui torneremo più avanti).
- Gestione finanziaria e amministrativa inadeguata: talvolta la crisi non dipende dal mercato ma da inefficienze interne. Ad esempio, una struttura dei costi eccessivamente pesante, magari per spese fisse non più sostenibili (personale sovrabbondante, locazioni onerose), può generare perdite anche a fronte di fatturato costante. Oppure l’azienda può avere troppe scorte di magazzino immobilizzate in prodotti finiti o ricambi, sottraendo liquidità, oppure ancora mancare di un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare subito i segnali di crisi (indici di bilancio negativi, flussi di cassa operativi in sofferenza) . Senza un assetto organizzativo adeguato, l’allerta arriva tardi e il dissesto patrimoniale si aggrava rapidamente.
In sintesi, una combinazione di fattori esterni (costi, mercato, credito bancario) e interni (scelte gestionali) può portare un’azienda di macchine fardellatrici da una situazione di semplice tensione finanziaria a una vera e propria insolvenza. A questo punto è cruciale passare all’azione: vediamo quali sono le prime mosse da compiere per difendere l’azienda.
Cosa fare subito se l’azienda ha troppi debiti
Di fronte a un grave sovraindebitamento aziendale, la prima regola è non restare inerti. Ignorare il problema o procrastinare le decisioni peggiorerà soltanto la situazione, riducendo le opzioni di salvataggio. Ecco le prime mosse urgenti che un’impresa indebitata dovrebbe attuare per difendersi e prevenire danni irreversibili:
- Non ignorare le comunicazioni dei creditori: ogni atto ufficiale ricevuto (sollecito di pagamento, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, avviso di accertamento fiscale, atto di pignoramento ecc.) ha termini precisi per reagire. Se arriva una notifica, è fondamentale segnare la data e consultare immediatamente un esperto (avvocato o commercialista). Ad esempio, una cartella esattoriale va pagata o impugnata entro 60 giorni, un decreto ingiuntivo va opposto entro 40 giorni, un preavviso di ipoteca precede di 30 giorni l’iscrizione dell’ipoteca. Scaduti i termini senza azione da parte del debitore, l’atto diventa definitivo e il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata senza ulteriori avvisi . Evitare di aprire la posta o fare finta di nulla è l’errore peggiore: spesso esistono rimedi legali (ricorsi, opposizioni) ma hanno finestre temporali strette.
- Verificare la legittimità e l’esattezza dei debiti: non tutti i debiti contestati all’azienda sono effettivamente dovuti o calcolati correttamente. È essenziale far eseguire a un professionista un’analisi approfondita di ogni posizione debitoria. Spesso emergono vizi formali (es. notifiche inesistenti o viziate che rendono annullabile la cartella), prescrizioni maturate (molte pretese fiscali decadono dopo 5 anni, altre dopo 10 – ad esempio tributi locali prescritti dopo 5 anni; IVA e imposte dirette dopo 10), errori di calcolo o applicazione di interessi non dovuti. Nel caso di debiti bancari, andrebbero verificati eventuali anatocismo o tassi usurari su interessi passivi, commissioni non dovute, ecc. Anche un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore va scrutinato: magari è basato solo su fatture e mancata contestazione, ma l’importo potrebbe includere penali o spese non pattuite. Contestare i debiti ingiusti o gonfiati è un diritto del debitore: si possono proporre ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, oppure azioni per accertare l’inesistenza del credito, a seconda dei casi . Ad esempio, molte cartelle esattoriali per contributi o tasse possono essere annullate se il credito sottostante è prescritto (l’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione va sempre controllato). Contestualmente, un decreto ingiuntivo fondato su un estratto conto bancario potrebbe essere attaccato eccependo tassi usurari o anatocismo. Insomma, difendersi in giudizio può ridurre il monte debitorio e guadagnare tempo prezioso.
- Evitare il blocco immediato dell’attività: se vi è il timore concreto che a breve possano partire pignoramenti o misure che paralizzino l’azienda (es. preavviso di ipoteca su capannone, intimazione di pagamento della riscossione che scade tra pochi giorni), è possibile agire d’urgenza per congelare la situazione. Un avvocato potrà, ad esempio, presentare un’istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario (in caso di ricorso contro una cartella o avviso di accertamento); allo stesso modo, si può chiedere al tribunale civile un provvedimento d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) se un creditore minaccia atti immediati su beni vitali. Da notare che in ambito tributario la legge prevede la sospensione automatica della riscossione solo su richiesta del contribuente e dimostrando un danno grave e irreparabile (oltre a evidenti motivi di ricorso) . In alternativa, o in parallelo, si può attivare subito una rateizzazione delle somme dovute (quando possibile): ad esempio, presentare domanda di dilazione ad Agenzia Entrate-Riscossione prima che scada il termine di pagamento di una cartella. Ottenere un piano di rate (fino a 120 rate mensili) blocca le azioni esecutive, purché le rate vengano poi pagate regolarmente .
- Proteggere i beni aziendali essenziali: bisogna mettere in sicurezza, per quanto lecito, gli asset senza i quali l’azienda non può operare – tipicamente macchinari chiave, impianti, automezzi per le consegne, nonché i beni immateriali come brevetti o software se cruciali. Come fare? Innanzitutto verificando le garanzie esistenti: ad esempio, se un macchinario produttivo è finanziato in leasing, formalmente appartiene alla società di leasing fino a riscatto finale; ciò significa che i creditori dell’azienda (diversi dalla leasing stessa) non possono pignorarla, e in caso di concordato il leasing può essere mantenuto pagando i canoni come spese di esercizio. Se invece macchinari o immobili sono ipotecati a favore di una banca, quel creditore sarà privilegiato ma almeno il bene non può essere aggredito da altri (salvo ipoteche successive). Per i beni non ancora vincolati, si può valutare – in tempi non sospetti – di porli a garanzia in modo da scoraggiare future aggressioni: ad esempio, patto marciano nelle garanzie bancarie (garanzia che consente alla banca di soddisfarsi sul bene evitando aste giudiziarie, ma restituendo l’eventuale surplus al debitore), oppure sale and lease back di macchinari (vendere il macchinario a una società di leasing ottenendo liquidità immediata, e poi riutilizzarlo in leasing: il ricavato può servire a pagare debiti urgenti, mentre il bene esce dal patrimonio dell’azienda diventando della leasing, difficile da pignorare). In extremis, alcuni imprenditori pensano a strumenti come il fondo patrimoniale o il trust per mettere al riparo beni immobili o liquidità personali: va però precisato che se questi atti vengono compiuti quando l’azienda è già insolvente o con lo scopo di frodare i creditori, potranno essere dichiarati nulli o revocati in caso di fallimento, e addirittura configurare reati (ad esempio bancarotta fraudolenta per distrazione di beni) . Quindi la tempistica è tutto: certe operazioni di protezione patrimoniale possono essere lecite se fatte quando l’azienda è ancora in bonis (solvibile), ma diventano rischiose e controproducenti se fatte ex post. In generale, una volta che i debiti sono già scaduti e i creditori “alle porte”, spostare o occultare beni è molto pericoloso e quasi mai utile.
- Avviare trattative mirate con i creditori strategici tramite professionisti: un errore comune dell’imprenditore in difficoltà è provare a pagare “quel poco che c’è” al creditore più pressante, trascurando gli altri. Si finisce magari per soddisfare il fornitore che minaccia azioni legali, restando però scoperti verso il fisco o le banche – con il risultato di aver compiuto pagamenti preferenziali contestabili e di non aver risolto il problema generale. È invece preferibile affidare a un professionista esperto in crisi d’impresa il compito di contattare formalmente i principali creditori (es. banca principale, fornitori critici) per negoziare moratorie o piani di rientro sostenibili . Spesso con una lettera ben formulata su carta intestata di un legale, corredata magari da un abbozzo di piano di risanamento, si ottiene ascolto. Ad esempio, la banca potrebbe concedere una moratoria sul mutuo (sospensione temporanea delle rate) o prorogare le linee di fido per qualche mese; i fornitori, dal canto loro, potrebbero accettare una dilazione dei pagamenti scaduti pur di evitare di perdere il cliente. Queste negoziazioni “in bonis” convengono spesso anche ai creditori, specie se l’alternativa plausibile è che l’azienda fallisca lasciandoli con un pugno di mosche. È fondamentale mettere tutto per iscritto: se si raggiunge un accordo, formalizzarlo in un accordo transattivo firmato o – meglio – in un piano di risanamento attestato (di cui diremo oltre), per renderlo vincolante e non contestabile. Inoltre, coinvolgere un commercialista può aiutare a predisporre un convincente piano industriale e finanziario di risanamento da sottoporre ai creditori, aumentando la credibilità dell’operazione .
Queste prime mosse mirano essenzialmente a guadagnare tempo e stabilizzare la situazione, evitando che i debiti “diventino esecutivi” e che la produzione sia paralizzata . Ovviamente ogni caso concreto richiede un approccio personalizzato: un consulente specializzato valuterà quali tra le azioni sopra descritte siano praticabili e prioritarie. Ad esempio, se l’azienda di macchine fardellatrici ha macchinari essenziali in leasing, bisognerà dare precedenza a evitare che la società di leasing risolva i contratti (magari pagando qualche canone arretrato critico) perché perdere quei beni fermerebbe la produzione . Se invece il grosso del debito è verso il Fisco, sarà cruciale attivarsi subito con un’istanza di rateizzazione o approfittare di eventuali definizioni agevolate per bloccare sul nascere le procedure esecutive dell’Agenzia Entrate-Riscossione . In ogni caso, una volta ottenuto respiro nel brevissimo termine, occorre passare alla strategia di medio-lungo periodo per riequilibrare la situazione finanziaria: è il momento di valutare gli strumenti legali di ristrutturazione o insolvenza.
Soluzioni legali per un’azienda indebitata: panoramica degli strumenti
Superata la fase emergenziale, l’azienda deve impostare una strategia per gestire e ridurre il debito complessivo nel medio termine. Le opzioni a disposizione variano a seconda della forma giuridica dell’impresa (società di capitali o di persone, oppure ditta individuale) e della gravità dello stato di crisi o insolvenza. In generale si possono distinguere soluzioni stragiudiziali (accordi privati con i creditori, al di fuori di procedure concorsuali) e procedure concorsuali vere e proprie (soluzioni giudiziali regolate dalla legge, con l’intervento del tribunale). Di seguito elenchiamo i principali strumenti di risanamento del debito aziendale, con una breve descrizione dei loro effetti:
- Rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi (fino a 120 rate): è uno strumento amministrativo che consente di diluire fino in 10 anni il pagamento di imposte o contributi dovuti allo Stato. Può essere richiesto all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, AER) quando ricorrono i requisiti di legge – ad esempio, per debiti fino a €120.000 non è richiesta prova di difficoltà, per importi maggiori va documentata la temporanea situazione di obiettiva crisi . Ottenere un piano di rate significa mettere “a bada” il Fisco perché, una volta concessa la dilazione, l’Agente della Riscossione non può avviare né proseguire azioni esecutive o cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche) finché il debitore rispetta i pagamenti rateali . Attenzione: l’ammissione alla rateazione fa decadere eventuali precedenti misure agevolative; inoltre, se successivamente l’azienda entra in procedura concorsuale (es. concordato preventivo), la dilazione in corso decade automaticamente e il debito residuo va inserito per intero nella procedura .
- “Saldo e stralcio” con banche o fornitori: consiste in un accordo transattivo volontario in cui un creditore accetta di rinunciare a una parte del proprio credito in cambio del pagamento immediato (o entro breve termine) di un importo concordato. È una soluzione tipica con banche o factor su crediti deteriorati: l’istituto può preferire incassare subito, ad esempio, il 30-50% del dovuto, anziché affrontare lunghe azioni legali con il rischio di incassare meno . Analogamente, un fornitore molto esposto potrebbe accettare di stralciare interessi o parte del capitale se ottiene un pagamento parziale sicuro. Il saldo e stralcio è un accordo bilaterale (azienda-creditore) che non vincola gli altri creditori e non richiede omologazione giudiziaria. Può dare sollievo togliendo dal tavolo alcuni debiti chiave (es. estinguendo il mutuo ipotecario con la banca mediante un saldo stralcio, si libera l’ipoteca sull’immobile). Tuttavia, bisogna avere risorse immediate da offrire; inoltre, pagare solo alcuni creditori rilevanti e non altri può esporre l’azienda al rischio di azioni revocatorie se poi si apre un fallimento (i pagamenti stralcio fatti nell’anno prima del fallimento possono essere revocati dal curatore come atti a favore di un creditore a discapito degli altri, salvo particolari esenzioni).
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: è uno strumento nuovo (introdotto nel 2021 con D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) e ora disciplinato nel Codice della Crisi (artt. 12-25 CCII) . Si tratta di una procedura volontaria stragiudiziale assistita da un esperto indipendente, volta a favorire la negoziazione tra l’imprenditore e i suoi creditori . In pratica, l’imprenditore in stato di crisi (ma non ancora insolvenza irreversibile) può richiedere alla Camera di Commercio la nomina di un Esperto in crisi d’impresa. Con l’esperto si analizzano le cause della crisi e si tenta di raggiungere accordi con i creditori (accordi singoli o plurimi). L’impresa rimane in bonis (continua a gestire la società) e la procedura è riservata; tuttavia, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale può concedere delle misure protettive temporanee (tipicamente il blocco delle azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative) . La composizione negoziata è indicata per imprese ancora vitali ma in difficoltà, che vogliono evitare procedure concorsuali trovando un accordo rapido e meno formale. Se ha esito positivo, la Composizione Negoziata può concludersi con diversi risultati a seconda dei casi: ad esempio un accordo stragiudiziale semplice (privato) con alcune banche o fornitori; oppure la formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (vedi oltre) da sottoporre a omologazione; oppure – in caso non si raggiungano adesioni sufficienti – la possibilità di proporre un concordato “semplificato” liquidatorio (introdotto anch’esso nel 2021) per liquidare i beni sotto controllo del tribunale senza voto dei creditori . Se invece la composizione non produce soluzioni, l’imprenditore potrà comunque accedere ad altre procedure concorsuali (concordato, liquidazione) senza incorrere in sanzioni o pregiudizi. Novità 2023-2024: per rendere più appetibile questo strumento, il legislatore ha previsto la possibilità di stipulare, nell’ambito della composizione negoziata, speciali accordi con il Fisco per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari (transazione fiscale “fuori concorso”) . Ciò è stato introdotto inserendo il comma 2-bis all’art. 23 CCII dal correttivo 2024, e consente di alleggerire il carico fiscale durante le trattative con l’assenso dell’Agenzia delle Entrate. Restano esclusi, però, i debiti verso gli enti previdenziali (INPS) in sede di composizione negoziata . L’accordo fiscale così concluso deve garantire la sostenibilità dell’impresa e può essere risolto di diritto in caso di successiva apertura di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali . In sostanza, la composizione negoziata oggi offre un “ombrello protettivo” più ampio, potendo congelare le azioni dei creditori e negoziare anche col Fisco, il che la rende un passaggio consigliato quando vi sono margini di risanamento.
- Opposizione ad atti esecutivi illegittimi: se alcuni creditori hanno già avviato pignoramenti, fermi o ipoteche contro l’azienda, è possibile difendersi in giudizio anche in quella fase. Ad esempio, si può presentare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che il creditore non abbia un titolo esecutivo valido o che il bene pignorato sia impignorabile (si pensi a macchinari necessari all’esercizio dell’impresa: di regola pignorabili, ma in alcuni casi limitati il giudice può sospendere la vendita se pregiudica la continuità aziendale); oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per denunciare irregolarità procedurali (pignoramento eseguito in modo non conforme, vizi di notifica etc.) . Anche un’ipoteca iscritta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere contestata se in violazione di legge – ad esempio se viene iscritta per un debito sotto la soglia di €20.000 prevista o senza la previa comunicazione di avviso all’azienda . Va detto che queste azioni non risolvono il debito di per sé (non cancellano l’obbligazione), ma possono guadagnare tempo sospendendo le esecuzioni o rimuovendo vincoli illegittimi su beni aziendali, in attesa di soluzioni più strutturali.
- Rinegoziazione di mutui e leasing: i debiti bancari e finanziari possono spesso essere ristrutturati anche fuori dalle procedure concorsuali, se c’è la disponibilità delle parti. Ad esempio, l’azienda debitrice può chiedere alla banca di rinegoziare un mutuo allungandone la durata e riducendo l’importo della rata, magari offrendo in cambio qualche garanzia aggiuntiva (un’ipoteca su un bene finora non garantito, oppure una fideiussione personale degli soci se prima non c’era). Dal 2019 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) promuove periodicamente le cosiddette “convenzioni di moratoria”: accordi-quadro cui aderiscono molte banche, che consentono alle PMI in temporanea difficoltà di ottenere la sospensione per 6-12 mesi del pagamento delle quote capitale dei mutui o dei leasing, o altre forme di allentamento del credito . Se l’azienda rientra nei parametri (ad esempio non deve avere posizioni deteriorate gravi), vale la pena verificare con la propria banca la possibilità di accedere a tali moratorie. In ogni caso, qualsiasi accordo modificativo di piani di ammortamento (mutui, leasing) dovrebbe idealmente essere formalizzato prima di entrare in procedure concorsuali, perché dopo l’apertura di un concordato o fallimento subentrano vincoli legali più rigidi.
- Piano attestato di risanamento: il piano attestato è uno strumento stragiudiziale previsto dall’art. 56 del Codice della Crisi (già art. 67 lett. d) l.fall. prima della riforma). Consiste in un piano di risanamento aziendale predisposto dall’impresa, con l’accordo di alcune banche o creditori, il quale viene “attestato” da un professionista indipendente (attestatore) riguardo alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano. Questo documento rimane riservato (non viene depositato in Tribunale) ma offre un beneficio legale importante: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti ad azione revocatoria in caso di successivo fallimento dell’azienda . Ciò serve a incentivare i creditori a accordarsi, sapendo che le operazioni compiute non verranno messe in discussione se poi la situazione peggiora. Il piano attestato, in sostanza, è un accordo privatissimo e flessibile: non richiede il coinvolgimento di tutti i creditori (ci si accorda solo con quelli che aderiscono) né l’approvazione del tribunale; tuttavia occorre l’intervento dell’attestatore indipendente che ne certifica i numeri e le prospettive . Ad esempio, la società può concordare con due banche principali la ristrutturazione dei debiti (allungamento scadenze, rinuncia a quota di credito) e su tale base costruire un piano di rilancio certificato da un esperto. Se il piano è credibile, anche altri creditori minori potrebbero rispettarlo di fatto. Importante: il piano attestato non impone nulla ai creditori non firmatari. È uno strumento adatto quando l’impresa ha un numero limitato di creditori chiave (tipicamente le banche) con cui riesce a trovare un’intesa fuori dai tribunali; l’attestazione serve a dare fiducia e solidità all’accordo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR): è una procedura concorsuale snella disciplinata dagli artt. 57-64 CCII (corrispondente all’ex art. 182-bis l.fall.). Si tratta di un accordo tra l’imprenditore e una parte rilevante dei creditori, che viene poi omologato dal Tribunale. I requisiti principali: l’accordo deve coinvolgere tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali (in pratica serve l’adesione di una maggioranza qualificata di creditori per importo) . I creditori non aderenti rimangono estranei (il che significa che, a differenza del concordato, l’accordo di ristrutturazione non li vincola, salvo eccezioni), però l’omologazione da parte del giudice comporta alcuni effetti protettivi: ad esempio sospende le azioni esecutive dei creditori estranei per 60 giorni dall’omologa (per evitare il sabotaggio dell’accordo). Il vantaggio dell’ADR è la sua rapidità e riservatezza: si deposita l’accordo e un piano attestato di fattibilità, il tribunale verifica la regolarità e, in presenza delle adesioni richieste, omologa senza coinvolgere tutti i creditori. Negli ultimi anni sono state introdotte varianti come l’accordo di ristrutturazione agevolato (possibile con adesione del 30% dei creditori, ma solo se tutti i creditori finanziari – banche – aderiscono) e l’accordo ad efficacia estesa, che permette di estendere gli effetti anche ai creditori dissenzienti appartenenti a una certa categoria omogenea, se chi aderisce rappresenta il 75% di quella categoria. Inoltre, esiste l’accordo con riserva (simile al concordato in bianco) per ottenere subito protezione dai creditori e poi finalizzare l’accordo entro termini brevi. Nell’ADR può essere inclusa una transazione fiscale per il trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII), analogamente a quanto avviene nel concordato . Novità 2024: il correttivo 2024 ha previsto il cram-down fiscale anche negli accordi di ristrutturazione, in linea con la Direttiva UE 2019/1023: se il Fisco o l’INPS non aderiscono all’accordo ma la proposta soddisfa quei crediti in misura almeno pari al ricavabile in liquidazione, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il loro assenso, superando quindi il veto dell’erario (prima l’adesione dell’erario era imprescindibile per omologare) . Ciò riduce il potere di blocco del credito pubblico nelle ristrutturazioni.
- Concordato preventivo: è la procedura regina tra le soluzioni concorsuali per le aziende medio-grandi in crisi o insolventi. Prevista dagli artt. 84 e ss. CCII (corrispondenti all’art. 160 e ss. vecchia legge fall.), consente all’impresa di evitare la liquidazione giudiziale proponendo ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre a voto e all’omologazione del Tribunale . Il concordato preventivo può avere due modalità principali: concordato in continuità aziendale (quando l’impresa prosegue l’attività, eventualmente ristrutturandola, e paga i creditori col ricavato della prosecuzione e magari con apporti di finanza nuova) o concordato liquidatorio (quando l’azienda prevede di cessare l’attività e liquidare il patrimonio, distribuendo il ricavato ai creditori) . Il Codice della Crisi richiede in ogni caso che il piano assicuri ai creditori un soddisfacimento migliore di quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale (principio di convenienza). Nel concordato liquidatorio puro è imposto inoltre un pagamento minimo del 20% ai creditori chirografari (unsecured), salvo che i creditori stessi approvino percentuali inferiori – soglia introdotta per legge già dal 2015 e confermata dal CCII. Proceduralmente, il concordato prevede: la presentazione di un ricorso in tribunale con una proposta e un piano dettagliato, accompagnati dalla relazione di un attestatore indipendente che certifichi veridicità dei dati e fattibilità del piano; una fase iniziale di ammissione (controllo di fattibilità e di regolarità da parte del tribunale); quindi la votazione dei creditori (che può avvenire per adunanza o per classescritto) suddivisi in classi omogenee per interesse; infine, se si raggiungono le maggioranze richieste (maggioranza del credito ammesso per ogni classe, e la maggioranza semplice delle classi votanti, oppure – in assenza di classi – 50%+1 del totale crediti) , il tribunale procede all’omologazione, rendendo il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Anche chi ha votato contro o non ha partecipato resta vincolato alle condizioni stabilite nel piano omologato . Dal momento del deposito della domanda, scattano inoltre gli effetti protettivi: il debitore è protetto da azioni esecutive individuali dei creditori (art. 54 CCII) e i contratti in corso possono proseguire. Per evitare un assalto alla diligenza prima di presentare il piano, la legge consente il concordato “con riserva” (o “in bianco”): l’azienda deposita intanto la domanda di concordato riservandosi di presentare il piano dettagliato entro un termine (di norma 60-120 giorni prorogabili) ottenendo nell’immediato la protezione del tribunale . Novità 2022-2023: una rivoluzione importante riguarda i crediti fiscali e contributivi nel concordato. In passato, la regola era che la proposta concordataria dovesse necessariamente prevedere il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute (imposte “pregiate” non falcidiabili) salvo accordo con l’erario, e che se l’erario votava “no” il concordato saltava. Oggi, invece, la legge (art. 112, c.2 CCII) consente la omologazione forzata del concordato anche in caso di voto contrario dell’Amministrazione finanziaria o dell’INPS, purché la proposta assicuri a questi crediti un trattamento almeno pari a quello che otterrebbero in caso di liquidazione . In altre parole, il tribunale può approvare il concordato nonostante il diniego del Fisco, se ritiene che per il Fisco quella proposta sia comunque più conveniente della liquidazione fallimentare. Questo meccanismo di cram-down fiscale è stato riconosciuto prima dalla giurisprudenza e poi recepito normativamente . La Cassazione, con sentenza 28 ottobre 2024 n. 27782, ha chiarito infatti che la norma (già introdotta in emergenza col D.L. 125/2020) si applica sia in caso di mancata espressione di voto da parte dell’Erario sia in caso di voto negativo espresso: il dissenso del Fisco non impedisce l’omologa se i presupposti di convenienza sono rispettati . Questo ha eliminato una situazione prima controversa e spostato l’ago della bilancia verso la tutela del “bene-impresa” rispetto all’interesse fiscale. In sintesi, il concordato preventivo è uno strumento potente ma impegnativo: vantaggi – blocca le azioni dei creditori, consente di ristrutturare massivamente il debito (anche riducendolo) e, se in continuità, di rilanciare l’azienda con l’ok dei creditori; svantaggi – è pubblico, lungo e costoso, richiede la maggioranza dei voti dei creditori (non scontata), e se fallisce l’azienda finisce quasi certamente in liquidazione giudiziale.
- Liquidazione giudiziale (già “fallimento”): è la procedura concorsuale liquidatoria per eccellenza, volta a soddisfare i creditori attraverso la spossessione e la vendita dei beni del debitore. Si ricorre alla liquidazione giudiziale quando l’impresa è insolvente in modo irreversibile e non vi sono prospettive di risanamento, oppure quando gli strumenti di composizione negoziata o concordataria falliscono. Possono chiedere l’apertura della liquidazione gli stessi amministratori della società (ricorso in proprio) oppure uno o più creditori, o il PM se vi sono ragioni di interesse pubblico (es. insolvenza con reati). Il tribunale, accertato lo stato di insolvenza, dichiara l’apertura della procedura e nomina un Curatore fallimentare che prende in mano la gestione dell’azienda e del patrimonio. Gli organi sociali (amministratori) perdono i poteri di gestione, sostituiti dal curatore, mentre ai soci viene preclusa ogni possibilità di disporre dei beni aziendali. La liquidazione giudiziale comporta la formazione dello stato passivo: tutti i creditori devono insinuare i propri crediti entro una scadenza e il giudice delegato, su proposta del curatore, forma l’elenco dei crediti ammessi e delle relative cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni). Il curatore procede poi a realizzare l’attivo, cioè vendere i beni dell’azienda (dalle attrezzature ai fabbricati, dalle rimanenze ai crediti verso clienti) mediante procedure competitive. Il ricavato viene distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima i creditori con privilegi speciali su determinati beni o con ipoteca/pegno (che verranno soddisfatti col ricavato di quei beni), poi i creditori privilegiati generali (come dipendenti, Fisco e INPS per alcune voci) sul ricavato residuo, infine gli chirografari (senza garanzie) se avanza qualcosa – evento raro. Al termine, la società viene cancellata dal registro imprese e cessa di esistere; i debiti non soddisfatti rimangono permanentemente inesigibili nei confronti della società (poiché estinta). Attenzione però: la chiusura per insufficienza attivo o la cancellazione non fanno sparire i debiti nei confronti di eventuali coobbligati o garanti: ad esempio, se un socio o amministratore aveva firmato una fideiussione personale verso la banca, il fallimento della società libera la società dal debito residuo ma il garante potrà essere escusso dal creditore. Similmente, se l’azienda è una società di persone (SNC o SAS), i soci illimitatamente responsabili restano obbligati coi propri beni per i debiti sociali non pagati dal fallimento. Va detto che la procedura di liquidazione giudiziale oggi è concepita per durare il meno possibile (l’obiettivo del Codice della Crisi è di chiudere la liquidazione entro 3 anni ), e al suo esito i debiti non soddisfatti possono essere oggetto di esdebitazione. Esdebitazione significa liberazione dai debiti residui: nel caso di società di capitali ciò è irrilevante perché la società si estingue; ma nel caso di imprenditore individuale o soci illimitatamente responsabili falliti, la legge prevede che, se hanno cooperato lealmente, possano ottenere la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della liquidazione, di regola trascorsi 3 anni (fresh start) . La liquidazione giudiziale è dunque la soluzione di “ultima istanza”: vantaggi – mette un punto finale alla crisi, sotto supervisione del tribunale, garantendo la parità di trattamento dei creditori secondo la legge; consente (per le persone fisiche) di ripartire da zero una volta chiusa; svantaggi – l’impresa viene spossessata e cessano le attività (salvo esercizio provvisorio autorizzato in casi eccezionali per vendere l’azienda intera), gli amministratori possono subire azioni di responsabilità e sanzioni, e la soddisfazione dei creditori di solito è parziale e tarda anni.
- Procedure di sovraindebitamento (per soggetti non fallibili): finora abbiamo parlato di società ed imprese soggette alle procedure concorsuali ordinarie. Esistono però debitori “minori” che non possono accedere al concordato preventivo o al fallimento: ad esempio l’imprenditore sotto soglia (che negli ultimi anni ha avuto meno di €200k di ricavi, meno di €300k di attivo patrimoniale e debiti sotto €500k), le start-up innovative, gli imprenditori agricoli, i professionisti e le persone fisiche consumatrici. Tali soggetti possono ricorrere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (ex Legge 3/2012, ora integrate nel Codice della Crisi agli artt. 65-81) . In concreto, l’imprenditore sovraindebitato può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti (detto concordato minore se è un imprenditore, o piano del consumatore se è un privato non imprenditore) da omologare in tribunale – simile a un piccolo concordato, ma con regole più flessibili e la presenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al posto del commissario . Ad esempio, nel piano del consumatore i creditori non votano affatto: decide tutto il giudice valutando la meritevolezza e convenienza; nel concordato minore invece i creditori votano ma le maggioranze sono calcolate sul totale e senza classi. Se queste procedure vengono omologate e completate, il debitore persona fisica ottiene la esdebitazione totale dei debiti chirografari residui (in pratica viene liberato dai debiti, a differenza delle società che invece si estinguono). Infine c’è la liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del sovraindebitato), una sorta di fallimento semplificato per il piccolo imprenditore o il privato: il patrimonio viene liquidato dall’OCC nominato liquidatore e al termine il debitore persona fisica ottiene comunque l’esdebitazione dei debiti rimasti. Da notare che dal 2023 la Cassazione ha aperto la possibilità, nei piani del consumatore, di diluire il pagamento dei crediti privilegiati anche oltre l’anno senza automatica bocciatura – superando il previgente limite annuale previsto dalla vecchia L.3/2012 . In altre parole, nei piani dei soggetti sovraindebitati oggi è possibile prevedere moratorie più lunghe per i debiti fiscali o con garanzia, purché i creditori siano messi in grado di esprimersi sulla dilazione e il piano risulti fattibile.
Quanto sopra fornisce un quadro di massima degli strumenti disponibili. Nella sezione successiva approfondiremo in particolare due aspetti fondamentali per la nostra azienda di macchine fardellatrici: (A) come gestire i debiti tributari e contributivi, che seguono regole proprie e per i quali la legge offre strumenti specifici; (B) come orientarsi tra le procedure concorsuali (concordato, liquidazione) valutando pro e contro a seconda della situazione. Successivamente esamineremo anche le responsabilità personali che possono ricadere sugli amministratori o soci in caso di indebitamento, e proporremo una simulazione pratica con possibili scenari risolutivi.
Gestione dei debiti tributari e contributivi dell’azienda
I debiti verso il Fisco e l’INPS meritano un capitolo a parte, in quanto seguono regole speciali. Le imposte e i contributi non pagati generano rapidamente sanzioni, interessi e, come visto, azioni esecutive privilegiate. Inoltre, alcuni debiti fiscali godono di privilegi sul patrimonio dell’azienda (es. l’IVA dovuta e le ritenute non versate hanno privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c., così come i contributi INPS ex art. 2753 c.c.), e certi non sono “stralciabili” facilmente per ragioni di ordine pubblico (ad esempio l’IVA rappresenta una risorsa UE e tendenzialmente va pagata integralmente salvo insolvenza conclamata). Di seguito, le strategie per affrontare i debiti fiscali/previdenziali:
1. Rateizzazione ordinaria e defiscalizzazione delle sanzioni: come già accennato, la via primaria per gestire un debito tributario esigibile è chiedere un piano di rateazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). In base all’art. 19 del D.P.R. 602/1973, l’AER può concedere fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a €120.000 senza bisogno di provare lo stato di difficoltà, oppure fino a 120 rate (10 anni) per importi superiori o in caso di comprovata temporanea difficoltà . Le ultime modifiche normative (D.Lgs. 83/2021 e D.Lgs. 110/2023) hanno reso più accessibili le dilazioni, ad esempio elevando a 5 le rate non pagate che causano decadenza (prima erano 3), e prevedendo tassi di interesse più favorevoli. Attenzione: se l’azienda ha già in corso una rateazione e deposita un concordato preventivo, quella rateazione decade automaticamente e l’intero importo residuo diventa esigibile nel concordato . Inoltre l’apertura di una liquidazione giudiziale interrompe le dilazioni. Pertanto, la rateazione è ottima in fase stragiudiziale per bloccare i recuperi, ma va “congelata” (chiedendo la sospensione delle rate residue) se poi si accede a procedure concorsuali. Periodicamente, poi, lo Stato vara misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cosiddette rottamazioni): l’ultima in vigore (definizione 2023, D.L. 34/2023 conv. L. 197/2022) ha consentito di pagare solo il tributo e gli interessi legali, con stralcio totale di sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate . Queste misure a finestra temporale determinata sono opportunità preziose per ridurre il carico fiscale: l’azienda deve tenersi informata (tramite il proprio consulente) se ne riapriranno in futuro e attivarle tempestivamente.
2. Transazione fiscale e contributiva nel concordato o ADR: all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato, la legge consente di inserire una proposta di transazione dei debiti tributari e previdenziali (artt. 63 e 88 CCII) . In pratica, si tratta di proporre al Fisco e agli enti previdenziali un trattamento che può prevedere stralci (rinunce) su imposte, sanzioni e interessi, oppure dilazioni di pagamento oltre i limiti ordinari. Questa “transazione fiscale” deve assicurare al Fisco/INPS almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione, ed è soggetta ad approvazione: nell’ADR serve la loro adesione formale, nel concordato si concretizza col loro voto favorevole (oppure, come visto, anche se votano contro il tribunale può omologare lo stesso, applicando il cram-down). Ad esempio, un’azienda può proporre in concordato: pagamento integrale dell’IVA (che per prassi si cerca di non falcidiare) ma stralcio dell’80% delle sanzioni e interessi, nonché pagamento parziale del debito IRPEF e INPS in misura pari al 40% ciascuno, dilazionato in 4 anni. Se l’Agenzia delle Entrate e l’INPS votano sì (o anche se dicono no ma il piano rispetta la regola di convenienza), la transazione viene omologata insieme al concordato e vincola tali enti . Da notare: l’IVA e le ritenute non pagate possono essere oggetto di stralcio nel concordato solo in termini di interessi e sanzioni; l’imposta in sé generalmente va prevista per intero a meno che la relazione dell’attestatore giustifichi che, in liquidazione, il Fisco non avrebbe comunque recuperato tutto (in tal caso, anche l’IVA può considerarsi soddisfatta pro quota). La Cassazione a Sezioni Unite nel 2021 ha affermato la legittimità di soddisfare l’IVA in misura parziale se il piano dimostra che così comunque l’Erario prende il massimo possibile . In sostanza, oggi si può proporre anche di non pagare il 100% dell’IVA, ma occorre una attestazione molto rigorosa e di solito il tribunale sarà estremamente prudente nel consentirlo. Le sanzioni fiscali invece possono essere tagliate quasi integralmente nel concordato, poiché in sede fallimentare sono considerate chirografarie e spesso non recuperano nulla. Un aspetto importante: se si intraprende la strada del concordato, i benefici delle definizioni agevolate decadono – come detto – e le sanzioni “risorgono” per essere trattate nella transazione fiscale . Quindi prima di avviare un concordato bisogna ponderare se convenga attendere la chiusura di eventuali rottamazioni in corso. Negli accordi di ristrutturazione, similmente, si può inserire un accordo col Fisco: fino al 2022 era necessario che l’Agenzia aderisse, ora con la modifica 2024 il giudice può omologare l’accordo anche senza adesione erariale se il trattamento offerto è fair (cram-down ADR) .
3. Gestire gli avvisi di accertamento e le cartelle in contenzioso: se i debiti fiscali non sono ancora definitivi ma derivano da accertamenti impugnabili, l’azienda può valutare di fare ricorso tributario. Ad esempio, un avviso di accertamento per IRES o IVA che si ritenga infondato può essere portato di fronte alla Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie). Il ricorso, se accolto, annulla in tutto o in parte la pretesa fiscale. Anche la cartella esattoriale può essere oggetto di ricorso se riferita a un atto mai notificato o viziato. Durante il contenzioso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice tributario, evitando che l’Agente riscossore aggredisca i beni . Certo, il contenzioso tributario può richiedere anni e non risolve problemi di liquidità immediati, ma può ridurre drasticamente il debito fiscale se vi sono valide ragioni. Inoltre, a volte la pendenza di un giudizio tributario importante può indurre l’Agenzia a trattare un accordo transattivo (cosa ora possibile anche nella composizione negoziata). Discorso simile vale per le cartelle INPS: si può fare opposizione al verbale o all’intimazione se vi sono motivi (es. prescrizione dei contributi decorsi 5 anni dopo l’anno di riferimento, come chiarito anche di recente dalla Cassazione ).
4. Conseguenze penali da gestire (omessi versamenti): i debiti fiscali e contributivi, se di importo elevato, possono innescare procedimenti penali a carico degli amministratori. I casi tipici: omesso versamento di IVA superiore a €250.000 per periodo d’imposta (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) – reato punito con reclusione 6 mesi–2 anni; omesso versamento di ritenute dovute (ad es. ritenute IRPEF su stipendi) superiore a €150.000 annui (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) ; omesso versamento di contributi previdenziali superiore a €10.000 annui (art. 2 D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983, come modificato) – quest’ultimo con pena fino a 3 anni . In questi casi l’amministratore può difendersi dimostrando di aver compiuto il possibile per adempiere (es. crisi di liquidità non imputabile a lui) oppure, più concretamente, provvedendo a pagare il dovuto entro specifici termini: la legge prevede infatti cause di non punibilità se il pagamento avviene entro una certa data (per l’IVA e le ritenute, entro la scadenza della dichiarazione annuale dell’anno successivo; per i contributi, la procedura è particolare: l’INPS invia una diffida a regolarizzare entro 3 mesi e se si paga entro tale termine il reato è estinto). Dunque è fondamentale, nella gestione dei debiti fiscali, considerare anche il profilo penale: a volte può essere opportuno, ad esempio, destinare risorse a pagare preferibilmente l’IVA e le ritenute entro fine anno, per non superare le soglie di punibilità, anche a costo di ritardare altri pagamenti, perché evitare un procedimento penale per l’amministratore è prioritario (oltre che moralmente evitare di “trarre in tasca” imposte dovute). Da notare che accedere a una procedura concorsuale non estingue i reati tributari: se i debiti non pagati superavano le soglie, il fatto è commesso. Tuttavia, l’atteggiamento collaborativo (ad es. includere il Fisco al meglio nel concordato, o segnalare tempestivamente la crisi) può essere valutato come attenuante. E dopo il fallimento, l’aver aggravato i debiti erariali potrebbe rilevare come elemento di bancarotta semplice (avere ritardato il fallimento aggravando il dissesto). Quindi, gestire i debiti fiscali significa anche evitare responsabilità penali: la strada maestra è pagare almeno entro i limiti di legge e, se non possibile, attivarsi in sede di concordato per ottenere l’esdebitazione consensuale con l’Erario.
Scegliere la strada giusta: continuità aziendale o liquidazione?
Quando un’azienda è gravata da debiti ma possiede ancora potenzialità di business, l’obiettivo dovrebbe essere salvarne la continuità, se possibile. Viceversa, se la situazione è compromessa, può essere preferibile chiudere l’attività in modo ordinato limitando i danni (ad esempio attraverso un concordato liquidatorio con cessione dell’azienda a terzi). La decisione sul percorso da intraprendere è delicata e va presa caso per caso, valutando: la fattibilità del risanamento, la disponibilità di finanziamenti o investitori disposti a supportare il rilancio, la struttura del debito (se prevalentemente finanziario, prevalentemente fiscale, ecc.), e naturalmente la volontà dell’imprenditore di proseguire o meno l’attività.
In generale: se la crisi appare reversibile – ad esempio c’è un buon portafoglio ordini futuro, il mercato è in ripresa, l’azienda ha un know-how valido ma necessita di ridurre il debito – allora conviene tentare strumenti di ristrutturazione in continuità (concordato in continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato) oppure la composizione negoziata se si è ancora in tempo a negoziare con i creditori . Al contrario, se l’insolvenza è ormai irreversibile e l’azienda non è più competitiva (perdita di mercato, impianti obsoleti, nessun investitore disposto a sostenerla), è più saggio procedere a una liquidazione ordinata attivata dal debitore stesso (concordato liquidatorio o liquidazione giudiziale in proprio) piuttosto che attendere passivamente l’istanza di un creditore .
Concordato preventivo vs. liquidazione giudiziale: il concordato preventivo anche liquidatorio presenta alcuni vantaggi: il debitore mantiene inizialmente un certo controllo sul processo (può presentare una sua proposta), ed evita alcune conseguenze traumatiche del fallimento (ad esempio evita l’interdizione legale dell’imprenditore, e può consentire di scegliere quali beni cedere e come). Inoltre nel concordato il debitore può, ad esempio, vendere l’azienda in esercizio a un terzo e distribuire il prezzo ai creditori – ciò massimizza il valore rispetto a una vendita frammentata da fallimento. Va però considerato che un concordato liquidatorio impone di offrire almeno il 20% ai chirografari (salvo consenso diverso) e di pagare integralmente i creditori con cause di prelazione sui beni liquidati (o trattare col loro consenso). Se l’azienda ha pochi asset e molta esposizione, è possibile che un concordato del genere non sia fattibile (non si raggiunge il 20% per i chirografari, ad esempio). In tal caso tanto vale optare per la liquidazione giudiziale, che almeno non ha soglie minime (i creditori prenderanno quel che c’è).
Strumenti negoziali ex art. 182-bis vs. composizione negoziata: se l’impresa è in crisi ma ha chance di risanarsi con l’appoggio di alcuni creditori chiave (banche), si può tentare prima la via stragiudiziale (piano attestato) o semi-stragiudiziale (accordo di ristrutturazione omologato). Questi strumenti evitano la lentezza e la pubblicità di un concordato, ma hanno lo svantaggio di richiedere un certo consenso tra i creditori. La composizione negoziata è un ottimo primo passo perché consente di esplorare tutte le opzioni con la guida di un esperto: se in quella sede si capisce che l’accordo è a portata, si può formalizzare un ADR; se invece serve il voto di tutti, si passa a un concordato preventivo ben preparato, magari con un investitore individuato durante la negoziazione. Importante: l’azienda dovrebbe evitare di arrivare alla liquidazione giudiziale “di sorpresa” su iniziativa dei creditori; meglio anticipare con una propria strategia (concordato o liquidazione volontaria) per gestire il processo. Ricordiamo anche che presentare tempestivamente un ricorso a una procedura concorsuale non può essere considerato di per sé un inadempimento degli amministratori: anzi, il Codice della Crisi prevede espressamente che la presentazione di una domanda di concordato o simili non costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore (art. 120-bis CCII) , a tutela di chi agisce responsabilmente. Dunque non bisogna temere lo stigma di “portare i libri in tribunale” se ciò è nell’interesse dei creditori e può evitare conseguenze peggiori.
Esempio riassuntivo: l’azienda Alfa Srl (produttrice di fardellatrici) ha 10 milioni di debiti: 5 milioni con banche (di cui uno garantito da ipoteca sul capannone), 2 milioni con fornitori, 1 milione di debiti fiscali (inclusi 200k di IVA e 100k di ritenute) e 500k di contributi INPS, oltre ad altri debiti vari. Ha però ancora ordini e un organico specializzato. Ipotizziamo tre scenari possibili di gestione:
- Scenario A – Ristrutturazione negoziata e continuità: Alfa Srl avvia una composizione negoziata della crisi. Ottenute misure protettive dal tribunale, blocca i pignoramenti in corso. L’esperto la aiuta a formulare proposte: la banca ipotecaria accetta di allungare il mutuo residuo e ridurre il tasso, due banche chirografarie acconsentono a uno stralcio del 30% dei rispettivi crediti se pagate cash tramite l’ingresso di un nuovo socio finanziatore, diversi fornitori accettano pagamenti dilazionati su 2 anni rinunciando alle penali contrattuali. Il Fisco, grazie alla nuova norma, conclude un accordo transattivo: l’azienda paga il 50% del debito tributario (esclusa IVA) in 5 anni e la totalità dell’IVA in 2 anni; sanzioni azzerate. L’INPS purtroppo per legge non può stralciare il dovuto, ma concede il massimo della dilazione (5 anni) sulle somme. Alla fine Alfa Srl ha un pacchetto di accordi che coprono l’80% del monte debiti con adesioni. Per dare efficacia erga omnes, Alfa omologa un accordo di ristrutturazione (avendo oltre il 60% di crediti aderenti). In sede di omologa, l’Agenzia delle Entrate – che paradossalmente aveva votato no ritenendo insufficiente il 50% – si vede applicare il cram-down perché il tribunale verifica che in un fallimento prenderebbe forse il 20%. L’accordo omologato chiude la posizione debitoria: Alfa Srl riprende l’attività con un debito ridotto e sostenibile, evitando il fallimento.
- Scenario B – Concordato preventivo in continuità: la situazione è un po’ più tesa, le banche non sono unanimi nell’aderire stragiudizialmente e alcuni fornitori hanno già chiesto decreti ingiuntivi. L’azienda allora, assistita dai professionisti, presenta direttamente un concordato preventivo con continuità aziendale. Propone un piano a 5 anni: i creditori ipotecari (banche) saranno pagati integralmente (rifinanziando il debito magari con nuova finanza garantita dal Fondo centrale), i chirografari riceveranno il 40% in 4 anni, i crediti fiscali e contributivi ricevono un trattamento ad hoc (50% di soddisfacimento, eccetto IVA 100%) . I dipendenti sono salvi e l’attività prosegue. Al voto, banche e fornitori (la maggior parte) si dicono favorevoli perché preferiscono incassare 40 su 100 piuttosto che rischiare il fallimento. Erario e INPS votano contro, formalmente, chiedendo più garanzie. Tuttavia, in sede di omologazione, il tribunale applica l’art. 112 CCII: verifica che il piano dà a Erario e INPS almeno quello che avrebbero in liquidazione (diciamo il 30%), e quindi omologa il concordato nonostante il loro voto contrario . In forza del concordato omologato, tutti i debiti anteriori rimasti vengono stralciati secondo il piano e Alfa Srl può continuare l’attività (magari con un nuovo investitore entrato durante la procedura).
- Scenario C – Liquidazione con vendita dell’azienda: in questo scenario l’indebitamento e la mancanza di liquidità sono troppo gravi, e nessuno è disposto a finanziare la prosecuzione. L’imprenditore decide però di procedere ordinatamente. Presenta una domanda di concordato preventivo liquidatorio con una proposta: vendere l’intera azienda (impianti, avviamento, know-how, magazzino) a un competitor del settore disposto a pagarla, poniamo, €2 milioni; liquidare gli immobili non strategici e le partecipazioni entro 1 anno per altri €1 milione; e distribuire il ricavato ai creditori. Il piano stima che i creditori chirografari potranno così ricevere il 25% del dovuto – più di quanto otterrebbero in un fallimento (stimato 10-15%). Il tribunale ammette la procedura e autorizza – anzi prevede – la vendita diretta dell’azienda a quel compratore (il che preserva la continuità di fatto, trasferita al nuovo soggetto). I creditori votano il concordato liquidatorio; se la maggioranza approva, si procede all’omologa. Al termine, Alfa Srl viene liquidata e cancellata; i debiti sono estinti per la parte eccedente (non esigibile perché la società sparisce). Gli amministratori evitano il fallimento e relative conseguenze; l’azienda come complesso produttivo non va disperso ma prosegue in mano del compratore. Se invece i creditori non approvassero il 25%, il concordato non passerebbe e si andrebbe in liquidazione giudiziale: scenario peggiore per tutti.
Come si vede, la scelta della procedura influenza notevolmente l’esito. Un bravo consulente dovrà simulare questi scenari per consigliare all’imprenditore quale via offre il miglior bilanciamento tra salvataggio dell’attività, soddisfazione dei creditori e minimizzazione dei rischi personali.
Responsabilità personali degli amministratori e tutela del patrimonio personale
Un elemento cruciale, dal punto di vista del debitore, è capire se e quando i debiti aziendali possono “ricadere” sugli amministratori o sui soci. In una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.), vige in generale il principio della separazione patrimoniale: la società risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, e soci e amministratori non ne sono personalmente responsabili. Tuttavia, ci sono importanti eccezioni e aree di responsabilità che è bene conoscere:
Responsabilità civile verso i creditori sociali: gli amministratori di società possono essere chiamati a rispondere personalmente se, violando i propri doveri, hanno pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori, ossia hanno aggravato il passivo sociale rendendo insufficienti le risorse per pagare i debiti . Questo fondamento è nell’art. 2394 c.c. (per S.p.A.) esteso alle S.r.l. dall’art. 2476 c.c.: i creditori possono agire (di solito tramite il curatore fallimentare) contro gli amministratori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfarli a causa di mala gestio. Un caso tipico è la prosecuzione illecita dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (es. perdita totale del capitale sociale ex art. 2484 c.c.). In quella situazione gli amministratori dovrebbero astenersi da nuove operazioni e convocare i soci per ricapitalizzare o liquidare; se invece continuano ad operare aggravando il dissesto, possono dover risarcire il danno corrispondente all’aggravamento del passivo . La riforma del Codice della Crisi ha introdotto criteri presuntivi di quantificazione di questo danno: l’art. 2486 c.c. comma 3 (introdotto dall’art. 378 CCII) prevede che, salvo prova contraria, il danno risarcibile si calcola come differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si doveva cessare l’attività e il patrimonio netto alla data dell’apertura della liquidazione (il cosiddetto criterio dei “netti patrimoniali”). In parole semplici, se la società aveva patrimonio netto zero nel momento in cui si doveva fermare ma poi va in fallimento con un deficit di 1 milione, quel milione è il danno presunto a carico degli amministratori. Questo meccanismo è stato confermato di recente dalla Cassazione (sent. n. 5252/2024) come applicabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di criterio equitativo di valutazione del danno . Dunque, gli amministratori rispondono dei debiti non pagati ai creditori quando si prova che hanno aggravato la situazione invece di attivarsi tempestivamente. Il Codice della Crisi ha peraltro introdotto uno specifico dovere: all’art. 3 CCII si stabilisce che l’imprenditore collettivo deve adottare adeguati assetti organizzativi e contabili per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio per affrontarla. La violazione di questo dovere (ad esempio non dotarsi di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa, o ignorare gli indicatori di allerta) può costituire elemento di colpa grave. La Cassazione 2025 ha ribadito che anche gli amministratori non esecutivi (senza deleghe operative) non possono restare passivi: hanno l’obbligo di vigilare attivamente e intervenire di fronte a segnali evidenti di crisi, pena condividerne la responsabilità . In un caso del 2025, due consiglieri non operativi sono stati condannati perché non si attivarono nonostante bilanci con perdite macroscopiche, consentendo la prosecuzione illegittima dell’attività dopo la perdita del capitale .
Azione di responsabilità e patrimonio personale: se la società fallisce (liquidazione giudiziale), il curatore ha il potere di esercitare l’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci per conto di tutti i creditori (art. 146 l.fall., ora art. 255 CCII). Se l’azione viene accolta, gli amministratori possono essere condannati a risarcire un certo importo (spesso molto ingente) che entra nell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori. Il patrimonio personale degli amministratori è dunque a rischio in questi casi. Non solo: l’azione può essere esercitata anche dagli stessi creditori (se il curatore omette) o dalla società stessa prima del fallimento. È quindi essenziale che l’amministratore dimostri diligenza nella gestione, specialmente in fase di crisi: documentare di aver informato i soci e tentato di accedere a strumenti di composizione può aiutare a evitare imputazioni di inerzia. A tal riguardo, il Codice della Crisi prevede addirittura una sorta di “esimente organizzativa”: l’art. 2086 c.c. comma 2 (introdotto dall’art. 375 CCII) obbliga l’organo amministrativo a istituire assetti adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi ; un amministratore che lo fa e che convoca l’OCC o avvia una composizione negoziata nei tempi giusti difficilmente potrà essere accusato di colpa grave nel ritardo.
Responsabilità penale: sul fronte penale, i rischi per gli amministratori di un’azienda indebitata riguardano principalmente i reati fallimentari e i reati finanziari/fiscali. Se la società viene dichiarata fallita, i comportamenti precedenti degli amministratori saranno scrutinati: distrazioni di beni o risorse dall’azienda (es. prelievi ingiustificati di denaro, cessione di cespiti a prezzo vile a terzi) possono integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 322 CCII, ex art. 216 l.fall.), punita severamente con reclusione 3–10 anni. Anche aver occultato o falsificato le scritture contabili (per non far ricostruire il patrimonio) costituisce bancarotta fraudolenta documentale. Se invece l’amministratore non ha commesso atti di frode ma ha semplicemente aggravato la situazione per negligenza, può configurarsi la bancarotta semplice (art. 324 CCII, ex art. 217 l.fall.) punita più lievemente (fino a 2 anni). Un caso tipico è aver continuato ad assumere debiti sapendo di non poterli pagare: ciò è visto come ricorso abusivo al credito e rientra nella bancarotta semplice. La legge non punisce chi prova onestamente a salvare l’impresa (anzi, come visto, incoraggia a tentare concordati), ma sanziona chi ritarda colpevolmente il dissesto aumentando il danno. Dunque, un amministratore che invece di attivarsi ha continuato a fare nuovi ordini ai fornitori sapendo di essere insolvente rischia sanzioni penali. Anche atti come pagare preferenzialmente un creditore invece di altri poco prima del fallimento possono costituire bancarotta preferenziale (se fatti con dolo di favorire uno rispetto ad altri). In sintesi, comportarsi con trasparenza e tempestività è la miglior difesa: attivare per tempo le procedure di crisi non solo aiuta l’azienda ma tutela l’amministratore da accuse di mala gestio o peggio di bancarotta.
Garanzie personali e patrimonio dei soci: un altro ambito di potenziale responsabilità personale sono le fideiussioni e garanzie che l’imprenditore o i soci hanno prestato. Molto spesso le banche, per concedere credito alla società, chiedono ai soci/amministratori una fideiussione omnibus o una garanzia reale personale (ipoteca su casa, pegno su titoli personali). Se l’azienda non paga, la banca può agire direttamente contro i garanti, indipendentemente dalle procedure concorsuali. Tuttavia, vanno verificate le clausole di tali contratti di garanzia: le clausole standard ABI delle fideiussioni omnibus degli anni 2000, ad esempio, sono state dichiarate nulle per violazione della normativa antitrust (intese restrittive della concorrenza) dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 . Ciò significa che un amministratore che avesse firmato una fideiussione bancaria con quelle clausole potrebbe oggi eccepirne la nullità integrale o parziale, neutralizzando la propria esposizione verso la banca. Si tratta di questioni tecniche su cui conviene consultare un legale specializzato in diritto bancario: ma è un esempio di come difendersi personalmente dai debiti aziendali. Per il resto, i soci di S.r.l. e S.p.A. non rischiano il proprio patrimonio salvo abbiano assunto comportamenti specifici (ad esempio prelevato indebitamente beni sociali: in tal caso il curatore può fare azione di restituzione). Discorso diverso, come già detto, per i soci di società di persone: quelli sì rispondono illimitatamente e devono attendersi, in caso di insolvenza, di essere chiamati a pagare coi propri beni i debiti sociali rimasti scoperti (salvo poi liberarsi tramite l’esdebitazione personale).
Ricapitolando: l’azienda può fallire ma l’imprenditore onesto può risollevarsi grazie all’esdebitazione; tuttavia, se l’imprenditore amministra male, rischia di pagare di tasca propria i danni verso i creditori e di incorrere in sanzioni penali. Conviene quindi agire sempre con diligenza e trasparenza, rivolgersi a professionisti esperti quando la situazione degenera, e documentare ogni sforzo compiuto per contenere il dissesto (riunioni del CDA, consultazioni con advisor, ecc.). Il Codice della Crisi fornisce una sorta di scudo a chi si muove per tempo: ad esempio, se l’amministratore convoca l’OCC e segue le indicazioni dell’esperto, sarà difficile accusarlo di non aver fatto il possibile. Viceversa, chi ostacola la convocazione dell’assemblea o nasconde la crisi rischia grosso. Un’ultima nota: anche il collegio sindacale o il revisore, se presenti in azienda, hanno obblighi di segnalazione della crisi agli amministratori e, in casi estremi, al tribunale (art. 25-octies CCII). Se non li adempiono, possono concorrere nella responsabilità per i danni ai creditori. È quindi un gioco di squadra: quando i numeri iniziano a virare in rosso, tutti gli organi sociali devono attivarsi, o rischiare in proprio.
Domande frequenti (Q&A)
D: I debiti della società possono “andare in prescrizione” se aspetto senza pagarli?
R: È estremamente rischioso non pagare e sperare nella prescrizione. La prescrizione per debiti commerciali ordinari è 10 anni (5 anni per alcuni tributi locali, 3 anni per retribuzioni, ecc.), ma ogni atto di messa in mora o giudiziale interrompe il termine, facendolo ricominciare da capo. I creditori, specie banche e Fisco, difficilmente restano inattivi per anni: invieranno solleciti, decreti ingiuntivi, cartelle, ognuno dei quali impedisce la prescrizione. Inoltre, se anche un debito diventasse prescritto, va eccepito in giudizio: se il debitore non solleva la prescrizione in tribunale, il giudice non la applica d’ufficio. Quindi contare sulla prescrizione significa restare esposti ad azioni esecutive nel frattempo – che possono portare via beni vitali all’azienda. Meglio affrontare il problema diversamente (riconoscere il debito e rateizzarlo, oppure contestarlo formalmente se vi sono motivi).
D: Se presento una domanda di concordato preventivo, i creditori non potranno più aggredirmi?
R: Sì, l’ammissione al concordato comporta per legge il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali (art. 54 CCII, ex art. 168 l.fall.), quindi nessun creditore potrà iniziare o proseguire pignoramenti sui beni dell’azienda, né sequestri o simili . Inoltre, i fornitori non potranno interrompere forniture essenziali invocando insolvenze pregresse (c’è un divieto di esecuzione delle clausole risolutive nei contratti in corso, art. 94 CCII). Va però chiarito che la protezione inizia dal momento del deposito della domanda di concordato (o dalla pubblicazione del ricorso per misure protettive, se si chiede prima). Gli atti compiuti dai creditori prima restano validi (es: se un pignoramento è già avvenuto, verrà sospeso ma non annullato). E se il concordato poi sfocia in fallimento, quei creditori riprenderanno le azioni sul ricavato. Comunque, il concordato è uno scudo temporaneo molto efficace: dà respiro per attuare il piano. Attenzione però: non protegge eventuali coobbligati o fideiussori (art. 55 CCII, ex art. 184 l.fall.), quindi ad esempio se un socio aveva garantito un debito, la banca durante il concordato può agire contro di lui personalmente.
D: Se il concordato preventivo viene omologato, i debiti residui dell’azienda si cancellano?
R: Sì, in larga misura. L’omologazione del concordato vincola tutti i creditori anteriori e sostituisce le originarie obbligazioni con quelle previste nel piano . Ciò significa che, ad esempio, se un creditore chirografo vantava €100k e il concordato prevede il pagamento del 40%, quel creditore incasserà €40k e non potrà più pretendere il resto €60k: il suo credito si estingue per legge. I creditori privilegiati che nel piano vengano soddisfatti solo parzialmente (perché magari hanno rinunciato a qualcosa) perdono la parte rinunciata. Fa eccezione il caso dei garanti/persona: come detto, un garante estraneo (socio, terzo) non è liberato dall’omologa (a meno che i creditori abbiano espressamente rinunciato anche verso di lui). Inoltre, se la forma giuridica è una società, va notato che nel concordato liquidatorio la società poi si estingue e quindi i debiti residui “muoiono” con essa; nel concordato in continuità la società prosegue, ma quei debiti ormai sono giuridicamente estinti (l’azienda “ripulita” ne esce se rispetta il piano). Altra eccezione: debiti esattoriali per sanzioni. Le sanzioni amministrative pecuniarie (es. multe stradali, sanzioni antitrust) in teoria non sono falcidiabili più di tanto salvo nei limiti del concorso, ma nella pratica raramente vengono pagate integralmente nei concordati, e lo Stato accetta il parziale soddisfo de facto.
D: Quali sono le differenze principali tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale?
R: Riassumendo: nel concordato preventivo l’iniziativa è del debitore, che propone un piano e può restare alla guida (specie nel concordato in continuità) sotto la vigilanza di un commissario. I creditori votano e decidono se accettare di “tagliarsi” i crediti secondo il piano. Se tutto va bene, l’azienda evita il fallimento e può continuare (nei limiti del piano). Nella liquidazione giudiziale (fallimento) invece il processo è in mano al tribunale e al curatore: l’impresa viene spossessata e i creditori non hanno voce in capitolo sul se liquidare – viene liquidato tutto secondo la legge. I tempi di un concordato possono essere più brevi (il CCII impone di chiudere in 12 mesi dall’apertura, prorogabili di 6: art. 54 CCII) mentre un fallimento dura spesso più a lungo (anche se il CCII auspica 3 anni). Dal punto di vista dell’imprenditore, il concordato è meno afflittivo: ad esempio l’amministratore non subisce l’interdizione dai pubblici uffici né altre incapacità personali che invece scattano con la sentenza di fallimento. Anche a livello reputazionale c’è differenza: il concordato è visto come un tentativo di sistemare (richiede l’attestazione di un professionista, quindi è una soluzione seria), il fallimento come un collasso. Per contro, il concordato è costoso (bisogna pagare commissari, attestatore, spese legali) e complesso; il fallimento, pur con costi suoi, li spalma su tutta la procedura. Per i creditori, a volte il fallimento può portare azioni revocatorie o di responsabilità che incrementano l’attivo; nel concordato invece quel potenziale è in parte sacrificato (i creditori accettano meno in cambio di tempi più rapidi e continuità). In sintesi: concordato se c’è qualcosa da salvare e si vuole avere un ruolo proattivo; fallimento se non c’è nulla da fare o serve un intervento terzo imparziale.
D: La composizione negoziata è diversa dal vecchio “concordato in bianco”?
R: Sì, sono strumenti differenti. Il concordato in bianco (o con riserva) è semplicemente un modo per prenotare il concordato preventivo ottenendo subito protezione dai creditori e poi depositare il piano concordatario entro un termine . La composizione negoziata, invece, è un percorso stragiudiziale (l’autorità giudiziaria interviene solo marginalmente per le misure protettive) in cui un esperto aiuta a cercare un accordo con i creditori senza passare per voti e classi. Non c’è un “piano imposto” ai creditori né un effetto paragonabile all’omologa concordataria: se i creditori non vogliono accordarsi, la composizione negoziata semplicemente fallisce. È insomma un tavolo di negoziazione, favorito e protetto dalla legge, ma non una procedura concorsuale. Se durante la composizione negoziata si vede che non si arriverà a un accordo globale, l’imprenditore può “cambiare cavallo” e presentare un concordato preventivo vero e proprio (anche qui, magari prima depositando un ricorso con riserva per guadagnare protezione una volta cessate le misure protettive della composizione stessa). D’altra parte, la composizione negoziata ha un ambito temporale più ampio: può essere attivata già in fase di “pre-crisi” (quando l’insolvenza non c’è ancora ma iniziano squilibri). È quindi uno strumento di allerta precoce volontario, mentre il concordato presuppone uno stato di crisi o insolvenza conclamato.
D: Se l’azienda viene liquidata o fallisce, l’amministratore e i soci cosa rischiano in concreto?
R: Se si tratta di una società di capitali (s.r.l., s.p.a.): i soci di norma perdono il capitale investito ma non rispondono con i propri beni dei debiti sociali, salvo abbiano prestato garanzie personali o salvo casi di abuso di personalità giuridica (molto rari, richiedono frode). Gli amministratori, in caso di fallimento, possono subire: un’azione di responsabilità dal curatore che mira al loro patrimonio (come spiegato sopra, per mala gestio); l’apertura di un’indagine penale per bancarotta (se emergono atti distrattivi, irregolarità contabili, ecc.); inoltre saranno soggetti a misure come la ineleggibilità a nuove cariche se dichiarati responsabili del dissesto (le cosiddette pene accessorie fallimentari, oggi in parte riviste ma presenti). Tuttavia, se l’amministratore ha agito correttamente e la crisi deriva da cause oggettive, difficilmente verrà sanzionato: anzi potrebbe collaborare col curatore e non subire conseguenze rilevanti. Nel caso di società di persone (snc, sas): i soci illimitatamente responsabili (tutti nella snc, i soli accomandatari nella sas) sono essi stessi dichiarati falliti in estensione insieme alla società (art. 147 l.fall.), quindi il loro patrimonio personale entra nella procedura e potrà essere aggredito per soddisfare i creditori sociali . Avranno però poi diritto all’esdebitazione come persone fisiche se meritevoli. Per l’imprenditore individuale, vale lo stesso: fallisce lui come persona fisica e i suoi beni (presenti e futuri per 5 anni) rispondono ai debiti d’impresa, con possibilità di liberarsi dal residuo post-chiusura. In ogni caso, una volta aperta la liquidazione giudiziale o il concordato, gli atti dispositivi del patrimonio personale fatti prima dagli amministratori o soci possono essere oggetto di revocatoria fallimentare se pregiudizievoli (es: aver rimborsato un debito ai soci poco prima del fallimento, o aver venduto a un familiare un bene a prezzo irrisorio). Quindi, quello che rischiano soci e amministratori è in primis perdita economica (per investimento o per risarcimenti/danni), e in secondo luogo possibili sanzioni (civili o penali) se hanno gestito male. L’aspetto positivo è che la legge offre anche a loro vie d’uscita: l’esdebitazione per il debitore onesto e la non punibilità o attenuanti per chi non ha frodato e ha collaborato.
D: Abbiamo scoperto che la fideiussione bancaria firmata dal socio aveva clausole nulle (schema ABI). Possiamo non pagare la banca?
R: Le fideiussioni omnibus predisposte secondo lo schema ABI 2003 (con le famigerate clausole di reviviscenza, sopravvivenza, ecc.) sono state dichiarate nulle perché frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza fra banche . Questo significa che, in tribunale, il garante può far valere la nullità della fideiussione e liberarsi dall’obbligo, o comunque ridurne l’efficacia. Tuttavia non è un automatismo: bisogna vedere se la fideiussione specifica riproduce esattamente quelle clausole e far causa alla banca (o opporsi se la banca agisce, eccependo la nullità). Molte corti di merito stanno dando ragione ai garanti sulla scia della Cassazione. Quindi, sì, è possibile evitare di pagare se effettivamente la fideiussione è quella tipo ABI e il giudice riconosce la nullità: in tal caso la banca resta creditrice solo verso la società. Questo è un esempio di come il garante può difendersi. Attenzione che la nullità è integrale o di singole clausole a seconda dei casi; in molti contratti le banche hanno modificato le clausole dopo il 2005 per cercare di sfuggire alla censura. Conviene sicuramente far esaminare il testo da un legale.
D: L’azienda è in crisi ma ha una produzione valida: e se la vendessimo a una società concorrente?
R: Vendere l’azienda (intesa come complesso di beni e rapporti) può essere una soluzione per soddisfare i creditori e al contempo preservare la continuità aziendale sotto un altro imprenditore. Ci sono diversi modi: fuori dalle procedure, vendere l’azienda a un terzo richiede il prezzo adeguato per pagare i debiti, altrimenti i creditori potrebbero opporsi (soprattutto il Fisco, che in caso di cessione d’azienda con debiti tributari può rivalersi solidalmente sull’acquirente nei limiti dell’attivo ceduto, art. 14 D.Lgs. 472/97). Inoltre, i creditori non soddisfatti resterebbero comunque a carico della vecchia società. Invece, all’interno di un concordato preventivo o concordato semplificato, la vendita dell’azienda può essere fatta con l’autorizzazione del tribunale e libera l’acquirente dai debiti pregressi (l’azienda viene ceduta “pulita”, i debiti restano nella procedura a carico del ricavato). Questa è spesso la soluzione migliore: si individua un compratore, si concordano le condizioni (ad es. affitto d’azienda immediato e successivo acquisto), si presenta un concordato liquidatorio che prevede la cessione dell’azienda e la distribuzione del prezzo ai creditori. Se i creditori approvano, l’operazione si perfeziona e l’attività continua con il nuovo soggetto economico, mentre la vecchia società viene liquidata. Anche in fallimento si può vendere l’azienda, ma di solito il valore in fallimento è più basso perché subentra la disgregazione e l’urgenza della vendita all’asta. Insomma, vendere a un concorrente può essere ottimo, ma fatelo nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato) se i debiti sono molti: così eviterete rischi di azioni revocatorie o di responsabilità per aver leso par condicio.
D: Dopo la chiusura della procedura, se rimangono debiti non pagati, possono ancora perseguitarci?
R: Dipende dalla procedura e dal soggetto debitore. Per la società di capitali, dopo un concordato liquidatorio o un fallimento, i debiti residui non sono più esigibili perché la società si estingue (cessa la “persona” giuridica debitrice). In un concordato in continuità, la società sopravvive ma i debiti residui anteriori sono comunque “cancellati” dall’effetto esdebitatorio dell’omologa: i creditori non possono chiederli (salvo riavviare l’azione se il concordato viene risolto per inadempimento grave). Per la persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile), i debiti residui dopo la liquidazione giudiziale resterebbero in teoria a suo carico, ma qui interviene l’esdebitazione: l’imprenditore fallito, se ha collaborato e non ha commesso irregolarità gravi, viene liberato da tutti i debiti chirografari rimasti di diritto entro 3 anni dalla chiusura del fallimento (nel nuovo Codice la liberazione è quasi automatica, non serve neppure domanda, art. 278 CCII) . Dunque può ripartire senza quell’ombra. Anche chi chiude un concordato minore o un piano del consumatore è liberato dai debiti residui. Eccezioni: restano comunque dovuti dopo l’esdebitazione alcuni debiti peculiari come quelli di natura personale (obblighi di mantenimento, risarcimenti per danni da fatto illecito, multe penali) e le sanzioni amministrative, oltre ovviamente ai debiti che il concordato ha volontariamente lasciato impregiudicati (rarissimo). In ogni caso, i creditori non possono “perseguitare” l’ex fallito se c’è esdebitazione: il debito per legge si estingue. Un aspetto da ricordare: la garanzia ipotecaria o pignoratizia sopravvive alla procedura sull’oggetto della garanzia – quindi se ad esempio la casa del socio era ipotecata a garanzia di un debito sociale, e quella casa non è stata venduta nella procedura, la banca potrebbe escutere l’ipoteca anche dopo (perciò conviene far liquidare i beni in procedura per liberarsene, se possibile). Ma casi del genere sono particolari. In sintesi: l’obiettivo ultimo delle procedure di insolvenza è proprio cristallizzare i debiti e dare pace al debitore e ai creditori: chiudono una storia, nel bene o nel male.
Tabelle riepilogative
Di seguito, due tabelle riassumono i principali strumenti di gestione della crisi d’impresa e ne evidenziano le caratteristiche salienti, nonché le differenze rispetto alle procedure minori di sovraindebitamento per soggetti non fallibili.
Tabella 1 – Strumenti per la ristrutturazione o liquidazione delle imprese (soggette a fallimento)
| Strumento | Tipo | Chi può accedervi | Caratteristiche principali | Effetti per i creditori |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII) | Procedura stragiudiziale assistita (riservata) | Imprese in stato di crisi (anche pre-crisi) ma non insolventi irreversibili. Attivabile volontariamente dall’imprenditore. | Nomina di un Esperto indipendente tramite la Camera di Commercio. L’impresa resta in gestione al debitore. Possibile chiedere al Tribunale misure protettive (blocco delle azioni esecutive). L’Esperto facilita la ricerca di accordi con i creditori. Durata iniziale 3+3 mesi. | Nessun effetto vincolante automatico. Si punta ad accordi consensuali (privati) con i creditori. Se si raggiunge un accordo globale, può essere formalizzato in un piano attestato o accordo omologato. Se fallisce, l’impresa può accedere ad altre procedure senza sanzioni. Durante la procedura, grazie alle misure protettive, i creditori non possono agire (se autorizzato). |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Accordo privato con protezione limitata (esenzione revocatoria) | Imprese in crisi reversibile. Richiede l’accordo almeno dei principali creditori (tipicamente banche). | Piano di risanamento con evidenza di equilibrio futuro, asseverato da un professionista indipendente (attestatore). Non passa dal tribunale (solo registrazione facoltativa). Gli atti esecutivi del piano non sono revocabili in fallimento . | Vincola solo i creditori aderenti. I terzi estranei non sono toccati (possono agire se non pagati). Non c’è moratoria legale: eventuali sospensioni pagamenti vanno contrattate. Utile per accordi “mirati” con banche o partner strategici. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR, art. 57 e ss. CCII) | Procedura concorsuale semplificata (richiede omologa tribunale) | Imprese in crisi o insolvenza non troppo estesa. Devono ottenere l’adesione di almeno il 60% dei crediti totali (o 30% se accordo “agevolato” con soli finanziari). | Contratto di ristrutturazione con parte dei creditori, corredato da piano e attestazione di fattibilità. Si deposita in Tribunale per l’omologazione. Possibile chiedere misure protettive già con ricorso “in bianco”. Varianti: ADR con estensione (vincola anche dissenzienti di una classe omogenea, se 75% di quella classe ha aderito), ADR agevolato (30%). Include transazione fiscale eventuale. Durata: breve (120 giorni max per raccogliere adesioni dal ricorso). | I creditori aderenti sono vincolati nei termini dell’accordo; i non aderenti restano fuori (ma non possono intralciare fino a 60 giorni post-omologa). Dopo l’omologa, l’azienda paga i debiti secondo l’accordo; i creditori estranei possono riprendere azioni individuali sui loro crediti (ma se l’accordo va a buon fine, spesso vengono comunque soddisfatti per evitare default). Novità: con il cram-down fiscale, il Tribunale può omologare l’accordo anche senza adesione del Fisco/INPS se è garantito il “pari trattamento” rispetto alla liquidazione . |
| Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII) | Procedura concorsuale giudiziale (con voto creditori) | Imprese soggette a fallimento in stato di crisi o insolvenza. Anche grandi imprese. Ammissibile se piano fattibile e, se liquidatorio, almeno 20% ai chirografari. | Proposta di piano ai creditori, con suddivisione in classi (se eterogenei) e eventuale suddivisione tra continuità e liquidazione. Voto dei creditori per classi o in massa (maggioranze: 50% crediti se no classi, altrimenti 2/3 per classe) . Controllo del Tribunale all’ammissione e all’omologa. Vari tipi: in continuità diretta o indiretta (azienda prosegue, eventualmente ceduta a terzi), oppure liquidatorio (tutti i beni venduti). Possibile concordato con riserva iniziale. Commissario giudiziale nominato a vigilare durante la procedura. | Se omologato, il concordato vincola tutti i creditori anteriori , anche dissenzienti, secondo i termini del piano. I crediti subiscono le eventuali decurtazioni e dilazioni proposte e non possono più essere richiesti oltre quanto previsto. L’omologa comporta esdebitazione per la società debitrice (che però se liquida si estingue). Durante la procedura, azioni esecutive sospese. In caso di esito negativo (mancata approvazione o mancata omologa), di solito si apre la liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità l’azienda prosegue sotto vigilanza e i contratti possono continuare; nel liquidatorio l’attività cessa salvo affitto d’azienda transitorio. Cram-down fiscale: tribunale può omologare anche con voto contrario di Fisco/INPS se piano ≥ scenario liquidatorio . |
| Liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss. CCII) | Procedura concorsuale liquidatoria (fallimento) | Imprese (anche piccole, se superano soglie fallibilità) e soci illimitatamente responsabili, in stato di insolvenza accertato. Avvio su istanza di creditore, debitore o d’ufficio (PM). | Il Tribunale dichiara la liquidazione (sentenza) e nomina un Curatore. L’impresa perde la disponibilità dei beni (che passano al curatore). Viene formato lo stato passivo dei crediti. Il curatore liquida i beni singolarmente o in blocco (possibile esercizio provvisorio se utile). Procedura svolta sotto controllo del giudice delegato e del Comitato creditori. Obiettivo: conversione di tutto in denaro e riparto ai creditori secondo prelazioni. Può chiudersi per insufficienza di attivo, oppure con riparti finali e decadenza delle obbligazioni insoddisfatte. Tempi medi: variabili (il CCII auspica <3 anni). | I creditori sono soddisfatti in moneta fallimentare (riparti percentuali) secondo l’ordine delle cause di prelazione. Tutti i debiti pregressi non producono più interessi (salvo ipotecari entro limiti di valore bene). I creditori non possono più agire individualmente: devono insinuarsi al passivo e attendere i riparti. Possono però promuovere azioni collettive tramite il curatore (es: istanze di revoca di atti di disturbo, azioni di responsabilità). Al termine, la società debitrice viene cancellata e i debiti residui si estinguono con essa. I creditori insoddisfatti non hanno ulteriori rimedi contro la società; possono però escutere eventuali garanti o soci illimitatamente responsabili. Se il debitore è persona fisica, può ottenere l’esdebitazione dei residui (fresh start) . |
Tabella 2 – Procedure minori per debitori non fallibili (sovraindebitamento)
| Procedura sovraindebitamento | Destinatari | Modalità | Effetti finali |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (art. 67 CCII) | Persone fisiche consumatori (debiti personali, non d’impresa) sovraindebitati. | Proposta di ristrutturazione dei debiti rivolta al Tribunale, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Niente voto creditori: decide il Giudice se omologare, valutando la fattibilità e la meritevolezza del consumatore (che non deve aver colposamente creato il sovraindebitamento). | Se omologato, vincola tutti i creditori chirografari e anche privilegiati per la parte eventualmente falcidiata. Il consumatore esegue il piano (es. paga mensilmente una somma per 5 anni). Debiti residui cancellati al 100% a fine piano (esdebitazione completa) . |
| Concordato minore (art. 74 CCII) | Imprenditori sotto-soglia, startup innovative, ex soci di società insolventi, professionisti, piccoli agricoltori, ecc. in sovraindebitamento. | Procedura simile a un concordato preventivo ma semplificata: il debitore propone un piano a tutti i creditori, gestita dall’OCC come commissario. Creditori votano (maggioranza dei crediti ammessi senza classi). Il Tribunale omologa se maggioranza raggiunta (o può bypassare dissenso in certi casi di convenienza). | Effetti analoghi al concordato preventivo: tutti i creditori anteriori sono vincolati e soddisfatti secondo il piano. Il debitore mantiene la propria attività (se c’è continuità) sotto vigilanza OCC. Al termine, se il debitore è persona fisica, i debiti residui chirografari sono cancellati (esdebitazione). Per le società minori, se si estinguono vale come sopra. |
| Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII) | Qualsiasi debitore non fallibile insolvente (anche consumatore). Spesso scelta in mancanza di un piano di rientro sostenibile. | Il debitore (o anche un creditore/PM) chiede la liquidazione del patrimonio. Il Tribunale nomina un Liquidatore (di solito l’OCC) che vende tutti i beni del debitore e soddisfa i creditori secondo prelazioni. Procedura analoga al fallimento ma più semplice e con esenzioni da revocatoria per atti di necessità. | I creditori ottengono riparti proporzionali sul ricavato, secondo privilegio. Il debitore persona fisica, una volta liquidato tutto il possibile, ottiene di diritto l’esdebitazione dei debiti residui senza bisogno di ulteriore domanda (salvo comportamenti fraudolenti) . In sostanza è un “fallimento personale” con perdono finale dei debiti onesti. |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019 aggiornato. OCC = Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento. OCRI = Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa, previsto dal Codice ma di fatto sostituito dalla composizione negoziata nel 2021. Protezione = misure di sospensione di azioni esecutive. Cram-down = omologazione forzata nonostante dissenso di una classe o del Fisco.)
Conclusioni
Un’azienda di macchine fardellatrici automatiche indebitata può intraprendere diversi percorsi per difendersi e cercare di superare la crisi. La soluzione “giusta” dipende dalla specifica combinazione di fattori: l’entità dei debiti, la natura dei creditori (se prevalgono banche, Fisco, fornitori), le prospettive del mercato e la volontà dell’imprenditore di proseguire l’attività. In ogni caso, attendere passivamente è la scelta peggiore: l’ordinamento offre oggi strumenti avanzati per gestire la crisi d’impresa, ma richiede che l’imprenditore li attivi tempestivamente e con trasparenza.
Dal semplice piano di rientro dilazionato col Fisco, passando per accordi stragiudiziali mirati, fino ai più strutturati concordati preventivi o accordi di ristrutturazione, abbiamo visto che esiste un vero e proprio “arsenale” di strumenti. Molte volte, una combinazione intelligente di essi porta al miglior risultato (ad es. composizione negoziata per fermare le esecuzioni e negoziare, seguita da un concordato per coinvolgere tutti i creditori). Il punto di vista del debitore deve però anche considerare i rischi personali: un imprenditore informato saprà evitare comportamenti che possano causare responsabilità civile o penale, preservando il proprio patrimonio personale e la propria libertà d’azione anche dopo la crisi.
In sintesi, difendersi dai debiti aziendali significa: agire presto, farsi assistere dai professionisti giusti, scegliere lo strumento legale adeguato e rispettarne le regole, negoziare ove possibile ma essere pronti a passare sotto l’egida del tribunale se necessario. Un’azienda specializzata e di nicchia come quella di macchine fardellatrici può avere un valore intrinseco (know-how, clientela, macchinari) che sarebbe un peccato disperdere in un fallimento: con gli strumenti di allerta e ristrutturazione oggi disponibili, c’è spesso la possibilità di salvarla, magari ridimensionata ma ancora operativa. E anche quando ciò non fosse fattibile, una liquidazione guidata e concordata permette di chiudere dignitosamente, riducendo l’impatto sui creditori e sull’imprenditore stesso. Questa guida ha fornito le coordinate avanzate per orientarsi in tali scelte.
Ricordiamo infine l’importanza di rivolgersi a consulenti esperti in crisi d’impresa: ogni caso ha sfumature giuridiche e di fatto che vanno valutate attentamente (ad esempio la presenza di pegni, di crediti verso la PA, di contenziosi pendenti, ecc.). Le norme sono in continua evoluzione – basti pensare alle novità del 2024 in ambito di transazione fiscale e obblighi di segnalazione – quindi un aggiornamento costante è d’obbligo. Con la giusta strategia e conoscenza dei propri diritti, anche una situazione debitoria pesante può essere gestita e risolta, permettendo all’imprenditore di difendersi efficacemente e, auspicabilmente, di tornare a concentrarsi sul proprio business una volta superata la tempesta.
Fonti (normativa e giurisprudenza)
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in vigore dal 15 luglio 2022, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, e dal terzo correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). Ha introdotto le procedure di allerta (poi sostituite dalla composizione negoziata) e riformato completamente il diritto concorsuale, con nuovi strumenti di ristrutturazione e norme sul cram-down fiscale . Articoli citati: artt. 12-25 CCII (Composizione negoziata della crisi), 23 c.2-bis CCII (Accordo con Fisco nella composizione negoziata) , 54 CCII (effetti protettivi nel concordato), 56 CCII (Piani attestati di risanamento), 57-64 CCII (Accordi di ristrutturazione: standard, agevolati, ad efficacia estesa, con moratoria), 63 CCII (Transazione fiscale nei concordati/accordi) , 65-81 CCII (Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione).
- Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (sovraindebitamento): la “legge salva-suicidi”, ora abrogata e confluita nel CCII dal 2022 . Stabiliva tre procedure (accordo con creditori, piano del consumatore, liquidazione patrimonio) per debitori non fallibili, introducendo i concetti di meritevolezza ed esdebitazione del debitore civile onesto. I principi base sono stati mantenuti nel Codice della Crisi (con qualche modifica, es. voto nel concordato minore, automatismi nell’esdebitazione).
- Codice Civile (disciplina societaria): artt. 2086 c.c. (dovere di assetti organizzativi adeguati, introdotto dall’art. 375 CCII) ; 2392-2393 c.c. e 2476 c.c. (responsabilità amministratori verso la società e soci); art. 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali per insufficienza patrimoniale); art. 2485-2486 c.c. (obblighi in caso di perdita capitale e divieto di nuove operazioni; criteri liquidazione danno – introdotto comma 3 dall’art. 378 CCII) ; artt. 2476 c.6 e 2486 c.3 c.c. applicabili alle S.r.l. (azioni di responsabilità e criteri di quantificazione del danno).
- Leggi tributarie e di riscossione: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 (Rateazione delle cartelle esattoriali) , come modificato dal D.Lgs. 30 agosto 2023, n. 110 (riforma riscossione attuativa L. 111/2023) e dal D.M. MEF 27.12.2024 (nuovi parametri piani di dilazione dal 2025). Definizioni agevolate recenti: D.L. 34/2023 conv. L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater” 2023, saldo stralcio di sanzioni e interessi). Norme sulle procedure concorsuali e fisco: art. 182-ter l.fall. (transazione fiscale) confluito in art. 63 CCII; D.L. 125/2020 conv. L. 159/2020 (ha introdotto cram-down fiscale poi trasfuso nel CCII). Norme su IVA e ritenute non pagate: il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute in concordato è stato superato dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale (Cass. SU 8504/2021) e ora dal combinato artt. 112 e 88 CCII (possibile omologa nonostante dissenso Erario se soddisfazione ≥ liquidazione) .
- Normativa penal-tributaria e previdenziale: D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate, soglia €150.000) e art. 10-ter (Omesso versamento IVA, soglia €250.000); art. 10-quater (indebita compensazione crediti fiscali). Legge 24/11/1981 n. 689, art. 116-bis come modif. (reato omesso versamento contributi INPS oltre €10.000 annui, depenalizzato se sotto soglia) . Dlgs 8/2016 e D.L. 19/2020 hanno inasprito sanzioni per importi maggiori.
- Corte Costituzionale: sentenza n. 87/2025 (dep. 26 giugno 2025) – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sull’art. 147 l.fall. (fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili), confermando che la mancata convocazione del socio accomandante in sede di istruttoria fallimentare non viola il diritto di difesa . Decisione rilevante per confermare la prassi nel fallimento esteso alle società di persone.
- Cassazione Civile:
- Cass., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150: in tema di sovraindebitamento, ha sancito la legittimità di moratorie ultrannuali nel pagamento di crediti privilegiati (es. imposte) nei piani del consumatore, purché i creditori abbiano la possibilità di esprimersi sulla dilazione . Si supera così il precedente limite rigido di 1 anno (art. 8 c.4 L.3/2012 abrogata).
- Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782: ha confermato la possibilità del cram-down fiscale nel concordato preventivo . Principio di diritto: il tribunale può omologare il concordato anche in caso di voto contrario del Fisco o degli enti previdenziali, se il piano garantisce loro una soddisfazione almeno pari a quella ottenibile dalla liquidazione fallimentare . Ciò chiarisce definitivamente che non serve la mera astensione erariale: anche col voto negativo dell’Erario, l’omologa forzata è possibile nei concordati, consolidando un orientamento favorevole alla conservazione dell’impresa.
- Cass., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6358: ha ribadito che la presentazione di domanda di concordato preventivo non impedisce la decadenza da una definizione agevolata o rateizzazione fiscale in corso . In pratica, se prima del concordato il debitore aveva un piano di dilazione con l’Agenzia Riscossione e non l’ha terminato, l’accesso al concordato fa decadere quel piano e tutto il debito va trattato nella procedura. Importante per coordinare piani fisco e procedure concorsuali.
- Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504: (decisione storica in materia di transazione fiscale) – ha affermato il primato dell’interesse concorsuale alla continuità aziendale rispetto all’interesse erariale al pieno incasso. Ha statuito che nei concordati il tribunale può valutare la convenienza della proposta per l’Erario e omologare anche senza il suo consenso, anticipando di fatto il cram-down poi normato .
- Cass., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252: ha chiarito l’applicabilità immediata del nuovo criterio del “netto patrimoniale” (art. 2486 c.3 c.c.) anche ai giudizi di responsabilità pendenti alla data di entrata in vigore del CCII . Ha ribadito che tale norma non introduce una presunzione a carico del convenuto ma un criterio legale di liquidazione equitativa del danno, destinato al Giudice . Questa pronuncia consolida l’orientamento per cui agli amministratori convenuti è ammessa la prova contraria (danno inferiore), ma in difetto di prova il giudice deve utilizzare il delta patrimonio netto come misura del risarcimento.
- Cass., Sez. I, 20 novembre 2025, n. X [ordinanza]: (richiamata per analogia) ha confermato la responsabilità degli amministratori non esecutivi per omessa vigilanza in presenza di segnali di crisi . In particolare, ha affermato che anche i consiglieri privi di deleghe hanno l’obbligo di attivarsi (dovere di agire informati ex art. 2381 c.c.) quando i risultati aziendali sono drasticamente peggiori del piano, e sono responsabili in solido dei danni da illegittima continuazione dell’attività . Caso in cui due consiglieri sono stati ritenuti colpevoli per non aver impedito l’aggravamento del dissesto dopo perdita del capitale (criterio di calcolo danno: differenza netti patrimoniali applicato).
- Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2019, n. 34447: (antitrust – fideiussioni) ha dichiarato nulle per contrarietà alla normativa anticoncorrenza (intesa restrittiva ex art. 2 L. 287/90) le clausole uniformi predisposte dall’ABI nei contratti di fideiussione omnibus a garanzia di obbligazioni bancarie . Ha aperto così la via ai debitori garanti per eccepire in giudizio la nullità (totale o parziale) delle fideiussioni basate sul modulo ABI 2003, liberandoli dall’obbligo di pagamento. Questo principio è stato applicato da molte corti di merito nelle cause tra banche e fideiussori.
La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene macchine fardellatrici automatiche, fardellatrici termo-retraibili, confezionatrici industriali, sistemi di imballaggio automatizzati, linee di fine linea, nastri trasportatori, saldatrici, sistemi di avvolgimento o macchine per packaging alimentare e industriale è in difficoltà per colpa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene macchine fardellatrici automatiche, fardellatrici termo-retraibili, confezionatrici industriali, sistemi di imballaggio automatizzati, linee di fine linea, nastri trasportatori, saldatrici, sistemi di avvolgimento o macchine per packaging alimentare e industriale è in difficoltà per colpa dei debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore del packaging automatico è complesso e costoso: componenti elettronici e meccanici onerosi, assistenza tecnica continua, magazzino impegnativo, progetti su misura e forti anticipi di produzione.
Basta un ritardo nei pagamenti o una riduzione dei fidi per generare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può ancora essere salvata, se agisci subito e con metodo.
Perché un’Azienda di Fardellatrici Va in Debito
- aumento dei costi di PLC, sensori, motori, resistenze, film plastici e componenti meccanici
- ritardi nei pagamenti di clienti industriali e contractor
- magazzino immobilizzato tra ricambi, elettroniche, gruppi motore, film e saldature
- investimenti in R&D, collaudi, software e assistenza tecnica
- costi di trasporto, montaggio e avviamento impianti
- linee di credito bancarie ridotte o revocate
Il problema principale non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di macchine, ricambi e strumenti tecnici
- impossibilità di completare consegne, collaudi e assistenze
- perdita di clienti fondamentali e reputazione
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con l’intervento di un avvocato specializzato puoi fermare pignoramenti, bloccare rientri urgenti e proteggere i conti aziendali.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molti debiti contengono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per crisi più complesse:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende con debiti.
Le sue competenze includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Inserito negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un mix di competenze che lo rende tra i più efficaci in Italia nel bloccare i creditori, ridurre i debiti e proteggere le aziende del settore packaging.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, ricambi e linee di produzione
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di macchine fardellatrici automatiche non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, concreta e mirata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- proteggere produzione, assistenza e magazzino
- salvare la continuità aziendale
Agisci ora, prima che la situazione peggiori.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.