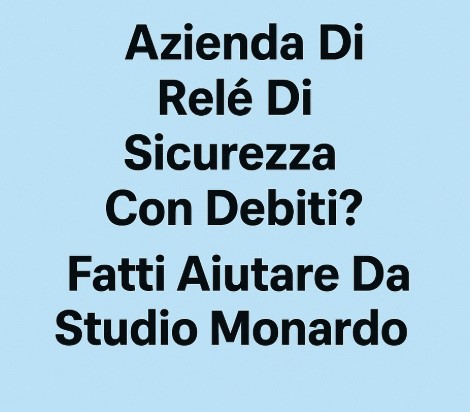Se gestisci un’azienda che realizza impermeabilizzazioni industriali, impermeabilizzazioni di capannoni, coperture civili e agricole, rifacimenti di tetti, trattamenti anticorrosione, isolamenti, sigillature e interventi speciali su superfici complesse, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la tua attività è concretamente a rischio.
Il settore delle impermeabilizzazioni richiede materiali specifici (guaine, membrane, resine, poliurea, prodotti bituminosi), manodopera specializzata, attrezzature costose, rigorose procedure di sicurezza e tempi di intervento stretti. Un blocco dovuto ai debiti può fermare cantieri, creare ritardi critici, generare infiltrazioni, contestazioni, penali e farti perdere imprese edili, proprietari di capannoni, industrie e amministratori di immobili.
La buona notizia è che puoi ancora difenderti, ridurre i debiti e salvare la tua azienda, se intervieni subito con la strategia corretta.
Perché le aziende di impermeabilizzazione per industrie e capannoni accumulano debiti
Le cause principali sono:
- costi elevati per memebrane, guaine, resine, poliurea, primer, isolanti e materiali speciali
- rincari dei prodotti bituminosi, dei chimici e dei materiali tecnici
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, aziende e amministrazioni immobiliari
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi e materiali con scadenza o condizioni di stoccaggio delicate
- investimenti continui in attrezzature, sicurezza in quota, mezzi e DPI
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli dei cantieri
- fornitori strategici che chiedono pagamenti anticipati o rapidi
Questi fattori possono trasformarsi rapidamente in crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
È essenziale agire subito. Ecco le prime azioni concrete:
- fai analizzare l’intera situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verifica quali debiti sono legittimi e quali possono essere contestati, ridotti o prescritti
- evita piani di rientro o rateizzazioni che non riusciresti a sostenere
- richiedi la sospensione immediata di pignoramenti o procedure esecutive in corso
- valuta rateizzazioni realmente sostenibili con Agenzia delle Entrate e INPS
- metti in sicurezza fornitori e materiali critici (guaine, resine, membrane, isolanti)
- previeni il blocco del conto corrente e la riduzione dei fidi bancari
- utilizza gli strumenti legali disponibili per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Solo una valutazione professionale ti permette di capire quali debiti ridurre, sospendere o contestare davvero.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni in tempo, i rischi diventano pesanti:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di attrezzature, mezzi, pompe, spruzzatori e macchinari per applicazioni speciali
- blocco delle forniture di guaine, membrane, resine e materiali fondamentali
- impossibilità di completare lavori su capannoni, industrie o tetti civili
- perdita di imprese edili, clienti aziendali e amministratori di immobili
- danni alla reputazione professionale e contestazioni legali per infiltrazioni
- crisi di liquidità e difficoltà a pagare dipendenti e fornitori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Nel settore delle impermeabilizzazioni anche un piccolo ritardo può causare infiltrazioni immediate e danni ingenti ai clienti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può:
- bloccare subito pignoramenti e altre azioni esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative mirate con Fisco, INPS e creditori privati
- ottenere rateizzazioni sostenibili basate sui reali flussi di cassa
- far annullare debiti irregolari, prescritti o calcolati in modo scorretto
- negoziare con banche e fornitori per evitare sospensioni delle forniture
- proteggere attrezzature, materiali, mezzi e continuità operativa
- stabilizzare la situazione mentre l’azienda ristruttura i propri debiti
- evitare procedure concorsuali e rischio di insolvenza
Una strategia legale ben studiata può fare la differenza tra chiusura e rilancio dell’impresa.
Come evitare il blocco dell’attività
Per non fermare la tua azienda devi:
- intervenire subito, non quando è troppo tardi
- evitare di trattare da solo con i creditori
- proteggere materiali e fornitori essenziali
- ristrutturare i debiti prima che arrivino pignoramenti o blocchi bancari
- contestare debiti irregolari o non più esigibili
- concentrare la liquidità su cantieri strategici e interventi a maggiore redditività
Così puoi evitare fermi, penali, danni gravi e perdita di clienti chiave.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo immediatamente se:
- hai ricevuto cartelle, intimazioni, avvisi o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS, banche o fornitori sono diventati ingestibili
- temi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità sta scendendo rapidamente
- i fornitori minacciano di sospendere materiali o consegne
- ritieni che la situazione possa portare alla chiusura dell’impresa
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e riportare stabilità alla tua attività.
Attenzione
Molte aziende del settore impermeabilizzazioni non falliscono per l’ammontare dei debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e proteggere davvero il futuro della tua azienda.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e tutela di imprese edili, industriali e specializzate – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di impermeabilizzazione industrie e capannoni.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Gestire un’azienda specializzata in impermeabilizzazioni per industrie e capannoni può comportare l’assunzione di obbligazioni finanziarie significative. Quando tali obbligazioni diventano debiti insostenibili, l’imprenditore si trova ad affrontare un complesso scenario legale e strategico. In Italia, esistono strumenti sia giudiziali che stragiudiziali per difendersi dai creditori, salvaguardare la continuità aziendale ove possibile, oppure gestire in modo ordinato la crisi d’impresa. Questa guida offre un approfondimento avanzato – aggiornato a ottobre 2025 – su come un’azienda debitrice può tutelarsi, con un focus particolare sul punto di vista del debitore.
Il taglio è pratico e giuridico al contempo: adotteremo un linguaggio tecnico ma divulgativo, adatto tanto a professionisti legali quanto a imprenditori e privati interessati. Verranno analizzate le principali tipologie di debiti (tributari, previdenziali, verso fornitori, bancari, derivanti da appalti pubblici o privati, ecc.) e per ciascuna si illustreranno i rischi e le strategie di difesa disponibili. Si esamineranno poi le soluzioni stragiudiziali (come rinegoziazioni e transazioni) e quelle giudiziali (dalle opposizioni individuali alle procedure concorsuali del nuovo Codice della Crisi d’Impresa).
Troverete inoltre tabelle riepilogative per un confronto immediato delle opzioni e una sezione di Domande & Risposte con casi pratici simulati riguardanti solo la normativa italiana. In fondo, è presente una sezione con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate (sentenze recentissime della Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e provvedimenti normativi) per approfondire ogni aspetto con riferimenti autorevoli. L’obiettivo è fornire una guida completa, oltre 10.000 parole, evitando il ricorso a contenuti preconfezionati e garantendo originalità nell’esposizione (scongiurando qualsiasi problema di plagio).
Nota: La situazione di riferimento – un’azienda italiana (ad esempio, una SRL) operante nelle impermeabilizzazioni industriali con debiti in varie aree – serve da filo conduttore, ma le indicazioni fornite valgono in generale per qualsiasi forma societaria. Il punto di vista assunto è quello del debitore: come proteggere l’azienda e i suoi amministratori dall’aggressione dei creditori, come uscire dalla crisi o quantomeno gestirla minimizzando i danni.
Nei paragrafi successivi inizieremo esaminando i diversi tipi di debito che un’azienda può accumulare e i rimedi specifici per ciascuno.
1. Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi
Non tutti i debiti sono uguali: la natura del creditore e del credito influenzano le modalità con cui il debitore può essere escusso e le difese attivabili. Qui distinguiamo le principali categorie di debiti aziendali:
- Debiti tributari verso l’Erario (Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione), ad esempio per imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) o cartelle esattoriali pendenti.
- Debiti previdenziali verso enti come INPS e INAIL, dovuti a contributi non pagati o premi assicurativi omessi.
- Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali privati, derivanti da forniture di beni/servizi non pagate.
- Debiti bancari e finanziari, quali esposizioni su prestiti, mutui o scoperti di conto.
- Debiti da appalti pubblici o privati, che possono includere somme da restituire per penali contrattuali, importi dovuti a subappaltatori, o revoche di pagamenti da parte di enti pubblici a causa di irregolarità contributive dell’azienda.
Ogni tipologia comporta strumenti di riscossione diversi da parte dei creditori e richiede quindi strategie difensive specifiche. Di seguito analizziamo in dettaglio ciascuna categoria.
1.1 Debiti tributari (Erario e Agenzia Entrate-Riscossione)
I debiti tributari includono imposte non versate (IVA, imposte sui redditi, IRAP), ritenute non corrisposte, sanzioni e interessi derivanti da controlli fiscali, nonché le cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). Questi debiti sono particolarmente insidiosi perché la legge fornisce al Fisco poteri speciali di riscossione. Vediamo i punti chiave:
- Titoli esecutivi e atti del Fisco: se l’azienda omette il pagamento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme dovute e AdER emette la cartella di pagamento. In casi di controllo fiscale, prima della cartella vi sarà un avviso di accertamento impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla giustizia tributaria. In altri casi (ad esempio omessi versamenti dichiarati) la cartella è il primo atto. La cartella notifica il debito e, se non viene pagata entro 60 giorni, diviene esecutiva consentendo al riscossore di agire. È fondamentale verificare sempre la regolarità della notifica degli atti (le notifiche inesistenti o viziate possono rendere annullabile la cartella). Tuttavia, l’orientamento attuale restringe le possibilità di impugnazione diretta: la Corte Costituzionale, sent. n. 190/2023 ha confermato la legittimità dei limiti alla contestazione immediata del ruolo o della cartella conosciuti solo tramite estratto di ruolo, auspicando però un intervento legislativo che ampli le tutele. In sostanza, oggi non è ammessa l’impugnazione “preventiva” dell’estratto di ruolo (cioè del mero elenco dei debiti), a meno che il debitore provi un pregiudizio attuale (ad es. l’impossibilità di partecipare a gare d’appalto ex art. 80 Codice Appalti o di incassare crediti da PA ex art. 48-bis DPR 602/1973). Ciò impone al contribuente di attendere un atto esecutivo (pignoramento, fermo, ipoteca) per far valere certi vizi, con evidente compressione delle garanzie di difesa.
- Azioni di recupero: AdER ha facoltà di attivare procedure esecutive senza bisogno di passare dal giudice: ad esempio può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore (previo preavviso), disporre il fermo amministrativo dei veicoli (cosiddetta “ganascia fiscale”), e procedere al pignoramento di conti correnti, crediti verso terzi (es. clienti) o beni mobili e immobili. Tali azioni possono avvenire ex lege dopo 60 giorni dalla notifica della cartella se il debito non è stato pagato né validamente impugnato. Il quadro normativo tutela però l’abitazione principale del debitore: dal 2013, l’art. 76 DPR 602/1973 proibisce ad AdER di espropriare l’unico immobile di proprietà adibito ad abitazione principale (non di lusso) del debitore persona fisica. La Cassazione ha chiarito che questa impignorabilità della prima casa si applica anche ai pignoramenti già in corso all’entrata in vigore della norma, imponendo la cessazione della procedura e la cancellazione del pignoramento se ricorrono i requisiti (unico immobile, non di lusso, residenza del debitore). Restano possibili, tuttavia, l’ipoteca sull’immobile e l’espropriazione di altri beni immobili diversi dalla prima casa (previa iscrizione di ipoteca e per debiti sopra €120.000, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione).
- Prescrizione dei debiti tributari: La normativa è complessa e varia a seconda del tributo. Spesso si applica la prescrizione ordinaria decennale dopo la definitività del debito tributario, ma la giurisprudenza recente è orientata verso termini più brevi di natura quinquennale per molti crediti tributari (in analogia ai contributi previdenziali, v. infra) in assenza di atti interruttivi. La legge ha lacune sul punto, colmate dal ricorso ai principi civilistici. Occorre distinguere dalla decadenza: ad esempio, per notificare la cartella da un avviso serve rispettare termini decadenziali. Un aspetto importante è che richiedere e ottenere una dilazione di pagamento non costituisce acquiescenza definitiva al debito, né impedisce in futuro di contestarne la legittimità: la Cassazione ha ribadito che la mera richiesta di rateazione non equivale a un riconoscimento incontestabile del debito e non preclude eccezioni sull’“an debeatur” (esistenza del dovuto). Inoltre, un pagamento parziale non accompagnato dall’indicazione che è effettuato “in acconto” non viene considerato rinuncia a contestare il restante, né automaticamente un riconoscimento ai fini interruttivi della prescrizione. Dal 2021, tuttavia, il legislatore ha stabilito che la semplice domanda di rateazione sospende la prescrizione durante l’esame della richiesta (art. 19 co. 1-quater DPR 602/1973, mod. dal DL 146/2021).
- Difese e strumenti per il debitore fiscale: Davanti a una pretesa fiscale, il debitore ha varie opzioni di difesa:
- Impugnazione in sede tributaria: se arriva un avviso di accertamento o una cartella (quando è primo atto), l’azienda può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni. Nel ricorso si possono far valere vizi formali (notifica, motivazione), sostanziali (insussistenza del tributo, prescrizione, ecc.) e documentare i motivi per cui il debito non è dovuto o va ridotto. Va valutato attentamente ogni atto: ad esempio, un vizio di notifica dell’accertamento può rendere nulla la cartella successiva. Attenzione: con la riforma del contenzioso tributario (L. 130/2022) i giudici tributari sono ora magistrati professionali e sono state introdotte novità come il giudizio di rinvio ai mediatori e l’estensione delle definizioni agevolate delle liti pendenti. Se la materia è complessa, è consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista, anche perché il ricorso richiede, oltre certi valori, la firma di un difensore abilitato.
- Sospensione giudiziale: Contestualmente al ricorso tributario, si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato se vi è pericolo di danno grave e irreparabile (ad es. imminente esecuzione) e fondati motivi. Se concessa, l’Agente della riscossione non potrà procedere fino alla decisione.
- Autotutela e sgravio: In parallelo (ma senza garanzia di esito) si può presentare istanza di autotutela all’ente creditore (Es. Agenzia Entrate) evidenziando errori palesi nell’atto, chiedendone l’annullamento o correzione. L’autotutela non sospende i termini di ricorso né l’obbligo di pagare, ma talvolta l’ente riconosce l’errore e annulla la cartella (sgravio).
- Rateizzazione ordinaria: Se il debito è dovuto ma non si è in grado di pagarlo in unica soluzione, AdER consente piani di dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a €120.000, anche senza necessità di dimostrare difficoltà economica. Importi maggiori o situazioni di grave crisi possono portare ad autorizzare fino a 120 rate (10 anni) in casi straordinari. Con le modifiche introdotte dalla “Riforma della riscossione” (D.Lgs. 29/07/2024 n. 110), le condizioni di rateazione sono diventate più flessibili e indulgenti: ad esempio, è aumentato il numero massimo di rate possibili e sono previste modalità per riattivare dilazioni decadute (pagando le rate scadute). La dilazione accordata ha l’effetto di bloccare nuove azioni esecutive, purché il debitore rispetti i pagamenti concordati. Importante: essere in regola con una rateazione consente di ottenere il DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e non essere considerato inadempiente verso la PA, il che è cruciale se l’azienda opera con appalti pubblici (vedremo oltre l’impatto del DURC).
- Definizioni agevolate (“rottamazioni” e “stralci”): Negli ultimi anni il legislatore, tramite le leggi di bilancio, ha spesso introdotto misure di “pace fiscale” che permettono di estinguere i debiti iscritti a ruolo a condizioni favorevoli. Ad esempio, la “Rottamazione-quater” 2023 (L. 197/2022) ha consentito di pagare le cartelle 2000-2017 senza sanzioni né interessi di mora, rateizzando in 18 rate fino al 2027. Per il 2024-2025 è in discussione una “Rottamazione-quinta (V)”, già prevista in bozza nella Legge di Bilancio 2026, che coprirà i carichi affidati fino al 31/12/2023 e consentirà pagamento del solo tributo (niente sanzioni né interessi) in un massimo di 54 rate distribuite fino al 2035. Durante la procedura di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza e stand still azioni esecutive e cautelari (no nuovi fermi/ipoteche, no nuovi pignoramenti). Inoltre, finché si è in regola con il pagamento delle rate rottamazione, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini di eventuali compensazioni con crediti verso la PA (art. 48-bis DPR 602/1973) e può ottenere il DURC regolare. Si tratta dunque di strumenti preziosi per un’azienda in crisi di liquidità, da cogliere quando disponibili. All’ottobre 2025, la Rottamazione-quater si è conclusa (la scadenza per la domanda era il 30/6/2023) mentre la Rottamazione V è prevista ma non ancora operativa (domande presumibilmente entro aprile 2026).
- Transazione fiscale nelle procedure concorsuali: Se l’azienda accede a una procedura di composizione della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, ecc., v. sezione 4), la normativa consente di includere i debiti fiscali in un accordo denominato transazione fiscale, offrendo il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte e contributi. Un tempo la transazione fiscale era considerata straordinaria perché l’Erario tendeva a non accettare falcidie; oggi è integrata nel sistema. Il Codice della Crisi 2019 e successive modifiche (specie il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024) ne hanno ampliato l’ambito, seppur con alcuni limiti anti-abuso. In particolare, il Correttivo 2024 ha previsto che nei piani di ristrutturazione omologati (accordi e concordati) il giudice possa negare l’omologa se l’indebitamento fiscale supera l’80% del totale indebitamento dell’impresa ed è frutto di un uso sistematico del mancato versamento tributi come autofinanziamento surrettizio. Ciò mira a evitare che imprenditori disinvolti accumulino quasi solo debiti fiscali confidando di scaricarli poi sui creditori pubblici. In ogni caso, la transazione fiscale richiede che la proposta al Fisco sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (deve offrire al fisco almeno quanto otterrebbe in caso di fallimento dell’impresa); tale convenienza va attestata da un professionista indipendente e valutata dal tribunale.
In sintesi, i debiti tributari vanno gestiti con tempestività: contestando gli atti infondati, sfruttando piani di pagamento e “finestre di tregua fiscale” quando disponibili, e tenendo presente che ignorare il Fisco porta a conseguenze rapide (pignoramenti, fermi, ecc.) difficili da ribaltare ex post. Nel frattempo, non bisogna aggravare la posizione penale: ricordiamo infatti che alcuni omessi versamenti costituiscono reato. In particolare l’omesso versamento IVA oltre €250.000 per anno (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) e l’omesso versamento di ritenute fiscali oltre €150.000 (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) sono fattispecie penali. Per i contributi previdenziali omessi (parte datoriale sulle retribuzioni), se l’importo supera €10.000 annui scatta il reato ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983 (punito con reclusione fino a 3 anni o multa) – su questo punto la Corte Costituzionale nel 2025 ha confermato la legittimità del doppio binario sanzionatorio (amministrativo sotto 10k, penale sopra). Dunque, se l’azienda ha omesso versamenti di tale natura, è fondamentale correre ai ripari: il ravvedimento operoso con pagamento integrale prima della contestazione penale può estinguere il reato (nel caso dell’IVA e ritenute fiscali, entro la dichiarazione dell’anno successivo o prima dell’inizio del dibattimento, a seconda dei casi; per i contributi, entro 3 mesi dalla contestazione). In ogni caso, rivolgersi a un legale per valutare le soglie penali e le opportune mosse è indispensabile.
1.2 Debiti previdenziali (contributi INPS, INAIL)
Un’azienda con dipendenti (o iscritta a gestioni previdenziali artigiani/commercianti) può trovarsi con debiti previdenziali per omissione o insufficienza nel versamento di contributi obbligatori all’INPS (pensionistici) o all’INAIL (premi assicurativi contro gli infortuni). Questi debiti, pur essendo verso enti pubblici, presentano caratteristiche peculiari: – Titoli e riscossione: L’INPS può emettere un Avviso di Addebito (AA) con valore di titolo esecutivo immediato per crediti contributivi. L’Avviso di Addebito viene notificato al debitore e, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, consente all’INPS (tramite AdER) di procedere coattivamente, analogamente alla cartella esattoriale. In alternativa, per crediti affidati fino a qualche anno fa, l’INPS può iscrivere a ruolo i contributi non versati, portando all’emissione di una cartella contributiva da parte di AdER. In entrambi i casi, dopo la notifica l’ente può agire in via esecutiva con pignoramenti e misure cautelari (ipoteche, fermi) come per i tributi. Anche qui è cruciale controllare le notifiche: se un avviso di addebito non è stato notificato regolarmente, l’eventuale pignoramento potrà essere opposto per far valere il vizio. – Giurisdizione competente: Le opposizioni a pretese contributive seguono regole diverse da quelle tributarie. In generale, le controversie su contributi previdenziali (obbligo di pagamento, cartelle INPS, avvisi di addebito) rientrano nella cognizione del Giudice del Lavoro (Tribunale ordinario, sezione lavoro), in quanto materia assistenziale/previdenziale. Si applicano i termini e le modalità dell’opposizione a decreto ingiuntivo o dell’opposizione all’esecuzione, a seconda dei casi: ad esempio, per contestare nel merito un Avviso di Addebito INPS, il debitore deve proporre opposizione ai sensi della L. n. 689/1981 (che richiama il processo del lavoro) entro 40 giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Se invece il contribuente intende far valere l’estinzione del debito o vizi formali di atti successivi (pignoramento, ecc.), può proporre opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. al giudice dell’esecuzione. Questa duplicazione giurisdizionale è complessa; in pratica, gli atti dell’INPS possono essere oggetto sia di ricorsi amministrativi interni (in prima battuta l’azienda può presentare ricorso amministrativo agli organi INPS, come il Comitato Provinciale, ma si tratta di rimedi facoltativi e non sospensivi) sia di cause giudiziarie. È altamente consigliabile, appena emerge un debito contributivo contestato, farsi assistere da un legale per scegliere il percorso giusto (es: ricorso giudiziario tempestivo per evitare decadenze). – Prescrizione contributi: I contributi previdenziali godettero in passato di prescrizioni decennali in talune ipotesi, ma interventi normativi e giurisprudenziali hanno uniformato i termini. In particolare, la L. 335/1995 aveva introdotto la prescrizione quinquennale per i contributi dovuti dagli iscritti obbligatori; successivi interventi (L. 402/1996, DL 384/1992) avevano mantenuto termini lunghi per contributi da omissioni accertate d’ufficio. La Corte Costituzionale (sent. n. 294/2017) ha però dichiarato illegittima la proroga a 10 anni per i contributi in determinati casi, affermando che tutti i contributi previdenziali sono soggetti a prescrizione in 5 anni, salvo atti interruttivi. Di conseguenza, dal 2018 in poi l’INPS applica il termine quinquennale in via generale. La Cassazione ha confermato orientamenti in tal senso: cinque anni dal momento in cui il contributo è dovuto, interrotti eventualmente da atti legittimamente notificati al debitore. Occorre però fare attenzione: una diffida accertativa o un verbale di accertamento ispettivo regolarmente notificati interrompono la prescrizione e fanno decorrere un nuovo termine (che rimane di 5 anni). Inoltre, contributi minori (es. contribuzioni a casse professionali) possono avere regole proprie. Per l’azienda debitrice, controllare se il credito INPS è prescritto è una prima linea difensiva importante, da far valere nell’opposizione in giudizio. – Strumenti di regolarizzazione: Molto simili a quelli fiscali, con alcune particolarità: – Rateazione INPS: L’INPS consente dilazioni dei debiti contributivi (in genere fino a 24 rate mensili, estensibili a 36 in casi eccezionali, o 60 rate per somme ingenti con autorizzazione ministeriale). Per ottenere la rateazione, l’azienda deve presentare domanda motivando la temporanea difficoltà e offrendo garanzie se richieste. Una volta concessa la dilazione, l’INPS rilascia il DURC regolare a condizione che le rate vengano pagate puntualmente. Questo aspetto è cruciale: se l’azienda opera in edilizia o appalti, avere un DURC irregolare (per contributi non pagati o rate scadute) comporta l’esclusione dalle gare pubbliche e può causare la risoluzione di contratti in corso con la Pubblica Amministrazione. Dunque, aderire a un piano di rientro contributivo è spesso l’unico modo per proseguire l’attività senza essere tagliati fuori dal mercato pubblico e senza incorrere in sanzioni civili (come il pagamento dell’intero appalto agli operai in caso di inadempienza contributiva). – Sgravi e sanatorie: Anche per i contributi esistono talvolta condoni o agevolazioni. Ad esempio, la L. 197/2022 (Bilancio 2023) ha disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 affidati ad AdER dal 2000 al 2015 (lo “stralcio” dei micro-debiti), che ha incluso molti crediti INPS di modesto importo: dal 31 marzo 2023 tali debiti sono stati cancellati senza bisogno di domanda. Inoltre, il “saldo e stralcio” 2019 per contribuenti persone fisiche in difficoltà ha permesso di estinguere debiti contributivi con percentuali ridotte. Attualmente, la rottamazione-quater ha incluso contributi in cartella (senza sanzioni e interessi). La eventuale rottamazione V menzionata includerà anche i contributi affidati entro il 2023. Vale dunque quanto detto per il Fisco: monitorare le normative di periodo perché possono offrire vie d’uscita più favorevoli. – Opposizione a sanzioni civili: I debiti contributivi crescono con sanzioni civili (interessi e penali per ritardato pagamento) spesso molto elevate. In sede giudiziaria, qualora l’azienda versi il dovuto in ritardo ma prima della sentenza, può chiedere al giudice la riduzione delle sanzioni civili al tasso legale (in luogo del ben più alto tasso di dilazione/mora normalmente applicato), ex art. 116, co. 15, L. 388/2000. Ciò può diminuire sensibilmente l’importo finale dovuto. – Transazione previdenziale: Nelle procedure concorsuali, parallelamente alla transazione fiscale, esiste la transazione dei debiti contributivi con INPS/INAIL. Oggi è disciplinata anch’essa dal Codice della Crisi (artt. 63 e 88 CCII per accordi e concordati) e permette di proporre il pagamento parziale dei contributi dovuti. Il correttivo 2024 ha equiparato il trattamento dei crediti previdenziali a quello tributario in molte sedi, pur escludendoli dall’accordo semplificato in composizione negoziata (comma 2-bis art. 23 CCII riguarda solo il Fisco, escludendo enti previdenziali). Comunque, in concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, l’INPS può aderire a piani di falcidia dei suoi crediti, fermo restando il rispetto della regola di convenienza (non peggior sorte rispetto alla liquidazione).
- Profili penali specifici: Abbiamo già accennato all’omesso versamento di ritenute previdenziali > €10.000 annui come reato. Va ricordato che tale reato si perfeziona quando il datore non versa, entro il termine di legge, le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Se l’azienda ha difficoltà, potrebbe essere tentata di pagare i netti ai lavoratori “rinviando” il versamento dei contributi trattenuti: ciò è illecito oltre la soglia. Esiste però causa di non punibilità se il datore versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dall’accertamento della violazione. Dunque, qualora l’INPS notifichi un avviso di addebito per ritenute omesse, l’azienda (o meglio il legale rappresentante su cui ricade la responsabilità penale) dovrebbe reperire le somme e pagare al più presto, per evitare il procedimento penale. La Cassazione penale ha più volte ribadito che la crisi di liquidità non esime dalla punibilità, salvo i casi di forza maggiore rigorosamente intesi. Pertanto, anche dal punto di vista del debitore, la priorità dovrebbe essere versare i contributi trattenuti ai dipendenti, prima ancora di altri debiti, per non incorrere in conseguenze penali personali.
1.3 Debiti verso fornitori e altri creditori privati
Le obbligazioni commerciali verso fornitori di beni o servizi costituiscono una parte fisiologica dell’attività d’impresa. Tuttavia, se l’azienda versa in difficoltà, queste obbligazioni possono accumularsi in ritardi di pagamento e diventare debiti scaduti. I fornitori e gli altri creditori privati (ad esempio professionisti, consulenti, locatori di immobili aziendali per i canoni non pagati, ecc.) hanno a disposizione le ordinarie azioni civili per il recupero dei loro crediti.
Mezzi di tutela dei creditori commerciali: in genere, se un debitore azienda non paga una fattura entro la scadenza pattuita, il fornitore: – Può inviare solleciti di pagamento e messe in mora formali (art. 1219 c.c.) tramite PEC o raccomandata, intimando il pagamento e preannunciando azioni legali. La messa in mora interrompe la prescrizione (che per i crediti commerciali è di 5 anni, salvo eccezioni) e fa decorrere gli interessi moratori. – Se il credito è documentato (es. da fatture, DDT firmati, contratto) e liquido, il creditore può richiedere un decreto ingiuntivo al tribunale competente. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento monitorio che ingiunge al debitore di pagare entro 40 giorni, salvo opposizione, e che può essere emesso inaudita altera parte (senza sentire il debitore) in base a prove scritte del credito (artt. 633 ss. c.p.c.). Se il giudice ritiene sufficiente la documentazione (ad es. fattura più estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.), emette il decreto. Esso va notificato al debitore, il quale ha appunto 40 giorni per pagare o proporre opposizione. Trascorso tale termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo equiparato a una sentenza. – In situazioni di particolare urgenza o pericoli nel recupero, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sin dall’emissione (ex art. 642 c.p.c.) – ad esempio se vanta cambiali o assegni impagati, oppure se il credito riguarda forniture di merci e ha un principio di prova scritto. Ciò consente di iniziare subito il pignoramento senza attendere i 40 giorni.
Difese del debitore verso i decreti ingiuntivi: dal punto di vista dell’azienda debitrice, ricevere un decreto ingiuntivo è un campanello d’allarme grave. Occorre valutare: – Se il credito è effettivamente dovuto nella misura ingiunta (magari ci sono contestazioni sulla qualità della fornitura, o errori di conteggio, o il credito è parzialmente compensabile con un controcredito verso il fornitore). – Se vi sono motivi formali per contestare il decreto (ad esempio, notifica viziata, incompetenza territoriale del giudice, mancanza dei requisiti per l’ingiunzione). – In tal caso, entro 40 giorni dalla notifica va proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo davanti allo stesso tribunale (ma con atto di citazione in opposizione). L’opposizione apre un giudizio a cognizione piena, in cui l’originario debitore diventa attore opponente e il creditore diventa convenuto opposto. Il giudice potrà, su istanza dell’opponente, sospendere l’esecutorietà provvisoria del decreto se ricorrono gravi motivi, oppure – se il decreto non era stato munito di esecutorietà iniziale – concederla al creditore in corso di causa se l’opposizione appare pretestuosa. – Nel merito del giudizio di opposizione, si discute come in una normale causa civile sul credito. È un’opportunità per il debitore di far valere eccezioni e difese (ad es. merce contestata, lavori non conformi, prescrizione del credito, nullità contrattuali, ecc.). Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 26727 del 15.10.2024) hanno chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative o aggiuntive rispetto a quelle fatte valere col ricorso monitorio, purché fondate sullo stesso interesse sostanziale sotteso alla pretesa originaria. In sostanza, la Suprema Corte ha ammesso una certa flessibilità: il creditore, pur non potendo ampliare arbitrariamente il petitum, può ad esempio trasformare la domanda di adempimento contrattuale in una di arricchimento senza causa subordinata, o aggiungere una pretesa correlata, se tutto attiene alla medesima vicenda sostanziale. Questo per evitare eccessivi formalismi e favorire la definizione completa della controversia in sede di opposizione. Per il debitore opponente, ciò significa prestare attenzione: l’opposizione potrebbe non limitarsi a ritardare il dovuto ma portare a una rivisitazione (ad esempio il creditore potrebbe chiedere interessi di mora maggiori, o diverse forme di tutela). Conviene dunque che l’opposizione sia basata su motivi solidi e, preferibilmente, che nel frattempo si tenti un accordo transattivo col creditore, se l’insolvenza è momentanea. – Se l’azienda non si oppone entro 40 giorni, il decreto diventa definitivo: a quel punto sarà difficilissimo contestare il credito (l’unica via residuale sarebbe chiedere la revocazione del decreto per vizi gravissimi tipo dolo o prova falsa, oppure opporre la prescrizione sopravvenuta se il creditore tardasse oltre 10 anni a eseguirlo, ma sono situazioni eccezionali). Quindi ignorare un decreto ingiuntivo è altamente sconsigliato; meglio trovare un accordo col creditore oppure presentare almeno un’opposizione per guadagnare tempo e margine di manovra.
Esecuzione forzata da parte di fornitori: Una volta munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto, sentenza, o scrittura privata di credito se dichiarata esecutiva ex art. 474 c.p.c.), il creditore privato può procedere a esecuzione sui beni dell’azienda debitrice. Tipicamente: – Pignoramento mobiliare presso la sede aziendale: l’ufficiale giudiziario può recarsi in azienda ed elencare macchinari, attrezzature, arredi, da mettere all’asta. In pratica, però, i beni mobili usati hanno spesso scarso valore e la loro vendita forzata produce poco (salvo beni di pregio). – Pignoramento presso terzi: strumento molto usato. Il creditore intima ad esempio alla banca dove l’azienda ha il conto corrente di bloccare le somme disponibili (pignoramento di conti) oppure ad un cliente debitore della nostra azienda di non pagarle ma versare a disposizione della procedura (pignoramento di crediti). Questo può paralizzare l’operatività aziendale (conto bloccato) e aggravare la crisi. – Pignoramento immobiliare: se l’azienda possiede immobili (es. il capannone) e il debito è consistente, il creditore può iscrivere ipoteca giudiziale (dopo aver ottenuto il titolo) e avviare l’espropriazione. Tuttavia, le banche sono spesso in posizione prioritaria su tali immobili con ipoteche volontarie; un fornitore chirografario avrà convenienza solo se ci è capienza nel valore.
Difese del debitore nell’esecuzione: Dal lato dell’impresa debitrice: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se si vuole contestare il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché il debito è già stato pagato, o perché il titolo è stato ottenuto per frode, o altri fatti estintivi successivi alla formazione del titolo. In sede di opposizione all’esecuzione si può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice, ma occorrono prove forti sull’inesigibilità del credito. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se invece si riconosce il debito ma si riscontrano vizi formali nella procedura esecutiva (es: il pignoramento è nullo perché notificato in modo errato, o l’atto di precetto è viziato), si può opporre specificamente quell’atto entro termini brevissimi (5 giorni dalla notifica per gli atti dell’ufficiale giudiziario, 20 giorni per il precetto dalla notifica). – Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al dovuto (comprensivo di spese e interessi), anche a rate (fino a 36 mesi con interesse). Questo richiede comunque di reperire liquidità o garanzie. – Accordo con il creditore: in qualsiasi momento, anche a esecuzione iniziata, il debitore può trattare col creditore (magari offrendo un pagamento parziale immediato) per fargli rinunciare alla procedura. Spesso i creditori sono disponibili a transigere, specie se intravedono che l’esecuzione si prospetta lunga o infruttuosa.
Rischio di istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale): Va evidenziato che un creditore, anche di modesta entità, ha facoltà – ricorrendone i presupposti – di presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) dell’impresa debitrice. In base all’art. 121 del Codice della Crisi (già art. 5 legge fall.), lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. Tradizionalmente, un debito non pagato e una esecuzione infruttuosa potevano costituire presupposto per il fallimento. La soglia di rilevanza però è limitata: oggi non si può aprire la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti sono inferiori a €30.000 (art. 2 co.1 lett. c CCII). Tuttavia molti fornitori superano insieme questa cifra. Quindi, se l’azienda accumula ritardi gravi, c’è il rischio concreto che uno o più creditori tentino la via concorsuale, specie se percepiscono che l’impresa sta collassando (magari creditori strategici come fornitori di materie prime o subappaltatori preoccupati di perdere tutto). Difendersi da un’istanza di fallimento significa convincere il tribunale che non sussiste insolvenza oppure che è già in corso una procedura di soluzione della crisi (es. un concordato preventivo presentato prima, che blocca le istanze individuali). Torneremo su questo nella parte dedicata alle procedure concorsuali (sezione 4).
In conclusione per i debiti verso fornitori: dal lato del debitore, la strategia migliore è preventiva. Mantenere un dialogo con i fornitori, concordare piani di rientro in via stragiudiziale (magari garantiti da pagherò o piani d’importo decrescente) può evitare l’escalation a decreti ingiuntivi e pignoramenti. Una volta scattato il meccanismo giudiziale, la posizione del debitore si indebolisce e le possibilità di manovra si riducono (soprattutto per i costi che lievitano con spese legali e interessi di mora elevati, che ex D.Lgs 231/2002 per le transazioni commerciali sono generalmente alti).
1.4 Debiti bancari e finanziari
Molte aziende operano grazie a finanziamenti esterni: affidamenti bancari, linee di credito di conto corrente, mutui ipotecari su immobili aziendali, leasing finanziari per macchinari o veicoli, anticipi fatture e altre forme tecniche. Quando l’impresa va in crisi di liquidità, tende a utilizzare al massimo gli affidamenti, spesso sforando, e può arrivare all’insolvenza verso le banche: rate di mutuo non pagate, scoperti oltre fido, interessi non corrisposti. I crediti bancari hanno natura privata ma sono spesso garantiti e i contratti contengono clausole risolutive espresse. Di conseguenza: – La banca, in caso di insolvenza o anche semplice peggioramento del merito creditizio, può revocare gli affidamenti a breve termine (fidi in conto, castelletto anticipo fatture, ecc.), trasformando all’istante lo scoperto in debito esigibile. Può inoltre segnalare l’evento in Centrale Rischi, aggravando la reputazione creditizia dell’impresa. – Per i mutui o finanziamenti rateali, dopo un certo numero di rate non pagate (di solito due consecutive, ma può variare), scatta la decadenza dal beneficio del termine: la banca può esigere l’intero capitale residuo immediatamente. – Se il credito è garantito da ipoteca su beni (spesso il capannone aziendale o immobili dei soci/familiari dati in garanzia) la banca può procedere col pignoramento immobiliare relativamente rapidamente, senza dover andare in tribunale per ottenere il titolo (in quanto il mutuo è solitamente un contratto notarile esecutivo). Basterà notificare un atto di precetto e poi il pignoramento. – Se vi sono fideiussioni personali dei soci o di terzi (circostanza comune: molte banche ottengono fideiussioni omnibus dei garanti), la banca potrà escutere contestualmente i garanti per l’intero importo, aggredendo il loro patrimonio personale (case, conti, stipendio). I garanti sono co-obbligati solidali: non è necessario per la banca escutere prima la società e poi il garante; può scegliere la via più fruttuosa.
Difendersi dai crediti bancari presenta complessità: – Spesso il debito è certo e liquido (deriva da contratti firmati, estratti conto). Se l’azienda non ha pagato, contestare l’“an debeatur” è difficile, a meno di eccepire irregolarità contrattuali (ad es: interessi usurari o anatocistici, commissioni non dovute, invalidità di clausole). Negli anni passati c’è stato contenzioso sull’usura bancaria: se i tassi applicati (sommando interessi corrispettivi, moratori e spese) superano la soglia di usura, il debitore può contestare la nullità delle clausole di interessi e pagare solo il capitale. La Cassazione ha chiarito, con orientamenti del 2017-2020, che gli interessi moratori vanno considerati separatamente dai corrispettivi per valutare l’usura, ma se i moratori superano soglia, si riducono al tasso legale (non si annulla l’intero contratto). In ogni caso, queste eccezioni vanno sollevate in giudizio e richiedono perizie tecniche. Sono strumenti difensivi che possono avere successo, ma occorre un’attenta valutazione specialistica (analisi dei conti corrente, conteggio interessi, ecc.). – Un altro fronte è la verifica delle fideiussioni omnibus: molte banche utilizzavano in passato schemi contrattuali uniformi (schema ABI 2003) che l’Autorità Antitrust e Banca d’Italia hanno censurato come anticoncorrenziali (provvedimento Bankitalia 55/2005). La Cassazione (Sez. Unite n. 41994/2021) è intervenuta sulla questione delle fideiussioni conformi allo schema ABI vietato: ha affermato la nullità parziale delle clausole incriminate (clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ecc.), mantenendo però efficace il contratto per il resto. In sostanza, il garante può invocare la nullità di quelle clausole, ma ciò tipicamente non lo libera dall’intera garanzia: ottiene solo che, ad esempio, la banca non possa pretendere la sopravvivenza della fideiussione per obbligazioni future dopo l’adempimento, o non possa invocare la rinuncia al beneficio del termine decadenziale. Quindi, come difesa totale la questione ABI spesso non salva il fideiussore, ma può limitare l’importo dovuto o far cadere richieste tardive. Va comunque esaminata da un legale: se la garanzia è antecedente e ricalca le clausole vietate, una contestazione mirata può mettere pressione alla banca nella trattativa. – Azioni esecutive: se la banca ha ipoteca su un immobile dell’azienda o del socio, il pignoramento immobiliare segue le norme ordinarie ma con qualche particolarità: la banca ha un privilegio ipotecario di grado generalmente elevato, quindi anche in sede di eventuale concordato preventivo o fallimento, il suo credito è prededucibile dal ricavato dell’immobile. Il debitore può rallentare la procedura alzando eccezioni procedurali (es. contestare la validità della notifica del precetto, o proporre una rateizzazione prima dell’asta – ma in sede esecutiva classica le dilazioni non sono riconosciute, salvo accordo col creditore). – Negoziazione con la banca: Spesso, la strada più proficua è trattare. Le banche hanno interesse a ristrutturare il debito se intravedono possibilità di recuperare col tempo e se la crisi aziendale è reversibile. Si possono negoziare: – Piani di rientro: l’azienda propone di pagare gradualmente il debito su base mensile/trimestrale, magari con un periodo di preammortamento. Ciò richiede presentare alla banca un piano finanziario credibile (spesso con l’ausilio di un professionista). – Moratorie: in periodi di crisi sistemica (ad es. durante la pandemia) c’erano moratorie generali. Fuori da questi, a volte l’ABI e le associazioni imprenditoriali concordano moratorie volontarie per PMI (sospensione temporanea delle quote capitale dei mutui). Verificare se esistono iniziative in tal senso può aiutare. – Rinegoziazione tassi e condizioni: in cambio di garanzie aggiuntive (es. garanzia Fondo PMI statale, o ipoteche su ulteriori beni), la banca può allungare la durata del mutuo, abbassare la rata corrente. – Accordi transattivi a saldo e stralcio: se l’azienda è ormai compromessa e magari prossima alla liquidazione, può capitare che la banca accetti una percentuale a stralcio, specie se il debito è chirografario e la prospettiva altrimenti è il fallimento con incognita di recupero. Questi accordi di solito richiedono un one-off (pagamento immediato di una parte, spesso ottenuto da terzi o vendite di asset). – Procedure giudiziali concorsuali: qualora la situazione sia acuta, l’azienda può coinvolgere le banche in procedure di regolazione della crisi (si veda la sezione 4). Ad esempio: – Negoziare un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ex art. 57 CCII) con le banche principali: se si raggiunge un accordo con creditori finanziari rappresentanti almeno il 60% dei debiti, il tribunale può estenderne gli effetti anche agli eventuali dissenzienti della stessa categoria e proteggerlo da azioni individuali. – In un concordato preventivo, presentare un piano che preveda o la continuità aziendale (con pagamento parziale dei debiti finanziari nel tempo) o la liquidazione con vendita dei beni e soddisfazione parziale dei creditori (le banche ipotecarie avranno prelazione sul ricavato degli immobili). – Utilizzare la composizione negoziata: dal 2021 è attivo uno strumento per facilitare accordi stragiudiziali con la supervisione di un esperto terzo (approfondito più avanti). La composizione negoziata spesso vede coinvolte primariamente le banche, in quanto creditori cruciali: l’esperto può persuaderle a concordare dilazioni o nuovi finanziamenti prededucibili se l’azienda ha prospettive di risanamento. – Tutela del patrimonio personale del titolare: se l’impresa è individuale o società di persone, i creditori bancari possono aggredire direttamente i beni personali dell’imprenditore o dei soci. Se è una SRL, in teoria il patrimonio dei soci è separato, ma attenzione: come detto, di frequente le banche chiedono fideiussioni ai soci o ai coniugi. Dunque i beni personali (come la casa di abitazione dei soci) possono essere a rischio. Valgono i limiti di pignorabilità della prima casa già discussi? Per i creditori privati (banche) non c’è un divieto analogo a quello del Fisco: la prima casa del debitore non è protetta dall’esecuzione se il creditore ipotecario è una banca. Anzi, la banca normalmente ha già ipoteca sull’immobile se l’ha accettato in garanzia. L’unico limite è se trattasi di bene in fondo patrimoniale o trust, ma sono protezioni costituite antecedentemente ai debiti e comunque revocabili se fatte in frode ai creditori. Dunque il titolare/socio deve valutare misure di salvaguardia come: – Ricorrere a strumenti di pianificazione patrimoniale in bonis (costituzione di fondi patrimoniali, trust, vincoli di destinazione ex art.2645-ter c.c.), sebbene siano opponibili ai creditori solo se attuati in tempi non sospetti e con finalità coerenti; se fatti quando i debiti sono già noti e scaduti, rischiano di essere revocati come atti in frode. – In caso di sovraindebitamento personale, il socio garante potrebbe accedere a procedure di esdebitazione personale (vedi sezione 4.5) per liberarsi residualmente dai debiti dopo aver messo a disposizione il suo patrimonio liquidabile.
In definitiva, la gestione dei debiti bancari richiede spesso un approccio negoziale sofisticato: le banche sono creditori forti, ben organizzati e con legali dedicati. Tuttavia, hanno anche interesse a evitare le perdite di un default totale: se l’impresa può essere salvata, collaborare è meglio che concorrere in un fallimento. Dal punto di vista del debitore, è essenziale non trincerarsi ma aprire linee di comunicazione con gli istituti finanziari, preferibilmente presentando un business plan o un piano di ristrutturazione, magari asseverato da un professionista, per convincerli a dare respiro. Se invece la situazione è irrecuperabile, la priorità diventa mitigare i danni: assicurarsi che gli atti delle banche rispettino le norme (per poterli impugnare se viziati), e preparare eventualmente un percorso di insolvenza pilotata (concordato/liquidazione) che fermi le esecuzioni e consenta la chiusura più ordinata possibile.
1.5 Debiti derivanti da appalti pubblici o privati
Questa categoria può comprendere vari scenari, ma in generale per “debiti da appalti” intendiamo le situazioni in cui l’azienda, operando come appaltatore in lavori pubblici o privati, contrae obbligazioni specifiche che poi restano inadempiute e diventano debiti: – Debiti verso subappaltatori e fornitori in cantieri: ad esempio, l’azienda impermeabilizzatrice subappalta parte dei lavori o acquista materiali ma, trovandosi in difficoltà finanziaria, non paga i subappaltatori o i fornitori edili. Questi soggetti agiscono come normali creditori (vedi 1.3), con in più qualche tutela speciale: nelle opere pubbliche, ad esempio, vige l’istituto del pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante in caso di inadempienza dell’appaltatore, nonché la possibilità di escutere le ritenute di garanzia. Quindi, se l’azienda appaltatrice non paga, il subappaltatore può chiedere all’ente pubblico committente il pagamento diretto delle sue spettanze (fino al limite del contratto subappalto approvato). – Penali contrattuali e danni: Nei contratti d’appalto, specialmente pubblici, sono previste penali per ritardi o inadempimenti. Se l’azienda non rispetta tempi e standard, il committente può applicare penali contrattuali, trattenendole sui pagamenti dovuti. Se i danni superano le penali, il committente (sia pubblico che privato) può chiedere un risarcimento danni, che diventa un debito dell’appaltatore. Ad esempio, se per grave ritardo nei lavori il committente subisce un danno, potrebbe ottenerne il ristoro giudizialmente. – Revoche di contributi o pagamenti: Nei lavori pubblici, se l’impresa appaltatrice perde i requisiti (ad es. DURC irregolare), la PA può sospendere i pagamenti o addirittura risolvere il contratto. Inoltre, l’art. 48-bis DPR 602/1973 – già citato – obbliga gli enti pubblici, prima di pagare somme oltre €5.000 all’appaltatore, a verificare presso AdER se l’impresa ha debiti iscritti a ruolo > €5.000. In caso positivo, il pagamento viene bloccato e l’importo può essere pignorato da AdER per saldare i debiti fiscali dell’impresa. Dunque un’azienda indebitata con il fisco rischia di non incassare i crediti vantati verso la PA, perché vengono intercettati. Questo meccanismo porta a un circolo vizioso: niente incassi dal contratto pubblico perché l’azienda ha debiti fiscali, e non può sanare i debiti fiscali perché non incassa. – Fideiussioni di appalto escusse: Negli appalti pubblici l’impresa fornisce polizze fideiussorie (o cauzioni) a garanzia dell’anticipazione contrattuale, della corretta esecuzione e della manutenzione postuma. Se l’impresa incorre in gravi inadempimenti, l’amministrazione può escutere la polizza fideiussoria (ad esempio la cauzione definitiva, generalmente il 10% dell’importo di contratto). L’istituto di credito o assicurazione che aveva prestato la garanzia, a quel punto, pagherà la PA e poi agirà in regresso contro l’azienda per recuperare l’importo. Questo genera un nuovo debito dell’azienda verso il garante, che spesso per contratto è immediatamente esigibile e munito di clausola di pagamento a prima richiesta. In sostanza, il fatto di essere inadempienti sull’appalto può attivare le garanzie e trasformare quell’importo in un debito liquido verso la banca/assicurazione garante, che agirà come al punto 1.4 (credito bancario). – Sanzioni amministrative: In ambito di appalti pubblici, se le inadempienze configurano violazioni di norme (es. subappalto non autorizzato, mancato rispetto di norme di sicurezza), ci possono essere sanzioni pecuniarie da parte delle autorità, anche queste diventando debiti dell’impresa.
Difese e strategie per l’impresa debitrice nel settore appalti: – Mantenere il DURC regolare: come sottolineato, per un’azienda impegnata in appalti (soprattutto pubblici, ma oggi anche molti committenti privati controllano il DURC dei fornitori critici), è vitale risultare in regola con contributi e tasse. Un DURC irregolare comporta: – Impossibilità di partecipare a nuove gare (è causa di esclusione automatica: l’art. 94 del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023 riprende la regola del precedente art. 80, escludendo operatori con violazioni contributive o fiscali gravi e definitivamente accertate). – Nei contratti in corso, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto se l’appaltatore perde i requisiti, tra cui la regolarità contributiva (in realtà, la prassi prevede che in caso di DURC negativo, prima si sospende il pagamento e si invita l’impresa a regolarizzare entro 90 giorni; se non lo fa, scatta la risoluzione). – Il blocco dei pagamenti ex art. 48-bis DPR 602/73 se ci sono debiti fiscali sopra soglia. – Soluzione: se l’azienda ha debiti contributivi/fiscali, deve attivarsi per regolarizzarli o quantomeno congelarli con strumenti come rateazioni o definizioni agevolate, così da ottenere un DURC positivo. Infatti, quando è presente un piano di rateazione in corso, il DURC viene emesso come regolare (il soggetto è considerato adempiente in quanto ha un accordo in atto). Questo può fare la differenza tra poter continuare i lavori o essere estromessi. Nel 2023-2024, molte imprese hanno usufruito della rottamazione-quater proprio per ripulire situazioni debitorie e ottenere DURC puliti; con la rottamazione V, si potrà fare altrettanto, dato che la norma prevede espressamente l’effetto di considerare non inadempiente il debitore che aderisce. – Opposizione a penali e riserve: se la PA applica penali o decurta pagamenti, l’impresa può iscrivere riserve sui registri di contabilità contestando l’addebito. In caso di contenzioso, potrà far valere che la penale è non dovuta (ad esempio per cause di forza maggiore) o eccessiva. La giurisprudenza talora riduce le penali se sono manifestamente sproporzionate rispetto al danno effettivo, qualificandole come clausole penali ex art. 1384 c.c. (riducibili equamente). Quindi l’impresa può difendersi sul quantum delle penali in sede arbitrale o giudiziale. – Gestione dei subappaltatori: se l’impresa principale non riesce a pagare i subappaltatori, rischia ritorsioni sul cantiere e la reputazione. Una strategia è coinvolgere il Committente (soprattutto se pubblico) per attivare il pagamento diretto dei subaffidatari, evitando l’accumularsi di decreti ingiuntivi. Certo, questo significa rinunciare a parte dell’utile, ma può prevenire danni maggiori e assicurare la prosecuzione dei lavori. – Attenzione al “codice della crisi” vs codice appalti: Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) ha previsto interazioni con le procedure di crisi d’impresa. Ad esempio, un’impresa in concordato preventivo può partecipare a gare pubbliche solo in determinate condizioni: se il concordato è in continuità aziendale (non liquidatorio) e l’impresa presenta certificazione di un istituto creditore che garantisce l’esecuzione del contratto (vecchio art. 110 D.Lgs. 50/2016, ora rifuso nel D.Lgs. 36/2023). Nel caso di concordato già aperto, la stazione appaltante può consentire la prosecuzione dei contratti in corso se ciò è funzionale alla continuità (art. 95 CCII). La dirittodellacrisi.it evidenzia come finalmente sia chiaro che, anche se l’impresa è in concordato “con riserva” (prenotativo), i contratti pubblici possono proseguire ricorrendo le condizioni dell’art. 95 co.2 CCII . Tradotto: se l’impresa in crisi chiede il concordato, non è automaticamente esclusa da tutti gli appalti; i contratti in essere possono continuare se un professionista attesta che ciò non arreca pregiudizio e c’è prospettiva di recupero (anche in concordato liquidatorio è possibile, se l’indipendente attesta convenienza a far completare i lavori) . Quindi, il debitore deve attivarsi in sede concorsuale per ottenere dal tribunale l’autorizzazione a proseguire i contratti pubblici in corso, mostrando che pagherà regolarmente subappaltatori e dipendenti su quei lavori (magari creando un conto dedicato). – Risoluzione del contratto d’appalto: se la crisi porta a una risoluzione anticipata dell’appalto (per default dell’impresa), le conseguenze sono pesanti: escussione delle fideiussioni, risarcimento dei costi extra per il completamento in danno, ecc. Il debitore potrebbe tentare di evitare la risoluzione cedendo il contratto a un’altra impresa prima che la PA lo faccia d’ufficio (il Codice lo permette in alcuni casi, con autorizzazione). In alternativa, se ormai inevitabile, prepararsi a quantificare e negoziare i danni per evitare rivalse eccessive. Ad esempio, se la PA affida a terzi il completamento con costi maggiori, l’impresa uscente può contestare voci di danno non pertinenti. – Procedura di concordato in continuità indiretta: Un’altra via, se l’impresa debitrice è in crisi ma ha appalti in corso di valore, è il concordato con continuità indiretta: cedere i contratti e l’azienda a un altro operatore (ad es. tramite affitto o cessione di ramo) nel contesto concordatario, così i lavori proseguono e i creditori sociali possono soddisfarsi parzialmente col valore recuperato. Questo richiede l’ok del committente pubblico e del tribunale concorsuale, ma è stato fatto in vari casi per salvare cantieri pubblici (si pensi ai casi di grandi imprese edili in concordato con prosecuzione dei lavori tramite terzi).
In generale, per l’azienda appaltatrice indebitata la parola chiave è “regolarità”: mantenersi regolare con fisco e contributi per non perdere i contratti e relativi flussi finanziari. Se la situazione degenera, utilizzare strumenti concorsuali per proteggere i contratti in essere e preservare il valore residuo. Dal lato dei creditori pubblici (enti appaltanti), essi tendono a tutelarsi inserendo clausole e usando gli strumenti di legge (verifiche, risoluzioni). Un dialogo franco con la stazione appaltante a volte può aiutare: se l’ente committente è informato delle difficoltà e di come l’impresa sta provando a risanarsi (es. presentazione di concordato, ingresso di un socio, ecc.), potrebbe essere disposto a concedere dilazioni sui pagamenti e attendere, piuttosto che risolvere subito l’appalto (cosa che comporta anche per l’ente ritardi e problemi).
Tabella 1: Tipologie di debito e strumenti di difesa principali
| Tipo di debito | Creditori e azioni tipiche | Difese del debitore |
|---|---|---|
| Tributari (Erario) | Agenzia Entrate: avvisi di accertamento; Agenzia Entrate-Riscossione: cartelle, fermi auto, ipoteche, pignoramenti. Possibile istanza di fallimento se debito rilevante (sopra soglie) – oggi meno frequente. | – Ricorso a Giustizia Tributaria (entro 60 gg) con eventuale sospensiva.<br>– Istanze di autotutela (sgravio) se errori evidenti.<br>– Rateazione ordinaria fino a 72/120 mesi.<br>– Adesione a definizioni agevolate (rottamazione, stralcio) quando previste.<br>– Opposizione a atti esecutivi viziati in sede civile (es. opposizione a pignoramento).<br>– Transazione fiscale in concordato/accordo (pagamento parziale con omologa).<br>– Eccezioni di prescrizione (spesso 5 anni) e difetti di notifica in ogni sede utile. |
| Previdenziali (INPS/INAIL) | INPS: avvisi di addebito immediatamente esecutivi; cartelle tramite AdER; blocco DURC; pignoramenti e ipoteche come Fisco. | – Ricorso giudiziario al Tribunale (Lavoro) entro 40 gg dall’avviso, o opposizione a cartella.<br>– Richiesta di rateazione amministrativa INPS (fino a 24-36 rate, più estese in casi gravi) per ottenere DURC regolare.<br>– Adesione a condoni/conciliazioni (es. stralcio automatico mini-debiti, rottamazioni per contributi in cartella).<br>– Contestazione di sanzioni civili e richiesta riduzione ex art.116 L.388/2000.<br>– Eccezione di prescrizione breve (5 anni) se mancano atti interruttivi validi.<br>– Pagamento immediato delle ritenute per evitare denuncia penale (soglia €10.000). |
| Fornitori e privati | Fornitori, affittuari, ecc.: solleciti, interessi moratori (spesso >8% ex D.Lgs 231/02); decreti ingiuntivi; pignoramento beni aziendali o crediti; istanze di fallimento (se >€30k e insolvenza). | – Negoziazione stragiudiziale: accordi di dilazione o saldo e stralcio prima che agiscano.<br>– Opposizione a decreti ingiuntivi entro 40 gg con contestazione del credito (vizi merito o forma).<br>– Richiesta di sospensione dell’esecutorietà se necessario.<br>– Opposizione all’esecuzione/atti esecutivi per evidenziare pagamenti già fatti o vizi procedurali.<br>– Se l’insolvenza è conclamata, avvio volontario di procedura concorsuale (concordato) per bloccare le azioni individuali. |
| Banche e finanziarie | Banche, leasing, factor: revoca fidi e richiesta rientro immediato; decadenza dal termine su mutui (tutto il debito esigibile); segnalazione Centrale Rischi; escussione garanzie reali (ipoteche: pignoramento immobili) e personali (fideiussioni: pignoramento ai garanti); decreto ingiuntivo rapido per scoperti o sconfinamenti; insinuazione in procedure concorsuali con privilegio se ipotecari. | – Trattative di ristrutturazione del debito: moratorie, allungamento piani di ammortamento, nuova finanza assistita da garanzie statali (Fondo PMI) etc.<br>– Piano attestato di risanamento o accordo di ristrutturazione ad hoc con le banche (evitando il default formale).<br>– Opposizioni mirate: contestazione di interessi usurari o anatocismo per ridurre il quantum; eccezione di nullità parziale di fideiussioni schema ABI.<br>– Concordato preventivo con continuità (se l’azienda è salvabile) coinvolgendo le banche come classe separata; oppure liquidazione controllata se non vi è alternativa, cercando accordi su vendita beni.<br>– Tutela dei garanti: valutare esdebitazione personale o accordi transattivi con banca per liberare i beni personali (ad es. offrire ipoteca su altro bene in cambio di stralcio parziale). |
| Da appalti (pubblici) | Stazioni appaltanti pubbliche: sospensione pagamenti se DURC irregolare; risoluzione del contratto per grave inadempimento; escussione cauzioni; applicazione penali; affidamento a terzi in danno (e addebito extra-costi); segnalazione all’ANAC (che può disporre interdittiva in casi estremi). | – Prevenire il DURC negativo: rateizzare subito debiti fiscali/previdenziali per conservare i requisiti.<br>– Se DURC irregolare notificato: regolarizzazione entro termine (in genere 90 gg) per evitare risoluzione.<br>– Negoziare con la PA una continuità: informare l’ente se si intraprende un concordato preventivo e chiedere di proseguire i lavori ex art.95 CCII , fornendo garanzie su buona esecuzione.<br>– Opporsi a penali ingiustificate: iscrivere riserve e, se serve, ricorrere ad arbitrato o al giudice per riduzione penale.<br>– Pagare i subappaltatori direttamente (o permettere pagamento diretto) per evitare contenziosi multipli.<br>– In caso di risoluzione inevitabile: minimizzare danni collaborando col subentrante e contestando addebiti non dovuti sull’esecuzione in danno. |
| Da appalti (privati) | Committenti privati: sospensione pagamenti all’appaltatore insolvente; rescissione contratto per inadempimento; causa per danni da ritardi/inadempienze; escussione di eventuali fideiussioni cauzionali. | – Mantenere dialogo col committente: proporre varianti o proroghe in cambio di rinuncia a penali.<br>– Se il committente minaccia risoluzione, valutare offerta di uno swap di appaltatore (far completare a terzi di fiducia) per evitare cause.<br>– Assicurarsi di consegnare le opere eseguite formalmente (Stati di avanzamento) così da farsi pagare almeno il dovuto per lavori svolti, prima che i pagamenti vengano bloccati.<br>– Se incagliato in un contenzioso, tentare mediazione o arbitrato rapido per ridurre l’incertezza e trovare un accordo transattivo. |
Nota: La tabella sopra riassume per grandi linee strumenti tipici; ogni situazione concreta può presentare varianti. Ad esempio, i debiti erariali in certi casi possono essere compensati con crediti d’imposta (se l’azienda vanta rimborsi IVA, può usarli in compensazione su F24 per pagare cartelle, evitando esborso di cassa), ma vige il blocco compensazione se vi sono carichi a ruolo > €1.500 non pagati. Oppure, i debiti bancari garantiti da pegno su magazzino avranno dinamiche diverse (la banca può vendere i beni dati in pegno senza giudice). È importante quindi valutare caso per caso con consulenti esperti.
Passiamo ora ad esaminare le strategie generali che un’azienda indebitata può adottare: distingueremo le soluzioni stragiudiziali, che puntano a evitare il contenzioso, da quelle giudiziali, che includono sia le difese nelle singole cause sia l’eventuale ricorso a procedure concorsuali di regolazione della crisi.
2. Strategie stragiudiziali per la gestione dei debiti
Di fronte a una situazione debitoria difficile, spesso “il miglior contenzioso è quello che si evita”. Le strategie stragiudiziali mirano a trovare un accordo con i creditori o a migliorare la posizione debitoria senza passare (o prima di passare) dal tribunale. Ciò può evitare pubblicità negativa, costi legali e soprattutto risultati incerti. Vediamo gli strumenti principali:
2.1 Rinegoziazione dei debiti e accordi transattivi individuali
Rinegoziare il debito significa contattare ciascun creditore (o i principali) per concordare nuovi termini di pagamento o una riduzione dell’importo dovuto (transazione a saldo e stralcio). Questa via è particolarmente indicata con fornitori commerciali e talvolta con le banche: – Con i fornitori, specie se c’è interesse a mantenere il rapporto commerciale, si può chiedere una dilazione del pagamento, spesso garantita dall’emissione di effetti cambiari (pagherò) scadenzati, o da un piano di bonifici mensili. Il fornitore preferisce magari incassare tardi che mai, soprattutto se intuisce che avviare un decreto ingiuntivo potrebbe portare a un concorso con altri creditori (rischio di fallimento dell’azienda). Nella trattativa, l’azienda debitrice può usare la leva del “se mi date respiro, vi pago integralmente; se mi fate fallire, forse incassate il 20%” – questo argomento spesso convince creditori pragmatici. – La transazione a saldo e stralcio implica che il debitore offre di pagare subito una parte del debito, a fronte della remissione del resto. Ad esempio, pagare il 50% cash ora per estinguere un credito di €100k. Il creditore accetta se ritiene che la prospettiva alternativa sia peggiore (ad es. recuperare zero o dopo anni in caso di fallimento). Questo tipo di accordo richiede che il debitore trovi la somma offerta: a volte proviene da un finanziatore terzo, o dalla vendita di un bene non strategico. Formalmente si redige un accordo transattivo scritto, meglio se con clausola che la somma è dovuta salvo revoca fallimentare (per cautelarsi se poi, entro 2 anni, intervenisse fallimento: la transazione stragiudiziale può essere soggetta a revocatoria fallimentare se ha soddisfatto il creditore in misura superiore al concorso, ma se il creditore ha rinunciato a parte significativa del credito, spesso la transazione non è revocata in quanto atto a “valore equilibrato”). – Con le banche la rinegoziazione è delicata ma possibile: presentando un piano industriale realistico, si può ottenere ad es. moratoria di 6-12 mesi sul rimborso del capitale (pagando solo interessi), oppure allungamento del finanziamento (riducendo la rata). In Italia c’è stato un Protocollo ABI per le PMI che prevedeva misure simili, rinnovato più volte. Le banche valutano caso per caso; spesso chiedono impegni aggiuntivi: ad es. aumento del tasso, commissioni upfront, impegno dei soci a ricapitalizzare l’azienda o fornire garanzie personali se non già presenti. – Un caso particolare è quando l’azienda è debitrice e creditrice di uno stesso soggetto (ad es. fornitore che a sua volta ci deve pagare per una controfornitura, o situazioni triangolari): la strada è la compensazione. Se legale, va formalizzata (compensazione volontaria) per ridurre i flussi reciproci. Anche col Fisco esiste la compensazione orizzontale (crediti IVA con debiti tributi), ma attenzione ai vincoli normativi (non compensabile se ci sono cartelle in sospeso sopra €1.500 senza aver presentato richiesta di sgravio o rateazione).
Vantaggi: La rinegoziazione stragiudiziale consente di: – Evitare procedure concorsuali pubbliche, mantenendo la reputazione migliore possibile. – Mantenere maggiore controllo sui tempi e modi di pagamento, senza subire imposizioni di un tribunale. – Risparmiare spese di giustizia e oneri formali. – Scongiurare, se ha successo, l’insolvenza conclamata che porterebbe a perdita di avviamento.
Svantaggi / limiti: – Necessità del consenso di tutti i creditori coinvolti: basta uno importante che resti fuori e agisca legalmente per far saltare il castello. – Rischio di comportamenti opportunistici: i creditori possono accordare proroghe e poi comunque agire se vedono un vantaggio (per questo gli accordi andrebbero formalizzati per iscritto). – Nessuna protezione generale: a differenza di un concordato, la rinegoziazione privata non blocca legalmente le azioni esecutive. Se un creditore non aderisce e pignora, gli altri accordi si complicano. – Difficoltà con creditori pubblici: l’Agenzia Entrate-Riscossione e l’INPS normalmente non fanno “accordi privati” (o paghi integralmente secondo legge, o usi gli istituti di legge come rateazione o definizione agevolata). Quindi la presenza di debiti fiscali importanti è uno scoglio: serve ricorrere a strumenti di legge (trattati più avanti, come piano di risanamento o accordo di ristrutturazione con transazione fiscale).
In pratica, la rinegoziazione funziona bene in situazioni di crisi non ancora irreversibile, con un numero limitato di creditori chiave. Ad esempio, l’azienda ha 4-5 fornitori principali: li convoca, espone la situazione (ordini in calo, incassi ritardati, ecc.) e propone un piano di rientro collettivo. Se l’azienda ha un rapporto consolidato e offre garanzie di buona fede (magari impegno a pagare un interesse di dilazione, o la garanzia personale dei soci), può ottenere supporto.
2.2 Piani di risanamento “attestati” (strumenti ex art. 56 CCII)
Quando i debiti diventano troppi per semplici accordi informali, ma l’imprenditore vuole evitare procedure giudiziali, esiste la possibilità di predisporre un piano di risanamento attestato, già noto nell’ordinamento fallimentare (ex art. 67 LF) ed ora disciplinato dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa (CCII).
Cos’è un piano attestato? È un piano industriale-finanziario di risanamento dell’impresa, redatto dall’organo amministrativo, corredato da: – analisi della situazione di partenza (debiti, cause della crisi), – misure da adottare (ristrutturazione del debito, aumento di capitale, cessione di asset, rilancio commerciale, taglio costi, ecc.), – proiezioni economiche e finanziarie a medio termine che dimostrino la sostenibilità del risanamento, – l’intervento di un professionista indipendente (iscritto in apposito albo) che attesta sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Il piano attestato è uno strumento stragiudiziale al 100%: non richiede omologa dal tribunale, né informativa ai creditori non coinvolti. Il suo vantaggio principale è che le operazioni attuate in esecuzione del piano godono di esenzione da revocatoria fallimentare (art. 56 co.3 CCII). Ciò significa che, se l’azienda poi dovesse fallire, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse ai creditori in adempimento del piano non potranno essere dichiarati inefficaci come avviene di norma per quelli fatti in stato di insolvenza nel periodo sospetto. Questo serve a incoraggiare i creditori ad aderire: sanno che incassare denaro o prendere una garanzia come parte di un piano di risanamento non sarà revocato in futuro, a patto che il piano fosse ben attestato e realizzato.
Utilizzo pratico: L’impresa redige il piano e lo sottopone ai creditori significativi, proponendo loro ad esempio: – di aspettare i pagamenti secondo un certo calendario, – di rinunciare a una quota di credito (stralcio) o convertirlo in capitale (se società per azioni, a volte banche e fornitori possono divenire soci come contropartita del taglio debiti), – di accettare modifiche contrattuali (ad es. leasing: allungamento durata, riduzione canoni), – di fornire nuova finanza (spesso le banche condizionano l’accordo a un apporto di equity fresco dei soci, così che anche l’imprenditore “ci metta del suo”).
I creditori che aderiscono firmano con l’impresa degli accordi bilaterali (o un accordo quadro plurilaterale) attuativi del piano. Non serve l’adesione di tutti i creditori: il piano può coinvolgere solo alcuni (ad esempio solo le banche) mentre altri vengono pagati regolarmente. Non c’è una maggioranza legale richiesta (a differenza degli accordi di ristrutturazione ex art.57 CCII o del concordato); tuttavia, è ovvio che se molti creditori non aderenti restano ostili, il piano rischia di fallire. Il “piano attestato” spesso è usato in crisi aziendali moderate dove c’è omogeneità tra i creditori principali (ad es. banche consorziate). Può essere segreto, se non pubblicato.
Pubblicazione: L’art. 56 CCII prevede la facoltà di pubblicare il piano e l’attestazione nel registro delle imprese. Questo conferisce data certa agli atti ed efficacia esimente per eventuali terzi (es. ai fini revocatoria). Ma l’azienda può optare per la riservatezza se teme effetti reputazionali negativi.
Limiti: Il piano attestato non offre protezione dalle azioni esecutive. Dunque se un creditore non aderente decide di pignorare un bene, legalmente può farlo. In pratica, se la maggioranza aderisce e l’operazione appare solida, spesso anche i non aderenti attendono gli esiti (possono poi essere pagati integralmente come da piano). Inoltre, il piano attestato non consente di imporre tagli ai dissenzienti: è basato sul consenso.
È insomma uno strumento contrattuale, ma rafforzato dall’attestazione che ne garantisce la genuinità e dalla protezione anti-revocatoria. In gergo, rientra tra le cosiddette soluzioni di allerta interna e prevenzione del fallimento, molto incoraggiate dalla riforma. Gli amministratori, ai sensi dell’art. 2086 c.c. come modificato, hanno il dovere di attivarsi per adottare un piano di risanamento appena la continuità aziendale è a rischio. La mancata adozione di adeguati strumenti di allerta e risanamento può costituire una violazione degli obblighi gestori, con responsabilità civile e persino penale per aggravamento del dissesto (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII). La Cassazione civile ha affermato (sent. 36365/2021) che grava sull’imprenditore, ai sensi dell’art. 2086 c.c. comma 2, l’obbligo di predisporre assetti adeguati e attivarsi per la continuità aziendale. Dunque utilizzare strumenti come il piano attestato, ove possibile, è anche un modo per gli amministratori di proteggersi da accuse di inerzia: mostra che hanno tentato un risanamento strutturato.
2.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII e seguenti)
Gli accordi di ristrutturazione sono un ibrido tra stragiudiziale e giudiziale: sono accordi privatistici con i creditori, ma richiedono l’omologazione del tribunale e offrono, a certe condizioni, effetti protettivi verso tutti i creditori. Introdotti nell’ordinamento con la legge fallimentare (art. 182-bis L.F.), oggi disciplinati dagli artt. 57-64 CCII, rappresentano una soluzione molto interessante per imprese con pochi creditori dissenzienti.
Caratteristiche chiave: – È necessario raggiungere un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti totali (quorum ridotto in alcuni tipi speciali, vedi oltre). Il che significa che l’impresa deve convincere una maggioranza qualificata (per valore) di creditori ad accettare un certo trattamento (es: pagamento parziale magari in percentuale X, o in tempi dilazionati). – I creditori aderenti sottoscrivono l’accordo; per i non aderenti, la legge prevede che devono essere integralmente pagati entro 120 giorni dall’omologazione (se già scaduti) o dalla scadenza (se successiva), altrimenti l’accordo non può essere omologato (principio di par condicio per dissenzienti). In pratica, l’accordo di ristrutturazione non crambra i creditori estranei: questi vanno soddisfatti per intero nei termini di legge. Ciò differenzia l’accordo dal concordato, dove invece tutti i creditori sono coinvolti e possono subire falcidie. – Si deposita l’accordo in tribunale assieme a una relazione di un attestatore indipendente che certifica la completezza e l’attuabilità dell’accordo, nonché la capacità dell’impresa di adempiervi regolarmente. – Dal deposito dell’accordo, l’impresa può chiedere al tribunale misure protettive (stay) temporanee: tipicamente fino a 60-120 giorni di sospensione delle azioni esecutive dei creditori, per evitare che qualcuno rovini l’accordo in corso di omologa (art. 54 CCII). – Il tribunale valuta la regolarità dell’accordo e la fattibilità (senza entrare troppo nel merito economico, che è rimesso all’attestatore e al consenso dei creditori) e omologa l’accordo. Con l’omologa, l’accordo acquista efficacia piena erga partes, e i creditori aderenti sono vincolati alla falcidie/piano pattuiti. I creditori estranei restano fuori formalmente, ma spesso in pratica beneficiano indirettamente del risanamento.
Novità introdotte dal Codice della Crisi: – Accordi ad efficacia estesa: Se l’impresa ha debiti finanziari verso banche o obbligazionisti, può raggiungere un accordo con il 75% di questi creditori finanziari e chiedere che l’omologa estenda gli effetti anche al rimanente 25% dissenziente (art. 61 CCII). Questo è utile per superare sacche di holdout tra banche. – Accordo agevolato: il correttivo D.Lgs. 83/2022 ha introdotto la possibilità di omologa anche con il solo 30% di consenso dei creditori totali, a patto che l’accordo preveda il pagamento integrale (100%) dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologa e che ai creditori aderenti venga offerto non meno di quanto otterrebbero in liquidazione fallimentare (art. 60 CCII). È una sorta di accordo semplificato, ma richiede comunque che i dissenzienti siano pagati per intero – in pratica serve quando l’impresa ha molti creditori ma pochi in grado di bloccare, e ha le risorse per pagare i piccoli per intero. – Transazione fiscale e contributiva: negli accordi omologati si può includere la falcidia di tributi e contributi, con il voto implicito dell’Erario se aderisce. Se l’Erario o INPS non aderiscono, il tribunale può comunque omologare l’accordo anche senza il loro consenso purché essi vengano soddisfatti in misura non inferiore al valore di liquidazione (c.d. cram-down fiscale, art. 63 CCII). Il correttivo 2024, come accennato, ha posto un guard-rail: se il debito fiscale > 80% del totale, l’omologa senza consenso del fisco può essere rifiutata perché si presume l’abuso. Ma in generale, oggi è possibile ristrutturare anche i debiti con l’Erario in sede di accordo.
Quando conviene l’accordo di ristrutturazione? In situazioni in cui: – L’impresa è ancora fondamentalmente sana ma illiquida, e ha bisogno di tempo o di alleggerire la pressione: l’accordo può allungare le scadenze e formalizzare la fiducia dei creditori. – C’è accordo di massima con le banche/creditori maggiori, ma serve la benedizione del tribunale per bloccare eventuali iniziative di minoranza e per gestire il fisco. – Si vuole evitare la pubblicità di un concordato (che implica convocare tutti i creditori e votazione): l’accordo coinvolge solo chi firma. Viene reso pubblico con l’omologa, ma senza passare per assemblee di creditori. – A differenza del concordato, l’azienda non deve cessare i pagamenti: può continuare a pagare normalmente i fornitori strategici e i nuovi debiti, senza incorrere in favor privilegiati (nel concordato vi è par condicio su crediti anteriori).
Esempio: l’azienda impermeabilizzazioni ha debiti per 1 milione: 600k con banche (mutui e fidi), 200k con fornitori, 200k di fisco. Non è insolvente del tutto, ha ancora commesse, ma non riesce a rispettare le rate mutuo e paga i fornitori a 120 giorni. Potrebbe: – negoziare con banche di allungare i mutui e mantenere fidi aperti (magari convertendo fido in mutuo), – offrire ai fornitori il pagamento del 50% subito e 50% tra un anno (o 80/20, dipende), – chiedere al fisco una dilazione massima (72 rate) per le cartelle. Se riesce a far aderire banche e fornitori ad un term sheet, può presentare un accordo di ristrutturazione con l’adesione di, ad esempio, l’80% dei creditori (banche e gran parte fornitori). I fornitori dissenzienti li paga comunque entro 120 giorni (li stralcia da subito pagandoli integralmente per evitare rogne). Il tribunale omologa. L’azienda esce dalla crisi, con un debito riscadenzato e ridotto nei confronti di alcuni (i fornitori magari hanno accettato il 20% di riduzione in cambio di essere pagati prima). Questo è un tipico caso di ARD (Accordo Ristr. Debiti) ben riuscito.
2.4 Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata è uno strumento introdotto di recente (D.L. 118/2021, confluito nel CCII agli artt. 17-25 septies) che mira a fornire all’imprenditore in difficoltà un aiuto professionale per trovare soluzioni, prima di arrivare all’insolvenza conclamata. Si tratta di un percorso volontario e confidenziale: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente (solitamente un commercialista o esperto di crisi iscritto in apposito elenco presso le Camere di Commercio) che lo assiste nel negoziare con i creditori.
Come funziona: – L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica delle Camere di Commercio, allegando informazioni sullo stato dell’impresa. Deve dimostrare di trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far presumere la crisi o insolvenza probabile, ma con ragionevoli prospettive di risanamento. – Viene nominato un esperto (terzo, indipendente). Si apre una fase di trattative (non pubblica) tra impresa e creditori, sotto la regia dell’esperto, che ha il compito di facilitare le parti nel raggiungere una soluzione concordata. – Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive simili a quelle dell’accordo di ristrutturazione: cioè una moratoria temporanea sui procedimenti esecutivi e cautelari dei creditori, per lavorare serenamente al piano (di regola inizialmente fino a 4 mesi). – Esito: se le trattative riescono, possono sfociare in diverse soluzioni: – un contratto di ristrutturazione (es. nuove scadenze di pagamento convenute, riduzioni, standstill), – un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (trasformando la negoziazione in un ARD formale in tribunale), – un concordato semplificato per la liquidazione (caso di insuccesso, v. più avanti sezione 4.2), – altra soluzione come il piano attestato. – Se non si trova alcun accordo, l’impresa è libera di uscire e considerare altre vie (concordato preventivo o fallimento, purtroppo). La procedura di per sé è volontaria e l’esperto, se vede che non c’è trippa per gatti, può concluderla anticipatamente.
Vantaggi della composizione negoziata: – Supporto professionale a costi contenuti: l’esperto viene pagato secondo tariffe fissate e spesso con contributo camerale. L’impresa beneficia di know-how senza dover subito investire in costosi advisor privati (anche se è opportuno farsi seguire da proprio consulente). – Riservatezza: la procedura non è pubblicizzata, se non nel caso in cui si chieda la protezione giudiziale (allora l’istanza e il provvedimento del giudice sono pubblici). – Misure premiali di legge: Per incentivare l’uso, il legislatore offre “carote”: – l’art. 25-bis CCII prevede la possibilità di richiedere una riduzione degli interessi sui debiti fiscali, la dilazione fino a 72 rate di quelli non ancora a ruolo, la sospensione di alcuni obblighi contributivi, se l’imprenditore avvia la composizione negoziata. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può sospendere nuove iniziative esecutive e accettare pagamenti parziali spontanei concordati con l’esperto. – Il correttivo 2024 ha introdotto la possibilità (art. 23 co.2-bis CCII) di concludere un accordo con il Fisco per pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari durante la composizione negoziata, anche se – come notato – gli enti previdenziali sono esclusi da questa facoltà in sede di composizione negoziata. È una novità importante: prima, senza una procedura concorsuale, il Fisco non poteva falcidiare; ora, in via negoziale riservata, può farlo su IVA e imposte (restano esclusi i tributi UE puri e locali, ma l’IVA è includibile perché considerata risorsa UE indiretta). Questo accordo fiscale richiede però il controllo del tribunale, che ne autorizza l’esecuzione e verifica la relazione dell’esperto sulla convenienza rispetto al fallimento. – L’imprenditore che segue le indicazioni dell’esperto e di conseguenza tutela i creditori può godere di esenzioni di responsabilità: ad esempio esenzione da revocatoria per pagamenti autorizzati dall’esperto a fornitori strategici; non si applicano sanzioni per gli amministratori per mancata tempestiva emersione crisi se attivano la composizione e seguono il piano. – In generale, la legge tende a considerare virtuoso chi tenta la composizione: in futuro un eventuale fallimento verrà giudicato meno severamente (anche in ambito penale, la cooperazione con l’esperto e i creditori potrà evitare accuse di bancarotta preferenziale se i pagamenti erano nel piano ecc.).
Utilizzo concreto: la composizione negoziata è partita nel novembre 2021. Nei primi due anni, non è stata usatissima, spesso per scarsa informazione o per riluttanza delle imprese (temono di “mettere il naso del tribunale in casa”). Tuttavia, quando usata ha dato esiti: molte imprese hanno trovato accordi con banche e fornitori grazie all’autorità “terza” dell’esperto che modera (non a caso, li chiamano facilitatori). Uno dei problemi segnalati era la posizione delle banche: alcune revocavano i fidi appena sapevano dell’attivazione (per autoprotezione). Il Correttivo ter 2024 ha chiarito che l’accesso alla composizione negoziata di per sé non impedisce alle banche di revocare linee di credito, quindi non c’è un divieto di legge (a differenza di quanto originariamente proposto). Ciò significa che l’impresa deve prepararsi: se teme la reazione di una banca, magari deve assicurarsi prima un accordo informale o un nuovo fido altrove, per non restare a secco all’avvio. Questo è un punto critico: l’azienda dovrebbe coinvolgere volontariamente le banche e convincerle che partecipare conviene.
Differenze con piano attestato e accordo ristrutturazione: – La composizione negoziata è procedura assistita: non produce effetti vincolanti se non si arriva ad un esito contrattuale. Non richiede soglie di consenso, e anzi è lo strumento per conseguirlo. – Il piano attestato non ha tutor esterni né protezione giudiziaria; la comp. negoziata sì (esperto + possibili misure protettive). – L’accordo di ristrutturazione è un risultato possibile di una comp. negoziata. – La comp. negoziata è accessibile anche a imprese minori e sotto soglia, mentre l’accordo e il concordato (in forme ordinarie) tendenzialmente no per le non fallibili (ma esiste il concordato minore, vedi più avanti).
Quando attivarla: Non troppo tardi. Essa è concepita per la “pre-crisi”. L’azienda magari è ancora solvibile ma vede all’orizzonte problemi di liquidità o sostenibilità del debito. Aspettare di essere in default totale diminuisce le chance di successo. Gli amministratori dovrebbero farlo non appena gli indici interni (flussi di cassa, DSCR, ecc.) segnalano tensioni persistenti. Difatti l’art. 3 CCII incoraggia l’allerta interna: se con gli strumenti organizzativi (controllo di gestione) si rileva la crisi, o se arrivano segnali esterni (es. ritardi fiscali), meglio agire.
In conclusione sulle strategie stragiudiziali: l’azienda ha a disposizione una scaletta di interventi progressivi (trattativa amichevole, piano attestato, comp. negoziata, accordo 60%, etc.). Più agisce tempestivamente e per gradi, più probabilmente eviterà il precipitare nell’insolvenza. Va sottolineato che tutte queste strategie richiedono trasparenza e credibilità: presentare dati veritieri e convincenti ai creditori. A tal fine, spesso è bene che l’azienda si faccia affiancare da un consulente finanziario (es. un CRO, chief restructuring officer) per predisporre il business plan di risanamento. L’investimento in assistenza qualificata può essere ripagato dal buon esito (al contrario, il fai da te improvvisato rischia di fallire se non si è abituati a negoziare con banche e fisco).
Nei prossimi paragrafi passeremo alle tutele giudiziali, cioè come l’azienda può difendersi in tribunale nelle cause promosse dai creditori (opposizioni, ecc.) e quali strumenti concorsuali può utilizzare per risolvere la crisi con l’intervento del giudice.
3. Difese giudiziali individuali (contenzioso e opposizioni)
In questa sezione trattiamo le opzioni difensive che l’impresa può esercitare nell’ambito di procedimenti giudiziari specifici avviati dai creditori. Ci riferiamo quindi alle cause civili o tributarie, e alle opposizioni contro atti esecutivi o monitori. Queste difese non risolvono strutturalmente la crisi, ma possono guadagnare tempo o ridurre l’importo dovuto, ed evitare pagamenti indebitamente pretesi. È fondamentale che l’imprenditore, appena riceve un atto giudiziario (ingiunzione, citazione, precetto, pignoramento, ecc.), non resti inerte: il sistema processuale concede termini spesso perentori per reagire, e una volta decorsi le possibilità si affievoliscono.
3.1 Opposizione a decreto ingiuntivo e a provvedimenti monitori
Come visto, il decreto ingiuntivo è lo strumento principale con cui un creditore insoddisfatto ottiene rapidamente un titolo esecutivo. L’azienda ingiunta ha 40 giorni dalla notifica per presentare atto di opposizione. L’opposizione si propone con atto di citazione dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto (o al giudice di pace, se del caso) e si iscrive a ruolo la causa.
Contenuto dell’opposizione: Deve indicare tutti i motivi di contestazione del credito: – Vizi formali del decreto: es. incompetenza del giudice (il decreto è stato emesso da ufficio territorialmente non competente, o valore eccedeva la competenza del giudice di pace), difetto dei presupposti (il credito non era di pronta soluzione, il decreto è stato emesso contra legem). – Eccezioni procedurali: notifica nulla (se sanabile, attivarsi comunque entro 40gg per non rischiare decadenze, poi far valere la nullità in giudizio), mancata concessione di provvisoria esecutorietà in assenza di requisiti (utile se il creditore sta eseguendo nel frattempo, si può chiederne la sospensione). – Merito del credito: contestazione sul petitum (l’importo non è dovuto in tutto o in parte) e sulla causa petendi (motivi giuridici o fattuali). Qui rientrano tutte le difese “di sostanza”: ad esempio, l’azienda ingiunta afferma che la fornitura non era conforme (inadempimento del creditore, quindi eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.), oppure che il credito è prescritto (classico in caso di decreti su fatture vecchie), oppure che c’è stata compensazione con altro credito, oppure che il calcolo degli interessi è errato ecc.
Istanza di sospensione: Poiché l’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione del decreto (se questo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo oppure se il giudice dell’opposizione, su istanza di parte creditrice, gli ha dato esecuzione nonostante l’opposizione), l’azienda opponente può chiedere con ricorso al giudice istruttore di sospendere l’efficacia esecutiva. Il giudice valuta fumus boni iuris (motivi seri di opposizione) e periculum (danno grave dall’esecuzione) e può emettere ordinanza di sospensione. Ad esempio, se l’ingiunzione è di €300.000 e l’azienda oppone un pagamento già effettuato di €200.000, il giudice potrebbe sospendere parzialmente.
L’opposizione trasforma il procedimento in un giudizio ordinario con fasi di trattazione, prove e decisione. Se l’azienda opposta ha ragione, il decreto verrà revocato (totalmente o parzialmente). Se ha torto, il decreto verrà confermato in sentenza (e le eventuali sospensioni revocate).
Giurisprudenza rilevante: Le opposizioni a DI aprono questioni su chi può fare cosa: – Se l’azienda oppone e il creditore non si costituisce, il giudice può dichiarare improcedibile il decreto? Sì, se l’opponente non ha chiesto pronuncia di merito. In pratica però, il creditore opposto di solito si costituisce per chiedere rigetto. – Questione delle domande nuove del creditore opposto: come menzionato, le Sezioni Unite 2024 hanno stabilito che il creditore può formulare domande alternative nella comparsa di risposta, se restano nell’ambito della stessa vicenda sostanziale e del medesimo interesse. Esempio: se aveva chiesto pagamento fattura, può in sede di opposizione introdurre domanda subordinata di arricchimento senza causa se la fattura risultasse giuridicamente inefficace. Ciò evita duplicazioni di giudizi. Per l’azienda opponente significa poter dover fronteggiare anche queste eventuali domande subordinate. – L’opposizione a DI è una causa di primo grado: la sentenza che la conclude è appellabile come ogni sentenza civile. Se l’azienda perde in primo grado, può appellare chiedendo sospensione dell’esecutività in appello. Attenzione però: il giudice che rigetta l’opposizione può dichiarare la provvisoria esecutività della sentenza, rendendo di fatto il credito immediatamente eseguibile pur in pendenza di appello (art. 282 c.p.c. come modif. da riforma 2021). L’opponente dovrà eventualmente chiedere in appello la sospensione di tale esecutività ex art. 283 c.p.c., ma servono gravi motivi e, di nuovo, un giudizio prognostico di possibile riforma. – Costi: se l’azienda opponente perde, pagherà le spese legali e, se il giudice ravvisa mala fede o colpa grave nell’opposizione, anche un risarcimento ex art. 96 c.p.c. (danno da lite temeraria). Quindi opporsi solo per prendere tempo senza veri motivi è rischioso: valutare bene con l’avvocato.
3.2 Opposizione a cartella esattoriale e atti della riscossione
Nel campo dei debiti fiscali e contributivi, l’equivalente del decreto ingiuntivo è la cartella di pagamento (o l’avviso di addebito INPS). Anche questi possono essere opposti, ma con regole peculiari: – Cartella per debiti tributari: l’opposizione si chiama ricorso tributario e va presentato entro 60 giorni all’organo di giustizia tributaria competente. Il debitore deve dedurre motivi inerenti il merito della pretesa (perché il tributo non è dovuto, errori di calcolo, decadenza del potere di iscrizione a ruolo, prescrizione maturata ecc.) oppure vizi propri della cartella (ad esempio omessa notificazione dell’atto presupposto, difetto di motivazione, sanzioni calcolate male). La difesa può anche sostenere che la cartella è stata notificata fuori termine di decadenza previsto dalla legge (ci sono termini per emetterle, ad esempio per ruoli da controllo automatizzato). – Cartella per contributi INPS/INAIL: si inquadra come un atto del procedimento di esecuzione esattoriale su contributi. L’opposizione qui segue due binari: – Se si contesta l’an della pretesa contributiva (non dovuto, già pagato, ecc.), è opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., da proporre al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni. – Se si contestano vizi formali della cartella (notifica nulla, ecc.) e basta, allora opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., 20 giorni. – Spesso conviene cumulare entrambe le cose in un ricorso unico al giudice del lavoro entro 40 giorni, per non sbagliare (il giudice poi qualifica). – Intimazione di pagamento e altri atti di riscossione: L’intimazione è un sollecito che AdER invia quando una cartella è scaduta da oltre 1 anno, intimando di pagare entro 5 giorni se no esecuzione. L’intimazione di per sé è difficilmente impugnabile, a meno che si voglia eccepire la prescrizione sopravvenuta del debito (spesso viene usata per interrompere). In genere, se si contesta il debito bisogna risalire alla cartella originaria. – Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale: Il fermo (blocco veicoli) e l’ipoteca iscritta da AdER su immobili non sono preceduti da titolo giudiziale, ma hanno un preavviso. La giurisprudenza oscillava su come impugnarli: tribunale ordinario vs commissione tributaria a seconda se si attaccava il diritto di procedere o la regolarità. Le Sezioni Unite (sent. 7822/2020 e 8770/2020) hanno chiarito che il fermo e l’ipoteca su crediti tributari vanno impugnati davanti al giudice tributario, essendo atti della riscossione aventi natura cautelare legati al tributo. Quindi l’azienda che riceve un preavviso di fermo per cartelle IVA, se vuole opporsi (es. perché non gli è giunta la cartella originaria o ha una rateazione in corso), deve far ricorso in commissione tributaria in 60 giorni. – Esecuzione forzata esattoriale (pignoramento): Se AdER pignora un conto o altro, l’opposizione va al giudice ordinario per vizi del pignoramento (atti esecutivi) o per contestare il diritto a procedere quando non si è fatto prima in Commissione. Tuttavia, la L. 130/2022 ha portato all’istituzione di una “Giurisdizione tributaria allargata”: dal 2023, alcune opposizioni all’esecuzione esattoriale su crediti tributari spettano ai giudici tributari (in particolare, questioni su prescrizione del credito, vizi della cartella mai impugnata, ecc., se sollevate dopo l’inizio esecuzione). La Corte Costituzionale 2023 n. 196 ha avallato questa attribuzione. Pertanto, il debitore deve stare attento: se contesta il fondamento del credito tributario durante l’esecuzione, il suo giudice è la Corte di giustizia tributaria; se contesta atti del procedimento esecutivo (es. regolarità del pignoramento), è il giudice dell’esecuzione ordinario. – Termini: Molto rigidi. Se si perde il treno del ricorso entro 60 giorni, la cartella diventa definitiva come un giudicato. Si potrà solo tentare di opporsi all’esecuzione eccependo eventualmente la prescrizione maturata dopo, oppure la nullità radicale della notifica (ma qui entra la diatriba dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo: come visto, la Consulta 190/2023 ha di fatto obbligato i debitori a attendere un atto successivo, potendo anticipare solo in specifici casi).
Per l’azienda debitrice, in pratica: – Controllare sempre ogni dettaglio: se una cartella non è mai stata notificata regolarmente e la si scopre in ritardo, c’è spazio per far valere la decadenza della pretesa. Ma l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo è preclusa (salvo i casi appalto/48-bis già detti). Occorre spesso attendere un intimazione o un pignoramento, e lì far valere che la cartella presupposta è nulla per omessa notifica e il credito prescritto nel frattempo. La Cassazione aveva oscillato: prima con SU 19704/2015 aveva aperto all’impugnazione immediata, poi col DL 146/2021 e la Consulta 190/2023 questo è ristretto. – Nel dubbio, se l’importo è alto, conviene sfruttare qualunque appiglio processuale per avere un giudice esaminare la vicenda. Ad esempio, presentare istanza di sgravio in autotutela e contestualmente un ricorso fuori termine sperando nella conversione in querela nullitatis. Non è banale e serve avvocato esperto. – Un caso frequente: l’azienda riceve comunicazione di iscrizione ipoteca su capannone per cartelle mai viste prima. Ha 60 giorni dal preavviso per ricorrere al giudice tributario sostenendo che quelle cartelle non furono notificate o che i tributi sono prescritti. Fornire prove (es. estratti cronologici di notifica dove magari appare un “irreperibilità temporanea” non seguita da deposito corretto). In parallelo, negoziare con AdER per rateizzare se la situazione legale è incerta: la rateazione blocca l’esecuzione (ipoteca rimane ma niente esproprio finché paghi). – Spese di lite: Nei ricorsi tributari il giudice può compensare spese se la questione era dubbia. Nei giudizi ordinari su cartelle INPS, se l’azienda vince di solito ottiene spese a carico dell’ente.
3.3 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (procedure civili)
Quando un creditore (fornitore, banca, ecc.) ha già un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, mutuo esecutivo) e avvia un pignoramento, la difesa residua dell’azienda è nelle opposizioni esecutive: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta in radice il diritto del creditore di eseguire. Ad esempio: – Il titolo è stato soddisfatto (ho già pagato il debito: allego ricevute). – Il titolo non è (o non è più) efficace: es. un decreto ingiuntivo non ancora definitivo, opposto, e il creditore esegue lo stesso: posso far sospendere per mancanza di esecutività (ma qui è più competenza del giudice dell’opposizione monitoria in realtà). Oppure, un precetto su un titolo prescritto. – Il creditore procede per importi non coperti dal titolo (precetta più del dovuto). – O il titolo è venuto meno: es. un decreto ingiuntivo su cambiale è caducato perché la cambiale è stata annullata da tribunale. – Opposizione all’esecuzione si può fare prima che inizi il pignoramento (contro il precetto) o dopo (ma in tal caso se non si è fatta prima, limitatamente a fatti sopravvenuti al titolo). – Competente: il giudice del luogo dell’esecuzione (se già iniziata) o quello che ha emesso il titolo se prima. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali di singoli atti della procedura: – Il precetto è nullo (manca indicazioni obbligatorie, non sono decorsi 10 gg tra notifica precetto e pignoramento, ecc.). – Il pignoramento è nullo (es. l’ufficiale giudiziario non ha rispettato forme, ha pignorato beni impignorabili, non ha rispettato termini). – La notifica del titolo esecutivo o del precetto era nulla. Attenzione: c’è dibattito se notifica nulla del titolo vada in 615 o 617; la Cassazione tende a dire atto pre-esecutivo come il precetto sta su 617 (20 gg dalla notifica del precetto medesimo). – Termine: stringente 20 giorni da quando si ha conoscenza dell’atto viziato (ad es. dal deposito pignoramento per il debitore). – Forma: ricorso al GE se esecuzione già iniziata, o citazione in altri casi. – Sospensione della procedura: L’azienda di solito, se subisce un pignoramento rilevante (conto corrente aziendale bloccato, macchinari pignorati) chiederà contestualmente la sospensione dell’esecuzione (in caso di opp. 615) o dell’atto (in caso di 617). Il giudice esamina d’urgenza e concede se vede seri profili di fumus + pericolo nel proseguire. – Esempi: – La banca pignora il conto per €100k. L’azienda oppone che in realtà il saldo dovuto è €50k perché €50k erano stati addebitati illegittimamente come interessi anatocistici (questione di merito sul diritto a procedere per quell’importo). Il giudice dell’esecuzione può sospendere per €50k e far proseguire per il resto, oppure sospendere tutto se la questione è intricata, rimettendo le parti a un giudizio di merito parallelo. – Un fornitore pignora un macchinario ma era in leasing (quindi non di proprietà dell’azienda): opposizione agli atti per impignorabilità di bene non del debitore. – Pignoramento di bene indispensabile all’attività? Il codice prevede che l’azienda possa chiedere al giudice di sostituire il bene con altro o far proseguire l’attività provvisoriamente (ma questo è più nel concorso). – Se l’esecuzione è già avanti (beni all’asta): c’è la possibilità di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) come detto, depositando somma pari al dovuto + spese + 10%. Questo non è propriamente un’opposizione ma un’istanza che, se accolta, ferma la vendita e libera i beni. – Coordinamento con procedure concorsuali: Se nel frattempo l’azienda decide di presentare un ricorso per concordato preventivo o viene dichiarato fallimento, l’esecuzione individuale viene stoppata per legge. Quindi a volte può non valere la pena fare costose opposizioni se sai che entro breve attiverai un concordato: quell’automatismo (lo stay concorsuale) prevale. Attenzione però: se un bene è già stato venduto all’asta prima del concordato, la vendita rimane valida.
Conclusione: Le opposizioni esecutive sono tecnicamente complesse e vanno calibrate. L’azienda deve valutare il costo/beneficio: vale la pena spendere soldi in avvocati su questo, o meglio destinare risorse a un accordo col creditore? A volte l’opposizione è tattica per guadagnare tempo e nel frattempo trattare da posizione un po’ più forte (perché la procedura è sospesa). Ma dev’esserci buona fede nei motivi, se no rischia di essere condannata a spese e danni.
4. Procedure di crisi e insolvenza (soluzioni concorsuali)
Quando i debiti superano la capacità dell’impresa di farvi fronte e le misure stragiudiziali non bastano, si entra nel campo delle procedure concorsuali, ora disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) in vigore dal luglio 2022 (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Queste procedure sono strumenti giudiziari che permettono di regolare la crisi o l’insolvenza, con effetti vincolanti per tutti i creditori secondo regole di legge. Dal punto di vista del debitore, possono servire sia per tentare un risanamento aziendale (mantenendo in vita l’impresa) sia per effettuare una liquidazione ordinata del patrimonio, magari con esdebitazione finale.
Le procedure di interesse per la nostra azienda sono: – Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) – Liquidazione giudiziale (l’equivalente dell’ex fallimento) – Concordato minore e Liquidazione controllata (per sovraindebitamento, se l’azienda non è fallibile o per debiti personali dei soci) – Esdebitazione del sovraindebitato (liberazione dai debiti residui a certe condizioni) – Amministrazione straordinaria (per grandi imprese insolventi, non trattata qui perché non applicabile a PMI come l’azienda in esame) – Composizione negoziata e concordato semplificato (già discussa prima la comp. negoziata come fase stragiudiziale; c’è però uno sbocco concorsuale semplificato possibile).
Esamineremo i principali con taglio pratico.
4.1 Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza, utilizzata dall’imprenditore per evitare il fallimento presentando un piano ai creditori. In sostanza, l’imprenditore propone ai creditori un accordo concorsuale il cui contenuto è regolato dalla legge: – Può prevedere la continuazione dell’attività (concordato in continuità), oppure la cessazione e la vendita del patrimonio (concordato liquidatorio), o una combinazione (es. continuazione parziale). – Deve assicurare il pagamento di almeno una parte dei crediti chirografari e il soddisfacimento integrale di quelli privilegiati, salvo consenso alla falcidia da parte dei privilegiati stessi o salvo che vi sia incapienza su quei beni (in quel caso i privilegiati per la parte incapiente diventano chirografari). – Attualmente, in base all’art. 84 CCII, è ammesso un concordato liquidatorio puro solo se soddisfa almeno il 20% dei crediti chirografari (soglia di legge) e impiega proventi esterni rilevanti (altrimenti spingono verso la liquidazione giudiziale). Se invece c’è continuità aziendale (diretta o indiretta), non c’è soglia minima fissa, basta che sia superiore all’alternativa fallimentare.
Procedura: 1. L’impresa deposita una domanda di concordato presso il tribunale competente (dove ha sede). Può essere una domanda completa (piano, proposta e tutta la documentazione) o una domanda “in bianco” (con riserva, ex art. 44 CCII, presentando solo ricorso e chiedendo tempo – 60-120 gg – per depositare il piano definitivo). Il ricorso in bianco serve per bloccare subito le azioni dei creditori (ha effetto protettivo immediato), guadagnando tempo per definire i dettagli del piano. 2. Il tribunale, se la domanda non è manifestamente inammissibile, dichiara aperta la procedura (nel concordato pieno) o ammette alla procedura e nomina organi provvisori (commissario giudiziale) nel concordato con riserva. 3. Effetti: dal momento di presentazione della domanda si attiva l’automatic stay: nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori anteriori, né possono essere acquisite cause di prelazione se non concordate. Anche eventuali istanze per liquidazione giudiziale (fallimento) restano sospese. L’impresa continua ad operare ma sotto vigilanza del Commissario e con alcuni vincoli (atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione giudice delegato). 4. I creditori vengono informati e invitati a votare sulla proposta. Il commissario redige una relazione. Si tiene un’adunanza dei creditori (in continuità di solito dopo 120-180 gg dall’ammissione) e ogni creditore vota per accettare o meno il concordato. 5. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza per teste non conta, solo valori >= 50%). Se classi di creditori, maggioranza in almeno la metà delle classi più altre condizioni (no dettaglio eccessivo qui). 6. Se i creditori approvano, il tribunale procede ad omologare il concordato, verificando legalità e fattibilità. 7. Una volta omologato, il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori (anche i dissenzienti e non votanti): costoro riceveranno quanto previsto dal piano ed esonerano il debitore dal resto.
Concordato in continuità vs liquidatorio: – Continuità diretta: l’impresa prosegue la propria attività durante e dopo il concordato, utilizzando i ricavi futuri per pagare i creditori secondo il piano. Esempio: l’azienda impermeabilizzazioni ottiene commesse profittevoli, e col margine generato in 5 anni pagherà il 60% dei debiti precedenti. I creditori accettano perché credono nel piano e perché in fallimento avrebbero magari 30%. Il piano deve essere attestato da un professionista che evidenzia la sua realizzabilità e convenienza. La legge privilegia questi concordati perché salvano l’impresa e i posti di lavoro: non impone soglie minime di pagamento ai chirografari, basta migliorare la loro condizione rispetto alla liquidazione. – Continuità indiretta: la gestione prosegue ma non in capo allo stesso soggetto: ad es. l’azienda affitta o vende l’azienda (o un ramo) ad un terzo che continua l’attività. Il ricavato serve a pagare i creditori del concordato. Ci sono regole per tutelare i lavoratori (passaggio dipendenti) e per assicurare che il prezzo di cessione sia adeguato (per evitare svendite ai compiacenti). – Liquidatorio: l’impresa cessa l’attività e liquida tutto l’attivo ai creditori, sotto la supervisione del liquidatore nominato dal tribunale (di solito il commissario diventa liquidatore). Questo è come un fallimento pilotato dal debitore, con il vantaggio per quest’ultimo che ottiene l’esdebitazione concorsuale (per le società si chiude senza debiti residui, per le persone fisiche apre la via esdebitazione). Però, come detto, la legge consente concordato liquidatorio solo se c’è un plus per i creditori rispetto al fallimento, ad es. un apporto di finanza esterna (soci che mettono soldi freschi destinati solo ai creditori chirografari) o la soglia 20%.
Ruolo del debitore: Nel concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, il debitore conserva l’amministrazione dei beni (salvo atti straordinari) se in continuità. Nel liquidatorio, comunque nominano un liquidatore che gestisce la cessione dei beni, ma sotto la direzione dell’imprenditore in fase di proposta.
Vantaggi per il debitore: – Sospende le azioni esecutive e blocca maturazione di interessi chirografari. – Può ottenere la cessazione di contratti onerosi (chiedendo autorizzazione a scioglimento di contratti in corso, come affitti troppo cari, appalti non vantaggiosi). – Può ridurre in modo significativo i debiti: es., i chirografari prendono il 30% in 4 anni e il resto è esdebitato. – Pianifica le vendite di attivo massimizzando il valore (magari vendendo l’azienda intera anziché in pezzi). – Una volta eseguito il concordato, la società è liberata dai debiti concorsuali residui (le società in realtà se soddisfano il concordato, i creditori non hanno altre pretese; se fosse persona fisica avrebbe bisogno di esdebitazione, ma i soci eventualmente fallibili possono chiedere esdebitazione pure loro). – Gli amministratori evitano le sanzioni e interdizioni connesse al fallimento (non c’è sentenza dichiarativa di fallimento, niente rapporti col curatore sulla condotta se non quanto esaminato in concordato). – Con la riforma, c’è anche la possibilità di un concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) senza voto dei creditori ma solo liquidatorio, utilizzabile se la composizione negoziata fallisce e l’esperto dichiara che non si è trovato accordo ma c’è una soluzione liquidatoria da proporre. È un istituto nuovo: in pratica il debitore chiede al tribunale di omologare un concordato senza passare dal voto, presentando comunque un piano che distribuisce l’attivo secondo le priorità. È “semplificato” perché non c’è la fase di votazione. Si applica raramente e solo in esito negativo alla comp. negoziata. Può capitare se un’impresa ha provato la negoziazione e nessuno accordo è stato possibile: per evitare il fallimento immediato, propone di vendere i beni e dare quel che viene ai creditori. Saranno i creditori a poter fare opposizione all’omologa se trovano ingiusto il piano. In assenza di opposizioni o se superate, il tribunale omologa.
Svantaggi / oneri: – Il concordato è pubblico: l’iscrizione nel registro imprese avvisa del ricorso, la reputazione può risentirne (clienti e fornitori ne vengono a conoscenza). In casi di continuità, però, la procedura stessa può dare fiducia (perché è controllata). – I tempi: qualche mese per la votazione + eventuale omologa, in cui l’azienda è come in “rianimazione”: ha libertà limitata, ogni atto rilevante soggetto ad autorizzazioni. Tuttavia, se in continuità, può operare (pagare fornitori correnti, incassare crediti, fare nuovi contratti) nel rispetto di un budget approvato dal giudice. – Costi: vi sono spese di procedura (compenso del commissario, del liquidatore, dell’attestatore, le spese legali per predisporre il piano, ecc.). Queste vanno considerate nel piano e coperte. – Rischio di esito negativo: se i creditori non votano a favore, il concordato viene dichiarato inammissibile e di solito si apre la liquidazione giudiziale (fallimento). Quindi è un passo da fare con preparazione: normalmente prima di presentarlo si testa il terreno con i creditori maggiori per assicurarsi che voteranno sì.
Caso pratico: L’azienda impermeabilizzazioni, con debiti multi-stakeholder (banche, fisco, fornitori), potrebbe optare per un concordato in continuità se ha commesse in corso che possono generare margini. Ad esempio, propone: ai fornitori e banca chirografaria do il 40% in 4 anni, alle banche ipotecarie vendo un immobile e le soddisfo al 70% del loro credito (il restante diviene chirografo al 40%), all’Erario e INPS offro il 30% delle loro somme (oggi è consentito includerli con transazione nel concordato, il limite è che se dissentono il tribunale può ugualmente cramdownearli se do almeno il valore di liquidazione). I soci magari mettono €50k freschi per aumentare la percentuale ai chirografari di qualche punto e raggiungere convenienza. Il commissario verifica tutto. I creditori valutano che conviene rispetto al fallimento e approvano. La società continua a lavorare, risana la propria situazione e a fine concordato è “pulita” dai debiti residui.
4.2 Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Se l’impresa è insolvente senza rimedio, oppure se un concordato fallisce (non viene approvato, o viene revocato perché l’imprenditore non rispetta gli impegni), la conseguenza è l’apertura di una liquidazione giudiziale, cioè la vecchia procedura fallimentare. Essa può essere: – Chiesta dai creditori (istanza di liquidazione): qualunque creditore (o l’azienda stessa, o la Procura in taluni casi) dimostri che l’impresa non paga i debiti ed è in stato di insolvenza, oltre la soglia di legge (€30k), può provocare questa procedura. – Conseguenza di inammissibilità / revoca di concordato: se il tribunale respinge un concordato perché irrealizzabile o per atti di frode del debitore verso i creditori, dichiara d’ufficio la liquidazione giudiziale (entro un anno dalla domanda di concordato). – Volontaria: un imprenditore può anche direttamente presentare ricorso per essere dichiarato in liquidazione giudiziale (ad esempio se vuole far scattare immediatamente l’esdebitazione personale poi, nel caso di ditta individuale). Spesso però preferiscono tentare concordato.
Effetti: – Nomina del Curatore (professionista che amministra tutti i beni) e del Giudice Delegato. – L’imprenditore perde la disponibilità dei beni: ogni atto lo fa il Curatore per la massa dei creditori. – Si forma lo stato passivo: i creditori devono presentare domanda di insinuazione e il GD li ammette o esclude con un provvedimento (impugnabile). – Il curatore liquida l’attivo (vende cespiti, anche l’azienda se c’è interesse a esercizio provvisorio in rari casi). – Distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima creditori con pegni, ipoteche, ecc., poi chirografari proporzionalmente. – La società (se è una società) al termine viene cancellata; se è persona fisica (imprenditore individuale), rimane la persona ma con ancora i debiti insoddisfatti salvo chieda esdebitazione.
Dal punto di vista del debitore: – È il peggior scenario in termini di perdita di controllo: l’imprenditore non può più decidere nulla del patrimonio. Inoltre scattano possibili azioni di responsabilità: il curatore può citare in giudizio gli amministratori se hanno commesso atti di mala gestio causando danni ai creditori, oppure promuovere azioni revocatorie di atti compiuti prima (pagamenti preferenziali a taluni creditori nei 6 mesi pre-fallimento, atti dispositivi senza corrispettivo nell’ultimo biennio, ecc.). – Sul lato penale, la sentenza di liquidazione giudiziale può portare a indagini per bancarotta: se l’imprenditore ha distratto beni, tenuto male le scritture, favorito dei creditori a danno di altri, ecc., commette reati fallimentari. – Tuttavia, c’è anche uno spiraglio di fresh start: Il CCII prevede che l’imprenditore persona fisica meritevole ottenga l’esdebitazione di diritto dopo la chiusura della procedura, anche senza bisogno di un giudizio ad hoc (art. 278 CCII). Per i soci illimitatamente responsabili di società fallita e per i piccoli imprenditori non fallibili c’è un meccanismo analogo nel sovraindebitamento. L’idea è che dopo la liquidazione del patrimonio, ciò che rimane impagato viene cancellato, dando all’ex imprenditore onesto la possibilità di ripartire. In passato (legge fall.) l’esdebitazione doveva essere richiesta e concessa solo se varie condizioni; oggi l’orientamento è di renderla quasi automatica salvo casi di frode o di mancata cooperazione. – Per una società, la questione esdebitazione non si pone in quanto la società, una volta liquidata, si estingue e i debiti insoddisfatti non hanno più un soggetto giuridico su cui far valere pretese (si perdono, a meno di coinvolgere soci garanti o responsabili). – La durata di una liquidazione giudiziale varia ma può essere anche di anni, specie se ci sono contenziosi su crediti, azioni legali in corso, ecc. Durante questo periodo l’imprenditore è spossessato e subisce alcune incapacità (ad es. divieto di espatrio senza autorizzazione, ritiro del passaporto; interdizione dagli uffici direttivi di società per l’intera procedura). – Dal lato “difesa”, l’impresa può opporsi alla dichiarazione di liquidazione quando è instata da altri, se ritiene di non essere insolvente. Ad esempio, se un creditore chiede il fallimento ma l’impresa prova di avere patrimonio sufficiente o di aver rimediato, può persuadere il tribunale a respingere l’istanza. Il carico della prova in realtà è sul creditore dimostrare insolvenza (non bastano debiti scaduti modesti). Ma nella pratica, se più creditori supportano l’istanza e mostrano inadempimenti gravi, è difficile evitarla a meno di avere un concordato depositato (il concordato presentato prima dell’udienza fallimentare “sospende” la decisione e se poi il concordato va male, riprende). – Un aspetto positivo, per così dire: se l’impresa era sommersa di debiti non pagabili, la liquidazione giudiziale fa piazza pulita in modo ordinato. I creditori recuperano qualcosina secondo legge, e l’imprenditore chiude col passato e può eventualmente (se persona fisica) ripartire senza debiti residui post esdebitazione. Per i soci di SRL, se non hanno garanzie personali, il fallimento della società li colpisce solo indirettamente (perdita capitale investito, eventuali azioni di responsabilità se amministratori). Diciamo che per i debiti puramente sociali, la SRL in fallimento funge da “scudo” per il patrimonio personale (lo scopo della forma societaria).
Simulazione pratica: se la nostra azienda impermeabilizzazioni fosse proprio insolvente (cantieri fermi, niente liquidità, debiti > attivo), e non trovasse accordi o concordati fattibili, probabilmente i creditori (fornitori ed eventualmente INPS/AdER) ne chiederebbero il fallimento. Verrebbe nominato un curatore che magari cercherà di vendere i macchinari, cedere eventuali contratti attivi ad altra ditta (così i creditori ricavano qualcosa da quelle commesse incomplete), e chiudere. I creditori chirografari piglieranno forse il 10% ciascuno. L’attività dell’azienda cessa, i dipendenti vengono licenziati (con accesso al Fondo di garanzia INPS per TFR e ultime mensilità). I soci perdono l’investimento, ma se non ci sono garanzie personali escono senza ulteriori perdite patrimoniali (salvo la reputazione). Gli amministratori, se non hanno commesso irregolarità, non avranno grossi guai; se invece hanno fatto movimenti strani (tipo prelevato cassa prima del fallimento) rischiano denunce di bancarotta.
4.3 Sovraindebitamento e procedure “minori”
Il Codice della Crisi ha unificato anche la disciplina del cosiddetto sovraindebitamento, che prima stava nella L. 3/2012. Riguarda: – Consumatori (persone fisiche non fallibili, con debiti personali) – Piccoli imprenditori non soggetti a fallimento (sotto soglie dimensionali) – Imprenditori cessati – Soci illimitatamente responsabili di società già fallita (che rimangono con debiti personali per l’escussione del socio)
Le procedure disponibili: – Concordato minore (artt. 74-83 CCII): molto simile al concordato preventivo ma calibrato su piccole masse. Serve a proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti, con eventuali garanzie di terzi, dilazioni ecc. Si chiama “minore” perché riservato a debitori minori (non fallibili). Non richiede soglie di voto percentuali fisse come il concordato classico, ma deve garantire ai creditori una soddisfazione migliore di quella liquidatoria e almeno il 20% ai chirografari salvo casi eccezionali (se il debitore è consumatore può bastare pure meno in teoria, ma in concordato minore il 20% c’è come regola generale art. 78). – Piano di ristrutturazione del consumatore: specifico per chi ha debiti come privato (non d’impresa) e vuole proporre un piano di pagamento parziale, valutato anche secondo criteri di meritevolezza (il giudice deve verificare che il sovraindebitamento non dipenda da colpa grave del consumatore, se no può rigettare). – Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII): l’equivalente del fallimento per chi non è soggetto a fallimento. Viene nominato un liquidatore che vende i beni e ripartisce. Al termine, la persona fisica può chiedere l’esdebitazione. – Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): introdotta recependo la Direttiva UE 2019/1023, permette al debitore persona fisica meritevole, privo di beni da liquidare (c.d. incapiente), di ottenere comunque la cancellazione dei debiti senza nessun pagamento, a certe condizioni (non deve aver beneficiato di questa esdebitazione nei 5 anni precedenti e per 4 anni successivi all’esdebitazione, se la sua situazione economica migliora significativamente, una parte di reddito eccedente gli verrà chiesta per i creditori). È una sorta di fresh start per persone disperate: debitore nullatenente esdebitabile.
Nel contesto della nostra azienda impermeabilizzazioni: – Se fosse una ditta individuale, l’imprenditore potrebbe usare queste procedure in alternativa al fallimento (che per piccolo imprenditore sotto soglie non si aprirebbe proprio). Ad esempio, se i debiti sono 300k e non c’è modo di pagarli integralmente, il titolare potrebbe proporre un concordato minore offrendo, poniamo, il 30% in 5 anni usando redditi futuri, oppure mettere in vendita l’unico immobile per dare un tot ai creditori e su quello chiudere la partita. Se approvato dai creditori (anche qui c’è voto maggioranza richiesto, ma più flessibile) e omologato, il debitore poi paga quanto promesso e viene esdebitato dal resto. – Se i creditori non si fidano o la proposta non c’è, può attivare la liquidazione controllata: un liquidatore vende i beni del piccolo imprenditore (compresi eventuali beni personali, salvo quelli impignorabili), e poi il giudice lo esdebità dal residuo. Questa è una strada per la pace finale: accetti di perdere ciò che hai oggi, in cambio di tornare libero domani dai vecchi debiti. Dura qualche anno, ma è molto utile soprattutto per ex imprenditori pieni di debiti e senza attivo: piuttosto che restare inseguiti a vita da Equitalia o banche, preferiscono consegnare quel poco che hanno a un liquidatore e ricominciare da capo puliti. – Nel caso di soci illimitatamente responsabili (di SNC, SAS) che abbiano patrimoni personali aggredibili per i debiti sociali: se la società è fallita, i soci rispondono. Oggi c’è dibattito su se possano fare procedure di sovraindebitamento separate. La Cassazione (SU n. 10507/2019) aveva ammesso che un socio illimitatamente responsabile di società non fallita potesse accedere al sovraindebitamento per sistemare i propri debiti (compresi quelli per fideiussioni e coobbligazioni), a condizione che la società non fosse a sua volta in procedura. Con la riforma, se la società non è fallibile (perché minore), i soci lo sono e possono essi stessi attivare un concordato minore comprensivo dei debiti sociali, purché la società poi venga liquidata o risanata a parte. Insomma, il quadro è tecnico, ma in pratica: un socio accomandatario indebitato personalmente potrebbe fare un piano del consumatore se i debiti sono in gran parte estranei all’attività, o un concordato minore se sono per l’attività, per evitare di essere perseguito a vita.
Meritevolezza: Le procedure da sovraindebitamento originariamente richiedevano un giudizio di meritevolezza (il debitore non doveva aver colpa grave, malafede). Oggi questo aspetto è stato sfumato: solo per il piano del consumatore c’è valutazione puntuale di meritevolezza, per il concordato minore meno. Ma condotte fraudolente (es. aver aumentato i debiti quando già sapeva di non poter pagare) possono portare a diniego di omologa se ledono i creditori.
Difendersi come debitore sovraindebitato: Ciò significa usare questi strumenti per evitare pignoramenti e vivere dignitosamente: – Una volta accettata la procedura, i creditori non possono aggredire nuovi beni (c’è anche qui lo stay). – Il debitore tipicamente conserva in bonis le cose essenziali (la legge salvaguarda alcuni beni impignorabili come la casa di abitazione se serve a vita dignitosa – in sovraindebitamento c’è più flessibilità a lasciarla, dipende). – Al termine, può ottenere l’esdebitazione. – Esempio pratico: Titolare ditta individuale, perse commesse, chiude con 200k debiti: tramite un OCC (Organismo Composizione Crisi) presenta un piano: offre di pagare €50k in 4 anni (fondi attesi da un nuovo lavoro dipendente che ha trovato, e dalla vendita dell’auto di lusso). I creditori votano e accettano (si aspettavano niente). Omologa, esegue i pagamenti, ottiene esdebitazione degli altri 150k. Oppure se non ha nulla da offrire: chiede esdebitazione del debitore incapiente, e in 4 anni se la sua situazione migliora verserà quel che può; se no, libero.
Tabelle riepilogative delle procedure concorsuali
Possiamo ora sintetizzare in tabella i principali strumenti di regolazione della crisi:
| Procedura | Chi può accedere | Scopo | Effetti principali | Requisiti/Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Concordato preventivo | Imprese soggette a fallimento (SRL, spa, snc, ditte sopra soglie) | Risanamento (in continuità) o liquidazione controllata di un’impresa insolvente, con accordo dei creditori (voto) | – Blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori.<br>– L’impresa rimane in esercizio (specie in concordato in continuità).<br>– Pagamento parziale dei debiti secondo un piano approvato a maggioranza e omologato dal tribunale.<br>– Estinzione dei debiti residui a fine procedura (per la società). | – Stato di crisi o insolvenza attuale o imminente.<br>– Per concordato liquidatorio: almeno 20% ai chirografari (salvo apporto esterno) e cessione integrale dei beni.<br>– Per concordato in continuità: azienda prosegue attività (direttamente o ceduta/affittata) e piano attestato di fattibilità; no soglia % minima, ma soddisfazione migliore che in liquidazione .<br>– Necessaria approvazione dei creditori >50% dei crediti votanti (con maggioranze per classi se previste).<br>– Possibile falcidia di crediti privilegiati solo se il piano dimostra che su quei beni avrebbero minor valore (o se privilegiati acconsentono); falcidia di tributari e contributivi ammessa solo se aderisce Agenzia Entrate/ente o se giudice omologa nonostante dissenso dando almeno valore di liquidazione. |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Imprese soggette a fallimento e relativi soci illimitatamente responsabili (in pratica qualsiasi imprenditore sopra soglie) | Liquidazione coattiva del patrimonio e distribuzione ai creditori secondo prelazioni (procedura concorsuale liquidatoria) | – Spossessamento dell’imprenditore: gestione affidata al Curatore.<br>– Interruzione attività aziendale (salvo esercizio provvisorio se utile per valore).<br>– Scioglimento di diritto dei contratti in corso (il Curatore può subentrare o sciogliere a seconda dei casi, es. affitto d’azienda).<br>– I creditori anteriori concorrono al riparto, perdendo azioni individuali.<br>– A fine procedura, per le persone fisiche: esdebitazione dei debiti rimasti insoluti (se il fallito ha cooperato lealmente); per società: estinzione senza successione nei debiti. | – Stato di insolvenza conclamata (cessazione dei pagamenti).<br>– Attivo non inferiore a costi di procedura (se patrimonio nullo, spesso si opta per archiviazione – meritevolezza esdebitazione incapiente per persone fisiche come via alternativa).<br>– Soglia debiti > €30.000 per istanza (art. 2 CCII): insolvenze di importo minore non portano a liquidazione giudiziale.<br>– Può essere dichiarata su ricorso del debitore, dei creditori o d’ufficio dal tribunale in caso di esito negativo di concordato preventivo. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) | Imprese (anche piccole) e in generale debitori commerciali; tipicamente usato da società di capitali | Evitare il fallimento tramite accordo con la maggior parte dei creditori e omologazione giudiziale (contratto omologato) | – Moratoria temporanea su azioni esecutive su richiesta (protettiva durante trattative e fino a omologa).<br>– Vincola solo i creditori aderenti, tranne alcuni casi in cui si estende a dissenzienti finanziari (cram-down finanziario).<br>– Creditori non aderenti devono essere pagati integralmente alla scadenza naturale (o entro 120 giorni da omologa se già scaduti), altrimenti niente omologa.<br>– Riduzione/ristrutturazione dei debiti secondo accordo; possibilità di transazione fiscale analoga al concordato (art. 63 CCII). | – Consenso di creditori rappresentanti ≥60% dei debiti totali (accordo “pieno”).<br>– Soddisfazione integrale dei creditori estranei nei termini di legge (salvo diversa moratoria se autorizzata).<br>– Attestazione di un esperto sulla fattibilità e sulla veridicità dei dati aziendali.<br>– Omologazione da parte del tribunale (controllo di legalità e merito relativo).<br>– Possibili varianti: ARD agevolato (≥30% di adesioni se estranei comunque pagati al 100%) e ARD ad efficacia estesa (estensione a dissenzienti finanziari se ≥75% aderisce in quella categoria). |
| Composizione negoziata (strumento di allerta)** | Tutte le imprese (anche piccole) in situazione di squilibrio finanziario potenzialmente reversibile | Facilitare un accordo stragiudiziale o pre-concorsuale con i creditori, con l’aiuto di un esperto nominato, evitando l’insolvenza | – Nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori.<br>– Procedura riservata (non iscritta salvo richiesta di misure protettive).<br>– Possibilità di misure protettive dal tribunale: sospensione temporanea di azioni esecutive (di regola 4 mesi) mentre si negozia.<br>– Possibilità di accordi parziali con singoli creditori (anche accordo fiscale per pagamento parziale imposte).<br>– Eventuale accesso a finanziamenti prededucibili autorizzati dal tribunale per urgenze di cassa.<br>– Se accordo riesce: può restare privato (contratto) o essere formalizzato in uno degli strumenti di cui sopra (es. accordo di ristrutturazione o concordato). Se non riesce: l’esperto chiude le trattative; il debitore può comunque optare per concordato semplificato liquidatorio. | – Presenza di segni di crisi ma ragionevoli prospettive di risanamento (verificate nella piattaforma telematica delle Camere di Commercio).<br>– Nessun requisito dimensionale minimo (anche micro-imprese).<br>– Debitore deve cooperare con trasparenza; l’esperto riferisce se trova ostacoli o mancanza di buona fede (può far terminare prima la procedura).<br>– Per ottenere misure protettive dal tribunale, serve attestazione che sono necessari e che la trattativa è in corso con concrete possibilità di esito (il tribunale può revocarle se il debitore abusa della protezione).<br>– Durata massima: 180 giorni prorogabile di 180 (norma originaria) – correttivo ha lasciato flessibilità, ma in generale procedure veloci. |
| Concordato minore (sovraindebitamento) | Debitori non fallibili: imprenditori sotto soglie, professionisti, start-up innovative (esentate da fallimento), enti non commerciali, consumatori (se svolgono attività minima) | Simile al concordato, ma su scala ridotta: regolare la crisi da sovraindebitamento con accordo dei creditori e provvedimento del giudice | – Sospensione azioni esecutive come nel concordato grande.<br>– Proposta di pagamento parziale ai creditori, con eventuali garanti o apporti di terzi.<br>– I creditori votano sulla proposta (maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto).<br>– Omologazione dal tribunale (possibile anche senza voto favorevole se la maggioranza dei creditori non si forma ma il tribunale ritiene la proposta comunque più vantaggiosa per tutti rispetto alla liquidazione).<br>– A esecuzione del piano, il debitore persona fisica è esdebitato dal residuo (la società minore verrebbe estinta). | – Sovraindebitamento qualificato: situazione in cui il debitore non riesce a pagare i debiti nei termini e non ha accesso alle procedure maggiori (fallimento o concordato preventivo).<br>– Se il debitore è consumatore, la procedura analoga è il piano del consumatore (oggi “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”), che non richiede voto dei creditori, ma solo omologazione giudiziale, basata sulla verifica di meritevolezza e fattibilità.<br>– Contenuto della proposta: garantire ai creditori un’utilità non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione controllata.<br>– Pagamento di almeno il 20% ai chirografari in caso liquidatorio (art. 80 CCII) salvo che il debitore sia un consumatore. |
| Liquidazione controllata (sovraindebitamento) | Qualsiasi debitore sovraindebitato (persona fisica o giuridica minore), anche consumatore | Liquidazione giudiziale “piccola”: liquidare il patrimonio del debitore non fallibile per soddisfare i creditori | – Effetti simili al fallimento: nomina di un Liquidatore giudiziale, spossessamento del debitore sui beni (ma con rispetto maggiore dei bisogni personali, es. stipendi futuri in parte esclusi salvo quota disponibile dei 4 anni post apertura).<br>– I creditori presentano domande e sono soddisfatti pro-quota dal ricavato.<br>– Al termine, se il debitore persona fisica ha cooperato, può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui immediatamente su istanza (non automatica ma di regola concessa). | – Insolvenza o grave indebitamento del debitore non fallibile.<br>– Può accedervi anche chi ha tentato senza successo un concordato minore o piano consumatore.<br>– Patrimonio liquidabile non interamente assente (se proprio zero, c’è l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente).<br>– In caso di comportamento doloso del debitore (es. ha aggravato i debiti con colpa grave, o violato obblighi informativi), il giudice può escludere l’esdebitazione finale o dichiararlo improcedibile. |
La tabella 2 offre un confronto. In sintesi, dal punto di vista del debitore, il ventaglio va dal massimo controllo con strumenti volontari (piani attestati, comp. negoziata) al minimo controllo nel fallimento. Ovviamente, i creditori e l’ordinamento concedono maggiore libertà al debitore solo finché c’è la prospettiva di soddisfarli meglio che con la liquidazione forzata. Se il debitore abusa o ritarda troppo, la legge tende a togliergli la gestione (arrivando al fallimento).
Il punto cruciale è la tempestività: un’azienda indebitata deve attivarsi prima che i creditori perdano fiducia e avviino aggressioni scoordinate. Ad esempio, richiedere una composizione negoziata o presentare un concordato “in bianco” blocca il deterioramento e consente di trattare con tutti su un piano ordinato, evitando il caos di pignoramenti multipli.
5. Domande frequenti (FAQ) e casi pratici
Di seguito presentiamo una serie di domande comuni, con risposte sintetiche che consolidano quanto esposto, calandolo in situazioni pratiche tipiche dal punto di vista del debitore.
D: La mia SRL ha ricevuto diversi decreti ingiuntivi dai fornitori e non riesce a pagarli tutti. Cosa posso fare per difendermi e salvare l’azienda?
R: Innanzitutto, opporsi tempestivamente ai decreti ingiuntivi ove vi siano motivi validi (contestazioni sui crediti, prescrizioni, ecc.), per guadagnare tempo e forse ridurre l’importo preteso. In parallelo, avvia un dialogo con questi fornitori: spesso preferiscono una rinegoziazione stragiudiziale (ad esempio un piano di rientro) anziché affrontare una lunga esecuzione o rischiare il tuo fallimento. Se il debito complessivo è insostenibile ma l’azienda è ancora valida, considera di presentare un concordato preventivo “in bianco” che blocchi le azioni esecutive (come pignoramenti su conti e beni) e ti dia respiro per formulare una proposta di ristrutturazione . Ad esempio, potresti offrire ai fornitori di pagarli parzialmente (un certo % del credito) nell’arco di alcuni anni, magari attingendo ai futuri profitti; un concordato in continuità ben congegnato può essere votato dai creditori se credono nella prosecuzione dell’attività e se comunque offre più di quanto recupererebbero in caso di fallimento . Durante il concordato, le esecuzioni individuali sono sospese, e potrai continuare ad operare sotto la vigilanza del commissario. In alternativa, se i debiti dei fornitori sono l’unico problema e le banche supportano, potresti anche percorrere un accordo di ristrutturazione dei debiti: aderiscono i fornitori principali (almeno il 60% di quei crediti), e paghi integralmente i piccoli estranei. Questo accordo, omologato dal tribunale, eviterebbe la procedura più complessa del concordato e terrebbe l’azienda fuori dalla pubblicità di un fallimento. L’importante è agire subito: se lasci che i fornitori ottengano esecuzioni e pignorino i conti, l’operatività dell’azienda sarà compromessa. Meglio anticiparli con una soluzione concorsuale o stragiudiziale complessiva.
D: Ho debiti fiscali molto alti (IVA e ritenute) e l’Agenzia Entrate-Riscossione minaccia ipoteche e fermi. Posso risolvere senza perdere tutto?
R: Sì, ci sono diverse mosse. Primo, verifica se puoi accedere a qualche definizione agevolata in corso (nel 2023 c’era la rottamazione-quater, e per il 2025 si prospetta una “rottamazione V”). Queste misure ti permettono di pagare il debito sgravato di sanzioni e interessi e in comode rate, congelando nel frattempo qualunque azione esecutiva. Se non ci sono rottamazioni attive, valuta una rateizzazione ordinaria: con adeguate garanzie puoi ottenere fino a 6 o 10 anni di dilazione. Una volta in regola con le rate, AdER non potrà iscrivere nuovi fermi o ipoteche né procedere con pignoramenti, e soprattutto otterrai il DURC fiscale regolare per continuare a lavorare. Nel frattempo, controlla la legittimità delle cartelle: magari alcune sono vecchie e prescritte (molti tributi dopo 5 anni, se non sono stati notificati atti interruttivi). In tal caso puoi presentare un ricorso tributario per farle annullare. Riguardo all’ipoteca: sappi che se la tua è prima casa e unica proprietà, l’AdER può iscrivere ipoteca (oltre €20k di debito) ma non può espropriarla. In ogni caso l’ipoteca è solo una garanzia: se dilazioni o definisci il debito, non procederanno alla vendita e in futuro l’ipoteca verrà cancellata. In estrema ipotesi, se il debito fiscale è talmente alto da rendere impossibile qualsiasi pagamento integrale, si può includerlo in una procedura concorsuale: ad esempio, in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, proponendo di pagare al Fisco solo una percentuale (purché almeno pari a quanto otterrebbe liquidando i tuoi beni). Il tribunale può omologare anche senza il consenso diretto dell’Agenzia Entrate se il piano è conveniente. Questo però è un passo drastico da valutare con un tributarista e un esperto di crisi. In sintesi: difenditi attivamente – non subire passivamente cartelle e ipoteche. Rateizza, sfrutta rottamazioni e prescrizioni, e se sei in buona fede cerca un accordo col Fisco magari attraverso la composizione negoziata (oggi persino l’Erario può accettare pagamenti parziali in quella sede). Ciò ti eviterà la paralisi aziendale e potrai continuare l’attività mentre ripiani gradualmente il debito.
D: La banca ha revocato gli affidamenti e minaccia di escutere la fideiussione che ho firmato come socio. L’azienda è in crisi ma vorremmo salvarla. Come possiamo difenderci da azioni della banca?
R: La revoca degli affidamenti è un segnale serio: la banca teme per il suo credito. Prima che passi alle vie legali (ingiunzioni, pignoramenti ipotecari, escussione fideiussione), conviene aprirsi al dialogo. Prepara un piano di ristrutturazione del debito finanziario: ad esempio proponi di convertire lo scoperto revocato in un mutuo a medio termine, di ipotecare qualche bene aggiuntivo per dare garanzie o di far entrare un investitore/socio nuovo che apporti liquidità per rimborsare almeno una parte. Presenta questi elementi alla banca, magari con l’ausilio di un advisor finanziario, per rinegoziare il debito. Se la banca intravede una prospettiva di recuperare più denaro nel tempo, potrebbe aderire a un accordo. Tieni presente che come fideiussore personale hai interesse anche tu a trovare un’intesa, altrimenti la banca potrebbe venire direttamente sul tuo patrimonio personale (casa, conto corrente). Verifica con un avvocato se la tua fideiussione ricalca lo schema ABI 2003 sanzionato: in tal caso alcune clausole possono essere nulle, dandoti un po’ di margine di trattativa (la banca sa che potrebbe avere difficoltà giudiziarie a far valere interamente la garanzia omnibus). In parallelo, considera strumenti di allerta: potresti attivare la composizione negoziata con l’aiuto di un esperto terzo, che sedendosi al tavolo con la banca (e altri creditori) potrebbe facilitare un accordo equo. Durante la negoziazione, puoi chiedere misure protettive al tribunale per evitare che la banca pignori nel frattempo i tuoi beni o quelli aziendali. Se la situazione è molto compromessa e la banca non sente ragioni, un’opzione concorsuale è il concordato preventivo in continuità: includeresti la banca nel piano, magari pagando il suo credito ipotecario in modo dilazionato (o vendendo l’immobile ipotecato e dandole il ricavato). L’ammissione al concordato blocca la banca dal procedere esecutivamente (anche contro il fideiussore c’è il “beneficio” della moratoria concordataria, benché per i garanti non sia assoluto, in genere i tribunali lo estendono in via di fatto). In definitiva, la difesa migliore è proattiva: offrire alla banca una soluzione migliore di quella che otterrebbe liquidandoti d’imperio. In più, proteggi i tuoi beni personali: se hai prima casa non di lusso, ricorda che per il Fisco è impignorabile, ma per la banca no se hai ipoteca; valuta se puoi far rientrare la posizione entro parametri gestibili vendendo beni secondari o coinvolgendo un coobbligato più solvibile. Ogni caso è a sé: l’importante è non aspettare l’atto di pignoramento – una volta che la banca parte col procedimento, sarà meno incline a negoziare.
D: Ho una piccola ditta individuale ormai sommersa di debiti (fornitori, fisco, banca). Ho già chiuso l’attività perché non reggevo più. Come posso liberarmi dai debiti e difendermi da futuri pignoramenti sul mio stipendio (ora sono dipendente altrove)?
R: La legge offre una via d’uscita per le persone fisiche sovraindebitate onestamente: puoi rivolgerti all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) presso la tua Camera di Commercio o ordine professionale, e attivare una procedura di sovraindebitamento. Nel tuo caso, avendo cessato l’attività, potresti presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se la maggior parte dei debiti non deriva da attività d’impresa, oppure un concordato minore se comunque inerenti all’attività, ma essendo cessata potresti essere considerato “consumatore” ormai). Proporrai di pagare ai creditori quello che realisticamente puoi in base al tuo attuale stipendio, per un certo periodo (di solito 4–5 anni), e chiederai l’esdebitazione del resto. Ad esempio, se hai €100.000 di debiti e col tuo stipendio puoi pagarne €30.000 in 5 anni, proponi quello. I creditori verranno informati, ma nel piano del consumatore non serve nemmeno il loro voto, basta che il tribunale valuti il piano fattibile e che tu sia stato sincero e meritevole (ovvero che non hai fatto debiti con leggerezza o frode). Una volta omologato il piano, tu paghi quelle rate concordate; i creditori non possono aggredirti (lo stipendio è salvo pignoramenti, a meno che tu non decada dalla procedura) e al termine il giudice cancella i debiti residui. Se invece non hai proprio alcuna capacità di pagamento – poniamo che il tuo stipendio basti a malapena alle esigenze familiari – potresti chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente. È una novità: il tribunale, riconoscendo che non hai beni né redditi pignorabili, ti libera dai debiti subito; per 4 anni terrà monitorato se per caso non ti arriva una vincita o un’eredità, nel qual caso dovresti dare ai creditori ciò che eccede il necessario, ma se ciò non avviene i tuoi debiti pregressi sono definitivamente cancellati. Questa è proprio una “seconda chance”. In entrambi i casi, la difesa sta nell’usare la legge a tuo favore: non aspettare i decreti ingiuntivi o i pignoramenti sullo stipendio (che arriverebbero – il 1/5 dello stipendio te lo potrebbero togliere per anni); invece, iniziativa tua e vai dal giudice con un piano. Per esperienza, i giudici delle crisi concedono queste opportunità se vedono buona fede. Una volta ottenuta l’esdebitazione, i creditori non potranno più perseguitarti: addio cartelle, decreti, ecc. È l’equivalente di un “fallimento personale” ma con l’uscita pulita. Perciò, difenderti significa attivare una procedura di sovraindebitamento il prima possibile: nel frattempo eventuali esecuzioni sono sospese (puoi chiedere la sospensione al giudice appena ammette la procedura). Avrai la tranquillità per ripartire da capo, questa volta con le lezioni imparate dalla crisi precedente.
D: La nostra azienda ha un appalto pubblico in corso, ma siamo in sofferenza con contributi e rischiamo il DURC irregolare. Come evitare che ci tolgano il lavoro e ci escludano da future gare?
R: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è cruciale: un DURC negativo comporta l’esclusione automatica dalle gare e può portare alla risoluzione del contratto pubblico in essere. Quindi, per difendere la commessa attuale e la possibilità di lavorare ancora nel settore, devi regolarizzare la posizione contributiva/fiscale. Se non hai liquidità per saldare gli arretrati, la via è attivare un piano di rateazione sia con l’INPS/INAIL che con l’Erario. Una volta ottenute le dilazioni e pagata la prima rata, ti verrà rilasciato il DURC regolare (perché si considera che stai adempimento, seppur dilazionato). Ciò impedirà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza contributiva. In parallelo, informa il Responsabile del Procedimento dell’appalto della tua situazione e delle misure intraprese: la trasparenza può far guadagnare tempo (spesso concedono qualche settimana per procurarsi il DURC regolare prima di rescindere). Occhio all’art. 48-bis DPR 602/73: se la PA deve pagarti un SAL (stato avanzamento lavori) e tu hai debiti fiscali sopra €5k, il pagamento verrà bloccato e segnalato ad Agenzia Riscossione. Per evitare questo, assicurati di aver rateizzato anche quei debiti fiscali: con la domanda di rateazione accettata, non dovresti risultare “inadempiente” ai fini del 48-bis. Un’altra difesa: se sei già in crisi grave e temi di non finire il lavoro, valuta strumenti concorsuali con continuità. Ad esempio, presentare un concordato in continuità aziendale prima che la PA ti dichiari decaduto dall’appalto: con il concordato, puoi chiedere al tribunale di autorizzare la continuazione del contratto pubblico . La nuova normativa (Codice appalti 2023 e art. 95 CCII) consente all’impresa in concordato preventivo di proseguire l’esecuzione del contratto pubblico, previa attestazione che ciò è vantaggioso e garanzie date . Così eviti la risoluzione e porti a termine l’opera, pagando i contributi correnti sotto vigilanza del commissario. Infine, per le future gare: oltre al DURC, attento alle cause di esclusione ex art. 94 D.Lgs. 36/2023. Avere procedure concorsuali in corso può escludere, salvo concordato con continuità autorizzato. Quindi, se prevedi di partecipare a nuovi appalti durante la crisi, meglio risanare in silenzio (via accordi stragiudiziali magari) piuttosto che attivare procedure pubbliche, a meno che non sia inevitabile. In sintesi: difenditi proattivamente sul DURC (rateizza e paga) e usa la legge (concordato con continuità) per proteggere i contratti in essere, così i tuoi committenti pubblici non avranno motivo legale di estrometterti.
D: Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili personalmente dei debiti dell’azienda? Come si possono tutelare?
R: In generale, in una società di capitali (SRL, SPA), gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali verso i creditori, purché agiscano correttamente. Tuttavia, ci sono casi in cui possono diventare responsabili: – Fiduciariamente: se hanno firmato fideiussioni personali (tipico con banche, fornitori strategici). In tal caso, la responsabilità discende da quel contratto, non dal ruolo di amministratore. – Azioni di responsabilità: se la società fallisce o va in liquidazione e si riscontra che la mala gestio degli amministratori ha aggravato il dissesto (es. hanno continuato a fare debiti pur essendo matematicamente insolventi, o hanno distratto risorse), il curatore o i creditori possono fare causa agli amministratori per risarcimento. Ad esempio, non aver adottato “assetti adeguati” ex art. 2086 c.c. oggi è considerata grave violazione: tribunali hanno rimosso amministratori in sede di reclamo ex art. 2409 c.c. proprio perché non monitoravano la crisi. Se ciò ha portato danno (più debiti accumulati), potrebbero dover rispondere di tasca propria. – Obblighi tributari/previdenziali: amministratori possono avere sanzioni personali, anche penali, per omessi versamenti (vedi sopra). Inoltre, nel caso ad esempio di ritenute non versate, l’INPS può emettere avviso di addebito anche in capo al legale rappresentante per le sanzioni (ma di solito è penale la questione). E in caso di liquidazione volontaria della società: se gli amministratori distribuiscono attivi ai soci lasciando debiti non pagati, ne rispondono verso i creditori ex art. 2495 c.c. e 2394 c.c. – Reati fallimentari: se la società fallisce e emergono condotte distrattive o preferenze illegali, l’amministratore può subire condanne penali (bancarotta fraudolenta o preferenziale) e il giudice penale può condannarli anche a risarcire i danni ai creditori (costituiti parti civili). – Società di persone: se l’azienda è una SNC o SAS, i soci amministratori sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali, dunque i loro beni personali sono esposti direttamente. L’unica difesa qui è utilizzare procedure di sovraindebitamento per gestire anche il debito personale (es. far fallire la società e poi i soci chiedono esdebitazione, oppure concordato minore che coinvolga pure i soci).
Come tutelarsi: 1. Diligenza e allerta precoce: amministrare con prudenza. Adottare strumenti di controllo di gestione (flussi, indicatori), come richiesto dall’art. 2086 c.c. Se emergono segnali di crisi, attivarsi immediatamente – ad esempio riducendo costi, negoziando dilazioni, e se necessario attivando la composizione negoziata. La Cassazione ha sancito che l’adeguatezza degli assetti e la tempestiva reazione sono un obbligo legale: se lo rispetti, difficilmente potranno accusarti di aggravamento del dissesto. 2. Documentazione: tenere contabilità e bilanci corretti. Molte azioni di responsabilità fanno leva su conti falsati o su assenza di prove. Se i libri sono in ordine, l’amministratore mostra di non aver nulla da nascondere. 3. Non aggravare la posizione: evitare di contrarre nuovi debiti quando sai che non potrai pagarli. Ad esempio, se la società è insolvente ma continua ad accumulare debiti verso fornitori o fisco, quello può essere visto come mala gestio. Meglio, in tali casi, sospendere l’attività e cercare procedura concorsuale. Un amministratore che chiede concordato preventivo (invece di tirare avanti dissipando patrimonio altrui) in genere si protegge da colpa grave: sta facendo il possibile per regolarizzare la situazione secondo legge. 4. Transazioni con i creditori: se riesci a far approvare un concordato o un accordo collettivo, i creditori rinunciano a pretese ulteriori. Questo indirettamente blinda gli amministratori: ad esempio, in un concordato omologato con esecuzione regolare, è difficile immaginare un’azione di responsabilità dei creditori poi (perché hanno accettato un trattamento e l’hanno ottenuto). 5. Assicurazione D&O: Valuta un’assicurazione di responsabilità civile per amministratori e sindaci (D&O). Non coprirà dolo o casi gravissimi, ma potrebbe intervenire se vieni citato per negligenza. 6. Fondo patrimoniale / Trust: soluzioni di asset protection andrebbero fatte ante litteram (prima che la crisi sia conclamata, se no possono essere revocate come atti in frode ai creditori). Un amministratore potrebbe proteggere la casa con un fondo patrimoniale dedicato alla famiglia. Tuttavia, attenzione: i debiti di impresa non sempre beneficiano di quella protezione (se dimostrano che quei debiti erano contratti per bisogni di famiglia? In genere debiti fiscali o verso banche non lo sono, quindi il fondo potrebbe non opporsi con successo). 7. Esdebitazione personale: se tutto va male e l’amministratore finisce pieno di debiti personali (magari per fideiussioni escusse), può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento come persona fisica per essere liberato. Certo, è l’ultima spiaggia, ma esiste (vedi sopra).
In poche parole, un amministratore si difende meglio gestendo bene la crisi: se potessimo citare una sentenza, Cass. civ. n. 36365/2021 ha affermato che l’amministratore ha obbligo di predisporre mezzi idonei alla continuità e, se non lo fa, può incorrere in responsabilità. Quindi paradossalmente, attivare le procedure come concordato o comp. negoziata, invece di scappare, è una difesa sia per l’azienda sia per sé stessi. Evita l’accusa di inerzia colposa o di aver fatto “struthio-camelus” (la politica dello struzzo). Mostrando proattività e correttezza, riduci moltissimo il rischio di dover rispondere tu dei debiti sociali.
Fonti e riferimenti
(In questa sezione elenchiamo le fonti normative e giurisprudenziali autorevoli citate o utilizzate nella guida, per approfondimento e verifica.)
- Codice Civile, art. 2086 comma 2 – Obbligo per l’imprenditore di istituire assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e continuità aziendale, introdotto dall’art. 375 D.Lgs. 14/2019.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, modificato dai D.Lgs. 83/2022 e 136/2024) – in particolare art. 2 (soglie liquidazione giudiziale), artt. 17-25 (Composizione negoziata), art. 23 comma 2-bis (accordo Fisco in comp. negoziata), art. 54 (misure protettive), art. 57-64 (Accordi di ristrutturazione), art. 63 (transazione fiscale negli accordi), art. 74-83 (Concordato minore), art. 80 (soglia 20% sovraindebitamento), artt. 84-88 (Concordato preventivo; requisiti continuità vs liquidatorio) , art. 94 D.Lgs. 36/2023 (cause di esclusione appalti per concordato), art. 95 CCII (continuità nei contratti pubblici) , art. 109 CCII (esdebitazione persone fisiche), art. 268-277 (Liquidazione controllata), art. 283 (Esdebitazione del debitore incapiente).
- Codice di Procedura Civile, in particolare art. 615 e 617 c.p.c. (opposizioni esecuzione e atti), art. 633 ss. c.p.c. (decreto ingiuntivo), art. 642 c.p.c. (provvisoria esecuzione), art. 648 c.p.c. (esecuzione dopo opposizione), art. 183 c.p.c. (emendatio/novatio domande, v. Cass. SU 26727/2024).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 48-bis (verifica pubblica amministrazione prima di pagare debitore moroso), 76 (limiti pignoramento prima casa da parte AdER), 77 (ipoteca), 78 (iter espropriazione esattoriale).
- D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (conv. L.157/2019) e Corte Cost. n. 15/2022 – Omesso versamento IVA soglia €250k annuali reato; D.Lgs. 74/2000 art. 10-bis e 10-ter – reati tributari omissivi (soglie €150k per ritenute e €250k per IVA). L. n. 638/1983 art. 2 – reato omesso versamento contributi > €10k (Constitutional Court pending, v. Corte Cost. n. 139/2021 e n. 103/2025 in G.U.).
- Legge 197/2022 (Bilancio 2023), commi 231-252 – Rottamazione-quater cartelle (definizione agevolata 2000-2017); Bozza Legge Bilancio 2026 – prevista Rottamazione-quinquies (V) con pagamento tributi 2000-2023 senza sanzioni, fino a 18 anni.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 15 ottobre 2024 n. 26727 – Opposizione a decreto ingiuntivo: ammissibilità per il creditore opposto di domande alternative fondate sul medesimo rapporto sostanziale.
- Cassazione civile, Sez. Unite, 30 dicembre 2021 n. 41994 – Nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI censurato nel 2005: invalide le clausole di reviviscenza, rinuncia termini ex art.1957 c.c., ecc., ma contratto valido per il resto.
- Cassazione civile, Sez. I, 29 novembre 2021 n. 36365 – Doveri dell’imprenditore ex art. 2086 c.c.: l’obbligo di predisporre assetti adeguati grava anche sugli amministratori di società; la mancata attivazione di strumenti per rilevare e reagire alla crisi può integrare grave irregolarità gestionale, fonte di responsabilità.
- Cassazione civile, Sez. I, 12 settembre 2014 n. 19270 – Impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia: la nuova norma (art. 76 DPR 602/73 modif. dal DL 69/2013) si applica ai pignoramenti esattoriali pendenti alla data di entrata in vigore (21/08/2013); va disposta la cessazione dell’esecuzione e cancellata la trascrizione se l’immobile pignorato è unica casa, non di lusso e residenza del debitore.
- Corte Costituzionale, sentenza 17 ottobre 2023 n. 190 – Impugnazione del ruolo e della cartella noti tramite estratto di ruolo: dichiarate inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 12 co. 4-bis DPR 602/73 introdotto nel 2021; la Consulta riconosce che la limitazione incide sulla tutela giurisdizionale del contribuente, ma invita il legislatore a porvi rimedio, stante la necessità di evitare ricorsi strumentali. (Dunque resta vigente il divieto di impugnazione “immediata” dell’estratto, salvo eccezioni ex lege).
- Corte di Cassazione, Sez. Trib., 17 luglio 2020 n. 15292 – In tema di “stralcio” dei debiti fino €1000 (DL 119/2018), ha chiarito aspetti sul discarico dei ruoli. (Richiamata tra le fonti normative in Fiscomania).
- Corte di Cassazione, SS.UU. 13 febbraio 2020 n. 7822 e n. 7823 – Competenza giurisdizionale per fermo amministrativo e ipoteca ex artt. 86 e 77 DPR 602/73: trattandosi di atti della riscossione relativi a crediti tributari, le opposizioni vanno proposte dinanzi al giudice tributario, non a quello ordinario, tranne per aspetti formali. (Consolidato poi da legislatore in L. 130/2022).
- Corte di Cassazione, SS.UU. 25 maggio 2021 n. 8500 – (Massa esattoriale/estratto di ruolo) Ha statuito – ante modifica – che l’estratto di ruolo non è atto impugnabile se non nelle ipotesi di cui all’art. 12 co. 4-bis DPR 602/73 (introducendo il contrasto poi risolto dal DL 146/2021 e Corte Cost. 190/2023).
- Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 2025 n. 103 – (In G.U.) Ha giudicato legittimo il doppio binario sanzionatorio per omesso versamento contributi: soglia €10.000 annui penale, sotto soglia illecito amministrativo (respingendo dubbi di ragionevolezza).
- “Riforma della riscossione – Discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni”, D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, illustrata da Fiscomania (E. Migliorini, ult. agg. 2/9/2025): introduce dal 2025 il discarico d’ufficio dei crediti non riscossi entro 5 anni dall’affidamento ad AdER. Non estingue il debito ma libera AdER dal carico, restituendolo all’ente creditore. Previsti allungamento piani rate a 10 anni e commissione per smaltire ruoli pre-2024.
- Corte di Cassazione, sez. I, 26 febbraio 2025 n. 9549 – (indicata da professionistidellacrisi) sulla possibilità di inserire moratoria pagamenti nel piano del consumatore (flessibilità ristrutturazione debiti).
- Norme codice appalti 2023: Art. 11 D.Lgs. 36/2023 (obbligo DURC regolare e CCNL), Art. 94 (esclusione per concordato/liquidazione in corso, salvo continuità autorizzata), FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) – digitalizzazione DURC.
- Corte Cass. sez. un. 07/02/2023 n. 30416 (SS.UU. penali) –i – rileva responsabilità penale amministratori per omissioni causative di dissesto (bancarotta impropria da violazione obblighi di legge, art. 330 CCII).
La tua azienda che realizza impermeabilizzazioni industriali, impermeabilizzazioni di capannoni, coperture impermeabili, membrane bituminose, guaina liquida, poliurea, resine, tetti piani, linee vita, coibentazioni, rifacimenti completi, bonifiche amianto, manutenzioni di coperture industriali e interventi urgenti contro infiltrazioni si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che realizza impermeabilizzazioni industriali, impermeabilizzazioni di capannoni, coperture impermeabili, membrane bituminose, guaina liquida, poliurea, resine, tetti piani, linee vita, coibentazioni, rifacimenti completi, bonifiche amianto, manutenzioni di coperture industriali e interventi urgenti contro infiltrazioni si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni con Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori di materiali, piattaforme, mezzi, trasportatori, finanziarie o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore dell’impermeabilizzazione industriale è complesso e ad alto costo: richiede materiali certificati, manodopera specializzata, attrezzature tecniche, piattaforme aeree, sicurezza in quota, cantieri organizzati e continui anticipi di spesa.
Basta un ritardo negli incassi, un cantiere sospeso o una riduzione dei fidi bancari per far emergere una crisi anche molto grave.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata e rilanciata, se intervieni nel modo giusto e rapidamente.
Perché un’Azienda di Impermeabilizzazione Va in Debito
Le cause più diffuse includono:
- aumento dei costi di membrane, guaine, resine, poliurea e materiali isolanti
- rincari di autogru, piattaforme aeree, ponteggi, mezzi e carburante
- ritardi nei pagamenti da parte di imprese edili, industrie, general contractor e PA
- cantieri bloccati da meteo, permessi, bonifiche, controversie o varianti
- costi elevati di personale, sicurezza e DPI
- investimenti in attrezzature, pompe per resine, macchine per poliurea
- magazzino immobilizzato tra membrane, rotoli, resine e accessori
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema quasi sempre è la mancanza di liquidità immediata, non la mancanza di commesse.
I Rischi per un’Azienda di Impermeabilizzazione con Debiti
Se non intervieni rapidamente rischi:
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di membrane, resine, guaine, materiali isolanti
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di mezzi, attrezzature, pompe e materiali
- impossibilità di completare cantieri, urgenze e manutenzioni
- perdita di appalti strategici e clienti importanti
- rischio concreto di fermo totale dell’attività
Una crisi non gestita può fermare l’intera organizzazione operativa.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- bloccare richieste di rientro immediate
- proteggere conti correnti e liquidità
- evitare lo stop delle forniture critiche
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si passa alla ristrutturazione dei debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso nei debiti si trovano irregolarità:
- interessi non dovuti o calcolati male
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Entrate-Riscossione
- costi e commissioni bancarie anomale
Una parte importante del debito può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili
Le opzioni più efficaci includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori chiave
- rinegoziazione delle linee bancarie
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
L’obiettivo è ripristinare liquidità e sostenere i cantieri attivi.
4. Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Per situazioni più complesse si possono adottare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- concordato minore
- liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Queste procedure:
- bloccano TUTTI i creditori
- sospendono pignoramenti e azioni esecutive
- permettono di pagare solo una parte dei debiti
- consentono la continuità operativa
5. Proteggere materiali, attrezzature e cantieri
Per un’azienda di impermeabilizzazione è fondamentale tutelare:
- membrane, rotoli, guaine, resine, primer, materiali isolanti
- attrezzature: pompe, miscelatori, cannoni per poliurea, utensili tecnici
- mezzi: autocarri, piattaforme, furgoni
- documentazione: POS, piani di sicurezza, certificazioni
- continuità dei cantieri e delle urgenze
Un blocco del magazzino o dei mezzi può fermare completamente l’attività.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- Elenco completo dei debiti (bancari, fiscali, commerciali)
- Estratti conto aggiornati
- Estratto di ruolo
- Bilanci e documentazione fiscale
- Lista fornitori strategici (materiali impermeabilizzanti, attrezzature, piattaforme)
- Inventario magazzino
- Atti giudiziari ricevuti
- Cantieri aperti, contratti e cronoprogrammi
Tempistiche di Intervento
- Analisi preliminare in 24–72 ore
- Blocco dei creditori in 48 ore – 7 giorni
- Piano di ristrutturazione in 30–90 giorni
- Eventuale procedura giudiziaria in 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi già dai primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
- Stop immediato ai pignoramenti
- Riduzione concreta dei debiti
- Protezione di materiali, attrezzature e mezzi
- Trattative efficaci con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- Continuazione dei lavori e dei cantieri
- Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
- Ignorare solleciti o atti giudiziari
- Fare nuovi debiti per coprire quelli vecchi
- Pagare solo alcuni fornitori
- Lasciare avanzare pignoramenti
- Affidarsi a società senza competenze legali reali
Ogni errore aumenta il rischio di fermo aziendale.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- Analisi approfondita della tua esposizione debitoria
- Blocco immediato delle azioni dei creditori
- Redazione di piani di ristrutturazione su misura
- Attivazione degli strumenti legali più efficaci
- Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Tutela completa dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di impermeabilizzazione per industrie e capannoni non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e mirata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre sensibilmente i debiti
- proteggere materiali, attrezzature, mezzi e cantieri
- mantenere la continuità operativa
- salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.