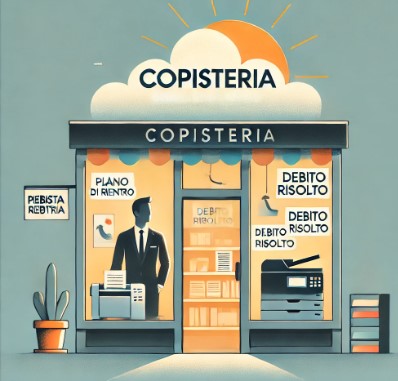Gestisci una copisteria o un piccolo centro stampa e ti trovi in difficoltà economica per via di debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche? È una situazione comune a molte attività del settore, messe in crisi dall’aumento dei costi, dalla digitalizzazione dei servizi e dalla concorrenza dei grandi centri o delle piattaforme online. Quando iniziano ad arrivare cartelle esattoriali, solleciti o pignoramenti, la situazione può rapidamente diventare ingestibile. La buona notizia è che la legge offre strumenti concreti per difendersi, ristrutturare o cancellare i debiti, tutelando la tua attività e il tuo patrimonio personale.
Perché molte copisterie si indebitano
Le cause più frequenti di indebitamento per le copisterie derivano dalla contrazione del mercato e dai costi di gestione sempre più alti. I rincari di energia, carta, toner e materiali di consumo hanno ridotto i margini di guadagno, mentre il calo della clientela universitaria e l’uso crescente di strumenti digitali hanno diminuito gli incassi. Spese fisse come affitti, leasing delle stampanti, contributi e tasse, unite ai ritardi nei pagamenti dei clienti, rendono difficile mantenere la liquidità necessaria. Molti titolari, per far fronte alle spese quotidiane, rinviano i versamenti fiscali o contributivi, accumulando così debiti che crescono con interessi e sanzioni.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Quando il debito non viene saldato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono avviare procedure di recupero. Le più frequenti sono la notifica di cartelle esattoriali, le intimazioni di pagamento, i pignoramenti dei conti correnti o dei compensi, i fermi amministrativi sui veicoli e le ipoteche sugli immobili. Gli importi aumentano nel tempo a causa di sanzioni e interessi, e la pressione fiscale può mettere a rischio la sopravvivenza dell’attività. Se gestisci la copisteria come ditta individuale, rispondi personalmente dei debiti, anche con i beni personali.
Cosa fare subito se hai debiti come titolare di una copisteria
Il primo passo è avere un quadro preciso della situazione. Richiedi l’estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conoscere gli importi, gli anni e i creditori coinvolti. Verifica poi la regolarità delle cartelle: molte contengono errori di notifica, importi prescritti o somme non dovute che un avvocato può contestare. Se i debiti sono corretti, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili e sospendere le azioni di recupero. È utile anche controllare se è attiva una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale, cancellando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o ipoteche, puoi chiedere la sospensione immediata con un ricorso o un’istanza di autotutela.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se il debito è troppo alto e non riesci più a sostenerlo, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È uno strumento legale dedicato a piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che consente di bloccare pignoramenti e azioni esecutive, proporre un piano di rientro sostenibile e ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui (esdebitazione). È una procedura riconosciuta dai tribunali italiani e rappresenta la via più sicura per chi vuole salvare la propria attività o chiuderla in modo ordinato, senza lasciare pendenze fiscali o bancarie.
Come difendersi da banche, fornitori e finanziarie
Molte copisterie si indebitano anche con banche o fornitori di materiali e macchinari. In questi casi puoi chiedere la rinegoziazione dei finanziamenti, proporre un saldo e stralcio per chiudere la posizione a un importo ridotto, verificare la presenza di clausole abusive o interessi usurari nei contratti e impugnare eventuali decreti ingiuntivi entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nelle trattative con i creditori, aiutandoti a proteggere la tua attività e a trovare soluzioni sostenibili, evitando il fallimento o la chiusura forzata.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Una difesa legale ben strutturata può portare risultati concreti: sospensione dei pignoramenti e delle azioni esecutive, rateizzazione o cancellazione dei debiti fiscali e contributivi, protezione dei beni personali e continuità dell’attività. In molti casi è possibile evitare la chiusura del centro stampa e ripartire con un piano di rientro realistico e sostenibile.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto cartelle, intimazioni di pagamento o pignoramenti, se hai debiti con il Fisco o con le banche che non riesci più a gestire, o se temi la chiusura della tua attività. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento può bloccare la riscossione, contestare gli atti illegittimi e guidarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire tempestivamente è essenziale per difendere la tua impresa e tutelare il tuo patrimonio.
⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o gli avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, blocchi dei conti e perdita dei beni personali. Intervenire subito è l’unico modo per salvare la tua attività e ricominciare senza debiti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle attività commerciali – spiega cosa fare se gestisci una copisteria con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che mettono a rischio la tua copisteria?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Una copisteria – tipicamente una piccola impresa specializzata in servizi di stampa, fotocopie e rilegature per terzi – può trovarsi esposta a debiti di varia natura. Tasse non pagate, contributi previdenziali arretrati, rate di mutui o finanziamenti scadute, fatture insolute verso fornitori, oppure canoni di affitto commerciali non corrisposti: tutte queste passività possono accumularsi e mettere in crisi l’attività. Dal punto di vista del debitore (il titolare o la società che gestisce la copisteria), affrontare una situazione di indebitamento richiede la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento italiano e delle strategie legali per gestire o ridurre i debiti.
Questa guida offre un quadro avanzato e dettagliato, rivolto tanto ad avvocati quanto a imprenditori e privati, sulle soluzioni giuridiche disponibili quando una copisteria è gravata dai debiti. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma con taglio divulgativo, per spiegare cosa fare e come difendersi in caso di debiti eccessivi. Saranno illustrate le diverse tipologie di debiti (fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, locativi, ecc.) e le rispettive conseguenze, distinguendo le situazioni a seconda della forma giuridica dell’attività (ditta individuale, società di persone come SNC, società di capitali come SRL, ecc.). Verranno poi esaminati sia gli strumenti extragiudiziali (soluzioni stragiudiziali, piani di rientro, composizione negoziata) sia le procedure giudiziali concorsuali oggi previste dal legislatore italiano: dalla liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”) alle procedure di sovraindebitamento introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), inclusi il concordato minore, la liquidazione controllata e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il tutto sarà corredato da riferimenti normativi aggiornati e dalle più recenti sentenze della giurisprudenza, per fornire una guida completa e attendibile. In fondo al documento, una sezione di Fonti e riferimenti normativi elencherà la normativa e le pronunce giurisprudenziali citate.
Struttura della guida: dopo un esame delle tipologie di debiti e dei relativi rischi, analizzeremo le strategie difensive a disposizione del debitore, prima in via stragiudiziale e poi attraverso le procedure giudiziali. Saranno incluse tabelle riepilogative per confrontare le diverse procedure concorsuali e le differenze tra forme societarie, nonché esempi pratici e una sezione finale di Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti (FAQ). L’obiettivo è fornire al titolare di una copisteria indebitata una bussola per orientarsi tra le norme e difendere al meglio i propri diritti, evitando errori che possano aggravare la situazione debitoria. È importante ricordare che ogni caso concreto va valutato con attenzione – possibilmente con l’assistenza di un professionista legale – ma conoscere in anticipo gli strumenti offerti dalla legge può fare la differenza nel salvare l’attività o quanto meno nel limitare i danni e ripartire senza il peso dei debiti residui (grazie agli istituti dell’esdebitazione, di cui diremo più avanti).
Passiamo dunque in rassegna i principali aspetti da considerare quando una copisteria si trova in crisi per i debiti, partendo dalla natura di questi debiti e dalle responsabilità giuridiche connesse.
Tipologie di debiti di una copisteria
Una copisteria può contrarre diversi tipi di debiti nello svolgimento della sua attività. È utile distinguere le varie categorie di debito perché ciascuna è regolata da norme specifiche e comporta conseguenze diverse. Ecco le principali tipologie rilevanti:
- Debiti fiscali (tributari): comprendono le imposte dovute e non versate (es. IVA sulle vendite, imposta sul reddito d’impresa o IRPEF per ditte individuali, eventuale IRAP, ecc.) nonché le somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) tramite cartelle esattoriali. I debiti fiscali possono generare sanzioni e interessi di mora e godono di cause di prelazione (privilegi) in caso di insolvenza. Ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate ai dipendenti sono crediti privilegiati nello scenario concorsuale (hanno priorità di pagamento) . Inoltre, il mancato pagamento di talune imposte oltre soglie di legge può integrare reati tributari (come l’omesso versamento IVA sopra 250.000 € ex art. 10-ter D.lgs. 74/2000, o l’omesso versamento di ritenute sopra soglia). Il fisco dispone di poteri di riscossione coattiva molto incisivi: in presenza di cartelle esattoriali non pagate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore (per debiti ≥ 20.000 €) e avviare pignoramenti su beni mobili, conti correnti o crediti verso terzi, salvo alcuni limiti (ad es. non può ipotecare o pignorare la prima casa se è l’unico immobile di residenza e il debito è sotto 120.000 €, come vedremo) .
- Debiti previdenziali: sono quelli verso gli enti previdenziali (principalmente INPS), ad esempio contributi non versati per i dipendenti della copisteria (contributi obbligatori su stipendi) oppure, nel caso di ditte individuali o società di persone, i contributi dovuti dal titolare o dai soci alla Gestione artigiani/commercianti. Questi debiti spesso sono riscossi con le stesse modalità dei tributi (cartelle esattoriali) e beneficiano di privilegi nel concorso tra creditori (i contributi non pagati ai dipendenti hanno privilegio generale sui mobili ex art. 2753 c.c.). Anche l’omesso versamento di ritenute previdenziali (trattenute al dipendente in busta paga ma non versate all’INPS) oltre una certa soglia è penalmente sanzionato. L’INPS, tramite Agenzia Riscossione, può attivare misure esecutive simili a quelle del fisco (espropriazioni, fermi amministrativi su veicoli aziendali) per recuperare i contributi dovuti.
- Debiti bancari e finanziari: derivano da prestiti, affidamenti in conto corrente, mutui o leasing contratti per finanziare l’attività. Una copisteria potrebbe aver acceso un mutuo per acquistare macchinari (es. stampanti professionali) o ottenuto un fido di cassa dalla banca. Se non riesce a rimborsare regolarmente le rate o rientrare dall’esposizione, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rimborso integrale. In caso di persistenza del mancato pagamento, la banca (o la finanziaria/leasing) può agire giudizialmente ottenendo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e procedere a pignorare i beni dell’azienda o del debitore (incluse eventualmente le macchine prese in leasing, che spesso sono di proprietà della leasing e possono essere riprese al termine della procedura). I debiti bancari non pagati comportano anche la segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e nelle banche dati creditizie (ad es. CRIF), compromettendo l’accesso futuro al credito. Molto frequenti sono anche le fideiussioni personali: se la copisteria è gestita da una SRL, può darsi che la banca abbia richiesto al socio/amministratore una garanzia personale; in tal caso, il mancato pagamento attiverà le pretese anche sul patrimonio personale del garante.
- Debiti verso fornitori: riguardano le fatture non saldate ai fornitori di merci e servizi. Nel caso di una copisteria, i fornitori tipici sono quelli di carta, toner, attrezzature, nonché le utenze (bollette di energia elettrica, telefono, internet) e altri servizi. Questi creditori sono normalmente chirografari (senza garanzie né privilegi) e in caso di insolvenza verranno soddisfatti dopo i crediti privilegiati. Tuttavia, nel breve termine, i fornitori possono tutelarsi sospendendo le forniture (se non vengono pagati, interrompono le consegne) e possono agire per vie legali: spesso ricorrono al decreto ingiuntivo per ottenere in tempi rapidi un titolo esecutivo. Una volta muniti di titolo, possono iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore o procedere con pignoramenti (di beni mobili presenti in copisteria, del conto corrente aziendale, oppure pignoramento presso terzi come ad esempio crediti che la copisteria vanta verso i propri clienti). I fornitori non hanno strumenti drastici come il fisco, ma un insieme di decreti ingiuntivi può condurre l’azienda all’aggressione di tutti i suoi beni liquidi. I fornitori, inoltre, potrebbero coalizzarsi: ad esempio più piccoli creditori potrebbero presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se ritengono che l’azienda sia insolvente, purché i debiti scaduti superino una certa soglia (nel CCII attuale è richiesta un’esposizione scaduta ≥ €30.000 per poter aprire una liquidazione giudiziale ).
- Debiti da locazione commerciale: riguardano l’affitto dei locali in cui opera la copisteria. Se l’attività è in locazione (caso frequente, essendo spesso situata in prossimità di università o centri cittadini), i canoni non pagati espongono al rischio di sfratto per morosità. Il proprietario dell’immobile, dopo alcuni mesi di mancato pagamento (anche una sola mensilità può bastare in teoria), può avviare la procedura di sfratto: il tribunale, verificata la morosità, emette un’ordinanza di rilascio dell’immobile (convalida di sfratto), spesso condizionata al mancato pagamento entro un termine di grazia (ex art. 55 L. 392/1978, il conduttore può evitare lo sfratto saldando interamente gli arretrati alla prima udienza). Se il debito non viene estinto, la copisteria rischia di perdere il locale commerciale e dover cessare l’attività per mancanza della sede. Inoltre, il locatore ha diritto di ottenere un decreto ingiuntivo per i canoni arretrati e attivare il pignoramento dei beni del conduttore per recuperarli. Da notare che i crediti da locazione godono di privilegio speciale sui beni mobili che arredano l’immobile locato (art. 2764 c.c., ad esempio il locatore può essere parzialmente preferito su mobili presenti nei locali della copisteria fino a due anni di canoni). In procedure concorsuali, i canoni degli ultimi mesi possono essere considerati crediti prededucibili o privilegiati entro certi limiti.
- Debiti verso il personale (dipendenti): qualora la copisteria abbia dipendenti o collaboratori, il mancato pagamento di stipendi, TFR o compensi genera debiti di natura privilegiata (i lavoratori subordinati hanno un privilegio generale sui mobili per le retribuzioni degli ultimi 12 mesi e TFR, ex art. 2751-bis c.c.). In caso di crisi grave dell’impresa, i dipendenti possono agire giudizialmente (ingiunzione per paghe arretrate) e anche chiedere le dimissioni per giusta causa se non ricevono lo stipendio, con diritto alla disoccupazione (Naspi). Inoltre, in caso di insolvenza conclamata (es. liquidazione giudiziale), interviene il Fondo di Garanzia INPS per anticipare TFR e ultime mensilità ai lavoratori, surrogandosi poi nei loro diritti verso il datore. È bene ricordare che alcune condotte, come l’omissione dolosa del versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) o gravi violazioni in materia di sicurezza e contributi, possono avere risvolti penali o amministrativi per l’imprenditore.
Oltre a queste categorie principali, una copisteria potrebbe avere debiti personali del titolare connessi all’attività (ad es. sanzioni amministrative per violazioni varie, debiti verso soci finanziatori, fideiussioni escusse, ecc.). Ciascun tipo di debito ha implicazioni diverse: alcuni creditori (fisco, INPS) hanno poteri più forti e crediti privilegiati; altri (banche, locatori) possono rapidamente ottenere titoli esecutivi; altri ancora (fornitori chirografari) rischiano di rimanere insoddisfatti se il patrimonio è insufficiente, il che li spinge magari a iniziative concorsuali.
Importante: i termini di prescrizione variano per tipologia (i tributi si prescrivono generalmente in 5 anni dopo la notifica della cartella se non rinnovata, i contributi pure 5 anni, le fatture commerciali 5 anni, canoni locazione 5 anni, assegni non pagati 6 mesi per protesto etc.). Verificare se un debito è prescritto può essere una linea difensiva (ad esempio, contestare una cartella esattoriale antica). Tuttavia, spesso i creditori attivano atti interruttivi che azzerano i termini.
Nei prossimi paragrafi vedremo come il tipo di debito interagisce con la forma giuridica dell’impresa e quali strumenti specifici di difesa o definizione agevolata sono previsti (ad esempio, dilazioni di pagamento per debiti fiscali/previdenziali, transazioni con banche o fornitori, ecc.). Prima, però, è fondamentale chiarire come la forma giuridica della copisteria incide sulla responsabilità per i debiti.
Forma giuridica dell’impresa e responsabilità per i debiti
Le obbligazioni debitorie di una copisteria possono ricadere in maniera differente sul patrimonio del titolare a seconda della forma giuridica con cui è esercitata l’attività. In Italia, una copisteria può essere gestita come impresa individuale (ditta individuale), come società di persone (es. una SNC – società in nome collettivo – tra soci, o una SAS) oppure come società di capitali (ad esempio una SRL, società a responsabilità limitata, eventualmente nella forma semplificata SRLS). Ecco le differenze principali dal punto di vista della responsabilità verso i debiti e dell’accesso alle procedure concorsuali:
- Ditta individuale (impresa individuale): il titolare è una persona fisica che esercita l’attività commerciale senza un’entità giuridica autonoma. Ciò comporta responsabilità illimitata: il titolare risponde di tutti i debiti dell’impresa con tutto il suo patrimonio personale, presente e futuro (art. 2740 c.c.). Non c’è separazione tra i beni “aziendali” e quelli personali (salvo il beneficio dell’imprenditore di non subire esecuzioni sulla casa di abitazione se rientra nei limiti di legge per il fisco, come visto). In caso di insolvenza grave, l’imprenditore individuale può essere soggetto a liquidazione giudiziale (fallimento), a meno che non sia qualificato come piccolo imprenditore sotto le soglie previste (vedi oltre). Storicamente, i piccoli imprenditori commerciali erano esclusi dal fallimento; oggi il CCII ha formalizzato precisi limiti dimensionali. Se la ditta individuale supera anche uno solo dei parametri seguenti – attivo annuo > €300.000, ricavi annui > €200.000, debiti > €500.000 – essa è assoggettabile a liquidazione giudiziale in caso d’insolvenza . Viceversa, se resta sotto tutti questi tre limiti, è considerata “impresa minore” e non può essere dichiarata in liquidazione giudiziale ordinaria . L’onere di provare il mancato superamento di tali soglie incombe sul debitore . Ad esempio, una copisteria individuale con debiti totali per €600.000 (anche se attivo e ricavi inferiori) sarebbe soggetta a fallimento se insolvente, mentre con €400.000 di debiti e parametri di fatturato/attivo sotto soglia, non potrebbe essere sottoposta a liquidazione giudiziale – in tal caso restano applicabili solo le procedure di sovraindebitamento (il cosiddetto concordato minore, liquidazione controllata, ecc. previsti per il debitore civile). Da notare che l’imprenditore individuale non fallibile non sfugge comunque alle responsabilità: i creditori possono chiederne la liquidazione controllata (procedura concorsuale minore) e aggredirne il patrimonio personale. Vantaggio del ricorso alle procedure concorsuali (fallimento o sovraindebitamento) per il titolare è la possibile esdebitazione finale, ossia la liberazione dai debiti residui una volta terminata la procedura, come dettagliato più avanti.
- Società di persone (SNC, SAS): nelle società di persone i soci rispondono in maniera illimitata e solidale delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c. per SNC; art. 2313 c.c. per SAS – in quest’ultima i soli soci accomandatari hanno responsabilità illimitata, mentre gli accomandanti sono limitatamente responsabili ma non possono gestire). Ciò significa che se la copisteria è organizzata come SNC, ogni socio è personalmente obbligato per i debiti della società, e i creditori sociali possono escutere i soci (dopo aver escusso il patrimonio sociale). In caso di insolvenza di una SNC o SAS, la società può essere dichiarata in liquidazione giudiziale se supera i limiti di fallibilità. Inoltre, insieme alla società vengono automaticamente assoggettati a procedura concorsuale anche i soci a responsabilità illimitata (art. 147 L.F. ante 2022, ora trasfuso in CCII) – in pratica, se una SNC viene dichiarata in liquidazione giudiziale, anche il patrimonio personale dei soci sarà coinvolto nella procedura. Viceversa, se la società non supera le soglie dimensionali, essa rientra nelle procedure di sovraindebitamento (si parla di “concordato minore” per società di persone non fallibili ). Attenzione: i soci illimitatamente responsabili di società di persone non beneficiano automaticamente dell’esdebitazione concessa alla società: il CCII (art. 82) prevede che, salvo accordo diverso, il concordato di una società di persone libera i soci illimitati dai debiti solo se ciò è espressamente previsto dal piano . In liquidazione giudiziale, i soci possono chiedere separatamente la propria esdebitazione personale a fine procedura. Dunque, la struttura società di persone comporta un rischio patrimoniale totale per i soci, analogo alla ditta individuale, con la differenza che ci sono più soggetti co-obbligati. Ciò può spingere i creditori (ad esempio la banca) ad essere più fiduciosi nel concedere credito a una SNC, sapendo di avere più patrimoni su cui rivalersi.
- Società di capitali (SRL, SRLS, SPA): le società di capitali godono della responsabilità limitata: la copisteria organizzata in forma di SRL risponde delle obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio sociale, mentre i soci (quotisti) non sono personalmente responsabili oltre il capitale sottoscritto (art. 2462 c.c. per SRL). Ciò è un vantaggio rilevante per tutelare il patrimonio personale dell’imprenditore: se la copisteria-SRL accumula debiti e fallisce, i creditori sociali non possono pretendere nulla dai soci (a meno che questi abbiano prestato garanzie personali, come spesso avviene con le banche, o abbiano compiuto illeciti di gestione). Occorre però notare che la “scatola” societaria non protegge da tutte le conseguenze: ad esempio, i debiti fiscali di una SRL possono ricadere sugli amministratori se viene accertata una loro responsabilità per mala gestione (si pensi al caso di omesso versamento di IVA: l’amministratore potrebbe incorrere in sanzioni penali personali). Inoltre, se la SRL diventa insolvente oltre certe soglie, può essere soggetta a liquidazione giudiziale come ogni imprenditore commerciale. Le soglie dimensionali di non fallibilità non si applicano alle società di capitali (tali limiti valgono solo per determinare chi è “piccolo imprenditore” commerciale) – una SRL anche con fatturato modestissimo può teoricamente fallire, salvo il filtro del debito minimo di €30.000 di cui diremo tra poco. Quindi una piccola SRL che gestisce la copisteria, se insolvente, può accedere alle ordinarie procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) o utilizzare anch’essa gli strumenti di composizione negoziata e ristrutturazione previsti dal CCII. Anzi, va ricordato che non tutte le SRL in crisi vengono fatte fallire dai creditori: se la mole di debiti è bassa, il CCII prevede che la liquidazione giudiziale non si apra se i debiti scaduti e non pagati sono complessivamente < €30.000 . Questo significa che, ad esempio, se la SRL copisteria ha insolvenze diffuse ma i debiti scaduti ammontano a €25.000, un’istanza di fallimento potrebbe essere rigettata in base all’art. 49 CCII (soglia minima). Tale soglia di €30.000 viene aggiornata periodicamente e funge da “filtro di rilevanza” per evitare procedure su insolvenze irrisorie . Per contro, se il debito scaduto supera tale cifra, la SRL insolvente è candidabile alla liquidazione giudiziale su istanza di creditori, del PM o della società stessa. In caso di apertura della procedura, la SRL perderà la disponibilità dei propri beni a favore del curatore e l’attività verosimilmente cesserà, ma i soci non rischiano il loro patrimonio (salvo garanzie personali come detto). Il downside della SRL è che i costi di gestione e di procedura concorsuale possono essere alti rispetto a una piccola attività, e che gli amministratori devono rispettare specifici obblighi di legge (compresi quelli introdotti dal Codice della crisi sulla rilevazione tempestiva della crisi), altrimenti possono incorrere in responsabilità per aggravamento del dissesto.
Riassumiamo in una tabella le differenze chiave tra queste forme giuridiche in relazione ai debiti:
| Forma giuridica | Responsabilità per i debiti | Procedure concorsuali applicabili |
|---|---|---|
| Ditta individuale | Illimitata sul patrimonio personale del titolare. | Liquidazione giudiziale se supera soglie (attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k); altrimenti sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). Esdebitazione personale possibile a fine procedura. |
| Società di persone (SNC, SAS) | Illimitata per i soci illimitatamente responsabili, solidale tra loro (accomandanti SAS limitata al conferimento). Soci coobbligati anche con patrimonio personale. | Liquidazione giudiziale se insolvente (soci illimitati coinvolti nella procedura); se sotto soglie di cui sopra, procedure di sovraindebitamento (accordo o liquidazione minore). Soci possono chiedere esdebitazione individuale (non automatica salvo patto nel piano concordatario) . |
| Società di capitali (SRL) | Limitata al patrimonio sociale. Soci non rispondono personalmente (salvo garanzie o azioni di responsabilità). | Liquidazione giudiziale e concordato preventivo applicabili se insolvente (no limiti di soglia per qualifica imprenditore commerciale, ma debito scaduto ≥ €30.000 richiesto) . Accesso a concordato preventivo o accordi ristrutturazione possibile anche in fase di crisi. In alternativa, composizione negoziata per tentare risanamento. Esdebitazione non pertinente ai soci (società cancellata), amministratori eventualmente perseguibili per mala gestio. |
Nota: forme particolari come start-up innovative godono di esenzioni temporanee: ad esempio, le start-up innovative iscritte in apposito registro non possono essere dichiarate fallite (liquidazione giudiziale) per un periodo iniziale dalla costituzione . Anche gli imprenditori agricoli sono esclusi dalla liquidazione giudiziale tradizionale; tuttavia, il CCII prevede che se svolti in forma societaria e di grandi dimensioni possano accedervi . Nel contesto di una copisteria, è raro che rientri in queste categorie speciali, ma vanno menzionate per completezza normativa.
In sintesi, la scelta della forma giuridica incide su chi “paga” i debiti in ultima istanza: nella ditta individuale e SNC/SAS, il titolare o i soci rischiano tutti i propri beni; nella SRL, il sacrificio è limitato ai beni della società (con possibili riflessi indiretti tramite garanzie e responsabilità gestorie). Ciò riflette anche sulla strategia di difesa: ad esempio, un imprenditore individuale fortemente indebitato potrà valutare la liquidazione controllata del patrimonio e successiva esdebitazione per liberarsi dei debiti personali, mentre un socio di SRL punterà a chiudere la società in crisi eventualmente con una procedura concorsuale senza intaccare i propri beni, oppure a tentare un concordato preventivo per dare continuità all’azienda salvaguardando il capitale investito.
Rischi e conseguenze del mancato pagamento dei debiti
Quando una copisteria accumula debiti e non riesce a pagarli regolarmente, va incontro a una serie di rischi legali e patrimoniali. Comprendere in anticipo tali conseguenze è fondamentale per attivarsi per tempo ed evitare esiti irreversibili. Di seguito, elenchiamo le principali conseguenze che il debitore (impresa o imprenditore) può subire:
1. Aggressione esecutiva del patrimonio (pignoramenti): Il rischio più immediato per ogni debito non pagato è che il creditore avvii una procedura esecutiva. In base alla natura del credito, i passaggi possono variare: – Il Fisco (Agenzia Entrate-Riscossione) e l’INPS possono procedere senza bisogno di una causa civile: dopo la notifica della cartella e l’eventuale intimazione di pagamento, possono iscrivere fermo amministrativo su veicoli aziendali (impedendo di usarli legalmente) o ipoteca legale sugli immobili (se il debito ≥ €20.000) . Trascorsi i termini di legge, possono eseguire il pignoramento di beni mobili (macchinari, arredi), di crediti (ad es. pignorare i crediti che la copisteria vanta verso terzi, come eventuali contratti con enti o aziende), oppure il pignoramento immobiliare su immobili del debitore. Vi sono tuttavia importanti limiti: la legge vietà il pignoramento della prima casa da parte dell’ente di riscossione se il debitore possiede un solo immobile adibito a propria abitazione principale, non di lusso . Inoltre, per procedere su un immobile residenziale del debitore, il totale dei debiti verso lo Stato deve superare €120.000 e dev’essere stata iscritta ipoteca da almeno 6 mesi senza pagamento . In pratica, se la copisteria è una ditta individuale e il titolare ha come unico bene la propria casa, il Fisco (o l’INPS) non potrà metterla all’asta salvo il caso in cui vi siano più immobili o debiti fiscali enormi (oltre 120 mila euro con ipoteca pregressa). Resta però possibile l’iscrizione di ipoteca sulla casa unica (che vincola l’immobile e lo rende non finanziabile o vendibile senza saldare il debito). Per gli altri beni (conti bancari, attrezzature) non vi sono simili protezioni: un pignoramento del conto corrente aziendale è spesso il primo atto, bloccando di fatto la liquidità necessaria all’attività.
- I creditori privati (banche, fornitori, locatori) devono innanzitutto munirsi di un titolo esecutivo (tipicamente un decreto ingiuntivo emesso dal giudice su prova scritta del credito, oppure un mutuo fondiario dà titolo immediato). Una volta esecutivo (se non viene opposto entro 40 giorni o con apposizione di clausola provvisoria), procedono anche essi con pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi. Ad esempio, la banca mutuante con garanzia ipotecaria potrebbe bypassare il decreto ingiuntivo attivando direttamente il pignoramento immobiliare dell’immobile dato in garanzia (ma se è la sede dell’attività o un bene strumentale, in caso di fallimento della società poi dovrà coordinarsi con le procedure concorsuali). Un fornitore tipicamente chiederà il pignoramento di somme dal conto corrente della copisteria o il pignoramento mobiliare dei beni d’ufficio (pc, stampanti) tramite l’ufficiale giudiziario. Il locatore, dopo aver ottenuto lo sfratto, può pignorare i beni presenti nei locali (nei limiti del privilegio). In generale, qualsiasi creditore con titolo può pignorare i beni aziendali: ciò spesso porta a bloccare l’operatività (se vengono pignorati i macchinari essenziali o i conti bancari, l’attività non può proseguire). Per il debitore, i rimedi in questa fase sono limitati: può al più chiedere al giudice dell’esecuzione una rateizzazione del debito in sede esecutiva (art. 124 c.p.c., possibile in talune condizioni di particolare gravità, frazionando fino a 48 mesi il dovuto, ma è poco frequente) oppure tentare una conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) versando una somma a garanzia. In assenza di accordi, i beni pignorati saranno venduti all’asta e il ricavato distribuito ai creditori. Nella fase esecutiva individuale non c’è un ordine di priorità assoluto tra creditori di diversa natura (salvo i privilegi che si fanno valere sul ricavato): ad esempio, su una somma pignorata in banca, se concorrono Equitalia e un fornitore, Equitalia prevale sul riparto per interessi di mora e sanzioni esattoriali? No, in esecuzione individuale ognuno va per conto suo finché non c’è concorso formale; in pratica però il primo che ha pignorato potrebbe soddisfarsi. Quando poi si attiva una procedura concorsuale, tutte le esecuzioni individuali vengono sospese (divieto di azioni esecutive individuali, automatic stay).
2. Lievitazione del debito per interessi, sanzioni e spese legali: Un’altra conseguenza del protrarsi del mancato pagamento è l’aumento dell’importo dovuto. I debiti fiscali maturano interessi di mora e sanzioni amministrative per omesso versamento (che possono arrivare al 30% dell’importo per omissioni tributarie). I debiti da cartelle esattoriali vedono aggiungersi l’aggio di riscossione (fino al 6% circa) oltre a interessi giornalieri. I debiti commerciali producono interessi moratori (spesso più alti del tasso legale, specialmente nelle transazioni commerciali B2B dove si applica il D.lgs. 231/2002 con tassi di mora elevati, anche oltre il 8-10% annuo salvo patto). Inoltre, il creditore che agisce giudizialmente chiederà le spese legali e queste saranno poste a carico del debitore soccombente: parcelle di avvocati, contributo unificato, spese di procedura esecutiva, tutte somme che andranno ad aggiungersi al debito originario. Ad esempio, un decreto ingiuntivo non pagato porta a un pignoramento immobiliare: nel giro di 1-2 anni il debito iniziale verso il fornitore potrebbe aumentare del 20-30% tra interessi e costi di procedura. Questo effetto “palla di neve” peggiora la crisi di liquidità.
3. Sfratto e perdita dei locali: Come accennato, per i debiti di locazione, la conseguenza diretta è la perdita dell’immobile aziendale. Lo sfratto priva la copisteria del luogo in cui opera e spesso equivale a chiudere i battenti (traslocare i macchinari altrove in poco tempo è difficile, e può far perdere la clientela fidelizzata in quella zona). Inoltre, subire uno sfratto incide negativamente sull’affidabilità creditizia e i rapporti con altri fornitori (un imprenditore sfrattato viene percepito come in gravissime difficoltà).
4. Azioni giudiziarie per la riscossione e istanze di fallimento: Se i debiti non pagati sono significativi, oltre alle esecuzioni singole, i creditori potrebbero prendere in considerazione azioni più drastiche: – Istanza di liquidazione giudiziale (fallimento): Qualsiasi creditore (anche con credito modesto, purché nel complesso vi siano almeno €30.000 di insoluto) può presentare ricorso al tribunale per far dichiarare il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’impresa debitrice . Per farlo, deve dimostrare lo stato di insolvenza del debitore, cioè l’incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni (provata da inadempimenti, protesti, ecc.) . Se l’impresa è soggetta a fallimento (cioè non “piccola” sotto soglia), il tribunale istruisce il procedimento e, se ravvisa l’insolvenza, emette la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. Da quel momento l’imprenditore è spossessato dei beni, le azioni individuali dei creditori si arrestano, e un curatore gestirà la liquidazione. Dal punto di vista del debitore, essere trascinato in liquidazione giudiziale significa perdere il controllo sull’azienda e sui beni, subire possibili revocatorie di pagamenti passati, e (se persona fisica) eventuali limitazioni personali (come l’inabilitazione all’esercizio di attività commerciale senza autorizzazione, finché dura la procedura). Tuttavia, la dichiarazione di fallimento apre anche la via alla esdebitazione finale, che vedremo, e mette ordine nella situazione bloccando la corsa caotica dei creditori. – Decreti ingiuntivi e azioni monitorie seriali: Un creditore può scegliere la via del decreto ingiuntivo piuttosto che l’istanza di fallimento, specie se spera di recuperare qualcosa con un’esecuzione mirata. Il debitore rischia allora di ricevere numerosi decreti ingiuntivi da creditori diversi. Se non si fa opposizione (perché magari il debito è certo e liquido), ogni ingiunzione diventa titolo dopo 40 giorni. Più titoli significano più pignoramenti potenziali in parallelo. – Ricorsi per decreto ingiuntivo su effetti cambiari o assegni: Nel caso in cui la copisteria abbia emesso assegni o pagherò cambiari poi risultati insoluti, i creditori dispongono di titoli di per sé (l’assegno protestato è titolo esecutivo dopo il protesto, la cambiale pure). Il rischio collegato è anche la protesta: un assegno scoperto porta all’iscrizione del protesto nel Registro Informatico dei Protesti, infamando commercialmente l’impresa e il titolare. Ciò pregiudica la reputazione e l’accesso al credito (le banche revocano fidi se scoprono protesti a carico dell’azienda o dell’imprenditore). I protesti per assegni inoltre comportano sanzioni amministrative accessorie (divieto di emettere assegni per 2 anni se non si provvede al pagamento tardivo, cosiddetta “riabilitazione”).
5. Interessi del fisco e del penale: Non pagare debiti fiscali può sfociare, oltre che nei provvedimenti esecutivi citati, in due ambiti ulteriori: – Preclusione nei confronti della Pubblica Amministrazione: se la copisteria lavora con enti pubblici (es. convenzioni con università, scuole, ecc.), avere debiti fiscali o contributivi può portare al durc irregolare (documento unico di regolarità contributiva negativo) e quindi all’impossibilità di ottenere pagamenti dalla PA o partecipare a gare/appalti finché non si regolarizza. – Responsabilità penale tributaria: Come menzionato, alcuni importi non versati configurano reato. Per esempio, omettere il versamento di IVA dovuta superiore a 250.000 € per periodo d’imposta è reato (punito con reclusione fino a 2 anni). Lo stesso per omesso versamento di ritenute certificate sopra €150.000. Anche l’emissione di fatture false o la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (es. nascondere beni per non farli pignorare) integrano reati tributari. Il titolare potrebbe trovarsi indagato/condannato con tutte le conseguenze del caso (fino all’interdizione da attività d’impresa in certe ipotesi). Questo ovviamente è un extrema ratio, ma va tenuto presente come deterrente: le pendenze fiscali vanno gestite con priorità, eventualmente cercando piani di rateizzo o definizioni agevolate prima che scattino violazioni penali.
6. Crisi di fiducia e reputazione commerciale: Infine, sebbene meno tangibile giuridicamente, la condizione di debitore moroso incide sulle relazioni d’affari. Fornitori potrebbero passare la voce in città che la copisteria “non paga”, i clienti potrebbero intuire problemi (specie se scaffali vuoti o macchinari fermi per pignoramenti), la banca potrebbe revocare gli affidamenti ancora in essere (ad esempio revoca immediata del fido di conto corrente, causando ulteriore crisi di liquidità). I rating creditizi peggiorano. Tutto ciò crea un effetto domino: un’impresa in difficoltà può venire spinta ancora più a fondo dalla reazione sfavorevole del mercato e delle controparti.
Dato questo quadro di rischi, è fondamentale per il debitore attivarsi prima che la situazione precipiti. Nel prossimo capitolo vedremo quali strategie extragiudiziali si possono adottare per gestire i debiti, evitando – se possibile – di arrivare all’aggressione esecutiva o alla chiusura coattiva dell’attività. Successivamente, analizzeremo le soluzioni giudiziali concorsuali disponibili, qualora l’azione negoziale privata non basti. L’obiettivo sarà minimizzare le perdite, proteggere i beni essenziali (quando consentito) e magari risanare la copisteria o, se ciò non è più fattibile, liquidare il debito con la maggiore tutela possibile del debitore, sfruttando ad esempio l’esdebitazione.
Strategie extragiudiziali per gestire i debiti
Prima di ricorrere ai tribunali, un imprenditore indebitato dovrebbe valutare tutte le soluzioni stragiudiziali (ovvero, al di fuori delle procedure concorsuali formali) per rimettere in sesto la situazione finanziaria. Le strategie extragiudiziali hanno il vantaggio di evitare la pubblicità e lo stigma di una procedura concorsuale, di lasciare il controllo dell’azienda al debitore e spesso di essere più rapide e flessibili. Di contro, richiedono la collaborazione volontaria dei creditori e una capacità di negoziazione. Ecco le principali opzioni extragiudiziali:
1. Rinegoziazione e dilazione dei debiti con i singoli creditori: La prima strada è dialogare con ciascun creditore per trovare accordi di pagamento sostenibili. In pratica: – Rateizzazioni e piani di rientro informali: Si può chiedere ai fornitori una dilazione extra (es. pagare il dovuto in 6 tranche mensili anziché in un’unica soluzione). Molti fornitori preferiscono incassare lentamente piuttosto che affrontare cause dall’esito incerto. È bene formalizzare per iscritto tali patti (ad es. scrittura privata in cui il creditore sospende le azioni legali in cambio del rispetto del piano di pagamento rateale). – Saldo e stralcio extragiudiziale: Con taluni creditori si può proporre un pagamento immediato parziale a stralcio del debito totale. Ad esempio, offrire a un fornitore il 50% del dovuto subito e il resto condonato. Questa leva funziona se il creditore percepisce che l’alternativa è non vedere nulla causa fallimento o chiusura dell’attività. Spesso banche e finanziarie sono disposte a transazioni a saldo e stralcio su crediti deteriorati (NPL) ceduti o incagliati: ad esempio, la banca potrebbe accettare €30.000 su un’esposizione di €50.000 pur di chiudere subito la partita, magari dietro cessione del credito a società di recupero. – Riduzione di penali e interessi: Anche laddove il capitale vada onorato per intero, c’è margine per farsi abbuonare interessi di mora maturati o spese accessorie. Molte imprese fornitrici, se vedono buona fede, rinunciano agli interessi pur di accelerare il recupero del capitale. – Moratorie concordate con le banche: In situazioni di crisi diffusa (come fu nella pandemia Covid-19), il governo o l’ABI promuovono accordi di moratoria. Ad esempio, l’ABI aveva concesso nel 2020-21 la sospensione delle rate dei mutui per PMI in difficoltà. Fuori da tali programmi, l’imprenditore può comunque chiedere alla propria banca una moratoria temporanea (es. 6 mesi di solo pagamento interessi, posticipando la quota capitale) o una rinegoziazione del mutuo allungandone la durata per abbassare la rata. È interesse della banca evitare di classificare il credito a sofferenza, quindi talvolta mostrano apertura a ristrutturare il debito anziché escutere immediatamente le garanzie. – Utilizzo di garanzie esterne: Se l’imprenditore riesce a ottenere un nuovo finanziamento ponte (ad es. da un parente, o un socio disposto a immettere liquidità) può usarlo come leva nelle trattative: offre un pagamento immediato con quei fondi in cambio di sconto sul totale dovuto. Oppure potrebbe offrire nuove garanzie per ottenere tempo (es. un’ipoteca su un bene di famiglia a fronte di proroga del fido bancario – mossa da valutare con cautela, perché sposta il rischio sul patrimonio personale). – Assistenza di un professionista o mediatore creditizio: A volte coinvolgere un consulente esperto in crisi d’impresa può agevolare gli accordi. Ci sono società specializzate nella risoluzione debiti che trattano con i creditori per conto del debitore, cercando pacchetti transattivi. Questo è utile anche per gestire eventuali società di recupero crediti se i debiti sono stati ceduti: è noto che tali società acquistano crediti a frazioni del valore e possono accettare stralci vantaggiosi (ma attenzione alle truffe: rivolgersi a professionisti seri).
2. Definizioni agevolate dei debiti fiscali e contributivi: Il legislatore, specialmente negli ultimi anni, ha introdotto misure di definizione agevolata per i debiti con il Fisco e l’agente della riscossione. Queste misure, note anche come “pace fiscale”, consentono di regolarizzare le pendenze con sconti su sanzioni e interessi. Aggiornate al 2025, possiamo citare: – La “rottamazione” delle cartelle esattoriali: per vari anni (2016, 2018, 2023) sono state aperte finestre per pagare i carichi affidati all’Agente Riscossione senza le sanzioni e con interessi ridotti. Ad esempio, la rottamazione-quater introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha permesso di definire i debiti affidati dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo l’imposta e interessi legali (senza sanzioni né interessi di mora) in un massimo di 18 rate . Le prime due rate (10% ciascuna) scadono il 31 ottobre e 30 novembre 2023 (poi prorogate a dicembre 2023 ), e le restanti in 4 anni fino al 2027. Per aderire bisognava presentare domanda entro aprile 2023. Se la nostra copisteria aveva debiti in cartella, aderire a questa definizione comporta un risparmio notevole su sanzioni e more, purché si rispettino poi le rate (il mancato pagamento di due rate fa decadere i benefici). – Stralcio dei piccoli debiti fino a €1.000: sempre la L.197/2022 ha previsto l’annullamento automatico al 31 marzo 2023 (poi slittato al 30 aprile 2023) dei carichi fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015 . Questo stralcio era parziale per i crediti di enti diversi dallo Stato (cancellati interessi e sanzioni, restava il capitale salvo diversa delibera dell’ente locale) , mentre per i crediti erariali lo stralcio è stato integrale (capitale e accessori) . In pratica, se la copisteria aveva vecchie cartelle fino a 1000 € di importo residuo (molte multe, tributi locali, ecc.), a fine aprile 2023 quei debiti sono stati annullati d’ufficio (salvo che alcuni enti locali potevano opt-out). Questa misura ha alleggerito molti piccoli imprenditori da code di vecchi ruoli. – Rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali/previdenziali: indipendentemente dalle sanatorie straordinarie, esiste la possibilità di chiedere una rateazione delle cartelle. Attualmente, per importi fino a €120.000 non è richiesta la prova di difficoltà e si può ottenere una dilazione fino a 72 rate (6 anni) semplicemente facendo domanda . Per importi superiori occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà tramite ISEE o documentazione finanziaria. Inoltre, in casi di grave e comprovata situazione (ad es. calo di fatturato notevole), è possibile richiedere un piano straordinario fino a 120 rate (10 anni). La rateazione ha il vantaggio di sospendere le azioni esecutive (finché si pagano le rate, Agenzia Riscossione non procede a nuovi pignoramenti). Tuttavia, gli interessi di dilazione (circa 2% annuo attualmente) si aggiungono. Importante: dal 2022 la decadenza da una rateazione si verifica solo con 8 rate non pagate, anche non consecutive (prima bastavano 5). Quindi c’è un po’ più di flessibilità. – Transazione fiscale e contributiva stragiudiziale: in assenza di procedure concorsuali, non esiste una vera e propria “transazione fiscale” extragiudiziale (che invece è prevista dentro concordati preventivi o accordi di ristrutturazione). Fuori dalle procedure, il fisco non può accettare pagamenti parziali sull’imposta dovuta (per obbligo di legge). Tuttavia, per alcune fattispecie l’Agenzia Entrate può rinunciare alle sanzioni in via amministrativa (ad es. istituti deflativi come acquiescenza, conciliazione giudiziale in Commissione Tributaria, ecc.). Se la copisteria avesse contenziosi in corso con il fisco (avvisi di accertamento contestati), potrebbe valutare di chiuderli col “saldo e stralcio” giudiziale previsto dal DL 119/2018 (stralcio delle liti pendenti) se reiterato, o con la conciliazione in appello come da DL 50/2017. Sono misure tecniche da valutare caso per caso con un tributarista. – Sospensione amministrativa della riscossione: se si ritiene che la cartella esattoriale sia infondata o vi siano cause di non esigibilità (pagamento già avvenuto, prescrizione, sgravio, ecc.), si può presentare istanza di sospensione all’ADER entro 60 giorni dalla notifica, con documenti probatori. L’ADER sospende le azioni esecutive in attesa che l’ente creditore confermi o annulli. Questo non risolve il debito ma può guadagnare tempo. – Interlocuzione con l’ente creditore: per contributi INPS, a volte ci sono piani di rateazione ad hoc (es. 24 rate per i debiti sui contributi volontari o artigiani). L’INPS applica tassi agevolati. Similmente l’Agenzia Entrate per debiti da avvisi bonari consente rate fino a 8 rate trimestrali senza garanzie.
Sfruttare queste opportunità può ridurre significativamente l’importo dovuto e diluirne il pagamento, dando respiro alla copisteria. È cruciale monitorare le normative in evoluzione: ad esempio, nel 2024-2025 potrebbero esservi ulteriori “rottamazioni” o sanatorie introdotte dalla legge di bilancio o da decreti emergenziali. Tenere d’occhio le fonti ufficiali (Agenzia Entrate Riscossione pubblica sul sito notizie su nuove definizioni) consente di non perdere occasioni di alleggerimento del carico fiscale.
3. Composizione negoziata della crisi d’impresa: Un importante strumento introdotto di recente (D.L. 118/2021, poi confluito nel Codice della Crisi) è la composizione negoziata. Si tratta di un percorso volontario e riservato attivabile dall’imprenditore (anche piccolo) in situazione di squilibrio economico-finanziario, volto a favorire il risanamento tramite la negoziazione assistita da un esperto indipendente. In pratica, l’imprenditore in crisi si iscrive sulla piattaforma telematica delle Camere di Commercio e chiede la nomina di un esperto (di norma un commercialista o avvocato qualificato in crisi) . Con l’aiuto dell’esperto, in un periodo di alcuni mesi, cerca accordi con i creditori o nuove finanze. I vantaggi: – La procedura è confidenziale (non viene pubblicata inizialmente, si evita allarme pubblico). – L’esperto può proporre soluzioni e fare da mediatore super partes con banche, fornitori e fisco. – L’imprenditore può chiedere misure protettive dal tribunale: ad esempio, una moratoria delle azioni esecutive individuali per la durata delle trattative (generalmente 3+2 mesi), ottenibile con decreto se la situazione non è compromessa irreparabilmente . – Durante la composizione negoziata, l’impresa continua ad operare sotto tutela: certi atti necessari al piano di risanamento (come finanziamenti prededucibili, o cessione di rami d’azienda) possono essere autorizzati dal tribunale con protezione da revocatorie. – Se si raggiunge un accordo con taluni creditori, si può chiedere al tribunale di omologare l’accordo per renderlo efficace anche verso dissenzienti in alcuni casi (ad esempio, omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti con percentuale ridotta di consenso se ricorrono le condizioni dell’art. 61 CCII, il cosiddetto accordo esteso) – questo sconfinerebbe già nelle procedure semigiudiziali.
Per una copisteria, la composizione negoziata ha senso se c’è una prospettiva di salvare l’attività con una ristrutturazione (es. riducendo costi, ottenendo nuova finanza) ma servono tempi brevi e stop ai creditori. Ad esempio, se la copisteria ha subito un calo incassi transitorio (pensiamo durante il lockdown) ma ha ordini potenziali futuri, può tramite composizione negoziata ottenere la sospensione dei pagamenti immediati e magari convincere i creditori ad accettare un piano di risanamento. Se invece la situazione è compromessa (debiti enormi rispetto agli asset), la composizione negoziata potrebbe semplicemente preludere a una liquidazione controllata (l’esperto, constatato il fallimento delle trattative, può invitare l’impresa a passare a procedura concorsuale). Da segnalare: la normativa prevede incentivi per chi usa la composizione negoziata, ad esempio esenzioni da alcune responsabilità penali minori per gli imprenditori che la intraprendono con lealtà, o premi in termini di riduzione interessi sui nuovi finanziamenti. Inoltre, durante la composizione negoziata è sospeso l’obbligo per gli amministratori di SRL di attivare l’iter di liquidazione in caso di perdite rilevanti di capitale, proprio per favorire il risanamento (art. 20 DL 118/2021). In sostanza, il legislatore vuole che le imprese cerchino di risolvere la crisi prima di arrivare all’insolvenza conclamata, e offre uno spazio protetto per farlo.
4. Piano di risanamento attestato (strumento art. 56 CCII, ex art. 67 LF): Questo è un accordo stragiudiziale che però la legge riconosce ai fini di esenzioni dalle revocatorie. Un imprenditore può predisporre un piano di risanamento della propria azienda (taglio costi, accordi con creditori, intervento di nuovi capitali) e farlo attestare da un professionista indipendente che ne certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità. Se il piano è poi eseguito e porta a risanamento, bene; se purtroppo l’impresa fallisce successivamente, tutti gli atti compiuti in esecuzione di quel piano attestato (pagamenti, garanzie) non possono essere soggetti a revocatoria fallimentare. Questo strumento è spesso usato dalle aziende per ristrutturare il debito con banche e fornitori in via privata: la presenza dell’attestatore dà fiducia ai creditori sulla bontà del piano. Per una piccola copisteria, il piano attestato può essere eccessivamente costoso (bisogna pagare l’attestatore e predisporre documentazione dettagliata) – è più comune per aziende di medie dimensioni. Ma lo citiamo perché fa parte del ventaglio di soluzioni pre-concorsuali.
In generale, il consiglio al debitore è: tentare ogni strada di accordo prima di considerare procedure giudiziali. Bisogna però essere realistici: se il debito supera di molto la capacità di rimborso e i creditori non sono disposti a stralci sostanziosi, forse è inevitabile ricorrere a una procedura concorsuale per gestire la situazione in modo collettivo (e ottenere l’esdebitazione). Inoltre, va evitato l’errore di favorire alcuni creditori a scapito di altri in questa fase: pagare solo chi fa più pressione e trascurare gli altri potrebbe, in caso di successivo fallimento, portare a contestazioni (pagamenti preferenziali revocabili entro 6 mesi se fatti in stato d’insolvenza). Perciò, mosse come pagare un parente creditore o un fornitore “amico” a detrimento di fisco o dipendenti sono pericolose. Meglio predisporre un piano organico e trasparente e, se possibile, farlo benedire da un professionista.
Nei paragrafi seguenti, daremo uno sguardo alle procedure giudiziali concorsuali vere e proprie: queste entrano in gioco quando l’accordo privato non è riuscito o non è praticabile. La conoscenza delle procedure concorsuali è essenziale anche per usarle come leva negoziale: ad esempio, far capire a una banca che, se non accetta un accordo ragionevole, l’alternativa sarà la procedura concorsuale in cui potrebbe recuperare meno (tramite concordato o fallimento). Ciò spesso li motiva a venire a patti.
La liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Quando si parla di “fallire”, in termini giuridici ci si riferisce oggi alla liquidazione giudiziale, la procedura concorsuale introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019) in sostituzione del vecchio fallimento . La liquidazione giudiziale ha la finalità di liquidare tutti i beni del debitore insolvente per soddisfare collettivamente i creditori, secondo le regole della parità di trattamento (par condicio creditorum) e dei privilegi. Per una copisteria in grave dissesto, questa è la procedura concorsuale liquidatoria tipica, da cui uscire eventualmente “puliti” dai debiti residui grazie all’esdebitazione.
Vediamo gli aspetti principali della liquidazione giudiziale:
Presupposti soggettivi: possono essere assoggettati a liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali (inclusi gli artigiani commerciali) non piccoli . Come già spiegato, l’art. 2, c.1, lett. d) CCII individua i limiti dimensionali sotto i quali l’imprenditore è considerato “minore” e quindi escluso: attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000 (congiuntamente) . Se la copisteria rientra sotto tutti questi parametri (es. fatturato annuo 150k, debiti 400k) e il debitore lo prova, il tribunale non potrà aprire la liquidazione giudiziale ordinaria . In tal caso, come visto, restano le procedure di sovraindebitamento. Viceversa, se anche uno solo è superato, la copisteria è “fallibile”. Le società di capitali sono sempre assoggettabili, indipendentemente dai limiti (salvo startup innovative protette per il periodo di legge). Inoltre, occorre che i debiti scaduti e non pagati siano almeno €30.000 , soglia di rilevanza. Quindi, se una SRL copisteria insolvente ha 25k di debiti scaduti, l’istanza verrebbe dichiarata inammissibile; se ne ha 50k, può procedere.
Presupposto oggettivo: lo stato di insolvenza. L’art. 121 CCII richiede l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (ad es. protesti, fughe, chiusura dell’attività) . Non basta la temporanea illiquidità; deve trattarsi di una situazione irreversibile o comunque non risolvibile con mezzi ordinari. Nei casi di copisteria, segnali tipici: accumulo di debiti per molte mensilità, impossibilità di pagare forniture essenziali, conto costantemente scoperto oltre fido, ecc. Se la copisteria ha già cessato l’attività, basta la sproporzione tra passivo e attivo liquidabile per provarne l’insolvenza .
Come si avvia: la liquidazione giudiziale può essere richiesta: – dal debitore stesso (ricorso di autodichiarazione d’insolvenza, raramente utilizzato salvo in strategie concordatarie non riuscite), – da uno o più creditori (anche non privilegiati, purché credito certo liquido ed esigibile; spesso Equitalia faceva istanza su debiti erariali), – dal Pubblico Ministero (se emergono elementi da procedimento penale o segnalazioni Vigilanza, il PM può attivarsi, ad esempio in caso di società che hanno abbandonato l’attività insolventi).
Il tribunale competente è quello dove l’impresa ha il centro degli interessi principali (di solito sede legale). Nel caso di ditta individuale, la residenza dell’imprenditore. Il procedimento prevede un’istruttoria: il giudice convoca l’imprenditore a un’udienza. Importante per il debitore: in questa sede può opporsi mostrando di non essere insolvente o di non superare le soglie (se vuole eccepire la non fallibilità). Ricordiamo che è onere del debitore provare di essere sotto soglia minore . Se non si costituisce o non produce bilanci, il tribunale presume superate le soglie e può dichiarare il fallimento . La Corte d’Appello di Trento nel 2025 ha ribadito che l’assenza di prova da parte del debitore comporta l’assoggettabilità alla procedura (onere probatorio rigoroso a suo carico) . Dunque, una copisteria che riceva una convocazione per istanza di fallimento dovrebbe presentarsi con i libri contabili e dimostrare eventualmente di rientrare nei parametri o di avere ancora prospettive (ad es. se è in trattativa di composizione negoziata, potrebbe chiedere al tribunale una conversione in concordato preventivo per evitare la dichiarazione immediata di liquidazione).
Effetti della sentenza di liquidazione: Quando il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale: – Nomina un Curatore (figura terza, solitamente un commercialista o avvocato esperto in fallimenti, scelto dall’albo). – Nomina un Giudice Delegato per supervisione. – Dispone il cessamento dell’esercizio dell’impresa, salvo che si valuti di esercitarla provvisoriamente per migliori risultati di vendita (caso raro per una copisteria, ma possibile se ci sono commesse in corso che aumentano il valore proseguendo l’attività qualche mese). – Il debitore (imprenditore individuale o organi della società) viene spossessato dei beni: non può più disporne, passa tutto sotto controllo del curatore . Il curatore redigerà l’inventario e gestirà la liquidazione dei beni (vendita macchinari, incasso crediti, ecc.). – I creditori non possono più iniziare né proseguire azioni esecutive individuali né cautelari sui beni del debitore (automatic stay ex art. 150 CCII). I pignoramenti in corso sono dall’apertura improseguibili. Ciò evita la corsa al patrimonio e riserva la soddisfazione al concorso collettivo. – Si apre la fase di accertamento del passivo: i creditori sono invitati a presentare domanda di ammissione al passivo entro una data. Il curatore esamina le domande, predispone lo stato passivo e il giudice delegato verifica crediti e privilegi in udienza di verifica. Vengono così cristallizzati i debiti riconosciuti in procedura, suddivisi per categoria (prededucibili, privilegiati, chirografari, ecc.). – Il curatore procede quindi alla liquidazione dell’attivo: può vendere i beni mobili tramite procedure competitive, cedere l’azienda (o quel che ne resta) se fruttuosamente alienabile, riscuotere i crediti (anche attivando azioni giudiziarie se servono, ad es. ingiunzioni contro debitori della copisteria). Nel caso di una copisteria, l’attivo tipico potrebbe consistere in: qualche macchinario usato (valore modesto), eventuali crediti verso clienti (spesso privati, di difficile recupero se non hanno già pagato), arredi, scorte di magazzino (carta, toner), forse un veicolo commerciale. Se c’è un immobile di proprietà (ad es. se la copisteria era proprietaria del fondo), quello sarà venduto all’asta. – Azioni revocatorie fallimentari: il curatore può chiedere al tribunale di revocare pagamenti o atti dispositivi compiuti prima del fallimento in pregiudizio dei creditori. Ad esempio, pagamenti a fornitori effettuati nei 6 mesi prima della procedura, se fatti quando il debitore era già incapiente, possono essere revocati (il fornitore deve restituire le somme al concorso, salvo esenzioni per pagamenti ordinari di merce a pronti etc.). Atti come la concessione di garanzie per debiti preesistenti nell’anno prima, o alienazioni a terzi a titolo gratuito negli ultimi 2 anni, sono anch’essi revocabili. Queste azioni mirano a ricostituire l’attivo sottratto e assicurare parità di trattamento. Per il debitore onesto non sono un grande problema, ma se ad esempio prima di fallire l’imprenditore ha rimborsato interamente un debito a un parente lasciando a secco gli altri, il curatore potrebbe riprendere quei soldi. – Durata della procedura: dipende dalla complessità. Un fallimento senza immobili né cause pendenti potrebbe chiudersi in 1-2 anni; se ci sono immobili da vendere o contenziosi (es. cause contro ex amministratori per responsabilità, ecc.), può durare diversi anni. Il CCII spinge per chiusure più rapide, e la Corte Costituzionale ha di recente evidenziato la necessità di contenere anche le liquidazioni controllate entro un triennio in linea di massima , principio estensibile alla liquidazione giudiziale.
Soddisfacimento dei creditori: al termine, il curatore ripartisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione. In cima i crediti prededucibili (spese di procedura, compenso del curatore, avvocati della massa, eventuali finanziamenti urgenti autorizzati in esercizio provvisorio). Poi i privilegiati speciali sull’immobile (es. banca ipotecaria) e mobiliari (es. imposte su beni specifici, credito del venditore con riserva di proprietà su un macchinario, se esiste). Poi i privilegi generali mobiliari: tra questi rientrano i crediti di lavoro (salari) e una parte dei crediti fiscali/contributivi (ad esempio IVA e ritenute hanno privilegio generale, ma solo sul 20% del loro ammontare per IVA, superprivilegio per ritenute), i canoni di locazione ultimi 2 anni su mobili del locale, ecc. Infine i chirografari (fornitori non privilegiati, banche per la parte non garantita, ecc.) che di solito prendono solo ciò che residua (spesso poco o nulla). Se l’attivo è esiguo, può accadere che si soddisfino appena le spese prededucibili e qualche privilegio, e i chirografari restino a bocca asciutta.
Chiusura della procedura ed esdebitazione: Una volta esaurito tutto l’attivo distribuibile, il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. Se il debitore è una società, la società viene cancellata e cessa di esistere; i debiti insoddisfatti si estinguono per confusione (nessuno più ne è obbligato). Se il debitore è una persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitato), può chiedere entro 1 anno dalla chiusura la esdebitazione: l’istituto che libera il debitore persona fisica dai debiti residui non pagati in procedura . Il CCII ha reso l’esdebitazione di diritto per il sovraindebitato dopo 3 anni dalla liquidazione controllata , mentre per la liquidazione giudiziale l’esdebitazione rimane su istanza ma tendenzialmente concessa se il fallito ha collaborato, non ha commesso reati fallimentari e non era un soggetto malizioso. Già con la legge fallimentare si concedeva l’esdebitazione salvo casi di frode o malafede. Dunque l’imprenditore esdebitato riparte pulito, non più inseguito dai creditori pregressi (ad eccezione di debiti non esdebitabili, come eventualmente le obbligazioni alimentari, il risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali/amministrative: tasse e contributi invece si esdebitano eccome, compresi interessi e sanzioni, perché la legge 3/2012 e ora il CCII lo consentono). La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’esdebitazione libera da tutti i debiti concorsuali residui, inclusi quelli tributari, purché non derivino da illecito doloso del debitore . Nel CCII, peraltro, è previsto un caso particolare di esdebitazione immediata per il debitore persona fisica incapiente (che non ha nulla da offrire ai creditori), a cui accenneremo parlando di sovraindebitamento.
Per una copisteria (specialmente se in forma societaria), la liquidazione giudiziale è spesso l’ultima spiaggia quando ogni tentativo di risanamento è fallito. Ha il pregio di cristallizzare la situazione: l’azienda chiude, i debiti vengono trattati in massa, e se è ditta individuale il titolare dopo potrà godere della liberazione dai debiti e eventualmente ricominciare. Ma è una procedura dura: l’attività commerciale cessa (salvo magari riprenderla con altra società ex novo se possibile), i dipendenti perdono il lavoro (salvo TFR dal Fondo di garanzia), il nome commerciale può venire leso. Inoltre, eventuali comportamenti irregolari dell’imprenditore possono essere sanzionati: il curatore segnala fatti di bancarotta se riscontra distrazioni di beni, scritture non tenute, etc. In conclusione, va valutata attentamente e di solito resta come scenario inevitabile se l’insolvenza è conclamata e nessun accordo di ristrutturazione ha avuto successo.
Il concordato preventivo (salvare l’azienda evitando la liquidazione)
In alternativa alla liquidazione giudiziale, l’ordinamento offre all’imprenditore in crisi ma desideroso di evitare la cessazione dell’attività lo strumento del concordato preventivo. Si tratta di una procedura concorsuale di risanamento o liquidazione concordata, che consente al debitore di proporre ai creditori un piano per il soddisfacimento, evitando così lo scenario peggiore del fallimento. Il concordato preventivo è riservato agli imprenditori che sarebbero fallibili (quindi non ai piccoli sotto soglia, per i quali esiste il concordato minore di cui diremo), ed è soggetto all’approvazione dei creditori e all’omologazione del tribunale.
Quando e perché usare il concordato preventivo: Una copisteria potrebbe valutare il concordato preventivo se: – Ha una mole di debiti insostenibile nel breve termine, ma possiede potenzialità di continuare l’attività generando utili futuri se alleggerita dal debito (concordato in continuità). – Oppure intende cessare l’attività, però gestendo la liquidazione dei beni in modo ordinato e potenzialmente offrendo ai creditori una resa migliore di quella fallimentare (concordato liquidatorio), magari evitando procedure concorsuali lunghe. – Vuole congelare le azioni dei creditori immediatamente: la presentazione della domanda di concordato preventivo (in bianco o con piano) attiva automaticamente lo stay dei creditori (art. 54 CCII), bloccando pignoramenti e sequestri durante la procedura. – Intende approfittare di strumenti di ristrutturazione del debito pubblico nel concordato: ad esempio, inserire una transazione fiscale per tagliare parte dei debiti tributari e contributivi (cosa che, come detto, fuori da procedura non è possibile senza il consenso dell’ente). Nel concordato, con le modifiche normative, è possibile proporre il pagamento parziale di IVA, ritenute e contributi, purché non inferiore a una certa soglia di convenienza e secondo le regole (specialmente dopo la L. 119/2023 che ha fissato nuove condizioni, v. infra). – Vuole evitare le azioni di responsabilità e le istanze di fallimento: finché il concordato è in corso, un socio o amministratore è al riparo da istanze di fallimento (che vengono assorbite) e può tentare di mantenere il controllo sotto supervisione del commissario giudiziale.
Tipologie di concordato: – Concordato in continuità aziendale: il piano prevede che l’attività della copisteria prosegua, o direttamente dal debitore o tramite affitto/cessione dell’azienda ad un terzo che la continua (continuità indiretta). In questo scenario, i creditori vengono soddisfatti con i flussi generati dalla prosecuzione dell’impresa (ad es. utili futuri, o magari l’ingresso di un investitore che mette soldi per far ripartire). La legge incentiva la continuità perché preserva il valore dei beni (ad es. una copisteria funzionante con i suoi clienti vale di più di una spenta). Nel concordato in continuità la regola è che ai creditori chirografari venga garantito un pagamento almeno pari al 10% del loro credito , salvo deroghe, e che i creditori privilegiati non vengano alterati se non nei limiti di legge. Inoltre, gli atti di gestione ordinaria proseguono sotto osservazione, quelli straordinari richiedono autorizzazione. L’impresa in continuità può anche ottenere finanziamenti prededucibili per operare durante la procedura. – Concordato liquidatorio: il piano prevede la cessione dei beni (liquidazione) però effettuata dal debitore stesso sotto il controllo del commissario e con un programma specifico, piuttosto che dal curatore fallimentare. Un concordato solo liquidatorio oggi è ammissibile se assicura ai creditori chirografari almeno il 20% di soddisfazione (questa soglia è stata introdotta dal DL 83/2015 e confermata nel CCII) – serve a evitare concordati “troppo penalizzanti”. Ad esempio, se la copisteria vuole chiudere ma propone di vendere i macchinari e magari far entrare un terzo a rilevare il contratto di affitto restituendo una parte ai creditori, deve poter dare almeno 20 cent per euro ai chirografari. Se non ci arriva, il concordato sarebbe inammissibile a meno di contributi esterni (un apporto di finanza esterna al patrimonio può far eccezionalmente scendere sotto il 20%). – Concordato misto o con classi: spesso i piani prevedono parti in continuità e parti liquidatorie, oppure suddividono i creditori in classi in base alla posizione giuridica o interessi (es. una classe banche, una classe fornitori, ecc.). Ogni classe vota separatamente. Il CCII consente una certa flessibilità, l’importante è rispettare la regola che se una classe dissente ma ottiene meno di quanto avrebbe in liquidazione giudiziale, il tribunale può non omologare (principio di soddisfazione migliore o almeno equivalente rispetto all’alternativa liquidatoria, art. 112 CCII).
Procedimento di concordato preventivo (linee generali): – L’imprenditore deposita ricorso al tribunale con una proposta di concordato e un piano dettagliato, corredato dalla relazione di un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. (In alternativa, può presentare un ricorso “in bianco” o con riserva, contenente solo la domanda e poi depositare piano e documenti entro un termine, di solito 60-120 giorni, prorogabile). – Il tribunale, se la domanda è ammissibile, emette decreto di apertura del concordato: nomina un Commissario Giudiziale (diverso dal curatore, funge da supervisore senza togliere la gestione all’imprenditore) e ordina le misure protettive (sospende le azioni esecutive). – I creditori vengono informati e convocati per esprimere voto sulla proposta. Nel CCII, la regola è maggioranza dei crediti ammessi al voto > 50% (se ci sono classi, serve maggioranza in ogni classe o in mancanza si applica il cram-down interclassi se alcune classi approvano e altre no, secondo criteri di legge). – Se la maggioranza approva, si passa all’omologazione: il tribunale verifica legalità e fattibilità e omologa rendendo vincolante il concordato per tutti i creditori anteriori. Se non si raggiunge la maggioranza, il concordato viene dichiarato non approvato e normalmente si apre la liquidazione giudiziale d’ufficio (salvo il debitore chieda la conversione in liquidazione controllata se era non fallibile, come visto nell’esempio Alfa & Co. in un caso pratico ). – Durante il concordato, l’impresa continua l’attività sotto la propria amministrazione, ma con atti vigilati dal commissario (che riferisce al giudice eventuali abusi). Il debitore non perde i beni (non c’è spossessamento pieno come nel fallimento, c’è una sorta di spossessamento attenuato). – Omologato il concordato, il debitore deve eseguire il piano: fare i pagamenti promessi nelle percentuali e tempi previsti. I creditori ricevendo quelle somme si considerano soddisfatti a saldo e non possono pretendere altro (il concordato ha effetto esdebitativo per definizione, sui crediti anteriori non pagati si forma una remissione ex lege). – Se il debitore non rispetta il piano, su segnalazione si può chiedere la risoluzione del concordato (entro 1 anno dall’ultimo adempimento dovuto) e a quel punto si aprirebbe il fallimento, ma attenzione: la Cassazione a Sezioni Unite nel 2022 ha statuito che la risoluzione concordataria segue regole contrattuali ordinarie e non c’è un termine di decadenza stretto come nel vecchio art. 186 LF . In pratica, i creditori possono far valere l’inadempimento anche successivamente se il concordato fallisce. Tuttavia, se gran parte del piano è eseguito e rimangono poche pendenze, difficilmente si torna a fallimento (spesso quei residui rimangono insoddisfatti ma la procedura non viene riaperta per economia).
Transazione fiscale e trattamento dei crediti pubblici nel concordato: Questo è un punto chiave per molte piccole imprese indebitate col fisco. Fino a pochi anni fa, era controverso fin dove si potessero “tagliare” i debiti tributari in un concordato. Oggi: – È possibile includere nel piano una proposta di transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII) in cui si offre di pagare parzialmente e/o dilazionare i debiti verso Erario e INPS. Secondo la legge attuale, l’Erario può aderire o dissentire al voto. Nel 2023, il legislatore con L. 103/2023 ha modificato transitoriamente la disciplina: non vale più il silenzio-assenso automatico se l’Agenzia non risponde . Oggi, se il Fisco vota no (o non vota entro 90 giorni, equiparato a no), il tribunale può comunque omologare il concordato (cram-down fiscale) solo a stringenti condizioni: 1. Il piano non dev’essere puramente liquidatorio (deve esserci un minimo di continuità) . 2. Senza il voto del Fisco non si raggiungerebbe la maggioranza richiesta (cioè il Fisco è determinante: se togli i suoi crediti, i consensi scendono sotto il 50%). 3. I crediti chirografari non pubblici aderenti devono essere almeno il 25% del totale crediti (a garanzia che c’è un sostegno significativo da privati). 4. La proposta al Fisco dev’essere conveniente rispetto alla liquidazione (deve prendere almeno quanto avrebbe in caso di fallimento, cosa certificata dall’attestatore) . 5. La proposta deve offrire al Fisco almeno il 30% del credito complessivo (comprensivo di sanzioni e interessi) . Se invece i creditori privati sono <25%, servirebbe alzare l’offerta al 40% e max 10 anni di dilazione per convincere il giudice . – Queste regole, in vigore nel 2024-2025, fanno sì che il Fisco non possa più essere trattato troppo peggio degli altri. Se il piano non rispetta questi minimi, il tribunale non potrà omologare contro il parere dell’Erario. – In pratica, un concordato per essere approvato senza l’adesione esplicita del Fisco deve pagare almeno 30% del debito fiscale, in un lasso ragionevole (entro 10 anni al massimo) e dimostrare che quell’offerta è il meglio possibile (esempio: in fallimento il Fisco prenderebbe 10%, qui gliene offro 35% -> allora il giudice può forzare l’omologa nonostante voto contrario). – Se invece il Fisco aderisce volontariamente (cosa che farà se ritiene il piano valido), allora ogni vincolo decade e può accettare anche meno, ma con le nuove norme il silenzio non è più considerato adesione.
Per una copisteria con un debito fiscale grande, queste norme significano: posso ridurre il debito fiscale attraverso un concordato, ma devo comunque garantire un pagamento significativo. Ad es., se ho €100.000 di debiti tra IVA e INPS, dovrò offrirne almeno €30.000 in 5-6 anni. Se la copisteria genera utili annuali, può farlo. Se invece non è fattibile, allora probabilmente si punterà alla liquidazione (dove però, paradossalmente, il Fisco magari prenderebbe ancora meno ma l’imprenditore si libererebbe via esdebitazione).
Conclusione sul concordato preventivo: È uno strumento potente di soluzione negoziale della crisi, perché coinvolge i creditori e li fa votare su una proposta che generalmente conviene anche a loro più del fallimento (altrimenti non voterebbero a favore). Per il debitore, se approvato, significa evitare la dichiarazione di fallimento e spesso poter continuare l’attività pur riducendo il debito a una parte (la percentuale concordataria). Richiede però un rigoroso studio di fattibilità e la capacità di ottenere l’assenso dei creditori. Non va improvvisato: servono bilanci trasparenti, un buon attestatore e il rispetto delle regole di priorità (non si possono danneggiare i privilegiati oltre certo limite: se un privilegiato non viene pagato integralmente, deve votare come chirografo nella sua parte falcidiata, ecc.).
Per le PMI, il concordato preventivo a volte risulta oneroso e complesso, motivo per cui è stato introdotto il concordato minore per i soggetti sotto soglia. Difatti, passiamo ora alle procedure di sovraindebitamento, che includono un concordato semplificato per i piccoli imprenditori.
Procedure da sovraindebitamento (ex Legge 3/2012) nel CCII
Le cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono gli strumenti previsti per i debitori non soggetti né assoggettabili a fallimento (liquidazione giudiziale). Originariamente introdotte con la L. 3/2012 (la “legge salva suicidi”), sono state ridefinite e ampliate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza entrato in vigore nel 2022. Il termine sovraindebitato indica la persona (fisica o giuridica) che non può accedere alle procedure maggiori ma si trova in perdurante squilibrio e incapacità di pagare i debiti. Vi rientrano: i consumatori (persone fisiche non imprenditori), i piccoli imprenditori commerciali sotto soglia, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative (nel periodo di esenzione), i professionisti, e in generale tutti i debitori “civili” non fallibili.
Per una copisteria, ciò è rilevante se l’attività è svolta in forma di impresa individuale o società di persone che risulti sotto i limiti dimensionali di fallibilità. In tali casi, in luogo di concordato preventivo e fallimento, si applicano: – il concordato minore (ex “accordo di composizione”) – procedura negoziale con i creditori per ristrutturare i debiti; – il piano di ristrutturazione del consumatore – simile al concordato minore ma riservato a chi ha debiti da consumo (non d’impresa); – la liquidazione controllata del sovraindebitato – procedura liquidatoria equivalente al fallimento per chi non può accedervi, attivabile anche dai creditori; – l’esdebitazione del debitore incapiente – una novità, che consente al debitore persona fisica senza beni di ottenere comunque la liberazione dai debiti a certe condizioni.
Esaminiamo brevemente ciascuno:
Concordato minore: Introdotto dagli artt. 74-83 CCII, è l’erede dell’“accordo di composizione dei debiti” della L.3/2012, destinato ai debitori non fallibili che svolgono attività economica (imprenditori minori, professionisti, artisti, start-up) . Esclude il consumatore puro. È simile a un concordato preventivo ma semplificato: – Il debitore (anche società di persone) propone ai creditori un piano di ristrutturazione con qualsiasi forma (pagamento parziale in percentuale, dilazioni, cessione di beni, mantenimento attività, ecc.), mantenendo la gestione dei beni sotto supervisione di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) . – Si deposita ricorso al tribunale competente, con il piano e la documentazione, accompagnato dall’attestazione dell’OCC sulla veridicità dei dati e fattibilità. Contestualmente si possono chiedere misure protettive (sospensione dei pignoramenti) . – Non c’è rigidamente un adunanza dei creditori: i creditori vengono consultati per iscritto. Essi votano esprimendo adesione o diniego entro un termine fissato (di regola 30 giorni) comunicando all’OCC . – La proposta si intende accettata se ottiene oltre il 50% dei crediti ammessi al voto . Non occorrono maggioranze per classi (di solito non si classano i creditori nel concordato minore, salvo magari separare interni/esterni se opportuno). – Raggiunto il quorum, il tribunale tiene udienza per l’omologazione. Verifica legalità, fattibilità e meritevolezza (affidabilità) del debitore . Se tutto ok, omologa con decreto/sentenza che rende il piano obbligatorio per tutti i creditori concorsuali. – Effetti: come nel concordato grande, i creditori ricevono quanto previsto nel piano e per il resto non possono più agire. Il debitore ottiene l’esdebitazione già con l’omologa a condizione di eseguire correttamente il piano . Se in futuro non adempie, il concordato può essere risolto su istanza dei creditori e allora i creditori recuperano i diritti (potranno chiedere liquidazione controllata). – Cram-down per creditori pubblici: Anche nel concordato minore opera il meccanismo per superare l’eventuale voto negativo di Fisco/INPS. L’art. 80 co.3 CCII consente al giudice di omologare ugualmente se ritiene la loro opposizione “irragionevole” confrontando quanto offerto col ricavabile in liquidazione . È il cosiddetto cram-down fiscale: se ad esempio Agenzia Entrate vota no ma la proposta è meglio del fallimento, il giudice può imporla lo stesso. – Soci illimitatamente responsabili: se a proporre concordato minore è una società di persone, per liberare anche i soci occorre prevederlo espressamente nel piano, altrimenti i debiti personali dei soci restano . – Soglia di pagamento: non c’è un minimo fisso per i chirografari (non esiste il 20% del concordato preventivo), si valuta caso per caso. Questo rende il concordato minore flessibile, ma ovviamente deve rispettare il test di convenienza rispetto alla liquidazione controllata (nessun creditore può essere trattato peggio di quanto otterrebbe liquidando tutto).
In pratica, il concordato minore è la via di uscita negoziale per la piccola copisteria non fallibile. Esempio: Ditta individuale Mario ha debiti totali 100k; propone di pagarne 50k in 5 anni coi profitti futuri, in cambio i creditori stralciano il 50% restante. Se i creditori che rappresentano >50k credito dicono sì, il giudice omologa e Mario salva l’attività pagando la metà dei debiti in 5 anni. Abbiamo visto nello scenario pratico 1 riportato sopra un caso simile con debiti fiscali: l’architetto Mario con 100k debiti pagherà in 5 anni grazie al concordato minore e otterrà il cram-down sull’Erario dissenziente .
Piano di ristrutturazione del consumatore: Se il debitore non esercita attività d’impresa (es. un ex imprenditore, o i debiti sono personali), allora la procedura ad hoc è il “piano del consumatore”, ora detto piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). La differenza principale è che qui non serve il voto dei creditori: il tribunale omologa il piano valutandone la fattibilità e la meritevolezza del consumatore, senza consultazione (salvo sentire i creditori se riduce ipoteche). Questo perché si presume che un consumatore, a differenza di un imprenditore, non abbia potere contrattuale coi creditori. Il requisito chiave è che il consumatore non abbia colpe gravi nell’aver contratto il debito (no indebitamento irresponsabile). La Cassazione nel 2023 (sent. 22890/2023) ha chiarito che, dopo la riforma, il criterio di meritevolezza si riduce all’assenza di dolo o colpa grave nel causare il sovraindebitamento . Non si richiede più di valutare la proporzione tra credito ottenuto e capacità patrimoniale come prima. Quindi c’è maggiore apertura a concedere piani ai consumatori, salvo frodi. Se la nostra copisteria fosse, ad esempio, un ex imprenditore che ha chiuso ma gli sono rimasti debiti personali (affitti, bollette, prestiti personali), potrebbe usare il piano del consumatore per pagare ciò che può in un periodo e farsi esdebitare il resto.
Liquidazione controllata del sovraindebitato: È la procedura “fallimentare” per chi non può fallire. Prevista agli artt. 268-277 CCII, ricalca la struttura della liquidazione giudiziale: – Può essere avviata su richiesta del debitore o dei creditori . Questa è una differenza: nella vecchia L.3/2012 la liquidazione del patrimonio era solo volontaria, ora i creditori possono chiedere la liquidazione controllata di un debitore civile, costringendolo in procedura (purché provino lo stato d’insolvenza). – Viene nominato un Liquidatore (simile al curatore) che amministra e liquida i beni del debitore sotto la vigilanza di un giudice. – Tutti i beni pignorabili del debitore diventano parte della massa attiva, compresi quelli che dovessero sopravvenire entro una certa finestra: qui c’è stato un intervento della Corte Costituzionale nel 2024, che ha fissato in 3 anni dalla apertura il limite massimo per acquisire beni futuri , analogamente al termine per l’esdebitazione di diritto (art. 282 CCII) . In pratica, se il debitore ottiene redditi nei 3 anni seguenti, vanno ai creditori salvo la parte per mantenersi; dopo 3 anni la procedura si chiude e scatta l’esdebitazione automatica . Questo per evitare che la liquidazione si prolunghi “a vita” per chi deve ripagare poco a poco i debiti (la Consulta ha stabilito che oltre 3 anni il debitore ha diritto a riavere la disponibilità dei propri redditi) . – La liquidazione controllata non richiede meritevolezza per l’accesso (anche un debitore in mala fede può finirci, soprattutto se sono i creditori a chiederla), ma per ottenere poi l’esdebitazione finale il debitore persona fisica dovrà dimostrare di aver cooperato lealmente e di non aver frodato i creditori (criteri simili alla legge fallimentare). Se ci sono condotte fraudolente o frodi, il giudice può escludere l’esdebitazione. – Gli effetti per i creditori: analoghi al fallimento, con stop ai pignoramenti e soddisfacimento collettivo. Tuttavia, l’assenza di soglie di fallibilità comporta che anche situazioni molto piccole possono finire in liquidazione controllata: ad esempio, un artigiano con 20k di debiti, insolvente, potrebbe essere messo in liquidazione controllata su istanza di un creditore. Bisogna vedere se economicamente ha senso, perché le spese procedurali rischiano di assorbire tutto se l’attivo è esiguo. – Per il debitore, come detto, c’è la prospettiva di una esdebitazione “automatica” decorsi 3 anni dall’apertura, senza bisogno di domanda formale, purché abbia soddisfatto certi presupposti (art. 282 CCII). Questo è un miglioramento rispetto al passato: chi liquidava tutto sotto L.3/2012 doveva poi chiedere l’esdebitazione e non era garantita, ora è un effetto di diritto a fine triennio, salvo eccezioni (frodi, etc.). – Esempio: se la nostra copisteria individuale non è più attiva e i creditori vogliono liquidare i suoi beni (poniamo abbia una casa, dei mezzi), potranno ottenerne la vendita con liquidazione controllata, e dopo 3 anni il debitore persona fisica verrà liberato dai debiti residui.
Esdebitazione del debitore incapiente: Questa è una novità (art. 283 CCII) che merita menzione. È rivolta al debitore persona fisica meritevole che: – non ha né patrimonio né redditi da offrire ai creditori (c.d. incapiente totale), – ha adempiuto ai doveri di cooperazione e non ha commesso atti in frode, – non ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti.
Può chiedere direttamente al tribunale di essere esdebitato senza liquidazione (quindi liberato dai debiti) pur non pagando nulla ai creditori. Il tribunale, sentiti i creditori, può concedere questa esdebitazione gratuita una tantum. Tuttavia, per i successivi 4 anni, se le condizioni economiche del debitore migliorano in modo rilevante (ad es. vince alla lotteria, o ottiene un’eredità consistente), è obbligato a versare ai vecchi creditori fino a concorrenza di quanto ricevuto o comunque non oltre i debiti originari. In pratica, è un “fresh start” per chi è davvero nullatenente, con un meccanismo di claw-back sui redditi futuri eccezionali. Questa misura è stata pensata come ultima spiaggia per persone oneste ma sfortunate, per evitare che restino schiacciate a vita da debiti impagabili e senza prospettiva (ha anche finalità sociali di contrasto all’usura e all’economia sommersa: un indebitato cronico altrimenti finirebbe per lavorare in nero o simili per sfuggire ai creditori, mentre con l’esdebitazione può tornare nell’economia legale).
Applicandolo al caso copisteria: immaginiamo un piccolo stampatore che ha chiuso e venduto già tutto, rimangono €50.000 di debiti che non potrà mai pagare col suo stipendio da dipendente che ora ha. Potrebbe chiedere l’esdebitazione da incapiente. Se gliela concedono, i 50k sono cancellati. Ma se entro 4 anni, poniamo, riceve 100k di eredità, dovrà avvisare i creditori e pagarli fino a 50k (il debito originario) altrimenti l’esdebitazione è revocata.
Conclusione sulle procedure di sovraindebitamento: Per la copisteria sotto soglia queste procedure sono fondamentali, perché sono l’unico modo per trattare il debito in modo ordinato ed essere esdebitati senza passare per il “fallimento”. Spesso le microimprese individuali usano molto la liquidazione controllata come via per chiudere definitivamente l’attività e liberarsi dei debiti: consegnano quel poco che hanno al liquidatore, e dopo 3 anni ottengono l’esdebitazione. Oppure, se vogliono ancora provare a salvare il business, tentano il concordato minore proponendo ai creditori uno sconto. L’OCC (organismo di composizione della crisi, in genere istituito presso gli Ordini professionali) fornisce assistenza tecnica al debitore per predisporre piani e procedure, agendo come ausilio del tribunale. Questo è un supporto importante, soprattutto per debitori non assistiti da costosi studi legali.
Va sottolineato che l’accesso a queste procedure richiede onestà e trasparenza: occorre depositare tutta la documentazione di bilanci, elenco beni, elenco debiti, redditi degli ultimi anni, e l’OCC verifica. Se emergono sottrazioni di beni ai creditori (es. si è regalata la casa al figlio prima di chiedere la procedura), il giudice rigetterà per atti in frode (art. 69 CCII). La meritevolezza conta molto di più per il consumatore; per l’imprenditore minore è più questione di leale cooperazione.
In definitiva, le procedure da sovraindebitamento sono l’equivalente “a misura di piccolo” di concordato e fallimento. Offrono un equilibrio tra interesse del debitore (tramite l’esdebitazione garantita in 3 anni o immediata) e interesse dei creditori (tramite un soddisfacimento collettivo, sebbene parziale, evitando di lasciar correre situazioni insolventi).
Di seguito presentiamo una tabella riepilogativa comparativa delle principali caratteristiche delle procedure concorsuali per soggetti sovraindebitati:
| Strumento | Destinatari | Contenuto del piano/Procedura | Esito ed effetti |
|---|---|---|---|
| Concordato minore | Imprenditore minore, professionista, agricoltore, start-up (non consumatore) . | Piano proposto dal debitore per pagare i creditori in tutto o in parte, con eventuale continuazione dell’attività. Gestione rimane al debitore (coadiuvato da OCC) . Creditori votano (>50% crediti) . | Se omologato, sospende le azioni esecutive; il debitore esegue il piano sotto vigilanza. Debiti residui cancellati a fine piano (esdebitazione). Possibile cram-down su Fisco/INPS se piano più conveniente di liquidazione . Soci illimitati liberati solo se previsto . |
| Piano del consumatore | Persona fisica consumatore (debiti non professionali). | Piano simile al concordato, ma senza voto creditori: decide solo il giudice in base a fattibilità e meritevolezza . Può prevedere dilazioni fino a 5-6 anni, pagamenti anche parziali non proporzionali (flessibilità massima). | Omologato dal tribunale se il debitore meritevole e i creditori non ricevono meno di quanto avrebbero dalla liquidazione. Creditori vincolati all’omologa; debiti residui cancellati se il debitore esegue il piano. Se inadempiuto, si può convertire in liquidazione controllata. |
| Liquidazione controllata | Qualsiasi debitore sovraindebitato (persona fisica o giuridica) che non sia in grado di offrire un piano fattibile oppure su iniziativa dei creditori . Include imprenditori minori, consumatori, ex imprenditori, ecc. | Procedura concorsuale esecutiva: un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. Il debitore perde la disponibilità del patrimonio (spossessamento) . Procedura analoga al fallimento (pubblicazione, domande di credito, riparto). | Al termine (durata max ~3 anni per persone fisiche) , il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto (liberazione dai debiti residui) . Durante la procedura, stop a pignoramenti individuali. Se debitore in mala fede (atti in frode), può essergli negata esdebitazione. I creditori vengono soddisfatti secondo i privilegi; se recuperano una percentuale esigua subiscono il sacrificio ma non possono più pretendere altro in futuro. |
| Esdebitazione incapiente | Persona fisica sovraindebitata meritevole che non ha beni né redditi da liquidare (nullatenente) e almeno 5 anni dopo eventuale altra esdebitazione. | Procedimento semplificato: il debitore chiede al giudice di essere esdebitato pur non offrendo nulla ai creditori, impegnandosi però a informare su eventuali sopravvenienze attive significative nei 4 anni successivi. | Il tribunale, se concede l’esdebitazione, cancella tutti i debiti immediatamente. Se entro 4 anni il debitore ottiene entrate rilevanti, deve pagarle (fino concorrenza debiti cancellati) ai vecchi creditori, altrimenti l’esdebitazione può essere revocata. Se dopo 4 anni nessuna sostanziale miglioria economica è intervenuta, i creditori non possono più reclamare nulla. È una “seconda chance” totale per chi è senza risorse. |
(Fonti: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, artt. 65-83, 268-277, 282-283 CCII; Relazioni ministeriali; giurisprudenza di legittimità aggiornata )
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Oltre a concordati e sovraindebitamento, l’ordinamento italiano prevede un ulteriore strumento per imprese in crisi: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviati in “ADR” – accordi di ristrutturazione). Si tratta di accordi stragiudiziali tra l’imprenditore e una parte significativa dei creditori, che vengono poi omologati dal tribunale per acquisire efficacia verso tutti (quantomeno indirettamente). Sono disciplinati dagli artt. 57-64 CCII e rappresentano una via intermedia: meno complessi del concordato, più vincolanti di una semplice transazione privata.
Caratteristiche principali: – Percentuale di adesione richiesta: per un accordo “ordinario” serve il consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Ciò significa che l’imprenditore deve convincere una larga maggioranza (per valore) dei creditori a sottoscrivere un accordo sul piano di rientro/ristrutturazione. I creditori non aderenti restano estranei (devono esser pagati integralmente nei termini di legge, di solito entro 120 giorni dall’omologa o scadenza originaria, per essere omologabile l’accordo). – Procedura: l’accordo viene depositato in tribunale insieme a una relazione di un attestatore indipendente che certifica che con l’accordo il debitore potrà pagare regolarmente i creditori estranei (quelli che non firmano) nei termini di legge . Il tribunale, verificati i requisiti (soglia 60%, corretta informazione ai creditori, fattibilità), omologa l’accordo. Da quel momento, l’accordo è vincolante per i sottoscrittori; i non aderenti, come detto, vanno soddisfatti a parte ma nei modi previsti (integralmente entro 120 giorni). – Misure protettive: l’imprenditore può chiedere contestualmente una moratoria delle azioni esecutive sin dalla pubblicazione della domanda di omologa (art. 54 CCII), così come nel concordato. Inoltre, con l’avvio delle trattative può ottenere dal tribunale una sospensione provvisoria di 30-60 giorni delle azioni esecutive, se comunica che sta negoziando un accordo con almeno il 30% dei creditori . – Vantaggi rispetto al concordato: – Quorum più basso (in concordato serve >50% ma su 100% dei crediti e tutte le classi; qui basta 60% dei crediti totali e non c’è voto formale, solo adesioni contrattuali). – Procedimento più snello: di solito non c’è adunanza creditori né commissario; il controllo del tribunale è limitato. – Riservatezza: prima dell’omologa le trattative sono riservate; diventa pubblico solo quando depositi in tribunale per omologa. – Nessuna necessità di par condicio interna: si può trattare diversamente con diversi creditori a seconda dell’accordo bilaterale (fermo restando il 40% estranei vanno pagati per legge integrale). – Dopo omologa, l’impresa non è formalmente “in procedura concorsuale” (ci sono vantaggi anche reputazionali, e.g. non perde qualifiche SOA se avesse appalti, ecc.). – Effetti protettivi simili al concordato: blocco delle esecuzioni su richiesta. – Esenzione da revocatoria: i pagamenti e atti eseguiti in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti a revocatoria fallimentare, come previsto dall’art. 59 CCII (già art. 67 LF).
- Varianti introdotte nel CCII:
- Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII): se non si chiedono misure protettive e si paga per intero entro 120 giorni i creditori estranei (nessuna moratoria per estranei), la percentuale di adesione richiesta è ridotta a 30% . Quindi in uno scenario di copisteria, se si hanno pochi creditori e il 30% di essi (in valore) è d’accordo, si può fare un accordo “agevolato” ottenendo comunque l’omologa purché si garantisca protezione totale ai dissenzienti (pagati integralmente subito). Questo strumento serve per anticipare le crisi: con pochi consensi l’imprenditore può formalizzare un accordo senza dover arrivare a insolvenza conclamata.
- Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): se si raggiunge un accordo con creditori appartenenti a certe categorie qualificate (tipicamente banche e intermediari finanziari) pari ad almeno il 75% dei crediti di quella categoria, il tribunale può estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori finanziari dissenzienti della stessa categoria . Ciò è pensato per evitare le resistenze di un singolo istituto quando tutti gli altri hanno aderito. Per esempio, se la copisteria ha debiti con 4 banche e 3 su 4 (che rappresentano magari 80% dell’esposizione) sottoscrivono l’accordo, la quarta banca dissenziente può essere obbligata ad accettarne gli effetti per decisione del tribunale, purché la proposta fosse omogenea per tutti.
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): consente di vincolare anche le banche dissenzienti a una moratoria dei pagamenti se almeno il 75% degli istituti l’ha accettata. Queste sono norme specialistiche destinate per lo più a ristrutturazioni di medio-grandi imprese con pool bancari.
- Transazione fiscale negli ADR: L’art. 63 CCII consente di includere i debiti fiscali e contributivi in un accordo omologato. Dopo le modifiche del 2023, valgono gli stessi parametri restrittivi visti per il concordato (offrire almeno il 30%, ecc.) per poter omologare l’accordo senza adesione dell’Erario . Nel regime transitorio attuale, il silenzio dell’Agenzia Entrate entro 90 gg è considerato dissenso superabile col cram-down alle condizioni a-e menzionate . Quindi, per includere Equitalia in un accordo, la copisteria dovrà proporre almeno il 30% sul debito fiscale e dimostrare che senza quell’accordo i crediti pubblici prenderebbero meno in fallimento. Se l’Agenzia comunque non firma, potrà chiedere al giudice di omologare lo stesso (le stesse regole di L. 103/23 prima viste).
- Termini e opposizioni: i creditori non aderenti possono fare opposizione all’omologa entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo, lamentando ad es. che sono pregiudicati. Il tribunale deciderà in camera di consiglio. Se tutto regolare, omologa e l’accordo produce i suoi effetti.
Quando può servire un ADR a una copisteria? In imprese di piccole dimensioni raramente si usano gli accordi di ristrutturazione, perché occorre comunque coinvolgere un attestatore e c’è la soglia del 60%. Però pensiamo a una SRL copisteria con due banche principali e il fisco come creditori maggiori. Un concordato preventivo è oneroso e lungo; se la SRL è in crisi ma vuole evitare fallimento, potrebbe negoziare con le due banche (che detengono ad es. 70% dei crediti) un accordo di rientro (tipo: rinegoziare i mutui allungandoli e rinunciando a interessi di mora) e con il fisco un piano di pagamento con taglio sanzioni (transazione fiscale). Se ottiene la firma di banche (70% > 60%), deposita l’accordo, il giudice omologa: le banche saranno vincolate a rispettare le nuove scadenze, il fisco se ha aderito uguale, se non aderisce va comunque pagato per intero fuori dall’accordo (salvo tentare cram-down se si rispettano condizioni). I piccoli fornitori estranei saranno pagati regolarmente. L’azienda non risulta “fallita” né in concordato, continua normalmente ma con un accordo omologato alle spalle. Questo scenario è utile se il nodo sono poche banche/enti con cui trovare un’intesa, mentre i fornitori minori possono essere soddisfatti normalmente.
Rischi e svantaggi degli ADR: – Se non si raggiunge la soglia del 60% (o 30% agevolato), l’accordo non può essere omologato: ci si ritrova punto e a capo (per questo spesso chi avvia trattative chiede subito la composizione negoziata o deposita riserva di concordato per pararsi). – I creditori non aderenti, benché vadano pagati per intero legalmente, possono nel frattempo rompere le uova nel paniere (pignoramenti): serve chiedere misure protettive, ma queste riducono la flessibilità dell’accordo (ricorrere a misure protettive impedisce l’accordo agevolato al 30%, ad esempio). – Se l’accordo poi non viene eseguito (l’imprenditore non rispetta i pagamenti), i creditori aderenti tornano liberi e possono chiedere il fallimento. La Cassazione SU 4696/2022 ha chiarito che la risoluzione di un accordo segue le regole generali: il creditore aderente può chiedere il fallimento anche senza prima una pronuncia formale di risoluzione contrattuale entro un anno (a differenza del concordato) . Quindi c’è meno rigidità di termini: un creditore bancario aderente che non viene pagato può anche attendere e poi far valere l’accordo risolto. – Non c’è coinvolgimento di tutti i creditori: se l’impresa ha molti piccoli creditori chirografari arrabbiati, questi, pur dovendo essere pagati integralmente secondo la legge, potrebbero cercare di presentare istanza di fallimento prima che l’accordo decolli. Però il tribunale, sapendo dell’accordo depositato, potrebbe sospendere l’istruttoria prefallimentare in attesa di vedere se l’accordo ha successo (c’è giurisprudenza in merito). – La necessità di un attestatore indipendente è comunque presente: va quindi predisposto un piano con serietà e costi.
In sintesi, gli accordi di ristrutturazione sono pensati soprattutto per imprese che hanno meno creditori e più strutturati (banche, grandi fornitori) e vogliono una soluzione flessibile e confidenziale. Per microimprese come una tipica copisteria, è più comune ricorrere direttamente a sovraindebitamento o concordato minore, salvo casi dove magari l’indebitamento è quasi tutto bancario e si preferisce l’ADR.
Esdebitazione: liberarsi dei debiti residui
Un filo conduttore che abbiamo più volte menzionato è l’esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore persona fisica dai debiti non soddisfatti al termine di una procedura concorsuale. Dal punto di vista del debitore insolvente, è fondamentale comprenderne la portata: è ciò che consente di avere una seconda opportunità senza restare perseguitati vita natural durante dai creditori.
Principali situazioni in cui opera: – Dopo la liquidazione giudiziale (fallimento): l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile, una volta chiuso il fallimento, può ottenere con provvedimento del tribunale l’esdebitazione dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti (art. 279 CCII). I requisiti sono: aver cooperato, non aver distratto attivi, non aver commesso reati fallimentari, non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, ecc. La Corte di Cassazione sin da prima (SU 24214/2011) sottolineava l’importanza di dare al fallito meritevole la possibilità di ripartire. Oggi è quasi “ordinaria amministrazione” concederla se non ci sono opposizioni. Viene negata solo a falliti fraudolenti o irreperibili che non hanno consegnato libri. – Dopo il concordato preventivo: in realtà nel concordato il concetto classico di esdebitazione non serve perché l’omologa stessa funge da esdebitazione ipso iure per i crediti falcidiati. Cioè, se in concordato paghi il 30%, il restante 70% è già inesigibile per effetto dell’omologa. Non serve un provvedimento ad hoc. – Dopo il concordato minore o il piano del consumatore: analogamente, l’omologazione e l’esecuzione integrale del piano comportano la definitiva inesigibilità della quota residua di debiti. Il CCII esplicita che con la sentenza di omologa, se il piano è soddisfacente e il debitore ha cooperato onestamente, è autorizzata l’esdebitazione per la parte non pagata . In pratica, i creditori chirografari accettano di prendere una percentuale e rinunciano al resto. – Dopo la liquidazione controllata: qui c’è la grossa novità già detta: l’esdebitazione scatta automaticamente entro 3 anni dall’apertura, senza bisogno di istanza, salvo che il debitore non la meriti per comportamenti scorretti . Quindi, il debitore sovraindebitato che liquida tutto si vede cancellare i debiti al massimo in un triennio. – Esdebitazione “immediata” dell’incapiente: è anch’essa un modo di liberare dai debiti, solo che avviene subito e senza attivo da distribuire, come già spiegato.
Cosa comporta l’esdebitazione? Comporta che i creditori chirografari non soddisfatti perdono definitivamente il diritto di procedere contro il debitore per la parte residua. I crediti sono estinti civilmente. Fanno eccezione (art. 278 CCII, ex art. 142 LF) alcuni tipi particolari: – obblighi di mantenimento e alimentari, – debiti da risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale (es. se il debitore deve risarcire un danno per aver causato un incendio colposo, quel debito resta), – sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non vengono esdebitate (multe, ammende, contravvenzioni, ecc., lo Stato vuole che comunque se un domani l’ex fallito ha soldi paghi le sue multe, anche se in pratica se non glieli ha presi prima difficilmente li riprenderà). – I debiti fiscali invece sono esdebitabili (questo è importante: inizialmente la normativa fallimentare non lo chiariva, ma poi giurisprudenza e Legge 221/2012 hanno chiarito che anche lo Stato rimane vincolato dall’esdebitazione, altrimenti sarebbe inutile).
Ci sono stati casi in cui l’Agenzia Entrate provava a riscuotere differenze dopo l’esdebitazione, ma la Corte di Cassazione li ha stoppati: ad esempio Cass. 205/2020 ha ribadito che le cartelle riferite a crediti anteriori al fallimento si estinguono con l’esdebitazione. Quindi è davvero un “fresh start”.
Importanza pratica: per il titolare di copisteria che ha visto fallire o liquidare la propria attività, l’esdebitazione è la luce in fondo al tunnel: può tornare a intraprendere (anche se come fallito per un certo periodo ha limitazioni, una volta esdebitato può aprire nuova azienda, ottenere un mutuo — benché le banche possano essere caute, ma legalmente non c’è una preclusione ad eterno).
Va osservato che con il CCII l’orientamento è di rendere l’esdebitazione più accessibile e rapida, in linea con la direttiva UE 2019/1023: ecco la riduzione a 3 anni per i sovraindebitati, e l’introduzione dell’istituto per incapienti. Questo riflette la filosofia che punire a vita l’imprenditore sfortunato scoraggia l’iniziativa economica e la tempestiva emersione della crisi (se so che fallendo sarò libero dai debiti in pochi anni, sono più propenso a dichiarare crisi e chiudere, piuttosto che trascinarmi indefinitamente e aumentare i buchi).
Distinguiamo tuttavia i soggetti esdebitabili: solo persone fisiche ne beneficiano. Se la copisteria è SRL e fallisce, la società viene liquidata e cancellata: i creditori sociali non hanno più un soggetto da inseguire (salvo garanzie), ma i soci non hanno bisogno di esdebitazione perché non erano debitori (a meno di garanzie personali: ma quelle sono obblighi separati, l’esdebitazione del fallimento della SRL non copre il fideiussore socio, attenzione!). Però se quel socio ha garantito i debiti, allora lui magari come persona fisica può attivare proprie procedure (sovraindebitamento suo per le garanzie escusse, ad esempio). Invece il titolare di ditta individuale o i soci SNC falliti usufruiscono dell’esdebitazione.
Revoca o diniego dell’esdebitazione: È bene sapere che l’esdebitazione può essere revocata se si scopre che è stata ottenuta fraudolentemente (ad esempio il debitore ha occultato beni e post esdebitazione salta fuori che li aveva venduti di nascosto) oppure se non rispetta i doveri post (nel caso dell’incapiente, come detto, se non paga le sopravvenienze di cui è obbligato). Anche comportamenti come aver falsificato i dati nel piano del consumatore possono portare a revoca su istanza di creditori danneggiati. Quindi non è un condono incondizionato: richiede correttezza.
Per dare una visione dal punto di vista del debitore: in ogni strategia, egli dovrebbe mirare, se il debito è sproporzionato, a incanalarsi verso una soluzione che preveda l’esdebitazione. Ad esempio, se la copisteria non è salvabile come business, tanto vale che il titolare faccia liquidazione controllata e in 3 anni sia libero: diversamente, se prova a restare aperto ma la situazione peggiora, tra 5 anni avrà ancora i debiti e magari nel frattempo perso altri beni. Questo ragionamento (“meglio fallire subito e ricominciare pulito, che agonizzare a oltranza”) è spesso difficile da accettare emotivamente per l’imprenditore, ma giuridicamente è la ratio del sistema: la discarica dei debiti esiste, va usata responsabilmente quando non c’è alternativa.
Riassumendo, ecco una breve FAQ conclusiva per chiarire alcuni dubbi comuni dal lato del debitore.
Domande frequenti (FAQ)
D: Una piccola copisteria può essere dichiarata fallita (liquidazione giudiziale)?
R: Dipende dalle dimensioni dei suoi affari e dall’ammontare dei debiti. Se l’impresa individuale o la società di persone che gestisce la copisteria supera anche solo uno dei seguenti parametri – attivo annuo > €300.000, ricavi annui > €200.000 o debiti totali > €500.000 – allora non è considerata “piccolo imprenditore” e può essere assoggettata a liquidazione giudiziale in caso di insolvenza . Se invece rientra sotto tutti e tre i limiti, è esclusa dal fallimento ordinario e rientra nelle procedure di sovraindebitamento. Inoltre, in ogni caso, la legge prevede che non si apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti non pagati sono inferiori a €30.000 . Quindi, ad esempio, una copisteria individuale con €400.000 di debiti potrebbe essere dichiarata fallita (perché supera la soglia debiti 500k? No, 400k < 500k, quindi in realtà rientra nei parametri e non sarebbe fallibile; se avesse €600.000 sì). Una SRL copisteria, invece, non gode di quella franchigia dimensionale: anche con ricavi modesti, può fallire se insolvente (salvo il filtro dei 30.000 € di debito minimo). In pratica molte copisterie sottoforma di ditte individuali o società di persone di piccola scala non possono essere portate in tribunale per fallimento dai creditori, ma solo utilizzare la via del sovraindebitamento. Una società di capitali, seppur micro, potrebbe tecnicamente fallire, ma spesso per importi minimi non conviene a nessuno attivare la procedura.
D: Cosa succede se non pago le tasse della mia copisteria?
R: L’omesso pagamento di imposte (IVA, imposte sui redditi) attiva la riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ti verrà notificata una cartella esattoriale. Se continui a non pagare, dopo 60 giorni la riscossione può procedere con: interessi di mora (circa 3,5-4% annuo attualmente), fermo amministrativo sui veicoli aziendali, ipoteca sui tuoi beni immobili (se il debito ≥ €20.000) , e pignoramenti su conti correnti, attrezzature, crediti verso clienti. Inoltre, se sei un’impresa individuale, dal 2013 Equitalia (oggi ADER) non può pignorare la tua prima casa se è l’unica e vi risiedi . Tuttavia può iscrivere ipoteca su di essa (che blocca di fatto la possibilità di venderla o ipotecarla altrove). Può pignorare altri immobili diversi dalla prima casa (magazzini, seconde case) se il debito supera €120.000 . Se gli importi non versati superano soglie penali (IVA > 250k, ritenute > 150k), rischi un procedimento penale per omesso versamento. È fondamentale in caso di debiti fiscali muoversi per tempo: ad esempio chiedere una rateizzazione della cartella (ottenibile fino a 6 anni senza troppe formalità per debiti sotto 120k) o aderire a eventuali rottamazioni (nel 2023 c’era la “rottamazione-quater” per annullare sanzioni e interessi). Non pagare le tasse porta anche all’irregolarità contributiva (niente DURC se hai dipendenti, problemi se lavori con enti pubblici) e agli interessi che maturano su base quotidiana. In sintesi: se hai difficoltà a pagare le imposte, comunica con l’Agenzia (per esempio, puoi chiedere una proroga per lieve inadempimento se sei decaduto da una rateazione con il cosiddetto “saldo del 10%” entro 30 gg dalla scadenza, oppure attendere nuove definizioni agevolate – ma quest’ultima è rischiosa perché non garantita). Ignorare il debito fiscale porterà quasi sicuramente a pignoramenti (specie su conto corrente e a eventuali clienti tramite pignoramento crediti presso terzi).
D: Posso evitare il fallimento aprendo una procedura di concordato o sovraindebitamento?
R: Sì. La legge incoraggia il debitore a prendere l’iniziativa. Se la tua copisteria è in crisi ma ancora vuoi salvarla, puoi presentare domanda di concordato preventivo (se sei fallibile) o di concordato minore (se sei sovraindebitato non fallibile). Dal momento del deposito della domanda (anche “in bianco”), il tribunale concede la sospensione delle azioni esecutive dei creditori, impedendo di fatto che qualcuno ti faccia fallire nel frattempo . Poi, se il concordato va a buon fine (omologato), il fallimento è scongiurato definitivamente. Analogamente, presentare un piano del consumatore o una liquidazione controllata volontaria blocca le esecuzioni e toglie motivo ai creditori di istigare un fallimento (tra l’altro, quando c’è un sovraindebitamento aperto, per legge non può essere dichiarato un fallimento parallelo). In pratica, anticipare i creditori attivando tu una procedura ti mette in posizione di controllo e consente di evitare la dichiarazione d’ufficio della liquidazione giudiziale. Ad esempio, se un creditore ha depositato istanza di fallimento, puoi ancora depositare (fino all’udienza) una domanda di concordato preventivo: ciò obbliga il tribunale a congelare la decisione sul fallimento e darti tempo per il piano (il cosiddetto concordato “in extremis”). Attenzione però: dev’essere una mossa seria, con prospettive – i tribunali vigilano su domande di concordato abusivamente dilatorie. Nel nuovo CCII hanno introdotto l’art. 44 bis che punisce l’abuso del concordato in bianco. Quindi sì, puoi evitare il fallimento se tempestivamente proponi un’alternativa concordataria plausibile.
D: Se ho troppi debiti e nessuna possibilità di pagarli, cosa mi conviene fare?
R: In tal caso, probabilmente chiudere l’attività e avviare la liquidazione controllata del tuo patrimonio, per poi ottenere l’esdebitazione, è la soluzione drastica ma efficace. Mi spiego: se la copisteria non genera utili sufficienti neanche a pagare gli interessi sui debiti e non ci sono scenari di ripresa, procrastinare peggiora solo l’esposizione. Richiedendo tu stesso la liquidazione controllata (ex L.3/2012, oggi art. 268 CCII) metti i beni a disposizione dei creditori in modo ordinato. Il liquidatore li venderà, darà ai creditori quel poco ricavato secondo priorità, e dopo tre anni sarai automaticamente liberato dai debiti residui . Durante quei tre anni, se hai redditi, ti verrà chiesto di contribuire in parte (ciò che eccede le necessità di mantenimento, valutate con un occhio di riguardo alla dignità, quindi non ti tolgono tutto). Finito il triennio, ciò che non è stato pagato viene cancellato. In alternativa, se proprio non hai niente da liquidare (metti caso hai già venduto i macchinari per campare, non hai immobili né stipendi pignorabili), puoi tentare la via dell’esdebitazione dell’incapiente, che ti libera subito dai debiti senza passare per tre anni di liquidazione – ma devi essere sinceramente nullatenente e meritevole. Questa procedura è una novità e ha i suoi paletti, ad esempio è una sola volta nella vita e resta quella tagliola dei 4 anni per eventuali migliorìe economiche. Tendenzialmente i giudici la concedono in casi umani difficili (debitori malati, pensionati poveri sommersi dai debiti). Se sei un giovane imprenditore, forse preferiranno farti fare la liquidazione controllata classica di 3 anni. In ogni caso, affrontare il problema per via legale è meglio che fuggire o lasciare incancrenire la situazione: perché fino a che i debiti pendono, maturano interessi, i creditori possono colpirti, e tu vivi nell’ombra (magari senza intestarti nulla per paura di pignoramenti). Con l’esdebitazione invece giri pagina e, se vorrai, potrai persino riaprire un’attività nuova con le lezioni apprese dagli errori precedenti.
D: Quali debiti devo assolutamente pagare prima degli altri?
R: Dal punto di vista legale, se la tua prospettiva è di entrare in una procedura concorsuale, devi stare attento a non fare pagamenti preferenziali in periodo sospetto: pagare “assolutamente” qualcuno e lasciare altri a zero può portare a una revocatoria in fallimento (entro 6 mesi). Tuttavia, in concreto, alcuni debiti hanno un impatto immediato più grave: – I debiti verso i dipendenti: vanno pagati per evitare cause di lavoro e soprattutto perché quelle persone contano su di te per il sostentamento. Inoltre, hanno privilegio massimo e se non li paghi, in fallimento comunque verrebbero prima degli altri; tanto vale saldarli se puoi. – I debiti fiscali e contributivi correnti: se possibile, evita di creare nuovo debito con Fisco/INPS, perché questi enti hanno poteri forti. Meglio pagare IVA corrente e contributi, e magari chiedere dilazioni sul pregresso, piuttosto che continuare a accumulare. Inoltre, alcuni tributi non pagati generano sanzioni e interessi enormi. – I fornitori essenziali o le utenze: se smetti di pagare la bolletta elettrica, ti staccano la luce – e addio copisteria. Idem per affitto: due mesi e il locatore ti sfratta. Dunque queste posizioni vanno tenute sotto controllo. Può aver senso pagare il locatore e magari ritardare con fornitori secondari, se ciò mantiene aperta l’attività. Ma attenzione: questi pagamenti preferenziali se fatti in prossimità del fallimento (in tempi sospetti) potrebbero poi essere contestati. Tuttavia, i pagamenti di forniture necessarie e contestuali (ad esempio pagare il toner consegnato per continuare a lavorare) non sono revocabili perché rientrano nell’esercizio normale dell’impresa. – Il banco (istituti di credito): se hai uno scoperto di conto e smetti di rientrare, la banca potrebbe revocare i fidi e segnalarti a sofferenza, peggiorando immediatamente la tua situazione (niente più liquidità per lavorare). A volte mantenersi “buoni” con la banca finché possibile è strategico. Però non indebitarti ulteriormente per pagare la banca a scapito di tutto: valuta con un consulente se la banca eventualmente ha garanzie (se ha ipoteca, verrà soddisfatta comunque, magari conviene destinare risorse ad altri). In sostanza: paga i debiti che servono a tenerti operativo (utenze, affitto, materie prime) e quelli che possono bloccarti legalmente (stipendi, imposte fondamentali) se vedi un orizzonte di continuità. Se invece stai andando verso la chiusura, conserva cassa per pagare magari i professionisti che ti assisteranno nella procedura concorsuale e lascia che la par condicio decida chi prendere qualcosa (non dilapidare le ultime risorse pagando magari il fornitore amico e nulla al resto, perché tanto poi può essere revocato). Ogni situazione è a sé: la parola chiave è priorità e proporzionalità. Informati sempre presso un legale prima di fare scelte drastiche.
D: La mia copisteria è una SRL e sta fallendo: perdo anche la casa personale o altri beni miei?
R: In linea di massima, no, i soci di SRL non rispondono dei debiti sociali con i propri beni . Quindi se la SRL fallisce, i creditori aggrediranno solo il patrimonio aziendale (macchinari, cassa, crediti della società). I tuoi beni personali sono al sicuro, salvo tu abbia prestato garanzie personali. Spesso però, come socio/amministratore, magari hai firmato una fideiussione bancaria o hai locato l’immobile come persona fisica garantendo i canoni. In tal caso, per quella specifica obbligazione, il creditore potrà rivalersi su di te a titolo personale. Se per esempio la SRL aveva un leasing e tu hai fatto da fideiussore, se la SRL non paga, la società di leasing verrà da te. Quindi indirettamente potresti trovarti con debiti personali. Se l’esposizione è grande e non riesci a farvi fronte, potresti dover ricorrere tu stesso a una procedura di sovraindebitamento da consumatore per ottenere esdebitazione su quei debiti di garanzia (o farti includere nel concordato preventivo come coobbligato se la norma lo prevede, ma di solito no, i coobbligati restano obbligati). Riguardo la casa di abitazione: come socio SRL non viene toccata dal fallimento sociale. Potrebbe però essere colpita da ipoteche se l’hai data in garanzia (es. ipoteca volontaria su casa per mutuo aziendale). Oppure, se tu hai debiti personali col Fisco (ad esempio perché la SRL non ha versato IVA e ti contestano reati o sanzioni amministratore), il Fisco potrebbe ipotecare casa tua per il tuo debito personale. Ma strettamente parlando, i crediti verso la SRL muoiono con la società fallita e non “passano” a te. Attenzione anche a eventuali azioni di responsabilità: se la SRL fallisce e risulta che tu hai gestito in modo malaccorto o doloso causando danni ai creditori, il curatore potrebbe fare causa a te (azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. o bancarotta). Se condannato, il tuo patrimonio risponde. Questo è un rischio indiretto. Quindi, nella maggior parte dei casi il tuo patrimonio personale è protetto dall’essere socio di SRL, ma non se hai compiuto irregolarità gravi o hai firmato garanzie.
D: Se vado in concordato o fallimento, potrò aprire un’altra attività in futuro?
R: Sì, ma con delle condizioni temporanee. Durante la procedura concorsuale liquidatoria ci sono limitazioni: ad esempio, il fallito (persona fisica) non può, senza autorizzazione del giudice, iniziare una nuova impresa o assumere cariche direttive in società . Questo vincolo dura per tutto il fallimento. Nel concordato preventivo invece rimani legale rappresentante e puoi anche continuare l’attività attuale, figuriamoci aprirne un’altra – però è poco realistico pensare di aprire un nuovo business con un concordato in corso, a meno che il concordato stesso preveda la prosecuzione su altra società. Dopo la chiusura del fallimento o l’omologa del concordato, non ci sono preclusioni legali definitive: potrai aprire un’altra partita IVA o essere socio di società. Una volta ottenuta l’esdebitazione se persona fisica, non hai più restrizioni. Tieni conto tuttavia di aspetti pratici: se sei stato coinvolto in un fallimento o concordato, la tua reputazione creditizia potrebbe essere compromessa per un po’. Le banche potrebbero essere restie a concederti nuovi fidi, i fornitori potrebbero volere pagamenti anticipati. Col tempo, e dimostrando affidabilità nella nuova iniziativa, questa “macchia” pesa meno. Per legge comunque non c’è una fedina fallimentare permanente. Va anche detto che la Camera di Commercio tiene traccia dei ruoli (es. sarai stato amministratore di una società fallita, questo risulta visibile in visura storica). Ma ciò non impedisce di essere amministratore di una nuova società: occorre però valutare se si incorre in normative specifiche (per alcune licenze o albi, un fallimento potrebbe essere rilevante – ad esempio, per gli appalti pubblici occorre dichiarare di non aver procedimenti concorsuali in corso, ma se è chiuso e sei esdebitato sei a posto). In sintesi: il sistema è congegnato per dare all’imprenditore onesto un fresh start. Quindi sì, potrai riprovarci, preferibilmente facendo tesoro dell’esperienza. Magari la nuova copisteria la aprirai come SRL se prima eri ditta individuale, per ridurre i rischi personali. Oppure scalerai più prudentemente.
D: I debiti verso Stato e Fisco vengono cancellati nelle procedure?
R: Sì, sia nel concordato preventivo/sovraindebitamento (dove paghi una percentuale e il resto è stralciato all’omologa) sia nel fallimento (esdebitazione), i debiti tributari residui vengono cancellati esattamente come quelli verso fornitori . Non esistono più, dal 2017 in poi, eccezioni per cui “le tasse te le devi comunque pagare”: una volta che sei esdebitato, anche l’Agenzia Entrate non può avanzare pretese (lo ha confermato la Corte Costituzionale anni fa e il legislatore l’ha recepito). Fanno eccezione solo le sanzioni penali o amministrative: ad esempio, se avevi una multa stradale o un’ammenda per reato, quella non si esdebita. Ma le cartelle per IVA, IRPEF, contributi sì, rientrano. Tuttavia, nota bene: durante il concordato preventivo, se vuoi farla franca su parte di IVA e contributi, devi rispettare le regole della transazione fiscale (offrire almeno il 30% e convincere il giudice che è il massimo possibile) . Quindi non è banale ottenere uno sconto sul Fisco in concordato, ma in fallimento a posteriori quel che non è stato pagato è perso per il Fisco come per gli altri. Anche nell’esdebitazione del sovraindebitato vale lo stesso: ad esempio, la legge 3/2012 già prevedeva che l’esdebitazione cancella anche il debito dell’IVA non versata (non considerandolo debito di danno erariale doloso, c’è giurisprudenza su questo). Quindi su questo il debitore può stare tranquillo: le procedure concorsuali chiudono i conti con tutti i creditori concorsuali in modo definitivo.
D: Conviene far fallire la società o aderire a un accordo per ristrutturare i debiti?
R: Dipende dalla prospettiva di salvataggio aziendale. Se c’è ancora un business sano dietro il peso dei debiti (cioè la copisteria ha clientela, genera ricavi, ma è stata affossata da eventi straordinari o errori gestionali correggibili), allora conviene tentare un accordo di ristrutturazione o concordato per conservare l’attività. Così i creditori prendono di più (da continuità) e tu mantieni il lavoro. Se invece il mercato è calato, i macchinari obsoleti, i debiti sono spropositati e l’imprenditore magari è stanco o prossimo alla pensione, forse è meglio accettare la fine: liquidare e voltare pagina, magari vendendo l’attività (se qualcuno la rileva) o chiudendo. Far “fallire” una società di capitali poi per il socio non è drammatico sul piano personale (come detto, i soci non pagano di tasca). Per un imprenditore individuale, farlo fallire comporta la vendita dei suoi beni, ma se tanto è inevitabile pagarli ai creditori, tanto vale. La scelta spesso è emotiva oltre che razionale. Un parametro chiave: se la somma dei debiti supera di molto il valore di ciò che possiedi e non hai utili futuri credibili per colmare il gap, la ristrutturazione potrebbe non riuscire (i creditori potrebbero non fidarsi di un piano troppo ottimistico). In tal caso, meglio l’ordinata liquidazione concorsuale, in cui quantomeno avrai la certezza dell’esdebitazione. Invece, se vedi che con un taglio del 30-40% dei debiti e un po’ di respiro la tua copisteria tornerebbe florida (es. hai tante commesse in arrivo, ma ti serve scontare i debiti pregressi), allora prova il concordato minore o accordo: ristrutturare conviene se c’è qualcosa da salvare. È un bilanciamento difficile e va valutato col commercialista e l’avvocato, magari elaborando un business plan realista. Tieni anche conto dei costi procedurali: un concordato comporta spese per attestatore, commissario, percentuale di attivo a creditori privilegiati… se l’azienda è molto piccola, paradossalmente il costo del concordato potrebbe mangiarsi risorse che in fallimento non avresti (es. il curatore viene pagato sui realizzi, non prima). Quindi, copisterie microscopiche raramente fanno concordati perché non c’è capacità di generare flussi per mantenere la procedura.
Conclusione: Navigare nella crisi debitoria di una copisteria richiede di conoscere bene le regole del gioco. Ogni scelta – pagare questo o quel creditore, avviare un piano o liquidare – ha conseguenze giuridiche precise. L’esperienza insegna che la tempestività è fondamentale: prima ci si attiva (verso i creditori o tramite le procedure), maggiori sono le chance di limitare i danni e magari salvare l’impresa. Abbiamo illustrato gli strumenti a disposizione del debitore italiano aggiornati al 2025, con un focus sul quadro normativo introdotto dal Codice della Crisi e le ultime novità giurisprudenziali. Si raccomanda, in situazioni concrete, di farsi assistere da professionisti specializzati in crisi d’impresa, perché la materia – come avete visto – è tecnica e in continua evoluzione. Ma con le informazioni giuste, un debitore può difendersi efficacemente: evitare gli errori comuni (come restare passivi o fare atti di disposizione incauti), utilizzare la legge a proprio vantaggio (dilazioni, concordati, esdebitazione) e così superare anche un momento difficile e ripartire. La “seconda chance” non è solo un concetto morale, è scritta nelle norme – saperla cogliere fa la differenza tra essere sopraffatti dai debiti o tornare padroni del proprio destino economico.
Gestisci una copisteria, centro stampa o tipografia digitale e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci una copisteria, centro stampa o tipografia digitale e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate?
Hai mutui, leasing per macchinari di stampa, cartelle esattoriali o rate arretrate e temi pignoramenti, blocchi bancari o la chiusura dell’attività?
👉 Non farti sopraffare: oggi esistono strumenti legali efficaci per bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti e salvare o chiudere in modo protetto la tua attività.
In questa guida scoprirai perché molte copisterie finiscono in difficoltà economica, quali soluzioni legali puoi adottare, e come difenderti per ripartire senza debiti.
🖨️ Perché molte copisterie accumulano debiti
Le copisterie e i centri stampa locali hanno subito, negli ultimi anni, una crisi profonda a causa di:
- crescente concorrenza dell’online e delle grandi catene;
- riduzione delle commesse da scuole, università e uffici;
- aumento dei costi di carta, toner e energia elettrica;
- leasing onerosi per macchine digitali e plotter;
- mancati pagamenti da parte di clienti pubblici o privati;
- ritardi fiscali o contributivi che hanno generato cartelle e accertamenti.
📌 Tutto ciò ha portato molti piccoli imprenditori del settore a non riuscire più a coprire costi e scadenze, finendo in una spirale di debiti fiscali, bancari e commerciali.
💰 Tipologie di debiti più frequenti per le copisterie
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IRPEF, IVA, INPS, INAIL, cartelle esattoriali, multe, TARI e sanzioni.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Leasing e mutui per stampanti, plotter, computer e arredi.
- Fidi bancari o prestiti aziendali.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori di carta, toner, inchiostri, software o assistenza tecnica.
✅ Debiti personali o familiari
- Carte di credito, prestiti privati o fideiussioni a garanzia dell’attività.
⚠️ Cosa rischia chi non agisce in tempo
Se la situazione non viene gestita subito, i creditori possono:
- pignorare conti correnti, incassi o macchinari;
- revocare fidi o leasing, bloccando l’attività;
- iscrivere ipoteche o bloccare la sede;
- avviare esecuzioni e vendite forzate;
- far chiudere il negozio per insolvenza.
👉 Tuttavia, oggi la legge ti permette di bloccare tutto e ripartire senza debiti, grazie agli strumenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
🧩 Le soluzioni legali per una copisteria con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Puoi ottenere, con l’assistenza di un avvocato, una riduzione o ristrutturazione delle somme dovute.
Tra le opzioni:
- saldo e stralcio (paghi meno per chiudere tutto);
- rateizzazione sostenibile in base ai ricavi effettivi;
- sospensione temporanea dei pagamenti.
👉 È la scelta giusta per chi vuole mantenere il negozio aperto e continuare a lavorare.
💠 2. Procedura di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012 e Codice della Crisi)
È la procedura legale pensata per ditte individuali e piccoli imprenditori che non riescono più a far fronte ai debiti.
Permette di:
- bloccare subito pignoramenti e cartelle esattoriali;
- proporre un piano di rientro sostenibile o un saldo parziale;
- ottenere, al termine, la cancellazione del debito residuo (esdebitazione).
📌 È accessibile anche se hai chiuso la partita IVA o l’attività.
💠 3. Concordato minore (per società o SRL)
Se la copisteria è una società, puoi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, approvato dal Tribunale.
Con questo strumento puoi:
- bloccare tutte le azioni esecutive;
- ridurre il debito complessivo;
- continuare a gestire l’attività con regolarità.
💠 4. Liquidazione controllata (ex fallimento personale)
Se la copisteria non è più sostenibile, puoi scegliere di liquidare i beni non essenziali e ottenere la cancellazione definitiva dei debiti residui.
👉 È una soluzione legale e protetta, che ti consente di ricominciare senza vincoli economici o rischi penali.
💠 5. Verifica delle cartelle e accertamenti fiscali
Molte cartelle contengono errori, duplicazioni o importi prescritti.
Un avvocato può:
- controllare la validità della notifica;
- eccepire la prescrizione (5 o 10 anni);
- chiedere l’annullamento o lo sgravio parziale o totale.
🧠 Cosa fare subito
✅ 1. Raccogli tutti i documenti relativi ai debiti
Prepara: cartelle, fatture, leasing, estratti conto, contratti di finanziamento e bollette.
✅ 2. Blocca i creditori con una procedura legale
Con il deposito di un ricorso per sovraindebitamento o concordato, tutti i creditori devono fermarsi per legge.
✅ 3. Evita accordi improvvisati o “non sostenibili”
Molti accordi privati peggiorano la situazione. Serve una strategia completa e approvata dal Tribunale, gestita da un avvocato esperto.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Visura camerale o chiusura della partita IVA.
- Dichiarazioni dei redditi e posizione INPS/INAIL.
- Estratti conto bancari e contratti di leasing o mutuo.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori e fatture pendenti.
- Bilanci o contabilità semplificata.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e valutazione legale: 1–3 settimane.
- Presentazione della procedura o piano: 1–2 mesi.
- Blocco immediato delle azioni esecutive: al deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Stop a pignoramenti, cartelle e ipoteche.
- Riduzione o cancellazione dei debiti residui.
- Tutela dei beni familiari e dell’attività.
- Ripartenza economica in modo legale e sereno.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni dei creditori.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Tutela delle attrezzature e dei beni necessari all’attività.
✅ Possibilità di mantenere aperta la copisteria o chiuderla in modo protetto.
✅ Ripartenza professionale pulita e senza pendenze fiscali.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare le notifiche o i solleciti dell’Agenzia delle Entrate.
- Accumulare nuovi debiti per pagare i vecchi.
- Firmare rateizzazioni non sostenibili.
- Affidarsi a intermediari o agenzie non autorizzate.
- Rimandare troppo: ogni giorno aumenta il rischio di azioni giudiziarie.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la situazione finanziaria e debitoria della tua copisteria.
📌 Ti guida nella scelta tra rinegoziazione, sovraindebitamento o concordato.
✍️ Predispone e deposita il piano in Tribunale per bloccare i creditori immediatamente.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche e fornitori.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione definitiva dei debiti e alla piena riabilitazione economica.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di piccoli imprenditori e artigiani del settore grafico e stampa.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere una copisteria con debiti non significa dover chiudere o fallire.
Con una difesa legale adeguata puoi bloccare le azioni dei creditori, ridurre i debiti fiscali e commerciali e continuare a lavorare in serenità, o chiudere l’attività in modo ordinato e protetto.
Il Codice della Crisi d’Impresa oggi tutela chi agisce con trasparenza e vuole davvero ricominciare.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova stampa di libertà dai debiti comincia oggi.