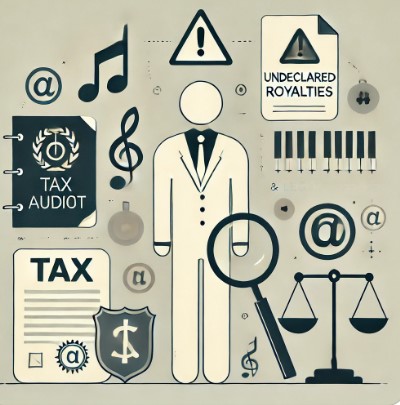Hai ricevuto un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate per redditi da royalties non dichiarati?
È una delle contestazioni fiscali più frequenti per professionisti, artisti, autori, inventori, startupper e titolari di brevetti o marchi che percepiscono compensi per lo sfruttamento delle proprie opere o proprietà intellettuali.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso i controlli automatici e le segnalazioni internazionali, può rilevare royalties non dichiarate e contestare l’omessa tassazione, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Tuttavia, non sempre la pretesa del Fisco è corretta: molte volte si tratta di redditi già tassati all’estero, di compensi imputati erroneamente o di interpretazioni non conformi alla normativa.
In questa guida vedremo cosa sono le royalties, quando devono essere dichiarate, perché scatta l’accertamento e come difendersi legalmente da una contestazione di questo tipo.
Cosa sono le royalties e quando sono tassabili
Le royalties sono i compensi percepiti per la concessione in uso di un diritto d’autore, un brevetto, un marchio, un know-how o un’altra forma di proprietà intellettuale.
In Italia, tali redditi sono considerati redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, a seconda della loro natura e della continuità con cui vengono percepiti.
Le royalties sono tassabili se:
- derivano dallo sfruttamento di opere dell’ingegno (libri, software, musica, opere artistiche);
- provengono da brevetti, marchi, licenze o modelli di utilità;
- rappresentano corrispettivi per la cessione o concessione di diritti d’uso su proprietà intellettuali;
- sono percepite da società, artisti o eredi dei titolari dei diritti.
Devono essere dichiarate nel modello Redditi PF o SC, a seconda del soggetto percettore, indicando gli importi lordi percepiti e le eventuali ritenute d’acconto già subite.
Perché l’Agenzia delle Entrate può contestare le royalties non dichiarate
L’Agenzia delle Entrate può accertare la mancata dichiarazione di royalties in diversi modi:
- tramite controlli incrociati sui dati comunicati da SIAE, società editoriali o case discografiche;
- attraverso la cooperazione internazionale e lo scambio automatico di informazioni (CRS, OCSE, FATCA);
- mediante segnalazioni bancarie relative a bonifici provenienti dall’estero;
- in seguito a ispezioni fiscali o verifiche su società che concedono licenze o marchi.
Se l’importo delle royalties non risulta dichiarato, l’Agenzia presume un reddito occulto e può emettere un avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, con sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta.
Quando le royalties non devono essere tassate in Italia
Le royalties possono non essere tassabili in Italia in alcune situazioni specifiche, soprattutto se percepite da soggetti residenti all’estero o se già tassate in base a una Convenzione contro la doppia imposizione.
In particolare, non sono imponibili in Italia se:
- il percettore è residente fiscale all’estero e le royalties provengono da uno Stato con cui l’Italia ha una Convenzione che attribuisce il diritto di tassazione solo al Paese di residenza;
- le somme sono state già tassate all’estero e spetta il credito d’imposta in Italia;
- la società o il soggetto che ha corrisposto le royalties ha già effettuato le ritenute alla fonte previste dalla legge.
In questi casi, la difesa si basa sulla documentazione che dimostra la residenza fiscale estera o la tassazione già avvenuta, così da evitare la doppia imposizione.
Cosa fare se ricevi un avviso di accertamento per mancata dichiarazione di royalties
Se ricevi un accertamento o una comunicazione di irregolarità, non ignorarla: il termine per opporsi è breve (60 giorni dalla notifica).
Ecco i passaggi da seguire per tutelarti:
- Analizza attentamente l’avviso.
Verifica a quali anni d’imposta si riferisce, quali importi vengono contestati e su quali basi documentali. - Recupera la documentazione.
Contratti di licenza o cessione dei diritti, fatture, bonifici, certificazioni di ritenuta e, se applicabile, le dichiarazioni fiscali estere o certificati di residenza. - Verifica l’origine delle royalties.
È importante capire se i compensi derivano da un rapporto professionale, da una cessione di diritti o da una successione ereditaria, perché cambia il regime fiscale applicabile. - Contatta un avvocato esperto in diritto tributario e internazionale.
Il professionista può valutare se l’accertamento è fondato, se vi sono errori formali o sostanziali e se è possibile impugnare l’atto o chiedere l’annullamento in autotutela.
Le principali strategie difensive
Le strategie di difesa dipendono dalla natura delle royalties e dal tipo di contestazione ricevuta. Le più comuni sono:
- dimostrare la tassazione già avvenuta all’estero, presentando le dichiarazioni e i versamenti effettuati nel Paese di origine;
- provare la correttezza della dichiarazione italiana, se le royalties sono state incluse ma l’Agenzia ha commesso errori di calcolo o di interpretazione;
- impugnare l’accertamento se mancano prove documentali concrete della percezione dei redditi;
- richiedere la definizione agevolata o la riduzione delle sanzioni in caso di irregolarità parziali;
- invocare la Convenzione internazionale applicabile per dimostrare che l’imposizione spetta solo allo Stato estero.
Con una difesa tempestiva e ben documentata è spesso possibile ridurre drasticamente o annullare del tutto le somme richieste.
Le sanzioni per omessa dichiarazione di royalties
Se l’accertamento viene confermato, il contribuente può essere sanzionato per:
- omessa dichiarazione dei redditi, con sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
- infedele dichiarazione, se le royalties sono state indicate solo in parte, con sanzione dal 90% al 180%;
- omesso versamento delle imposte e degli acconti IRPEF o IRES;
- mancata applicazione delle ritenute, se si tratta di società o intermediari che hanno corrisposto i compensi.
Tuttavia, la legge consente la riduzione delle sanzioni tramite il ravvedimento operoso o la definizione agevolata del contenzioso.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto un avviso di accertamento per royalties non dichiarate, se le somme provengono da società estere o se sospetti un errore nei conteggi dell’Agenzia.
Un avvocato esperto in diritto tributario e fiscale internazionale può:
- verificare la legittimità dell’accertamento;
- individuare la normativa o la Convenzione applicabile;
- presentare ricorso al giudice tributario o istanza di autotutela;
- assisterti nel dialogo con il Fisco e nella documentazione da produrre.
⚠️ Attenzione: ignorare l’accertamento significa accettarlo tacitamente. Dopo 60 giorni, l’atto diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo, con conseguenti azioni di riscossione e pignoramenti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e fiscalità internazionale – spiega cosa fare se ricevi un accertamento per mancata dichiarazione di royalties, come contestare la pretesa fiscale e come evitare la doppia imposizione.
👉 Hai ricevuto un accertamento per royalties non dichiarate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia legale personalizzata per difenderti dal Fisco, evitare sanzioni e tutelare i tuoi diritti in Italia e all’estero.
Introduzione
Hai ricevuto un accertamento fiscale relativo a royalties non dichiarate su marchi, brevetti, software, diritti d’autore o altri beni immateriali? L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestarti di aver omesso o dichiarato in modo infedele i redditi derivanti da tali royalties, con potenziali conseguenze gravi. In questa guida avanzata – aggiornata a settembre 2025 – esamineremo come difendersi efficacemente in caso di verifiche e accertamenti sulle royalties non dichiarate, sia per persone fisiche (autori, inventori, privati) sia per imprese. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro, con riferimenti alla normativa italiana vigente, prassi amministrative recenti (2024-2025) e gli orientamenti giurisprudenziali più aggiornati. Troverai inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti. L’ottica è quella del contribuente (debitore d’imposta) che deve tutelarsi durante un accertamento tributario e nell’eventuale contenzioso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) e alla Corte di Cassazione .
Nozione e categorie di royalties
In ambito giuridico-fiscale, per royalties si intendono generalmente i corrispettivi periodici pagati per l’utilizzo di un bene immateriale altrui, versati in base a un contratto di licenza. Tipicamente si tratta di opere dell’ingegno protette da diritto d’autore, brevetti industriali, marchi d’impresa, know-how tecnico-commerciale, diritti di sfruttamento artistico o commerciale, e simili . Il licenziatario (utilizzatore) paga un canone al titolare dei diritti (licenziante), spesso calcolato in proporzione allo sfruttamento (es. percentuale sul fatturato generato con l’opera concessa). Di seguito le principali categorie di royalties e il loro trattamento fiscale di base:
- Royalties da proprietà industriale – Canoni per l’uso di marchi, brevetti, disegni o modelli industriali, formule segrete e know-how. In ambito aziendale queste royalties intercorrono sia tra soggetti indipendenti sia in contesti infragruppo (es. società controllate che pagano royalty alla capogruppo titolare del marchio). Fiscalmente, per le imprese che pagano la royalty il costo è deducibile se inerente all’attività d’impresa e determinato a valore normale di mercato; per chi incassa, costituisce un ricavo tassabile (reddito d’impresa se il percettore è una società, oppure reddito di lavoro autonomo/intellettuale se il percettore è una persona fisica titolare del diritto) . Esempio: una società italiana concede in uso un proprio brevetto a un’altra azienda dietro pagamento di una royalty annua; la royalty incassata sarà tassata come ricavo d’impresa per la società concedente, mentre l’azienda pagante dedurrà il costo se effettivamente inerente alla sua produzione.
- Royalties da diritti d’autore – Canoni per l’utilizzo di opere letterarie, artistiche, musicali o software protetto da copyright. Se percepite da persone fisiche residenti fuori dall’esercizio di impresa o professione abituale, tali royalties godono di un trattamento fiscale agevolato: una quota forfettaria dei compensi è esclusa da imposizione a titolo di spese (in base all’art. 54, comma 8 del TUIR). In pratica solo una parte del reddito è tassata (tipicamente il 60-75%, con esclusione del 25-40% a seconda dei casi) . Ad esempio, un autore italiano over 35 anni tassera solo il 75% delle royalty derivanti dai suoi libri, usufruendo di un’esenzione forfettaria del 25% come costo . Se invece le royalties da diritto d’autore sono percepite nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa (o da soggetti diversi dall’autore originario, come gli aventi causa), esse saranno tassate integralmente come reddito di lavoro autonomo o d’impresa (salvo eventuali altre agevolazioni specifiche). Esempio: uno scrittore trentenne residente in Italia che percepisce €10.000 di royalties per un e-book avrà diritto all’abbattimento del 40% (under 35), dichiarando così €6.000 come reddito imponibile, su cui l’editore avrà operato una ritenuta d’acconto del 20% .
- Royalties su risorse naturali o concessioni pubbliche – In alcuni settori (minerario, estrattivo, concessioni demaniali) il termine “royalty” indica i canoni dovuti per lo sfruttamento di risorse naturali o concessioni pubbliche. Nel diritto italiano questi importi hanno una disciplina specifica: spesso sono determinati per legge o convenzione e corrisposti a enti pubblici concedenti. Fiscalmente, le royalties pagate dall’impresa concessionaria sono deducibili come costi di esercizio, mentre per chi le percepisce (es. lo Stato o un ente pubblico concessionario, oppure un privato titolare di concessione) costituiscono un reddito tassabile di natura d’impresa (talora con trattamento particolare). In genere tali canoni sono esenti IVA e difficilmente contestati dal Fisco, trattandosi di obblighi legali predeterminati; le eventuali dispute riguardano il corretto calcolo della base (es. se l’impresa ha sottostimato la quantità estratta per ridurre la royalty dovuta) .
- Royalties infragruppo e operazioni internazionali – Quando le royalties intercorrono tra soggetti collegati (es. società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale, o tra un imprenditore individuale e la sua società), assumono rilievo i profili di transfer pricing e inerenza. Il principio di libera concorrenza impone che le royalties infragruppo siano determinate al valore normale di mercato (arm’s length price) che sarebbe praticato tra parti indipendenti, come stabilito dall’art. 110 comma 7 del TUIR . Se un’impresa italiana controllata paga un canone eccessivamente alto a una consociata estera per l’uso di un marchio o brevetto, l’Amministrazione finanziaria può rettificare il reddito imponibile italiano riducendo il costo deducibile alla misura “normale” (contestando l’eccedenza come extra-profitto trasferito all’estero) . Allo stesso modo, sul piano internazionale, l’art. 12 dei trattati contro le doppie imposizioni definisce le royalties e ne disciplina la tassazione: in assenza di disposizioni diverse, le royalties pagate da un soggetto di uno Stato a un residente dell’altro Stato contraente possono essere tassate in entrambi i Paesi (con ritenuta alla fonte limitata nel Paese di origine, di solito 5-10%, e tassazione ordinaria nel Paese di residenza con credito d’imposta) . Le direttive UE – in particolare la Direttiva Interessi e Canoni 2003/49/CE – prevedono poi l’esenzione completa da ritenute per le royalties pagate intragruppo tra società consociate di Stati membri (partecipazione ≥25% e status di beneficiario effettivo) . Dunque, ad esempio, una società italiana che paga royalties annuali a una controllata francese applicherà la ritenuta ridotta del 5% prevista dalla Convenzione Italia–Francia (in luogo del 30% domestico), mentre se paga a una consociata UE con requisiti della direttiva, può non applicare alcuna ritenuta . Esempio pratico: una società italiana versa €100.000 annui a una società consociata estera per l’uso di un marchio: se la consociata è in UE e soddisfa i requisiti della direttiva, la royalty esce senza ritenuta; se invece la consociata è in un Paese senza trattato, l’Italia applicherà la ritenuta interna del 30%, salvo poi il percettore chieda credito d’imposta nel suo Stato .
- Royalties su software e contratti misti – I compensi per l’uso di software possono rientrare o meno tra le royalties secondo i casi. La normativa italiana assimila ai diritti d’autore i compensi per programmi per computer, ma con importanti distinzioni operative e convenzionali. Ad esempio, se un contratto di “licenza software” concede all’utente diritti sostanzialmente equivalenti a quelli di un acquirente di una copia (uso personale del software standard), allora il pagamento non è qualificabile come royalty in senso fiscale internazionale, bensì come corrispettivo commerciale (reddito d’impresa) . L’Agenzia delle Entrate ha confermato nel 2023 che in tali casi (software standard ceduto per uso personale) il compenso non costituisce royalty ai fini convenzionali, ma servizio digitale o cessione di bene, non soggetto a ritenuta estera e tassabile come business profit . Viceversa, se il contratto prevede la concessione di diritti di utilizzo economico del software (es. diritto di riprodurre, modificare o distribuire il codice), i canoni pagati assumono natura di royalty. Esempio: l’interpello Agenzia Entrate n. 116/2023 ha affrontato un caso di contratto misto per servizi videogame e licenze software, distinguendo la parte di corrispettivo qualificabile come royalty (con applicazione del trattato sul beneficiario effettivo) da quella qualificabile come servizio puro (profitto d’impresa) . In sintesi, è fondamentale analizzare il contratto: un pagamento per fornitura di software “pacchettizzato” o per servizi di accesso a piattaforme digitali potrebbe non essere considerato una royalty in senso fiscale, con importanti differenze in termini di ritenute e tassazione estera.
Tabella 1 – Principali tipologie di royalties e trattamento fiscale (schema)
| Tipo di royalty | Esempio pratico | Trattamento fiscale (Italia) | Possibili contestazioni del Fisco |
|---|---|---|---|
| Royalties industriali infragruppo | Canone 3% sul fatturato pagato da società italiana a casa madre estera per uso del marchio di gruppo. | Deducibile per la società italiana se inerente; ritenuta 30% all’estero (o aliquota ridotta se trattato/direttiva UE). Percettore estero tassato nel proprio Paese (trattato evita doppia imposizione). | Transfer pricing (canone troppo alto rispetto al valore di mercato); verifica del beneficiario effettivo (se la società estera è solo schermo); mancanza di inerenza (se il marchio non apporta reale beneficio all’azienda italiana). |
| Royalties da diritto d’autore (persona fisica) | Compensi pagati da un editore italiano a uno scrittore per vendite di un libro. | Percepiti dall’autore come reddito di lavoro autonomo – tassati parzialmente: esenzione forfettaria 25% (o 40% se under 35) a titolo di spese . L’editore italiano opera una ritenuta d’acconto 20% sui compensi . Il costo è integralmente deducibile per l’editore come spesa di esercizio. | Qualificazione del reddito: il Fisco verifica che sia effettivamente diritto d’autore e non, ad esempio, reddito di lavoro dipendente mascherato o altro. Controllo della documentazione (contratto di edizione, attestazione della paternità dell’opera). |
| Royalties a soggetto in Paese “black list” | Pagamento di royalty da società italiana a società localizzata in un paradiso fiscale (es. holding alle Cayman). | Fino al 2015 vigeva l’art. 110 co.10 TUIR che rendeva il costo indeducibile salvo prova dell’attività economica effettiva e del beneficio economico. Dal 2016 tale norma è abrogata, ma resta l’onere generale di provare l’inerenza e congruità del costo verso paradisi fiscali . La ritenuta alla fonte del 30% va comunque applicata in assenza di trattato. | Evasione/elusione internazionale: il Fisco può sospettare che la royalty sia usata per spostare utili verso un paradiso fiscale (transfer pricing o interposizione fittizia). Possibili contestazioni sull’indeducibilità del costo se mancano prove solide dell’effettivo servizio reso dalla società estera (sostanza economica) e del valore normale del canone. |
| Royalties interne tra parti indipendenti | PMI italiana paga royalty del 5% a un inventore persona fisica per l’utilizzo di un brevetto. | Il canone è deducibile per la PMI se correlato all’attività (inerenza). La società paga una ritenuta d’acconto del 20% se il percettore è persona fisica residente. Il percettore dichiara il reddito come lavoro autonomo (con eventuale abbattimento se è reddito da diritto d’autore originale). | Verifica di inerenza: il Fisco controlla che il brevetto sia effettivamente utilizzato nell’impresa e dia un’utilità economicamente apprezzabile. Contestazioni di antieconomicità: se il costo appare eccessivo rispetto ai benefici o al fatturato dell’azienda (es. royalty = 50% dei ricavi), può essere indizio di spesa non inerente o di distribuzione utili dissimulata . |
| Royalties da concessioni pubbliche | Azienda estrae gas naturale e paga royalties allo Stato italiano titolare della concessione. | Canoni dovuti ex lege al concedente pubblico; costo deducibile per l’azienda estrattrice; per l’ente pubblico percettore costituiscono entrate patrimoniali (talora esenti da IVA). | Contestazioni rare (trattandosi di importi fissati per legge o convenzione). Possibili controversie sul calcolo della royalty se l’impresa ha dichiarato meno produzione per ridurre il canone dovuto (in tal caso il Fisco può contestare il volume estratto dichiarato). |
(N.B.: La tabella sopra offre uno schema semplificato; il trattamento effettivo può variare in base alle condizioni contrattuali, alla qualifica del percettore – es. autore originario vs. cessionario – e ad eventuali normative speciali in vigore.)
Regime fiscale delle royalties in Italia: normativa di riferimento
Per affrontare al meglio un accertamento su royalties, occorre conoscere i riferimenti normativi chiave del sistema tributario italiano in materia. Di seguito elenchiamo le principali fonti normative e il loro contenuto rilevante:
- TUIR (DPR 917/1986) – Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi contiene le definizioni di reddito e le regole di tassazione per persone fisiche e società. In particolare:
- Art. 53 e 54 TUIR: disciplinano il reddito di lavoro autonomo e redditi assimilati. Comprendono, al comma 2 lett. b) dell’art. 53, i proventi derivanti dalla concessione in uso di opere dell’ingegno, brevetti industriali e conoscenze tecnico-scientifiche. L’art. 54, comma 8 (come riformato dal 2023-2024, v. infra) stabilisce la deduzione forfettaria dei compensi da diritto d’autore per gli autori: attualmente il 25% (o 40% se under 35) dei proventi è escluso da tassazione come spesa forfettaria . Fino al 2023, la deduzione forfettaria del 25% si applicava in maniera generalizzata a tutti i redditi da concessione di beni immateriali (marchi, brevetti, know-how); dal 2024 la normativa è cambiata, rendendo tale agevolazione non automatica ma subordinata a specifici requisiti (vedi oltre le Novità 2024) .
- Art. 9 TUIR: definisce il concetto di valore normale dei beni e servizi, riferimento essenziale per valutare la congruità di royalties infragruppo. Il comma 3 recita: “per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per beni e servizi similari in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e luogo in cui sono stati acquisiti, o in mancanza, in tempi e luoghi prossimi” . Questo concetto è la base del principio di libera concorrenza in ambito transfer pricing.
- Art. 110, comma 7 TUIR: è la norma sul transfer pricing internazionale. Stabilisce che i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti, legate da rapporti di controllo, “sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti […] se ne deriva aumento di reddito”. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può rettificare in aumento il reddito imponibile italiano se transazioni infragruppo con l’estero avvengono a prezzi non di mercato (non è però consentito rettificare in diminuzione nel solo interesse del contribuente) . La Cassazione ha chiarito che questa norma non è un’aggressione anti-evasione che richiede prova di intento elusivo, ma una disposizione di rettifica automatica dei prezzi fuori mercato . Quanto all’onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che spetta al Fisco provare l’esistenza di transazioni infragruppo a valori anomali, e al contribuente dimostrare che i prezzi contestati erano invece allineati al mercato (art. 2697 c.c.) .
- (Ex) Art. 110, commi 10-12 TUIR: fino al 2015 questi commi disciplinavano i costi verso fornitori situati in Stati a fiscalità privilegiata (“black list”), prevedendo condizioni stringenti per la deducibilità. Tali norme (note come “prova della business purpose” per costi black list) sono state abrogate dal 2016, allineando il trattamento a quello ordinario. Ciò è storicamente rilevante perché molte contestazioni su royalties prima del 2016 riguardavano pagamenti verso paradisi fiscali, che venivano disconosciuti se il contribuente non forniva prova convincente dell’operatività reale del percettore estero e dell’effettività della prestazione ricevuta .
- DPR 600/1973 (Accertamento e Riscossione) – Rilevano:
- Art. 23 e 25 DPR 600/73: disciplinano le ritenute alla fonte sui redditi. In particolare l’art. 25, comma 4, prevede che i compensi corrisposti a soggetti non residenti per l’uso di opere dell’ingegno, brevetti, marchi e know-how siano soggetti a una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sulla parte imponibile del loro ammontare (salvo diversa aliquota convenzionale) . Per le royalties corrisposte a imprese estere, normalmente l’intero importo è imponibile e quindi si applica il 30%; per taluni diritti d’autore percepiti da persone fisiche non residenti può applicarsi la ritenuta sul 75% del compenso (rispecchiando l’abbattimento previsto internamente) . Le convenzioni internazionali prevalgono sulla norma interna (art. 75 DPR 600/73), sicché in presenza di un trattato contro le doppie imposizioni il sostituto d’imposta italiano deve applicare l’aliquota ridotta prevista (o l’esenzione) a condizione che il percettore estero dimostri la residenza convenzionale e lo status di beneficiario effettivo . Ad esempio, con Convenzione Italia-USA la ritenuta sulle royalties pagate a un residente USA è 5% per diritti d’autore, 8% per brevetti, 10% per know-how . Con Convenzione Italia-Germania, le royalties per diritti d’autore sono esenti da ritenuta .
- Art. 37-bis DPR 600/73: (abrogato e confluito nell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente, v. oltre) – Era la clausola anti-elusiva generale, applicabile anche a schemi con royalties volti a ottenere vantaggi indebiti (es. interporre una società estera a bassa tassazione per incassare le royalties). Oggi l’abuso del diritto è regolato dall’art. 10-bis L. 212/2000, che richiede all’Ufficio di provare il disegno abusivo e l’indebito vantaggio fiscale ottenuto con operazioni prive di sostanza economica.
- Provvedimenti sul transfer pricing: il Provvedimento Agenzia Entrate 30.05.2018 (aggiornato nel 2020) ha definito i contenuti della documentazione idonea di transfer pricing (Masterfile e Local File, in attuazione dell’art. 31-quater DPR 600/73). L’impresa che predispone tale documentazione e ne dà comunicazione in dichiarazione beneficia del regime di “penalty protection”: in caso di rettifica di transfer pricing, non si applicano le sanzioni per dichiarazione infedele relative alla parte di reddito rettificato . Dal 2016, questa protezione si estende anche alle sanzioni per eventuali ritenute non operate conseguenti alla rettifica: in altre parole, se un’azienda ha applicato una ritenuta convenzionale (es. 5%) su royalties infragruppo e il Fisco ridetermina ex post che la royalty doveva essere inferiore, non verrà sanzionata per non aver trattenuto il 30% sull’eccedenza disconosciuta, purché avesse la documentazione TP conforme . Tuttavia, attenzione: alcuni Uffici tendono ancora a irrogare la sanzione del 20% per omessa ritenuta (art. 14 D.Lgs. 471/97) sulla parte eccedente, ritenendo la penalty protection limitata alla sanzione per infedele dichiarazione del sostituto . Una lettura sistematica suggerisce che la protezione debba coprire l’intero spettro sanzionatorio, evitando disparità di trattamento , ma su questo punto la prassi non è uniforme.
- Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – È la legge che enuncia principi e diritti fondamentali del contribuente. Nell’ambito di accertamenti sulle royalties, rilevano in particolare:
- Art. 6, c. 4 e 5: diritto del contribuente ad un contraddittorio endoprocedimentale (quando previsto), ossia la possibilità di essere ascoltato e fornire spiegazioni prima che l’avviso di accertamento sia emanato. In materia di tributi non armonizzati (come imposte dirette), l’obbligo generalizzato di contraddittorio non è riconosciuto dalla giurisprudenza, salvo nei casi previsti da norme specifiche o se dall’assenza di confronto derivi concreto pregiudizio al diritto di difesa (la Corte di Giustizia UE ha imposto il contraddittorio anticipato in alcuni casi di utilizzo di informazioni da altri Stati).
- Art. 7: obbligo di motivazione chiara degli atti tributari, con indicazione dei presupposti di fatto e delle norme di diritto. Un avviso di accertamento su royalties deve dunque spiegare la ricostruzione effettuata (es. come sono state quantificate le royalties non dichiarate, quali fonti o presunzioni sono state usate) e le basi giuridiche delle riprese, pena l’annullabilità per motivazione carente o apodittica.
- Art. 10-bis: disciplina l’abuso del diritto fiscale. Il Fisco non può più sanzionare operazioni abusive come violazioni tributarie (sono atti leciti ma elusivi), ma può disconoscerne gli effetti fiscali. Nel farlo, deve seguire una specifica procedura di contraddittorio e provare la mancanza di sostanza economica delle operazioni e l’indebito vantaggio ottenuto. Nel contesto royalties, questa norma potrebbe applicarsi se, ad esempio, viene interposta una società puramente passiva in un paese terzo per usufruire di aliquote di ritenuta inferiori (treaty shopping): l’Ufficio potrebbe invocare l’abuso e ignorare la società interposta, tassando il pagamento come se fatto al reale beneficiario. È importante notare che dal 2015 la legge processuale (art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/92) impone all’Amministrazione la prova delle condotte abusive in giudizio, invertendo precedenti orientamenti che gravavano il contribuente .
- D.Lgs. 471/1997 (Sanzioni amministrative tributarie) – Questo decreto, modificato dal D.Lgs. 158/2015 e di recente dal D.Lgs. 87/2023, prevede le sanzioni pecuniarie per le violazioni relative a dichiarazioni e versamenti. In particolare:
- Art. 1, c.2 D.Lgs. 471/97 – Dichiarazione infedele: se il contribuente dichiara un reddito inferiore a quello effettivo (o indebite detrazioni/deduzioni) si applica una sanzione proporzionale. Per violazioni fino al 31/8/2024, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta evasa (con un minimo di €250) . Dal 1° settembre 2024, in base alle modifiche attuate dalla legge delega di riforma fiscale, la sanzione è fissata al 70% dell’imposta non versata, con minimo €150 (salvo riduzione al 50% se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa spontanea prima di controlli) . Ad esempio, se vengono accertati €10.000 di IRPEF evasa su royalties non dichiarate, la sanzione base attualmente sarebbe €7.000 (70%) per violazioni post-riforma, rispetto ad un range €9.000-18.000 in passato. Occorre tuttavia considerare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti: la sanzione è aumentabile di 1/3 se la violazione riguarda redditi esteri non dichiarati (non soggetti a ritenuta a titolo d’imposta in Italia) , e può essere ridotta di 1/3 se ci si avvale di conciliazione o accertamento con adesione (vedi oltre). Nota: la soglia di punibilità penale è distinta e non incide sul calcolo della sanzione amministrativa.
- Art. 1, c.1 D.Lgs. 471/97 – Omessa dichiarazione: se il contribuente non presenta affatto la dichiarazione dei redditi (quando dovuta), la sanzione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con minimo €250. Se non c’era imposta dovuta (dichiarazione a zero), si applica la sanzione fissa da €250 a €1.000. L’omessa dichiarazione di un singolo reddito all’estero non configura omessa dichiarazione complessiva se il resto era dichiarato (è un caso di infedele); la sanzione “omessa” si applica quando completamente non viene presentata la dichiarazione annuale.
- Art. 14 D.Lgs. 471/97 – Omesso versamento di ritenute: sanzione del 20% delle ritenute non operate o non versate, a carico del sostituto d’imposta. Questa può rilevare nel caso in cui una società italiana doveva applicare la ritenuta su una royalty pagata all’estero e non l’abbia fatto. Come detto, la penalty protection può offrire scudo se la mancata ritenuta deriva da un transfer pricing adjustment, ma in assenza di documentazione idonea, se l’Ufficio contesta che una royalty versata avrebbe dovuto subire ritenuta (es. perché nega i requisiti di esenzione UE o convenzionale), la società italiana rischia la sanzione del 20% sull’importo non trattenuto , oltre all’obbligo di versare la ritenuta arretrata.
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari) – Prevede le fattispecie penali per le dichiarazioni fraudolente, omesse e infedeli, con soglie di punibilità:
- Omessa dichiarazione (art. 5): scatta se il contribuente omette di presentare la dichiarazione annuale avendo imposte evase > €50.000. È punita con reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso di royalties, potrebbe configurarsi se un soggetto non ha proprio presentato il Modello Redditi pur avendo incassato royalties rilevanti.
- Dichiarazione infedele (art. 4): scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e, contemporaneamente, gli elementi attivi sottratti a tassazione superano il 10% del totale degli elementi attivi dichiarati (oppure €2 milioni) . Ad esempio, se un imprenditore dichiara €1.000.000 di ricavi ma ne ha occultati €300.000 di royalties (30%, sopra soglia 10%) e l’evasione d’imposta correlata è €120.000, allora oltre alle sanzioni amministrative vi sarà rilevanza penale. La pena va da 2 anni a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Va sottolineato che ai fini penali occorre l’elemento soggettivo del dolo di evasione fiscale (consapevolezza dell’alterazione dichiarativa). In ambito penale, come in quello amministrativo, è escluso il ne bis in idem costituzionale, quindi il contribuente può subire sia la sanzione tributaria sia il processo penale per lo stesso fatto. Tuttavia, il pagamento integrale del debito tributario prima del giudizio penale può attenuare la pena e in alcuni casi evitare misure cautelari; inoltre, rientrando la dichiarazione infedele tra i reati “tributari”, sono possibili cause di non punibilità se l’omessa dichiarazione dei redditi esteri deriva da cause di forza maggiore o altre particolari circostanze (rare).
- Giurisprudenza recente – La materia delle royalties ha prodotto numerose sentenze di merito e di legittimità. I principi principali affermati di recente (Cassazione Sez. Trib.) includono:
- Inerenza qualitativa dei costi: l’inerenza va valutata in termini di compatibilità e coerenza del costo con l’attività d’impresa, non in base a una correlazione diretta con specifici ricavi. La congruità quantitativa del costo non è di per sé criterio di inerenza, ma se un costo appare macroscopicamente antieconomico può costituire indizio che l’operazione esula dall’attività d’impresa e persegue altre finalità . In altre parole, non tutto ciò che è antieconomico è automaticamente indeducibile, ma una sproporzione evidente mette sull’avviso il giudice che può richiedere al contribuente maggiori prove di utilità economica. La Cassazione n. 972/2023 ha ribadito che spetta al contribuente provare l’inerenza in senso qualitativo, e che l’antieconomicità manifesta può indicare estraneità all’attività (costi estranei) .
- Prezzi di trasferimento e circolare 32/1980: la Cassazione n. 9615/2019 ha confermato la legittimità di un accertamento che aveva ridotto una royalty infragruppo dal 3,5% al 2% del fatturato, prendendo a riferimento i criteri indicativi della Circolare Ministeriale 32/9/2267 del 22.09.1980. In quella circolare, storicamente, il Ministero delle Finanze suggeriva che nelle operazioni infragruppo un tasso di royalty fino al 2% del fatturato fosse “non sospetto”, tra 2% e 5% richiedesse valutazione, oltre il 5% potesse considerarsi anomalo salvo giustificazioni . La Suprema Corte ha ritenuto che tali soglie costituiscano una “seria presunzione” di anomalia che sposta l’onere della prova sul contribuente . In Cass. 9615/2019 la società contribuente non aveva provato la congruità del tasso superiore al 5%, e la Corte ha rigettato il suo ricorso . Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha precisato che quei parametri di prassi non rappresentano limiti assoluti: la Cass. 12846/2022 (ord.) ha affermato che le royalties possono essere deducibili anche oltre le soglie del 5% se supportate da valide ragioni economiche, e che l’Amministrazione non può sindacare la convenienza economica delle scelte imprenditoriali del contribuente . In particolare, la Cassazione ha escluso che pagare royalty al titolare stesso del marchio (scenario peculiare di cessione di prodotti a chi è proprietario del brand) faccia venir meno l’inerenza: non compete al Fisco stabilire se sia “conveniente” per un’azienda pagare il marchio al suo proprietario, ciò rientra nelle scelte imprenditoriali insindacabili . Inoltre ha sottolineato che la deducibilità delle royalties non è limitata da soglie predefinite di prassi, dovendosi valutare il caso concreto nel rispetto del riparto dell’onere probatorio . Nella fattispecie, in Cass. 12846/2022 la società italiana è riuscita a giustificare un tasso di royalty superiore al 5% presentando elementi quali: il diritto di esclusiva territoriale ottenuto, l’elevato valore del marchio, uno studio di transfer pricing a supporto e il fatto che la parte estera aveva dichiarato la royalty al fisco francese (quindi senza intento evasivo) . La Corte ha quindi riconosciuto la piena deducibilità del canone pattuito, ammonendo che l’Amministrazione non può applicare meccanicamente i “numeretti standard” senza considerare le specificità .
- Beneficiario effettivo e look-through: nei pagamenti transfrontalieri, un tema caldo è l’applicazione delle aliquote di trattato solo se il percettore estero è il beneficiario effettivo della royalty. La giurisprudenza italiana recente ha seguito la scia delle sentenze “Danish Cases” della Corte di Giustizia UE (2019) adottando un approccio look-through: in presenza di una conduit company intermedia, occorre guardare al beneficiario sostanziale finale. La Cassazione n. 24288/2019 (in materia di dividendi esteri) ha affermato che se il beneficiario effettivo è un soggetto di un terzo Stato, va applicata la convenzione con tale terzo Stato, disconoscendo i vantaggi del trattato intermedio . Nelle controversie su royalties, la Commissione Tributaria Regionale (Corte Giustizia Trib.) Emilia-Romagna n. 929/2023 ha fatto applicazione innovativa di tali principi: ha stabilito che, quando il Fisco contesta l’aliquota di trattato sostenendo che il percettore estero non è il beneficiario effettivo, deve essere l’Ufficio a provarlo, in virtù dell’art. 7, c.5-bis D.Lgs. 546/92 . Nel caso concreto (royalties pagate da società italiana a consociata svizzera con controllante USA), il giudice ha ritenuto che la società svizzera avesse sostanza economica (nessuna retrocessione integrale dei fondi alla controllante) e dunque le ha riconosciuto il trattamento convenzionale del 5%. Ha aggiunto che, anche se il beneficiario effettivo fosse stato la controllante USA, comunque si sarebbe applicata l’aliquota 8% Italia-USA su quella parte (principio di look-through) . Questo orientamento è molto favorevole al contribuente, poiché sposta sul Fisco l’onere di dimostrare l’abuso (holding fittizia), in linea col principio generale sull’abuso del diritto. Da notare che su tale tema esistevano pronunce di Cassazione precedenti contrastanti, alcune delle quali attribuivano l’onere al contribuente; il panorama però sta mutando a vantaggio del contribuente grazie alla norma del 2015 sul processo tributario .
- Documentazione vs presunzioni: un filo comune nelle sentenze è l’importanza della documentazione contrattuale e di supporto. La Cassazione ha più volte evidenziato che il contribuente può vincere le presunzioni del Fisco se esibisce documenti chiari: ad esempio, un contratto di licenza ben congegnato, documentazione di transfer pricing, evidenze dell’effettivo utilizzo del bene immateriale, ecc. (si veda la sezione Strategie difensive). In mancanza di prove concrete, invece, le presunzioni semplici del Fisco (purché gravi, precise e concordanti) possono essere sufficienti per legittimare l’accertamento . Ad esempio, il riferimento ai criteri della circolare 32/1980 è stato considerato una “seria presunzione” che sposta l’onere della prova a carico del contribuente, come detto sopra . Tuttavia, va ricordato che se l’accertamento si fonda esclusivamente su presunzioni non qualificate (es. movimenti bancari non giustificati), il contribuente può contestare l’assenza di prova diretta ed esigere che l’Ufficio fornisca elementi concreti.
Tabella 2 – Giurisprudenza rilevante in materia di royalties (Massime principali)
| Pronuncia | Oggetto / Scenario | Principio chiave espresso |
|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. V, n. 9615/2019 (sentenza) | Royalties infragruppo – valore normale (circolare 32/1980) | Legittimo l’accertamento che riduce la royalty eccedente il valore normale ex art. 110(7) TUIR. L’adozione dei criteri della Circ. 32/1980 costituisce “seria presunzione” che sposta sul contribuente l’onere di provare la normalità di un valore superiore al 2%. Nel caso di specie, ricorso della società rigettato per mancata prova di congruità del maggior valore . |
| Cass. civ. Sez. V, n. 12846/2022 (ord.) | Inerenza e congruità – royalty pagata al titolare del marchio (infragruppo UE) | Riconosce la piena deducibilità di royalties anche oltre i limiti di prassi, se supportate da valide ragioni economiche. Stabilisce che l’Agenzia non può sindacare la convenienza economica delle scelte imprenditoriali (pagare royalties al proprietario del marchio non esclude l’inerenza). Inoltre chiarisce che le soglie di prassi non sono vincoli assoluti: la deducibilità non è limitata a misure predeterminate, va considerato il caso concreto rispettando il riparto dell’onere della prova . |
| Cass. civ. Sez. V, n. 23587/2023 (ord.) | Transfer pricing – onere della prova ed elusività | Ribadisce che l’art. 110(7) TUIR reprime lo spostamento di imponibile nei gruppi senza necessità di provare una finalità elusiva specifica; basta dimostrare operazioni infragruppo a prezzo diverso dal normale. Conferma che l’onere di provare la conformità al mercato spetta al contribuente ex art. 9 TUIR. (Nel caso concreto, confermata la ripresa su royalty ridotta dal 3,5% al 2% del fatturato, non avendo la società giustificato l’extra) . |
| Cass. civ. Sez. V, n. 972/2023 (ord.) | Inerenza costi infragruppo | Richiama orientamenti consolidati: l’inerenza si misura in termini qualitativi di coerenza con l’attività (non di correlazione ai ricavi specifici); tuttavia un’antieconomicità evidente può costituire indizio di non inerenza (costo estraneo all’attività). Conferma il disconoscimento di costi infragruppo non inerenti in caso di sproporzione non giustificata . |
| Cass. civ. Sez. V, n. 24288/2019 (ord.) | Beneficiario effettivo in ambito dividendi (applicabile analogicamente alle royalties) | Nei pagamenti transfrontalieri, afferma il principio del “look through”: se il beneficiario effettivo del flusso è un soggetto residente in un terzo Stato, si applica la convenzione con tale Stato (in linea con CGUE casi danesi 2019). Questo principio, sebbene espresso per dividendi, viene richiamato nelle controversie su royalties (es. CTR Emilia 929/2023) a favore del contribuente. |
| CTR Emilia-Romagna (C.G.T. II grado) n. 929/2023 (sentenza) | Royalties a consociata estera – Beneficial owner e onere della prova | Pronuncia di merito innovativa: stabilisce che quando il Fisco nega l’aliquota di trattato per asserita mancanza del beneficiario effettivo, deve provarlo l’Ufficio (art. 7 c.5-bis D.Lgs. 546/92). Nel caso concreto, considerata operativa la società percettrice svizzera (nessuna retrocessione integrale a controllante USA) e dunque legittima l’aliquota 5% del trattato Italia-Svizzera. Aggiunge che, anche ipotizzando come beneficial owner la società USA controllante, si sarebbe comunque applicata l’aliquota 8% Italia-USA (applicazione del look-through convenzionale). Decisione favorevole al contribuente, in linea con i principi antiabuso più recenti . |
| C.T. Prov. Milano n. 2887/2019 (sentenza di I grado, esemplificativa) | Royalties a società black-list – inerenza e sostanza | (Caso non massimato, ma utile): ha annullato un accertamento su royalties pagate a una società di Hong Kong ritenuta fittizia, poiché il contribuente ha documentato l’effettiva attività svolta dal licenziante estero e il concreto beneficio ottenuto (accesso a mercati asiatici). Ha valorizzato la prova contraria del contribuente e ridotto la sanzione al minimo, giudicando sproporzionata l’irrogazione massima. Nota: Pur essendo decisione di merito isolata, illustra l’approccio che premia la sostanza economica rispetto a mere presunzioni di evasione. |
Come si evince dalle pronunce sopra, l’esito dei contenziosi su royalties dipende molto dalla solidità delle prove presentate dal contribuente e dalla capacità di spiegare le proprie scelte economiche. In generale, gli orientamenti più recenti sono in parte più garantisti per il contribuente rispetto al passato: ad esempio, è stato riconosciuto che un’operazione antieconomica non è automaticamente abusiva, che l’Ufficio ha oneri probatori più stringenti in caso di contestazione di abuso del diritto, e che le soglie di comodo (2%-5%) non sono plafond rigidi . Tutto ciò offre margini di difesa più ampi a chi abbia agito con buona fede sostanziale. Nei prossimi paragrafi vedremo come concretamente difendersi durante un accertamento su royalties, prima e dopo la notifica dell’atto.
Accertamenti fiscali sulle royalties: cause frequenti e iter del controllo
Quando scattano le contestazioni fiscali sulle royalties? In pratica, i controlli dell’Amministrazione finanziaria su compensi da royalties si attivano in alcune situazioni tipiche :
- Omissione di redditi da royalty in dichiarazione: è il caso più diretto. Se un contribuente (persona fisica o società) ha percepito royalties e non le ha indicate nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate – grazie alle informazioni incrociate – può rilevare l’anomalia e avviare un accertamento. Ciò è diventato più frequente soprattutto per royalties provenienti dall’estero, perché i canali di monitoraggio internazionale si sono potenziati: lo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS) e accordi come FATCA con gli USA fanno affluire dati sui pagamenti transfrontalieri e sui conti esteri dei residenti italiani . Ad esempio, se un autore italiano riceve periodicamente bonifici da un editore estero, tali flussi potrebbero emergere dalle segnalazioni bancarie internazionali. Anche i registri di proprietà intellettuale (es. brevetti e marchi registrati) possono essere incrociati con le dichiarazioni per vedere se chi possiede un bene immateriale stia dichiarando proventi dalla sua eventuale concessione in uso. Caso pratico: la società Alpha non ha dichiarato nel 2021 royalties per 100.000€ ricevute da una consociata estera; nel 2024 l’Agenzia riceve dai sistemi di cooperazione internazionale l’informazione di un pagamento transfrontaliero su un conto di Alpha. Parte quindi un controllo formale che porta a un avviso di accertamento per redditi non dichiarati.
- Errata qualificazione dei redditi da royalties: talvolta i contribuenti dichiarano gli importi percepiti, ma in maniera non conforme alla loro natura fiscale. Ad esempio, un privato potrebbe aver inserito le royalties tra i “redditi diversi” occasionali, mentre l’Ufficio ritiene si trattasse di reddito di lavoro autonomo abituale (o viceversa); oppure una società potrebbe aver contabilizzato un introito da royalty come sopravvenienza o come riduzione di costo invece che come ricavo tassabile. Similmente, dal lato di chi paga, si vedono casi di royalties dedotte come spese di pubblicità o consulenza invece che come licenza d’uso. L’Agenzia controlla la documentazione contrattuale e la sostanza dell’operazione: se rileva una qualificazione fiscale diversa da quella dichiarata, può contestare l’errore. Un esempio comune è la distinzione tra cessione di bene immateriale e licenza: se hai trattato come “plusvalenza” la vendita di un software ma l’Amministrazione la considera in realtà una royalty periodica, potresti subire una rettifica (le plusvalenze godono di regimi diversi, talora più favorevoli, e potrebbero non includere le stesse ritenute). Esempio: l’artista X dichiara un compenso da streaming musicale come “reddito diverso” occasionale; l’Agenzia invece lo qualifica come diritto d’autore professionale, esigendo il ricalcolo dell’imposta con aliquote progressive e l’applicazione solo parziale dell’abbattimento 40% (valido per redditi non professionali). In questo caso non c’è omessa dichiarazione del reddito, ma infedele dichiarazione (dichiarazione errata) con recupero della maggiore imposta dovuta.
- Presunzione di ricavi occulti da royalties: il Fisco può presumere l’esistenza di royalties non dichiarate sulla base di indizi. Ad esempio, se un soggetto risulta titolare di un marchio sfruttato da terzi, ma non ha dichiarato alcun canone, l’Ufficio può ipotizzare che abbia percepito pagamenti “in nero”. Oppure se un artista risulta vendere opere tramite piattaforme online o editori stranieri, l’Agenzia può inviargli una lettera di compliance chiedendo se ha percepito compensi e sollecitando la regolarizzazione. Anche movimenti bancari ingiustificati (versamenti sul conto) possono far scattare l’indagine: in sede di verifica bancaria, se emergono accrediti periodici da un soggetto senza un contratto noto, il Fisco potrebbe qualificarli come possibili royalties o diritti d’autore non dichiarati e chiederne conto . In questi casi l’accertamento poggia su presunzioni semplici: starà al contribuente fornire la prova contraria (es. dimostrare che quell’importo era un prestito, non un pagamento per licenza). Va ricordato che i versamenti su conti di professionisti o imprese si presumono ricavi salvo prova contraria (art. 32 DPR 600/73). Esempio: Tizio, programmatore, riceve bonifici mensili da una società estera su PayPal; non li dichiara pensando siano rimborsi spese. Il Fisco, vedendo il flusso costante, presume siano royalties per l’uso di un software sviluppato da Tizio e avvia un accertamento sintetico del reddito.
- Mancanza di documentazione contrattuale chiara: un altro terreno di contestazione è l’assenza o inadeguatezza dei contratti di licenza o altra documentazione di supporto. Se durante una verifica fiscale l’azienda (o il privato) non esibisce un contratto che giustifichi i pagamenti di royalty (in entrata o in uscita), l’Ufficio può contestare la natura stessa dei flussi. Ad esempio, l’azienda Beta paga annualmente €50.000 a una società collegata all’estero senza un contratto scritto di licenza: il Fisco potrebbe considerare quei pagamenti come utili occulti o come costi indeducibili per mancanza di causa. Oppure, se un autore percepisce somme da una piattaforma ma non ha documenti che spieghino a che titolo, il Fisco potrebbe riqualificarle. Una difesa efficace richiede contratti dettagliati, fatture e documenti che spieghino la causale delle transazioni . Spesso le contestazioni nascono proprio perché i contratti mancano o sono redatti in modo generico, non specificando ad esempio la percentuale di royalty, la durata, il territorio, etc., lasciando spazio al sospetto che i pagamenti celino altro.
- Royalties infragruppo “anomale” o transfer pricing: come evidenziato sopra, se un’azienda paga o riceve royalties all’interno di un gruppo multinazionale, l’Amministrazione finanziaria verifica che il valore sia di mercato e che non vi sia uno spostamento di utili verso giurisdizioni a minor tassazione. Dunque, contestazioni tipiche sono: “royalty eccessiva” dedotta in Italia (con trasferimento di utili all’estero), oppure “royalty troppo bassa” percepita dall’Italia (con spostamento di profitti su un licenziatario estero poco tassato). Nel primo caso, l’Ufficio recupera imposte limitando la deduzione; nel secondo caso, potrebbe contestare una sotto-fatturazione di ricavi, rideterminando per presunzione maggiori royalties attive spettanti all’italiana. Esempio interno: Gamma S.r.l. (Italia) ha concesso un marchio alla consociata Gamma DE (Germania) al 1% delle vendite, mentre in casi simili aziende indipendenti applicano 4-5%. Il Fisco può sostenere che Gamma S.r.l. avrebbe dovuto chiedere almeno il 4%, imputandole un ricavo aggiuntivo per differenza, tassabile in Italia (specularmente in Germania quell’1-3% non pagato potrebbe far aumentare gli utili tassati). Queste contestazioni richiedono complesse analisi di transfer pricing, spesso con scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi (Mutual Agreement Procedure). In sede nazionale, si configureranno come accertamenti “parziali” sul singolo componente di reddito (art. 41-bis DPR 600/73).
Iter e forma dell’accertamento: i controlli sulle royalties possono nascere da diverse attività istruttorie:
- Questionari e richieste di documenti: spesso l’Agenzia invia un questionario preliminare al contribuente, chiedendo di fornire chiarimenti su eventuali licenze, contratti, pagamenti esteri, ecc. Questo avviene, ad esempio, quando arriva una segnalazione di flussi esteri: l’Ufficio, prima di emettere accertamento, può chiedere al contribuente di spiegare la natura dei pagamenti ricevuti dall’estero. È importante rispondere con precisione e produrre i documenti, perché una mancata risposta può spingere l’Ufficio a fare un accertamento induttivo (basato su presunzioni) meno favorevole. Attenzione: non sottovalutare i questionari – rappresentano una fase in cui è possibile chiarire la situazione ed eventualmente evitare la rettifica formale. Se non rispondi o la risposta è insoddisfacente, l’Ufficio potrebbe procedere.
- Verifiche fiscali in loco (PVC): nelle situazioni più complesse, la Guardia di Finanza o funzionari dell’Agenzia possono eseguire una verifica fiscale presso la sede del contribuente (azienda) o uno scambio di informazioni con autorità estere. Al termine di una verifica, la GdF redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC) con i rilievi riscontrati, ad esempio: “Si constata che la società non ha assoggettato a tassazione royalties passive per €X verso società in Lussemburgo, costi ritenuti indeducibili per carenza di inerenza”. Il contribuente può presentare osservazioni al PVC entro 60 giorni. Trascorso tale periodo (o prima in casi di urgenza, come abuso del diritto, se motivato), l’Agenzia emette l’Avviso di Accertamento.
- Notifica dell’Avviso di Accertamento: l’atto formale con cui l’Ufficio recupera le imposte ritenute evase, applica sanzioni e interessi. Deve essere motivato e indicare i periodi d’imposta, gli importi non dichiarati e le norme violate. In tema di redditi esteri, spesso l’accertamento è un “avviso di accertamento parziale” (ex art. 41-bis), quando riguarda solo specifici redditi scoperti successivamente (ad es. grazie a informazioni estere). La tempistica: l’atto deve rispettare i termini di decadenza (in generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; settimo anno se dichiarazione omessa) . Ad esempio, per redditi 2019 dichiarati regolarmente, il termine è fine 2024; se per il 2019 non hai presentato dichiarazione, il termine è fine 2026 . Eccezione: in caso di assets detenuti in paradisi fiscali non dichiarati in RW, i termini raddoppiano (da 5 a 10 anni, o da 7 a 14 in caso di omessa dichiarazione) , stante la presunzione per investimenti black list (questa regola è applicabile ai periodi d’imposta fino al 2015; per gli anni successivi vige un regime di inversione dell’onere probatorio sui capitali esteri, ma i termini restano quelli ordinari salvo reati). Dunque, se l’accertamento riguarda royalties canalizzate su società di Panama non dichiarate, l’Agenzia potrebbe sostenere l’applicabilità del raddoppio, notificando l’atto anche oltre il quinto anno (questo aspetto è delicato e contestabile, ma va considerato in consulenza). La notifica avviene di norma via PEC per i soggetti con domicilio digitale, oppure tramite raccomandata o messo notificatore.
- Contenuto economico dell’accertamento: l’Ufficio ricalcola il reddito imponibile aggiungendo le royalties non dichiarate (o recuperando i costi indebitamente dedotti). Su tale maggior reddito vengono calcolate le imposte dovute (IRPEF, IRES, addizionali, IRAP se applicabile). Viene poi aggiunta la sanzione amministrativa (infedele 90-180% o 70% etc., come visto sopra) e gli interessi moratori al tasso legale (dal momento in cui le imposte avrebbero dovuto essere versate, tipicamente dalla scadenza del saldo per quell’anno). Gli interessi legali attualmente (2025) sono relativamente bassi, ma in passato erano più alti; l’Agenzia li computa anno per anno. In caso di omessa dichiarazione RW di attività estere correlate, verranno contestate a parte anche le sanzioni da monitoraggio (3-15%/6-30% del valore non dichiarato) . Ad esempio, se le royalties da estero erano accreditate su un conto non dichiarato, arriverà sanzione RW su quel conto. Se chi ha ricevuto la royalty avrebbe dovuto operare una ritenuta e non l’ha fatto (caso di sostituto), l’accertamento includerà anche il recupero della ritenuta non versata e la sanzione del 20%. In alcuni casi, oltre all’avviso di accertamento può pervenire una separata contestazione di sanzioni (quando l’atto principale non contiene la quantificazione sanzionatoria, cosa però rara nel campo delle imposte dirette post-2016).
- Possibili conseguenze successive: se il contribuente non reagisce entro i termini (vedi sotto) né paga, l’avviso diverrà definitivo e verrà iscritto a ruolo. Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) potrà quindi avviare la riscossione coattiva: notifica della cartella di pagamento, intimazioni, e in mancanza di adempimento, procedure esecutive come fermo amministrativo, ipoteca o pignoramenti (conti correnti, stipendi, immobili) . Quindi, ignorare un accertamento su royalties può portare in breve tempo a conseguenze patrimoniali serie. Inoltre, nei casi gravi (es. evasione > soglia penale), l’Agenzia fa segnalazione alla Procura della Repubblica: il contribuente potrebbe venire indagato per reato tributario (omessa o infedele dichiarazione) . L’instaurazione del procedimento penale non sospende di per sé le procedure amministrative di incasso, e viceversa: sono due binari paralleli, seppur collegati (il pagamento del dovuto può influire positivamente in sede penale). Per questo è fondamentale attivarsi prontamente per la difesa, come vedremo, valutando tutte le opzioni disponibili.
Strategie di difesa prima e dopo la notifica: come tutelarsi
Passiamo ora alla parte operativa: come difendersi efficacemente da un accertamento fiscale per royalties non dichiarate. Le strategie vanno modulate in base alla fase in cui ci si trova (pre-contenzioso o contenzioso) e alla posizione (soggetto che ha percepito royalties non dichiarate, oppure impresa che le ha dedotte o non ha operato ritenute).
Prevenire e gestire il pre-accertamento
La prima regola è giocare d’anticipo quando possibile. Se ti rendi conto di aver commesso un’irregolarità in materia di royalties (ad esempio, omissione di redditi esteri), intervieni prima che lo faccia il Fisco. Ecco alcune mosse:
- Ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa: Finché non hai ricevuto formali “avvisi di accertamento” o anche solo un PVC conclusivo di verifica, puoi regolarizzare spontaneamente la situazione. Puoi presentare una dichiarazione integrativa per l’anno in cui hai omesso le royalties, dichiarando il maggior reddito e versando la maggiore imposta dovuta. Grazie al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) le sanzioni vengono ridotte in modo crescente in base alla tempestività: ad esempio, se integri entro 90 giorni, paghi una sanzione minima (1/9 del minimo); se oltre un anno ma entro il termine di accertamento, paghi 1/8 del minimo. Per la dichiarazione infedele, dal 2024 la sanzione base è 70%, quindi col ravvedimento ad esempio a 2 anni di ritardo pagheresti circa il 17,5% (un ottavo) dell’imposta evasa, invece del 90-180% pieno. È un risparmio enorme e soprattutto evita il contenzioso. Importante: il ravvedimento è ammesso anche per attività estere non dichiarate (incluso quadro RW), pagando le relative sanzioni ridotte . Non è ammesso se sono già iniziati accessi/verifiche o notifiche formali sul periodo in oggetto. Quindi, se hai la percezione di essere “a rischio” (perché hai ricevuto bonifici dall’estero non dichiarati, o hai venduto licenze senza dichiararle), conviene valutare immediatamente un ravvedimento operoso. Oltre a sanare, questo in caso di potenziale reato tributario può farti rientrare sotto soglia (pagando l’imposta riduci l’evasione calcolata).
- Autotutela su comunicazioni di irregolarità: talvolta le omissioni minori vengono prima segnalate con una comunicazione di irregolarità (es. un controllo automatico incrocia dati e trova un reddito estero segnalato che manca). In tal caso, se hai elementi per giustificare (magari quel reddito era esente da tassazione in Italia per qualche norma, oppure è un duplicato) puoi presentare memorie e documenti all’Agenzia chiedendo l’archiviazione in autotutela. Se invece la comunicazione è corretta, pagare subito beneficia di sanzioni ridotte a 1/3. Insomma, non ignorare le comunicazioni bonarie: affrontale entro 30 giorni.
- Risposta ai questionari: come detto, se ricevi un questionario o invito a comparire per spiegazioni, preparati accuratamente. Verifica innanzitutto la tipologia di reddito percepito: era royalty passiva (tu pagavi) o attiva (tu incassavi)? Derivava da cessione definitiva o da concessione d’uso? Era da fonte estera? Da soggetti collegati? Questa analisi serve a capire come inquadrare il caso . Analizza i contratti: se non li avevi, predisponi una documentazione ex post (non ideale, ma meglio di nulla) che ricostruisca l’accordo. Se le royalties erano estere, raccogli eventuali convenzioni applicabili (il nome del trattato, l’art. 12, ecc.) . Verifica le imposte pagate all’estero: se hai pagato una ritenuta fuori, preparati a dimostrarlo (certificati di withholding) per poter rivendicare il credito d’imposta, almeno in sede di definizione. Controlla i flussi finanziari: se la contestazione sarà basata su bonifici, predisponi estratti e prova la destinazione di quei fondi. Più elementi concreti porti prima dell’emissione dell’avviso, maggiori chance che l’Ufficio moduli diversamente la pretesa (o in rari casi la archivi del tutto). Ricorda che fino a quando non c’è un atto impositivo, sei in terreno di interlocuzione informale: sii collaborativo ma senza ammettere irregolarità inesistenti. Se l’ufficio basa tutto su presunzioni, sottolinea l’assenza di prove e fornisci tu spiegazioni alternative plausibili (evidence-based). Ad esempio, se ti imputano un 5% mancante su una royalty infragruppo, già in contraddittorio puoi consegnare uno studio di settore che dimostra come nel tuo settore i royalty rate vanno dal 5 al 7%, ergo il tuo 5% non era affatto anomalo.
- Accertamento con adesione (fase pre-contenziosa negoziale): una volta notificato l’avviso di accertamento, prima di fare ricorso hai una carta da giocare: presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97) all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica. Questo apre una fase di negoziazione: tu (e/o il tuo consulente) potrai sederti a un tavolo con i funzionari per discutere la pretesa. Nel caso di royalties, l’adesione è utile per ridurre sanzioni e trovare un accordo sul quantum evitando la causa. Puoi evidenziare elementi nuovi non considerati (ad es. “il trattato prevede aliquota 5% quindi la ritenuta del 30% non era dovuta interamente…” oppure “la royalty l’ho omessa ma ecco le imposte pagate all’estero, vorrei il credito…”). L’ufficio ha margine per rideterminare l’imponibile e le sanzioni in sede di adesione. Se si raggiunge un accordo, viene formalizzato in un atto di adesione: la sanzione applicata viene automaticamente ridotta a 1/3 del minimo , e puoi pagare il dovuto in 8 rate trimestrali (se >€50.000, in 16 rate). Attenzione: la domanda di adesione sospende i termini per ricorrere e il termine di pagamento dell’accertamento. Se le posizioni non sono distanti, conviene tentare questa strada. Ad esempio, hai omesso royalty €100k: imposte evase €24k, sanzione infedele base €21.6k. In adesione potresti concordare magari un imponibile leggermente inferiore (se porti qualche spesa deducibile connessa) e soprattutto la sanzione scende a 1/3 del 90%, cioè al 30% circa . Inoltre eviti il rischio di processi penali lunghi se sistemi tutto qui (il pagamento integrale prima della sentenza di primo grado estingue il reato di infedele per particolare tenuità, se rientra sotto soglia dopo sanzioni ridotte).
- Sospensione e istanza di autotutela: se l’accertamento appare manifestamente errato (ad es. richiede tasse su un reddito già dichiarato regolarmente altrove, oppure ignora un’esenzione di legge), si può provare a chiederne l’annullamento in autotutela all’ufficio o a organi superiori, allegando le prove dell’errore. Però, l’autotutela è discrezionale: l’Agenzia raramente annulla totalmente un proprio atto se non in casi di errore palese. Vale la pena tentare se c’è un evidente sbaglio matematico o giuridico. In parallelo, entro 60 giorni dalla notifica, se non hai definito in adesione, dovrai predisporre il ricorso al giudice tributario, per evitare decadenza (vedi prossimo paragrafo). Nota: se l’importo è elevato e temiamo misure cautelari, è possibile chiedere sospensione dell’esecuzione sia in adesione (l’ufficio la concede fino esito adesione) sia al giudice una volta presentato ricorso (sospensiva ex art. 47 D.Lgs. 546/92, se pagamento immediato arrecherebbe danno grave e il ricorso presenta buone chance).
Difesa nel contenzioso tributario
Se non si è addivenuti a un accordo con l’ufficio, o se si ritiene infondato l’accertamento, la strada è presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Vediamo come impostare la difesa tecnica:
- Ricorso introduttivo (primo grado): va depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine sospeso se si è presentata istanza di adesione). Il ricorso deve contenere i motivi di diritto e di fatto su cui contestiamo l’accertamento. In materia di royalties, i possibili motivi di ricorso includono:
- Vizi formali e procedurali: esaminare se l’atto è stato notificato entro i termini di decadenza , se la motivazione è adeguata (es. l’avviso spiega come ha quantificato le royalties? Ha considerato le controdeduzioni presentate in fase precontenziosa?), se sono state rispettate eventuali garanzie procedurali (ad es. in caso di utilizzo di informazioni estere: erano tradotte? è stato garantito il contraddittorio internazionale?). La carenza di motivazione o la violazione di norme sul procedimento possono portare all’annullamento dell’atto. Tuttavia, va notato che dal 2015 l’eventuale vizio di mancato contraddittorio pre-emissione è causa di annullamento solo se il contribuente prova in giudizio la rilevanza concreta che quel contraddittorio avrebbe potuto avere (Cass. SU n.24823/2015). Comunque, sollevare i vizi procedurali è doveroso, perché se fondati evitano anche di affrontare il merito. Esempio: “Violazione art. 7 L.212/2000: motivazione insufficiente – l’atto si limita a citare la circ.1980 senza spiegare perché il 5% applicato non sarebbe di mercato” è un motivo che attacca la chiarezza della pretesa . Oppure: “Violazione art. 12 c.7 L.212/2000: avviso notificato prima di 60 giorni dal PVC senza urgenza motivata” – motivo formale.
- Insussistenza del presupposto impositivo: contestiamo in fatto che quelle somme non costituiscano affatto reddito imponibile per il ricorrente. Ad esempio, potremmo sostenere che i pagamenti ricevuti non erano royalties ma restituzioni di capitale o finanziamenti (se plausibile e provabile). Oppure che le somme contestate erano già tassate in capo ad altro soggetto e non vanno tassate di nuovo. Se l’ufficio ha qualificato come royalty qualcosa che non lo era (es. il caso del software standard che non è royalty), qui diremo: error in iudicando, violazione dell’art. 12 convenzione X, in quanto il compenso era per cessione di copia software e non per concessione di diritto d’autore . Altro esempio: l’ufficio requalifica come royalty un pagamento verso estero, ma magari quel pagamento era già stato assoggettato a ritenuta alla fonte estera come servizio e hai pagato tasse piene all’estero – potresti sostenere che in base alla Convenzione quell’importo va tassato solo all’estero (se l’art. 12 del trattato prevede tassazione esclusiva Stato residenza percettore, come a volte accade per diritti d’autore).
- Infondatezza nel merito (quantificazione e valutazione): qui entra la maggior parte delle argomentazioni difensive. Si contesta la ricostruzione fattuale dell’ufficio: l’importo ritenuto evaso è errato, perché magari l’ufficio ha ignorato costi deducibili correlati o crediti d’imposta esteri. Si contesta la qualificazione giuridica: ad esempio l’ufficio ha trattato come reddito imponibile per intero un compenso che per legge andava parzialmente esente ex art. 54 TUIR (nel caso l’agente accertatore abbia ignorato l’abbattimento 25-40% sui diritti d’autore). Oppure l’ufficio ha considerato indeducibile una royalty infragruppo che invece era inerente e congrua: qui la difesa dovrà portare pezze giustificative (contratti, studi comparativi, perizie) per dimostrare la liceità della scelta di transfer pricing. Ad esempio, se contestano un tasso oltre il 5%, bisognerà produrre analisi di mercato e magari una perizia econometrica per convincere i giudici che quel tasso era ragionevole . Se contestano mancanza di beneficiario effettivo, dovrai provare la sostanza economica del percettore estero (struttura, personale, autonomia decisionale) . Se negano il credito per imposte estere perché il reddito non fu dichiarato, potresti contestare l’interpretazione stringente dell’art. 165 c.8 TUIR (anche se la Cassazione su questo è sfavorevole: il credito spetta solo se il reddito è dichiarato) . In sostanza, qui devi smontare punto per punto le presunzioni dell’ufficio: “la spesa non è inerente” → dimostro che invece lo è con evidenze (contratto + documento che mostra il beneficio economico ottenuto grazie a quella licenza) ; “il canone è troppo alto” → dimostro con comparables di settore che è in linea (o che comunque l’extra è giustificato) ; “manca il beneficial owner” → dimostro l’assenza di retrodonazioni o la corretta applicazione del look-through (ad esempio allegando la Convenzione col paese terzo e mostrando che anche con quella l’aliquota sarebbe bassa, segno che non c’era volontà di evasione) .
- Errata applicazione di norme convenzionali o UE: se il caso coinvolge trattati internazionali o direttive comunitarie, puoi invocare la loro violazione. Ad esempio: “Violazione dell’art. 12 Convenzione Italia-Francia: l’ufficio ha assoggettato a tassazione royalties già tassate in Francia in via esclusiva” – questo va calibrato sul trattato specifico. Oppure “Violazione della Direttiva 2003/49/CE attuata dall’art. 26-quater DPR 600/73: la mia società estera era consociata UE con requisiti, l’ufficio non avrebbe dovuto chiedere ritenuta”. O ancora, “Violazione art. 10 TFUE: abuso del diritto – l’ufficio erroneamente qualifica come abuso un’operazione commerciale genuina”. Questi motivi sono più tecnici e vanno supportati da riferimenti precisi (magari interpelli o giurisprudenza UE). Nel caso beneficial owner, se l’ufficio ha invertito l’onere della prova potresti citare la CTR Emilia 2023 a tuo favore, evidenziando che la normativa processuale impone l’onere al Fisco e che giurisprudenza si sta uniformando in tal senso .
Quando redigi il ricorso, cerca di supportare ogni affermazione con documenti allegati e, se possibile, con precedenti giurisprudenziali. Ad esempio, se sostieni che oltre il 5% è ammesso, allega copia di Cass. 12846/2022 integrale o almeno della massima . Se sostieni che l’onere della prova spetta all’AdE in tema abuso, allega magari la sentenza CTR 929/2023 o Cass. 10333/2018 che lo afferma. I giudici tributari apprezzano quando vedono supporto autorevole. Considera anche la possibilità di far testimoniare (in forma di dichiarazioni sostitutive, dato che la testimonianza orale è vietata nel processo tributario) eventuali soggetti che possano avvalorare la tua versione (es. il manager estero che dichiara “la società estera ha svolto realmente la funzione X…”). In più, se la controversia verte su valori normali, valuta di chiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU): un perito nominato dal giudice potrebbe stimare il range di royalty di mercato per quell’asset. Spesso i giudici accettano CTU in materia valutativa (soprattutto in appello), se la questione è complessa tecnicamente e c’è incertezza.
- Fase istruttoria e discussione: nel processo tributario il fascicolo è scritto, ma puoi depositare memorie aggiuntive e documenti fino a 20 giorni prima dell’udienza, e una memoria di replica fino a 10 giorni prima (art. 32 D.Lgs. 546/92). Usale per confutare le difese dell’ufficio (che arriveranno in un “atto di controdeduzioni”). Ad esempio, se l’ufficio ribatte che la tua analisi comparativa non è calzante, risponderai evidenziando perché invece lo è, magari portando ulteriori studi. Alla pubblica udienza (se non è trattata in camera di consiglio) puoi svolgere un’arringa di sintesi: concentrati sui punti chiave a tuo favore. Sottolinea eventuali precedenti vincolanti: p.es. “la Cassazione in casi analoghi ha già annullato pretese simili, come da sentenze allegate”. Se la materia è delicata, potresti persino suggerire al collegio di disporre una CTU se non l’hai già chiesta o di chiamare un esperto (in rari casi la Commissione può nominare un consulente tecnico d’ufficio autonomamente).
- Esito di primo grado e oltre: se vinci, bene (ma prepara comunque la difesa per l’appello che l’ufficio quasi certamente proporrà se la somma è rilevante). Se perdi in tutto o in parte, puoi appellare alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex CTR). L’appello va presentato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. In appello puoi portare nuovi documenti e anche nuove argomentazioni (purché relative a questioni già oggetto del giudizio, non completamente nuove domande). Ad esempio, se in primo grado hai contestato l’inerenza qualitativa ma non avevi enfatizzato un certo documento, in appello puoi depositarlo. Tieni presente che dal 2023 molte CTR (ora Corti di Giustizia di secondo grado) hanno sezioni composte da magistrati togati: c’è tendenzialmente maggior attenzione agli aspetti giuridici. Quindi, ancor più, incentra l’appello sulle eventuali errori di diritto o di motivazione commessi in primo grado. Ad esempio: “Error in iudicando: la CTR non ha considerato la prova documentale X che invece attestava l’utilizzo effettivo del brevetto – omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n.5 c.p.c.” ; oppure “Violazione art. 110(7) TUIR: i giudici hanno richiesto prova di un disegno elusivo, in contrasto con Cassazione 23587/2023”. Insomma, evidenzia dove il primo giudice ha sbagliato applicazione di norme o ha ignorato prove. In appello puoi anche far valere eventuali sviluppi nel frattempo: ad esempio, se dopo la sentenza di primo grado è uscita una nuova Cassazione a te favorevole, segnalalo e allegala . Se il contenzioso è ancora aperto, puoi provare anche in appello una conciliazione giudiziale (un accordo transattivo con l’ufficio, con sanzioni ridotte del 40%). Questa è spesso un’ottima via per chiudere la disputa dimezzando circa le sanzioni residue e risparmiando tempo e costi ulteriori. Va proposta prima dell’udienza di trattazione. In contropartita, rinunci a pretese di rimborso.
- Ricorso per Cassazione: qualora la vicenda arrivi fino in Corte di Cassazione (accade se le parti vi insistono dopo l’appello, soprattutto su questioni di principio o importi ingenti), la difesa cambia natura. La Cassazione giudica solo su questioni di diritto, non rivede i fatti nel merito. Quindi la tua difesa – nel controricorso o nel ricorso stesso se sei tu a proporlo – dovrà essere incentrata su motivi di legittimità: errori di diritto commessi dal giudice d’appello (violazione di norme tributarie, omesso esame di fatti decisivi, nullità procedurali). Ad esempio, un motivo potrebbe essere: “Violazione dell’art. 9, co.3 TUIR in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.: la CTR ha erroneamente applicato un criterio di valore normale in contrasto con la definizione legale, assumendo un tetto massimo del 5% non previsto dalla legge”. Oppure “Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n.5 c.p.c.): la CTR non ha considerato la perizia di parte che dimostrava la congruità del 7% di royalty, fatto discusso e decisivo” – ma attenzione, il motivo n.5 ora è molto limitato: l’omesso esame dev’essere su un fatto decisivo non valutato affatto dalla sentenza d’appello . In Cassazione non potrai più produrre nuovi documenti né rivedere l’apprezzamento del merito. Dovrai puntare su precedenti favorevoli, magari chiedendo, in caso di contrasto giurisprudenziale, l’intervento delle Sezioni Unite (ad esempio se ci fossero ancora divergenze sul punto del beneficial owner e onere probatorio) . Se sei il resistente (cioè hai vinto in appello e l’Agenzia ricorre), dovrai difendere la sentenza di secondo grado evidenziando come il ricorso avversario cerca di rivalutare i fatti (il che è inammissibile) e richiamando i principi di diritto a tuo favore già affermati in Cassazione .
La fase di legittimità è altamente tecnica e richiede un avvocato cassazionista esperto in tributario. Se la Cassazione accoglie il ricorso del contribuente e la questione è matura, può decidere nel merito annullando l’accertamento; altrimenti rinvia a diversa sezione della Corte di giustizia tributaria per un nuovo esame. Se invece viene rigettato il ricorso del contribuente, l’accertamento diviene definitivo (salvo estremi per ricorso alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia UE, ipotesi rare).
Prove e documenti fondamentali per la difesa
Indipendentemente dalla fase (amministrativa o giudiziale), difendersi in materia di royalties richiede di predisporre un vero “dossier” probatorio. I documenti chiave da esibire sono :
- Contratto di licenza: deve essere dettagliato, preferibilmente con data certa anteriore o coeva all’inizio dei pagamenti. Un buon contratto indica l’oggetto (bene immateriale concesso), il corrispettivo (percentuale, importo fisso, formula di calcolo), la durata, l’area geografica, eventuali servizi accessori inclusi. Se il contratto è registrato o autenticato, tanto meglio. L’assenza di contratto scritto è un handicap: in giudizio può essere sopperita con altri mezzi (corrispondenza, comportamenti concludenti) ma rende tutto più difficile.
- Documentazione di transfer pricing (per operazioni infragruppo): se la controversia riguarda società collegate, la predisposizione del Masterfile e della Documentazione Nazionale è il primo scudo. Nel Local File idealmente ci sarà un capitolo dedicato alla transazione di licenza: descrizione dell’intangibile, funzioni svolte dalle parti, scelta del metodo TP (es. royalty sul fatturato comparabile a contratti tra indipendenti, oppure ripartizione del profitto residuo), analisi dei comparables di mercato . Se la documentazione mostra che l’operazione è in linea col mercato, costituisce una prova forte a tuo favore: dimostra che hai applicato il principio di libera concorrenza e che non c’era intento evasivo. In giudizio, depositare la documentazione TP (se non l’avevi già consegnata prima) può far leva anche sul giudice, mostrando trasparenza.
- Prova dell’avvenuta prestazione: se la royalty è pagata per un know-how o un servizio, è cruciale mostrare che la controparte estera ha effettivamente fornito qualcosa. Ad esempio, rapporti tecnici, manuali, report di consulenza, sessioni di training svolte (con e-mail, calendari, attestati) . Se è un marchio, mostra come il marchio è stato usato: materiali pubblicitari, aumento di vendite grazie a quel marchio, ecc. Lo scopo è contrastare eventuali affermazioni del Fisco tipo “pagamento privo di causa” o “nessun beneficio ottenuto”. Nel caso di contestazioni di inerenza, presentare documenti che evidenzino il vantaggio economico prodotto dalla licenza può ribaltare la prospettiva. Esempio: portare studi di marketing che mostrano come l’uso del marchio licenziato abbia permesso di praticare prezzi più alti e penetrare nuovi mercati, giustificando così la spesa .
- Calcoli e dati finanziari di supporto: se la royalty è commisurata a parametri variabili (fatturato, utili, unità vendute), predisponi prospetti anno per anno che mostrino come hai fatto i calcoli e su quali basi. Ciò serve a rispondere a eventuali rilievi di errata base di calcolo o errori matematici. Esempio: se l’Agenzia dice “avresti dovuto applicare il 2% sul fatturato di 10 milioni, invece hai dedotto 400k”, tu presenti il calcolo che mostra che il 3,5% era riferito però a un fatturato che includeva certe voci, etc. Mantenere la chiarezza nei numeri aiuta a non far apparire la tua difesa fumosa.
- Certificazioni estere e ruling: se esistono tax rulings o APA (Advance Pricing Agreements) relativi alla transazione, presentali. Ad esempio, se la società estera beneficiaria ha un APA col suo fisco che convalida un certo tasso di royalty, è un elemento a tuo favore (mostra che almeno un’Amministrazione fiscale ha giudicato arm’s length quel valore) . Oppure se avete attivato una Mutual Agreement Procedure tra Italia e l’altro Stato per anni precedenti e si è conclusa con un certo esito, mostralo: indica la buona fede e collaborazione. Anche un eventuale interpello italiano (es. se avevi chiesto chiarimenti su quell’operazione) va esibito, perché vincola l’AdE se la risposta ti era favorevole. Se le imposte estere sono state pagate, allega i certificati di versamento (fondamentale per chiedere il credito d’imposta o almeno la non applicazione di sanzioni piene, invocando mancanza di intenzione evasiva). Nell’ambito UE, se hai beneficiato dell’esenzione interessi e canoni, allega la documentazione trasmessa all’AdE (dichiarazione di residency e beneficial owner della consociata): può provare che tu hai operato con diligenza ex ante.
- Corrispondenza e delibere interne: se esistono e-mail, lettere, minute di riunioni che spiegano il perché e come di quella royalty, produci anche queste. Ad esempio, una delibera del CDA di qualche anno prima dove si decide di registrare il marchio a nome di una società e licenziarlo all’altra con un certo canone per ragioni di brand strategy è molto utile a mostrare la razionalità economica della scelta . Anche comunicazioni interne dove il management discute dell’ammontare della royalty, del confronto con valori di mercato, ecc., mostrano che c’era un processo decisionale genuino e non una mera costruzione di comodo.
- Pareri di esperti o studi indipendenti: se per fissare la royalty vi siete avvalsi di un consulente indipendente o di banche dati, qualsiasi report prodotto ante litteram è prezioso. Ad esempio, una relazione di un advisor che suggeriva un range di royalty e la vostra rientra lì. Oppure uno studio comparativo commissionato allora. Questo è il tipo di elemento che sposta l’ago in giudizio: mostra che la scelta di pricing fu fatta con criterio e non arbitrariamente . Anche pubblicazioni di settore possono essere allegate (es. un articolo di rivista che dice: “nel settore farmaceutico le royalty su brevetti oscillano tra 2 e 5% delle vendite”), per dare un contesto al giudice.
In sintesi, devi costruire un fascicolo robusto che ricostruisca la storia economica dietro quelle royalties. Se ci riesci, hai ottime possibilità di successo, perché sposterai la percezione del giudice: da “contribuente che ha occultato redditi” a “contribuente che ha agito con logica imprenditoriale e può provarlo”.
Argomentazioni difensive specifiche
Vediamo ora alcune situazioni tipiche di contestazione e come articolare la difesa in concreto, facendo anche riferimento a principi giurisprudenziali:
- Royalty infragruppo considerata “troppo alta” (oltre soglie di prassi): come già accennato, non subire passivamente l’imposizione di una soglia arbitraria (2% o 5%). La difesa deve far emergere perché nel tuo caso quella percentuale maggiore era giustificata. Puoi, ad esempio, documentare che nel tuo settore di mercato royalties del X% sono normali: esibisci studi di società di consulenza o database sui licensing in quel campo . Se la royalty includeva più elementi (es. marchio + servizi), suddividi idealmente il valore: “3% effettivo per l’uso del marchio, 2% era remunerazione di servizi accessori di marketing forniti dalla casa madre” – in tal modo il 3% risulta pienamente in linea col mercato per la sola licenza . Evidenzia specificità: ad es. la licenza dava esclusiva territoriale? L’esclusiva aumenta il valore, giustificando una royalty più alta. Il marchio era particolarmente noto e già supportato da ingenti investimenti pubblicitari dal licenziante? Allora pagare di più è normale (stai sfruttando un asset prestigioso, non uno sconosciuto) . Sottolinea anche l’aspetto fiscale: se il percettore estero ha già tassato il 5% in più nel suo paese, non c’era un vantaggio fiscale indebito, specie se quel paese non è un paradiso fiscale . Quindi non era un tentativo di erodere la base italiana, ma una politica di gruppo con tassazione comunque avvenuta altrove. Porta eventuali precedenti di anni diversi: se in anni successivi l’Agenzia non ha contestato la stessa percentuale, evidenzia la disparità di comportamento, segno che quella misura poteva essere ragionevole . In definitiva, convincere i giudici che il tuo 5-7% “aveva una logica” significa spesso vincere il punto: Cass. 12846/2022 appoggia proprio la valutazione caso-specifica e dice che le circostanze particolari devono essere considerate . Quindi fai emergere quelle circostanze.
- Mancata applicazione di ritenuta su royalties UE contestata per “beneficiario effettivo”: scenario: società italiana ha pagato royalties a consociata UE senza ritenuta (ex direttiva), ma l’Ufficio sostiene che la consociata era un mero tramite di una controllante extra-UE. Difesa: dimostrare la sostanza della consociata UE e l’assenza di inoltro automatico dei fondi. Porta organigrammi, bilanci, descrizione dell’attività reale svolta dalla consociata (uffici, dipendenti, ecc.) per far vedere che non è “una scatola vuota”. Poi confuta il presunto “giro di soldi”: l’Agenzia afferma magari che la società Olandese ha girato i soldi alla controllante USA. Mostra che non c’è un flusso identico in uscita di pari importo, o che comunque i pagamenti verso la controllante non erano collegati alle royalties (es. erano dividendi annuali proporzionati all’utile, non retrocessione integrale) . Se anche c’è stato trasferimento di utili, evidenzia che la ritenuta sarebbe comunque stata bassa: es. “Ok, ammettiamo che la beneficiaria effettiva fosse USA: il trattato Italia-USA prevede 8%, e infatti quel 8% è stato assolto come withholding dai pagamenti Olanda->USA, quindi l’Italia non ha perso gettito” (questo ricalca l’approccio CTR Emilia 2023). Cita magari la Circolare 6/E/2016 dell’Agenzia sul beneficial owner, dove l’AdE stessa riconosce di dover valutare attentamente la sostanza (se nota) . Soprattutto, richiama la norma processuale: art. 7 c.5-bis D.Lgs. 546/92 – onere del Fisco provare l’abuso, come da CTR 929/2023. Dunque se l’ufficio non ha prove concrete di mancanza di sostanza (tipo contratti di retrolocazione, passthrough agreement), il giudice dovrebbe propendere per te. Non esitare a depositare copia di quella sentenza CTR e di eventuali ordinanze di Cassazione 2022-2024 che ne parlano: mostra un trend pro-contribuente. In subordine, potresti anche sostenere che la direttiva 2003/49/CE non impone esplicitamente la condizione del beneficiario effettivo (era una condizione introdotta in Italia e poi de facto avallata dalla giurisprudenza UE per evitare abusi): ma questa è un’argomentazione di riserva, da giocarci se proprio c’è margine (la CGUE ha di fatto confermato che la direttiva non tutela gli abusi, quindi se c’è abuso l’esenzione decade). Quindi meglio puntare sulla assenza di abuso in fatto.
- Credito d’imposta per imposte estere negate per omessa dichiarazione: come notato, l’art. 165 comma 8 TUIR è severo: se dimentichi di dichiarare un reddito estero, perdi il diritto al credito per l’imposta estera pagata su quel reddito. La Cassazione (es. sent. n. 29572/2018) ha confermato questa linea: niente credito se non dichiari, a meno che tu aderisca a voluntary disclosure. In un contenzioso, potresti provare una linea equitativa: chiedere al giudice tributario di considerare comunque l’imposta estera pagata come circostanza attenuante. Ad esempio, invocare l’art. 8 D.Lgs. 546/92 (potere di compensazione equitativa), o segnalare che c’è giurisprudenza di merito che in alcuni casi riconosce il credito in via postuma nell’ambito della definizione (specie se il contribuente ha successivamente integrato). Non è garantito, ma tentare può portare magari a una decisione di compromesso: il giudice potrebbe ridurre le sanzioni considerando che un doppio prelievo integrale sarebbe eccessivamente punitivo. In parallelo, se hai fatto ravvedimento prima del giudizio, il credito ti spetta (perché hai dichiarato seppur tardivamente): assicurati di evidenziare ciò e documentare il pagamento estero e la sua non spettanza originaria e ora richiesta.
- Interessi e sanzioni sproporzionati: se l’accertamento copre molti anni addietro (es. 7-8 anni fa per via di estero), gli interessi accumulati possono essere ingenti. Le sanzioni come visto possono superare il 100%. Una extrema ratio difensiva è invocare il principio di proporzionalità e la convenzione europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che l’importo complessivo richiesto costituisce una sanzione eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità (specie se c’è stata tassazione all’estero, etc.). Non sempre i giudici tributari accolgono questo genere di argomenti (tendono a dire che finché è nei limiti di legge, va applicato), ma la Corte EDU in passato ha affermato che le pene complessive (somma di sanzione amministrativa e penale) non devono essere eccessive. Potresti citare la sentenza Grande Stevens (anche se riguarda il ne bis in idem in ambito Consob) o la giurisprudenza sui ritardi di rimborso. In sede nazionale non c’è un vero strumento per ridurre sanzioni legittime salvo la conciliazione, ma un appiglio può essere l’art. 7 D.Lgs. 472/97 (cause di non punibilità): se riesci a far qualificare il tuo errore come dovuto a obiettive condizioni di incertezza normativa, le sanzioni possono essere annullate. Ad esempio, se c’era incertezza oggettiva nel qualificare quel reddito come royalty (es. compensi per software borderline), puoi sostenere che c’era dubbio interpretativo e quindi sanzioni non dovute. Questo però è raramente riconosciuto. Alternativamente, se hai aderito a consigli di un professionista, in teoria la delega fiscale 2023 prevede l’esimente per chi si è conformato a interpretazioni risultate errate ma in buona fede (non ancora trasfusa in norma specifica credo). In sintesi, questi argomenti “di equità” difficilmente vincono il ricorso da soli, ma possono portare magari a esiti conciliativi o a convincere il giudice a usare misure come la riduzione sanzioni al minimo.
Infine, non dimenticare l’aspetto penale se rilevante: se il caso sfora soglie penalmente rilevanti, è prudente coinvolgere anche un avvocato penalista per monitorare il procedimento. Il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale consente l’attenuante speciale (riduzione fino alla metà della pena) e in alcuni casi l’esclusione delle misure cautelari personali. Inoltre, a seconda della gravità, valutare il patteggiamento o l’uso della causa di non punibilità per particolare tenuità (se l’evaso < 5% del dichiarato e < 30k €). È utile coordinare la difesa tributaria e penale in modo che elementi utilizzati nell’una non pregiudichino l’altra (ad esempio, ammissioni in sede tributaria vanno ponderate se c’è un’indagine in corso). Fortunatamente, la recente riforma della giustizia tributaria (2022) ha introdotto la facoltà per il giudice tributario di sospendere il processo in attesa dell’esito penale, ma è discrezionale.
Evoluzioni normative e di prassi nel 2024-2025
Negli ultimi due anni ci sono stati sviluppi significativi nella disciplina fiscale delle royalties, sia a livello normativo interno sia nelle prassi applicative dell’Amministrazione finanziaria. È importante esserne al corrente perché potrebbero influire sui casi pendenti o sulla pianificazione futura.
Riforma dell’art. 54 TUIR (2023-2024): Come anticipato, a partire dal periodo d’imposta 2024 è entrata in vigore una sostanziale revisione della tassazione delle royalties per persone fisiche. Questa riforma, attuata con i decreti legislativi emanati in attuazione della Delega Fiscale 2023 (in particolare il D.Lgs. n. 142/2023 e successivi), ha introdotto nuovi articoli nel TUIR, tra cui l’art. 54-octies denominato “determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo” . In pratica, il legislatore ha riordinato il trattamento dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno, brevetti e know-how da parte di persone fisiche non imprenditori. La deduzione forfettaria del 25% (40% under 35) è stata confermata, ma collocata nel nuovo art. 54-octies con maggiore specificazione dei beni immateriali ammessi e dei requisiti per goderne . Si mira a evitare che tale agevolazione venisse applicata indiscriminatamente anche a beni non previsti. Ad esempio, pare che i marchi d’impresa – che non erano esplicitamente menzionati nella vecchia norma – rimangano fuori dall’abbattimento forfettario secondo la lettera del nuovo testo, a meno che non si configurino come opere dell’ingegno o brevetti . Ciò per contrastare pianificazioni elusive che in passato sfruttavano la registrazione di marchi a persone fisiche per poi incassare royalties tassate solo al 75%. D’ora in poi, il 25% di esclusione si applicherà chiaramente ai proventi da diritti d’autore in senso stretto, brevetti industriali e opere di ingegno tutelate, mentre sui canoni da concessione di marchi commerciali il trattamento sarà ordinario salvo si dimostri che rientrano in altra categoria (ad esempio se il marchio include elementi creativi protetti dal diritto d’autore). L’obiettivo dichiarato della riforma è duplice: da un lato, evitare abusi/elusioni che sfruttavano l’agevolazione in contesti impropri; dall’altro, allineare la normativa italiana alle tendenze UE in materia di tassazione degli intangibili e agli standard OCSE (BEPS). La riforma ha anche ampliato concettualmente la definizione di “diritti immateriali” rilevanti, includendo espressamente il contesto digitale (menzione di software e know-how digitale) . Per i contribuenti, questo significa dover verificare attentamente, dal 2024 in avanti, se le royalties percepite hanno ancora diritto all’abbattimento forfettario oppure no, in base alla natura del bene. Ad esempio, un influencer che monetizza un brand name registrato a suo nome potrebbe scoprire che le royalties relative non godono più del 25% off se quel brand non è qualificabile come opera d’ingegno (a differenza delle royalties per diritti d’immagine legati a fotografie protette, che invece rientrerebbero). Sarà fondamentale attendere eventuali circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate sulla portata della nuova norma (specie sulla questione dei marchi). In caso di incertezza, si potrà ricorrere allo strumento dell’interpello qualificatorio per sapere in anticipo il trattamento.
Nuovo regime sanzionatorio (settembre 2024): Sul fronte delle sanzioni, come visto, il D.Lgs. 87/2023 (collegato alla riforma) ha modificato l’art. 1 D.Lgs. 471/97, abbassando la sanzione per dichiarazione infedele al 70% fisso (dal precedente minimo 90%) , con effetto per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 . Ciò riflette l’intento di rendere più proporzionate le pene amministrative ed evitare il cumulo eccessivo in caso di ravvedimenti. Per i contribuenti questo è positivo: eventuali future contestazioni su royalties non dichiarate vedranno sanzioni più miti. Attenzione però: per le violazioni pregresse (anni fino al 2023) in contenzioso, formalmente si applicano le sanzioni vigenti all’epoca. Tuttavia, un principio generale del diritto amministrativo sanzionatorio è la retroattività della norma più favorevole se non c’è giudicato (lo prevede l’art. 3 D.Lgs. 472/97). Quindi, se sei in causa per infedele e la legge ora prevede 70% anziché 100-180%, potresti chiedere al giudice di applicare la sanzione nella misura più favorevole. Già alcune CTP/CTR nel 2024 hanno cominciato a rimodulare le sanzioni secondo la novella (ad esempio, riducendo sanzioni 2018 al 70%). Questo può avere impatto concreto riducendo del ~20% l’importo sanzionatorio in molti contenziosi pendenti.
Prassi 2024-2025 dell’Agenzia delle Entrate: l’Agenzia, attraverso le risposte a interpello e le circolari, ha fornito chiarimenti su vari aspetti rilevanti per le royalties:
- La Risposta a interpello n. 361/2023 (giugno 2023) ha fatto luce sul trattamento fiscale di contratti misti riguardanti software. Nel caso esaminato, dopo la cessione di un software, se i diritti trasferiti al cliente sono equivalenti a quelli su una normale copia per uso personale, i compensi non vanno qualificati come royalties bensì come corrispettivi d’impresa (software acquistato) . Questo interpello conferma il distinguo di cui abbiamo parlato: licenze d’uso “standard” v. royalties su IP. Dunque, le aziende devono analizzare attentamente i contratti software: se vendono il software senza licenza di sfruttamento economico, i pagamenti non generano royalty (niente ritenute, niente quadro RL per persona fisica, ma ordinario ricavo).
- La Risoluzione 32/E/2021 e la Risposta 407/2022 (richiamate in prassi) hanno affrontato il tema del beneficiario effettivo nelle catene di sub-licensing. In particolare, l’Amministrazione ha rifiutato l’aliquota ridotta convenzionale quando la royalty passa per una società intermedia che non è beneficial owner (es. caso di artista italiano che aveva creato struttura estera: Risposta interpello 493/2020, citata in dottrina, dove venne confermata la tassazione piena in Italia perché la società estera non era beneficial owner) . Nel 2023 l’Agenzia ha mantenuto ferma questa posizione: chi vuole l’aliquota agevolata deve dimostrare chi è il beneficial owner e che quest’ultimo ha diritto al trattato. Allo stesso tempo, è stata ribadita la necessità di certificare la residenza estera del percettore per applicare la convenzione (Provv. 43999/2021).
- Attività di controllo intensificata su redditi esteri: i documenti di programmazione dell’AdE per il 2024 evidenziano un focus sui redditi di fonte estera non dichiarati, grazie all’enorme mole di dati CRS arrivate. In particolare, sono menzionati controlli su “nuovi modelli di business digitale”. Ciò include i ricavi da piattaforme online (YouTube, Spotify, Amazon KDP, ecc.) che spesso si configurano come royalties o diritti d’autore. Aspettiamoci dunque lettere di compliance mirate a creators e titolari di IP digitali. Ad esempio, notizie di stampa indicano che a fine 2024 l’AdE ha inviato migliaia di avvisi bonari a influencer e autori di contenuti per verificare se hanno dichiarato i proventi da piattaforme (non di rado incassati su conti esteri). Chi rientra in queste categorie dovrebbe affrettarsi a regolarizzare eventuali compensi dimenticati. L’AdE sta anche usando algoritmi di text mining su registri pubblici: per dire, se hai depositato un brevetto e poi non risulti avere redditi da esso ma l’hai concesso in licenza ad altri (che magari deducono il costo), è probabile che scatti un alert.
- Novità internazionali: a livello OCSE sono in corso lavori sul Pillar One e Pillar Two che riguardano la tassazione minima e la ripartizione di profitti delle multinazionali digitali. Questi non impattano direttamente la tassazione delle royalties del singolo, ma creeranno contesto: le multinazionali con IP potrebbero spostare meno profitti in giurisdizioni a bassa tassazione per via della minimum tax (15%). Quindi, in futuro, potremmo vedere meno strutture aggressive di royalty routing. Per l’Italia, rileva l’adesione all’Instrument Multilaterale OCSE (MLI) che è in vigore: esso ha introdotto clausole antiabuso generali nei trattati (Principal Purpose Test) e specifiche su tie-breaker e altri aspetti. Quindi, una pianificazione basata su trattati che non abbia sostanza rischia comunque di essere contrastata col PPT.
- Caso pratico 2024 (beneficial owner – Cassazione 2025): A inizio 2025 è stata pubblicata una sentenza di Cassazione (n. 4427/2025) in tema di interessi passivi infragruppo, in cui la Suprema Corte ha di fatto riconosciuto l’approccio look-through e il disconoscimento dei trattati in caso di conduit (Danish cases). Questo, pur riferito agli interessi, di riflesso conferma la linea restrittiva per le royalties: la Cassazione è allineata con l’orientamento anti-abuso europeo. Ciò significa che se un caso di royalties in Cassazione presentasse fatti analoghi (società conduit), è probabile che la Cassazione negherebbe l’aliquota di trattato se c’è evidenza di conduit. Tuttavia – come ricordato – la novità è che ora pretendono la prova concreta dell’abuso da parte del Fisco. Ecco perché è cruciale la dimensione probatoria in questi casi.
In conclusione su questo fronte, il periodo 2024-2025 porta con sé maggiori responsabilità per i contribuenti ma anche più chiarezza e qualche opportunità: dovremo adattarci a regole più stringenti (fine del 25% generalizzato sui marchi, enfasi su beneficiario effettivo), ma beneficeremo di sanzioni ridotte e di un contesto giurisprudenziale più equo (onere del Fisco in temi di abuso, riconoscimento di buonafede se documentata). Per chi opera con beni immateriali, rimane valido il consiglio di curare la pianificazione: in caso di dubbio su come tassare una royalty, meglio interpellare prima l’Agenzia (interpello ordinario o per nuovi investimenti) piuttosto che rischiare sanzioni dopo. Inoltre, strumenti preventivi come gli APA bilaterali possono risolvere a monte questioni di transfer pricing su royalties infragruppo, fornendo certezza e protezione.
Domande frequenti (FAQ) e risposte
D: Cosa si intende esattamente per “royalty” ai fini fiscali, e quando un compenso rientra in questa categoria?
R: In generale, royalty è ogni somma periodica corrisposta per l’utilizzo di un asset intangibile di proprietà altrui. Ai fini fiscali, la definizione può variare leggermente a seconda delle norme: l’art. 12 dei trattati internazionali e il Modello OCSE includono nei “canoni” i pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l’uso (o la concessione in uso) di un copyright, di un brevetto, di un marchio, di un disegno o modello, di una formula segreta, e simili diritti . Rientrano anche i pagamenti per informazioni industriali/commerciali segrete (il know-how). Non sono invece considerate royalties le somme pagate per la compravendita di beni materiali, né i compensi per servizi generici (consulenze, prestazioni d’opera non legate a concessione di diritti) – anche se a volte la distinzione è sottile. Un esempio emblematico: la licenza d’uso di un software standard venduto in scatola o scaricato online è equiparata a una cessione di bene e non a una royalty (perché l’utente finale non acquisisce un diritto di sfruttamento economico, ma solo l’uso personale) . Quindi, un compenso è fiscalmente una royalty se paga il diritto di sfruttare un bene immateriale (al di là del mero godimento personale), di cui la controparte è proprietaria o titolare. Rientrano nel concetto di royalty anche i corrispettivi di franchising (in quanto includono l’uso di insegne e know-how). Identificare correttamente se un compenso è royalty è cruciale: incide sulle ritenute alla fonte da applicare e sulla tassazione nei diversi Stati. Se erroneamente classifichi come “servizio” qualcosa che è royalty, rischi di non applicare una ritenuta dovuta, e viceversa.
D: Come vengono tassate le royalties in Italia, sia per chi le percepisce che per chi le paga?
R: Dipende dalla natura giuridica di chi percepisce la royalty e dal rapporto tra le parti: – Per il percettore residente: – Se è un’impresa (società o ditta individuale) o un lavoratore autonomo professionista, le royalties percepite rientrano nel reddito d’impresa/professionale ordinario. Sono sommate agli altri ricavi e tassate con IRES/IRPEF secondo le aliquote ordinarie (24% IRES per le società, IRPEF progressiva per imprenditori individuali/professionisti). Se svolge attività soggetta a IRAP, concorreranno anche alla base IRAP. Chi paga la royalty (se anch’esso italiano) in questo caso applica di solito una ritenuta d’acconto: ad esempio, se il percettore è un professionista o un autore che emette fattura, si applica la ritenuta del 20% a titolo d’acconto IRPEF . La ritenuta sarà scomputata dall’imposta dovuta dal percettore in sede di dichiarazione. – Se è una persona fisica privata (non in regime di impresa o professionale), ad esempio un autore o inventore che sfrutta le proprie opere, le royalties sono classificate come redditi di lavoro autonomo occasionale da diritto d’autore/brevetto. Godono della citata deduzione forfettaria (25% o 40% se under 35) a titolo di spese forfettarie . Solo il residuo tassabile concorre all’IRPEF. Anche qui, chi eroga il compenso opera una ritenuta d’acconto del 20% (in alcuni casi del 30% se il beneficiario non ha partita IVA e il diritto non rientra nell’art. 53, ma per semplificazione consideriamo 20%). Esempio: Autore over 35 riceve €10.000 di royalty: l’editore trattiene €2.000 (20%) come ritenuta d’acconto IRPEF, l’autore dichiara €7.500 (il 75% netto) come reddito imponibile , su cui calcolerà l’IRPEF dovuta (sottraendo la ritenuta come credito). – Se è un soggetto diverso dall’autore (es. un erede che percepisce royalty di opere altrui, o chi ha comprato un brevetto e lo licenzia), in linea generale quei compensi per il percettore sono redditi di capitale. Ad esempio, i canoni percepiti dall’erede di uno scrittore vengono di solito trattati come redditi di capitale tassati interamente IRPEF (senza abbattimenti, perché l’abbattimento è riservato agli autori originari). In questi casi chi paga può applicare una ritenuta d’acconto (spesso 20%). Bisogna però valutare caso per caso: la normativa non contempla espressamente tutti gli scenari, e l’Agenzia in alcuni interpelli ha dato qualificazioni specifiche.
- Per il percettore non residente: se la royalty proviene dall’Italia, l’Italia in genere trattiene alla fonte una ritenuta del 30% a titolo d’imposta (imposta definitiva) sul 100% del compenso, salvo convenzioni. Eccezione: taluni compensi per diritti d’autore verso non residenti godono per legge dell’abbattimento del 25%, e quindi la ritenuta 30% si applica sul 75% (questo ad esempio avviene per i diritti d’autore pagati a persone fisiche non residenti, equiparandoli al regime interno) . Le convenzioni internazionali generalmente riducono l’aliquota: tipicamente al 5-10%, in alcuni casi 0% su certe royalties (es. trattato Italia-UK pre-Brexit prevedeva 8%, Italia-Svizzera 5%, Italia-Germania 0% su diritti d’autore) . Pertanto, chi paga dall’Italia a un estero deve: ottenere un certificato di residenza fiscale estera dal percettore, applicare l’aliquota convenzionale se esiste trattato e i requisiti (es. beneficiario effettivo) sono soddisfatti, altrimenti applicare l’aliquota domestica 30% . Il non residente con quella ritenuta esaurisce il suo obbligo in Italia (trattandosi di imposta definitiva, non deve presentare dichiarazione qui, salvo opti per tassazione ordinaria se gli conviene, cosa rara).
- Per chi paga (sostituto d’imposta italiano): la royalty corrisposta è in linea di massima un costo deducibile dal reddito d’impresa (o dal reddito di lavoro autonomo se un professionista paga diritti per usare un’opera, ad esempio un architetto che paga royalties per usare un software CAD brevettato). La deducibilità è però subordinata alle regole generali: principio di inerenza e competenza. Deve cioè essere un costo correlato all’attività produttiva e di competenza dell’anno (non puoi dedurre anticipatamente più anni se non rispettando regole di ammortamento se del caso). Se la royalty è pagata a un non residente, fino al 2015 c’erano restrizioni se l’altra parte era in paradiso fiscale (come detto, ora abrogate, rimane solo la disciplina CFC se hai partecipazioni estere). Quindi oggi: la società italiana deduce la royalty al lordo dell’eventuale ritenuta versata allo Stato (perché quella ritenuta è un tributo, non un ricavo per l’estero). Attenzione: se successivamente il Fisco disconosce parte della royalty (perché “non inerente”), quella porzione diventa indeducibile e quindi ricalcola l’utile tassabile su cui paghi imposte e pure eventuale IRAP . Quindi un costo royalty non inerente comporta tassazione di quel valore come reddito. Sul fronte IVA: le royalties per l’uso di beni immateriali di regola sono considerate compensi per prestazioni di servizi; se rese da non residenti a soggetti IVA italiani scatta il reverse charge (il che è neutro se detraibile). Ma spesso i canoni IP sono fuori campo IVA per mancanza di territorialità (dipende se l’utilizzo avviene in Italia ecc.). Le royalties intragruppo tra società UE qualificate erano esenti da ritenuta per direttiva, come detto; ora con l’uscita del UK occorre applicare il trattato UK (es. 8%).
Riassumendo: – Chi incassa royalties in Italia le dichiara come reddito d’impresa/professione (tassazione ordinaria) o come reddito di lavoro autonomo occasionale (con abbattimento se autore). – Chi paga royalties dall’Italia: se paga a residente, funge da sostituto d’imposta con ritenuta d’acconto 20%; se paga a non residente, applica ritenuta a titolo d’imposta 30% (o minore per trattato/direttiva), e deduce il costo al lordo.
D: Quali documenti e prove devo raccogliere per difendere la deducibilità di una royalty infragruppo contestata dal Fisco?
R: È fondamentale predisporre un pacchetto documentale completo. In caso di verifica o processo, dovresti poter esibire almeno: – Contratto di licenza tra le parti correlate: deve mostrare che la transazione era pianificata e trasparente (data certa, firma di entrambe le società). Un contratto dettagliato che illustra il perché della royalty (es. concessione di marchio per espansione commerciale) e il come (metodo di calcolo, percentuali, etc.) è la prima linea di difesa . Se il contratto è successivo ai pagamenti, il Fisco potrebbe considerarlo di comodo, ma è sempre meglio averlo che non aver nulla. – Documentazione di transfer pricing: se parliamo di società di un gruppo multinazionale, dovresti aver predisposto il Masterfile e Documentazione Nazionale ogni anno (o quantomeno per gli anni contestati). Consegnarli al Fisco (se non lo hai fatto durante la verifica) è cruciale per ottenere la penalty protection (niente sanzioni su eventuali rettifiche). Inoltre, il contenuto stesso dei documenti TP può convincere sul merito: se nel Local File c’è uno studio di comparables che giustifica il tasso di royalty, allegalo e spiega i risultati . Talvolta le aziende trascurano di allegare la doc. TP in causa pensando valga solo per le sanzioni: invece può essere usata come prova tecnica a sostegno della congruità. – Prove del servizio/bene reso: ad esempio, se la royalty è per know-how tecnico fornito dalla casa madre, produci i manuali, i report, le e-mail con cui ti hanno trasmesso le informazioni, eventuali testimonianze di tecnici che hanno interagito . Se è per l’uso di un marchio, mostra i materiali di marketing col marchio e come il marchio ha beneficiato l’azienda (grafici di vendite pre/post introduzione del marchio). Se è per supporto tecnico incluso nella royalty, porta la corrispondenza in cui la consociata estera ti forniva assistenza, le trasferte di personale per training, etc. L’obiettivo è far vedere che non stavi pagando a vuoto: c’era un vantaggio concreto per la tua azienda. – Analisi finanziarie: come detto, prepara un prospetto che inquadri la royalty rispetto ai numeri aziendali. Ad esempio, “Royalty = 5% del fatturato, pari a 500k su 10 mln vendite; grazie al marchio, il margine di contribuzione è aumentato del 3%, generando utili di 300k, quindi costo giustificato”. Sono semplificazioni, ma aiutano il giudice a capire. Se contesti un valore normale imposto dal Fisco, proponi tu un calcolo alternativo con criteri più appropriati. Mostra eventualmente simulazioni: “Se avessimo applicato 2%, i nostri utili sarebbero aumentati di X ma la casa madre avrebbe perso Y; considerato che la casa madre paga tasse al 25% in Francia, non c’era interesse a spostare utili di Q per risparmiare 1-2 punti percentuali” – questo discorso evidenzia la mancanza di elusività. – Documenti societari: delibere del CDA che approvano il contratto di licenza, verbali interni in cui si discute della royalty (magari comparando più alternative), sono molto utili. Indicano che la decisione fu presa seriamente, non tanto per ridurre le tasse . – Consulenze terze: se hai studi di consulenti esterni (legali, fiscali) fatti prima o durante l’implementazione della royalty, produci quelli (attenzione però: se emergesse che l’unico scopo suggerito dal consulente era “ottimizziamo le tasse spostando utili via royalty”, meglio valutare l’uso, perché potrebbe rivoltarsi contro). Ma se la consulenza era: “il valore di mercato del marchio secondo perizia è tot e un giusto canone annuale è 5%”, allora presentala senz’altro.
In sintesi, più il dossier mostra coerenza economica e buona fede contrattuale, più chances hai di annullare o ridurre l’accertamento . Nei casi di successo, i contribuenti avevano spesso predisposto contratti, studi comparativi, e magari già una APA. Se invece improvvisi giustificazioni solo a posteriori senza pezze d’appoggio, la difesa è debole. Vale la pena investire in documentazione durante la vita aziendale, non solo ex post: questo è un messaggio anche per gli imprenditori che leggono – dotarsi di contratti e studi solidi prima di applicare royalty infragruppo è la migliore prevenzione.
D: L’Agenzia delle Entrate mi contesta che la mia azienda ha pagato una royalty “troppo alta” alla casa madre estera e l’ha arbitrariamente ridotta al 2% del fatturato (mentre noi pagavamo 5%). Posso difendermi sostenendo che quel 5% era giustificato dal mercato?
R: Assolutamente sì, e anzi è la tua linea di difesa principale. Come spiegato, la “regola” del 2%-5% è solo indicativa, non è legge. La Cassazione stessa (ord. 12846/2022) ha affermato che superare il 5% è lecito se giustificato da circostanze specifiche. Dovrai però fornire evidenze concrete per persuadere che il 5% era congruo. In pratica: – Porta analisi di settore comparabili: ad esempio, studi di società di consulenza o banche dati che mostrino range di royalty nel tuo settore merceologico. Se operi nel fashion luxury, potresti dimostrare che royalties del 5-7% non sono affatto inusuali per l’uso di marchi di alta gamma. Pubblicazioni su accordi di licenza di brand famosi possono servire. Anche documenti interni di gruppo che citano quali parametri di mercato avete considerato. L’ideale è avere un Transfer Pricing report che includa un benchmark di contratti comparabili: quello sarebbe oro colato come prova. – Spezzare la royalty se includeva servizi: spesso le case madri forniscono non solo il marchio ma anche supporto marketing, formazione, ricerca e sviluppo, ecc. Se la tua casa madre forniva qualcos’altro, evidenzialo e quantifica: “Di quel 5%, stimiamo che 2% remunerava servizi di supporto marketing (che se no avremmo dovuto comprare sul mercato), e 3% era strettamente per l’uso del marchio”. Così il 3% appare più ragionevole isolatamente (e il 2% per servizi è deducibile anch’esso, e comunque giustificato). – Metti in luce le specificità contrattuali: ad esempio, avevi ottenuto l’esclusiva territoriale per l’uso del marchio? L’esclusiva aumenta il valore della licenza, perché ti garantisce vantaggi monopolistici in quel paese. Oppure: il marchio era già affermato globalmente grazie a investimenti del licenziante? Se sì, tu stai pagando per sfruttare un asset di grande richiamo – normale che costi di più rispetto a un marchio sconosciuto. Ogni elemento unico del tuo caso dev’essere spiegato al giudice. – Argomento anti-elusivo: se l’Agenzia insinua che quel +3% fosse solo per spostare utili all’estero, evidenzia la situazione fiscale estera: se la consociata estera paga aliquota piena su quei profitti (metti 25% in Francia), non c’è un gran risparmio d’imposta di gruppo – quindi non c’era un fine elusivo primario, ma era una politica di business. Questo toglie forza al movente di evasione. Diverso se l’estero era un tax haven al 0%, ma se è in UE a tassazione normale, sottolinealo. – Comportamento del Fisco in altri anni: se per dire nel 2019 e 2020 avete applicato 5% e non vi hanno contestato nulla, e poi improvvisamente contestano 2018, mettete in luce la contraddizione. Mostrare una coerenza di comportamento nel gruppo aiuta: “applichiamo 5% da anni su base di policy internazionale, non è stato inventato quell’anno lì per spostare utili occasionalmente”. – Se avete ridotto volontariamente la royalty negli anni successivi (magari proprio perché contestata), spiegate che era per venire incontro alle richieste ma che ritenete il 5% originario ancora difendibile – non è una colpa cambiar politica, ma va argomentato.
In generale, sì: difendersi è possibile e spesso le Corti Tributarie danno ragione al contribuente se questi prova bene le sue ragioni economiche . Ricorda: “non subire passivamente il 2%” è quasi uno slogan a questo punto. Porta la discussione su qual è il vero valore normale giusto. Se dimostri che il 5% rientra in un range di mercato o comunque ha una logica nella vostra situazione, hai buone chance di far annullare o fortemente ridurre la pretesa. Anzi, proprio argomentando così si possono convincere i funzionari in adesione o i giudici in sentenza a ridurre, ad esempio, riconoscendo deducibile magari fino al 4% e tassando solo l’eccedenza, oppure annullando del tutto la ripresa (Cass. 12846/22 alla fine ha dato integralmente ragione al contribuente in un caso del genere, riconoscendo l’intero 5,6% deducibile). Certo, servono prove: asserire soltanto “è di mercato” senza portare dati rischia di non bastare.
D: La mia società non ha trattenuto la ritenuta del 0% sulle royalties pagate alla consociata UE perché sfruttava l’esenzione da direttiva, ma ora l’Agenzia dice che quella consociata non aveva i requisiti di beneficiario effettivo. Cosa posso fare?
R: Questo scenario riflette un’accusa di abuso di trattato/direttiva. In pratica l’AdE sostiene che la società consociata UE era un “filtro” per far arrivare i soldi magari alla holding extra-UE, e quindi nega l’esenzione e vorrebbe la ritenuta del 30% non applicata. La difesa deve concentrarsi su provare che la consociata UE ha sostanza e ruolo economico proprio, non è una conduit. In particolare: – Dimostra la sostanza operativa della consociata UE: spiega quale attività reale svolge. Esempio: “La consociata in Olanda gestisce i nostri marchi in Europa, ha uffici e dipendenti, non è una società vuota” – e allega prove: bilanci che mostrano costi del personale, foto degli uffici, sito internet aziendale, organigramma con funzioni . Se la società tiene registrato il marchio e cura centralmente la pubblicità europea, sottolinealo. – Confuta l’ipotesi di retrocessione immediata dei fondi: l’Agenzia probabilmente sostiene che la consociata UE ha girato i soldi alla capogruppo extra-UE (classico schema treaty shopping). Mostra che non c’è stato un flusso in uscita di pari importo subito dopo. Ad esempio, produci l’estratto conto della consociata: se le entrate royalty sono rimaste lì o sono state spese per la sua attività, evidenziarlo. Se una parte è stata distribuita come dividendo alla holding, far notare la differenza temporale (es. un anno dopo, e solo il 50%, quindi non un passthrough immediato) . Se addirittura nulla è stato ridistribuito, tanto meglio: vuol dire che i soldi restano alla consociata e finanziano le sue operazioni, indice chiaro di sostanza. – Ricorda il regime convenzionale “look-through”: se anche ipoteticamente il beneficiario effettivo fosse la holding extra-UE, individua quale sarebbe stata l’aliquota di trattato su quella (es. USA 5% su diritto autore, 8% su canoni industriali). Se quell’aliquota non è troppo diversa, sottolinea che comunque l’intento elusivo è minimo. Ad esempio: “Anche supponendo che la beneficiaria effettiva fosse la nostra parent company USA, il trattato Italia-USA avrebbe applicato un’aliquota dell’8%. Noi in Italia abbiamo applicato 0% per direttiva UE su Olanda; la differenza è minima (8 punti), e soprattutto la consociata Olanda ha tassato gli utili al 25%. Quindi non c’era un disegno di risparmio fiscale significativo, semmai organizzativo” . Questo argomento fu riconosciuto validamente dalla CTR Emilia 2023 (che disse: se anche beneficial owner fosse USA, l’Italia avrebbe preteso solo 8%; quindi non stiamo parlando di evasione totale, al limite di 3 punti percentuali). – Onere della prova in capo al Fisco: come rimarcato, richiama l’art. 7, co.5-bis D.Lgs. 546/92 e giurisprudenza (Cass. 19150/2022 per es.) che dicono: è il Fisco che deve provare l’abuso. Quindi se l’AdE non porta elementi concreti (se non illazioni), chiedi al giudice di dare atto che l’onere probatorio non è stato assolto. Tu nel frattempo hai portato prova contraria (sostanza, niente retropagamenti) quindi l’accusa di abuso cade. – Possibile conciliazione su sanzione ritenuta: una difesa parallela: qualora malauguratamente il giudice ritenesse dovuta la ritenuta (quindi tu hai sbagliato a non farla), insisti almeno sul fatto che avevi predisposto la documentazione di transfer pricing e che c’era obiettiva incertezza, quindi la sanzione del 20% per omessa ritenuta non andrebbe applicata (o quantomeno ridotta). Es. potresti argomentare che la penalty protection del 4-ter art.2 D.Lgs.471/97 dovrebbe estendersi anche a questa fattispecie, come da dottrina . Non è garantito sia accolto, ma può servire a ridurre il danno.
In sintesi: difenditi sul fatto (sostanza, no conduit) e sul diritto (onere del fisco, look-through non può peggiorare la tua posizione se rispetti trattati). Se la tua consociata UE è veramente una holding letterbox senza personale, la difesa è molto ardua – potresti puntare allora su un componimento: offrire di pagare la ritenuta del 5-10% (pari al trattato del beneficiario effettivo) in conciliazione, evitando il 30%. A volte l’AdE accetta accordi del genere in appello per evitare rischi. Ma se la consociata UE ha un minimo di sostanza, crediamo sia possibile vincere la contestazione citando anche la CTR favorevole.
D: Ho scoperto di non aver dichiarato royalties estere negli anni scorsi. Posso ancora rimediare ed evitare sanzioni gravi?
R: Sì, finché non sei oggetto di un accertamento formale, puoi utilizzare il ravvedimento operoso e la dichiarazione integrativa. Devi presentare una dichiarazione integrativa per ciascun anno in cui hai omesso le royalties (finché è nei termini: il ravvedimento è ammesso entro il termine di accertamento, quindi per il 2018 ad esempio fino al 31/12/2024). Pagherai la maggiore imposta dovuta su quelle royalties, gli interessi legali e la sanzione ridotta. La sanzione ridotta dipende da quando ravvedi: se sono trascorsi ad es. 2-3 anni, la riduzione è a 1/8 del minimo (cioè circa il 12% dell’imposta invece che 90-180%). Dopo il 1/9/2024, con la nuova norma, la sanzione base è 70%, quindi 1/8 di 70% = 8.75%. Ad esempio, su €10.000 di imposta evasa, la sanzione ravveduta potrebbe essere solo €875, anziché €9.000-18.000. Conviene farlo il prima possibile perché ogni anno la finestra di riduzione si restringe (entro 2 anni è 1/7, oltre 2 anni 1/6, etc. – queste percentuali sono pre-riforma, potrebbero cambiare con nuovi decreti ma il concetto rimane).
In pratica, sì, puoi metterti in regola spontaneamente e pagare molto meno di quanto pagheresti se ti accertano. Inoltre, il ravvedimento sterilizza il rischio penale (perché se paghi tutto prima che ti contestino, l’imposta evasa non è più “evasa” al momento del giudizio penale, in genere la soglia di punibilità non viene considerata superata).
Da notare: se le royalties erano incassate su conti esteri, c’è anche l’omessa compilazione del Quadro RW. Anche quella si può ravvedere, pagando la sanzione sul monitoraggio con riduzione. Ad esempio, invece del 15% del valore, potresti pagare il 3% se ravvedi tardivamente (qui la riduzione è 1/6 se oltre l’anno). Le sanzioni RW non sono condonabili per definizioni, quindi ravvederle è l’unico modo per abbassarle.
In passato c’erano le Voluntary Disclosure (2015 e 2017) per sanare in blocco capitali esteri: oggi non c’è un programma aperto di VD, ma non ce n’è bisogno se l’unica cosa è reddito omesso. Basta l’integrativa.
Procedi così: fai calcolare da un commercialista la maggiore imposta IRPEF/IRES dovuta su quelle royalties (magari hai anche diritto a credito per ritenute estere subite: ricorda di includerlo perché col ravvedimento puoi far valere il credito, a differenza di quando sei accertato che spesso lo perdi ). Poi compila F24 con imposta, interessi e sanzione ridotta (ci sono codici tributo appositi). Se gli importi sono grossi, valuta di autodenunciarti all’Agenzia con una istanza di adesione sui medesimi (non obbligatorio: il ravvedimento è atto unilaterale).
Assicurati di fare tutto prima che ti arrivi un qualsiasi atto (anche solo un questionario nominativo incentrato su quell’anno potrebbe precludere il ravvedimento completo su quell’aspetto). Quindi agisci spontaneamente e tempestivamente.
D: In caso di verifica fiscale sulle royalties, a cosa devo prestare più attenzione per evitare contestazioni?
R: Prevenire è meglio che curare. Ecco alcuni consigli pratici: – Tenere in ordine i contratti: come ribadito più volte, ogni royalty pagata o ricevuta deve avere un contratto (o documento) che la supporta. Non esitare a registrare i contratti di licenza, specie se tra parti correlate: dà data certa e opponibilità a terzi. – Allineare la contabilità al contratto: assicurati che i conti transitori, le fatture emesse/ricevute corrispondano esattamente a quanto previsto. Evita di fare pagamenti di importo tondo “a piacere” alla fine dell’anno senza documenti: solleva bandiere rosse. – Transfer pricing documentation: se fai parte di un gruppo internazionale e hai royalties infragruppo, predisponi sempre la documentazione TP e soprattutto spunta la casella in dichiarazione dei redditi (quella ti salva da sanzioni). Investire in uno studio comparativo professionale sul royalty rate vale la pena: costa meno di una causa tributaria e fornisce tranquillità. – Monitoraggio fiscale: se incassi su conti esteri, dichiara tali conti in RW e dichiara i redditi in Redditi Estero. Molte contestazioni sui redditi esteri partono proprio dalla mancata indicazione in RW (è come un segnale: “forse nasconde redditi”). – Pagamenti esteri: se sei un’azienda italiana e paghi fuori, chiedi sempre un certificato di residenza fiscale al beneficiario prima di applicare l’aliquota ridotta da trattato. Senza quel foglio, l’Agenzia in sede di verifica contesta quasi automaticamente la mancata ritenuta piena. E verifica il requisito di beneficial owner: se paghi a una consociata, assicurati che questa sia la beneficiaria effettiva. Se i fondi passeranno subito oltre, valuta di applicare comunque la ritenuta domestica e poi far chiedere rimborso via convenzione (procedura complessa, ma a volte più sicura). – Conserva la corrispondenza: e-mail con l’estero in cui discutete di royalty, meeting minutes ecc. Tutto potrebbe tornare utile. Meglio archiviare bene per anno queste comunicazioni. Ricordati che in giudizio tributario non c’è discovery come nei film americani: devi essere tu a esibire le prove a tua discolpa. – Consulta professionisti su novità legislative: ad esempio, con la nuova legge che esclude i marchi dall’abbattimento, se sei un privato che incassa royalty di marchio, studia se conviene creare una società per incassarle (che pagherà IRES e poi dividendi, piuttosto che IRPEF piena su persona fisica, a seconda dei casi). Le normative cambiano e quello che era vantaggioso ieri (es. tenere il marchio come persona fisica) oggi potrebbe non esserlo più. – Strumenti preventivi: per operazioni importanti, valuta l’interpello all’Agenzia. Ad esempio, se stai per iniziare a incassare royalty da un certo schema estero e non sei sicuro di come verrà visto, fai un interpello illustrando la situazione (è un costo di tempo, ma può darti protezione totale su sanzioni se segui la risposta). Oppure se hai un gruppo con tante transazioni IP, considera un APA bilaterale con l’altro Stato sulle politiche di TP: è lungo e costoso, ma toglie dall’agenda le dispute (per 5 anni hai la certezza del Fisco sul tasso). – Formazione interna: se sei un’impresa, forma chi si occupa di fatture estere sui concetti di ritenuta, trattati, requisiti. Spesso gli errori succedono perché chi fa i pagamenti non era a conoscenza: es. l’accountant paga €100k a un tizio in Svizzera per licenza musicale senza applicare ritenuta perché nessuno gli ha detto di farlo. Poi arriva la contestazione e la società paga 30k di imposta, 20% sanzione e interessi. La conoscenza può evitare errori banali.
Seguendo queste accortezze, ridurrai drasticamente la probabilità di contenzioso. E se anche arrivasse un controllo, potrai affrontarlo con maggiore serenità e cooperative compliance, magari chiudendolo sul nascere.
In definitiva, trasparenza e documentazione sono le migliori armi: un contribuente che documenta tutto e adotta prezzi di mercato di solito riesce a difendersi con successo, come abbiamo visto nei vari esempi e sentenze. Viceversa, manovre opache o eccessivamente aggressive finiscono per essere scoperte e sanzionate, spesso con esiti peggiori del risparmio ottenuto.
Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la mancata dichiarazione di royalties o compensi da diritti d’autore, brevetti, marchi o concessioni d’uso? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un’intimazione o un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate perché ti viene contestata la mancata dichiarazione di royalties o compensi da diritti d’autore, brevetti, marchi o concessioni d’uso?
👉 È una situazione sempre più frequente, soprattutto per professionisti, artisti, autori, inventori e aziende che percepiscono redditi da licenze o proprietà intellettuali, anche tramite piattaforme o società estere.
La buona notizia è che, se agisci per tempo e con una difesa tecnica adeguata, puoi impugnare l’accertamento, dimostrare la correttezza fiscale della tua posizione o ottenere la riduzione delle sanzioni.
In questa guida vedremo come funziona la tassazione delle royalties in Italia, perché può scattare l’accertamento e quali strategie legali adottare per difenderti.
⚖️ Cosa sono le royalties e come vengono tassate
Le royalties sono i compensi percepiti per la concessione in uso di opere dell’ingegno, marchi, brevetti, software, format, licenze o know-how.
📌 Fiscalmente, possono derivare da diverse fonti:
- diritti d’autore su opere artistiche, musicali o letterarie;
- licenze o concessioni d’uso di marchi, brevetti, invenzioni o software;
- contratti di franchising o licensing commerciale;
- utilizzo di diritti d’immagine o format televisivi.
Secondo l’art. 53 e 67 del TUIR (D.P.R. 917/1986), le royalties possono rientrare:
- nei redditi di lavoro autonomo (se derivano da attività professionale o artistica);
- oppure nei redditi diversi, se percepite in modo occasionale o da soggetti non professionisti.
📜 Cosa succede in caso di mancata dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento se rileva che:
- hai incassato royalties non dichiarate nel Modello Redditi;
- esistono bonifici, contratti o fatture che dimostrano compensi non riportati;
- hai percepito royalties da società estere (Google, Spotify, YouTube, piattaforme online, SIAE estere, ecc.);
- non hai dichiarato redditi di fonte estera, pur essendo fiscalmente residente in Italia.
📌 In questi casi, l’Agenzia presume che si tratti di redditi imponibili non dichiarati e procede a:
- calcolare la maggiore imposta dovuta;
- applicare sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa;
- aggiungere interessi di mora.
💡 I motivi più comuni di contestazione
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- mancata dichiarazione di redditi da piattaforme online (Spotify, YouTube, Amazon, Patreon, ecc.);
- royalties ricevute da società estere non comunicate tramite quadro RW;
- contratti di licenza o cessione di diritti non registrati correttamente;
- errore nella qualificazione del reddito (lavoro autonomo vs reddito diverso);
- doppia imposizione su redditi già tassati all’estero.
🧠 Cosa fare subito
✅ 1. Analizza attentamente l’accertamento ricevuto
Verifica:
- l’anno d’imposta contestato;
- le fonti da cui derivano le royalties;
- le prove utilizzate dall’Agenzia (bonifici, contratti, dati SIAE, scambi informativi esteri);
- la correttezza dei calcoli e delle sanzioni applicate.
👉 In molti casi, l’Agenzia presume un reddito imponibile anche senza prove certe: in questi casi, è possibile impugnare l’accertamento per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
✅ 2. Raccogli tutta la documentazione utile
Per difenderti, devi dimostrare che:
- le royalties non erano imponibili in Italia (perché già tassate all’estero);
- le somme non erano redditi, ma rimborsi o anticipi;
- i contratti di licenza o cessione sono stati correttamente dichiarati;
- i redditi sono già stati inclusi in altre categorie (es. reddito d’impresa).
📂 Documenti da raccogliere:
- contratti di licenza, cessione o sfruttamento;
- estratti conto bancari e bonifici;
- dichiarazioni fiscali italiane e, se applicabile, certificazioni fiscali estere;
- eventuale documentazione di tassazione estera (es. ritenute alla fonte).
✅ 3. Verifica la doppia imposizione internazionale
Se hai percepito royalties da un Paese estero con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione, puoi evitare di pagarci le tasse due volte.
L’Italia ha trattati in vigore con quasi tutti i Paesi OCSE.
📌 In base a tali convenzioni:
- le royalties sono tassate nel Paese di origine del reddito;
- in Italia, si applica un credito d’imposta per le imposte già pagate all’estero (art. 165 TUIR).
👉 In molti accertamenti, l’Agenzia non considera le ritenute già versate all’estero: in questi casi, è possibile ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa fiscale.
✅ 4. Richiedi l’annullamento in autotutela o impugna l’accertamento
Se l’accertamento contiene errori o manca di fondamento, puoi:
- presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate, allegando prove e spiegazioni;
- oppure, se l’atto è già definitivo, presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica.
Un avvocato tributarista può chiedere:
- la sospensione immediata del pagamento;
- l’annullamento totale o parziale dell’accertamento;
- il riconoscimento del credito d’imposta per le tasse estere già pagate.
✅ 5. Controlla i termini di decadenza dell’accertamento
L’Agenzia può notificare accertamenti entro:
- 5 anni dall’anno di imposta (ordinario);
- 7 anni in caso di omessa dichiarazione.
Se l’avviso arriva fuori termine, puoi eccepire la decadenza e far annullare l’atto.
📋 Documenti necessari per la difesa
- Copia dell’avviso di accertamento o della cartella.
- Contratti di licenza o cessione dei diritti.
- Dichiarazioni fiscali italiane e, se applicabile, estere.
- Estratti conto bancari e prove dei pagamenti.
- Certificazioni di ritenute o imposte già pagate all’estero.
- Comunicazioni con le piattaforme o le società pagatrici.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi del caso e documentazione: 1–2 settimane.
- Richiesta di autotutela: 30–90 giorni.
- Ricorso alla Corte Tributaria: entro 60 giorni dalla notifica.
- Decisione definitiva: 6–12 mesi medi.
🎯 Risultati concreti:
- Blocco delle richieste di pagamento.
- Riconoscimento della tassazione già avvenuta all’estero.
- Annullamento o riduzione dell’accertamento.
- Regolarizzazione della posizione fiscale.
⚖️ I vantaggi della difesa legale
✅ Eviti la doppia tassazione in Italia e all’estero.
✅ Dimostri la correttezza dei tuoi redditi dichiarati.
✅ Blocchi sanzioni e pignoramenti in via preventiva.
✅ Ottieni una riduzione delle somme dovute o la cancellazione dell’accertamento.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare la notifica dell’accertamento.
- Pagare subito senza verificare la correttezza dei calcoli.
- Non documentare l’origine e la natura delle royalties.
- Affidarsi a consulenti non esperti in diritto tributario internazionale.
- Superare i 60 giorni per proporre ricorso.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’accertamento e la documentazione fiscale.
📌 Verifica l’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
✍️ Predispone memorie difensive, istanze di autotutela o ricorsi tributari.
⚖️ Ti rappresenta davanti all’Agenzia delle Entrate e alla Corte Tributaria.
🔁 Ti assiste fino alla chiusura definitiva della controversia o alla cancellazione del debito fiscale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscale internazionale.
✔️ Specializzato nella difesa di professionisti, autori e imprese con redditi da royalties.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Un accertamento fiscale per mancata dichiarazione di royalties non va mai sottovalutato, ma può essere impugnato con successo se agisci in modo tempestivo e supportato da prove solide.
Con la giusta assistenza puoi dimostrare l’avvenuta tassazione all’estero, evitare la doppia imposizione e ottenere l’annullamento o la riduzione delle somme richieste.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro gli accertamenti fiscali sulle royalties comincia qui.