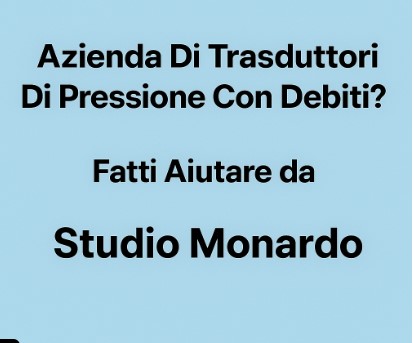Se la tua azienda produce, importa o distribuisce trasduttori di pressione, sensori piezoelettrici, sensori industriali, trasmettitori analogici/digitali, componenti per impianti oleodinamici, pneumatici o di processo, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare che l’attività venga compromessa.
Nel settore dei sensori e del controllo di processo, anche un piccolo fermo può bloccare impianti industriali dei clienti, causare ritardi produttivi, penali e perdita di contratti.
Perché le aziende di trasduttori di pressione accumulano debiti
- costi elevati di chip, membrane, elettronica di misura e componenti importati
- rincari dei semiconduttori e della componentistica digitale
- pagamenti lenti da parte di industrie, integratori e OEM
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti di scala, segnale e connessioni
- investimenti costanti in R&D, test di calibrazione, firmware e certificazioni
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far valutare l’intera situazione debitoria da un professionista competente
- verificare quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere i rapporti con fornitori critici e componenti essenziali
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di sensori, schede, microelettronica e componenti vitali
- fermo della produzione, test e calibrazione dei trasduttori
- impossibilità di consegnare o supportare i clienti
- perdita di integratori, industrie e costruttori di impianti
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
- bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
- ristrutturare o ridurre i debiti con strumenti normativi avanzati
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, componenti elettronici, strumenti e continuità produttiva
- evitare che la tua azienda arrivi alla chiusura
Agisci ora
Molte imprese non falliscono per i debiti, ma perché reagiscono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ridurre i debiti e salvare realmente la tua attività.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua azienda di trasduttori di pressione.
Introduzione
Una azienda produttrice di trasduttori di pressione che si trova sommersa dai debiti affronta sfide complesse e delicate. I debiti aziendali – siano essi verso banche, fornitori, Fisco o dipendenti – possono mettere a repentaglio la continuità dell’impresa e persino il patrimonio personale di imprenditori e amministratori se non gestiti correttamente. Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha profondamente riformato la materia della crisi d’impresa: a partire dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore dal luglio 2022, sono stati introdotti nuovi strumenti e procedure per aiutare le imprese in difficoltà a ristrutturare i debiti ed evitare il fallimento . Inoltre, aggiornamenti normativi recenti (come il c.d. “correttivo ter” del 2024) hanno ulteriormente perfezionato queste misure per renderle più efficaci e accessibili.
In questa guida affronteremo, dal punto di vista del debitore, come un’azienda manifatturiera (ad esempio una S.r.l. che produce sensori di pressione) possa difendersi dai creditori e risanare la propria posizione debitoria. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati interessati, fornendo un livello di approfondimento avanzato. Verranno esaminati i vari tipi di debito (bancari, fiscali, verso fornitori, dipendenti ecc.) e le possibili strategie di gestione per ciascuno. Illustreremo le principali soluzioni legali oggi disponibili – dalla composizione negoziata della crisi ai piani di risanamento attestati, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo – spiegando cosa fare per evitare il fallimento, ristrutturare i debiti e proteggere i beni personali.
Nel corso della trattazione forniremo anche tabelle riepilogative per confrontare strumenti e procedure, oltre a una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) e a simulazioni pratiche basate su casi tipici di una PMI in difficoltà. Infine, tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli saranno elencate in fondo alla guida, incluse le sentenze più aggiornate che chiariscono punti chiave della disciplina. L’obiettivo è offrire un quadro completo e aggiornato (ottobre 2025) su come un’azienda indebitata possa difendersi legalmente dai creditori e trovare una via di uscita sostenibile dalla crisi.
Nota: Le informazioni fornite riguardano esclusivamente la normativa italiana vigente e sono aggiornate alle ultime novità legislative e giurisprudenziali. Ogni situazione di crisi presenta peculiarità specifiche: è sempre consigliabile farsi assistere da professionisti qualificati (avvocati, commercialisti, esperti della crisi) per valutare le soluzioni più adatte al caso concreto.
Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi
Un’azienda può accumulare diverse tipologie di debiti, ognuna con caratteristiche e rischi propri. Comprendere la natura di ciascun debito è il primo passo per valutare le azioni difensive più efficaci. Ecco le principali categorie di debiti che una società produttrice di trasduttori di pressione (tipicamente una PMI industriale) potrebbe trovarsi ad affrontare:
- Debiti bancari e finanziari: derivano da mutui, finanziamenti, scoperti di conto, leasing. Sono spesso assistiti da garanzie reali (es. ipoteche su immobili, pegni su macchinari) o da garanzie personali (fideiussioni degli imprenditori). Il rischio principale è l’azione esecutiva da parte della banca (pignoramenti di beni, escussione delle garanzie) in caso di insolvenza. I crediti bancari privilegiati (garantiti) godono di prelazione sui beni dati in garanzia: ciò significa che la banca potrà soddisfarsi preferenzialmente su quegli asset. Inoltre, la presenza di fideiussioni comporta che, se la società non paga, la banca può aggredire direttamente il patrimonio personale del garante (titolare o amministratore). Una particolare attenzione va posta alle covenant finanziarie nei contratti di finanziamento: il mancato rispetto di indici di bilancio può far scattare la decadenza dal beneficio del termine rendendo immediatamente esigibile il debito.
- Debiti verso fornitori (commerciali): derivano da fatture non pagate per acquisto di materie prime, componenti elettronici, lavorazioni conto terzi, etc. I fornitori sono creditori chirografari (senza garanzie) e, se non pagati, possono interrompere le forniture essenziali mettendo in crisi la produzione. Possono inoltre agire legalmente per il recupero del credito (ingiunzioni di pagamento, pignoramenti). Un rischio rilevante è la possibile presentazione di un’istanza di fallimento: un creditore commerciale non soddisfatto, se il debito è significativo, può chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale) della società debitrice, qualora ritenga che quest’ultima versi in stato d’insolvenza. Va evidenziato che, secondo la legge, lo stato d’insolvenza è definito dall’incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (es. non pagare sistematicamente i debiti alle scadenze) – condizione che, se accertata dal tribunale, apre la strada alla procedura fallimentare.
- Debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali: includono IVA, imposte sui redditi, IRAP, tasse locali, nonché contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori (INPS, INAIL) relativi ai dipendenti. Questi debiti godono in parte di privilegi speciali o generali sui beni del debitore (ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate hanno privilegio generale sui mobili). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e gli enti previdenziali possono iscrivere ipoteche e fermi amministrativi, nonché avviare esecuzioni forzate (pignoramenti di conti correnti, macchinari, immobili) senza necessità di passare dal tribunale, grazie alla cartella esattoriale che è titolo esecutivo. Inoltre, alcuni omessi versamenti rilevano penalmente: ad esempio, il mancato versamento di IVA oltre una certa soglia (attualmente €250.000 annui) o il mancato versamento di ritenute previdenziali oltre €10.000 annui possono configurare reati tributari. Il rischio fiscale è dunque duplice: da un lato misure esecutive molto incisive, dall’altro conseguenze penali per gli amministratori in caso di inadempimenti di entità rilevante. È importante notare che, a differenza dei creditori privati, l’Erario e gli enti previdenziali sono soggetti a regole speciali quando si tratta di accordi di ristrutturazione: le cosiddette transazioni fiscali e contributive (di cui diremo oltre) consentono di trattare la parte pubblica del debito solo all’interno di specifiche procedure concordatarie o accordi omologati, mentre al di fuori di esse l’unica strada è ottenere dilazioni di pagamento secondo legge (fino a 6 anni o 10 anni in casi particolari) . Infatti, in via extragiudiziale non è possibile “stralciare” il debito tributario, ma solo rateizzarlo, e i margini di manovra sono più ristretti rispetto ai crediti privati.
- Debiti verso i dipendenti: riguardano retribuzioni arretrate, TFR, e altre spettanze non corrisposte. Questi crediti vantano un privilegio generale mobiliare di grado molto elevato e, per gli ultimi stipendi e TFR, anche un privilegio sul fondo di garanzia INPS. In caso di insolvenza, i lavoratori hanno diritto a essere soddisfatti con priorità rispetto ai creditori chirografari e la legge prevede il possibile intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR e ultime mensilità (il Fondo paga i lavoratori e si surroga poi nel credito in sede concorsuale). I dipendenti possono inoltre agire giudizialmente ottenendo decreti ingiuntivi e pignorando conti aziendali. Per l’imprenditore, i debiti verso dipendenti comportano anche rischi indiretti: ad esempio, malcontento interno, calo di produttività, scioperi o dimissioni dei lavoratori chiave. È dunque prioritario gestire con attenzione questo tipo di debito, anche perché in alcune procedure (come il concordato preventivo) certi crediti di lavoro devono essere soddisfatti integralmente se si vuole proseguire l’attività.
- Debiti verso altri enti e soggetti: ad esempio debiti verso fornitori di servizi (utenze, affitti di capannoni), verso soci finanziatori (finanziamenti infragruppo o soci), o verso partner commerciali. Ciascuno di essi può avere tutele diverse: i canoni di locazione non pagati possono portare allo sfratto e alla perdita dell’immobile aziendale; i finanziamenti soci possono essere postergati (i soci vengono rimborsati dopo tutti gli altri creditori ex art. 2467 c.c.). Anche enti pubblici non fiscali (ad esempio i Comuni, per tasse locali come IMU, TARI) vantano privilegi e poteri di riscossione coattiva. Da notare che con le novità legislative è stata ampliata la possibilità per gli enti locali di partecipare ad accordi di ristrutturazione: dal 2024 anche i tributi locali possono essere oggetto di accordi transattivi nell’ambito delle procedure di crisi , laddove prima i Comuni erano restii o impossibilitati a concordare riduzioni fuori dalla riscossione ordinaria.
Rischio insolvenza e azioni dei creditori: Quando i debiti superano la capacità dell’azienda di pagare, si configura lo stato di crisi o insolvenza. I creditori, come accennato, possono reagire avviando azioni esecutive individuali (pignoramenti) o chiedendo l’apertura di procedure concorsuali (liquidazione giudiziale/fallimento). Per il debitore, subire una procedura concorsuale significa perdere il controllo: nel fallimento, ad esempio, l’amministrazione viene affidata a un curatore, l’impresa può cessare l’attività e gli asset essere liquidati forzosamente. Inoltre, durante le azioni esecutive individuali vige la regola della “priorità del primo arrivato”, che può portare a smembramento disordinato dei beni aziendali e alla paralisi operativa. È quindi fondamentale, per difendersi, anticipare le mosse dei creditori e utilizzare gli strumenti legali che consentono di bloccare queste azioni, convogliandole in un percorso ordinato di risanamento o soluzione della crisi.
Riassumendo, la mappatura dei debiti e dei rischi associati potrebbe essere così schematizzata:
| Tipologia di debito | Caratteristiche | Rischi per l’azienda | Rischi per imprenditori/amministratori |
|---|---|---|---|
| Debiti bancari (mutui, fidi…) | Garantiti (ipoteche, pegni) o chirografari; possibili fideiussioni personali | – Escussione garanzie (es. ipoteca su stabilimento) <br> – Pignoramenti e azioni legali rapide (decadenza dal termine) <br> – Revoca fidi e blocco liquidità | – Escussione di fideiussioni e garanzie personali (beni privati aggredibili) <br> – Segnalazione in Centrale Rischi (danno reputazione creditizia) |
| Debiti verso fornitori | Chirografari (nessuna garanzia); pagamento a breve termine in fattura | – Azioni monitorie e pignoramenti su conti/beni aziendali <br> – Interruzione forniture essenziali (fermo produzione) <br> – Istanza di fallimento da parte del fornitore insoluto | – (In genere nessuna responsabilità personale diretta, salvo comportamenti illeciti verso specifici fornitori) <br> – Danno reputazionale nei rapporti di mercato |
| Debiti fiscali e contributivi | Privilegiati su beni mobili (e immobili per ipoteche Equitalia); rilevanza penale oltre soglie di legge | – Iscrizione di ipoteche e fermi su beni aziendali <br> – Cartelle esattoriali esecutive, pignoramenti senza giudice <br> – Possibili sanzioni e interessi elevati <br> – Blocco DURC (difficoltà ad operare con la P.A.) | – Responsabilità penale per omesso versamento IVA, ritenute (sopra soglie) <br> – Possibile sequestro beni personali se accertati reati tributari <br> – Azioni di responsabilità erariale (per contributi non versati si può configurare reato di omesso versamento) |
| Debiti verso dipendenti | Privilegiati (stipendi ultimi 12 mesi e TFR con super-priorità); insoddisfatti possono accedere a Fondo di Garanzia INPS | – Decreti ingiuntivi e pignoramento c/c aziendale <br> – Tensioni sindacali, scioperi, dimissioni collettive <br> – Intervento del Fondo di Garanzia (l’INPS poi diventa creditore) | – (Nessuna responsabilità personale per il solo mancato pagamento, ma) <br> – Possibili responsabilità per reati omissivi (es. mancato versamento contributi previdenziali, inadempienze sicurezza sul lavoro, ecc.) |
| Altri debiti (utenze, locazioni, soci finanziatori) | Varie; alcuni privilegiati (es. canoni locazione garantiti da titoli) o postergati (finanziamenti soci) | – Distacco forniture (energia, gas) <br> – Sfratto dal capannone in locazione per morosità <br> – Soci postergati: non possono chiedere rimborso finché altri creditori non pagati | – Se soci finanziatori postergati: nessuna azione finché crisi non risolta <br> – Eventuali garanzie personali date ai locatori/fornitori (escussione beni personali) |
Chiave di lettura: I debiti con garanzie e quelli pubblici hanno strumenti di recupero più immediati e impattanti. I debiti chirografari espongono a iniziative legali e al rischio di istanza di fallimento. In tutti i casi, però, l’imprenditore ha a disposizione difese legali e procedure per congelare le azioni dei creditori e ristrutturare l’esposizione debitoria in modo sostenibile, come vedremo nei prossimi capitoli.
S.r.l., S.p.A. e forme giuridiche: effetti sui debiti e responsabilità
La forma giuridica dell’impresa influisce notevolmente sul grado di protezione del patrimonio personale dei soci e sulle responsabilità di amministratori e proprietari rispetto ai debiti aziendali. Una società a responsabilità limitata (S.r.l.) o per azioni (S.p.A.) offre in genere uno scudo patrimoniale: la regola base della “responsabilità limitata” è che la società risponde delle obbligazioni con il proprio patrimonio e i soci non rispondono con i propri beni personali, salvo conferimenti sottoscritti . Ciò significa che, se l’azienda di trasduttori di pressione è una S.r.l. o S.p.A., in linea di principio i creditori non possono aggredire case, conti correnti e altri beni dei soci per soddisfarsi dei debiti sociali. Questo principio tuttavia conosce importanti eccezioni e va compreso nei dettagli, specie dal punto di vista di amministratori e soci di controllo:
- Responsabilità degli amministratori: i soci amministratori (o gli amministratori esterni nominati) di una S.r.l./S.p.A. possono essere chiamati a rispondere personalmente in diversi casi. Anzitutto, essi hanno per legge dei doveri di corretta gestione e conservazione del patrimonio sociale. In particolare, se la società subisce perdite rilevanti che erodono il capitale, gli amministratori devono attivarsi tempestivamente (convocare l’assemblea, adottare provvedimenti come ricapitalizzazione o liquidazione, ex artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.). Inoltre, dal 2019 il Codice Civile (art. 2086, comma 2) impone all’imprenditore collettivo di adottare “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” per rilevare tempestivamente la crisi e attuare interventi per farvi fronte . La violazione di questi doveri può costituire mala gestio e, in caso di insolvenza, i creditori sociali possono agire contro gli amministratori per i danni derivanti dall’aggravamento del dissesto (la cosiddetta azione dei creditori sociali, già prevista dall’art. 2394 c.c. e ora confermata dal Codice della crisi). Ad esempio, se gli amministratori hanno continuato a fare impresa in modo imprudente aumentando i debiti quando la società era già decotta, potranno essere chiamati a risarcire il danno corrispondente al peggioramento del passivo durante la prosecuzione illecita dell’attività . La legge fornisce persino criteri presuntivi per quantificare questo danno: il nuovo art. 2486 c.c. comma 3 (introdotto dalla riforma sulla crisi) presuppone che, salvo prova contraria, il danno da tardiva liquidazione equivale alla differenza tra patrimonio netto al momento in cui si doveva cessare l’attività e patrimonio netto all’apertura del fallimento (o alla cessazione della carica) . La Corte di Cassazione ha recentemente confermato l’applicazione di tale criterio, vincolando i giudici a utilizzarlo in via equitativa per stimare il danno, a meno che siano dedotti elementi concreti per un diverso calcolo . In pratica: continuare ad accumulare debiti quando si sarebbe dovuto liquidare la società può costare caro agli amministratori, che rischiano in proprio. Anche gli amministratori non operativi (ad esempio membri del CdA non delegati) possono essere co-responsabili se omettono di vigilare e impedire atti pregiudizievoli compiuti dai delegati: la Cassazione ha chiarito che gli amministratori “di fatto non operativi” rispondono solidalmente coi gestori attivi se non si oppongono alle loro condotte illecite .
- Obblighi di segnalazione e tempestività: con il nuovo assetto normativo, gli amministratori hanno anche il dovere di attivarsi tempestivamente in presenza di indizi di crisi. Ad esempio, se emergono significativi ritardi nei pagamenti di debiti fiscali o ai fornitori, o indicatori come indice di liquidità insufficiente, patrimonio netto negativo, DSCR (Debt Service Coverage Ratio) sotto soglia, essi devono prendere iniziative (come attivare la composizione negoziata, di cui diremo) per prevenire l’insolvenza. La mancata attivazione può essere valutata come colpa grave. Un aspetto cruciale introdotto è il sistema delle “segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi”: alcuni creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, agente riscossione) avrebbero l’obbligo di avvisare l’imprenditore e, in certi casi, l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) al superamento di soglie di esposizioni debitorie. Questo sistema di “allerta” era previsto nel Codice della crisi, ma la sua operatività è stata rinviata più volte ed è in fase di revisione; attualmente, al suo posto, è stato privilegiato l’istituto volontario della composizione negoziata, come vedremo. Resta però fermo che gli amministratori devono segnalare ai soci la perdita del capitale o la situazione di crisi e proporre soluzioni. In caso contrario, rischiano sanzioni e responsabilità.
- Responsabilità dei soci e dei garanti: i soci di S.r.l. o S.p.A. (non amministratori) di regola non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale sottoscritto. Tuttavia, possono sorgere responsabilità in situazioni eccezionali. Un caso è la sottocapitalizzazione e confusione patrimoni: se viene provato che la società era usata come “schermo” (ad es. soci che prelevano utili fittizi lasciando la società incapiente, o mescolano conti personali e sociali), la giurisprudenza può sanzionare tali abusi – ad esempio attraverso l’azione revocatoria di atti a favore dei soci o, raramente, con forme di “piercing the corporate veil” (specie in presenza di società di fatto o illeciti gravi come frodi ai creditori). Un altro caso importante è l’aver prestato garanzie personali: come già accennato, se i soci (tipicamente i soci di controllo, spesso coincidenti con gli amministratori nelle PMI) hanno firmato fideiussioni bancarie o garantito debiti dell’azienda, essi diventano co-obbligati di quei debiti. Pertanto, se l’azienda non paga, il creditore può aggredire direttamente il patrimonio personale del socio-garante. La protezione della responsabilità limitata qui non opera, perché il socio ha assunto volontariamente un’obbligazione personale verso il creditore. Nella prassi bancaria italiana è molto comune che, per erogare credito a una S.r.l., la banca chieda ai soci principali di firmare una fideiussione: ciò di fatto vanifica la separazione patrimoniale, ed è un elemento da considerare attentamente nelle strategie di difesa (ad esempio, negoziando con la banca una liberazione dalla garanzia contestualmente alla ristrutturazione del debito aziendale).
- Eccezioni legali specifiche: esistono poi specifiche norme che possono far ricadere sui soci obblighi altrimenti sociali. Ad esempio, nella S.r.l., se i soci approvano distribuzioni di utili fittizi o in violazione di legge, sono tenuti a restituirli e possono risponderne verso i creditori. Oppure, in tema di Gruppi di imprese, la nuova disciplina prevede un’azione di responsabilità verso la società (e i soci) che abbiano abusato della direzione unitaria causando il fallimento di una controllata (art. 2497 c.c. e segg. – responsabilità da direzione e coordinamento): in tal caso, la società controllante e i suoi amministratori/soci possono essere chiamati a risarcire i creditori della società eterodiretta per l’abuso commesso.
In sintesi, S.r.l. e S.p.A. offrono una forte tutela del patrimonio personale dei soci, purché la gestione sia corretta e non si commettano abusi. La responsabilità limitata rimane intatta se l’imprenditore agisce tempestivamente di fronte alla crisi e non trascura i doveri imposti dalla legge. Viceversa, gli amministratori negligenti o scorretti possono perdere lo scudo e trovarsi esposti ad azioni risarcitorie e sanzioni (civili e penali). Nel prosieguo vedremo come un imprenditore può proteggere attivamente i propri beni predisponendo per tempo strategie di separazione patrimoniale lecita e, soprattutto, utilizzando gli strumenti di composizione della crisi per evitare di giungere a situazioni di insolvenza irreversibile che innescano responsabilità personali.
Strumenti per evitare il fallimento e gestire la crisi debitoria
La legislazione italiana mette a disposizione delle imprese in difficoltà diversi strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Tali strumenti hanno l’obiettivo di evitare il fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale) attraverso accordi con i creditori o procedure di ristrutturazione del debito, preservando dove possibile la continuità aziendale. Si distinguono, in linea generale, due grandi famiglie di soluzioni:
- Strumenti stragiudiziali o “negoziali” – attivati volontariamente dall’imprenditore, caratterizzati da maggiore riservatezza e flessibilità, con intervento limitato (o assente) dell’autorità giudiziaria. In questa categoria rientrano:
- il piano attestato di risanamento;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (in varie forme);
- la composizione negoziata della crisi (procedura introdotta di recente, ibrida pubblico-privata).
- Procedure concorsuali giudiziali – attivate con il coinvolgimento diretto del tribunale, che offrono maggiori poteri di imposizione ai creditori dissenzienti ma sono più formali. In questa categoria rientrano:
- il concordato preventivo (nelle sue varianti, in continuità o liquidatorio);
- il concordato semplificato (una novità legata alla composizione negoziata, per la sola liquidazione del patrimonio);
- la liquidazione giudiziale (cioè il fallimento vero e proprio, da evitare se possibile);
- le procedure minori come il concordato minore o la liquidazione controllata (per imprenditori sotto-soglia, ex sovraindebitamento).
Nel caso di una società industriale (come la nostra azienda di trasduttori di pressione), generalmente saranno rilevanti gli strumenti destinati agli imprenditori commerciali “fallibili”, ovvero la gran parte di quelli elencati (le procedure minori riguardano gli imprenditori non fallibili, ad es. piccolissime imprese sotto determinate soglie). Vediamo in dettaglio i principali strumenti e come possono essere usati per difendersi dai creditori e ristrutturare i debiti.
Piano Attestato di Risanamento (Art. 56 CCII)
Il piano di risanamento attestato è uno strumento totalmente stragiudiziale e privatistico con cui l’imprenditore in crisi cerca un accordo con i propri creditori, sulla base di un piano di risanamento dell’esposizione debitoria asseverato da un esperto indipendente. In parole semplici, l’imprenditore elabora un piano industriale e finanziario volto a riequilibrare la situazione aziendale (ad esempio attraverso nuove linee di credito, dilazioni di pagamento, dismissione di asset non strategici, riduzione costi, accordi di saldo e stralcio con alcuni creditori ecc.), lo sottopone a un professionista indipendente (un commercialista o revisore esperto in crisi) che ne verifica la veridicità dei dati e la fattibilità e rilascia una relazione di attestazione. Sulla base di questo piano attestato, l’imprenditore negozia accordi bilaterali con i creditori (banche, fornitori, etc.) coinvolti, cercando di ottenere le concessioni necessarie (quali dilazioni, remissioni parziali, rinunce agli interessi, nuove finanza).
Caratteristiche salienti del piano attestato di risanamento:
– È un’iniziativa unilaterale del debitore: il piano è predisposto dall’azienda stessa, non c’è un intervento autorizzativo del tribunale né un voto collettivo dei creditori . Ogni creditore è libero di aderire o meno agli accordi proposti. Non vi è pubblicità obbligatoria del piano, sebbene l’imprenditore possa depositarlo presso il registro delle imprese per ottenere data certa e attivare alcune tutele. – Non comporta l’apertura di una procedura concorsuale: l’impresa resta in mano agli amministratori, non c’è un commissario né un giudice delegato che supervisioni . Questo garantisce riservatezza e nessuno stigma (utile per tutelare la reputazione e i rapporti commerciali). – L’efficacia dipende dal consenso individuale: solo i creditori che aderiscono agli accordi in esecuzione del piano saranno vincolati. Non si possono obbligare i dissenzienti a concessioni, a differenza di quanto avviene nel concordato o negli accordi omologati. Ciò significa che il piano attestato funziona bene quando c’è un numero relativamente ristretto di creditori cruciali e ragionevolmente disponibili (ad es. le banche principali e pochi altri), mentre è meno adatto in presenza di molti creditori piccoli e dispersi difficili da coordinare. – Il vantaggio legale principale del piano attestato è la protezione dagli effetti del fallimento successivo per certi atti. Mi spiego: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo a risanare l’impresa sono esenti dall’azione revocatoria fallimentare (art. 67, co.3, lett. d) Legge Fall. e oggi art. 166, co.3, lett. d) CCII) . In pratica, se l’azienda successivamente fallisse, il curatore non potrebbe far annullare quei pagamenti o garanzie dati ai creditori secondo il piano, purché il piano fosse serio e fattibile. Questo incentivo serve a rassicurare i creditori aderenti: ad esempio una banca che accetta di riscadenzare un debito o di finanziarne di nuovi sotto piano attestato, non rischierà di vedersi revocare quelle operazioni nel caso malaugurato in cui il risanamento fallisca e la società venga dichiarata insolvente. Attenzione: tale protezione vale solo se il piano era realisticamente idoneo al risanamento. La Cassazione ha chiarito (sent. n. 6508/2023) che se il piano attestato era inadeguato in modo palese a risanare l’impresa, gli atti esecutivi non godono dell’esenzione da revocatoria . Il tribunale, in sede fallimentare, compie infatti un giudizio ex ante sull’idoneità del piano: se riscontra che era un piano “di facciata” o privo di reale prospettiva di risanamento, non concede il beneficio e quei pagamenti potranno essere revocati . È quindi interesse sia del debitore sia dei creditori fare in modo che il piano attestato sia solido e credibile, e che l’attestatore indipendente svolga con rigore il suo compito di verifica (la Cassazione, con sent. n. 36401/2023, ha ribadito i rigorosi doveri dell’attestatore nel segnalare ogni informazione rilevante ai creditori, pena la sua responsabilità professionale ). – Non vi sono automaticamente misure protettive durante la negoziazione del piano: a differenza di concordato e accordi omologati, il piano attestato di per sé non sospende le azioni esecutive dei creditori. L’azienda deve quindi essere sufficientemente in bonis da evitare aggressioni mentre tratta. Tuttavia, una tecnica utilizzata è combinare il piano attestato con la richiesta al tribunale di misure cautelari ad hoc, oppure utilizzare la composizione negoziata (che vedremo tra poco) per ottenere una protezione temporanea e poi sfociare in un piano attestato depositato. Inoltre, la legge fallimentare riconosceva la possibilità, ora mantenuta dal Codice, di pubblicare il piano attestato nel Registro Imprese: la pubblicazione non è obbligatoria, ma se effettuata, innesca da quel momento il periodo protetto per gli atti in esenzione revocatoria e assolve al requisito della “data certa” del piano. – Ambito soggettivo: possono ricorrere al piano attestato tutti gli imprenditori in crisi o insolventi soggetti alle procedure concorsuali ordinarie . Restano esclusi gli imprenditori non fallibili (piccoli imprenditori sotto soglia e imprenditori agricoli) in quanto tali soggetti, pur potendo anche loro tentare accordi stragiudiziali, non beneficerebbero dell’esenzione da revocatoria (che si applica solo se poi c’è un fallimento e per legge i piccoli imprenditori non falliscono) . Per costoro esistono semmai le procedure di sovraindebitamento (accordo di composizione, piano del consumatore, ora “piano di ristrutturazione soggetto minore” nel CCII). Nel nostro caso, un’azienda industriale di dimensioni medio-piccole ma fallibile può certamente adottare un piano attestato.
Il procedimento in sintesi: l’imprenditore incarica consulenti finanziari e legali di predisporre un piano; individua un professionista attestatore iscritto agli appositi albi; raccoglie l’accordo di massima dei creditori chiave sulle linee del risanamento; ottiene la relazione positiva dell’attestatore; quindi conclude formalmente i vari accordi bilaterali (scritture private, contratti) con banche e fornitori, coerenti con il piano. Se lo ritiene opportuno, deposita tutto al Registro Imprese (dandogli data certa). Da quel momento l’azienda opera eseguendo il piano: ad esempio paga rate concordate ai creditori aderenti, ristruttura l’attività, effettua gli aumenti di capitale o il nuovo finanziamento previsto, ecc. Se tutto va bene, l’azienda esce dalla crisi senza essere mai “entrata in tribunale”.
I punti di forza di un piano attestato sono: riservatezza, flessibilità (il contenuto è liberamente negoziabile), rapidità (non ci sono udienze né votazioni formali), nessuno stigma pubblico, costi relativamente contenuti (si paga l’attestatore e i consulenti, ma non ci sono spese di procedura concorsuale). Per contro, i punti deboli sono: la necessità di un ampio consenso spontaneo (basta un creditore vitale che rifiuti, per compromettere il piano), l’assenza di misure protettive automatiche (se un creditore aggressivo pignora i beni durante il negoziato, può far saltare tutto) e l’impossibilità di imporre tagli ai creditori pubblici senza passare per un’omologazione (come detto, il Fisco può al più accettare dilazioni ordinariamente previste, ma non falcidie di imposta in un piano attestato ). In genere, il piano attestato funziona bene come soluzione precoce: se la crisi è individuata agli esordi, e l’azienda ha ancora credibilità, le banche preferiranno spesso ristrutturare il credito in via privata (evitando di dover passare da un tribunale, cosa che le costringerebbe a classificare l’esposizione come default conclamato). Allo stesso modo, fornitori disposti a continuare il rapporto possono acconsentire a piani di rientro graduali se c’è un risanamento credibile in vista.
Esempio pratico: La Alfa S.r.l., produttrice di trasduttori, accumula €500.000 di debiti con la banca X (scoperto e mutuo in arretrato) e €300.000 con vari fornitori, ma vede prospettive di nuovi ordini e margini di ripresa se ottiene liquidità e tempo. Alfa elabora un piano secondo cui la banca X rinuncia a metà degli interessi e rolla il debito in un mutuo a 5 anni, mentre i fornitori ricevono il 70% del credito in 24 mesi. Un commercialista indipendente attesta che i dati di Alfa sono veritieri e il piano è fattibile, dimostrando che con queste misure Alfa può tornare solvibile in 2 anni. Banca X e fornitori (rappresentativi dell’80% del totale crediti) aderiscono formalmente al piano; Alfa deposita il tutto al Registro Imprese. Per il Fisco (IVA arretrata €50.000) Alfa non può proporre stralcio col piano attestato, ma chiede contestualmente una rateazione in 60 rate come da normativa. Esegue poi il piano: con l’aiuto di nuova finanza dei soci (apporto di capitale) paga regolarmente le rate a tutti. Dopo 2 anni Alfa S.r.l. risulta risanata e credibile sul mercato, avendo evitato sia il fallimento sia la pubblicità di un concordato. I pagamenti fatti – es. il pegno concesso alla banca sul nuovo finanziamento e le percentuali pagate ai fornitori – sono al sicuro da revocatoria in ipotesi di un futuro fallimento perché coperti dall’art. 56 CCII, purché il piano fosse realmente idoneo (come attestato) e non solo apparente .
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (Artt. 57-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviati in “ADR” o “accordi 182-bis” dal vecchio articolo della legge fallimentare) rappresentano un ponte tra le soluzioni puramente private e il concordato preventivo. Si tratta di accordi stipulati dall’imprenditore con una percentuale qualificata di creditori, che vengono poi omologati dal Tribunale conferendo efficacia anche verso i terzi (in alcuni limiti). In pratica, l’imprenditore elabora un piano di risanamento molto simile a quello del piano attestato (necessita infatti di un’attestazione di fattibilità da parte di un esperto indipendente anche qui) e cerca l’adesione dei creditori principali. Se raggiunge il quorum di legge – almeno il 60% dei crediti totali devono essere coinvolti e consenzienti all’accordo – allora può chiedere al tribunale di omologare l’accordo. L’omologazione rende l’accordo efficace anche per i creditori estranei rispetto ad alcune previsioni (ad esempio le dilazioni concordate con i aderenti non impediscono ai dissenzienti di essere pagati a scadenza, ma l’omologa blocca azioni esecutive e, in alcune varianti, può estendere gli effetti ai dissenzienti di una certa categoria).
Caratteristiche principali degli accordi di ristrutturazione:
– Volontarietà e quorum: è lo strumento del “consenso di larga parte”. Non richiede unanimità come un accordo puramente privato, ma neppure basta la maggioranza semplice come nel concordato: serve almeno il 60% del totale crediti di ciascun creditore aderente (il calcolo è sui crediti, non sul numero di creditori). Dunque, se l’impresa ha pochi creditori principali che coprono gran parte del debito, può concentrarsi su di essi. I creditori che aderiscono sottoscrivono un accordo vincolante, mentre i creditori non aderenti rimangono estranei: questi ultimi, per legge, devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza se successiva (art. 57 co.3 CCII). Ciò tutela i dissenzienti assicurando che non subiscano decurtazioni né dilazioni eccessive rispetto ai loro diritti originari. In sostanza: l’accordo di ristrutturazione consente di ristrutturare il debito con la maggioranza qualificata, ma bisogna neutralizzare i dissenzienti pagando loro il dovuto. – Ruolo del Tribunale: a differenza del piano attestato, qui è prevista una procedura giudiziale di omologazione. L’imprenditore deposita la domanda di omologa con l’accordo sottoscritto dai creditori pari almeno al 60% dei crediti, il piano e la relazione dell’attestatore. Il tribunale verifica che tutto sia regolare – in particolare che l’accordo assicuri l’integrale pagamento dei non aderenti nei termini di legge e che non sia contrario all’interesse comune – e omologa rendendo l’accordo vincolante per le parti e opponibile ai terzi. – Protezione nella fase esecutiva: dall’accordo omologato discendono alcuni benefici. Il più importante: l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive già con il deposito della domanda di omologa, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive dei creditori durante le trattative e fino all’omologazione (analogamente a quanto avviene nel concordato) . Inoltre, dopo l’omologa, l’accordo omologato impedisce ai creditori aderenti di agire al di fuori di esso (non potrebbero, ad esempio, un mese dopo l’omologa, pignorare qualcosa pretendendo più di quanto accordato). È possibile anche prevedere che nuovi finanziamenti concessi in esecuzione dell’accordo siano prededucibili (privilegiati) in caso di successiva procedura concorsuale, per incentivare fresh money. – Varietà di tipologie: nel corso degli anni si sono aggiunte varianti agli accordi standard (ordinari). Oggi il CCII disciplina, oltre all’accordo di ristrutturazione “semplice” al 60%, anche: – Accordi ad efficacia estesa: sono accordi in cui se si raggiunge un’adesione alta in una categoria omogenea di creditori (ad es. banche finanziatrici) – tipicamente almeno il 75% di quella categoria – l’imprenditore può chiedere che l’accordo sia esteso anche ai creditori della stessa categoria che non hanno aderito (purché abbiano possibilità di essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero altrimenti). Questo strumento serve a evitare che pochi dissenzienti (per es. una banca su dieci) facciano fallire l’intesa quando la stragrande maggioranza è d’accordo. È un meccanismo assimilabile a un cram-down di categoria. – Accordi agevolati o a percentuale ridotta: il Codice consente – recependo la Direttiva UE 2019/1023 – accordi con percentuale di consensi inferiore al 60% in certi casi particolari: ad esempio, per gli accordi che coinvolgono solo creditori finanziari (banche e intermediari) è previsto un quorum ridotto del 30% di adesioni se l’accordo prevede determinate condizioni (questa soglia ridotta era già stata sperimentata durante l’emergenza Covid con il “decreto Liquidità”). Anche i cosiddetti “accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari e banche” sono stati introdotti per facilitare intese nel settore bancario, dove spesso poche banche detengono gran parte del debito: qui la legge consente omologa con il 30% purché i soli creditori siano banche e che a quelli dissenzienti sia esteso lo stesso trattamento concordato con gli altri (è un tecnicismo in evoluzione normativa). – Accordo di ristrutturazione soggetto a omologazione “minore”: per i debitori non fallibili (piccoli imprenditori), il CCII prevede una sorta di accordo semplificato analogo ma con percentuali e caratteristiche proprie (non approfondiamo qui, poiché attiene ai casi di sovraindebitamento, in cui l’azienda di trasduttori non rientra se supera i parametri dimensionali). – Transazione fiscale e contributiva: all’interno di un accordo di ristrutturazione, l’imprenditore può inserire la proposta di transazione fiscale (e contributiva) per i debiti tributari e previdenziali. Ciò consente di ottenere dalla Agenzia delle Entrate e dall’INPS l’adesione all’accordo anche con riduzione di sanzioni e interessi o, se necessario, anche del capitale (quest’ultimo solo se viene assicurato almeno il pagamento del massimo realizzabile in caso di liquidazione, come impone l’art. 63 CCII). La transazione fiscale negli accordi è facoltativa ma spesso determinante, dato che molte imprese hanno una porzione significativa di debiti verso Fisco/INPS. Se le Entrate non aderiscono, l’omologazione può comunque essere ottenuta tramite il meccanismo di cram-down fiscale previsto dall’art. 64 CCII: in sostanza, il tribunale può omologare anche senza voto favorevole del Fisco, a condizione che la proposta preveda per il Fisco una soddisfazione almeno pari a quanto otterrebbe in fallimento . Questo strumento del cram-down fiscale (novità della riforma) serve ad evitare che il diniego del Fisco, magari per rigidità burocratica, faccia saltare ristrutturazioni altrimenti vantaggiose per tutti (si è però discusso se valga anche per concordati in continuità – tendenzialmente sì, con qualche dubbio interpretativo ).
Quali vantaggi offre l’accordo di ristrutturazione rispetto al concordato preventivo? Essenzialmente, è una procedura più snella: non c’è il coinvolgimento di tutti i creditori con voto assembleare, ma solo la raccolta di firme dei principali; i termini e condizioni possono essere personalizzati con ciascuno (pur all’interno di un piano generale); l’esposizione pubblica è limitata (anche se l’omologa è un atto pubblico, il suo contenuto dettagliato non viene pubblicizzato come un piano di concordato che deve essere comunicato a tutti i creditori). Inoltre, la continuità aziendale è più libera: non si nominano organi concorsuali di controllo (commissari) salvo il caso di specifiche misure cautelari; l’imprenditore resta pienamente al timone.
D’altro canto, l’accordo ADR non consente di imporre sacrifici ai creditori dissenzienti oltre certi limiti: come detto, ai non aderenti devi comunque pagare il 100% (salvo l’estensione a dissenzienti nella medesima categoria omogenea se ricorrono i presupposti, ma parliamo di minoranze qualificate). Se hai molti piccoli creditori non finanziari, l’accordo rischia di non risolvere tutta la situazione, perché dovrai comunque trovare le risorse per pagare integralmente quelli fuori accordo entro 120 giorni dall’omologa. In casi con forte dispersione del debito, meglio il concordato.
L’accordo di ristrutturazione è utile quando, ad esempio, il grosso del debito è concentrato in poche banche e qualche grande fornitore e magari l’Erario. Si ottiene la firma delle banche (mettiamo che 5 banche detengono il 70% dei crediti finanziari), si include transazione fiscale per il 15% di debito pubblico, e restano fuori micro-fornitori per il 15% i quali verranno pagati regolarmente. Il tribunale omologa, sospende eventuali azioni in corso e l’impresa esegue l’accordo nel tempo (i contratti con banche ridefiniti, debiti dilazionati, ecc.). Se l’impresa per caso non dovesse rispettare l’accordo poi, ciascun creditore tornerebbe libero di agire (non c’è commissario che garantisca l’esecuzione continuativa come in concordato – sebbene si possa nominare un professionista vigilante su richiesta). Ma almeno nel frattempo il fallimento è evitato e c’è respiro.
Casi particolari recenti: negli anni passati molte ristrutturazioni del debito di medie imprese si sono fatte via accordi 182-bis, perché era uno strumento più flessibile rispetto al concordato. Con la riforma, sono stati potenziati anche i concordati, ma ancora oggi l’accordo ADR rimane una via preferenziale quando si ha il supporto convinto delle banche (che spesso suggeriscono esse stesse all’azienda debitrice di procedere con un 182-bis anziché un concordato, per minimizzare perdite e garantire continuità). Ad esempio, un’azienda industriale con debiti bancari elevati potrebbe negoziare un haircut (stralcio parziale) del debito con ciascuna banca: se la maggioranza aderisce, anche la minoranza contraria nella stessa classe potrebbe essere obbligata ad accettare le medesime condizioni grazie all’accordo ad efficacia estesa, come previsto dal CCII.
Da notare che col correttivo 2024 e normative collegate, si sono introdotte semplificazioni burocratiche per favorire questi accordi e la partecipazione di tutti gli enti: ad esempio, è stata formalizzata la possibilità per i Comuni di aderire alle transazioni fiscali (prima non chiara) e l’INPS ha emanato linee guida per le transazioni contributive dopo il correttivo (Messaggio INPS n.3553/2024), per cui anche l’ente previdenziale può concordare piani di rientro e abbattimento sanzioni in sede di accordo o concordato.
Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa
La composizione negoziata è uno strumento innovativo introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021) e poi integrato nel Codice della crisi (artt. 12-25 quinquies CCII) . Si tratta di una procedura volontaria e confidenziale in cui l’imprenditore in situazione di crisi (anche non ancora insolvente conclamato) chiede l’assistenza di un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione, per cercare di trovare con i creditori una soluzione concordata per il risanamento. È, in altre parole, una trattativa guidata da un facilitatore terzo, con alcuni possibili benefici legali di contorno (come la sospensione delle azioni esecutive su istanza al tribunale).
Caratteristiche principali:
– Accesso libero e senza soglie: possono accedere alla composizione negoziata tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e natura giuridica (anche agricole, anche sotto soglia), che si trovino in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderle ragionevolmente esposte al rischio di futura insolvenza, o già in stato di crisi o insolvenza reversibile. Non è richiesto alcun quorum di creditori né dichiarare lo stato di crisi in tribunale: basta presentare una domanda attraverso la piattaforma telematica nazionale, corredata di informazioni sullo stato dell’impresa. – Nomina di un esperto negoziatore: una volta accolta la domanda, un’apposita commissione nomina un esperto indipendente (di norma un commercialista, manager o avvocato con formazione specifica, pescato dagli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio) che avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori. L’esperto analizza la situazione aziendale e convoca le parti (debitore e principali creditori) invitandole al dialogo, cercando di far emergere una soluzione. – Nessuna spossessamento, l’impresa resta in mano al debitore: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria, sebbene sotto la supervisione (soft) dell’esperto e con l’obbligo di informarlo prima di compiere atti di particolare rilevanza (specie se sono state concesse misure protettive). – Misure protettive: l’imprenditore, fin dall’istanza o successivamente, può chiedere al Tribunale l’applicazione di misure protettive del patrimonio, ossia un decreto che fino a 4 mesi (prorogabili di 4 in 4 mesi per tutta la durata della composizione, massimo 12 mesi) inibisca ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei confronti dell’azienda . Se concesse, queste misure sono pubblicate nel registro delle imprese (diventano quindi note ai terzi) e bloccano anche eventuali istanze di fallimento nel frattempo (il fallimento non può essere dichiarato su richiesta di creditori durante la protezione, salvo casi di abuso). Ciò offre al debitore uno “spazio di respiro” per negoziare senza l’assillo di pignoramenti imminenti. Tali misure non sono automatiche: il tribunale le concede se ritiene plausibile che la prosecuzione dell’attività non arrechi danno ai creditori e che vi siano concrete possibilità di risanamento (valutate anche dal parere iniziale dell’esperto). Dalla statistica risulta che circa il 76% delle imprese in composizione negoziata ha richiesto misure protettive, segno che la protezione è uno degli elementi più utili dello strumento . – Esito delle trattative: la composizione negoziata non si conclude con una procedura “prefabbricata”, ma con l’esito che le parti riescono a costruire. Gli esiti possibili, secondo l’art. 23 CCII, sono vari: – a) Sottoscrizione di un contratto con uno o più creditori che realizza il risanamento (ad esempio nuovi finanziamenti, moratorie, aumento garanzie etc.), senza bisogno di ulteriori formalità. Questo è un esito privatistico puro. – b) Misure unilaterali adottate dal debitore su consiglio dell’esperto per migliorare la situazione (es. cessione di rami d’azienda, ricerca di soci, atti di straordinaria amministrazione autorizzati dal tribunale). Queste misure possono avvenire durante il percorso e con l’assistenza dell’esperto, ma non richiedono accordo coi creditori se non passivamente (il creditore subisce l’operazione, ad es. vendita di un asset per pagarlo). – c) Sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione con i creditori che raggiunge le percentuali di legge, da portare poi in omologazione (quindi la composizione funge da fase preparatoria per un successivo accordo ex art.57 CCII) . – d) Accesso a una procedura concorsuale: ad esempio presentazione di domanda di concordato preventivo o omologazione di un piano di ristrutturazione (concordato minore se piccola impresa) . Anche qui, la negoziazione servirebbe per preparare e concordare con i creditori i termini di un futuro concordato. – e) Predisposizione di un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) , grazie alle informazioni raccolte e al confronto con creditori (magari l’esperto poi può fungere da attestatore o coordinare il piano). – f) Se nessuna soluzione è possibile, la composizione può concludersi con l’attestazione dell’esperto dell’impossibilità di trovare un accordo. In tal caso, l’imprenditore può comunque – entro 60 giorni – presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (vedi infra), come extrema ratio per evitare il fallimento e liquidare sotto controllo. – Vantaggi ulteriori (“premialità”): la legge prevede alcune misure premiali per chi utilizza con successo la composizione negoziata. Ad esempio, se le trattative si concludono con un contratto o accordo idoneo a garantire la continuità per almeno 2 anni (con l’esperto che vi partecipa e lo sottoscrive), l’azienda può ottenere un piano di rateazione straordinaria dei debiti fiscali fino a 120 rate mensili (10 anni), invece delle normali 72 . Questa modifica è stata introdotta nel 2023 proprio per incentivare le imprese ad avvalersi della composizione negoziata: in pratica, l’Agenzia Entrate può concedere dilazioni più lunghe se c’è un accordo negoziato riuscito. Non è invece passato (sempre nel 2023) il progetto di estendere alla composizione negoziata la possibilità di transare i debiti fiscali riducendone l’ammontare (transazione fiscale), opportunità che resta confinata a concordati e accordi omologati . Un’altra premialità è l’esenzione da alcune fattispecie di reato fallimentare: ad esempio, certi atti compiuti in esecuzione di un accordo concluso con l’esperto nella negoziazione non sono punibili come bancarotta semplice o preferenziale, per evitare che l’imprenditore tema responsabilità penali nel tentare il salvataggio (art. 324 CCII prevede cause di non punibilità se l’accordo è poi eseguito con successo). – Costo e impegno: la composizione negoziata richiede un certo investimento di tempo e impegno da parte dell’imprenditore e dei suoi consulenti. La nomina dell’esperto avviene rapidamente (entro 2 giorni dalla richiesta), poi vanno fornite informazioni complete entro 7 giorni. L’esperto convoca una prima riunione entro 20 giorni. Tipicamente, l’intero percorso dura qualche mese (3-6 mesi) ma può prolungarsi se c’è progresso nelle trattative (massimo 12 mesi, oltre c’è chiusura). L’esperto ha il compito di redigere “check-list” di possibili interventi di risanamento e soluzioni, ed ogni mese fa relazione sullo stato delle trattative. Il suo compenso è a carico dell’impresa (in caso di esito positivo c’è un piccolo bonus, e lo Stato ha previsto un fondo per contribuire ai compensi nelle composizioni di PMI).
Diffusione e risultati: Essendo un istituto nuovo, inizialmente c’è stata prudenza. Nel primo anno (15/11/2021 – 15/11/2022) le istanze presentate furono solo 475 ; entro febbraio 2023 salite a 595 , con però esiti positivi molto limitati (solo 11 casi conclusi positivamente nel primo anno, pari a meno del 5%) . Ciò ha portato il legislatore a introdurre le modifiche incentivanti nel 2023. Nel 2023-2024 c’è stata una significativa crescita: al 17 maggio 2024 risultavano 1.450 istanze cumulative presentate dall’avvio , con un tasso di successo in miglioramento (21,2% di esiti favorevoli trimestrali nel 2023) . In particolare, su 831 istanze chiuse entro maggio 2024, 153 avevano esito positivo (circa 18%) . Gli esiti positivi più frequenti: 65 casi di accordo finale imprenditore-creditori-esperto (soluzione c), 43 casi di conclusione di un contratto con alcuni creditori (soluzione a), 21 casi sfociati in omologazione di accordo di ristrutturazione, 18 sfociati in procedure concorsuali (concordato ecc.), e 6 casi conclusi con la stesura di un piano attestato di risanamento . Questo dimostra che la composizione negoziata è servita spesso come “laboratorio” per costruire altre soluzioni (accordi 182-bis o concordati) oppure come sede per definire accordi stragiudiziali con la garanzia del terzo. Il trend 2024 mostra un aumento di oltre il 57% nelle nuove istanze rispetto al 2023 , segno di maggior conoscenza e fiducia nell’istituto, specie dopo le correzioni normative.
Quando e perché usarla: la composizione negoziata è indicata quando l’imprenditore percepisce per tempo i segnali di crisi e vuole tentare un risanamento concordato con i creditori in modo non conflittuale. È uno strumento di “allerta volontaria”: piuttosto che aspettare che siano i creditori a muoversi (magari chiedendo il fallimento), l’imprenditore prende l’iniziativa, mettendosi attorno a un tavolo con loro. La presenza dell’esperto dà credibilità e struttura al dialogo. Inoltre, la possibilità di ottenere protezione dalle azioni esecutive può congelare situazioni pericolose (es. bloccare sul nascere un pignoramento di Equitalia o lo sfratto dal capannone) e guadagnare qualche mese per elaborare una proposta di ristrutturazione.
Esempio pratico: Beta S.p.A., nostra ipotetica azienda di trasduttori, inizia ad accumulare ritardi nei pagamenti: ha debiti verso banca, Fisco e fornitori, ma ritiene di poter risanare se ottiene una moratoria di 6 mesi e un nuovo socio finanziatore. Beta avvia la composizione negoziata: nomina l’esperto, ottiene subito dal tribunale un provvedimento che blocca i creditori (in particolare ferma un’azione esecutiva della banca sul magazzino e sospende un’istanza di fallimento depositata da un fornitore). L’esperto, insieme a Beta, convoca banca, principali fornitori e Agenzia Entrate: propone che la banca conceda nuova finanza prededucibile per €200k, i fornitori convertano parte del credito in capitale (diventando soci di minoranza) e l’Erario dilazioni i €100k di debiti fiscali in 8 anni (grazie alla premialità 120 rate). Dopo trattative, si arriva a un accordo di massima: la banca acconsente a finanziamento fresco con garanzia statale, fornitori accettano uno swap debito-equity, l’Erario concede la dilazione massima (non potendo falcidiare il capitale fuori da concordato). Questo accordo viene formalizzato con l’aiuto dell’esperto e si decide di omologarlo come accordo di ristrutturazione per dare maggior certezza ed efficacia erga omnes. Beta, quindi, trasforma l’intesa in un accordo ex art.57 CCII col 75% dei crediti rappresentati (banche + fornitori), e lo deposita chiedendo l’omologa con contestuale cram-down del Fisco (che comunque ha accettato la dilazione quindi non è nemmeno contrario). Il tribunale omologa, revoca le misure protettive, e Beta esegue l’accordo sotto la vigilanza morale dell’esperto (che a quel punto termina il suo mandato). Beta ha così evitato il fallimento, protetto i propri beni (nessun pignoramento) e gettato le basi per il rilancio.
Concordato semplificato: se invece Beta non fosse riuscita a trovare alcun accordo, l’esperto avrebbe chiuso la composizione con esito negativo. Beta a quel punto potrebbe ancora, entro 60 giorni, presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, chiedendo al tribunale di approvare un piano di liquidazione dei suoi beni a beneficio dei creditori, senza passare per il voto di questi. È una procedura speciale, riservata all’esito infruttuoso della negoziazione assistita (introdotta anch’essa dal D.L. 118/2021), che consente di evitare il fallimento classico cedendo rapidamente gli asset ai creditori sotto supervisione giudiziale. Ne parleremo a breve nella sezione concordato.
In conclusione, la composizione negoziata è uno strumento moderno di crisis management consensuale: non è adatto a casi disperati in cui i creditori sono già sul piede di guerra, ma può fare la differenza in situazioni borderline dove un mediatore qualificato aiuta a ripristinare la fiducia e a costruire soluzioni creative. Dati i numeri in crescita e i perfezionamenti normativi, ogni imprenditore in difficoltà dovrebbe quantomeno valutare questa opzione prima che la situazione degeneri.
Concordato Preventivo (in continuità o liquidatorio)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale più nota e utilizzata storicamente per evitare il fallimento tramite un accordo tra debitore e creditori, gestito però interamente sotto l’egida del tribunale. A differenza degli strumenti fin qui visti, il concordato coinvolge tutti i creditori e vincola anche i dissenzienti, offrendo la possibilità di imporre sacrifici in maniera equa ma richiedendo il rispetto di regole formali rigorose. Con la riforma del Codice della crisi, il concordato preventivo ha mantenuto la sua struttura fondamentale, con alcune novità come la spinta alla continuità aziendale e meccanismi di omologa forzata (cram down) più ampi.
Nel concordato preventivo distinguiamo due macro-tipologie: – Concordato in continuità aziendale: quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa (direttamente dal debitore o tramite un affitto/cessione d’azienda che però ne preserva operatività e posti di lavoro). – Concordato liquidatorio: quando il piano è meramente liquidatorio, cioè prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio per ripartirne il ricavato ai creditori.
Le differenze sono importanti: la legge incoraggia fortemente la continuità aziendale (ritenuta preferibile perché preserva valore e occupazione) . Per il concordato liquidatorio, infatti, sono imposti requisiti più stringenti (come vedremo, una soglia minima di pagamento ai chirografari del 20%) per accettare la proposta.
Procedura in sintesi: L’imprenditore deposita un ricorso per concordato presso il tribunale, allegando il piano dettagliato e la proposta ai creditori, insieme a una relazione giurata di un attestatore indipendente che ne certifichi la fattibilità. Il tribunale, verificati i presupposti (stato di crisi o insolvenza, documentazione completa, ecc.), ammette alla procedura e nomina un commissario giudiziale, figura terza che vigila sull’impresa durante la procedura. Da quel momento i creditori sono bloccati: scatta l’automatic stay, ossia il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (e sospensione di quelle in corso) e non possono acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore. L’impresa, se in continuità, prosegue l’attività sotto la gestione degli amministratori attuali ma con l’affiancamento e la supervisione del commissario (per gli atti straordinari serve autorizzazione del giudice delegato). Il piano viene comunicato a tutti i creditori che hanno diritto di voto (esclusi alcuni privilegiati se pagati al 100% etc.) e si procede alla votazione: i creditori vengono suddivisi in classi se previsto dal piano (obbligatorio classificarli per tipologie di interesse omogeneo, soprattutto se trattati diversamente). Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (nel Codice della crisi conta la maggioranza per classi, quindi tutte le classi devono essere favorevoli, salvo possibilità di cram-down se almeno una classe approva ). Se c’è approvazione (o ricorrono i presupposti per omologare nonostante dissensi – es. un’unica classe approvante e certe condizioni), il tribunale procede all’omologazione del concordato, che lo rende efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori. A quel punto si apre la fase di esecuzione del piano sotto il controllo del commissario (che diviene liquidatore per la parte liquidatoria eventualmente prevista, ecc.).
Contenuto del piano di concordato: La proposta può prevedere le più varie soluzioni, purché rispetti la legge. In un concordato in continuità tipicamente troveremo un business plan con previsione di pagare i creditori col denaro generato dalla prosecuzione dell’attività (o in parte generato e in parte grazie a finanza esterna). Nel concordato liquidatorio invece l’idea è vendere i beni (anche attraverso una procedura competitiva sotto controllo del tribunale) e distribuire il ricavato. Spesso i concordati sono misti, con parte di continuità e parte di liquidazione di asset non strategici. È consentito anche prevedere la cessione dell’intera azienda a un terzo, che la continui (continuità indiretta) – scenario frequente, in cui di fatto il concordato serve a fare M&A in crisi (l’azienda viene acquistata da un investitore che ne assume la gestione e si fa carico di pagare i creditori secondo il piano).
Trattamento dei creditori nel concordato: Regole chiave includono: – I creditori privilegiati (p.e. ipotecari, pignoratizi, privilegi speciali) devono essere soddisfatti almeno per il valore di realizzo delle garanzie (o, se si vuole ridurre il loro credito, occorre il loro voto favorevole in classe). Se si vuole deviare dalla graduatoria legale (ad esempio pagare un chirografario meglio di un altro, o differenze tra classi di chirografari) bisogna prevedere classi separate e condizioni giustificate e farle approvare. – I creditori chirografari (senza garanzia) possono subire decurtazioni e dilazioni. Nei concordati con continuità non esiste una percentuale minima di legge di rimborso : in teoria potrebbero prendere anche pochissimo, purché sia più di quanto otterrebbero dalla liquidazione fallimentare (principio di convenienza). Al contrario, nei concordati meramente liquidatori la legge impone che i chirografari abbiano almeno il 20% di soddisfacimento (art. 84, comma 4, CCII). Questa soglia del 20% è derogabile solo se il concordato è in continuità (in tal caso non si applica affatto) . La ratio è scoraggiare concordati liquidatori che diano percentuali irrisorie: se l’imprenditore vuole solo liquidare i beni senza proseguire l’attività, tanto vale fallire se non garantisce almeno quel ritorno minimo. – Pagamento crediti pubblici: nel concordato è possibile la transazione fiscale (analoga a quella degli accordi) per ridurre o dilazionare debiti tributari e contributivi. La proposta al Fisco va motivata e attestata come conveniente rispetto alla liquidazione. Se il Fisco (o un altro creditore di peso) vota contro e fa eccezione di non-convenienza, il tribunale può comunque omologare se ritiene soddisfatto il test di convenienza (credito non inferiore a scenario liquidatorio) . Questo è il cram-down che il Codice ha potenziato: oggi il giudice può approvare il concordato anche contro il voto negativo di classi dissenzienti, purché almeno una classe rilevante abbia detto sì e la proposta sia equa (rispetti priorità e convenga a chi dissente). – Continuità aziendale: se il piano prevede continuità, il legislatore consente alcune agevolazioni, ad esempio la possibilità di richiedere finanza interinale (debito durante la procedura) con priorità di rimborso, per sostenere l’impresa in esercizio. Inoltre, la prosecuzione dei contratti in corso (forniture, appalti) è tutelata: il debitore può chiedere al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti pregressi di fornitori strategici se ciò serve a garantirsi forniture future (questo pagamento in prededuzione è ammesso se indispensabile per la continuità). Il CCII afferma un principio generale: “la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro” , orientando quindi le decisioni verso il mantenimento in vita dell’impresa ove possibile, anche a parità di soddisfacimento economico, preferendolo alla liquidazione . Va comunque verificato caso per caso se la continuità proposta è credibile e produttiva di valore aggiunto.
Iter temporale: Un concordato richiede generalmente diversi mesi: dalla presentazione del ricorso all’omologa possono volerci 6-12 mesi facilmente (salvo concordati “in bianco” o con riserva, in cui il piano viene depositato in seguito, ma non complichiamo qui). È dunque un percorso relativamente lungo. Durante questo periodo, l’impresa opera in regime protetto ma vigilato: non può ad esempio pagare debiti anteriori, se non autorizzata, per non fare trattamenti preferenziali; i nuovi crediti sorti durante il concordato sono “prededucibili” (saranno pagati prima degli altri, incentivando i fornitori a continuare a dare fiducia dopo l’omologa).
Esempio di concordato in continuità: Gamma S.r.l., la nostra azienda in crisi, presenta un piano dove prevede di continuare la produzione di trasduttori, grazie all’ingresso di un investitore che apporterà liquidità fresca di €1 milione. Con questi fondi e con i flussi di cassa attesi in 5 anni, Gamma propone di pagare integralmente i debiti privilegiati (banche ipotecarie, dipendenti, Fisco privilegiato) e di pagare il 30% dei debiti chirografari in 5 anni. I creditori chirografari stimano che in un fallimento prenderebbero forse il 10%, quindi la proposta è conveniente. Viene nominato il commissario, l’azienda continua a funzionare; i creditori votano favorevolmente (superando la maggioranza richiesta); il tribunale omologa. Gamma esce dal concordato e, sotto monitoraggio del commissario (ora nominato come attestatore di fine esecuzione), nei successivi anni paga le percentuali dovute ai creditori. Se Gamma per ipotesi non rispettasse i pagamenti, ci sarebbero meccanismi sanzionatori (revoca del concordato e dichiarazione di liquidazione giudiziale), ma ipotizziamo adempia. In questo scenario, l’azienda è salva, i creditori hanno avuto più di quanto avrebbero ottenuto dal fallimento, l’imprenditore ha mantenuto la titolarità (anche se magari l’investitore nuovo avrà preso quote societarie), e i posti di lavoro sono stati conservati. Il costo è stato sopportare la procedura (oneri legali e di commissario, tempi, pubblicità della cosa che può aver dissuaso qualcuno dal far affari durante il concordato).
Esempio di concordato liquidatorio: Delta S.p.A. invece è decotta al punto da non poter proseguire l’attività. Presenta un piano di concordato liquidatorio: tutti i suoi beni (immobili, brevetti, magazzino) saranno venduti in asta sotto controllo del giudice, oppure assegnati a un assuntore (un soggetto terzo che si incarica di pagarne il valore ai creditori). Dalla liquidazione si stima di ricavare €2 milioni; i creditori chirografari sono esposti per €10 milioni, ma grazie a qualche contributo esterno Delta propone di dare loro 25% (2.5 milioni) – superando così la soglia 20%. I privilegiati saranno soddisfatti col realizzo dei beni su cui vantano prelazione. I creditori, pur insoddisfatti, capiscono che in un fallimento prenderebbero forse il 15%, quindi votano sì (o se votassero no, Delta potrebbe chiedere ugualmente l’omologa dimostrando la convenienza). Il concordato viene omologato e un liquidatore giudiziale (spesso l’ex commissario) esegue il piano: vende i beni, distribuisce il 25% pattuito ai chirografari e chiude la procedura. L’azienda cessa di esistere, ma almeno lo fa in maniera ordinata e l’imprenditore evita le conseguenze peggiori di un fallimento (ad es. niente indagine penale per bancarotta salvo reati pregressi gravi, perché il concordato eseguito esenta dai reati di bancarotta semplice e preferenziale ex art. 324 CCII; inoltre l’imprenditore può tornare in attività prima, senza le interdizioni tipiche post-fallimentari).
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: introdotto nel 2021 e ora nel Capo II, Titolo II, Parte Prima CCII, è uno strumento riservato solo al caso in cui la composizione negoziata sia fallita. Se l’esperto attesta che le trattative non hanno prodotto un accordo risolutivo, l’imprenditore può, entro 60 giorni, chiedere al tribunale l’omologazione di un concordato semplificato liquidatorio senza voto dei creditori. È una scorciatoia: i creditori non votano, il tribunale valuta direttamente la fattibilità e la convenienza della proposta (che comunque deve garantire il rispetto delle priorità dei privilegi e il pagamento di almeno il 20% ai chirografari, analogamente al concordato liquidatorio ordinario). Se omologa, si procede poi a liquidare i beni con l’ausilio di un ausiliario nominato (simile a un liquidatore). Questo istituto è stato pensato per non spaventare le imprese dall’usare la composizione negoziata: se anche non si trova accordo coi creditori in via negoziale, c’è sempre una via d’uscita che evita di cadere direttamente in fallimento, permettendo di chiudere la partita in concordato unilaterale. Nella pratica, il concordato semplificato è poco usato finora, perché la maggior parte dei casi cerca di trovare soluzioni condivise. Ma è bene sapere che esiste come opzione di ultima istanza.
Confronto e strategia: Il concordato preventivo è il massimo strumento difensivo a disposizione del debitore, perché consente di congelare tutti i debiti e imporre una soluzione anche a chi non è d’accordo (purché la maggioranza lo sia e il tribunale la convalidi). Tuttavia, è un’arma da usare con cautela: una volta presentata domanda di concordato, l’azienda entra in una sorta di osservazione pubblica (registro imprese, nominativi di commissario e giudice delegato, ecc.), la fiducia del mercato può ridursi, e se il piano non è realistico si rischia solo di aver allungato l’agonia e aggravato il dissesto (con possibili responsabilità per gli amministratori). Inoltre, il concordato, pur volontario, è comunque un’ammissione formale di crisi che prelude, se fallisce, al fallimento vero e proprio. Quindi, in una scala di gradualità, spesso si tenta prima una via extra-giudiziale (piano attestato) o semi-giudiziale (accordo 182-bis, composizione negoziata) e solo se queste non vanno, si ricorre al concordato preventivo. Ciò non toglie che, in situazioni di dissesto avanzato o con troppi creditori per poter trattare individualmente, il concordato deve essere la prima scelta, per prendere in mano la situazione e bloccare i creditori prima che essi facciano collassare l’azienda con iniziative disordinate.
Nota sulle procedure minori: Se per ipotesi l’azienda di trasduttori fosse stata così piccola da non superare i limiti di fallibilità (art. 2 LF: attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k) oppure fosse una ditta individuale, non avrebbe accesso al concordato preventivo ordinario, ma potrebbe usare il concordato minore o il piano di ristrutturazione del consumatore (se persona fisica). Il concordato minore è molto simile al concordato preventivo ma su scala ridotta e destinato a chi era “non fallibile”; il piano del consumatore riguarda i debiti personali dell’imprenditore non fallibile. In ogni caso, il panorama normativo dopo la riforma del 2022 ha integrato le vecchie procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) nel Codice della crisi, offrendo anche ai piccoli debitori strumenti per composizioni dei debiti. Poiché il nostro focus è su una S.r.l./S.p.A. industriale, abbiamo trattato gli strumenti principali per imprese medio-grandi.
Proteggere i beni personali del debitore e dei garanti
Una preoccupazione centrale dell’imprenditore (socio o amministratore) di un’azienda indebitata è come proteggere il proprio patrimonio personale: casa di abitazione, risparmi familiari, altri beni estranei all’attività d’impresa. Come visto, una delle finalità della struttura societaria a responsabilità limitata è proprio segregare il rischio d’impresa, ma tale separazione può saltare in specifiche circostanze. Esaminiamo dunque le situazioni da evitare e le strategie di tutela:
1. Evitare condotte che portano a responsabilità personali:
La prima linea di difesa è gestire correttamente la crisi. Molte volte gli imprenditori incorrono in responsabilità personali non tanto per la crisi in sé, quanto per errori di gestione durante la crisi. Ad esempio: – Non aggravare il dissesto deliberatamente: se l’impresa è insolvente, continuare a fare nuove forniture senza pagare o accumulare ulteriori debiti può configurare profili di dolo o colpa grave verso i creditori. In un eventuale fallimento, il curatore potrebbe promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori per aver aggravato il passivo (oltre che denunce per bancarotta preferenziale se hanno pagato qualcuno preferendo altri). Seguire i doveri di cui all’art. 2086 c.c. (assetti adeguati, rilevazione tempestiva crisi) e attivarsi prontamente (ricorrendo agli strumenti di composizione della crisi) è anche funzionale a evitare accuse di mala gestio. La giurisprudenza odierna, supportata dall’art. 2486 c.c. novellato, presume il danno risarcibile in caso di ritardo nell’istanza di procedura concorsuale : dunque più tardi ci si muove, maggiore il rischio per gli amministratori di dover coprire il buco con denaro proprio. – Mantenere una contabilità regolare: l’assenza di scritture contabili o il loro disordine può peggiorare molto la posizione dell’organo amministrativo. Non solo impedisce eventuali ristrutturazioni (poiché manca fiducia), ma in caso di fallimento integra reato di bancarotta (documentale) e rende difficilissima la difesa in azioni di responsabilità (il giudice può quantificare il danno usando il criterio del deficit fallimentare in mancanza di conti attendibili). Dunque, per proteggersi, l’imprenditore deve continuare a tenere i libri in modo diligente anche in tempi bui e anzi predisporre con cura la documentazione richiesta se intraprende procedimenti come concordati o composizione negoziata. – Non distrarre beni dall’azienda per sottrarli ai creditori: questo è fondamentale. Operazioni come trasferire l’immobile sociale ai soci o a familiari per timore dei creditori, vendere macchinari sottocosto a società vicine, prelevare indebitamente liquidità dall’azienda in crisi sono atti pericolosissimi. Oltre a poter essere revocati (inefficaci) in un successivo fallimento, possono costituire reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale o preferenziale. Una condanna per bancarotta fraudolenta implica pene detentive e l’interdizione dai ruoli gestori. Conviene molto di più seguire le vie legali (ad es. un concordato, in cui magari l’imprenditore può destinare una parte di patrimonio personale al soddisfacimento parziale dei creditori, ottenendo in cambio l’esdebitazione residua). – Pagare i debiti strategici o obbligatori per legge: se l’azienda è in difficoltà, bisogna scegliere le priorità. Alcuni debiti, se non pagati, generano responsabilità personali o guai maggiori: i debiti IVA e contributivi, ad esempio, come detto, possono portare a denunce penali per gli amministratori. In linea generale, l’omesso versamento IVA oltre la soglia rilevante genera reato: l’amministratore sarà imputabile personalmente (la società in quanto tale non è soggetto penalmente responsabile per quel reato). Non c’è protezione del patrimonio che tenga in caso di condanna: lo Stato potrebbe aggredire beni personali per recupero delle sanzioni e multe, e il casellario macchiarsi. Dunque, se possibile, le risorse vanno allocate per evitare violazioni penal-tributarie (anche attivando strumenti come il ravvedimento operoso, la rateazione prima della soglia penale, etc.). Allo stesso modo, i debiti verso dipendenti: se non si pagano gli stipendi, al di là dell’azione civile, si rischiano denunce per mancata corresponsione di retribuzioni (illecito amministrativo grave) e per contributi omessi (penale oltre soglia). Pagare i dipendenti in prededuzione in un concordato è spesso necessario per la continuità, ma anche se non si fa il concordato, il datore di lavoro rischia sul piano personale se i dipendenti sporgono querela per alcune fattispecie (es. art. 603-bis c.p. “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” in casi estremi). Insomma, pagare il Fisco e i lavoratori per quanto possibile è una priorità sia morale che di autotutela per l’imprenditore, e se proprio non si riesce, allora è meglio istituzionalizzare la situazione aprendo una procedura concorsuale dove quelle pendenze saranno trattate legalmente (ad esempio, in concordato si può ottenere che il reato di omesso versamento IVA non sia punibile se il concordato viene poi omologato e adempiuto). – Usare consulenti esperti e trasparenti: agire con leggerezza o con consigli improvvisati può portare a errori fatali. Ad esempio, a volte imprenditori disperati pensano di svuotare la società trasferendo beni a una nuova società e lasciando la vecchia fallire (“phoenix company”). Questa pratica è quasi sempre scoperta e sanzionata come bancarotta fraudolenta e può condurre a report di responsabilità anche dei consulenti coinvolti. Invece, rivolgersi ad avvocati e commercialisti specializzati nella crisi permette di studiare strategie lecite di conservazione del valore aziendale (ad esempio, una pre-pack sale in concordato: vendere l’azienda a terzi nel contesto protetto del concordato, per massimizzare il ricavato senza incorrere in frodi).
2. Salvaguardare il patrimonio personale prima e durante la crisi:
Ci sono strumenti legali di pianificazione patrimoniale che, se predisposti per tempo (quando l’impresa è ancora in bonis), aiutano a proteggere i beni dell’imprenditore da eventuali vicende negative future. Alcuni di questi sono: – Separazione dei patrimoni tra coniugi: se l’imprenditore è sposato, adottare il regime della separazione dei beni evita che i creditori aziendali possano toccare beni intestati al coniuge che non ha parte nell’attività. Ad esempio, intestare la casa di abitazione al coniuge non socio può offrire un riparo, fatte salve eccezioni (se la casa è stata data in garanzia o se il trasferimento è avvenuto a titolo gratuito poco prima del dissesto potrebbe essere revocato). Questa è una scelta da fare a monte: farlo ad insolvenza conclamata potrebbe essere considerato un atto in frode ai creditori revocabile se entro 2 anni o, se molto sotto prezzo, addirittura bancarotta. – Trust o vincoli di destinazione: l’imprenditore può valutare di segregare alcuni beni personali in un trust o in fondi patrimoniali/vincoli ex art.2645-ter c.c., destinandoli ai bisogni familiari. Ad esempio, porre la casa in un trust familiare amministrato da un terzo per i figli. Se il trust è istituito non in prossimità dell’insolvenza e per scopi legittimi di pianificazione, i creditori futuri dell’imprenditore non potranno aggredire quei beni (salvo dimostrare che il trust fu fatto in frode specifica, il che richiede azioni revocatorie entro certi termini e prova dell’intento fraudolento). La giurisprudenza è variegata sui trust, ma ne riconosce la validità se non sono meramente auto-dichiarati in funzione anti-creditoria. Anche il patto di famiglia può essere utile per trasferire l’azienda ai figli separando indennizzi, ma è più strumento di successione che di protezione da creditori. – Assicurazioni e previdenza integrativa: somme versate su polizze vita o fondi pensione godono, entro certi limiti, di impignorabilità o comunque di status privilegiato (non fanno parte del fallimento se stipulate a beneficio di terzi, ad esempio). Un imprenditore prudente può collocare una parte di risparmi in strumenti assicurativi a lungo termine che siano fuori dalla portata immediata di creditori ordinari (fermo che c’è sempre la revocatoria se vengono fatti versamenti anomali per svuotare liquidità durante la decozione). – Attenzione alle garanzie personali: come già detto, la firma di fideiussioni espone il patrimonio personale. Un modo di proteggersi è negoziare limiti alle fideiussioni: ad esempio, se ci sono più soci, far sì che il rischio sia ripartito (fideiussione pro-quota e non solidale), o porre cap ai massimali garantiti, o ancora evitare di garantire con immobili di famiglia ma offrire garanzie reali su beni aziendali alternativamente. A volte è possibile ottenere la liberazione da una garanzia personale se il debito principale viene parzialmente rimborsato o rifinanziato: l’imprenditore dovrebbe cogliere queste opportunità (ad esempio convincere la banca a liberare la fideiussione se entra un nuovo garante o se la società concede un’ipoteca su un bene sociale). – Holding e società immobiliari separate: una tecnica lecita di segregazione è tenere l’immobile aziendale in una società distinta (una immobiliare leasingata ai soci) rispetto alla società operativa. Così, se la società operativa fallisce, l’immobile resta di proprietà di un soggetto giuridico diverso (fermo l’ovvio che se quell’immobiliare aveva garantito la controllata, i creditori avranno ipoteche). Questa separazione è utile anche perché l’immobile può essere protetto da aggressione diretta – i creditori della società operativa dovrebbero “risalire” alla holding o immobiliare ma se non vi sono motivi di confusione, non possono. Tuttavia attenzione: se la holding è mera schermatura e la operativa viene spolpata pagando affitti esagerati alla immobiliare dei soci, in fallimento potrebbero contestare un “gruppo di fatto” e colpire la holding. Quindi queste strutture vanno usate con correttezza e sostanza economica. – Beneficio dell’esdebitazione personale: se malauguratamente l’imprenditore si trova comunque coinvolto (ad es. fallisce la società e il socio ha dato fideiussioni e deve pagare, e non riesce) esiste uno strumento di ultima istanza: l’esdebitazione. Nel nuovo codice, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore può chiedere di essere esdebitato (liberato dai debiti residui insoddisfatti) purché abbia cooperato lealmente e non ci siano state condotte fraudolente. Ciò vale in primis per i soci illimitatamente responsabili o per l’imprenditore individuale fallito. Nel caso di S.r.l., i soci in sé non falliscono, ma se avevano garanzie personali, potrebbero essere escussi e poi dichiararsi insolventi personalmente (sovraindebitati). Per loro c’è la procedura di esdebitazione del sovraindebitato: per esempio un socio fideiussore che rimane con debiti personali verso banche può accedere al piano del consumatore o alla liquidazione controllata delle persone fisiche per chiudere la questione e ripartire pulito, se del caso. – Dissociazione da atti illegittimi: se esistono più amministratori, è saggio per i singoli dissociarsi formalmente da decisioni potenzialmente dannose o illecite. La legge prevede che l’amministratore non operativo che abbia manifestato il proprio dissenso a una operazione perniciosa può evitare la responsabilità solidale. Ad esempio, un consigliere di amministrazione che mette a verbale il proprio voto contrario all’occultamento di passività o a un’operazione rischiosa potrebbe salvarsi da future azioni di responsabilità o accuse di bancarotta, dimostrando di essersi opposto. Quindi, in collegialità, sempre far risultare a verbale eventuali contrarietà.
3. Rapporti con i creditori durante la crisi:
Proteggere i beni personali passa anche per il modo in cui ci si pone con i creditori: – Trasparenza e buona fede nelle trattative: Un debitore che affronta i creditori di petto, nascondendo la reale situazione o favorendo occultamente alcuni a scapito di altri, rischia reazioni aggressive (es: il fornitore ingannato che scopre che altri sono stati pagati lo denuncerà subito). Al contrario, se i creditori percepiscono che l’imprenditore sta agendo in buona fede e con equità, saranno più disponibili a percorsi concordati. Ciò indirettamente tutela il patrimonio del debitore perché riduce il contenzioso e la conflittualità. Ad esempio, comunicare ai creditori l’intenzione di avviare una composizione negoziata e invitarli al dialogo può prevenire istanze di fallimento e pignoramenti che spingerebbero l’imprenditore sulla difensiva (e magari a fare errori). – Negoziare le garanzie: se il patrimonio personale è già esposto, bisogna negoziare la ritirata. Ad esempio, se c’è una fideiussione su un finanziamento, si può trattare con la banca che, a fronte di un rientro parziale o di nuove garanzie aziendali (pegni su crediti, ipoteche su beni sociali), liberi il garante. Oppure, se un immobile del socio è ipotecato per un mutuo sociale, valutare la surroga dell’ipoteca su un diverso immobile societario o su beni di un terzo investitore. Insomma, usare la leva negoziale (magari all’interno di un accordo di ristrutturazione globale) per spostare il peso dai beni personali a quelli aziendali o a garanzie di terzi. Spesso i creditori sono aperti a ciò, purché il loro livello di sicurezza non diminuisca. – Non ignorare le comunicazioni ufficiali: se arrivano atti di precetto, ingiunzioni, ecc., non far finta di nulla. Questo è un errore comune di imprenditori in crisi, per imbarazzo o speranza che si risolva da sé. Invece, rispondere, incaricare subito un legale, cercare accordi stragiudiziali come moratorie temporanee (magari proponendo ai creditori di sospendere le azioni mentre si prepara un piano formale – alcuni creditori aderiscono a moratorie di 90-120 giorni se vedono serietà). Ignorare porta a decreti ingiuntivi non opposti che diventano definitivi, a pignoramenti magari su beni personali se vi sono fideiussioni, e riduce la possibilità di soluzioni guidate dal debitore.
– Spiegare la situazione ai garanti personali: se i soci o i familiari hanno garantito, coinvolgerli nella strategia è doveroso. Un garante escusso può a sua volta rivalersi sul debitore principale (la società) dopo, e comunque vorrà tutelare i propri interessi. Spesso i garanti sono gli stessi amministratori; ma se vi è, ad esempio, un genitore pensionato che ha firmato un mutuo, informarlo e magari includerlo nelle valutazioni (es. se conviene vendere un immobile di famiglia per soddisfare la banca ed evitare che pignori la casa del garante). Fa parte della protezione del patrimonio familiare considerare il nucleo come un tutt’uno nella crisi. – Valutare l’opzione di una liquidazione concordata per liberare i beni personali dalle obbligazioni: in alcuni casi, la via più pragmatica per salvare il salvabile del patrimonio privato è sacrificarne una parte in modo controllato. Esempio: il socio mette sul piatto la vendita della seconda casa per procurare liquidità da offrire ai creditori nel concordato, ottenendo però in cambio che la casa di abitazione (prima casa) resti intoccata e che dopo l’esecuzione del concordato nessuno potrà più avanzare pretese. Questo scambio è sensato e consigliabile, piuttosto che insistere a mantenere tutto e poi magari perdere tutto per vie forzose.
– Distinguere persona fisica e giuridica: sebbene possa sembrare ovvio, molti piccoli imprenditori confondono le finanze personali con quelle aziendali. Una buona pratica è tenere separati i conti: niente prelievi dal c/c aziendale per spese familiari, niente acquisti privati fatti con la carta aziendale. In caso di crisi, questa distinzione netta aiuta a evitare azioni dei creditori volte a dimostrare abusi di personalità giuridica (tipo “l’azienda è il alter ego del socio, quindi vengano i soci chiamati a rispondere”). Tali tesi sono eccezionali in Italia, ma comportamenti promiscui possono dare appigli a curatori o creditori per sostenere, ad esempio, una “super-società di fatto” tra l’imprenditore e la società di capitali, con confusione di patrimoni (concetto che la Cassazione ha a volte riconosciuto in casi limite di totale sovrapposizione) . Dunque disciplina finanziaria: i soci prendano utili formalmente se ce ne sono (non finanziamenti occulti), l’amministratore si faccia uno stipendio congruo ma non usi la cassa come bancomat.
4. Dopo la crisi: ricominciare senza zavorre illegali:
Una volta risolta o chiusa la vicenda, l’imprenditore deve poter ripartire. La legge oggi è più favorevole al fresh start, ma occorre essersi mantenuti nei binari. Ad esempio, ottenuto un concordato o accordo andato a buon fine, i debiti residui sono cancellati e l’imprenditore non è soggetto a sanzioni interdittive, può tornare a fare impresa subito. Invece, se la crisi sfocia in un fallimento con condanne per bancarotta, quella persona per anni non potrà amministrare altre società, avrà difficoltà ad ottenere credito e avrà un marchio di discredito. Dunque, proteggere il proprio futuro patrimoniale e professionale significa uscire dalla crisi “puliti”: meglio transigere e pagare qualcosa in concordato che nascondere asset in modo illecito e subire condanne.
In conclusione, la miglior difesa del patrimonio personale è una gestione accorta e tempestiva della crisi, sfruttando i benefici legali offerti dalle procedure (che di fatto, se ben utilizzate, permettono di cristallizzare le pretese ed evitare iniziative distruttive dei creditori) e affiancando ad esse una pianificazione patrimoniale prudente. Le soluzioni esistono, ma devono essere messe in campo prima che sia troppo tardi: come osserva un esperto, “la protezione del patrimonio personale deve iniziare prima di qualsiasi periodo di crisi”, con strumenti adeguati e interventi tempestivi . Se la crisi è già in atto, occorre allora impiegare tutte le leve normative disponibili per risanare l’azienda o, nella peggiore ipotesi, liquidarla in modo controllato, minimizzando l’impatto sui beni personali e garantendo all’imprenditore onesto la possibilità di ripartire.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, riportiamo due tabelle riassuntive sui principali strumenti di gestione della crisi e sulle differenze di trattamento dei creditori in base allo strumento scelto.
Tabella 1 – Confronto tra strumenti di risoluzione della crisi d’impresa
| Caratteristica | Piano Attestato di Risanamento | Accordo di Ristrutturazione (ADR) | Composizione Negoziata | Concordato Preventivo |
|---|---|---|---|---|
| Natura giuridica | Stragiudiziale puro (privato) | Ibrido: accordo privato + omologa tribunale | Stragiudiziale assistito (esperto + eventuale giudice per misure) | Procedura concorsuale giudiziale |
| Coinvolgimento creditori | Solo aderenti (consenso individuale, serve in pratica quasi unanimità di quelli principali) | Aderenti ≥ 60% crediti vincolano accordo; non aderenti estranei (devono essere pagati al 100%) | Principali creditori coinvolti in trattative guidate dall’esperto (volontaria) | Tutti i creditori coinvolti, con voto a maggioranza (classi) e vincolo anche ai dissenzienti |
| Protezione da azioni esecutive | No automatica (possibile se concordato con creditori o tramite altre procedure) | Sì su richiesta al tribunale (stay fino a 120 gg durante omologa) | Sì su richiesta (stay fino a max 12 mesi con decreto tribunale) | Sì automatica (stay per tutta la procedura dopo ammissione) |
| Attestazione di esperto | Sì, richiesta relazione attestatore indipendente sulla fattibilità | Sì, relazione attestatore indipendente obbligatoria | Sì, ma qui l’esperto è nominato ad hoc e produce varie relazioni (iniziale e finale) | Sì, relazione attestatore indipendente obbligatoria sul piano |
| Omologazione tribunale | No, nessuna omologa (solo eventuale deposito registro imprese) | Sì, omologa necessaria per efficacia erga omnes e protezioni | No omologa finale (chiusura con relazione esperto; salvo si converta in accordo o concordato) | Sì, omologa necessaria (dopo voto creditori) |
| Vantaggi principali | Riservato, flessibile; esenzione da revocatoria per atti eseguiti (se piano idoneo) ; nessun costo procedura | Coinvolge anche creditori pubblici (transazione fiscale); blocco azioni durante omologa; vincola i firmatari e può estendersi a dissenzienti finanziari; meno costoso di concordato | Rapido avvio; consulenza esperto; blocco azioni prima di procedure formali; può sfociare in qualsiasi soluzione (contratto, accordo, concordato); premialità (es. dilazione 120 rate tasse) | Impone soluzione a tutti i creditori; blocco totale dei creditori; possibile cram-down di classi dissenzienti; riduce debiti anche senza consenso unanime; esdebitazione a fine procedura per imprenditore |
| Svantaggi / Limiti | Nessun effetto sui non aderenti; nessuno stop a iniziative ostili; necessita consenso praticamente totale dei key creditors; non può imporre tagli al Fisco (solo dilazioni ordinarie) | Richiede consenso qualificato (non fattibile se troppi dissenzienti); deve pagare integralmente i non aderenti (richiede liquidità per questi); pubblicità comunque presente (registro imprese) | Non vincola se non c’è accordo finale; esito incerto (dipende da buona volontà creditori); possibile pubblicità se si chiedono misure protettive; esperto non decide nulla (solo mediatore); costi consulenze + compenso esperto | Procedura lunga e complessa; costi elevati (commissario, legali); pubblicità negativa; potenziale perdita di controllo (specie se liquidatorio); requisiti legali stringenti (20% minimo se liquidatorio; continuità monitorata); rischio di fallimento se non si ottiene/viene revocato; decisioni lente sotto autorizzazione giudice |
| Quando indicato | Crisi gestibile con pochi creditori chiave, ancora fiducia reciproca, necessità di riservatezza per non allarmare mercato | Crisi con concentrazione del debito su banche/grandi creditori disposti a negoziare; serve bind rapido e evitare voto di tanti piccoli; azienda con liquidità per soddisfare minoranza estranea | Crisi agli inizi o reversibile, imprenditore proattivo; scenario in cui serve congelare le azioni per guadagnare tempo; volontà di dialogo da parte dei creditori; quando si vuole evitare procedura formale pur necessitando aiuto terzo | Insolvenza conclamata o rischi immediati gravi; troppi creditori per accordarsi individualmente; necessità di tagliare pesantemente debiti e/o liberarsi di contratti; quando altre trattative fallite; per vendere azienda “pulita” tramite procedura competitiva |
Tabella 2 – Trattamento dei crediti e impatto sui creditori nei diversi strumenti
| Tipo di credito | Piano Attestato | Accordo Ristrutturazione | Concordato Preventivo | Fallimento (Liquid. giudiz.) |
|---|---|---|---|---|
| Banche (crediti garantiti) | Pagamento secondo accordo privato col singolo; se aderisce, può prevedere dilazione, riduzione interessi, ecc. (Nessun vincolo se non aderisce) | In genere rinegoziazione tassi/tempi; possibile stralcio se banca aderisce. Se non aderisce e ha ipoteca: fuori accordo (va pagata integrale entro 120 gg da omologa o per scadenza) | Se in continuità: può ricevere pagamento parziale dilazionato, purché ≥ valore garanzia (se dissentisce, comunque diritto a valore garanzia) <br>Se liquidatorio: di regola soddisfazione con vendita bene ipotecato; se vuole aderire può falcidiare credito a valore realizzo. Vota in classe separata se falcidiato. | Realizzo da vendita bene, meno spese: spesso recupero parziale se valore inferiore a credito; tempo lungo. Se credito residuo chirografario, riceve riparto come altri chirog. (spesso esiguo). (Può insinuarsi per intero e riceve privilegi per quota garantita) |
| Fornitori chirografari | Se aderisce all’accordo: paga secondo intesa (es: 70% entro tot mesi). Se non aderisce: da piano non ha effetti, può agire legalmente (a meno che piano vada a buon fine e fornitore venga soddisfatto lo stesso) | Se nel ≥60% aderente: avrà quanto concordato (es: 80% in 1 anno); se non aderisce: deve essere pagato integralmente entro 120 gg dall’omologa, altrimenti tribunale non omologa. Quindi di fatto non subisce perdite (salvo ritardo breve). | Sarà generalmente in classe chirografari: potrebbe ricevere percentuale (anche <100%) spesso su tempi lunghi (es: 20% in 2 anni). Vincolato dall’esito concordato anche se ha votato contro (basta approvazione maggioranza). Se concordato liquidat.: min. 20% (salvo consenso a meno). Se continuità: nessuna soglia minima , ma deve prendere ≥ scenario liquidazione. | Spesso recupera poco o nulla. Dopo anni di procedura fallimentare, i chirografari ricevono il residuo una volta pagati tutti i privilegiati e spese (statisticamente dividendi fallimentari chirografari modesti, <10%). Inoltre subisce tempi lunghi e incerti. |
| Fisco e Tributi | Puo’ solo aderire con dilazione standard (no riduzione imposta) . Se aderisce: segue piano, altrimenti resta libero di agire (cartelle, ipoteche). Piano pubblicato può dare 120 rate se esito positivo . Atti in esecuzione piano (pagamenti parziali) non revocabili se piano idoneo. | Può aderire tramite transazione fiscale: riduzione interessi/sanzioni e anche quota capitale se ≥ valore in fallimento. Se non aderisce ma accordo ha ≥60% altri creditori, si può chiedere ugualmente omologa con cram-down fiscale (giudice verifica che offerta Fisco ≥ quota fallimento) . Se omologa nonostante dissenso, Fisco vincolato a accettare i pagamenti come da piano. Non aderenti pubblici devono comunque ricevere integrale entro 120 gg se non transati. | Se concordato prevede falcidia o dilazione imposte: deve contenere proposta transazione fiscale. Fisco vota in classe privilegiati. Se vota contro ma concordato offre >=quoziente fallimentare, tribunale può omologare lo stesso (cram-down fiscale) . In continuità, IVA e ritenute non possono essere falcidiate nel capitale (devono essere pagate integralmente, norma speciale art. 84 co.6 CCII), ma possono avere interessi ridotti o dilazioni. In liquidatorio, anche IVA può essere stralciata purché prenda almeno quanto in fallimento. Post omologa, Fisco vincolato alla quietanza dei debiti come da piano e non può più rivalersi per la parte stralciata. | Se fallimento: Fisco insinua crediti (in parte privilegiati, in parte chirografari). Se attivo sufficiente, privilegiati (IVA, ritenute) verranno soddisfatti in prededuzione/priorità; spesso però c’è insufficienza e anche Fisco prende solo frazione. Nessuna riduzione formale sanzioni: vengono ammesse per intero ma poi pagate pro-quota. Procedimento può durare anni; per mancanza attivo, può non riscuotere nulla (specie sanzioni che sono chirografarie). |
| Dipendenti (stipendi, TFR) | Tendenzialmente l’impresa cercherà di pagarli per intero anche se non formalmente obbligata (per motivi operativi). Se piano prevede dilazioni su arretrati, deve ottenere consenso dei lavoratori o mantenerli fuori (meglio non toccare questo ambito via piano privato, rischio di azioni sindacali). | Non vengono quasi mai “tagliati” in accordo: di solito esclusi (pagati fuori accordo con risorse dedicate, anche perché privilegio altissimo). Possono essere inclusi solo come aderenti se accettano qualche dilazione su arretrati, ma comunque vanno pagati integrali. Per omologa, i non aderenti (es. un lavoratore) va pagato 100% entro 120 gg, quindi di fatto non subisce decurtazioni. | In concordato in continuità, gli stipendi e TFR maturati prima del deposito: se si vuole mantenere i dipendenti occorre saldarli o almeno garantire Fondo INPS che copra; per legge i crediti di lavoro privilegiati di solito vanno soddisfatti al 100% (possono essere dilazionati un po’, ma non falcidiati se privilegio capiente). Nel liquidatorio, ultimi 12 mesi stipendi e TFR hanno super-privilegio su attivo mobiliare: il piano deve prevedere pagamento integrale di tali crediti prima di dare qualcosa ai chirografari. Quindi i lavoratori generalmente prendono l’intero (possono essere soddisfatti anche via Fondo Garanzia INPS che poi subentra). Votano solo se prevedi di non pagarli interi (cosa rara e difficile da far approvare). | In fallimento: i dipendenti possono richiedere subito accesso al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime 3 mensilità impagate; quindi recuperano quelle voci a breve. Il resto (eventuali altre spettanze) sta tra i privilegiati: di solito sono soddisfatti in percentuale molto alta se attivo sufficiente (perché vengono prima dei crediti erariali nel grado generale). I tempi però possono essere lunghi per eventuali riparti. |
| Soci finanziatori (prestiti soci) | Considerati postergati per legge (non possono esigere rimborso finché altri creditori soddisfatti). In un piano, se l’azienda vuole risanarsi, di norma i soci rinunciano ai crediti o li convertono in capitale. La loro adesione è scontata (non chiedono rimborsi durante crisi). | I soci finanziatori non contano nel quorum (posti ultimo rango). Possono formalmente aderire rinunciando ai crediti. Spesso l’accordo prevede azzeramento crediti soci. | Nel concordato, i crediti dei soci sono postergati: non prendono nulla finché tutti gli altri non prendono il dovuto. Di fatto non votano e non ricevono distribuzioni, salvo l’eventuale surplus che raramente c’è. Potrebbero convertirli in capitale se fa parte del piano. | Nel fallimento, i crediti dei soci sono subordinati: vengono ammessi in coda e quasi mai prendono qualcosa (solo se per assurdo tutti gli altri crediti venissero soddisfatti al 100%, evento raro). |
Dalle tabelle emerge chiaramente che strumenti come concordato e accordi omologati permettono di ridurre i debiti chirografari e rimodulare quelli privilegiati (salvo eccezioni) in modo molto più incisivo rispetto ad accordi meramente privati, ma richiedono procedure più complesse e tempi maggiori. La scelta va fatta valutando il mix di creditori, l’entità del debito, la necessità di continuità aziendale e le risorse disponibili. Spesso le vie si combinano: ad esempio, una composizione negoziata può sfociare in un concordato preventivo in continuità, oppure un piano attestato può essere seguito da un accordo di ristrutturazione per “inglobare” il Fisco.
Domande Frequenti (FAQ) su debiti aziendali e difesa del debitore
D: La mia S.r.l. ha troppi debiti e non riesce a pagarli tutti: rischio il fallimento?
R: Il fallimento (ora liquidazione giudiziale) viene dichiarato dal Tribunale su istanza di un creditore, della Procura o dell’imprenditore stesso, quando l’impresa si trova in stato d’insolvenza, ossia incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Se la tua S.r.l. ha troppi debiti scaduti e i creditori iniziano azioni esecutive o istanze di fallimento, il rischio c’è. Tuttavia, puoi giocare d’anticipo: attivando una procedura concorsuale (come il concordato preventivo) o uno strumento di allerta/negoziazione (come la composizione negoziata), puoi temporaneamente bloccare i creditori e proporre tu una soluzione. Inoltre, se la tua impresa è “risanabile” (ha prospettive di recupero), i giudici tendono a favorire soluzioni diverse dal fallimento, purché siano concretamente attivate. Quindi, il rischio di fallimento esiste ma puoi ridurlo muovendoti per tempo e utilizzando gli strumenti di ristrutturazione previsti dalla legge. In nessun caso ignorare il problema farà evitare il fallimento: anzi, l’inattività è spesso causa di iniziative dei creditori.
D: Possono portarmi via la casa o altri beni personali per pagare i debiti della società?
R: In linea di principio, per una S.r.l. o S.p.A., no: i debiti sociali si soddisfano sul patrimonio sociale e i beni personali dei soci non sono aggredibili dai creditori della società . Tuttavia, ci sono importanti eccezioni. Primo, se tu o altri soci avete fornito garanzie personali (fideiussioni, pegni su beni personali) a favore di creditori della società, questi possono escuterle: ad esempio, la banca può pignorare la tua casa se hai firmato fideiussione sul mutuo aziendale e la società non paga. Secondo, se sei anche amministratore, potresti essere ritenuto responsabile in proprio per alcune obbligazioni: ad esempio, in caso di omessi versamenti IVA o ritenute oltre soglie penali, l’amministratore commette reato e il Fisco può aggredire anche il suo patrimonio personale (mediante sanzioni penali pecuniarie e confische). Ancora, se la società fallisce e ha patrimonio insufficiente, un curatore potrebbe intentare un’azione di responsabilità contro gli amministratori per mala gestio: in caso di condanna, il risarcimento lo pagano loro con i beni personali. Infine, se sei socio di fatto o hai mescolato conti personali e aziendali, qualche creditore potrebbe tentare di dimostrare un abuso della personalità giuridica e coinvolgere il tuo patrimonio (caso raro e complesso, ma teoricamente possibile in presenza di frodi). Quindi: di base la casa è al sicuro dai normali debiti aziendali, ma non lo è se l’hai data in garanzia o se hai violato obblighi legali. Per tutelarti, cerca di non firmare garanzie personali se non strettamente necessario, oppure predisponi alternative (garanzie reali sociali). E gestisci la società in modo corretto per non incorrere in responsabilità extra (non fare distrazioni, non aggravare i debiti volontariamente, ecc.).
D: Cos’è esattamente la “composizione negoziata” di cui sento parlare? È diversa dal concordato?
R: La composizione negoziata è uno strumento introdotto di recente (fine 2021) per aiutare le imprese in crisi a trovare una soluzione concordata con i creditori prima di dover ricorrere a procedure concorsuali formali. In pratica, l’imprenditore chiede che venga nominato un esperto indipendente (un professionista terzo) il quale lo assiste nel negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione. È una procedura volontaria e riservata: non è il tribunale a gestirla (se non per dare eventuali protezioni), e non implica né spossessamento né voto dei creditori. Dura qualche mese, durante i quali l’esperto cerca di mettere d’accordo le parti. Può concludersi con vari esiti: un contratto con alcuni creditori, un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato preventivo, un piano attestato o – se proprio non si trova nulla – l’accesso al concordato semplificato o al fallimento. È diversa dal concordato: il concordato è una procedura concorsuale formale dove i creditori votano e un giudice omologa. La composizione negoziata invece è una trattativa assistita extragiudiziale – pensa a una mediazione, ma per crisi d’impresa, con l’aggiunta che puoi ottenere la sospensione dei pignoramenti per il tempo delle trattative. In sintesi: col concordato imponi un accordo ai creditori attraverso il tribunale; con la composizione negoziata cerchi un accordo di comune soddisfazione con l’aiuto di un mediatore, restando fuori dalle procedure giudiziarie (almeno finché non decidi di formalizzare eventualmente quell’accordo). Spesso la negoziazione è propedeutica: se riesce bene, magari formalizzi con un accordo omologato; se non riesce, avrai comunque esplorato le possibilità prima di passare a un concordato o arrenderti al fallimento.
D: La società ha debiti col Fisco insostenibili (IVA, tasse) – possiamo trattare anche quelli?
R: Sì, ma solo attraverso determinati strumenti formali. Al di fuori di una procedura concorsuale o accordo omologato, l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali non possono acconsentire a ridurre l’importo dei tributi dovuti (capitale). Possono tuttavia concedere rateizzazioni fino a 6 anni (72 rate) secondo regole standard, e recentemente – se la tua azienda accede alla composizione negoziata e raggiunge un accordo di risanamento – puoi chiedere fino a 120 rate mensili per i debiti fiscali . Ma lo stralcio di parte dei tributi o delle sanzioni è possibile solo con la cosiddetta transazione fiscale, inserita in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione omologato. In un concordato, ad esempio, puoi proporre di pagare solo il 50% dell’IVA e azzerare sanzioni e interessi, purché dimostri che in caso di fallimento il Fisco prenderebbe ancora meno e che questa è la miglior soluzione realizzabile . Se il Fisco (che vota in classe di privilegio) rifiuta, il tribunale può comunque omologare se ritiene soddisfatta la condizione di convenienza per l’Erario. Lo stesso avviene negli accordi di ristrutturazione: puoi includere l’Agenzia in un accordo (abbattendo sanzioni e magari parte del capitale) e se non aderisce ma gli offri il massimo realizzabile, puoi chiedere al giudice di approvare l’accordo ugualmente (c.d. cram-down fiscale) . Quindi, in sostanza, puoi trattare col Fisco, ma devi farlo all’interno di una cornice legale specifica. In via informale, l’unica trattativa ammessa è sul calendario dei pagamenti (rate). Infine, ricorda: alcuni tributi come l’IVA e le ritenute previdenziali non possono essere falcidiati nel concordato in continuità (vanno pagati integralmente, possono al più essere dilazionati): è un vincolo di legge a tutela delle entrate erariali. Viceversa, in un concordato liquidatorio anche l’IVA può essere stralciata (sent. Corte Cost. 225/2014 lo consentì, e la regola è rimasta nel CCII) purché lo Stato prenda almeno quanto otterrebbe liquidando i beni.
D: Ho sentito parlare del 20% minimo ai chirografari: significa che devo pagare per forza almeno il 20% dei debiti in ogni caso?
R: Solo in caso di concordato preventivo liquidatorio (ossia senza continuità aziendale) la legge richiede che la proposta preveda un pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari (non privilegiati) . Questa soglia non si applica se nel concordato c’è una continuità aziendale (diretta o indiretta): in tal caso si può teoricamente offrire ai chirografari anche meno del 20%, se ciò è il massimo possibile, a patto che venga comunque dimostrato che riceveranno di più che in caso di fallimento e che almeno una classe di creditori accetta la proposta . Per gli accordi di ristrutturazione e gli strumenti stragiudiziali, non esistono percentuali minime fissate per legge – dipende tutto dalla negoziazione e dalla convenienza comparativa. Naturalmente per convincere i creditori ad aderire a un accordo privato, offrire meno del 20% potrebbe essere molto difficile salvo che la liquidazione sarebbe zero. Quindi il 20% è più una soglia legale per i concordati liquidatori. Se la tua azienda è in grado di pagare solo, ad esempio, il 10%, potresti ancora perseguire un concordato in continuità (mostrando che in fallimento i chirografari avrebbero magari il 3% e che il 10% è il meglio realizzabile col proseguimento dell’attività). Fuori dal concordato, puoi accordarti per qualunque percentuale con i creditori consenzienti (ho visto accordi stragiudiziali dove i creditori hanno accettato il 5% subito pur di chiudere, perché magari in fallimento non avrebbero preso nulla). Dunque: il “20% minimo” è un parametro da tenere a mente solo se scegli un concordato puramente liquidatorio.
D: Ho già ricevuto un decreto ingiuntivo da un fornitore e la banca minaccia revoca dei fidi: come posso fermarli immediatamente?
R: Per congelare nell’immediato le azioni dei creditori hai essenzialmente due strade: 1. Presentare un ricorso per concordato preventivo “in bianco” (con riserva). È la cosiddetta domanda prenotativa ex art. 44 CCII: depositi l’istanza di concordato senza piano completo, ottenendo subito le misure protettive (automatic stay) e poi hai fino a 120 giorni (prorogabili a 180) per presentare il piano e la proposta definitiva. Questa mossa, però, è un “colpo forte”: equivale a dichiarare pubblicamente che stai andando in concordato, va ponderata perché verrà pubblicata al Registro Imprese e può avere effetti sui rapporti (es. i clienti e fornitori lo sapranno). Però è efficace: dalla data di deposito, nessun creditore può iniziare o proseguire esecuzioni, e anche le revoche di fido devono passare al vaglio del tribunale se le ritieni abusivamente ritorsive. Tieni conto che dovrai poi seguire con un vero concordato, altrimenti rischi il fallimento se non presenti nulla di valido. 2. Attivare la composizione negoziata e contestualmente chiedere al tribunale le misure protettive. In 2-3 giorni dalla domanda ti nominano l’esperto, e puoi depositare istanza di protezione del patrimonio: se il giudice la concede, i creditori (incluso chi ti ha fatto decreto ingiuntivo) non possono procedere oltre (il fornitore non potrebbe pignorare, la banca non dovrebbe revocare fidi pena violare la sospensione contrattuale prevista per legge durante le trattative). Questa via è meno stigmatizzante inizialmente (anche se le misure protettive vengono annotate in visura camerale, quindi un po’ di pubblicità c’è). Ti consente però di avere fino a 12 mesi di tempo protetto per cercare una soluzione con quell’esperto che media. Entrambe le strade richiedono di essere serio nella volontà di risanamento: il tribunale, sia in caso di concordato in bianco sia in caso di composizione negoziata, vuole vedere che c’è una possibilità di risanare o quantomeno una proposta concreta. Non è pensabile ottenere lo stay e poi stare fermi. Se non fai nulla, il tribunale può revocare le protezioni (es. nel concordato in bianco può dichiarare improcedibile l’istanza e subito eventualmente aprire il fallimento su istanza del creditore). In alternativa alle protezioni giudiziali, puoi provare a negoziare “standstill” privati: convincere banca e fornitore a sospendere le azioni per un breve periodo mentre prepari un piano. Ma se hai già decreto ingiuntivo, il fornitore potrebbe non fidarsi delle sole parole. Quindi, realisticamente, se vuoi fermare subito le azioni, l’ombrello del tribunale è il modo più sicuro. La scelta tra concordato in bianco e composizione negoziata dipende da quanto pensi sia fattibile un accordo con i creditori e quanta pubblicità/struttura vuoi dare al processo. Composizione negoziata è più orientata al dialogo e flessibile; il concordato è più impositivo ma anche più drastico.
D: In caso di fallimento poi dovrò pagare i debiti restanti come socio o amministratore?
R: Se viene dichiarato il fallimento della società, questa andrà in liquidazione giudiziale e al termine, dopo aver liquidato il patrimonio, verrà cancellata. I debiti residui della società rimarranno insoddisfatti ma non potranno essere fatti valere sui soci (salvo siano soci illimitatamente responsabili, ma non è il caso di S.r.l./S.p.A.). Dunque tu come socio non dovrai pagare di tasca i debiti residui della società fallita. Neppure come amministratore c’è un obbligo di pagarli: sarà il curatore semmai a pagarne una parte ai creditori col ricavato e il resto viene cancellato con la chiusura del fallimento (la società cessa). Tuttavia, attenzione: il fallimento comporta possibili azioni contro amministratori e altri responsabili. Quindi se il curatore ritiene che il dissesto è stato aggravato o causato da gestioni colpose o dolose, potrebbe citare in giudizio te (e gli altri amministratori) chiedendo un risarcimento a favore dei creditori. Se un giudice civile ti condannerà, quel risarcimento dovrai pagarlo tu – e il ricavato andrà nella massa fallimentare per aumentare il soddisfacimento dei creditori. Inoltre, come accennato, dopo il fallimento i creditori non possono più agire contro la società (perché è spossessata, gestisce tutto il curatore), però possono (anche durante) agire contro eventuali fideiussori personali. Quindi se tu hai garantito il debito bancario, la banca potrebbe bypassare il fallimento e colpire direttamente te per la parte non soddisfatta nel fallimento. Infine, terminato il fallimento della società, tu come persona fisica non sei coinvolto dal punto di vista del dover pagare quei debiti – ma se il fallimento non ha pagato tutti, i creditori restano insoddisfatti e magari se tu hai altre società potrebbero essere diffidenti in futuro. Diciamo che l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti residui) opera per la società, non per i garanti. Nel vecchio regime i soci falliti personalmente potevano chiedere esdebitazione; ora per le società di capitali non rileva perché non c’è persona fisica fallita. In sintesi: no, non dovrai col tuo patrimonio coprire i debiti rimasti, ma potresti dover risarcire danni se ti vengono imputati e sicuramente risponderai delle garanzie personali date.
D: Conviene coinvolgere un professionista già in fase di allerta o posso aspettare?
R: Conviene assolutamente coinvolgere prima possibile un professionista esperto di crisi d’impresa (avvocato o commercialista) non appena si manifestano segnali di crisi significativi. I motivi: 1) La normativa attuale pone un dovere agli amministratori di attivarsi alla percezione degli indizi di crisi: rivolgersi a un esperto è di per sé un adempimento diligente. 2) Un professionista può aiutarti a fare una diagnosi corretta della situazione e a predisporre un piano (anche solo di emergenza) per gestire i creditori, prima che degeneri. 3) Molti strumenti (concordato, accordi, composizione negoziata) richiedono documentazione tecnica e attestazioni: non sono cose improvvisabili all’ultimo minuto. Se aspetti troppo, rischi di doverle fare in fretta e furia e magari male. 4) Coinvolgere un esperto terzo può anche rassicurare i creditori sulla serietà con cui affronti la crisi, predisponendoli a concessioni. Immagina la differenza tra “vi prometto che vi pago prima o poi” detta dall’imprenditore e “abbiamo incaricato un advisor e stiamo elaborando un piano di rientro certificato”: la seconda suona molto più credibile. In definitiva: aspettare può farti perdere opportunità (ad esempio, se arrivi troppo tardi, alcuni strumenti come la composizione negoziata potrebbero non essere più utili, e resterà solo il fallimento). C’è un proverbio tra gli advisor: “Time is the enemy in a restructuring” – il tempo è nemico, prima agisci più opzioni hai. Dunque, anche se costa, coinvolgi subito dei professionisti competenti: spesso il costo di un buon consulente è di gran lunga inferiore alle perdite che si evitano gestendo bene la crisi.
D: Una volta chiuso un concordato o accordo, i creditori possono ancora reclamare qualcosa?
R: Se il concordato preventivo viene omologato dal tribunale e tu (debitore) adempi integralmente la proposta come omologata, i creditori rimasti insoddisfatti nella percentuale residua non possono più avanzare pretese legali. Il concordato ha effetto esdebitativo: significa che libera il debitore dai debiti anteriori per la parte non pagata secondo il piano. Ad esempio, se in concordato hai pagato il 30% a un fornitore, il restante 70% è cancellato e non più esigibile. I crediti vengono considerati definitivamene soddisfatti nei limiti della percentuale concordataria. Chiaramente, devi aver rispettato il piano: se non paghi quelle percentuali, il concordato può essere risolto e allora i creditori riacquistano i loro diritti originari (tolto magari quanto hanno ricevuto). Per gli accordi di ristrutturazione omologati vale simile: i creditori aderenti sono contrattualmente vincolati alla riduzione concordata del credito; i non aderenti sono stati comunque pagati fuori (quindi non hanno residui da reclamare). Un accordo omologato fa stato di giudicato tra le parti: quindi se hai una transazione fiscale approvata con sconto su sanzioni, lo Stato non può poi richiedertele a posteriori. Diverso per un piano attestato privato: se non c’è omologa, giuridicamente i creditori rinunciano alle parti di credito nelle scritture private e quelle rinunce sono definitive tra loro, però se la società poi fallisce entro 2 anni, i creditori potrebbero subire revocatorie su i pagamenti ricevuti in più rispetto al dovuto par condicio se il piano era inidoneo . Ma se funziona, anche lì i creditori hanno firmato e non possono chiedere altro. In conclusione: concordato e accordi ti danno quietanza tombale sui debiti trattati, a patto di eseguire fedelmente quello stabilito. Nota che questo non copre eventuali debiti verso garanti: ad esempio, se un terzo ha pagato parte dei creditori per liberarti, quel terzo potrebbe aver diritto di rivalsa verso di te salvo abbia rinunciato (è subentrato nella posizione del creditore). Ma in sede di concordato di solito si estinguono tutte le obbligazioni collegate. Quindi sì, dopo una crisi risolta col buon esito di quegli strumenti, riparti pulito, i creditori non possono legalmente pretendere la quota tagliata dei loro crediti. Un residuo particolare: in passato i concordati non liberavano i coobbligati/garanti (es. se c’era un fideiussore, potevi ridurre il debito del debitore principale ma il garante restava obbligato per l’intero salvo patto contrario). Con la riforma, ora anche i fideiussori beneficiano degli effetti del concordato se il creditore ha potuto soddisfarsi parzialmente . Ciò significa che se chiudi col 30% in concordato, il creditore non può poi farsi dare il 70% dal tuo garante (salvo questi avesse rinunciato a tale protezione). Questa è una novità di coordinamento importante che tutela anche i garanti (è opportuno comunque verificare le clausole di fideiussione). Nel dubbio, meglio far aderire formalmente anche i fideiussori alla proposta transattiva così da includerli.
D: Se la mia società fallisce e poi ottengo l’esdebitazione come persona, posso aprire una nuova società e ripartire?
R: Se tu personalmente non sei fallito (perché era una società di capitali), l’esdebitazione riguarda la società e essa cessa. Tu come persona puoi certamente aprire una nuova attività (anche subito, non c’è preclusione se non eventuali interdizioni per condanne penali in caso). Se invece tu fossi anche fallito (ad es. come socio illimitato di una SNC o come ditta individuale), allora puoi chiedere l’esdebitazione al termine del fallimento: una volta ottenuta (cancella i debiti personali residui), nulla ti vieta di avviare un nuovo business. Anzi, l’obiettivo delle norme recenti è proprio non tenere imprenditori capaci fuori dal mercato troppo a lungo per colpe sfortunate. Attenzione però: le limitazioni legali. Durante la procedura di fallimento (liquidazione giudiziale) l’imprenditore insolvente non può ricoprire cariche (non può amministrare altre società senza informare i soci, e comunque difficilmente otterrebbe fiducia da banche). Dopo la chiusura, se esdebitato, torna pulito sul piano civile. Restano possibili problemi di reputazione o bancabilità (le banche nei sistemi interni segnalano pregressi fallimenti). Ma legalmente sei libero di tornare a fare impresa. Il Codice della crisi prevede però che se vuoi accedere di nuovo a strumenti concorsuali entro un certo periodo, devi aver rispettato gli obblighi di un eventuale concordato precedente o accordo (non puoi fare un concordato ogni anno lasciandoli inadempiuti). Quindi, se la tua domanda è: “posso aprire un’altra società dopo il fallimento e proteggere i nuovi beni?”, la risposta è sì, ma se la nuova società la apri mentre i creditori vecchi non sono soddisfatti e magari scoprono che trasferisci l’attività, potrebbero contestare un abuso. Meglio una cesura netta: chiusa la procedura, parti con entità nuova e senza trascinarti passività, allora non hai vincoli. Molti grandi imprenditori caduti in default poi son ripartiti con nuovi progetti (a volte intestati a familiari inizialmente per prudenza). Tieni presente anche eventuali condanne penali: se c’è stata bancarotta fraudolenta, scatta l’interdizione dai pubblici uffici e dalle cariche direttive di imprese per 10 anni, quindi in quel caso non potresti fare l’amministratore finché dura l’interdizione. Ma senza reati, la legge non ti impedisce di riprovarci.
Simulazioni pratiche (casi esemplificativi)
Per rendere più concreti i concetti esposti, immaginiamo alcune situazioni tipiche che potrebbe affrontare l’imprenditore di un’azienda produttrice di trasduttori di pressione indebitata, e vediamo quali strategie legali potrebbe adottare in ciascun caso.
Caso 1: Risanamento concordato con banche e fornitori (uso del piano attestato)
Scenario: La Alpha S.r.l. produce componenti per sensori di pressione. A causa di un calo di commesse e rincaro materie prime, registra perdite per due esercizi. Ha debiti bancari per 1 milione (mutuo ipotecario su capannone + fido per liquidità esaurito) e debiti verso fornitori per 600.000€. Nessun debito fiscale rilevante (è in pari con IVA e contributi) e i 50 dipendenti sono stati pagati con qualche lieve ritardo. I soci credono nel rilancio: hanno ordini promettenti per l’anno prossimo, ma servono liquidità e tempo per riorganizzare. Nessun creditore ha ancora agito legalmente, ma alcuni fornitori minacciano stop consegne se non vedono i pagamenti.
Obiettivo: evitare procedure concorsuali formali e salvare l’azienda tramite accordi con i creditori principali, approfittando del fatto che la crisi è ancora gestibile e la reputazione di Alpha è buona.
Strategia: Alpha potrebbe puntare su un piano attestato di risanamento. Incarica un advisor finanziario di redigere un piano industriale: prevede la dismissione di un magazzino inutilizzato (incasso 300k), l’ingresso di un socio investitore con aumento di capitale di 200k, e l’utilizzo di questi fondi per rimborsare parzialmente i debiti. Nel piano si propone che le banche prolunghino il mutuo di 5 anni riducendo la rata (con garanzia ipotecaria invariata) e concedano un nuovo fido di 200k coperto da garanzia MCC (MedioCredito Centrale) per sostenere il circolante. Ai fornitori strategici (che coprono 500k su 600k di debito) Alpha propone il pagamento del 80% dei loro crediti in 18 mesi, lasciando scoperto un 20% come sacrificio richiesto (oppure convertendo quel 20% in un ordine futuro, dipende dalla negoziazione). Un commercialista indipendente viene chiamato ad attestare che i numeri del piano sono corretti e che, se banche e fornitori accettano quelle condizioni, Alpha tornerà solvibile nel giro di 2 anni (ha ordini in portafoglio che lo confermano). L’attestatore rilascia la relazione positiva.
Alpha quindi convoca un meeting con i due istituti bancari e i 5 fornitori maggiori, presenta il piano e spiega che in alternativa dovrebbe portare i libri in tribunale (con il rischio per tutti di esiti peggiori). Grazie anche alla credibilità data dalla relazione dell’esperto indipendente, banche e fornitori aderiscono all’accordo di risanamento: formalizzano per iscritto che accettano le dilazioni e riduzioni proposte. Nel frattempo i soci di Alpha reperiscono il nuovo investitore e vendono il magazzino come da piano per fare cassa. Alpha deposita il piano e la relazione attestata presso il Registro delle Imprese, dandogli data certa (non è obbligatorio ma opportuno).
Esito: Nei mesi seguenti Alpha esegue l’accordo: paga puntualmente le rate dovute ai fornitori (che quindi continuano a fornire materiali), la banca eroga il nuovo fido garantito dal Fondo statale permettendo ad Alpha di acquistare componenti per evadere i nuovi ordini. Dopo 18 mesi i fornitori hanno incassato l’80% del loro credito e rinunciano al 20% finale come concordato; le banche hanno ottenuto regolarmente le nuove rate del mutuo e vedono l’azienda in ripresa (quindi mantengono aperte le linee). La crisi si considera superata: Alpha torna in utile e l’anno successivo può anche rifinanziare il debito bancario a condizioni normali. I creditori che hanno aderito non possono più pretendere nulla oltre quanto concordato (la rinuncia del 20% è definitiva). L’azienda ha evitato di finire in procedura concorsuale, quindi ha sofferto meno danni reputazionali e nessun controllo giudiziario. Questo è un caso da manuale di risanamento stragiudiziale riuscito. La chiave è stata agire in anticipo, prima che scattassero azioni legali dei creditori, e coinvolgere un esperto per dare fiducia agli interlocutori.
Caso 2: Crisi più grave con esposizione fiscale e minaccia di fallimento (accordo di ristrutturazione o concordato)
Scenario: La Beta S.p.A. (150 dipendenti) ha accumulato ingenti debiti: 2 milioni con banche (di cui 1 con garanzie ipotecarie, 1 chirografario), 1 milione verso fornitori, e 800.000€ verso Erario e INPS (IVA non versata negli ultimi 2 anni per 500k, contributi arretrati per 200k, più sanzioni). Inoltre, Beta ha leasing su macchinari con rate scadute. La situazione di liquidità è pessima e alcuni creditori hanno già ottenuto decreti ingiuntivi. L’Agenzia Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca sugli immobili per l’IVA non pagata. Due fornitori hanno chiesto il fallimento di Beta con ricorso in tribunale. Beta tuttavia ha un portafoglio ordini significativo e commesse che potrebbero renderla profittevole se superasse il collo di bottiglia finanziario.
Obiettivo: evitare la dichiarazione di fallimento imminente e ristrutturare l’azienda preservandone la continuità, magari trovando un investitore disposto a immettere capitali freschi.
Strategia: Data la fase avanzata della crisi (creditori in tribunale), Beta opta per il concordato preventivo. Presenta rapidamente (prima dell’udienza pre-fallimentare) un ricorso di concordato con riserva al tribunale competente, ottenendo il congelamento delle istanze di fallimento in corso. Ciò le dà tempo di elaborare un piano. Con l’aiuto di advisor e del management, Beta formula un piano in continuità: un investitore terzo (ad esempio un fondo) rileverà il 60% delle quote di Beta apportando 1,5 milioni di euro di nuova finanza destinata ai creditori, mentre l’imprenditore originario scenderà al 40%. Si prevede di mettere in vendita un immobile non strategico per altri 700k. Somme disponibili per i creditori: 2,2 milioni. I debiti totali sono circa 4,5 milioni (esclusi privilegiati). Con 2,2 milioni Beta propone di soddisfare integralmente i creditori privilegiati e una percentuale a quelli chirografari. Nello specifico: i debiti verso banche garantite (1 milione) sarebbero pagati al 100% utilizzando l’incasso della vendita immobiliare (l’ipoteca della banca verrà così soddisfatta e cancellata); i debiti verso Fisco e INPS (che sono per lo più privilegiati) verranno trattati con transazione fiscale: Beta offre di pagare il 100% dell’IVA e contributi in 5 anni (grazie all’apporto dell’investitore) ma chiede lo stralcio integrale di interessi e sanzioni (300k di sanzioni verrebbero azzerate). I fornitori chirografari vengono messi in classe separata: a loro Beta propone il 40% di soddisfazione (circa 400k su 1M) da pagarsi in 4 anni con risorse derivanti dalla ritrovata gestione profittevole (ci sono business plan annessi che mostrano margini per sostenere queste uscite). I leasing sui macchinari saranno regolarizzati (l’investitore provvede a saldare le rate scadute e la società continua a pagarle fino a scadenza, mantenendo i beni strumentali). Un professionista indipendente attesta che il piano è fattibile: conferma la serietà dell’impegno dell’investitore (c’è già un pre-accordo vincolante), valuta realistici i ricavi futuri per pagare i fornitori al 40%, e asserisce che in caso di fallimento i chirografari prenderebbero forse 5-10%, quindi il 40% è conveniente.
Beta deposita il piano e la proposta definitivi in tribunale. I creditori vengono convocati in adunanza per il voto. Durante la procedura, Beta opera in continuità: con l’autorizzazione del giudice, può utilizzare la finanza ponte dell’investitore (che viene erogata come prededucibile) per produrre e consegnare gli ordini. Alcuni fornitori essenziali vengono pagati per forniture correnti. Il commissario giudiziale sorveglia queste operazioni e riferisce ai creditori che l’andamento è positivo.
Al voto, le banche (classi privilegiate) votano a favore: ottengono integrale rimborso, nessun motivo per opporsi. Il Fisco e l’INPS, nella loro classe, sono formalmente dissenzienti perché la politica interna non consente di votare piani con stralcio del capitale (ma Beta ha proposto stralcio solo su sanzioni, capitale lo paga tutto: in realtà potrebbe persino convincerli a votare sì, ma ipotizziamo che per le sanzioni pendano indicazioni restrittive e si astengano o votino contro). I fornitori chirografari, classe numerosa ma con prospettiva 40% vs 0 in fallimento, votano per la maggioranza a favore (alcuni piccoli contrari, ma sono minoranza). Il quorum complessivo raggiunto soddisfa la legge (oltre 50% in ogni classe tranne il Fisco). Beta allora chiede al tribunale l’omologazione del concordato, anche in assenza di voto favorevole del Fisco: sfrutta la norma del cram-down fiscale, dimostrando che Agenzia Entrate e INPS ricevono il 100% dei loro crediti tributari/previdenziali, cioè sicuramente più di quanto avrebbero preso in fallimento (dove l’IVA di solito non viene mai pagata integralmente). Il tribunale verifica e approva il piano, con decreto di omologazione. Le sanzioni tributarie vengono cancellate in virtù dell’omologa (diventano inesigibili).
Esito: Beta esegue l’aumento di capitale con l’investitore, vende l’immobile e paga immediatamente le banche e le prime quote ai creditori come da piano. L’attività prosegue, i dipendenti conservano il posto. Nei 4 anni seguenti Beta paga puntualmente il 40% dovuto ai fornitori e le rate al Fisco. Trascorso questo periodo, il concordato è adempiuto al 100%. I creditori fornituri non possono più pretendere il restante 60%: è legalmente perdonato. L’Erario ha incassato tutto il dovuto (capitale) ma ha rinunciato alle sanzioni. L’investitore ora beneficia di un’azienda risanata (ha investito 1,5 milioni per rilevarla, in linea con i piani). Il tribunale dichiara chiuso il concordato per avvenuto adempimento. Beta S.p.A. continua la sua attività con successo.
Questa simulazione mostra un caso complesso di crisi avanzata risolta con un concordato in continuità: è servito un sacrificio degli stakeholder (soci diluiti, fornitori perdono 60% credito, Fisco rinuncia sanzioni, investitore mette soldi) ma tutti ne escono meglio di come sarebbero usciti dal fallimento, e l’impresa è salva.
Caso 3: Liquidazione dell’azienda ma salvaguardia patrimonio personale (concordato semplificato)
Scenario: La Gamma S.r.l. è purtroppo decotta: settore in crisi, perdite irreversibili, niente ordini nuovi. Ha debiti per 1 milione che non può pagare, e l’attività è ferma. I soci vogliono chiudere bottega ma temono il fallimento perché l’amministratore ha commesso qualche irregolarità formale (bilanci tardivi) e non vuole rischiare accuse, inoltre i soci garanti vorrebbero definire la posizione in modo ordinato per evitare l’escussione selvaggia delle garanzie. Il patrimonio sociale consiste in pochi macchinari e attrezzature, stimabili in €300k. C’è però un potenziale acquirente interessato a quei macchinari per €250k se riesce a ottenerli senza incognite.
Obiettivo: evitare l’apertura di un fallimento e invece vendere i beni residui in modo controllato massimizzando il ricavato, così da pagare qualcosa ai creditori e chiudere l’esperienza senza strascichi di azioni personali.
Strategia: Gamma tenta inizialmente la composizione negoziata (sperando di trovare accordi), ma l’esperto constata che non c’è prospettiva di risanamento (l’azienda è decotta). Dopo 3 mesi di tentativi, redige una relazione finale negativa. A questo punto Gamma, per evitare che i creditori chiedano il fallimento, deposita entro 60 giorni una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Nel piano, Gamma prevede di vendere tutti i macchinari e attrezzature all’offerente individuato per €250k (previa stima giurata del valore per garantire che il prezzo è congruo). Propone di distribuire tale somma ai creditori chirografari, che hanno 1 milione di crediti, ottenendo quindi un soddisfacimento previsto del 25%. Non essendoci creditori privilegiati significativi (mettiamo che i dipendenti erano già stati licenziati e pagati tramite fondi di garanzia, e i debiti fiscali erano modesti e senza attivo dedicato), quel 25% va equamente a tutti i chirografari. Il tribunale esamina la proposta – non c’è voto dei creditori in questo tipo di concordato – e la paragona allo scenario fallimentare: anche in fallimento i beni avrebbero fruttato intorno a 250k (forse meno dopo le spese). La percentuale offerta (25%) rispetta la soglia del 20% minima. Dà quindi omologa al concordato semplificato. Viene nominato un liquidatore (lo stesso esperto, o altra figura) per sovrintendere alla vendita al pre-determinato acquirente e poi distribuire il ricavato. Nel giro di pochi mesi, i beni sono trasferiti, i creditori ricevono un riparto del 25% ciascuno.
Esito: Gamma S.r.l. viene cancellata senza passare per fallimento; i creditori, pur non felici, hanno ottenuto in tempi brevi qualcosa e non possono più pretendere altro (il concordato – sebbene semplificato – li vincola, anche se non hanno votato). L’amministratore non subisce le restrizioni di un fallimento né l’onta di procedure lunghe: con la chiusura concordataria, eventuali reati di bancarotta semplice per cattiva gestione non vengono contestati perché la bancarotta è reato tipico del fallimento (e il concordato chiude la vicenda senza dichiarare fallimento). Inoltre, siccome c’è stato un adempimento regolare, i creditori non hanno ragione di aggredire i garanti: chi aveva fideiussione per quei debiti, può anch’egli trarre beneficio dell’accordo globale (in dottrina si ritiene che l’effetto esdebitativo del concordato, se non diversamente previsto, liberi anche i garanti in ragione del pagamento parziale effettuato, salvo avessero rinunciato al beneficio – e comunque, spesso i garanti partecipano mettendo risorse, come potrebbe essere stato il caso: magari quell’acquirente che ha pagato 250k è introdotto dai soci e parte di quei soldi li hanno messi i soci stessi, e in cambio le banche liberano le ipoteche e garanzie personali). In somma, i soci di Gamma chiudono l’azienda con una procedura concorsuale semplice e rapida, limitando danni personali e pagando il possibile ai creditori (forse avrebbero preso uguale in fallimento, ma in 4-5 anni e con più incertezze).
Questa simulazione illustra una liquidazione concordataria come alternativa “morbida” al fallimento, resa possibile dall’istituto del concordato semplificato successivo a composizione negoziata fallita.
Caso 4: Piccola impresa individuale sovraindebitata (procedure minori) – (Bonus scenario extra brevissimo)
Scenario: Mario Rossi, artigiano che produce componenti per sensori, opera come ditta individuale (no S.r.l.). Ha debiti per €300k (50k banca, 50k fornitori, 100k Equitalia per IVA non pagata, 100k privati vari). L’attività non è più sostenibile e vorrebbe chiudere. Non è soggetto a fallimento perché sotto le soglie di legge per dimensione.
Strumento: Mario può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: ad esempio presentare un piano di ristrutturazione del debitore (ex piano del consumatore se gran parte debiti non professionali, o accordo minore se ditta). Propone ai creditori il pagamento del 30% utilizzando la vendita del laboratorio e alcuni risparmi. Il giudice convoca i creditori, omologa il piano se c’è accordo di 50% crediti (o anche senza se “piano del consumatore” con meritevolezza). Mario paga quel che può e ottiene l’esdebitazione dal resto. Così chiude i debiti definitivamente senza fallire mai. Questa è la variante per imprese non fallibili.
Ogni caso è ovviamente diverso, ma questi esempi mostrano come si applicano concretamente gli istituti discussi: dal risanamento in bonis all’insolvenza grave con concordato, fino alla chiusura liquidatoria semplificata e alle soluzioni per i più piccoli. Pianificazione, tempestività e uso corretto degli strumenti legali sono state le chiavi della difesa in ciascun scenario.
Conclusioni
Affrontare una crisi d’impresa con debiti ingenti è un compito arduo, ma l’ordinamento italiano offre oggi una gamma articolata di strumenti per gestire queste situazioni in modo ordinato e – per quanto possibile – vantaggioso sia per il debitore che per i creditori. Dal punto di vista del debitore (imprenditore, amministratore o socio) è fondamentale non restare paralizzati dalla paura o dall’orgoglio: occorre invece attivarsi tempestivamente, riconoscere la crisi e scegliere la strada migliore per uscirne, con l’aiuto di professionisti qualificati.
Abbiamo visto come:
– un’azienda ancora vitalmente recuperabile possa evitare il fallimento tramite accordi stragiudiziali (piani attestati) o procedure negoziate (composizione assistita), mantenendo riservatezza e controllo sull’attività;
– in situazioni più gravi, strumenti come gli accordi di ristrutturazione omologati e il concordato preventivo permettano di ristrutturare i debiti imponendo sacrifici equi a tutti i creditori, privilegiando la continuità aziendale quando c’è prospettiva di rilancio e assicurando comunque soglie minime di tutela ai creditori;
– la legge incoraggi chiaramente il risanamento precoce, ad esempio con le novità sulla composizione negoziata e il favor legislativo verso la continuità, ma allo stesso tempo preveda vie di uscita dignitosa dall’attività per le imprese decotte (concordato semplificato, esdebitazione del sovraindebitato) che evitano la stigmatizzazione e la lungaggine del fallimento tradizionale;
– per il debitore è cruciale anche proteggere il proprio patrimonio personale: ciò avviene sia indirettamente, conducendo in porto procedure concorsuali che liberano dai debiti residui, sia direttamente, osservando i doveri di legge (così da non incorrere in responsabilità) e adottando misure di pianificazione patrimoniale lecite quando possibile.
Dal punto di vista pratico-operativo, gestire una crisi significa spesso comporre un puzzle fatto di accordi con categorie diverse di creditori, ottenendo ad esempio che banche, fornitori e Fisco accettino ciascuno un certo tipo di soluzione. Questo richiede negoziazione, trasparenza e competenza tecnica. Il ruolo degli esperti attestatori e negoziatori introdotti dalla nuova normativa è proprio fornire quel supporto di terzietà e credibilità alle trattative: un imprenditore lungimirante dovrebbe vederli come alleati, non come ingerenze.
Un tema che traspare dalla trattazione è la meritevolezza: gli strumenti sono efficaci soprattutto per l’imprenditore che ha agito (e agisce) con correttezza. Le riforme hanno voluto offrire una “seconda chance” a chi onestamente incappa in difficoltà – prevedendo ad esempio esoneri da responsabilità penale se viene raggiunto un accordo di ristrutturazione , oppure permettendo l’esdebitazione integrale dopo il fallimento all’imprenditore diligente. Viceversa, chi abusa dei meccanismi (ad esempio occultando informazioni nell’attestazione, o facendo spostamenti di beni in malafede) troverà porte chiuse e anzi sanzioni. Trasparenza, collaborazione e tempestività sono dunque i principi guida per difendersi efficacemente dai creditori senza scadere nell’illegalità.
In conclusione, un’azienda di trasduttori di pressione indebitata ha oggi diversi percorsi per provare a salvarsi o quantomeno per chiudere la propria vicenda minimizzando i danni. La scelta del percorso adatto – piano stragiudiziale, accordo, concordato o liquidazione controllata – dipende dalle specifiche circostanze: entità e tipo dei debiti, prospettive di mercato, atteggiamento dei creditori, presenza di risorse esterne o investitori, ecc. Non esiste una soluzione unica valida per tutti: la guida che abbiamo fornito serve a orientare l’imprenditore sulle opzioni disponibili, ma la decisione finale va presa caso per caso, con valutazione approfondita dei pro e contro (anche grazie alle tabelle riassuntive) e con l’assistenza dei consulenti.
Ciò che è certo è che non bisogna rassegnarsi né attendere passivamente: attivarsi per difendere la propria impresa (o liquidarla ordinatamente) è sempre la scelta preferibile, e l’ordinamento fornisce gli strumenti giuridici per farlo. L’imprenditore debitore, se ben guidato, da soggetto passivo in balìa degli eventi può così tornare regista del proprio destino, negoziando con i creditori soluzioni sostenibili e costruendo le basi per un futuro ripartenza o per una chiusura senza rimpianti e contenziosi.
Ricordiamo infine che questa guida, aggiornata a ottobre 2025, ha incluso le ultime novità normative (come il D.Lgs. 136/2024 correttivo, la prassi di Agenzia Entrate e INPS in tema di transazioni, e le sentenze di Cassazione più recenti) per offrire un quadro accurato e affidabile . Nella sezione seguente troverete tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate, per approfondire gli aspetti di vostro interesse o verificare in dettaglio i riferimenti legali menzionati.
Intraprendere un percorso di risanamento o liquidazione volontaria può sembrare complesso, ma con la giusta consulenza e determinazione può trasformare una crisi distruttiva in un’opportunità di risolvere il passato e, se possibile, gettare le fondamenta per un nuovo inizio.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)
- Codice Civile:
- Art. 2086 c.c. – Dovere dell’imprenditore di istituire assetti adeguati e rilevare tempestivamente la crisi .
- Art. 2486 c.c. – Obblighi degli amministratori dopo scioglimento e criteri di liquidazione del danno (introdotto da D.Lgs. 14/2019, art. 378). Presunzione differenziale patrimoni netti per quantificare danno .
- Artt. 2476, 2394 c.c. – Azione dei creditori sociali verso amministratori per mancata conservazione integrità patrimonio (responsabilità per aggravamento insolvenza).
- Art. 2467 c.c. – Postergazione dei finanziamenti dei soci (i crediti dei soci verso società sono subordinati).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, aggiornato):
- Art. 12 – 25 quinquies – Composizione negoziata della crisi e procedure connesse. Istituto introdotto nel 2021 e integrato nel CCII . Modifiche dal D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 e dal D.Lgs. 83/2022. (Include: nomina esperto, misure protettive ex art. 18-20, esiti ex art. 23, concordato semplificato ex art. 25-sexies).
- Art. 25-sexies – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (accessibile post-composizione negoziata fallita, senza voto creditori) .
- Art. 56 – Piani attestati di risanamento. Definisce finalità (risanare debiti e riequilibrare situazione finanziaria) e requisiti: piano deve essere attestato da professionista indipendente in merito a veridicità dati e fattibilità . Esonero da revocatoria per atti esecutivi di piano idoneo ex art. 166 co.3 lett. d.
- Art. 57 – 64 – Accordi di ristrutturazione dei debiti. Percentuale di creditori aderenti richiesta (≥60%) ; necessità attestazione; estensione effetti a creditori non aderenti (pagamento integrale entro 120 giorni) . Art. 60 consente accordi ad efficacia estesa (banche ≥75%). Art. 61-63 disciplinano la transazione fiscale e previdenziale nell’accordo (possibile falcidia tributi con adesione AE/INPS). Art. 64 prevede omologazione anche in mancanza di adesione Fisco/enti se soddisfatti requisiti (cram-down fiscale) .
- Art. 84 – Concordato preventivo: requisiti di ammissibilità. Definisce concordato in continuità (comma 2: la continuità aziendale tutela interessi creditori e preserva posti di lavoro) e concordato liquidatorio (comma 4: richiesta soddisfacimento almeno 20% crediti chirografari, salvo concordato con continuità) . Comma 6: divieto di falcidia IVA e ritenute nel concordato in continuità (devono essere pagate integralmente).
- Art. 88 – Concordato preventivo: transazione fiscale. Possibilità di trattare tributi e contributi. (Comma 2-bis menziona cram down fiscale in concordato, collegato con art. 112 CCII) .
- Art. 112 – Concordato: omologazione in caso di voto contrario di classi (cram-down di classi dissenzienti). Comma 2: tribunale può omologare con voto favorevole maggioranza delle classi o anche una sola classe se ricorrono presupposti . Comma 3: se contestata convenienza, omologa se credito dissenziente soddisfatto non meno che in liquidazione .
- Art. 113 – Effetti dell’omologazione: esdebitazione del debitore dai debiti anteriori per la parte eccedente quanto soddisfatto nel concordato.
- Art. 324 – Esenzioni da reati fallimentari: prevede non punibilità per bancarotta semplice e preferenziale in caso di concordato o accordo eseguito (anche in esito composizione negoziata) .
- Art. 375-378 – Modifiche al Codice Civile in tema di doveri degli amministratori. In particolare art. 378 CCII che introduce art. 2486 c.c. comma 3 con i criteri presuntivi di quantificazione del danno .
- Art. 390 – Disciplina transitoria e coordinamento con Legge Fallimentare previgente.
- Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942) – per riferimenti storici:
- Art. 67, co.3, lett. d) – Esenzione da revocatoria per atti esecutivi di piani attestati di risanamento (trasposto in art. 166 CCII).
- Art. 182-bis – Accordi di ristrutturazione (ora art.57 CCII).
- Art. 160-186 – Concordato preventivo (ora art.84 e ss CCII); art. 182-ter – transazione fiscale (ora art.63 CCII).
(Le norme della legge fall. sono abrogate dal 15/7/2022 in favore del CCII.) - Decreti legge recenti e correttivi:
- D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 – Introduzione composizione negoziata e concordato semplificato.
- D.Lgs. 83/2022 – Adeguamento CCII alla direttiva UE 2019/1023 (insolvency directive). Ha novellato parti su concordato e accordi (introduzione cram-down fiscale, percentuali ridotte accordi ecc.).
- D.Lgs. 13 ottobre 2022 n. 149 (riforma giustizia civile) – Ha modificato alcuni aspetti procedurali (procedimento unitario per accesso a strumenti di regolazione).
- D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 – “Correttivo ter” al Codice della crisi . Principali novità: rafforzamento composizione negoziata (es. estensione transazione fiscale anche a tributi locali , miglior coordinamento con procedure minori), modifiche al concordato preventivo (chiarimenti su cram down, classe trattamenti), e altre semplificazioni. Entrato in vigore 28/09/2024 .
- Prassi amministrativa:
- Agenzia Entrate – Circ. 34/E 2020: linee guida su transazione fiscale (post DL 34/2020).
- INPS – Messaggio n. 3553 del 25.10.2024: indicazioni operative su transazioni contributive dopo il correttivo 2024 (apre ai Comuni e disciplina gestione crediti previdenziali in concordati/accordi).
- Unioncamere – Osservatorio composizione negoziata (rapporti semestrali 2022-2024): dati statistici sull’utilizzo dello strumento . Ad esempio, VI edizione Nov. 2024: 1.860 istanze cumulate, tasso successo ~19% . Unioncamere ha promosso correttivi per incentivare l’istituto (diversi recepiti dal D.Lgs 136/2024) .
- Sentenze e Giurisprudenza di legittimità:
- Cass., Sez. I civ., 3 marzo 2023 n. 6508 – Piano attestato e revocatoria. Principio: gli atti esecutivi di un piano attestato non sono esenti da revocatoria se il piano era manifestamente inadeguato al risanamento . Giudice deve valutare ex ante l’idoneità del piano a riequilibrare la situazione finanziaria: in caso di “palese inadeguatezza”, l’esenzione ex art.67 co.3 lett. d L.F. (oggi art.166 CCII) non opera . La sentenza fissa che l’esenzione non è automatica ma condizionata alla serietà del piano.
- Cass., Sez. I civ., 29 dicembre 2023 n. 36401 – Doveri dell’attestatore. Ribadisce che l’attestatore del concordato (e analogamente nei piani attestati) ha l’obbligo di fornire informazioni complete e veritiere ai creditori, non potendo omettere fatti rilevanti. L’omissione di informazioni equivalenti al falso attestativo comporta responsabilità penale (ex art. 236-bis L.F., ora art. 342 CCII) . Questo a tutela della trasparenza: professionista tenuto a elevata diligenza, e omissioni ingannevoli – anche per “leggerezza” – integrano il reato di false attestazioni .
- Cass., Sez. Un. civ., 6 maggio 2015 n. 9100 – Criterio del deficit fallimentare. Pronuncia seminale (SS.UU.) sulla liquidazione equitativa del danno in azioni di responsabilità: legittimo criterio differenziale (attivo – passivo) in caso di contabilità inattendibile, poi recepito dal legislatore in art. 2486 c.c. comma 3 .
- Cass., Sez. I civ., 25 marzo 2024 n. 8069 – Applicazione art. 2486 c.c.: conferma l’uso dei criteri presuntivi introdotti dall’art.2486 co.3 c.c. per liquidare il danno da prosecuzione abusiva attività dopo perdita capitale . Ribadisce natura eccezionale e ambito specifico (violazione obbligo conservazione post scioglimento) di tali criteri . Oltre tali casi, restano criteri tradizionali risarcitori per mala gestio specifiche.
- Cass., Sez. I civ., 22 aprile 2024 n. 10739 – Responsabilità amministratori non esecutivi: individua i presupposti perché anche gli amministratori privi di deleghe rispondano solidalmente con gli esecutivi per omesso impedimento di atti pregiudizievoli . Conferma obbligo di vigilanza attiva e dovere di dissociarsi per evitare corresponsabilità.
- Cass., Sez. V pen., 24 novembre 2021 n. 36083 – Falso in attestazioni e omissioni: caso penale in cui un attestatore concordatario è stato condannato ex art. 236-bis L.F. (ora 342 CCII) per avere omesso informazioni rilevanti (dolo per omissione) . Stabilisce che l’attestazione reticente può integrare il reato di falso, non solo l’attestazione attivamente mendace.
- Cass., Sez. Un. civ., 23 gennaio 2013 n. 1521 – Attestatore, ruolo e responsabilità: afferma principi generali sul dovere di diligenza e terzietà dell’attestatore nel concordato; principi estensibili ai piani attestati . Attestatore responsabile per dolo o colpa grave in caso di false attestazioni con danno ai creditori.
- Tribunale di Roma, Sez. Fall., 27 ottobre 2022 (Osservatorio Insolvenza 2022) – Transazione fiscale nei piani attestati: chiarisce che nell’ambito di un piano attestato non omologato l’Erario può eventualmente aderire solo nei limiti concessi dalla legge ordinaria (rateazioni) e non può accettare falcidie di tributi in assenza di omologazione . Quindi niente taglio imposte in piano ex art.56 CCII, confermando che serve accordo/concordato omologato per efficacia su Fisco.
- Corte Costituzionale n.225/2014 – Sentenza che dichiarò illegittimo il divieto di falcidia IVA nei concordati liquidatori (consentendo la falcidia IVA se soddisfa miglior interesse creditori). Principio recepito poi nella normativa attuale: IVA falcidiabile in concordato liquidatorio, ma non in continuità (il CCII distingue).
- Corte di Giustizia UE, sentenza 16/07/2020 (causa C-253/19,) – Riguarda interazione procedure di insolvenza e regole IVA: conferma che gli Stati possono prevedere che l’IVA non pagata a causa di procedura concorsuale sia a carico del debitore e non rimborsabile allo Stato (questo per dire che falcidiare IVA nei concordati è compatibile con normativa UE se ben regolato, come avviene).
La tua azienda che produce, integra, distribuisce o ripara trasduttori di pressione, sensori piezoresistivi, trasmettitori 4-20 mA, sensori differenziali, celle di carico, sensori per fluidi e gas, strumentazione per impianti industriali, automazione, HVAC, oil & gas e idraulica è finita in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, integra, distribuisce o ripara trasduttori di pressione, sensori piezoresistivi, trasmettitori 4-20 mA, sensori differenziali, celle di carico, sensori per fluidi e gas, strumentazione per impianti industriali, automazione, HVAC, oil & gas e idraulica è finita in difficoltà a causa dei debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, fornitori elettronici, importatori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei sensori industriali è complesso e costoso: microchip e componenti difficili da reperire, investimenti in test e calibrazione, magazzino impegnativo, assistenza tecnica continua e clienti che spesso pagano lentamente. Tutto questo può generare crisi di liquidità improvvise.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con metodo.
Perché un’Azienda di Trasduttori di Pressione Va in Debito
- aumento dei costi di sensoristica, microchip, PCB e componenti speciali
- ritardi nei pagamenti di integratori, OEM, EPC e industrie
- magazzino immobilizzato tra sensori, trasmettitori e ricambi
- costi elevati di test, collaudi, calibrazione e certificazioni
- assistenza tecnica anticipata rispetto agli incassi
- riduzione dei fidi bancari
Il vero problema quasi sempre è la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture elettroniche
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di sensori, strumenti di misura e apparecchiature
- impossibilità di consegnare ordini e commissioni
- perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato esperto può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti dell’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molti debiti contengono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori di Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili
Possibili strumenti:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Attivare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per situazioni più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Queste procedure permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei massimi esperti in Italia nella gestione delle crisi aziendali.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo unico per chi deve bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare imprese tecniche.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata delle tue posizioni debitorie
- blocco urgente di pignoramenti
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, sensori e strumenti di misura
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di trasduttori di pressione non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida e mirata puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre concretamente i debiti
- proteggere strumenti, produzione e magazzino
- salvaguardare la continuità operativa
Il momento di agire è adesso.
📞 Contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.