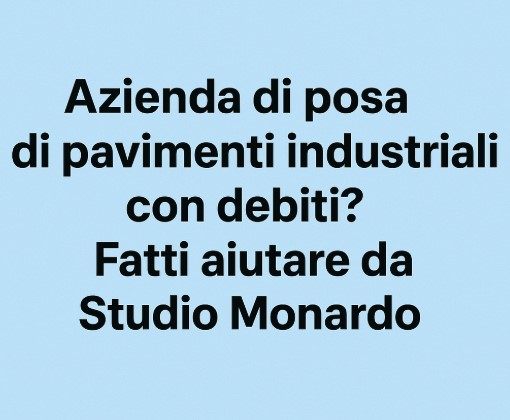Se la tua azienda si occupa di posa di pavimenti industriali, pavimentazioni in calcestruzzo, quarzo, resina, pavimenti per capannoni, stabilimenti, magazzini logistici, aree produttive e superfici ad alto traffico, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare il blocco dell’attività.
Nel settore dei pavimenti industriali, i ritardi possono generare penali, fermare cantieri, compromettere rapporti con imprese edili e mettere a rischio pagamenti e continuità dei lavori.
Perché le aziende di posa pavimenti industriali accumulano debiti
- costi elevati per cemento, resine, inerti, attrezzature e macchinari
- rincari di materiali e carburanti
- pagamenti lenti da parte di imprese edili e committenti
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- investimenti continui in attrezzature, levigatrici, frattazzatrici, pompe e DPI
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli dei cantieri
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista
- verificare quali debiti si possono contestare, ridurre o rateizzare
- evitare piani di rientro o accordi non sostenibili
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere i rapporti con fornitori di materiali e attrezzature
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di attrezzature fondamentali (frattazzatrici, levigatrici, pompe, mezzi)
- blocco di cantieri e perdita di appalti
- difficoltà nel rispettare consegne e tempistiche
- perdita di imprese edili, clienti e partner professionali
- rischio reale di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
- bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti normativi più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere attrezzature, mezzi, materiali e continuità operativa
- evitare la chiusura della tua impresa
Agisci ora
Molte aziende non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare davvero la tua attività.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua azienda di posa pavimenti industriali.
Introduzione
Un’impresa specializzata nella posa di pavimenti industriali può trovarsi, per varie ragioni, schiacciata dai debiti. Ritardi nei pagamenti da parte dei committenti, investimenti onerosi in macchinari, commesse annullate o sottocosto, crisi del settore edile: sono tutti fattori che possono portare anche un’azienda ben avviata ad accumulare debiti difficili da sostenere. Quando un’azienda di posa di pavimenti industriali si trova sommersa dai debiti, è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici disponibili per difendersi dalle azioni dei creditori e tentare di risanare la situazione.
In questa guida affrontiamo in dettaglio – con taglio tecnico ma comprensibile – ciò che un imprenditore debitore può fare per tutelarsi, focalizzandoci sul contesto italiano (normativa aggiornata a ottobre 2025). Esamineremo le varie tipologie di debiti (fiscali, previdenziali, bancari, verso fornitori, etc.) e i rischi connessi, gli obblighi legali dell’imprenditore in crisi, e le possibili soluzioni per gestire o ristrutturare i debiti (dalle procedure stragiudiziali ai procedimenti concorsuali). Saranno illustrate le responsabilità che possono gravare su amministratori e titolari dal punto di vista civilistico e penale, nonché le strategie di difesa legale per minimizzare le conseguenze negative.
Presentiamo inoltre sentenze recenti e fonti normative autorevoli per supportare le affermazioni (riportate tra parentesi con riferimenti bibliografici secondo il formato richiesto). Troverete anche tabelle riepilogative per confrontare rapidamente i diversi strumenti di gestione della crisi, casi pratici simulati basati su situazioni reali di imprese indebitate (dal punto di vista del debitore), e una sezione di Domande e Risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni. Tutte le fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali utilizzate sono elencate in fondo alla guida, per consentire approfondimenti e verifiche.
Obiettivo: Fornire a imprenditori, professionisti legali e consulenti un quadro avanzato ma chiaro su “cosa fare e come difendersi” quando un’azienda – come può essere un’impresa di pavimentazioni industriali – si trova gravata da debiti in Italia. Conoscere i propri diritti e doveri, nonché gli strumenti offerti dall’ordinamento (anche alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), è il primo passo per affrontare in modo proattivo la crisi ed evitare esiti irreversibili come il fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
Nei paragrafi che seguono partiremo dall’analisi dei debiti aziendali e dei relativi rischi, passeremo poi agli strumenti di regolazione della crisi (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato preventivo, ecc.), soffermandoci su transazione fiscale, procedure concorsuali e altre soluzioni. Approfondiremo le responsabilità legali degli amministratori e dell’imprenditore in caso di insolvenza o gestione non diligente, per poi proporre alcune strategie pratiche di difesa. Infine, tabelle riassuntive, FAQ e casi pratici completeranno la guida, offrendo una prospettiva concreta di applicazione delle norme.
Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi
Una prima mossa difensiva per un imprenditore indebitato è capire la natura dei debiti accumulati e le conseguenze legali di ciascuna categoria. Le imprese di posa pavimenti industriali possono contrarre vari tipi di debiti: fiscali, previdenziali, bancari/finanziari, commerciali verso fornitori, oltre ad eventuali debiti verso i dipendenti o altri. Ciascuna tipologia ha regole proprie quanto a modalità di riscossione da parte del creditore e possibili azioni esecutive. Vediamoli in dettaglio.
Debiti fiscali (Erario)
I debiti tributari includono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali, tasse locali, ecc.) e relative sanzioni e interessi. In Italia, dopo l’accertamento dell’imposta dovuta, il mancato pagamento porta all’iscrizione a ruolo e all’emissione di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Se l’azienda non adempie neanche dopo le cartelle, il Fisco può attivare una serie di azioni esecutive e cautelari, tra cui ad esempio:
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, macchinari registrati): un provvedimento che blocca la possibilità di utilizzare o vendere il bene.
- Ipoteca su beni immobili o mobili registrati dell’azienda: iscritta per garantire il credito tributario, spesso al superamento di certe soglie di debito.
- Pignoramenti sui conti correnti aziendali, sui crediti verso terzi (es. crediti dell’azienda verso clienti) o su beni mobili/immobili. L’Agente della riscossione può pignorare somme dal conto corrente o pignorare macchinari e immobili aziendali, seguendo le procedure di legge (notifica di atto di pignoramento e vendita all’asta in mancanza di pagamento).
Va considerato che i debiti IVA e le ritenute non versate possono sfociare anche in conseguenze penali se superano determinate soglie annue: ad esempio, l’omesso versamento IVA oltre 250.000 € annui e l’omesso versamento di ritenute certificate oltre 150.000 € sono reati tributari (puniti dal D.Lgs. 74/2000). Analogamente, non pagare le ritenute previdenziali sopra una soglia (attualmente 10.000 € annui) costituisce reato. La crisi di liquidità non è generalmente un esimente accettata per questi reati: la Cassazione penale ha affermato nel 2023 che lo stato di difficoltà economica, e la scelta di pagare altri costi (come stipendi o fornitori) al posto dei contributi, non esclude il dolo del reato di omesso versamento contributivo . In altre parole, l’imprenditore avrebbe dovuto ripartire le risorse in modo da versare i contributi anche a costo di ridurre le altre uscite, e la crisi non giustifica il mancato pagamento dei contributi obbligatori . Questa impostazione rigorosa implica che l’omissione di versamenti fiscali/previdenziali espone l’amministratore a responsabilità penale se non vi è un tempestivo ravvedimento o un pagamento entro i termini di legge.
Dal punto di vista civilistico, i debiti fiscali godono di privilegi nel caso di insolvenza: l’Erario e gli enti previdenziali sono creditori privilegiati (privilegio generale sui mobili e talora ipotecario, ad esempio l’IVA è credito privilegiato sui beni mobili aziendali fino al 70% del suo ammontare ex art. 2752 c.c.). Ciò significa che, in caso di procedure concorsuali o esecutive, il Fisco viene soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari (non garantiti).
Attenzione: Se la ditta individuale o la società non pagano i tributi, oltre alle azioni contro l’azienda, in certi casi la legge consente al Fisco di agire anche contro le persone fisiche responsabili. In particolare, l’art. 36 del DPR 602/1973 prevede che, in via eccezionale al principio della autonomia patrimoniale, siano responsabili personalmente per alcuni debiti tributari sociali: i liquidatori (se pagando altri debiti di ordine inferiore lasciano insolute imposte dovute in fase di liquidazione, o se distribuiscono attivi ai soci prima di pagare le imposte), gli amministratori (se non hanno tempestivamente chiesto la liquidazione societaria in presenza di cause di scioglimento, o se nei due anni precedenti la liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione di fatto od occultamento di attivo) e i soci (nei limiti di quanto ricevuto dai medesimi amministratori nei due esercizi precedenti lo scioglimento, o dal liquidatore durante la liquidazione) . Questa norma è un potente deterrente: ad esempio, se la società di pavimentazioni ha maturato un ingente debito IVA e l’amministratore ha continuato l’attività invece di avviare la liquidazione (in presenza magari di perdite rilevanti che azzeravano il capitale), egli può essere chiamato a risponderne col proprio patrimonio. Tuttavia, va garantito il diritto di difesa del presunto responsabile: la Cassazione ha stabilito che la sua responsabilità deve essere accertata con atto motivato notificato al diretto interessato prima di emettere la cartella esattoriale a suo nome . In un caso recente, la Suprema Corte (ord. n. 35497/2023) ha annullato una cartella emessa contro un ex amministratore proprio perché l’Agente della riscossione non gli aveva notificato prima un atto formale di accertamento della responsabilità ex art. 36 DPR 602/73, violando così il procedimento previsto dalla legge . È dunque fondamentale, qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione persegua l’amministratore per debiti tributari societari, verificare la correttezza formale della procedura (notifica di un avviso di accertamento della responsabilità ex art.36, possibilità di ricorso in Commissione Tributaria avverso tale avviso, ecc.).
Come difendersi dai debiti fiscali: Dal lato pre-concorsuale, l’imprenditore può chiedere la rateizzazione delle cartelle (dilazione fino a 72 rate mensili, ovvero 6 anni, elevabili in casi di grave e comprovata difficoltà a 120 rate, cioè 10 anni, secondo le norme vigenti) per evitare azioni immediate . Inoltre può valutare l’adesione a eventuali sanatorie fiscali varate dal legislatore (es. rottamazione delle cartelle: definizione agevolata pagando il solo tributo senza sanzioni né interessi di mora) – al 2023, ad esempio, era attiva la rottamazione-quater introdotta dalla L. 197/2022. Questi strumenti consentono di congelare sanzioni e ridurre l’esborso complessivo, ma richiedono comunque il pagamento dilazionato del debito in forma agevolata. In ambito concorsuale o para-concorsuale, il rimedio principe è la transazione fiscale, che vedremo più avanti: all’interno di un piano di risanamento o procedura concordataria, si può proporre al Fisco il pagamento parziale dei debiti tributari con stralcio di sanzioni e interessi, o anche parte dell’imposta, ottenendo l’accordo dell’Erario (o persino superando un suo eventuale diniego alle condizioni di legge).
Debiti verso enti previdenziali (INPS, INAIL)
Molte imprese edili e di pavimentazione industriale hanno dipendenti o collaboratori, generando debiti contributivi (contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori). I debiti verso INPS e INAIL seguono per certi versi un percorso analogo a quello fiscale: l’ente emette un avviso di addebito immediatamente esecutivo; se non si paga, l’avviso viene affidato all’Agente della riscossione per la notifica di una cartella e l’avvio delle esecuzioni (fermi, ipoteche, pignoramenti) in modo pressoché identico ai debiti erariali. Anche i crediti contributivi sono privilegiati (privilegio generale ex art. 2753 c.c. per gli ultimi 2 anni di contributi, e speciale per contributi dei dipendenti su eventuali beni ceduti dall’azienda).
Sul piano penale, come già accennato, l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre la soglia di 10.000 € annui configura reato (art. 2 D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). La giurisprudenza ha precisato che si tratta di reato a dolo generico: basta la consapevole scelta di non versare i contributi dovuti. Anche la difficoltà economica dell’impresa non esime dall’obbligo – l’imprenditore avrebbe dovuto, se necessario, ridurre gli stipendi netti pur di versare le ritenute, perché trattenere dalla busta paga del dipendente i contributi e poi non girarli all’INPS è considerato un comportamento penalmente rilevante . Solo la prova di una assoluta impossibilità finanziaria può essere valutata caso per caso, ma si tratta di una difesa complessa, poiché il datore di lavoro è tenuto per legge a dare priorità a questi versamenti. Dunque, non versare i contributi comporta non solo l’aumento del debito per interessi e sanzioni (le sanzioni civili INPS sono molto onerose), ma anche il rischio concreto di azioni penali a carico del legale rappresentante.
Per difendersi, anche in questo caso sono possibili dilazioni (rateizzazioni concesse dall’INPS direttamente, di solito fino a 5 anni, prorogabili in casi eccezionali), oppure includere i debiti contributivi in una transazione contributiva nell’ambito di un piano di risanamento o concordato. La transazione contributiva (disciplinata analogamente a quella fiscale) consente di proporre il pagamento parziale dei contributi e premi dovuti, con stralcio di sanzioni civili e accessori – purché si rispettino alcune condizioni di convenienza per l’ente (generalmente, offrire almeno quanto l’ente recupererebbe in caso di fallimento/liquidazione giudiziale). Anche qui la legge è evoluta: in passato l’INPS/INAIL potevano rifiutare e il loro diniego bloccava l’intera ristrutturazione; oggi, come vedremo, la riforma consente in certi casi al giudice di omologare ugualmente l’accordo o il concordato anche senza l’adesione degli enti previdenziali, se l’offerta verso di loro è equa (c.d. cram-down fiscale e contributivo introdotto nel 2023).
Debiti bancari e finanziari
Le aziende di costruzioni e posa pavimenti spesso ricorrono a finanziamenti bancari per l’acquisto di macchinari costosi, per l’anticipo delle forniture o per far fronte ai flussi di cassa irregolari. I debiti verso banche includono mutui, leasing, affidamenti di conto corrente (scoperti), anticipi su fatture (castelletto), ecc. Questi crediti sono in molti casi garantiti da ipoteche su beni aziendali (immobili, capannoni) o da fideiussioni personali dei soci/amministratori, oppure da pegni su macchinari o su crediti.
Se l’azienda smette di pagare le rate di mutuo o il saldo dovuto in conto, la banca può: – Revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato delle somme utilizzate (ad esempio, se c’è un fido di c/c o un anticipo fatture, la revoca rende immediatamente esigibile l’esposizione). – Avviare un’azione legale per recuperare il credito: spesso mediante decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (grazie alla prova scritta costituita dagli estratti conto o dal contratto di mutuo). Ottenuto il titolo (ingiunzione non opposta o sentenza), procederà a pignoramenti. – Se il credito è garantito da ipoteca, la banca potrà agire esecutivamente sul bene ipotecato (espropriazione immobiliare) e avrà diritto di prelazione sul ricavato. Se c’è un leasing e l’utilizzatore non paga i canoni, la società di leasing può risolvere il contratto e riprendere il bene (macchinario o veicolo) rapidamente. – Se vi sono garanti personali (es. il titolare ha firmato fideiussioni o ha dato in garanzia la propria casa), la banca, in caso di insolvenza della società, escuterà le fideiussioni, chiedendo il pagamento ai garanti o procedendo contro di loro (pignorando i beni personali del garante).
I debiti bancari, soprattutto se garantiti, conferiscono alle banche un forte potere contrattuale. In caso di crisi d’impresa, spesso sono proprio le banche i creditori più rilevanti con cui negoziare. Sul piano concorsuale, i crediti bancari ipotecari sono privilegiati (ipotecari) fino al valore del bene, mentre la parte eventualmente scoperta diventa chirografaria. I crediti chirografari delle banche (esposizioni non garantite) sono pari agli altri chirografari, ma le banche spesso agiscono tempestivamente appena si manifestano segnali di difficoltà (ad esempio segnalando l’azienda in Centrale Rischi di Bankitalia se ci sono ritardi nei pagamenti, o non rinnovando gli affidamenti).
Come difendersi dalle banche? In prima battuta, è possibile tentare una rinegoziazione o moratoria del debito: talvolta le banche (soprattutto se coordinate da associazioni come ABI) offrono piani di rientro, sospensione temporanea delle quote capitale dei mutui (le cosiddette moratorie), o consolidamento delle esposizioni a medio termine, per aiutare l’impresa in difficoltà momentanea. È cruciale però muoversi prima di finire in insolvenza conclamata: mantenere il dialogo con la banca e magari presentare un piano credibile di ristrutturazione può convincere la banca a non agire immediatamente per il rientro forzoso. Se l’azienda ha più banche esposte, sarebbe opportuno un approccio coordinato (ad esempio un accordo di moratoria con il pool di banche).
Nell’ambito delle soluzioni stragiudiziali e concorsuali, i debiti bancari potranno essere inseriti in un piano di risanamento attestato o in un accordo di ristrutturazione: le banche potrebbero accettare di allungare le scadenze, ridurre i tassi, talvolta persino rinunciare a parte del credito (stralcio) se intravedono che così facendo il resto del credito verrà soddisfatto meglio rispetto a un fallimento. Un esempio tipico: la banca accetta di tagliare il 20% dell’esposizione e di riscadenzare il restante 80% su 5 anni, pur di evitare la perdita quasi totale che subirebbe in caso di liquidazione giudiziale . Tali intese vanno formalizzate e, ove possibile, omologate dal tribunale (come negli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII) per diventare vincolanti e protette.
Bisogna però considerare le fideiussioni personali: anche se l’azienda riesce a ottenere uno stralcio del debito bancario, il garante potrebbe restare obbligato a coprire la parte stralciata. Molte fideiussioni bancarie contengono clausole di “sopravvivenza” che prevedono che il fideiussore resti obbligato anche se il debitore principale (la società) è esonerato in parte . Pertanto, se siete soci o amministratori garanti, negoziate anche la posizione personale: ad esempio, chiedendo espressamente che l’accordo liberatori l’azienda e i garanti (o che la banca si accontenti di quanto paga l’azienda e libererà le garanzie personali). In mancanza, si rischia che la banca, pur aderendo a un piano di riduzione del credito verso la società, poi chieda ai fideiussori il pagamento di quel differenziale non pagato dalla società.
Se la rinegoziazione privata non è percorribile e la banca minaccia azioni legali, l’imprenditore può attivare una delle procedure di composizione della crisi (ne parleremo a breve: composizione negoziata oppure concordato preventivo) per ottenere misure protettive dal tribunale che sospendano le azioni esecutive delle banche durante la trattativa o la predisposizione del piano . Questo “scudo” è prezioso: presentando, ad esempio, un’istanza di concordato in bianco o di misure protettive nella composizione negoziata, si può congelare temporaneamente il pignoramento di un immobile ipotecato, guadagnando tempo per trovare una soluzione. Occorre però usare questi strumenti in buona fede e realmente finalizzarli a un accordo, perché un abuso strumentale verrebbe sanzionato dal tribunale.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
I debiti commerciali verso fornitori (materiali edili, resine epossidiche, noleggio di attrezzature, trasporti, subappaltatori, ecc.) sono spesso la porzione più consistente dell’indebitamento di un’impresa di pavimentazioni industriali in crisi. Quando l’azienda fatica ad incassare dai propri clienti, tende a pagare in ritardo i fornitori, accumulando insoluti. I fornitori di norma non hanno garanzie specifiche (eccetto eventuali riserve di proprietà sui beni forniti, in rari casi, o fideiussioni di terzi se concordate) e sono quindi creditori chirografari. Tuttavia, dispongono di uno strumento rapido: possono richiedere un decreto ingiuntivo per le fatture non pagate (se munite di idonea documentazione come conferme d’ordine, DDT firmati, ecc.), spesso provvisoriamente esecutivo. Ottenuto il decreto, possono notificare atti di pignoramento verso beni aziendali o crediti (ad esempio presso i clienti dell’azienda debitrice, bloccando i crediti in arrivo).
Un’ondata di azioni esecutive da parte di fornitori può mettere in ginocchio l’impresa: i mezzi di lavoro pignorati, i conti bloccati, i crediti incassati dai creditori procedenti… Tutto ciò può portare al blocco totale dell’attività e precipitare l’azienda nell’insolvenza conclamata. Inoltre, qualsiasi creditore (anche un fornitore) con un credito certo, scaduto e esigibile, può presentare istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) se ritiene che l’impresa sia insolvente. La legge richiede che complessivamente i debiti scaduti superino €30.000 perché il tribunale possa dichiarare il fallimento . Questo significa che anche un singolo creditore per poche migliaia di euro potrebbe attivarsi, ma se il totale dei debiti scaduti è sotto 30.000 € non si aprirà la procedura; sopra tale soglia, la procedura è possibile (e in pratica quasi tutte le aziende in crisi serie superano tale cifra). È bene sapere che la soglia di €30.000 è riferita all’insieme dei debiti scaduti emersi nell’istruttoria prefallimentare , e non al singolo creditore istante. Quindi se l’azienda ha più debiti e uno solo si muove, quel singolo (anche se è creditore di 5.000 €) può causare il fallimento se complessivamente risultano scaduti >30.000 €.
Come difendersi dai fornitori? Una strategia chiave è giocare d’anticipo: invece di attendere decreti ingiuntivi, negoziare un accordo con i fornitori, magari offrendo un piano di rientro (es. pagamenti a rate) o uno stralcio del debito (pagare subito una parte a saldo e stralcio) se hanno margine. Molti fornitori preferiscono ottenere il, poniamo, 50-70% subito piuttosto che rischiare di non vedere nulla in caso di fallimento. Tali accordi andrebbero formalizzati (scrittura privata) e onorati scrupolosamente, perché un solo default potrebbe far saltare la fiducia residua. Attenzione però: pagare selettivamente alcuni fornitori a scapito di altri, quando l’insolvenza è già manifesta, espone l’imprenditore al rischio di azioni revocatorie o di contestazioni in sede fallimentare (pagamenti preferenziali). Se la crisi è già avanzata, meglio inserire tutti i fornitori in un piano unico (ad es. un accordo di ristrutturazione o un concordato) dove la proposta sia uguale per la stessa classe di creditori, in modo da rispettare la par condicio.
Un aspetto peculiare: nell’edilizia, i subappaltatori e fornitori possono talvolta avvalersi della “azione diretta” prevista dall’art. 1676 c.c. o dei privilegi del D.Lgs. 231/2002 (per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali), ma sono dettagli settoriali. Generalmente, per un subfornitore che non viene pagato, la via è uguale agli altri: decreto ingiuntivo e richiesta di fallimento.
Se l’azienda vuole evitare il tracollo, può sfruttare i rimedi concorsuali per congelare i debiti fornitori e proporre un pagamento dilazionato/parziale in forma collettiva. Ad esempio, presentando una domanda di concordato preventivo, tutte le azioni esecutive in corso vengono sospese e i creditori chirografari (fornitori inclusi) non possono procedere individualmente: dovranno aspettare l’esito del concordato. Nel concordato l’imprenditore propone di solito ai chirografari una percentuale (es. 20-40%) da pagare entro certi termini. Oppure, tramite la composizione negoziata, si può chiedere al tribunale misure protettive e trattare con i fornitori sotto la guida di un esperto indipendente, cercando un accordo anche plurilaterale. Importante: convincere i fornitori della convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Se il piano prospetta per esempio di pagarli al 30% entro un anno, e dalla liquidazione giudiziale otterrebbero forse il 5% dopo 5 anni, è nel loro interesse aderire. Difatti, ogni creditore aderente a un accordo lo fa sulla base di una valutazione di convenienza economica personale; il giudice, nel omologare l’accordo, non valuta la convenienza per i singoli (che è rimessa alla loro libera scelta), ma solo la legalità e l’idoneità generale del piano .
Debiti verso dipendenti
Se l’impresa ha personale dipendente, può trovarsi con debiti per retribuzioni non pagate, TFR o indennità. I lavoratori dipendenti godono di tutela speciale: i loro crediti per stipendi degli ultimi mesi e TFR sono privilegiati di grado molto alto (art. 2751-bis c.c.), addirittura con prelazione sui mobili superiore a quella fiscale in alcune voci, e con possibilità di escussione del Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza del datore. Inoltre, l’ordinamento punisce penalmente il datore che non versa le ritenute IRPEF trattenute sulle retribuzioni (equiparato all’omesso versamento contributi se oltre soglia) e prevede sanzioni amministrative per il mancato pagamento sistematico delle retribuzioni (ad esempio, la legge n. 13/2022 ha inasprito le conseguenze in caso di omesso versamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, potendo portare anche alla sospensione dell’attività per le imprese che non corrispondono stipendi).
Dal punto di vista difensivo, i debiti verso dipendenti vanno considerati prioritari in qualsiasi piano: in un concordato preventivo, ad esempio, i crediti di lavoro devono essere soddisfatti integralmente (salvo rinuncia del lavoratore) per poter essere omologato, oppure essere pagati dal Fondo di Garanzia (che poi subentra come creditore). È quindi sconsigliabile lasciar accumulare troppi arretrati: meglio trovare un accordo individuale (dilazionare il pagamento degli stipendi con il consenso del lavoratore, magari con scrittura sottoscritta dal sindacato) perché comunque quei debiti emergono e vanno saldati con precedenza. Se un dipendente ottiene un decreto ingiuntivo per stipendi, potrà anche lui chiedere pignoramenti o istanza di fallimento, ma spesso interviene il sindacato per mediare. In fase di crisi conclamata, l’impresa può valutare ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione straordinaria per crisi, se applicabile) per contenere il costo del lavoro e saldare il pregresso col tempo.
Tabella 1: Tipologie di debiti e azioni di recupero vs. difese
| Tipo di Debito | Creditori e azioni tipiche | Rischi per l’azienda/debitore | Strumenti di difesa |
|---|---|---|---|
| Fiscale (Erario) | Agenzia Entrate Riscossione (cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti). | – Ipoteca su beni aziendali e personali;<br>– Fermo amministrativo su mezzi;<br>– Pignoramento di conti e crediti;<br>– Possibili sanzioni penali (IVA, ritenute omesse). | – Rateizzazione fino a 72/120 rate;<br>– Rottamazione/stralcio cartelle (se previsto da legge);<br>– Transazione fiscale in concordato/accordo (stralcio sanzioni/interessi, dilazioni);<br>– Ricorsi tributari se il debito è contestabile;<br>– Misure protettive (concordato/composizione) per sospendere azioni. |
| Contributivo (INPS) | INPS-INAIL (avvisi addebito, cartelle, esecuzioni analoghe al Fisco). | – Come sopra: ipoteche, fermi, pignoramenti;<br>– Reato penale omesso versamento > €10k;<br>– Blocco DURC (niente nuovi appalti senza certificato regolarità contributiva). | – Rateizzazione contributi fino 5 anni (o più con dilazioni straordinarie);<br>– Transazione contributiva in procedure (stralcio sanzioni civili, dilazione contributi);<br>– Regolarizzazione spontanea prima di controlli (per evitare sanzioni penali);<br>– Misure protettive giudiziali per congelare esecuzioni;<br>– Utilizzo di cassa integrazione/Fondo di Garanzia INPS per parte delle spettanze. |
| Bancario/Finanziario | Banche, leasing, factor (decreti ingiuntivi immediati, escussione garanzie). | – Revoca fidi e richiesta rientro immediato;<br>– Pignoramento beni ipotecati/pegno (es. capannoni, macchinari);<br>– Escussione fideiussioni personali (coinvolgimento del patrimonio personale del socio/garante);<br>– Segnalazione a Centrale Rischi (difficoltà di ottenere nuovo credito). | – Moratorie e accordi ABI (sospensione rate mutui);<br>– Rinegoziazione piani di ammortamento, consolidamento debito;<br>– Accordi stragiudiziali con banche (taglio debito, allungamento durata);<br>– Procedura concordataria o accordo di ristrutturazione omologato (imporre ai dissenzienti l’accordo se maggioranza aderisce);<br>– Richiesta misure protettive al tribunale per bloccare pignoramenti mentre si negozia;<br>– Coinvolgimento dei garanti nelle trattative per liberare fideiussioni. |
| Fornitori (Commerciali) | Fornitori di beni/servizi, subappaltatori (decreto ingiuntivo, pignoramento beni, istanza fallimento). | – Blocco operatività per pignoramento attrezzature/conti;<br>– Azioni individuali disordinate che compromettono la par condicio;<br>– Istanza di fallimento (se debiti > €30k);<br>– Recesso da contratti in corso (fornitore non consegna più materiali per inaffidabilità). | – Accordi transattivi individuali (piani di rientro, saldo e stralcio) prima che partano azioni legali;<br>– Gestione in un piano collettivo (concordato/accordo) con proposta uguale per tutti i chirografari, così da bloccare azioni individuali;<br>– Misure protettive (concordato in bianco o composizione negoziata) per fermare i procedimenti esecutivi pendenti;<br>– Eventuale ricerca di nuova finanza per pagare fornitori strategici (anche tramite finanziamenti prededucibili in concordato). |
| Dipendenti | Lavoratori dipendenti (ingiunzione dal Tribunale del Lavoro, privilegi sul TFR e ultime mensilità; intervento INPS). | – Conflitto sindacale, scioperi o dimissioni in massa se non pagati;<br>– Decreti ingiuntivi con esecuzioni (anche se di solito puntano al Fondo di Garanzia INPS in caso di insolvenza conclamata);<br>– Obbligo di pagarli integralmente in procedura, pena mancata omologa;<br>– Responsabilità penale per ritenute fiscali omesse. | – Negoziare con i dipendenti una dilazione consenziente di stipendi (con accordo sindacale) per guadagnare tempo;<br>– Attivare ammortizzatori sociali (CIGS per crisi, contratti solidarietà) per ridurre temporaneamente costi e assicurare un minimo ai lavoratori;<br>– Prevedere nel piano di ristrutturazione il pagamento integrale dei privilegiati del lavoro (magari utilizzando crediti futuri o risorse terze dedicate);<br>– Utilizzare il Fondo di Garanzia INPS in caso di procedura liquidatoria per saldare TFR e ultime tre mensilità (alleggerendo il carico immediato sull’azienda). |
Legenda: misure protettive = provvedimenti del tribunale che sospendono o vietano temporaneamente azioni esecutive e cautelari dei creditori (si ottengono ad es. col deposito di un ricorso per concordato preventivo o con l’accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 18 CCII). Transazione fiscale/contributiva = accordo con Fisco/enti previdenziali in sede concorsuale per pagare parzialmente i loro crediti (vedi sezione dedicata). Prededucibile = credito che sarà pagato con precedenza assoluta in caso di procedura (es. nuovi finanziamenti autorizzati nel concordato). Par condicio creditorum = principio di pari trattamento dei creditori concorsuali dello stesso grado.
Come si evince dalla tabella, ogni tipologia di debito richiede un approccio specifico, ma emergono alcuni principi generali: – È cruciale agire per tempo: attendere passivamente peggiora la situazione. Meglio cercare accordi prima che i creditori perdano fiducia e si attivino legalmente. – Strumenti come le dilazioni amministrative (rate da Agenzia Entrate o INPS) o le moratorie bancarie vanno utilizzati appena possibile per congelare la situazione debitoria e prevenire azioni esecutive. – Quando la crisi è seria e coinvolge molti creditori, soluzioni collettive (piani di risanamento, accordi omologati, concordati) sono preferibili alle soluzioni individuali, perché permettono di gestire il debito in modo organico e sotto un “ombrello” protettivo dell’autorità giudiziaria. – L’imprenditore deve evitare di compiere atti che favoriscano alcuni creditori a discapito di altri in stato di insolvenza, perché ciò può portare a responsabilità personali (come vedremo nella parte sulle responsabilità degli amministratori) e a revocatoria fallimentare di quei pagamenti se l’azienda poi fallisce.
Obblighi dell’imprenditore in crisi e responsabilità degli amministratori
Il diritto italiano negli ultimi anni si è evoluto non solo fornendo strumenti per gestire la crisi, ma imponendo anche precisi obblighi a carico degli imprenditori e degli amministratori per prevenire e affrontare tempestivamente lo stato di difficoltà. È essenziale che l’imprenditore di un’azienda indebitata conosca questi doveri, sia per mettere in atto le azioni corrette (ed evitare ulteriori guai), sia per limitare la propria esposizione personale a conseguenze patrimoniali o penali.
Adeguati assetti e dovere di attivazione (art. 2086 c.c. e Codice della Crisi)
Dal 16 marzo 2019 è in vigore la modifica dell’art. 2086 comma 2 del Codice Civile, introdotta proprio in attuazione del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019). Questa norma impone che “l’imprenditore, il quale operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” . In sostanza: – Gli amministratori di società (di capitali e di persone) hanno il dovere legale di dotare la società di strutture e procedure adeguate a monitorare l’andamento economico-finanziario e a cogliere i primi segnali di squilibrio. – Non appena emerge una situazione di crisi o comunque quando il patrimonio netto si erode (es. perdite rilevanti) o la continuità aziendale è a rischio, gli amministratori devono attivarsi “senza indugio”, scegliendo uno degli strumenti di regolazione della crisi (che vedremo a breve: piani di risanamento, accordi, composizione negoziata, concordato, ecc.) per affrontare la situazione.
Questo obbligo di reazione tempestiva è un punto cardine della riforma: l’idea è che prima si interviene, maggiori sono le chance di salvare l’impresa e soddisfare i creditori. Non a caso, solo il 3,5% delle imprese analizzate ha dichiarato nei bilanci di aver adottato adeguati assetti ex art. 2086 c.c., segno che c’è ancora scarsa consapevolezza . Eppure, non rispettare tale dovere può costare caro: la mancata adozione di assetti adeguati è considerata grave irregolarità nella gestione (ai sensi dell’art. 2409 c.c., che può portare alla revoca giudiziale degli amministratori) e, in caso di fallimento, può essere vista come indice di colpa grave degli amministratori. Già alcune decisioni dei Tribunali (Tribunale Imprese Milano 21/10/2019, Trib. Roma 8/4/2020) hanno evidenziato che amministratori inerti di fronte alla crisi violano i loro doveri e possono esserne chiamati a rispondere .
Per un imprenditore di posa pavimenti industriali, questo significa: monitorare costantemente la situazione economica (tenere la contabilità aggiornata, usare indicatori di allerta come DSCR – Debt Service Coverage Ratio, indici di bilancio indicati dal CNDCEC per misurare la sostenibilità del debito, ecc.). Se i segnali si fanno rossi (ad esempio, la cassa non copre le spese per più mesi, i debiti superano i crediti esigibili, il DSCR scende sotto 1, ecc.), non aspettare ma consultare subito un esperto (commercialista o advisor) e valutare l’attivazione di uno strumento di composizione della crisi. Questo non solo è consigliabile per salvare l’azienda, ma è un preciso obbligo di legge. In caso di successivo fallimento, gli amministratori che non hanno predisposto assetti adeguati o non si sono attivati per tempo potrebbero subire un’azione di responsabilità da parte del curatore per i danni causati dal ritardo (il classico caso: continuare ad accumulare debiti quando l’insolvenza era manifesta, erodendo l’attivo a discapito dei creditori).
Responsabilità civile degli amministratori verso la società e i creditori
Quando una società di capitali fallisce (viene posta in liquidazione giudiziale), sovente emergono profili di responsabilità degli amministratori per mala gestio. Le possibili azioni di responsabilità sono di due tipi: – Azione sociale di responsabilità (art. 2476 c.c. per le S.r.l., art. 2393 c.c. per S.p.A.), esercitata dal curatore fallimentare (che rappresenta la società in insolvenza), per atti o omissioni degli amministratori che abbiano danneggiato il patrimonio sociale. Esempio: l’amministratore ha venduto un macchinario sottocosto a una società a lui riconducibile, o ha sostenuto spese personali con i fondi sociali – qui il danno è alla società e indirettamente ai creditori. – Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c. o azione “per insufficienza patrimoniale”), sempre esercitata dal curatore in via surrogatoria: viene imputato all’amministratore di aver violato obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, causando l’insufficienza di tale patrimonio a soddisfare i creditori. Ad esempio, aver continuato ad operare in perdita aggravando il dissesto invece di liquidare la società in tempo, oppure aver pagato preferenzialmente alcuni creditori riducendo le risorse disponibili per gli altri.
Una recente ordinanza della Cassazione (n. 23963 del 27/08/2025) ha offerto chiarimenti importanti su queste responsabilità. La Suprema Corte ha ribadito che “l’amministratore di una s.r.l. deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, perseguendo l’interesse sociale senza conflitti d’interesse”. Se egli compie atti che favoriscono un interesse extra-sociale (ad esempio personale o di altre società a lui collegate) a scapito della società, commette un atto illecito e può essere chiamato a risponderne . Nel caso esaminato, l’ex amministratore di una società fallita aveva effettuato compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere riconducibili a lui, svantaggiando così gli altri creditori . Il fallimento (il curatore) ha agito chiedendo danni, lamentando violazione del principio di par condicio creditorum. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano condannato l’amministratore, ritenendo provato che avesse operato in conflitto d’interessi e leso il patrimonio sociale preferendo taluni creditori (le sue società) in periodo di insolvenza . La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, confermando in sostanza la condanna . Da questa vicenda discendono principi chiave: – Pagare in via preferenziale alcuni creditori durante lo stato di insolvenza può costituire inadempimento dei doveri dell’amministratore e generare responsabilità per danni: il danno è dato dal minor attivo rimasto per soddisfare gli altri creditori, violando la par condicio . – Se i pagamenti sono effettuati a soggetti vicini all’amministratore (es. sue società correlate), c’è anche conflitto d’interessi e abuso di potere, aggravando la sua colpa. – L’amministratore deve provare di aver agito nell’interesse sociale e con correttezza; se vi sono indizi di favoritismi, l’onere di difesa è in capo a lui per dimostrare che quei pagamenti erano comunque dovuti e non dannosi (e.g. se riuscisse a provare che la società non era insolvente al momento dei pagamenti preferenziali – ma questo è difficile).
In pratica, per l’imprenditore-debitore ciò significa che, se si arriva al fallimento, verranno passati al setaccio gli ultimi anni di gestione: prelievi ingiustificati, vendite a prezzi irrisori, pagamenti anomali ad alcuni creditori, omissione di chiedere la liquidazione in presenza di perdite rilevanti, etc., possono portare a cause personali. L’esito tipico è che l’ex amministratore venga condannato a risarcire, con patrimonio personale, il deficit arrecato (importi spesso teorici, ma il curatore agisce comunque per massimizzare il recupero). Anche i soci di S.r.l., se hanno effettivamente diretto la gestione (amministratori “di fatto”) o se hanno deliberato distribuzioni di utili fittizie o riduzioni patrimoniali illegittime, possono essere coinvolti.
Vale la pena sottolineare che, secondo la “business judgement rule”, gli amministratori non sono responsabili per ogni scelta di gestione che si riveli sfortunata col senno di poi; se però la scelta era manifestamente imprudente o dettata da interessi personali, la protezione della business judgement viene meno . Ad esempio, contrarre debiti ingenti per speculazioni fuori dall’oggetto sociale o continuare a indebitarsi quando era chiaro che non c’era capacità di rimborso, difficilmente sarà considerata una scelta aziendale ragionevole.
Responsabilità verso il fisco e altri enti (sanzioni personali)
Oltre alle responsabilità civilistiche sopra descritte, ci sono responsabilità specifiche verso il Fisco e altri enti: – Come già trattato, l’art. 36 DPR 602/73 pone a carico di amministratori e liquidatori obblighi precisi nel trattare i debiti tributari in fase di scioglimento o pre-scioglimento della società. Un amministratore che non adempie al dovere di liquidare la società quando sarebbe obbligato (es.: perdita oltre un terzo del capitale in s.r.l. senza ricapitalizzazione né liquidazione) rischia che, se in quel periodo paga debiti di serie inferiore rispetto al fisco o distrae beni, venga ritenuto personalmente debitore per i tributi non pagati . Questo strumento è temibile perché consente all’Erario di bypassare la limitazione di responsabilità e colpire il patrimonio personale del dirigente colpevole di tardiva attivazione. – Se la società omette il versamento di IVA o ritenute in misura penalmente rilevante, il legale rappresentante risponde del reato. In caso di condanna penale (per omesso versamento IVA, art. 10-ter D.Lgs 74/2000, o omesso versamento ritenute, art. 10-bis), oltre alle pene detentive sono previste sanzioni accessorie (interdittive) e l’obbligo di pagamento del dovuto. Può essere esclusa la punibilità solo se prima del giudizio il debito viene integralmente estinto (causa di non punibilità per pagamento del debito tributario). – Reati fallimentari: se l’impresa arriva al fallimento, gli amministratori possono essere perseguiti per bancarotta fraudolenta o semplice. Ad esempio, aver sottratto o falsificato scritture contabili, distratto beni aziendali, pagato preferenzialmente taluni creditori poco prima del fallimento, aggravato il dissesto con azioni imprudenti: sono tutti comportamenti che integrano fattispecie di bancarotta (artt. 322 e segg. del Codice della Crisi, che riprendono le vecchie norme di bancarotta del R.D. 267/42). La bancarotta fraudolenta è un reato molto grave, con pene fino a 10 anni di reclusione. Quindi un imprenditore in crisi deve anche guardarsi da compiere atti potenzialmente qualificabili come distrattivi o preferenziali se sa di essere insolvente – oltre al profilo civilistico, v’è quello penale in agguato. – Responsabilità amministrativa “231”: in teoria, se gli amministratori compiono reati come quelli tributari o fallimentari nell’interesse o a vantaggio della società, si potrebbe applicare il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa dell’ente (ad esempio per alcuni reati tributari dal 2021 è prevista la responsabilità 231). Nella prassi, però, per reati come omesso versamento IVA ciò è di rado contestato alle PMI, e comunque non tocca l’imprenditore in sé ma la società (che potrebbe subire sanzioni pecuniarie e interdittive). Tuttavia, è un aspetto da considerare in contesti più ampi.
In sintesi, l’imprenditore/amministratore di una società indebitata deve: – Attivarsi presto (assetti adeguati e misure anti-crisi) per evitare di violare l’obbligo di legge di cui all’art. 2086 c.c. – Evitare di aggravare il dissesto: se continua l’attività, deve poter dimostrare che c’era una ragionevole prospettiva di risanamento; altrimenti, continuare a fare debiti configura una colpa. – Non favorire se stesso o parti correlate a scapito dei creditori (es.: non farsi restituire finanziamenti soci in anticipo, non liquidare parti correlate preferendo i loro crediti). – Non disperdere o occultare risorse aziendali (bancarotta). – Documentare in modo trasparente l’operato: tenere i libri contabili in ordine è fondamentale. Una contabilità caotica, con ammanchi non giustificati, è terreno fertile per accuse di bancarotta fraudolenta documentale. – Relativamente ai debiti fiscali/contributivi, valutare attentamente se assumersi impegni di versamento realistici. Se non si riesce a pagare l’IVA, meglio rivolgersi subito all’Agenzia Entrate per soluzioni o al giudice per un concordato, piuttosto che far decorrere i termini inadempiuti e cadere nel penale. – In ogni caso di dubbio, consultare legali e consulenti esperti in crisi: muoversi con cognizione di causa può evitare passi falsi (ad esempio, capire prima quali atti potrebbero essere revocati dal futuro curatore fallimentare consente di evitarli o farli nel modo meno rischioso).
Strumenti per affrontare la crisi e ristrutturare i debiti
Passiamo ora alla panoramica degli strumenti legali che l’imprenditore con debiti può attivare per risolvere o alleviare la crisi. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore nel luglio 2022 e aggiornato dai correttivi del 2022 e 2023/2024, mette a disposizione diverse procedure di regolazione della crisi. Queste vanno da soluzioni stragiudiziali private (accordi negoziati con i creditori, seppur con alcuni requisiti di legge) a procedure concorsuali giudiziarie vere e proprie (sotto il controllo del tribunale). La scelta dipende dal grado di insolvenza dell’azienda, dalla fattibilità del risanamento e dalla disponibilità dei creditori a cooperare.
In questa sezione esamineremo i principali strumenti – Piano attestato di risanamento, Accordo di ristrutturazione dei debiti (nelle sue varianti), Composizione negoziata della crisi, Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) e, infine, l’extrema ratio della Liquidazione giudiziale (ex fallimento). Accenneremo anche alle procedure per le imprese minori (concordato minore e liquidazione controllata). Un focus specifico sarà dedicato alla transazione fiscale e contributiva, che spesso è la chiave per gestire i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali all’interno di questi strumenti.
Soluzioni stragiudiziali “protette” e negoziali
Nell’ambito stragiudiziale, l’imprenditore può tentare di risanare l’impresa fuori dalle aule di giustizia, mantenendo la gestione e negoziando direttamente con i creditori. Due strumenti cardine rientrano in questa categoria: il Piano attestato di risanamento e gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (pur con l’ausilio, questi ultimi, dell’omologazione del tribunale per efficacia).
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento stragiudiziale puro, di origine privatistica, che consente all’imprenditore in crisi di predisporre un piano di risanamento dell’azienda asseverato da un professionista indipendente. In cambio di ciò, la legge gli riconosce alcuni benefici, in particolare la protezione da azioni revocatorie in caso di successivo fallimento e qualche attenuante sul piano penale (per esempio, certi pagamenti effettuati in esecuzione del piano attestato non sono considerati preferenziali ai fini della bancarotta).
Nel dettaglio: – Il piano consiste in un documento che descrive la situazione di partenza, le cause della crisi, e soprattutto le misure di risanamento proposte: può includere la ristrutturazione delle esposizioni (dilazioni, riduzioni), dismissione di beni non strategici per fare cassa, iniezioni di finanza nuova (dai soci o terzi), riorganizzazione aziendale e taglio costi, ecc. L’obiettivo è il riequilibrio dell’esposizione debitoria e il ripristino della continuità aziendale . – Un professionista indipendente (revisore, commercialista o esperto di crisi iscritto in apposito registro) deve esaminare il piano e rilasciare un’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano stesso. Questa attestazione è cruciale per dare credibilità al piano verso i creditori e per ottenere la protezione legale. – Una volta predisposto e attestato, il piano deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese (facoltativamente; il CCII art. 56 ora ne consente la pubblicazione su richiesta dell’imprenditore). La pubblicazione è importante perché, tra l’altro, consente di accedere a taluni benefici fiscali: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente (Risposta interpello n. 222/2024) che le sopravvenienze attive derivanti dal taglio dei debiti in esecuzione di un piano attestato godono dell’esenzione fiscale parziale ex art. 88, c.4-ter TUIR, purché il piano sia pubblicato nel registro imprese . Ciò significa che l’eventuale “guadagno” che l’azienda ottiene perché i creditori le abbuonano parte dei debiti non viene tassato interamente come reddito: una grossa agevolazione fiscale per incentivare l’uso del piano di risanamento. – Non vi è un procedimento giudiziale né un’omologazione: il piano resta un accordo privato tra l’imprenditore e i creditori che decidono di aderire. Non c’è coattività verso gli eventuali non aderenti: chi non partecipa al piano non è vincolato da esso. Per questo, di solito il piano attestato è utile quando si riesce ad ottenere il consenso informale di tutti o quasi i creditori rilevanti, oppure quando l’imprenditore ha risorse per pagare integralmente i creditori non aderenti. – L’effetto legale principale, sancito dall’art. 56 CCII (ex art. 67, co.3, lett. d L.F.), è che gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti a revocatoria in un eventuale successivo fallimento. Ad esempio, se l’azienda paga un fornitore in base al piano di risanamento, e poi dopo un anno dovesse comunque fallire, quel pagamento non potrà essere revocato dal curatore come preferenziale (purché il piano fosse idoneo e l’attestazione veritiera). Ciò dà ai creditori la tranquillità di poter accettare pagamenti scaglionati o transatti senza il timore di doverli restituire in caso di fallimento seguente. – Inoltre, sempre se il piano è veritiero e viene eseguito onestamente, l’amministratore potrebbe evitare accuse di bancarotta preferenziale per quei pagamenti (perché erano in esecuzione di un piano di risanamento volto a salvare l’impresa, quindi con causa lecita). Si tratta di una sorta di “safe harbor” sia civile che, in parte, penale.
Quando usare un piano attestato? È indicato se l’impresa ha chance concrete di risanamento e il numero di creditori è gestibile tramite accordi individuali. Tipicamente, se i creditori principali (banche, fornitori strategici, fisco) sono favorevoli a un accordo, si può optare per il piano attestato perché è rapido, riservato (non c’è udienza pubblica né nomina di commissari) e l’imprenditore mantiene piena la guida. Serve però fiducia tra le parti: nessun giudice “impone” l’accordo ai dissenzienti, quindi occorre convincere volontariamente i creditori. Il piano attestato non offre di per sé misure protettive automatiche: l’imprenditore non ha il beneficio del blocco delle azioni esecutive mentre lo prepara (a differenza di concordato o altri strumenti). Tuttavia, in pratica, spesso lo si combina con accordi di moratoria temporanei con i creditori o con l’accesso preventivo alla composizione negoziata per ottenere una breve protezione, per poi formalizzare il piano attestato.
Importante è anche la qualità dell’attestazione: i “Principi di attestazione dei piani di risanamento” emanati dal CNDCEC (aggiornati nel 2024) chiedono all’attestatore un’analisi rigorosa e indipendente . Un’attestazione negligente o falsa può esporre l’attestatore a responsabilità (anche penale per concorso in bancarotta fraudolenta documentale, se avalla dati falsi). Dal lato dell’imprenditore, fornire dati veritieri e completi all’esperto è essenziale: se emergessero omissioni ingannevoli, i benefici del piano decadono e si rischiano guai peggiori.
Vantaggi del Piano attestato: – Evita pubblicità negativa di una procedura concorsuale (l’azienda risulta “in bonis” mentre si risana). – Flessibilità massima nella struttura dell’accordo con i creditori (nessuna formalità di classi, percentuali minime, votazioni). – Nessun costo di procedura giudiziaria (si paga solo il professionista attestatore e gli eventuali consulenti). – Protegge da revocatorie e alcuni profili di responsabilità, incentivando quindi i creditori a collaborare. – Può essere preparatorio ad un successivo accordo più formale: ad esempio, se il piano non va come sperato, si può sempre ripiegare su un concordato preventivo successivamente.
Svantaggi/limiti: – Non vincola i creditori dissenzienti: se anche uno importante rifiuta e agisce legalmente, può far saltare tutto. È quindi poco utile se c’è un “franco tiratore” aggressivo. – Non sospende di diritto le azioni esecutive: serve fiducia che nessuno proceda in quei mesi. Ciò lo rende difficile da gestire in situazioni di conflittualità alta. – Non consente di imporre sacrifici a creditori privilegiati se non consensualmente: ad esempio, non si può tagliare il debito erariale se l’Erario non accetta; se una banca con ipoteca non aderisce, andrà pagata integralmente per liberare il bene ipotecato (o comunque tener conto che può escutere la garanzia). – Rischio di insuccesso e poi fallimento: se il piano attestato non riesce a far uscire l’azienda dalla crisi e la si porta comunque a fallimento, il tempo speso potrebbe aver ulteriormente deteriorato la situazione (per questo va adottato solo se c’è ragionevole confidenza di riuscita).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
L’accordo di ristrutturazione è uno strumento a metà tra il piano attestato e il concordato: è fondato su un accordo negoziato con i creditori, ma prevede l’intervento del tribunale per la sua omologazione (approvazione formale) che gli conferisce efficacia vincolante e alcuni effetti protettivi verso tutti i creditori coinvolti . In pratica, è un “concordato stragiudiziale” dove però il giudice interviene limitatamente per omologare e garantire che l’accordo non pregiudichi i creditori estranei.
Le caratteristiche principali: – Contenuto: L’imprenditore predispone un piano di ristrutturazione simile a quello del piano attestato (stato di crisi, misure proposte, business plan per ripresa, ecc.), con l’ausilio di un attestatore indipendente che certifica completezza e fattibilità. Sulla base di tale piano, negozia un accordo scritto con una parte dei creditori. La legge richiede che abbiano aderito creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (quorum ordinario) . Questo vuol dire, ad esempio, che se l’impresa ha 1 milione di debiti, servono creditori per almeno 600.000 € consenzienti alla ristrutturazione. – L’accordo può prevedere dilazioni, remissioni parziali, riscadenzamenti del debito, conversione di crediti in quote di capitale, ecc., secondo l’autonomia negoziale. Può includere anche la proposta di transazione fiscale/contributiva per i debiti erariali/previdenziali (art. 63 CCII), ossia chiedere all’Erario e INPS di aderire all’accordo accettando un pagamento parziale con stralcio di sanzioni (ne parleremo sotto). – Una volta raccolte le adesioni necessarie, l’accordo viene sottoposto al tribunale per l’omologazione. Il giudice verifica il rispetto dei requisiti (percentuale di consensi, fattibilità economica attestata, corretto trattamento dei creditori non aderenti, ecc.) e se tutto è regolare omologa l’accordo rendendolo efficace. – Effetti dell’omologazione: l’accordo omologato vincola tutti i creditori aderenti (ovviamente) e consente di cristallizzare la situazione. I creditori che hanno firmato non possono agire in executivis (devono rispettare le nuove scadenze e importi pattuiti). I creditori estranei (non aderenti) invece di regola restano fuori dall’accordo: devono essere pagati integralmente, altrimenti possono agire. Infatti, il CCII prevede che, per omologare, occorre dimostrare che i creditori estranei saranno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione o dalle loro scadenze, se successive . Questo è per tutelare chi non ha firmato: non subisce decurtazioni forzose e viene soddisfatto fuori dall’accordo. Un’eccezione è se l’accordo è ad efficacia estesa (vedi infra) o se si applica il cram-down fiscale su Fisco/INPS. – Misure protettive: a differenza del piano attestato, qui l’imprenditore può chiedere al tribunale, al momento del deposito del ricorso di omologazione, di emanare un decreto che sospende le azioni esecutive dei creditori fino all’omologazione (o finché il giudice ritenga, max 4-6 mesi). Questo “scudo” ha l’effetto pratico di congelare pignoramenti, impedire ai creditori di iniziare o proseguire esecuzioni, e anche sospendere la decorrenza degli interessi per i crediti chirografari. Ciò offre respiro all’impresa e la protegge durante il periodo (a patto di aver depositato almeno le adesioni al 60% o prove di trattative avanzate). Nota: se si sceglie la forma dell’accordo agevolato al 30% (vedi dopo), le misure protettive sono interdette, come contropartita della soglia ridotta . – Durata: un accordo di ristrutturazione è tendenzialmente più rapido di un concordato, perché non necessita di votazione di tutti i creditori né di complessi riparti. Se i creditori principali hanno firmato, l’omologa può arrivare in pochi mesi. Mediamente, occorrono comunque 4-6 mesi tra deposito e omologa. – Costi: ci sono i costi dell’attestatore e degli advisor legali, e un contributo unificato per il tribunale, ma non c’è un commissario di nomina obbligatoria (il tribunale può nominarne uno ad hoc per vigilare, ma di solito non lo fa se tutto è regolare). Dunque i costi sono inferiori a un concordato (dove c’è commissario e organi vari).
Il CCII prevede tre varianti di accordi di ristrutturazione : 1. Accordo “ordinario” (art. 57 CCII): quorum minimo 60%, misure protettive possibili, pagamento integrale entro 120g dei non aderenti, omologazione standard. 2. Accordo “agevolato” (art. 60 CCII): introdotto dalla riforma 2017-2020 (ex art. 182-novies L.F.), permette di ridurre il quorum al 30% dei crediti , a patto che tutti i creditori estranei vengano pagati integralmente e immediatamente (cioè al momento dell’omologa) e senza poter accedere a misure protettive. In sostanza l’imprenditore dice: “ho pochi creditori chiave che posso convincere (30%), gli altri li pago cash fuori dall’accordo”. È utile se l’impresa ha liquidità o garanzie per pagare quei creditori minori e vuole includere nell’accordo solo, ad esempio, le banche principali. Per esempio, su €1M di debiti, l’impresa concorda col 30% (€300k) di fare uno stralcio e paga invece l’altro 70% (€700k) subito (magari grazie a un nuovo finanziatore) ai creditori estranei. Così evita di dover convincere tutti, al prezzo di liquidare integralmente gli estranei. È uno schema adatto a crisi limitate o con pochi creditori dissenzienti affrontabili con risorse proprie. Ovviamente comporta che l’azienda disponga di quella liquidità immediata (o la procuri tramite terzi, ad esempio un nuovo socio investitore). Se durante il percorso ci si accorge che non si riesce a pagare gli estranei come promesso, occorrerà passare a un accordo ordinario (ma allora servirebbe il 60%). 3. Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): qui l’innovazione è grande. L’accordo ad efficacia estesa prevede di suddividere i creditori in classi omogenee e, se in ciascuna classe si raggiunge una super-maggioranza (almeno il 75% dei crediti di quella classe; ridotto al 60% se l’impresa aveva già tentato la composizione negoziata prima), gli effetti dell’accordo si estendono coattivamente ai creditori non aderenti di quella classe. Questo strumento, ereditato dall’ex art. 182-septies L.F., nasce per imporre l’accordo alle banche dissenzienti: infatti tipicamente si fa una classe di istituti finanziari e, se il 75% (per importo) ha accettato la ristrutturazione del credito, il tribunale può omologare l’accordo rendendolo vincolante anche per la minoranza di banche che ha rifiutato. In origine era limitato ai crediti finanziari, ma il CCII sembra consentire classi di creditori in senso ampio (omogenei per posizione giuridica ed interessi) – ad esempio, potrebbe ipotizzarsi una classe di fornitori strategici con medesimo trattamento. Tuttavia la prassi finora l’ha usato soprattutto per banche e obbligazionisti. Condizioni: serve comunque che la somma dei crediti aderenti sia ≥ 60% del totale (quorum globale), e che ai creditori dissenzienti sia offerto il medesimo trattamento degli aderenti nella loro classe. Se la banca A dissente ma le banche B, C, D (80% del debito bancario) accettano di prendere il 70% a saldo, allora anche A sarà costretta ad accettare 70% a saldo. L’accordo ad efficacia estesa è quindi un cram-down settoriale su categorie di creditori. È prezioso per superare rigidità di minoranze (ad esempio un fondo speculativo che non aderisce per puntare a far saltare tutto e comprare asset in fallimento: con efficacia estesa, se è minoranza, non può boicottare). – Da notare che questo meccanismo di solito esclude i crediti tributari e contributivi, a meno che essi stessi siano in una classe con le percentuali richieste. In pratica, l’Erario/INPS non possono essere crammed down con l’art. 61 (si usa invece l’altro strumento del cram-down fiscale ex DL 69/2023 di cui sotto). – L’accordo ad efficacia estesa richiede l’omologazione** e c’è la possibilità di opposizione da parte dei creditori non aderenti (che in udienza possono contestare ad es. che non vi fosse omogeneità di classe o convenienza). – Questo strumento è particolarmente utile quando c’è un numero alto di creditori (es. molte banche o obbligazionisti) e serve evitare che pochi dissenzienti pregiudichino il risanamento.
Durante l’attesa dell’omologazione, l’imprenditore deve eseguire l’accordo secondo i termini pattuiti (salvo attendere omologa per eventuali stralci). Se la situazione migliora, l’accordo può anche essere rivisto di comune accordo; se peggiora, si può convertirlo in un concordato preventivo (spesso capita: accordo non regge -> si “sdraia” in un concordato per avere un taglio più drastico ai debiti).
Un passaggio chiave aggiornato nel 2023: prima, se l’Erario o l’INPS non aderivano, era impossibile omologare se il loro credito era significativo (perché non riuscivi a raggiungere il 60% e dovevi pagarli fuori integralmente, cosa spesso proibitiva). Con il D.L. 69/2023 convertito (inserito come art. 1-bis), è stato introdotto il cram-down fiscale e contributivo negli accordi di ristrutturazione. In pratica: se il Fisco e/o l’ente previdenziale non aderiscono, ma la loro adesione sarebbe decisiva per raggiungere il quorum del 60% e l’accordo appare più conveniente della liquidazione giudiziale, il tribunale può ugualmente omologare l’accordo col parere favorevole del commissario giudiziale o attestatore sulla convenienza per il Fisco . Questo è successo, ad esempio, nel caso Tribunale di Vasto 11/12/2024: l’Agenzia Entrate non aveva firmato, impedendo di arrivare al 60%; ma il piano offriva al Fisco una somma superiore a quanto avrebbe preso dalla liquidazione, perciò il tribunale ha applicato l’art. 1-bis D.L. 69/2023 e ha omologato l’accordo lo stesso, estendendone gli effetti all’Erario dissenziente . Condizioni: l’accordo non deve essere meramente liquidatorio (cioè deve prevedere continuità o comunque soluzioni migliorative) e bisogna inserire una clausola risolutiva espressa che se il debitore non paga puntualmente le rate dovute al Fisco/INPS, l’accordo si risolve ex lege . Questa novità rimuove un tradizionale potere di veto assoluto del Fisco, responsabilizzandolo: se il piano è serio e vantaggioso, non può sabotarlo rifiutando irragionevolmente.
Pro e contro dell’accordo di ristrutturazione: – Pro: rispetto al concordato, coinvolge meno il tribunale (niente voto di tutti i creditori, procedura più snella), è riservato (si discute solo con i principali creditori, senza curatore), l’imprenditore resta in sella e di solito senza commissari. Consente soluzioni flessibili (classi mirate, varianti agevolate). Una volta omologato, dà certezza e protezione come un concordato (stop individual actions, vincola tutti gli aderenti e eventuale efficacia estesa sui dissenzienti in certe classi). È ideale se l’impresa è ancora economicamente valida e c’è consenso di larga parte dei creditori, magari grazie a prospettive di continuità (spesso usato per ristrutturazioni aziendali vere e proprie). – Contro: richiede comunque un consenso elevato dei creditori, più complicato da ottenere se sono tanti (in tal caso si preferisce il concordato, dove decidono le maggioranze in classi ma votano tutti). Se un creditore importante non aderisce e non lo si può cramdowndare (es. un fornitore estraneo troppo grosso che non puoi pagare subito), l’accordo potrebbe non reggere. Inoltre, fino all’omologa c’è sempre l’incertezza dell’opposizione di estranei (che possono far ritardare o mettere in discussione l’equità dell’accordo). E, come ogni procedura, se fallisce (manca omologa o si risolve per inadempimento), espone l’azienda immediatamente al rischio di istanze di fallimento.
TABELLA 2: Confronto sintetico strumenti di regolazione della crisi
| Strumento | Tipo | Quorum / Condizioni | Coinvolgimento Tribunale | Misure protettive? | Vincolatività | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Stragiudiziale puro | Nessun quorum legale (accordi individuali coi creditori; richiesto attestatore indip.) | Nessuna omologazione (solo eventuale deposito registro imprese) | No misure automatiche (possibile chiedere misure temporanee via composizione negoziata) | Vincola solo chi aderisce volontariamente. Estranei: vanno pagati secondo accordi propri. | Art. 56 CCII (ex art. 67 L.F.) |
| Accordo di ristrutturazione (ordinario) | Stragiudiziale + omologa | ≥ 60% dei crediti totali aderenti; attestazione fattibilità; pagamento integrale estranei entro 120 giorni | Sì, omologa tribunale (possibile nomina ausiliaria di commissario in rarissimi casi) | Sì, misure protettive ottenibili su richiesta durante omologa (salvo non più di 60gg prima deposito ricorso) | Vincola aderenti; estranei devono essere soddisfatti integralmente (altrimenti possono agire). | Art. 57 CCII (ex art. 182-bis L.F.) |
| Accordo “agevolato” (30%) | Stragiudiziale + omologa | ≥ 30% dei crediti aderenti; niente misure protettive richieste; pagamento immediato e integrale di tutti gli estranei entro l’omologa | Sì, omologa tribunale (stesse regole generali) | No, debitore rinuncia a chiederle (se le chiede, perde il beneficio del 30%) | Vincola aderenti; estranei tutti soddisfatti fuori (non subiscono modifica contrattuale) . | Art. 60 CCII (ex art. 182-novies L.F.) |
| Accordo ad efficacia estesa | Stragiudiziale + omologa | Suddivisione creditori in classi omogenee; in ogni classe ≥ 75% (o 60% se accesso a composizione negoziata prima) di consensi; somma consensi ≥ 60% totali ; equo trattamento dissenzienti. | Sì, omologa; maggior controllo su classi e trattamento equo. | Sì, misure protettive possibili (tranne che se era anche agevolato al 30%, ipotesi in teoria mutuamente esclusiva). | Vincola aderenti; dissenzienti nelle classi -> vincolati anch’essi (cram-down sulle minoranze delle classi) . Estranei fuori dalle classi (se ce ne sono) vanno soddisfatti integralmente. | Art. 61 CCII (ex art. 182-septies L.F.) |
| Composizione negoziata | Stragiudiziale assistito | Nessun quorum (strumento volontario); requisiti: impresa non in decozione irreversibile, situazione di squilibrio da recuperare. Esperto terzo nominato. | Intervento giudice eventuale: per misure protettive e provvedimenti urgenti su istanze (es. autorizzazione finanziamenti prededucibili, ecc.). Omologa solo se si conclude con accordi ex artt. 23/24 CCII (contratti o convenzione moratoria). | Sì, su istanza al tribunale, misure protettive del patrimonio per durata negoziazione (tipicamente 4+4 mesi) . | Non è di per sé vincolante, è un processo. Può concludersi con accordi vari:<br>– Contratto con creditori (puro stragiud.)<br>– Accordo sottoscritto con esperto (produce effetti piano attestato) <br>– Concordato semplificato (liquidatorio, omologato senza voto) se negoziazione fallisce (art. 25-sexies CCII). | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021; Artt. 17-25 CCII (modificati da D.Lgs 83/2022 e D.Lgs 136/2024) |
| Concordato preventivo (continuità) | Concorsuale giudiziale | Nessun quorum di adesione iniziale (tutti i creditori coinvolti); per approvazione serve ≥ 50% dei crediti votanti favorevoli (distinto per classi se classamento adottato) <br>+ almeno 2/3 in valore per classi privilegiate parzialmente soddisfatte. | Sì, controllo tribunale su tutta la procedura; nomina Commissario Giudiziale; omologa finale del tribunale (eventualmente anche contro voto contrario se superate contestazioni di convenienza). | Sì, automatic stay appena presentata domanda (in bianco o con piano): sospensione procedure esecutive e divieto pagamenti antecedenti. | Vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti (cram-down generale se approvato a maggioranza e omologato). Possibile anche cram-down interclassi da parte del tribunale se alcune classi votano contro ma piano equo. | Artt. 84-120 CCII (ex artt. 160-186 L.F.). |
| Concordato preventivo (liquidatorio) | Concorsuale giudiziale | Come sopra, ma deve garantire >=20% ai chirografari se nessuna continuità aziendale (salvo apporti esterni che innalzano attivo 10% in più rispetto a liqu. fallim.) . | Sì, organi della procedura e controllo giudice stringenti. | Sì, come sopra (protezione dal deposito domanda). | Vincola tutti i creditori anteriori (anche qui, con eventuali classi). Creditori privilegiati possono subire decurtazione solo se degradati a chirografo per incapienza garanzia o se rinunciano al privilegio. | Artt. 84-120 CCII (prevede requisiti speciali per concordato liquidatorio art. 84 co.4). |
| Concordato “minore” | Concorsuale giudiziale (sovraindebitamento) | Riservato a debitore non fallibile (piccolo imprenditore sotto soglie art. 2 CCII, o imprenditore cessato, o professionista). Richiede fattibilità e convenienza rispetto a liquidazione controllata. Approvazione con 50% crediti votanti. | Sì, simile a concordato preventivo ma in tribunale competente per sovraindebitamento. Nomina OCC (Organismo Composizione Crisi) e gestore. | Sì, misure protettive su istanza (come concordato). | Vincola tutti i creditori anteriori (dopo omologazione). Possibilità di cram-down giudiziale se mancata approvazione ma proposta comunque più favorevole di liquidazione (art. 75 co. 5 CCII). | Artt. 74-83 CCII (ex piano del consumatore/accordo minore L.3/2012). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Concorsuale liquidatoria | Dichiarata dal tribunale su istanza (creditore, debitore, PM) se insolvenza accertata. Presupposti: impresa assoggettabile (non piccolissima, vedi art. 2 CCII) e debiti scaduti ≥ €30.000 . | Sì, nomina di Curatore, giudice delegato, ecc. Procedura interamente in mano agli organi concorsuali. | No misure protettive (è la procedura di esecuzione collettiva stessa). Dal provvedimento di apertura scattano effetti ablativi (spossessamento amministratore). | Vincola tutti i creditori anteriori (diventano concorrenti nel fallimento). I crediti restano insoddisfatti proporzionalmente all’attivo ricavato. Possibile esdebitazione finale del debitore persona fisica onesto (liberazione dai debiti residui). | Artt. 121-270 CCII (sostituisce la L. Fall. 1942). |
Note: La composizione negoziata non è una procedura concorsuale né un accordo di per sé, ma un percorso assistito: può sfociare in vari esiti (accordo stragiudiziale semplice, accordo attestato con esperto, accordo di ristrutturazione o concordato, oppure se fallisce in concordato semplificato liquidatorio). Nel concordato in continuità, l’azienda prosegue l’attività (direttamente o ceduta in esercizio a terzi) e non vige l’obbligo del 20% ai chirografari (la percentuale può essere minore se il piano lo giustifica – ciò perché si presume la continuità offra benefici indiretti ai creditori) . Nel concordato liquidatorio puro, invece, la legge richiede almeno il 20% di soddisfo ai chirografari , salvo apporto di finanza esterna pari ad almeno il 10% dell’attivo (in tal caso si può scendere sotto 20%). Il concordato minore è analogo al concordato preventivo, ma destinato a debitori piccoli non fallibili: non può essere utilizzato da società che superano i limiti dimensionali dell’art. 2 CCII (che sono simili a quelli ex art. 1 L.Fall: attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k). La liquidazione controllata è invece l’equivalente del fallimento per debitori non fallibili (procedura di sovraindebitamento liquidatorio).
La Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e art. 17 CCII)
Merita un approfondimento la composizione negoziata, uno strumento innovativo introdotto a fine 2021 e ora integrato nel Codice della Crisi. Si tratta di una procedura volontaria, non concorsuale, finalizzata ad aiutare l’imprenditore in difficoltà a negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. È pensata per intervenire in uno stadio precoce di squilibrio, prima che l’insolvenza diventi irreversibile.
Caratteristiche: – L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) indicando la propria situazione economico-patrimoniale e le cause della crisi. Deve allegare documenti (bilanci ultimi anni, situazione aggiornata, elenco creditori, ecc.) e una dichiarazione di aver preso misure di auto-risanamento se possibile. – Un’apposita commissione nomina un esperto negoziatore, scelto tra professionisti con specifiche competenze in risanamenti. L’esperto è terzo e indipendente. – Si apre quindi una fase di negoziazione assistita: l’esperto convoca l’imprenditore e i creditori principali, analizza la situazione, e tenta di facilitare un accordo di ristrutturazione consensuale. Egli non ha poteri impositivi, ma può proporre soluzioni, mediare, chiedere concessioni. Il suo obiettivo è trovare un “esito idoneo al superamento della crisi”, che potrebbe essere: – Un contratto di ristrutturazione ad hoc (ad esempio, nuovi finanziamenti, dilazione collettiva dei debiti, haircuts concordati bilateralmente). – Un accordo di ristrutturazione dei debiti formalizzato e da omologare ex art. 57 CCII (se raggiunge le soglie). – Un piano attestato (l’esperto può concludere i lavori attestando che il piano predisposto è ragionevole e sottoscrivendo anche lui, conferendo al piano effetti protettivi analoghi a un piano attestato pubblicato ). – Oppure un concordato preventivo (se serve coinvolgere tutti con una procedura formale). – In caso di fallimento delle trattative, l’esperto dà atto della non fattibilità e l’imprenditore può comunque avere accesso entro 60 giorni a un particolare concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (una procedura introdotta per evitare il fallimento quando la composizione fallisce: l’imprenditore propone di liquidare i beni sotto controllo del tribunale, senza voto dei creditori, e il tribunale omologa se ritiene che soddisfi meglio i creditori rispetto al fallimento).
- Durante la negoziazione (che dura inizialmente max 180 giorni, prorogabile di 180), l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda, ma l’esperto vigila e riferisce se vengono compiute condotte pregiudizievoli per i creditori. L’esperto redige relazioni mensili sullo stato delle trattative.
- Cruciale: l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive del patrimonio per il tempo della composizione negoziata. Il tribunale, se concede, ordina ai creditori di astenersi o sospende procedure esecutive già avviate. Dà anche incarico all’esperto di vigilare sul rispetto delle regole da parte del debitore . Le misure protettive sono pubblicate nel registro imprese, così tutti i creditori ne hanno notizia. Esse valgono al massimo 4 mesi (prorogabili di altri 4 su richiesta motivata dell’esperto). Durante questo periodo i creditori non possono, ad esempio, iscrivere ipoteca giudiziale, iniziare pignoramenti, o proseguire azioni esecutive individuali.
- L’esperto può anche chiedere al giudice autorizzazioni per l’imprenditore come contrarre finanziamenti prededucibili, cedere azienda senza incorrere in revocatoria, sciogliersi da contratti onerosi, ecc. Il D.Lgs. 83/2022 e poi il D.Lgs. 136/2024 (correttivo) hanno ampliato l’uso di questi strumenti. Tra le novità, il correttivo 2024 ha previsto la possibilità di stipulare durante la composizione negoziata una sorta di accordo fiscale con l’Erario: l’art. 23 CCII comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs 136/2024) consente di includere una proposta di transazione fiscale nelle trattative , sostanzialmente anticipando il dialogo con l’Erario senza dover subito andare in concordato.
- Statistiche: la composizione negoziata ha mostrato incoraggianti risultati per imprese medio-grandi. Unioncamere ha comunicato che al novembre 2025 ci sono state oltre 3.600 istanze di composizione negoziata, con 423 aziende risanate con successo (23mila posti di lavoro salvati) e un raddoppio degli esiti positivi rispetto all’anno precedente . Questo indica che sta diventando lo strumento preferito per affrontare la crisi, grazie ai vantaggi di riservatezza, snellezza e salvaguardia della continuità . Va però notato che a farvi ricorso sono soprattutto aziende medio-grandi; per le piccole si discute di semplificarne l’accesso, data la minor struttura organizzativa di queste ultime .
Per il nostro imprenditore indebitato, la composizione negoziata può essere un’ottima prima mossa se: – L’impresa è ancora viva e ha prospettive di rilancio (magari con nuovi contratti all’orizzonte o mercato in ripresa, ma le serve tempo e respiro dai debiti pregressi). – Ci sono creditori chiave ragionevoli con cui sedersi al tavolo (es. la banca principale, un fornitore cruciale, l’Agenzia delle Entrate per i debiti fiscali). – Si vuole evitare subito la pubblicità negativa di un concordato (che spesso spaventa clienti e fornitori). – Si ha bisogno di un “coach” esperto e imparziale che aiuti a trovare un equilibrio (l’esperto nominato). – Si intende eventualmente accedere a misure protettive per fermare temporaneamente azioni esecutive, ma mantenendo flessibilità: nelle misure protettive ottenute con la composizione negoziata, il debitore non è poi vincolato a depositare un concordato obbligatoriamente (come avviene invece col concordato in bianco), può semplicemente usarle per trattare con meno pressione.
In caso di successo, la composizione negoziata si conclude con soluzioni contrattuali creative: es. i principali creditori firmano un accordo in cui accettano una moratoria di 1 anno sui pagamenti e una ripresa graduale, l’imprenditore ottiene nuova finanza per liquidare i piccoli creditori, l’Erario concede un piano di rateizzazione straordinario e cancella sanzioni, ecc., il tutto supervisionato dall’esperto. Questo accordo può restare riservato (se tutti si fidano) oppure essere trasfuso in un accordo di ristrutturazione omologato se si preferisce dargli forza esecutiva. In alcuni casi, l’esito è il reperimento di un investitore terzo grazie al tempo guadagnato, che subentra nell’azienda apportando risorse per pagare i debiti.
Se invece non si trova accordo, l’esperto ne prende atto. L’impresa a quel punto può: – Decidere un concordato preventivo (avendo già gran parte del lavoro di analisi fatto). – Se la situazione è di insolvenza irreversibile senza prospettive, forse optare per la liquidazione giudiziale o (se piccola) la liquidazione controllata volontaria. – Usufruire, come ultima spiaggia, del concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII: propone al tribunale la cessione dei beni ai creditori senza votazione. Questo strumento è stato ideato per evitare i fallimenti “disordinati” quando c’è stata una composizione negoziata tentata ma fallita. Non richiede il voto dei creditori, il tribunale valuta e se la proposta appare migliorativa rispetto al fallimento, la omologa. In pratica, è un modo per liquidare sotto controllo, nominando un liquidatore che esegue il piano. Non salva l’azienda (che viene liquidata), ma può ridurre i tempi e costi rispetto alla liquidazione giudiziale e dare ai creditori qualcosa in più.
Da notare: la composizione negoziata non fa scattare di per sé lo stato di insolvenza né è una procedura concorsuale, quindi l’imprenditore mantiene titolarità e amministrazione dell’impresa. Deve però operare secondo buona fede e con massima trasparenza verso l’esperto e i creditori, altrimenti l’esperto può abbandonare l’incarico segnalando abusi (ad esempio se l’imprenditore fa sparire risorse durante le trattative, il tribunale può revocare le misure protettive immediatamente).
Riassumendo: la composizione negoziata è un tavolo di negoziazione protetto e guidato da un esperto. In ottica difensiva, è un’opportunità per l’imprenditore di guadagnare tempo prezioso e di elaborare soluzioni condivise, sfruttando anche le leve normative (sospensione azioni, finanza prededucibile, transazione fiscale facilitata). Vista l’esperienza positiva accumulatasi (oltre 400 imprese salvate in 4 anni), sicuramente è da prendere in considerazione prima di arrendersi a soluzioni liquidatorie.
Il Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)
Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale di ristrutturazione, di origine giudiziaria, che consente all’imprenditore di proporre ai creditori un accordo concorsuale vincolante per tutti, sotto controllo del tribunale. Anche dopo la riforma, il concordato rimane centrale e adatto alle situazioni più complesse, in cui serve coinvolgere tutti i creditori e non si riesce ad ottenere consensi individuali sufficienti.
Due tipologie fondamentali: – Concordato in continuità aziendale: quando nel piano concordatario è prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa (in proprio o tramite cessione/affitto a terzi). L’obiettivo è salvaguardare il complesso aziendale come going concern, ristrutturando i debiti e magari apportando nuova finanza. Può essere diretto (l’azienda continua gestita dallo stesso debitore durante e dopo il concordato) oppure indiretto (il piano prevede che l’azienda sia ceduta o conferita a un altro soggetto che la prosegue, e il ricavato va ai creditori). – Concordato liquidatorio: quando invece il piano è essenzialmente di liquidazione del patrimonio, senza prosecuzione duratura dell’attività. L’azienda cessa o viene smembrata e venduta, distribuendo il ricavato ai creditori. In passato si richiedeva almeno il 20% ai chirografari, e tale vincolo permane nel CCII (20% minimo, salvo contributi esterni) .
Procedura in sintesi: 1. L’imprenditore in crisi presenta ricorso al tribunale con una proposta di concordato e un piano dettagliato. Può anche presentare un ricorso “in bianco” (con riserva)”, ossia chiedere il concordato riservandosi di presentare il piano entro un termine (max 120 giorni prorogabili a 180): questo serve a ottenere subito la protezione e poi perfezionare la proposta. 2. Il tribunale verifica i requisiti formali e la fattibilità iniziale, e ammette la società alla procedura, nominando un Commissario Giudiziale (figura terza di vigilanza) e fissando l’adunanza dei creditori per il voto. 3. Durante la procedura: l’azienda continua l’attività sotto la gestione dell’imprenditore (debtor in possession), ma con alcuni limiti (atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione del giudice, divieto di pagare debiti anteriori, ecc.). Tutti i creditori anteriori sono congelati: nessuna azione esecutiva individuale può proseguire o iniziare, nessuna ipoteca può essere iscritta su beni del debitore dopo il ricorso, e i contratti pendenti proseguono (salvo facoltà di scioglimento con autorizzazione). 4. I creditori vengono suddivisi in classi se opportuno (obbligatorio se trattamenti differenziati). Ad esempio, si può classare separatamente: banche ipotecarie, fornitori strategici, chirografari comuni, ecc. I crediti privilegiati che il piano non paga integralmente devono essere classati singolarmente per votare. 5. Votazione: nella riunione (o via urna telematica) i creditori votano sulla proposta. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (50% + 1). I privilegiati se integralmente soddisfatti non votano, altrimenti votano per la parte non soddisfatta. Ci sono regole per il caso di dissenso di classi: il tribunale può comunque omologare anche se alcune classi votano no, se ritiene che la proposta sia più vantaggiosa per quei dissenzienti rispetto alla liquidazione e che non li danneggi ingiustamente (c.d. cram-down giudiziale interclassi). 6. Omologazione: se i creditori approvano, il tribunale omologa il concordato con decreto, che lo rende efficace erga omnes. Se i creditori respingono, la procedura viene chiusa e normalmente si apre la liquidazione giudiziale (fallimento), salvo il caso di offerte concorrenti o altre eccezioni. 7. Esecuzione: una volta omologato, l’imprenditore deve eseguire il piano: pagare le percentuali offerte ai chirografari nei tempi previsti, liquidare eventuali beni da vendere, ecc., sotto la sorveglianza del Commissario (che diventa Liquidatore Giudiziale se è un concordato liquidatorio) e del giudice delegato.
Per un’azienda di pavimentazioni industriali, il concordato in continuità può significare ad esempio: presentare un piano in cui si prevede che l’attività prosegua, i contratti in corso vengano portati a termine, i dipendenti mantenuti, e i creditori ottengano soddisfazione nel tempo coi flussi generati dall’azienda, magari con l’apporto di nuova finanza dei soci o di un investitore. Ad esempio, offrire ai chirografari il 30% in 4 anni, mantenendo attiva l’impresa che produce utili per pagare. Spesso nei concordati in continuità c’è un elemento di “sacrificio” dei creditori, ma anche un vantaggio atteso: se li liquidasse subito, forse prenderebbero 5%; accettando il piano, l’azienda non muore e in qualche anno possono prendere 30%.
Nel concordato liquidatorio, invece, la prospettiva è solo vendere i beni (macchinari, immobili, magari cedere l’azienda come blocco) e distribuire il ricavato. Qui i creditori sanno che quello è quanto c’è da spartire. Lo preferiscono al fallimento perché tipicamente nel concordato l’imprenditore può proporre qualche risorsa aggiuntiva esterna (ad es. i soci mettono sul piatto un certo importo a fondo perduto per incrementare l’attivo a disposizione dei creditori e raggiungere il minimo 20% richiesto). In più, il concordato liquidatorio può essere più rapido e con minori costi rispetto a un fallimento, e il debitore evita le stigmatizzazioni penali di un fallimento (anche se, attenzione, se c’è stata distrazione di beni si incorre comunque in bancarotta fraudolenta anche nel concordato, non è uno scudo contro i reati commessi prima).
Vantaggi del concordato: – Universalità: risolve tutti i debiti in un colpo solo, li sostituisce con le obbligazioni derivanti dal piano omologato. Anche chi non è d’accordo si deve adeguare. È l’unico strumento (assieme alla liquidazione giudiziale) che consente di imporre perdite ai creditori senza il loro consenso individuale, grazie alla forza della maggioranza. – Stay delle azioni: blocca immediatamente il caos delle esecuzioni, dando respiro. – Gestione ordinata: c’è un Commissario e la vigilanza del giudice, quindi i creditori sono più fiduciosi che non vi saranno pasticci o preferenze occulte. – Prededucibilità: i nuovi fornitori durante il concordato sono prededucibili, quindi molti possono continuare a fornire l’azienda avendo garanzia di essere pagati prima degli altri. – Possibilità di scioglimento o sospensione di contratti onerosi con autorizzazione giudice (art. 94 CCII) per alleggerire la situazione (ad es. locazioni inutili). – Possibilità di finanziamenti prededucibili per sostenere l’attività (con autorizzazione del tribunale e attestazione di funzionalità). – Il debitore può proporre anche soluzioni particolari come il concordato con assunzione (un terzo si obbliga verso i creditori), ipotesi rara ma prevista.
Svantaggi del concordato: – Procedura complessa, lunga e costosa: tra spese legali, del commissario, contributo unificato. Richiede uno sforzo notevole di preparazione del piano e della documentazione. – Pubblicità negativa: l’apertura di concordato è pubblica e spesso clienti/fornitori perdono fiducia (anche se la riforma l’ha resa più comune e accettata, resta uno stigma). – Perdita di libertà gestionale: se il debitore deviasse dal lecito, il tribunale può revocare l’ammissione e farlo fallire subito. E comunque ogni atto fuori dall’ordinario va autorizzato. – Rigore per alcuni crediti: i dipendenti e l’Fisco per IVA e ritenute non possono essere falcidiati sul capitale (nel concordato liquidatorio l’IVA e ritenute vanno pagate integralmente, salvo transazione fiscale; nel concordato in continuità l’IVA può anche essere parzialmente non pagata purché soddisfatta come da transazione fiscale approvata dallo Stato, ma in generale i privilegiati vanno rispettati). Serve spesso la transazione fiscale per abbattere sanzioni e interessi su tributi. – Rischio di proposte concorrenti: nel CCII, i creditori qualificati o terzi possono presentare proposte alternative se il debitore chiede certi favori (come la moratoria dei privilegiati oltre 120 giorni o se non offre almeno il 30% ai chirografari in continuità). Questo può portare a “aste” sul destino dell’azienda, e l’imprenditore originale rischia di perderne la proprietà se arriva una proposta migliore (ad esempio un concorrente propone di soddisfare i creditori al 40% contro il 20% offerto dal debitore – i creditori potrebbero votare quella del terzo). – Se il concordato non passa (manca la maggioranza o l’omologa), quasi inevitabilmente scatta il fallimento. Quindi è un percorso senza rete.
In generale, l’imprenditore vi ricorre quando non vede alternative private praticabili. È il caso di uno scenario molto compromesso dove solo la protezione del tribunale e la falcidia generalizzata possono risolvere. Ad esempio, debiti enormi con troppi creditori da convincere uno a uno – in concordato basta convincere la maggioranza. Oppure situazioni con forte contenzioso, in cui serve l’autorità terza per imporre ordine.
Per la nostra impresa posatrice indebitata, un tipico concordato potrebbe essere: – In continuità: se ha ancora buon portafoglio ordini e competenze, presenta un piano dove i soci apportano qualche capitale fresco, ottiene dai fornitori di continuare a lavorare con pagamento alla pari dei nuovi ordini (prededuzione), e destina gli utili futuri per 5 anni a pagare i creditori nella misura proposta (es. 35%). Magari tiene i dipendenti, cede un capannone inutile per ricavare liquidità, e si impegna a pagare per intero i debiti fiscali in 4 anni grazie ai flussi di cassa. I creditori potrebbero preferire ciò al fallimento perché l’azienda ha prospettiva e il 35% è più del presumibile 5-10% in caso di liquidazione forzosa. Il tribunale vigilerebbe che l’esecuzione vada avanti e, se qualcosa va storto (es. non si rispettano le scadenze), dichiarerà il fallimento a posteriori. – Liquidatorio: se invece il mercato è saturo e non c’è speranza di recupero commerciale, l’azienda può decidere di smettere l’attività e proporre di vendere tutto in modo ordinato. Ad esempio, cedere i macchinari a un competitor e vendere l’immobile, incassare, e dare ai chirografari, poniamo, il 25%. Se aggiunge un 5% cash dei soci (per arrivare a 20-25%), soddisfa il requisito legale. Questo risparmia tempi lunghi rispetto a un fallimento e i creditori ottengono in pochi mesi il dividendo proposto.
Una considerazione sulle imprese minori: se la nostra ditta di pavimenti fosse individuale o comunque sotto le soglie di non fallibilità, non potrebbe accedere al concordato preventivo standard. In tal caso, userebbe il concordato minore del sovraindebitamento: meccanismo analogo ma semplificato e gestito dall’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con costi minori e procedure un po’ più snelle (niente commissario, c’è direttamente l’OCC). Ad esempio, l’imprenditore individuale Mario che ha debiti 400k (banche e fornitori) ma un fatturato di 150k annui, può presentare un concordato minore offrendo di pagare, che so, il 20% in 4 anni e mantenere attiva la ditta individuale, se i creditori (si sommano anche quelli personali) approvano. Le maggioranze di voto e il resto sono simili.
Transazione fiscale e contributiva: difendersi dai debiti verso Erario e INPS nelle procedure
Uno dei nodi più delicati nelle ristrutturazioni d’impresa riguarda i debiti fiscali e previdenziali: come abbiamo visto, spesso ammontano a cifre rilevanti e godono di privilegi o protezioni penali tali da renderli “rigidi”. Transazione fiscale è il termine comunemente usato per indicare un accordo con il Fisco (Agenzia delle Entrate/Agenzia Riscossione) e con gli enti previdenziali (INPS) all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, in cui tali enti acconsentono a un trattamento di favore diverso da quello ordinario.
Cosa consente la transazione fiscale (art. 63 CCII): – Di proporre il pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi, quindi uno stralcio sul capitale di imposta e contributi. Prima delle riforme, la legge non consentiva di falcidiare l’IVA e le ritenute (dovevano essere pagate integralmente anche nel concordato); oggi, invece, grazie all’evoluzione normativa e ad alcuni interventi (anche della Corte Costituzionale), è possibile includere qualsiasi tributo in transazione e proporre il suo pagamento in misura ridotta, purché se ne dimostri la convenienza rispetto alla liquidazione e l’Amministrazione vi aderisca (o sia forzosamente coinvolta col meccanismo di cram-down). – Di stralciare totalmente le sanzioni tributarie e gli interessi di mora: normalmente, in ogni transazione fiscale, si propone di pagare zero sanzioni e zero interessi di mora, perché la legge stessa incoraggia a abbatterli prima del capitale. – Di rateizzare il debito tributario ristrutturato su un periodo: tipicamente concordati e accordi prevedono pagamento dei debiti fiscali su alcuni anni (nei limiti possibili: in genere non oltre 5-6 anni dal piano). – Sul fronte contributivo (INPS), di tagliare le sanzioni civili (che possono essere molto alte) e parte degli interessi, e anche qui dilazionare l’importo dovuto.
Procedura: il debitore inserisce nella proposta di concordato (o nel testo dell’accordo di ristrutturazione) una specifica proposta di transazione per le somme dovute a tali enti. L’Agenzia delle Entrate ha delle linee guida interne e valuterà la proposta. Similmente l’INPS. Se entrambe accettano formalmente, l’accordo si perfeziona (raggiungendo anche il quorum se contano nel 60% dell’accordo). Se uno dei due rifiuta, in passato saltava il piano. Oggi, con la norma del 2023 citata, se la loro mancata adesione è determinante e la proposta è comunque conveniente, il giudice può procedere all’omologa forzosa .
Importante: perché il tribunale omologhi un concordato o accordo con transazione fiscale, è necessario che: – La proposta garantisca al Fisco/INPS non meno di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale (valutata con perizia). Cioè, se in caso di fallimento l’erario avrebbe preso 10 da realizzo beni, nel piano deve prendere almeno 10 (magari in valore attuale). – Se si falcidia l’IVA o ritenute, deve esserci un apporto di risorse esterne equivalente alla falcidia (requisito eliminato? In passato c’era un vincolo del genere dall’art. 182-ter; il CCII in verità non menziona più chiaramente questo obbligo, puntando tutto sulla convenienza comparativa). – Ci sia un voto favorevole dell’attestatore/commissario sulla fattibilità e congruità.
In concreto, un esempio: l’azienda ha €500k di debiti con Agenzia Entrate (di cui 300k IVA, 100k IRES, 50k interessi, 50k sanzioni) e €100k con INPS (di cui 70k contributi, 30k sanzioni). In transazione propone: pagamento di €250k in 5 anni a saldo di tutto (cioè circa il 50% del capitale tasse/contributi, zero sanzioni, zero interessi). Se fallendo l’Erario stimava di recuperare 100k, qui ne prenderebbe 250k, quindi l’offerta è conveniente e dovrebbe essere accolta. L’Erario accetterebbe di perdere il 50% nominale ma convinto che è meglio di alternative. All’omologa, quell’accordo vincola il Fisco.
Difendersi colla transazione fiscale: dal punto di vista del debitore, è uno strumento potentissimo perché: – Permette di ridurre drasticamente l’esposizione verso Fisco/INPS che spesso, con sanzioni e interessi, diventa fuori controllo. – Scongiura anche eventuali misure penali: se l’accordo include il pagamento rateale dell’IVA omessa, il reato di omesso versamento viene meno se si paga secondo la transazione (il 10-ter punisce l’omesso versamento entro la scadenza, ma se poi l’imposta è soddisfatta in concordato omologato, di fatto l’offesa viene riparata prima della sentenza). In pratica, con una transazione approvata e poi eseguita regolarmente, difficilmente l’Amministrazione finanziaria spingerà per la condanna penale, e comunque il giudice penale può tenerne conto ai fini di non punibilità per avvenuto pagamento. – Consente all’azienda di ripulirsi dei debiti fiscali e ripartire su basi sostenibili. Dopo l’omologa, i carichi iscritti a ruolo vengono spalmati come da piano e l’azienda può anche ottenere un DURC regolare (a certe condizioni) continuando l’attività.
In passato, l’Agenzia Entrate spesso era rigidissima e rifiutava transazioni che non fossero al 100% del capitale. Ma dopo la riforma e la giurisprudenza, l’orientamento è più flessibile, benché rimanga scrupoloso. È prassi che l’Erario accetti stralci del capitale solo se il debitore è davvero incapiente (es. in liquidazione), mentre nei concordati in continuità tende a chiedere almeno l’integrale pagamento del tributo (stralciando solo sanzioni e interessi). Comunque, la presenza della norma di cram-down li spinge a non essere irragionevoli: se rifiutano senza motivo, il giudice può procedere ugualmente.
Avvertenza: la transazione fiscale va usata con serietà. Se l’imprenditore poi non rispetta le scadenze post-omologa verso Fisco/INPS, scatta la risoluzione di diritto (inserita per legge come clausola nei piani) . Ciò significa che, se ad esempio non paga due rate, il concordato si risolve e i creditori riacquisiscono i diritti originari – ergo, per il Fisco decadono i benefici e potrà agire di nuovo per l’intero importo originale (detratto quanto pagato). Quindi fallire una transazione fiscale è devastante: l’azienda verrebbe quasi certamente poi dichiarata fallita su impulso dell’Erario, e senza più protezioni. Dunque, la proposta fatta deve essere sostenibile al 100%.
Transazione fiscale e composizione negoziata: come anticipato, il correttivo 2024 ha ammesso che anche durante la fase di composizione negoziata si possano negoziare i debiti tributari. Questo apre la porta a accordi stragiudiziali con il Fisco prima di arrivare a un concordato. Ad esempio, l’imprenditore può chiedere all’Agenzia: “d’accordo, mi dai una rateazione in 6 anni e cancelli sanzioni?” e se l’Agenzia (nel contesto protetto con l’esperto) accetta, si formalizza un accordo fiscale “in composizione” che poi, con l’aiuto dell’esperto, viene omologato come piano attestato con accordo ex art. 23 CCII. È una innovazione ancora fresca, ma potenzialmente utile a risolvere situazioni senza passare dal tribunale (a parte validare quell’accordo fiscale).
Liquidazione giudiziale (ex Fallimento) ed esdebitazione del debitore
Se nessuna misura di risanamento è praticabile o se si arriva troppo tardi, l’esito è la liquidazione giudiziale, cioè quella procedura in cui l’impresa viene spossessata e le sue attività vendute per soddisfare i creditori secondo le regole della par condicio. Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, la liquidazione giudiziale è qualcosa da evitare, perché: – Perde la gestione completamente (arriva il curatore). – L’azienda viene tipicamente fermata e i beni venduti all’asta, con dispersione del valore d’avviamento. – I soci di società di capitali perdono l’investimento (ma non subiscono di per sé ulteriori danni patrimoniali, salvo garanzie prestate o azioni di responsabilità se amministratori). – Gli amministratori rischiano di essere coinvolti in azioni di responsabilità e bancarotta, come visto. – Il debitore persona fisica, se è un imprenditore individuale, subisce l’espropriazione di tutti i beni (tranne quelli impignorabili di legge) e difficilmente potrà proseguire l’attività.
Detto ciò, a volte il fallimento è inevitabile (ad es. se il debito è insostenibile e i creditori non vogliono accordi, o se c’è un abuso e il tribunale rigetta il concordato). In tali casi, cosa può fare il debitore per difendersi? – Cooperare con il curatore: consegnare tutta la documentazione, aiutare a individuare i beni. Questo può evitare imputazioni penali e permettere di ottenere la esdebitazione a fine procedura. Infatti, il CCII prevede che il debitore persona fisica, esecutivo e meritevole, al termine della liquidazione giudiziale venga liberato dai debiti residui non soddisfatti (salvo eccezioni per debiti alimentari, risarcitori da dolo, etc.). Ad esempio, se una ditta individuale fallisce con 1 milione di debiti e il curatore realizza 100k dando un 10% di dividendo, il piccolo imprenditore, una volta chiuso il fallimento, può chiedere l’esdebitazione e cancellare il restante 90% di debiti . Questo è un diritto introdotto per dare una seconda chance. Tuttavia, viene negato se il fallito ha tenuto comportamenti fraudolenti o non ha cooperato. – Impugnare eventuali atti illegittimi: ad esempio, se viene dichiarato fallimento ingiustamente (magari la soglia di debiti era sotto 30k, come chiarito dalla Cassazione n. 2223/2025 che ha ricordato che va accertato il superamento della soglia al momento della decisione ), il debitore può reclamo in Corte d’Appello. – Proteggere il patrimonio personale lecito: se ad esempio i soci avevano beni personali dati in garanzia, cercare di negoziare con quei creditori per evitare escussioni (es. vendere privatamente l’immobile ipotecato e pagare il creditore, piuttosto che farselo espropriare all’asta, che di solito estingue meno debito e può lasciare strascichi).
In sostanza però, in liquidazione giudiziale le leve di difesa del debitore sono poche: la procedura serve i creditori. L’imprenditore può solo puntare ad uscire “pulito” alla fine, sfruttando l’esdebitazione se possibile. Se è una società di capitali, la società in sé verrà cancellata a fine procedura (i debiti eventualmente insoddisfatti si estinguono con essa), ma l’imprenditore in senso di persona fisica non aveva debiti personali salvo garanzie.
Liquidazione controllata (ex sovraindebitamento): per gli imprenditori non fallibili, c’è una procedura simile in tribunale, con nomina di un liquidatore nominato dall’OCC, che liquida i beni e poi anch’essa porta all’esdebitazione. Ad esempio, l’artigiano sottosoglia che non può fare concordato minore e che non ha prospettiva di risanamento, può chiedere la liquidazione controllata per chiudere la partita: consegna i beni all’OCC, vengono liquidati e poi chiedere la liberazione dai debiti residui.
Conclusione di sezione: La difesa migliore è giocare d’anticipo e usare gli strumenti di risanamento prima di arrivare al collasso. Se però il collasso avviene, restano misure difensive “tardive” come collaborare in fallimento per ridurre i danni (in primis personali).
Nei prossimi capitoli, metteremo in pratica questi concetti attraverso casi reali simulati e affronteremo le domande frequenti per sciogliere dubbi pratici specifici.
Casi pratici e simulazioni (scenario Italia)
In questa sezione illustriamo alcune simulazioni pratiche per chiarire l’applicazione degli strumenti discussi. I casi sono basati su situazioni tipiche di aziende (soprattutto PMI) nel settore edile/posa pavimenti che affrontano crisi finanziarie. Ogni caso evidenzia il punto di vista del debitore e le scelte compiute per difendersi.
Caso 1: Salvataggio in extremis con piano attestato e accordo agevolato
Scenario: Alfa S.r.l. è un’azienda di posa pavimenti industriali con sede in Lombardia. Ha 10 dipendenti e un fatturato annuo di circa €2 milioni, ma a causa del fallimento di un importante committente (che le ha lasciato insoluti per 500k) si trova con €800k di debiti: €200k con fornitori di materiali resinosi, €150k di debiti IVA e ritenute, €100k di contributi INPS, €250k con la banca (scoperto di conto e leasing macchinari), €100k con vari subappaltatori e artigiani. Il settore però è in ripresa e Alfa ha nuove commesse in vista, ma urgono investimenti per un nuovo macchinario di levigatura. Liquidità attuale quasi zero; alcuni fornitori hanno già minacciato decreti ingiuntivi. Alfa teme che un concordato preventivo danneggerebbe la sua reputazione verso i general contractor che le affidano lavori.
Azione intrapresa: L’amministratore di Alfa S.r.l., consapevole dei doveri di cui all’art. 2086 c.c., si attiva non appena realizza la gravità della situazione (perdita importante a bilancio e tensione di cassa). Entro fine anno convoca un advisor finanziario e un legale. In prima battuta, depositano istanza di Composizione Negoziata presso la Camera di Commercio: nel giro di un mese viene nominato un esperto. Nel frattempo, Alfa riesce a ottenere dal tribunale, su istanza con il rapporto iniziale dell’esperto, un decreto di misure protettive: per 3 mesi i creditori non possono iniziare/eseguire pignoramenti sui conti e sui macchinari . Ciò blocca sul nascere un’azione esecutiva di un fornitore (che stava per pignorare un muletto in cantiere) e dà respiro per lavorare alle soluzioni.
L’esperto convoca le parti: la banca (credito €250k ipotecario su capannone + fideiussione socio), i fornitori principali (due chimici per 150k combinati), un rappresentante dell’Agenzia Entrate (per IVA) e uno dell’INPS. Dopo analisi, emerge che Alfa S.r.l. può tornare redditizia: se ottiene un nuovo macchinario da €100k, può completare rapidamente due grossi cantieri e generare margine. Ma serve liberare cassa e alleggerire debiti. Tutti attorno al tavolo con l’esperto trovano una bozza di accordo: – I due fornitori chimici accettano un pagamento saldo e stralcio al 50% dei 150k in 12 mesi (75k totali) perché vedono possibili future forniture e preferiscono incassare metà che rischiare di più con un fallimento. – La banca, che ha ipoteca su un capannone (valore perizia €200k), è disposta a ridurre il suo credito del 20% e a rifinanziare il restante 200k su 7 anni, purché il socio garante rinunci alla liberazione della fideiussione per quell’importo stralciato (clausola di sopravvivenza: quindi il socio resta garante per il 20% tagliato, che se Alfa non paga nei 7 anni, potrà essergli chiesto – condizione che il socio alla fine accetta, confidando nella ripresa). – L’INPS accetta di abbuonare tutte le sanzioni civili (circa €20k su 100k) e di diluire i 80k restanti in 5 anni senza interessi, in linea con la normativa sulla transazione contributiva. – L’Agenzia Entrate, inizialmente riluttante, in sede di composizione negoziata non può formalmente concludere transazione (lo potrà solo con omologa), ma indica di essere disponibile, se formalizzata in un concordato o accordo, ad accettare il pagamento di tutto l’IVA (€100k) in 4 anni e la rinuncia alle sanzioni (€30k) e interessi (€20k) accumulati, purché Alfa porti evidenza che è il massimo ricavabile. L’esperto nella sua relazione evidenzia che in caso di fallimento il Fisco prenderebbe forse €50k, quindi la proposta di pagarne 100k è conveniente.
Raggiunto questo “accordo di massima”, l’esperto suggerisce di finalizzarlo tramite un Accordo di ristrutturazione agevolato. Infatti, i creditori chiave aderenti coprono: – Banca: €250k – Fornitori chimici: €150k – INPS: €100k – (Agenzia Entrate formalmente non aderisce su IVA finché non c’è omologa, ma la includeranno col cram-down fiscale in sede di omologa) – Altri piccoli fornitori/subappaltatori: Alfa conta di liquidarli con risorse nuove.
Il totale crediti è €800k; se Alfa ha il sì di banca+chimici+INPS, ha il 62,5% di adesioni (500k su 800k) – sufficiente per un accordo ordinario. Ma i creditori estranei (es. i subappaltatori 100k, qualche altro fornitore minore 50k, Equitalia per altre imposte 50k) come li gestisce? Ha ottenuto da un investitore locale (uno sviluppatore edile interessato a farla lavorare nelle sue commesse) la disponibilità a versare €150k in equity freschi nell’azienda. Con quei soldi, Alfa può pagare integralmente e subito i creditori estranei minori (circa 150-180k). Pertanto, l’accordo verrà presentato come “accordo agevolato 30%”, avendo risorse per liquidare gli estranei: – Adesioni richieste: almeno 30%. Alfa già ha circa 62%, quindi ben oltre. – Nessuna misura protettiva da qui in poi (non importa, l’ha già avuta in negoziazione; comunque con la firma di tutti i principali, nessuno agirà). – Impegno a pagare estranei subito all’omologa: userà i €150k dell’investitore per farlo.
Nei fatti, l’accordo depositato contiene: banca prende 200k su 7 anni (con ipoteca confermata), fornitori chimici 75k in 1 anno, INPS 80k su 5 anni, Fisco (Agenzia Entrate-Riscossione) 120k su 4 anni (100k imposte, 20k interessi ridotti). L’attestatore indipendente dichiara che il piano è sostenibile dati i nuovi contratti e l’investitore. Il tribunale concede l’omologa. L’AdE formalmente non aveva aderito, ma il tribunale applica l’art. 63 CCII come modificato dall’art. 1-bis D.L.69/2023: verifica che l’adesione dell’AdE era determinante per il 60% (non in questo caso, visto che c’era 62% anche senza AdE; però serve per falcidiare sanzioni e interessi), e che la proposta è conveniente. Omologa dunque l’accordo anche senza il voto dell’Erario , ritenendo soddisfatte le condizioni di legge (in più il decreto omologa include la clausola risolutiva su eventuale inadempimento verso Fisco/INPS ).
Esito: Alfa S.r.l. esce dalla procedura con un accordo omologato. Ha ridotto il debito complessivo da 800k a circa 500k (250 banca + 75 fornitori + 80 INPS + 100 AdE), da pagare gradualmente in anni. L’investitore è entrato in società portando i fondi per partire (e acquista il nuovo macchinario con ipoteca a garanzia di quell’investimento). I creditori estranei sono stati tutti pagati quindi Alfa riacquista reputazione commerciale (DURC regolare, fornitori di base tutti soddisfatti). La banca, pur tagliando 50k, conta di recuperare i 200k restanti in 7 anni e ha mantenuto la garanzia. Il Fisco incassa più del liquida (e se Alfa seguirà il piano, non attiverà sanzioni penali per l’IVA). I subappaltatori soddisfatti interamente continueranno a lavorare con Alfa fiduciosi.
Dal punto di vista difensivo, il successo è stato possibile perché l’imprenditore ha agito tempestivamente, sfruttando la composizione negoziata per trattare protetto e convincendo un investitore a credere nel rilancio (cosa facilitata proprio dal contesto di negoziazione strutturata e trasparente con l’esperto). Inoltre ha calibrato bene lo strumento legale: inizialmente puntava a un piano attestato, ma data la presenza di uno zoccolo duro di creditori, ha optato per un accordo di ristrutturazione. Avendo liquidità per estranei, ne ha fatto un accordo agevolato a basso quorum, riducendo l’iter (niente classi né 60% necessario di integrale). E ha beneficiato del cram-down fiscale introdotto nel 2023 per superare eventuali resistenze del Fisco. In definitiva, Alfa S.r.l. continua l’attività, i posti di lavoro sono salvi e l’azienda in pochi anni dovrebbe tornare sana.
Caso 2: Concordato preventivo in continuità “misto” con transazione fiscale
Scenario: Beta Pavimenti S.p.A. è una società più grande (50 dipendenti, vari cantieri in tutta Italia). Ha un indebitamento di circa €5 milioni: pesano in particolare €2M di debiti bancari (mutui su capannone e macchinari), €1M debiti verso fornitori, €0,5M debiti fiscali (IVA non pagata negli ultimi due anni) e €0,5M verso INPS (contributi di 1 anno non versati), oltre a €1M altre esposizioni (leasing, debiti vari). La crisi è dovuta a un contenzioso legale: Beta ha perso una causa con una stazione appaltante pubblica e deve restituire €1,5M incassati, inoltre quell’appalto si è interrotto causando perdite. Beta ha ancora commesse private importanti però, e un know-how notevole. Tuttavia, nessuna banca vuole darle nuova finanza finché pende la restituzione all’ente pubblico (che minaccia pignoramenti). I fornitori, vista la mala parata, hanno ridotto le forniture in attesa di pagamenti.
Azione intrapresa: Il CdA di Beta opta per un Concordato preventivo in continuità per congelare il maxi debito verso l’ente pubblico e gli altri, e ristrutturare l’azienda sotto ombrello del tribunale. Presenta dunque un ricorso “con riserva” (in bianco) al Tribunale di competente, ottenendo immediatamente lo stay delle azioni. L’ente pubblico quindi non può pignorare i conti (bloccando la restituzione coattiva). Beta poi deposita il piano concordatario: prevede che l’attività prosegua, concentrandosi però sul settore privato (lasceranno perdere gli appalti pubblici). L’azienda si impegna a vendere un immobile non strategico (valore €800k) e a far entrare un nuovo socio con €500k di equity fresco. Grazie a queste risorse e ai flussi futuri (stima €300k annui per 5 anni), Beta propone: – Pagare integralmente le banche garantite (i €2M, dilazionati grazie anche a rifinanziamento – le banche accettano la continuità e il pagamento integrale, magari con lieve allungamento). – Pagare integralmente i crediti privilegiati dei dipendenti (TFR e stipendi arretrati di 2 mesi) e al 100% anche i creditori privilegiati “generali” come l’INPS e una parte di fisco (lo prevede la legge a meno che transino). – Per i debiti fiscali (IVA), offre tramite transazione fiscale di pagarne il 60% in 4 anni, e stralciare il 40% e tutte le sanzioni. – Ai creditori chirografari (fornitori, l’ente pubblico che dopo restituzione del dovuto sarà chirografo per eventuali danni) offre il 30% in 5 anni, con due anni di pre-ammortamento (niente i primi due anni e poi rate dal terzo al quinto). – Subordina però questa proposta all’apporto del nuovo socio e alla vendita dell’immobile entro 1 anno.
Nel concordato Beta classa i creditori in 4 classi: banche ipotecarie (classe A, 100% in 6 anni), Erario+INPS (classe B, transazione fiscale 60% erario e 100% INPS su contributi), fornitori e chirografi vari (classe C, 30%), ente pubblico (classe D, considerato chirografo particolare 30% come altri, ma li separano per trasparenza di voto). I dipendenti privilegiati sono fuori dalle classi, pagati 100% in prededuzione (perché Beta li paga con la cassa corrente assistita da autorizzazione commissariale, visto che servono per continuare le attività – questo avviene spesso: i debiti per stipendi possono essere soddisfatti in anticipo durante la procedura con ok del giudice).
Il commissario giudiziale nominato valuta il piano: attesta che i flussi attesi sono realistici e che in liquidazione forzata i chirografari non prenderebbero nulla (perché i beni, salvo l’immobile, coprono a malapena i privilegiati). Quindi il 30% proposto è di gran lunga migliore. Anche la transazione fiscale appare equa: l’Erario con 60% recupera €300k su €500k, mentre in fallimento stimato avrebbe preso forse €50k (perché l’IVA è privilegiata ma l’attivo in quel caso sarebbe inferiore e divorato da costi).
Votazione: Al voto, le banche (classe A) approvano (felici di avere garanzia di rientro totale, anche se attendono un po’ di più). La classe B (Erario+INPS) vota favorevolmente perché Agenzia Entrate ha formalmente aderito alla transazione (convinta dalla convenienza) e l’INPS riceve tutto, quindi ok. I fornitori (classe C) votano sì per l’80% del credito (molti pensano che 30% in 5 anni è meglio di 0 in fallimento). L’ente pubblico (classe D) inaspettatamente vota no (per ragioni politiche, l’assessore non vuole “tagliare” nulla e preferirebbe il fallimento per punirli, benché economicamente svantaggioso). Ad ogni modo, avendo tre classi su quattro favorevoli e raggiungendo comunque oltre il 50% di consensi sul totale crediti (grazie alle altre classi), la mancanza della classe D non blocca. Beta chiede al tribunale l’omologazione nonostante il no dell’ente pubblico, invocando il cram-down interclasse: dimostra che anche la classe D (ente pubblico) col concordato prende 30%, mentre in liquidazione – dati i privilegi altrui – non avrebbe preso nulla (essendo un credito chirografo subordinato alla massa, col fallimento sarebbe stata quasi interamente insoddisfatta). Dunque la sua posizione non è pregiudicata dal concordato anzi migliorata. Il tribunale concorda e omologa il concordato , estendendo l’efficacia anche alla classe dissenziente.
Esito: Beta Pavimenti S.p.A. esce dal concordato, prosegue l’attività. L’immobile viene venduto come previsto entro 6 mesi, incassando €800k con cui soddisfa in parte i creditori. Il nuovo socio investe €500k per il 30% delle azioni, portando liquidità. Con questi fondi Beta inizia a pagare il primo 10% ai chirografari dal terzo anno (per ora mantenendo cassa per lavorare), e poi via via completa il 30% entro il quinto anno. Tutti i pagamenti verso banche, INPS e Fisco vengono eseguiti puntualmente secondo i piani. Il commissario (ora attestatore) sorveglia annualmente e riferisce al giudice delegato l’andamento. Dopo 5 anni, Beta ha onorato integralmente il concordato: esce effettivamente risanata, con meno debiti, un socio nuovo e attivo, e con la credibilità recuperata (ormai il concordato è “alle spalle” e fornitori e clienti hanno continuato a lavorare con lei, confortati dal fatto che l’azienda stava pagando regolarmente i creditori concorsuali). L’ente pubblico, che aveva votato no, non può più pretendere nulla oltre il 30% ricevuto – ha dovuto accettare la decisione giudiziale.
Da notare che i vecchi amministratori di Beta, avendo ben gestito la procedura, non subiscono azioni di responsabilità (i creditori li hanno di fatto discolpati approvando il piano e rinunciando a cause ulteriori) e nessun reato viene loro contestato (non avendo commesso distrazioni, e l’omologazione del concordato fa venir meno gli effetti penalmente rilevanti dei pagamenti preferenziali perché tutto è stato autorizzato e pianificato). Sono comunque stati sostituiti al timone dal nuovo socio, ma Beta rimane un player sul mercato.
Caso 3: Liquidazione giudiziale evitata all’ultimo e gestione del post-fallimento
Scenario: Gamma Snc, ditta familiare (due fratelli soci) di posa pavimenti, ha purtroppo accumulato troppi debiti e non è riuscita né a risanarsi né a trovare accordi. Ha soli 5 dipendenti, ma debiti per €300k tra Equitalia, banca e fornitori. Nel 2024 i creditori presentano istanza di fallimento. I soci, erroneamente, non si erano attivati prima (non avevano assetti adeguati, e hanno sperato in un grosso pagamento che non è arrivato). Arriva l’udienza pre-fallimentare. A quel punto un professionista suggerisce un ultimo colpo di coda: data la soglia modesta di debito (€300k), potrebbero tentare un concordato minore “liquidatorio”, offrendo di vendere macchinari e autocarri e far prendere ai creditori il 20%. I soci presentano in extremis la proposta di concordato minore al giudice (nel contempo, poiché Gamma non è fallibile ex art. 2 CCII? – ipotizziamo lo sia perché magari superava anche di poco le soglie, altrimenti sarebbe liquidazione controllata, ma l’approccio è simile). Purtroppo, i creditori non si fidano più e non raggiungono il quorum di voti, e il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale (fallimento) di Gamma Snc.
Sviluppo: Viene nominato un curatore. I fratelli soci si trovano spossessati dei beni aziendali. I dipendenti vengono licenziati, ma percepiranno il TFR e alcuni stipendi dal Fondo di Garanzia INPS. Il curatore vende rapidamente gli automezzi e attrezzature (incassando €50k) e conclude delle transazioni per incassare crediti verso clienti (€30k). Totale attivo €80k. I creditori insinuati sono €320k (compresi interessi e spese). Alla fine ogni creditore riceverà circa il 25%. Paradossalmente, i creditori ottengono più del 20% offerto dai soci in concordato (grazie a qualche recupero fortunato in più). Ma la differenza è che i soci hanno perso l’azienda e i beni (e l’avviamento è andato distrutto, i clienti hanno cercato altri fornitori), mentre nel concordato avrebbero potuto magari cedere i beni ugualmente ma evitare il disastro reputazionale.
Difesa dei soci-debitori post-fallimento: I fratelli a questo punto puntano a salvare il salvabile personalmente: – Niente atti distrattivi: consegnano al curatore libri contabili in ordine e collaboarono. Non avevano commesso reati di bancarotta, a parte aver pagato un paio di piccoli fornitori preferenzialmente nel mese prima del fallimento (circa €5k), che il curatore infatti revoca con un’azione revocatoria. I fratelli, consigliati, scelgono di non opporsi alla revocatoria e fanno restituire ai creditori 5k per evitare grane. – Esdebitazione: dopo la chiusura della liquidazione (dura 1 anno e mezzo), i soci in quanto ex imprenditori sovraindebitati chiedono al tribunale l’esdebitazione. Dimostrano di aver cooperato (hanno anche trovato acquirenti per qualche bene per aiutare il curatore a massimizzare l’attivo) e di non aver frodato nessuno. Nessun creditore si oppone. Il Tribunale concede ai due l’esdebitazione, cancellando i debiti residui . Ciò significa che, pur avendo soddisfatto i creditori solo al 25%, i fratelli non sono più debitori per il restante 75%. Ottengono una “pulizia” del proprio passato. – Nuovo inizio: uno dei due fratelli, approfittando che in fallimento non c’è stata prosecuzione d’azienda, apre dopo qualche mese una nuova ditta individuale di posa pavimenti, ricominciando da zero (legalmente può, essendo esdebitato e non avendo subito condanne per bancarotta). Certo, gli risulta difficile all’inizio ottenere fidi o fiducia, ma col tempo e con i contatti personali recupera qualche cliente. Il cognome ormai è macchiato nel settore, ma lui prova a riabilitarsi offrendo qualità e garantendo pagamenti anticipati ai fornitori (perché nessuno gli fa più credito per ora). Pian piano risale, con prudenza.
Considerazioni: In questo caso Gamma non è riuscita a difendersi prima (ha atteso troppo). Tuttavia, i soci hanno saputo almeno limitare il danno dopo: evitando guai penali e ottenendo l’esdebitazione. La loro difesa ex post è consistita nel collaborare, agevolare la chiusura rapida della procedura (che riduce costi) e usare lo strumento della liberazione dai debiti residui per avere una seconda opportunità. In caso contrario, avrebbero potuto restare inseguiti per anni dai creditori insoddisfatti (specie essendo SNC, i soci rispondevano illimitatamente). L’esdebitazione li protegge anche per eventuali debiti personali con banche su cui avevano garantito. Dunque, sebbene abbiano perso l’azienda, almeno come persone fisiche possono ripartire senza un macigno di debiti insaldabili sul collo.
Questo scenario insegna che, pur se si arriva al fallimento, non tutto è perduto per il debitore onesto: le norme attuali premiano chi collabora con la liberazione finale dai debiti . Resta comunque il rammarico: se Gamma avesse attivato per tempo una composizione negoziata o un concordato minore con una proposta leggermente migliore (magari un apporto di qualche decina di migliaia dai fratelli o da un parente per portare l’offerta al 30-35%), forse i creditori avrebbero accettato e l’azienda sarebbe sopravvissuta.
I casi sopra evidenziano diverse situazioni e soluzioni, ma il filo conduttore è: agire tempestivamente, scegliere lo strumento adeguato e rispettare le regole di trasparenza e correttezza paga. L’imprenditore debitore che si muove presto può evitare il peggio e magari salvare la propria azienda; quello che arriva tardi può comunque evitare conseguenze personali irreversibili usando gli istituti di legge a sua tutela (concordati minori, esdebitazioni, ecc.), purché abbia agito senza malafede.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo a una serie di domande frequenti che imprenditori, professionisti e privati si pongono quando affrontano una situazione di crisi debitoria di un’azienda di posa pavimenti (ma anche, in generale, di PMI italiane). Le risposte sintetizzano quanto esposto, con taglio pratico e riferimenti normativi.
D1: La mia azienda ha troppi debiti e non riesco a pagarli tutti. Posso evitare il fallimento in qualche modo?
R: Sì. L’ordinamento italiano offre vari strumenti per evitare la liquidazione giudiziale (fallimento) se c’è anche una minima prospettiva di risanamento o un accordo con i creditori. Puoi tentare soluzioni stragiudiziali come un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione, coinvolgendo i creditori in un’intesa volontaria . Oppure puoi accedere a procedure concorsuali come il concordato preventivo, in cui proponi formalmente un piano di pagamento (anche parziale) ai creditori sotto il controllo del tribunale . Anche la composizione negoziata della crisi è un ottimo primo passo: ti dà tempo e assistenza di un esperto per negoziare e blocca temporaneamente le azioni esecutive . Se i creditori accettano un accordo o approvano un concordato, il fallimento viene scongiurato. L’importante è agire prima che i creditori perdano fiducia e presentino istanza di fallimento. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, l’azienda perde la gestione. Tuttavia, persino in extremis, durante un’udienza pre-fallimentare, puoi depositare una domanda di concordato e congelare la decisione per tentare un’ultima soluzione concordata (art. 44 CCII). In breve: il fallimento è evitabile se proponi ai creditori (o realizzi con loro) una soluzione soddisfacente e conforme alla legge, e se c’è un business ancora recuperabile. Esempi riusciti non mancano, come confermato dal numero crescente di concordati e accordi che hanno salvato imprese dal 2022 in poi .
D2: Qual è la differenza tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione?
R: Entrambi mirano a regolare i debiti evitando il fallimento, ma differiscono per grado di coinvolgimento del tribunale e modalità di adesione. Un concordato preventivo è una procedura concorsuale vera e propria: coinvolge tutti i creditori, è gestito sotto il controllo del tribunale con un commissario giudiziale, prevede il voto dei creditori secondo maggioranze legali e si conclude con un decreto di omologazione vincolante erga omnes . Il concordato consente anche di imporre sacrifici ai creditori privilegiati (rispettando certe soglie o tramite transazione fiscale) e di creare classi di creditori con trattamenti differenziati. Un accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, è più vicino a un accordo contrattuale: il debitore deve ottenere il consenso di una parte significativa dei creditori (di regola almeno il 60% in valore) , e poi chiede al tribunale di omologare quell’accordo. Non c’è voto di tutti i creditori: solo i consenzienti firmano, mentre i “estranei” devono comunque essere pagati per intero (salvo se li includi in classi con efficacia estesa o se benefici del cram-down fiscale) . Il tribunale nel caso dell’accordo interviene molto meno: verifica legalità e convenienza per estranei, ma non nomina commissari (salvo eccezioni) né gestisce votazioni. In pratica: concordato = procedura collettiva con maggioranze, accordo = negoziazione privata con minor intervento giudiziale. Un altro punto: nel concordato automaticamente ottieni tutela (stay delle azioni) dal momento del deposito , mentre nell’accordo di ristrutturazione puoi chiedere misure protettive, ma se esageri (tipo chiedi il blocco e poi non concludi l’accordo) rischi di dover passare a un concordato. Per scegliere: se pensi di poter convincere solo una fetta di creditori e pagare gli altri integralmente, l’accordo è preferibile (meno costoso e più rapido); se invece devi coinvolgere necessariamente tutti e imporre tagli a molti, il concordato è lo strumento appropriato. In alcuni casi si parte con un accordo, ma se non raggiungi il 60% di adesioni, puoi convertire la procedura in un concordato preventivo (così i creditori minoritari saranno comunque coinvolti).
D3: Ho debiti IVA e INPS molto alti. È vero che non si possono tagliare e vanno sempre pagati al 100%?
R: Non è più vero in senso assoluto. Fino a qualche anno fa, l’IVA e le ritenute fiscali dovevano essere integralmente pagate nel concordato (era un divieto di falcidia sul capitale). Con l’evoluzione normativa, ora si può proporre il pagamento parziale anche di IVA e ritenute, tramite lo strumento della transazione fiscale . La legge (art. 63 CCII) consente espressamente di includere qualsiasi tributo nell’accordo coi creditori, quindi puoi offrire ad esempio di pagare solo una parte dell’IVA dovuta e far rinunciare lo Stato al resto. Ovviamente devi motivare perché quello è il massimo realizzabile: in genere devi offrire almeno quanto lo Stato incasserebbe se la tua azienda fosse liquidata (altrimenti l’Agenzia Entrate non accetterà). Ma se l’azienda è in crisi nera, spesso quel “quanto incasserebbe” è molto basso, e dunque anche pagare, poniamo, il 30-40% dell’IVA in concordato può essere migliorativo per il Fisco e quindi ammissibile . Le sanzioni tributarie e gli interessi di mora, poi, quasi sempre sono interamente stralciati nelle proposte (per legge, la transazione fiscale permette di abbatterli al 100%). Anche i debiti contributivi INPS possono essere ristrutturati: qui la prassi è pagare tutti i contributi principali (magari dilazionati) e chiedere lo stralcio delle sanzioni civili e degli interessi di ritardato pagamento. La legge ormai equipara contributi e tributi per il trattamento concorsuale. Quindi, no, non è vero che vanno sempre pagati integralmente, a patto di seguire la procedura corretta di transazione fiscale/contributiva e di ottenere l’ok del giudice se l’ente dissente ma l’offerta è comunque conveniente . Attenzione però: se scegli la via liquidatoria pura (fallimento), lì invece IVA e contributi hanno privilegio e tendono ad essere pagati per primi sul ricavato, ma di solito non si soddisfano per intero lo stesso perché l’attivo non basta. In un concordato ben congegnato, potresti offrire al Fisco più di quanto otterrebbe liquidandoti e convincerlo. Ricorda infine l’aspetto penale: se stralci parte dell’IVA in concordato omologato, non sei punibile per quella parte non versata perché la Cassazione riconosce che il debito è estinto come da provvedimento giudiziario (di fatto, il reato di omesso versamento può venir meno per intervenuta causa di non punibilità se paghi almeno il 10% e l’omologa è successiva a una certa data per fatti antecedenti – disposizioni transitorie – ma entra in tecnicismi: ad ogni modo, concordato e transazione fiscale aiutano anche a definire la posizione penale, perché dimostri la volontà di soddisfare il Fisco al meglio delle possibilità).
D4: Quali debiti devo assolutamente pagare per primi se la mia azienda è in difficoltà?
R: In linea di massima, in situazione di pre-crisi tutti i creditori vanno trattati equamente per evitare contestazioni di atti preferenziali. Però, pragmaticamente, ci sono certe categorie che è opportuno tenere correnti: – Dipendenti: paga stipendi e contributi correnti. Non solo è un obbligo morale e legale, ma i dipendenti hanno tutele e privilegi che li fanno comunque soddisfare davanti ad altri. Inoltre, un arretrato eccessivo con loro può portare a scioperi, dimissioni o denunce penali (es. omesso versamento ritenute >€10k annue è reato) . Se stai per depositare un concordato, cerca di essere in regola con gli stipendi degli ultimi mesi e contributi, perché tanto dovrai poi comunque pagarli in prededuzione. – Fornitori essenziali: se alcuni fornitori sono critici per proseguire l’attività (es. quello che ti fornisce resina o cemento industriale necessario per i cantieri in corso), cerca di trovare un accordo con loro e di non accumulare troppo ritardo. Magari pagali parzialmente ma costantemente. Nel concordato preventivo potresti anche chiedere di classificarli come “fornitori strategici” da pagare prima o interamente per assicurare la continuità (con autorizzazione del tribunale), ma devi motivarlo. In composizione negoziata, puoi pagarli regolarmente se l’esperto concorda che servono per la continuità aziendale, altrimenti rischi che interrompano forniture e peggiorino la crisi. – Erario e INPS correnti: per IVA e contributi, se vedi che non riesci a pagarli regolarmente, attivati subito (chiedi rateazioni formali). Non pagarli affatto e destinare risorse altrove può generare sanzioni e problemi penali. Meglio versare almeno gli F24 contributi, e se proprio devi scegliere, evitare il debito IVA sopra soglia. In concordato potrai comunque includere l’arretrato in transazione, ma ogni trimestre di IVA omessa che aggiungi aumenta rischio penale e debito difficile poi da compensare. – Banche con garanzie: se un finanziamento è garantito da pegno/ipoteca importante (es. ipoteca su immobile aziendale), valuta se pagare le rate per evitare decadenza dal beneficio del termine. Se smetti, la banca può attivare la procedura e magari portarti via il bene prima che tu organizzi il piano. A volte però in crisi è inevitabile sospendere pagamento mutui per cassa: in tal caso, appena entri in una procedura concorsuale, potrai sospendere legalmente i pagamenti ai chirografari e anche ai privilegiati (questi ultimi, però, matureranno interessi di mora che vanno considerati). In composizione negoziata puoi chiedere al giudice la sospensione delle rate di mutuo fino a 90 giorni rinnovabili . – Debiti personali di garanti: se hai garantito personalmente dei debiti sociali (fideiussioni in banca, leasing, ecc.), sappi che se la società non paga, aggrediranno te. Dunque devi difenderti anche sul fronte personale: se la società entra in concordato, i creditori potranno comunque escutere la garanzia sui soci (salvo diversa pattuizione) . Quindi, in parallelo alla strategia aziendale, potresti dover considerare procedure di sovraindebitamento personali (ad es. un piano del consumatore se i tuoi debiti personali non sono da attività d’impresa, oppure un concordato minore personale se rientri) per gestire eventuali escussioni. Non è “chi devo pagare per primo”, ma è “non dimenticare che il problema può estendersi al tuo patrimonio”. – Ricorda che se fai pagamenti preferenziali in periodo di insolvenza conclamata, il curatore potrà chiederne la revoca (entro 6 mesi se ordinari, 1 anno se con parti correlate, 2 anni se dolosi). Tuttavia, pagare debiti per evitare danni irreparabili (tipo versare contributi per evitare sanzioni penali, o pagare fornitore essenziale per non fermare produzione) è spesso giustificabile come atto di ordinaria amministrazione. La Cassazione comunque punisce l’amministratore che fa uscite a favore di interessi extra-sociali e pregiudica i creditori . Quindi mai pagare prima debiti verso società amiche o parti correlate se sei in crisi, altrimenti rischi responsabilità per danno ai creditori.
D5: Se presento un concordato o accordo, potrò continuare a gestire la mia azienda? O rischio di perdere il controllo?
R: Dipende dallo strumento scelto: – Nel concordato preventivo, in linea generale rimani alla guida dell’azienda (sei debtor in possession), ma sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale. Quindi continui a compiere gli atti di ordinaria amministrazione e a portare avanti l’attività. Per gli atti straordinari (ad esempio, vendere un macchinario, stipulare nuovi finanziamenti, affittare l’azienda) dovrai chiedere autorizzazione al tribunale . Finché rispetti le regole, non perdi il controllo. Solo se poi il concordato fallisce (manca omologa o vieni dichiarato insolvente) allora potresti perdere l’azienda con l’apertura del fallimento. Nel concordato in continuità, l’idea è proprio far continuare l’imprenditore a gestire perché conosce il business meglio di un estraneo, salvo affiancamento del commissario. – Negli accordi di ristrutturazione e nel piano attestato, mantieni al 100% la gestione perché non c’è organo concorsuale. L’azienda è “in bonis”, semplicemente tu e i creditori avete un patto. Quindi nessuna perdita di controllo. Solo, se non rispetti l’accordo e questo salta, i creditori potranno poi agire liberamente (incluso chiedere fallimento). – Nella composizione negoziata, anche qui resti alla guida. L’esperto nominato non ha poteri sostitutivi, è un mediatore e supervisore. Può darti consigli e fare pressing morale, ma non può firmare contratti al posto tuo. Tu decidi se accettare le proposte dei creditori o farne. Certo, se compi atti gravemente pregiudizievoli, l’esperto si può dimettere e le misure protettive decadono, ma formalmente il controllo è tuo. Anzi, uno scopo della composizione negoziata è evitare di arrivare ad amministrazioni straordinarie esterne. – L’unico caso in cui perdi subito la gestione è se entri in liquidazione giudiziale (fallimento): lì l’amministratore viene spossessato e il curatore prende in mano l’azienda (se la esercita provvisoriamente, ma in settori come il tuo difficilmente succede a lungo) . Oppure in un’eventuale amministrazione straordinaria (per grandi imprese insolventi, legge Prodi/Marzano) dove arrivano commissari nominati dal governo. Ma per una PMI non è applicabile quest’ultimo. – Esiste un caso particolare chiamato concordato con continuità indiretta: se il tuo piano prevede che la tua azienda venga ceduta a un investitore sin dall’inizio (quindi la continuità c’è ma in mano al terzo), potresti “perdere” l’azienda perché appunto la vendi come parte del concordato. Però è una tua scelta strategica (magari vendi l’attività e con il ricavato paghi i creditori in concordato – tu perdi la proprietà ma eviti guai peggiori e forse monetizzi qualcosa se l’investitore paga). – Attenzione anche alle offerte concorrenti: nel concordato, se tu proponi la continuità e un terzo è interessato alla tua azienda, la legge consente ai creditori o a terzi di presentare proposte concorrenti in certi casi (es. tu chiedi di dilazionare troppo i privilegiati). Se arrivano, i creditori potrebbero preferire la proposta di quel terzo (magari che implica cedere l’azienda a lui e pagare di più i creditori). In tal caso perderesti il controllo, perché il tribunale omologherebbe il concordato proposto dal terzo e quello diventerebbe il nuovo proprietario/gestore. Questa è una norma inserita per evitare proposte “al ribasso” dei debitori quando c’è chi può offrire di meglio . Ma nella pratica delle PMI è raro: succede più che altro in aziende medio-grandi con appetibilità sul mercato. Comunque, è bene saperlo: se la tua offerta è troppo penalizzante per i creditori, rischi che qualcuno faccia una contro-offerta e ti scalzi. – In sintesi: se collabori e rispetti le regole, resti al comando nel risanamento. Le procedure moderne privilegiano la continuità aziendale sotto l’imprenditore originario (chi conosce il mestiere), salvo che egli sia inaffidabile. Quindi l’interesse è tuo a non diventare inaffidabile: niente distrazioni, niente favoritismi illegali, rispetto degli impegni del piano. La Cassazione 2025 ricordava appunto che l’amministratore deve agire con diligenza e senza conflitti d’interesse : se lo fai, nessuno ti toglierà l’azienda durante una procedura concorsuale di risanamento.
D6: Che succede se un creditore (banca o fornitore) non aderisce né all’accordo né al concordato? Può tirarsi fuori e agire da solo?
R: Nel caso del concordato preventivo, se viene omologato dal tribunale, vincola tutti i creditori anteriori ex lege, anche quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato . Quindi un creditore dissenziente non può sottrarsi: non può iniziare azioni esecutive né pretendere pagamenti diversi da quelli previsti nel piano omologato. Ad esempio, se la banca X non vota il concordato ma esso viene approvato e omologato, X dovrà accontentarsi del trattamento che il piano le riserva (dilazione, percentuale ecc.) e non può più agire per conto proprio. Di fatto, col concordato la singola voce fuori dal coro viene zittita dalla maggioranza: è la forza del concorso. L’unica via di “uscita” per un creditore dissenziente nel concordato è presentare opposizione all’omologazione se ritiene che la sua posizione sia trattata in modo non equo o che il piano violi la legge. Il giudice valuterà, ma se respinge l’opposizione e omologa comunque (es. col cram down di classe), il creditore è definitivamente dentro e legato a ciò che prevede la sentenza di omologa . Non potrà più agire individualmente per il pregresso.
Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, un creditore che non aderisce formalmente all’accordo è detto estraneo. Per legge, gli estranei devono essere pagati integralmente (salvo accordi diversi) altrimenti l’omologazione non può avvenire . Quindi se tu hai un accordo con 70% di creditori e uno non firma, devi comunque prevedere di pagarlo al 100% fuori accordo (di solito entro l’omologa). Se riesci a farlo (magari con finanza terza), bene; se non riesci, quell’estraneo può opporsi in omologa e il giudice non omologherà se quell’estraneo è pregiudicato (a meno che sia l’Erario o INPS e applichi il cram-down, ma parliamo di creditori normali). Dunque in un accordo, se c’è un importante fornitore che rifiuta, o lo paghi fuori o converti l’accordo in concordato per trascinarlo dentro coattivamente. Fa eccezione l’accordo ad efficacia estesa: lì, se il creditore è di una certa categoria e tu hai il 75% di quella categoria consenziente, il giudice può estendere l’accordo anche a quel dissenziente . Questo tipicamente vale per banche: se hai 4 banche e 3 su 4 (80%) aderiscono, la 4a sarà obbligata a rispettare il piano approvato in classe. Quindi in quell’ambito specifico, sì, puoi “tirare dentro” un creditore finanziario dissenziente. Ma per i fornitori commerciali o altri chirografari comuni non c’è tale meccanismo nel CCII (era previsto solo per finanziari originariamente). Quindi un fornitore estraneo può in teoria, dopo l’omologazione dell’accordo (dove lui viene dichiarato estraneo perché pagato a parte), agire se non lo paghi come promesso. In pratica però, negli accordi si fa in modo di sistemare gli estranei contestualmente (pagandoli cash con risorse terze). Nota: se l’accordo è agevolato 30%, per definizione tutti gli estranei vengono soddisfatti integralmente prima/durante l’omologazione , quindi non c’è un estraneo scontento – ciò è condizione per usare quell’agevolazione. In conclusione, in un accordo un creditore può “sfilarsi” non firmando, ma deve essere pagato fuori (nessun haircut coatto). In un concordato, un creditore non può sfilarsi: se la maggioranza approva e giudice omologa, lui è vincolato. Quindi chi proprio non vuole subire decurtazioni di solito vota contro il concordato sperando nel fallimento; ma se la maggioranza la pensa diversamente, lui subisce comunque il concordato.
D7: La presentazione di una procedura di crisi blocca i pignoramenti in corso?
R: Sì, nella maggior parte dei casi c’è una sospensione delle azioni esecutive individuali. Nello specifico: – Concordato preventivo: dal momento in cui presenti il ricorso per concordato (anche con riserva), per legge i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni individuali (art. 54 CCII), né acquisire privilegi se non concordati. Se un creditore ha già pignorato un tuo macchinario, la procedura esecutiva rimane sospesa e poi, su omologa del concordato, si estingue. Non possono nemmeno iniziare nuovi pignoramenti . Quindi è uno scudo totale temporaneo. – Accordo di ristrutturazione: non è automatico, ma puoi chiedere al tribunale di emettere un decreto di misure protettive mentre stai raccogliendo consensi e poi aspettando l’omologa (art. 54 CCII applicato via art. 60). Il tribunale di solito concede uno stop delle azioni esecutive e cautelari per un periodo determinato (prorogabile) se vede che l’accordo ha buone chance e i creditori rappresentativi sono d’accordo. Dalla domanda di omologa depositata, di default c’è una sospensione in attesa dell’omologa, salvo il giudice decida diversamente . – Composizione negoziata: devi chiedere specificamente le misure protettive e il tribunale le concede con decreto se ne ricorrono i presupposti (lo fa abbastanza facilmente se l’esperto ritiene che serva). Queste misure impediscono nuovi pignoramenti e sospendono quelli in corso per la durata concessa . Ad esempio, se un creditore ti ha notificato atto di pignoramento ma l’asta non è ancora avvenuta, con la protezione viene tutto congelato (non vendono i beni). Tieni presente che i creditori possono fare ricorso per limitare l’ambito delle misure se ne abusassi, ma in genere è un salvagente efficace. – Liquidazione giudiziale: quando viene dichiarato il fallimento, tutte le azioni esecutive in corso decadono (i beni pignorati confluiscono nel fallimento) e nessuno può iniziarne di nuove, perché i creditori devono fare la domanda di ammissione al passivo e soddisfarsi secondo la procedura concorsuale. Quindi sì, anche il fallimento “blocca” le esecuzioni (le sostituisce con la vendita concorsuale). Ma ovviamente il fallimento è l’ultima cosa che vuoi. – Sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata): analogamente, dal deposito ricorso il giudice può disporre la sospensione delle azioni. Nella liquidazione controllata, l’apertura stessa sospende le esecuzioni e le unifica nella procedura concorsuale. – Nota bene: le misure protettive e lo stay non coprono i nuovi debiti. Se dopo il deposito del concordato, continui a non pagare i debiti che maturano (ad es. l’affitto, le forniture successive), quei creditori nuovi potrebbero chiedere la revoca delle misure o hanno il diritto di essere pagati integralmente (sono prededucibili). Esempio: continui a prendere merce durante il concordato – il fornitore post-domanda ha diritto al pagamento integrale, altrimenti può non fornirti più e magari chiedere la risoluzione del contratto con l’azienda in concordato. Quindi blocchi le azioni per debiti vecchi, ma devi onorare i debiti correnti salvo diversa disposizione. – Per alcuni tipi di crediti specifici (es. alimentari, lavoro), la sospensione può avere eccezioni, ma nel contesto aziendale classico tutto viene ricompreso.
In sintesi: se depositi un concordato o simili, nessun creditore può pignorare i beni aziendali o i conti finché la procedura è pendente, a meno che tu non commetta irregolarità gravi e il tribunale revochi la protezione. Ciò dà all’impresa fiato e ordine per trovare la soluzione di insieme.
D8: Nel frattempo che tratto coi creditori, può arrivare qualcuno e fallirmi d’ufficio?
R: Dal 15 luglio 2022, esistono gli obblighi di segnalazione della crisi da parte di organi interni o creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS) quando certi indicatori superano soglie. Tuttavia, l’attivazione di procedure d’ufficio (le cosiddette “allerta esterne”) è stata di fatto limitata: il legislatore ha preferito puntare sulla composizione negoziata volontaria piuttosto che su misure coercitive. Quindi in pratica, nessuno può dichiarare la tua azienda insolvente se non c’è un ricorso di un creditore o tuo. Non esiste un “fallimento d’ufficio” senza istanza (a parte rarissimi casi come fallimento derivato da procedure estere o iniziativa del PM per reati, ma c’è sempre un impulso esterno). Ciò che può succedere è: l’Agenzia Entrate o l’INPS ti mandano solleciti, e in caso di certe soglie di debito scaduto (es. >€5.000 per INPS, >€500.000 per AE) ti avvisano che se non attivi misure (tipo chiedere composizione negoziata) potrebbero farlo loro. Ma ad oggi questi meccanismi sono poco operativi e comunque comportano preavvisi e tempi. Quindi se stai trattando coi creditori in via riservata (prima di depositare qualcosa in tribunale), nessun giudice dichiarerà il tuo fallimento motu proprio. Solo i creditori possono farlo con ricorso. E se un creditore deposita istanza mentre tu tratti, puoi sempre prevenire il peggio avviando tu per primo una procedura (domanda di concordato o composizione negoziata) che, come visto sopra, blocca quell’istanza. Ad esempio, tipicamente appena arriva un’istanza di fallimento, molti debitori depositano un concordato in bianco per fermare il tutto e poi cercano soluzioni . Naturalmente non bisogna abusarne: depositare un concordato in bianco solo per procrastinare senza vera volontà di piano può portare a revoca e far arrabbiare i giudici. Ma se c’è un lavoro serio dietro, il sistema è indulgente con chi si muove per risolvere.
D9: I soci o amministratori rischiano responsabilità personali per i debiti dell’azienda?
R: Sì, ci sono varie situazioni in cui i soci/amministratori possono essere chiamati a rispondere in proprio: – Fideiussioni e garanzie personali: la forma più immediata. Se tu (amministratore o socio) hai garantito un debito societario con fideiussione o ipoteca su un bene tuo, quel creditore può escutere te se la società non paga. Questo non è neanche “responsabilità” in senso stretto, è un obbligo contrattuale tuo da garante. In pratica succede con le banche: di solito i piccoli imprenditori garantiscono personalmente. In caso di default aziendale, la banca ottiene un decreto contro il garante e procede sul suo patrimonio (casa, stipendio, etc.). Anche se fai un concordato per la società, la fideiussione di norma non è inclusa a meno che la banca rinunci (anzi, molte fideiussioni hanno clausola che l’omologa del concordato non libera il garante) . Quindi sì, come socio potresti dover pagare tu parte dei debiti (questo devi gestirlo parallelamente, magari accordandoti a titolo personale con la banca per un saldo e stralcio). – Azione di responsabilità per mala gestione: se l’azienda fallisce o va in liquidazione, il curatore (o i soci nelle srl) possono citare in giudizio gli amministratori per atti di cattiva gestione che hanno aggravato il dissesto. Ad esempio, se hai continuato ad operare in perdita bruciando risorse che potevano andare ai creditori, o hai pagato preferenzialmente certi creditori invece di altri in stato d’insolvenza, o non hai mantenuto “adeguati assetti” per prevenire la crisi . La Cassazione (ord. 23963/2025) ha proprio affermato che l’amministratore che persegue interessi extra-sociali o preferenziali in conflitto con la par condicio può dover risarcire i creditori danneggiati . Queste cause possono portare a condanne a risarcimenti anche ingenti (poi effettivamente incassare è un altro discorso, ma il rischio c’è). Tuttavia, se eviti il fallimento con un concordato successo, di solito queste azioni non vengono promosse (perché col concordato i creditori rinunciano a pretese risarcitorie dovute a gestione, salvo casi di dolo grave). Diverso se vai in liquidazione giudiziale: lì il curatore valuta e, se trova irregolarità, quasi sicuramente intenta l’azione ex art. 2476 c.c. o 2394 c.c. contro gli amministratori e/o sindaci. – Responsabilità tributaria ex art. 36 DPR 602/73: di cui abbiamo parlato. Se hai omesso di versare tributi e poi in fase di scioglimento hai pagato altri creditori lasciando indietro il Fisco, o hai tardato a mettere in liquidazione la società per evitare di pagare imposte, l’Agenzia delle Entrate può chiedere conto a te amministratore o liquidatore . Esempio classico: la società chiude senza beni e non paga IVA, il Fisco può notificare a te accertamento chiedendoti di pagare quell’IVA, se prova che hai pagato altri o occultato beni negli ultimi due anni di attività . Come detto, c’è stata anche una recente Cassazione (35497/2023) che ha annullato una cartella per difetto di atto motivato , a ricordare che devono seguirsi le procedure. Ma il rischio sostanziale c’è: tanti ex amministratori di SRL fallite si son visti recapitare cartelle personali per IVA non versata. – Reati penali: non sono responsabilità “civili” ma personali sì. Se hai commesso reati tipo bancarotta fraudolenta, l’essere amministratore comporta denunce e possibili condanne (oltre danno reputazionale e interdizioni). Se hai evaso l’IVA sopra soglia o trattenuto contributi, sei tu legale rappresentante a rischiare la condanna. La società potrà anche finire, ma il procedimento penale contro di te persona fisica prosegue. Quindi i comportamenti illeciti ti seguono a livello personale. Per difenderti: regolarizza dove puoi (es. pagando il debito fiscale prima del dibattimento ottieni non punibilità), e in generale evita condotte distrattive, altrimenti il curatore segnalerà al PM e partirà un procedimento. – Soci di SNC o SAS: se la tua azienda è una società di persone, i soci (illimitatamente responsabili) rispondono personalmente di tutti i debiti sociali. Quindi in tal caso non c’è neanche distinzione: se la snc fallisce, falliscono pure i soci. Questo è un caso specifico. Spesso si cerca di evitarlo trasformando la società in SRL prima che le cose peggiorino (anche se se è fatto per frodare i creditori poi non serve). Nel nostro contesto PMI, se eri in snc effettivamente sei esposto in proprio. – Soci di Srl fallita: di regola non rispondono oltre il capitale, a meno che abbiano fatto atti di direzione e coordinamento predatori o abbiano ricevuto patrimoni in restituzione in modo scorretto (c’è l’azione di cui all’art. 2497 c.c. in certi casi). Ma è più raro. Il tipico contenzioso col socio è sulla postergazione dei finanziamenti soci: se hai finanziato la tua srl quando era sotto-capitalizzata, in fallimento il curatore può chiedere di considerare quel finanziamento come capitale di rischio e quindi non restituibile al socio finché non pagano tutti gli altri creditori (postergazione ex art. 2467 c.c.). Quindi il socio magari aveva un credito verso la società, però va in coda a tutti. Non è proprio responsabilità, ma perdita di un suo diritto di credito. – Caso 231: l’azienda può essere sanzionata se l’amministratore commette reati in suo interesse (es. frodi fiscali). Ma questo non colpisce l’amministratore se non come riflesso (paga l’azienda).
Riassumendo, un amministratore/socio rischia sul proprio patrimonio se: ha garantito debiti, ha gestito male causando danni (responsabilità civilistica), ha violato norme tributarie specifiche (art.36 DPR 602/73) o penali (reati). Come difendersi? Agire correttamente e per tempo. Dotarsi di assetti adeguati (obbligo di legge dal 2019) e attivarsi per la crisi “senza indugio” ti protegge in parte: se malgrado ciò la tua azienda muore, potrai dire di aver fatto il possibile e ridotto il danno. Non a caso la mancata attivazione tempestiva è considerata colpa grave (e i tribunali l’hanno già sanzionata) . Se segui il percorso concordatario, i creditori spesso rinunciano a incolparti (perché accettano la soluzione proposta come migliore). E soprattutto, non mischiare interessi personali: non pagare prima l’azienda di tuo cugino trascurando il fisco, non prelevare utili in periodi di difficoltà (sarebbero considerati illegittimi e dovresti restituirli). Mantieni una gestione trasparente: contabilità a posto, flussi tracciati. In un caso di crisi questo può fare la differenza tra essere accusato di bancarotta fraudolenta documentale o meno (libri in ordine = niente accusa su quello). E ricorda: la transazione fiscale e il concordato, se eseguiti correttamente, fungono anche da “schermo” – ad esempio, pagamenti effettuati ai sensi di un concordato omologato non possono essere contestati come preferenziali o distrattivi . Quindi risanare in legalità è la miglior difesa per te stesso.
D10: Dopo la chiusura di una procedura, i debiti non pagati sono ancora dovuti?
R: Dipende dalla procedura: – Se chiudi un concordato preventivo regolarmente (adempiuto), i debiti originari si intendono estinti secondo quanto stabilito dal concordato. Ad esempio, se nel concordato hai pagato il 30% ai chirografari, il restante 70% è definitivamente stralciato e nessuno potrà richiederlo in futuro . L’omologazione e il completamento dell’esecuzione liberano la società da quelle obbligazioni. La società prosegue l’attività “ripulita” dai debiti concorsuali residui. Attenzione: se invece non adempie al concordato (lo viola), il tribunale può dichiarare la risoluzione e a quel punto i creditori riacquisiscono i diritti per intero (dedotto quanto incassato). Quindi devi completare il piano per ottenere la liberazione. Una volta completato, i creditori insoddisfatti per la quota mancante non possono far nulla (non possono più agire). – In un accordo di ristrutturazione, la dinamica è contrattuale: i creditori aderenti rinunciano formalmente a una parte di credito e quindi se l’accordo è eseguito, idem come sopra: quella parte stralciata non è più dovuta. Se l’accordo salta per inadempimento, dipende dalle clausole, ma di solito si ritorna alla situazione pre-accordo (quindi i creditori possono richiedere il dovuto originario detratto eventuali acconti). L’omologazione rafforza l’accordo, ma se risolto per inadempimento, si torna all’origine. – In liquidazione giudiziale (fallimento), la società viene cancellata al termine e quindi i suoi debiti insoddisfatti si estinguono con essa (nessun soggetto giuridico su cui farli valere). Se però avevi coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili), quelli restano obbligati verso i creditori per la parte non pagata. Per le persone fisiche fallite, c’è la possibilità di esdebitazione: se concessa, cancella i debiti residui verso quei creditori concorsuali . Quindi, ad esempio, se fallisce una ditta individuale e paga il 10%, con l’esdebitazione il 90% finisce per non essere più dovuto dal titolare (è un beneficio per dare fresh start). Se non chiedi l’esdebitazione (o ti viene negata per scorrettezze), i creditori potrebbero in teoria tornare a chiederti il residuo, ma tecnicamente col fallimento c’è una novazione soggettiva passiva: i creditori hanno dovuto insinuarsi e se non pagati integralmente resterebbero con nulla, salvo casi specifici (pignoramenti in corso non soddisfatti – comunque dovrebbero rifare causa, improbabile). Oggi la regola di default è che il fallito onesto ottiene l’esdebitazione di diritto (nel CCII c’è quasi automatismo, salvo opposizioni). – Sovraindebitamento (concordato minore o ristrutturazione debiti del consumatore): analogamente al concordato normale, la parte non pagata viene cancellata dall’omologa (purché il debitore esegua quanto promesso). – Caso composizione negoziata: se lì hai fatto solo accordi stragiudiziali semplici (tipo ridefinito piani di rientro), quelli novano i contratti originari per chi ha aderito. Un creditore non aderente invece potrebbe teoricamente proseguire per intero. La composizione negoziata in sé non dà scarico legale dei debiti, a meno che non sfoci in un accordo omologato o un concordato. Quindi se resti a livello privato, devi assicurarti di includere tutti i creditori principali in accordi transattivi, altrimenti quelli fuori potrebbero reclamare il 100%. Dunque poi conviene formalizzare un piano attestato pubblicato (che protegge da revocatorie ma non vincola estranei) o accordo omologato. – Transazione fiscale: se omologata in concordato/accordo e poi adempiuta, il Fisco non potrà mai chiedere la parte stralciata (viene annullata per legge la quota non pagata di imposte/sanzioni). Se l’adempimento manca e scatta risoluzione, allora l’intero debito originario risorge al netto di acconti, con eventuali nuovi interessi.
In breve: completa con successo la procedura concordataria o l’accordo, e i debiti residui spariranno giuridicamente. Questo è uno dei grandi vantaggi di usare questi strumenti – l’azienda (o l’imprenditore) può ripartire senza lo spettro di dover ancora milioni impossibili. Ad esempio abbiamo visto l’esdebitazione cancellare il 75% dei debiti ai soci nel Caso 3. La ratio del legislatore moderno è proprio dare discharge al debitore meritevole, sia in insolvenza (post-fallimento) che in concordato ademputo.
D11: L’azienda può essere soggetta a sanzioni o interdizioni se accede a queste procedure? (es. partecipare a gare d’appalto)
R: Questa è una domanda puntuale ma importante: la presentazione di una procedura concorsuale può avere effetti su rapporti contrattuali in corso, licenze o partecipazioni a bandi. Per esempio: – Negli appalti pubblici, fino al 2021 vigeva la regola che l’impresa in concordato preventivo non poteva partecipare a nuove gare (era causa di esclusione) salvo concordato con continuità aziendale con certe caratteristiche. Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 36/2023) però ha rivisto questa materia: ora l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alle gare purché presenti documentazione che la procedura garantisce l’esecuzione del contratto (es. attestazione del tribunale) . Quindi non c’è più un’interdizione assoluta. Resta esclusa invece se è in concordato liquidatorio (perché non proseguirà attività). Quindi se il tuo mercato è anche pubblico, devi puntare a un concordato in continuità e farti autorizzare dal tribunale a proseguire e concorrere. Analogamente per contratti pubblici in essere: l’ente appaltante non può risolvere il contratto solo perché sei in concordato in continuità (ci sono norme specifiche che lo vietano), mentre se fossi in liquidazione sì rescindono. Dunque il timore di perdere appalti c’è se la procedura è liquidativa, ma in continuità la legge oggi tende a proteggere la prosecuzione dell’appalto con l’impresa concordataria (anche per salvaguardare i cantieri). – Certificazioni e albi: alcune certificazioni (es. SOA per lavori pubblici) potrebbero necessitare di comunicare la procedura, ma se continui l’attività non te le revocano di default. Il concordato percepito come “quasi fallimento” poteva avere stigma presso partner privati, ma sta diventando più comune e accettato. Certo, qualche fornitore potrebbe chiederti pagamenti anticipati se sa che sei in concordato. Nel settore privato, a volte i contratti hanno clausole di risoluzione in caso di procedura concorsuale. Tuttavia, per i contratti essenziali, puoi chiedere al tribunale di impedirne la risoluzione per il solo motivo del concordato (il CCII prevede nullità di clausole risolutive automatiche in caso di concordato, se la prestazione è ancora utile alle parti). – Responsabilità 231: non c’è un’interdizione delle attività sociali per aver avviato un concordato. Anzi, la prosecuzione è il fine, quindi no. – Sanzioni amministrative: solo se commetti illeciti. Ad es., se non paghi contributi, l’Ispettorato potrebbe sospendere l’attività per gravi inadempienze contributive. Ma se sei in concordato e hai un piano di pagamento contributi approvato, di solito sospendono quell’ordine di chiusura. – Rapporti con banche: la segnalazione in Centrale Rischi come “sofferenza” avviene comunque se sei insolvente. Concordato e accordi verranno visti come ristrutturazione del credito – la centrale rischi connota in qualche modo, ma ormai le banche sanno leggere. Dopo l’omologa, avrai difficoltà a ottenere nuovi fidi finché non dimostri di essere risanato. Non c’è un divieto legale, ma è questione di rating e fiducia. Alcuni contratti di finanziamento, se vai in concordato, hanno clausole di decadenza fidi (ma poi, con la procedura, tanto erano congelati i rientri). – Immobili in leasing: attento qui – la legge ti consente di chiedere al giudice di mantenere i leasing pendenti nel concordato in continuità (pagando i canoni regolarmente). Se però il concordato non li prevede, la società di leasing può risolverli e riprendersi i beni. Quindi pianifica nel piano come trattare i leasing: continuarli se ti servono i beni. Il tribunale di solito autorizza la continuazione se essenziali alla continuità. In generale, direi: nessuna sanzione civile aggiuntiva per aver usato la legge (anzi, è incoraggiato). Semmai c’è la percezione di minor affidabilità per un periodo. Ma come evidenziava Unioncamere, il concordato o accordo è ormai visto come un “male minore” rispetto al fallimento, e aziende risanate con questi strumenti tornano sul mercato salvando posti di lavoro .
D12: Quanto costa in termini di tempo e denaro una procedura del genere? Ne vale la pena o conviene chiudere e basta?
R: I costi non sono trascurabili, ma vanno commisurati ai benefici. Indicativamente: – Un concordato preventivo comporta costi professionali (avvocati, commercialisti attestatori) che, per una piccola impresa, possono essere alcune decine di migliaia di euro. Inoltre c’è il contributo unificato di circa €1.032 e la marca da bollo da €27 da pagare allo Stato. Va nominato un Commissario Giudiziale, che a fine procedura ha diritto a un compenso a carico dell’azienda, liquidato dal tribunale in percentuale sul passivo e sull’attivo (per un passivo di qualche milione, il compenso può essere sui 10-20k € circa, modulato). Se c’è un Liquidatore Giudiziale (nel concordato liquidatorio) anche lui va compensato. Quindi parliamo di qualche punto percentuale del debito forse. D’altro canto, se la procedura riesce e la tua azienda continua, questi costi si ripagano col proseguimento dell’attività. La durata: un concordato richiede preparazione (2-3 mesi per il piano), poi l’iter in tribunale (ammissione, voto, omologa) che può essere ~6-9 mesi se tutto fila liscio (a volte 12). Quindi in meno di un anno potresti avere l’omologa. Poi l’esecuzione del piano può durare anni, ma quella è “vita normale” azienda, solo che hai vincolo di destinare utili ai creditori. Quindi è un investimento di tempo e soldi affrontare il concordato, ma spesso “conviene” rispetto a perdere l’azienda e magari doversi reinventare. – Un accordo di ristrutturazione è di solito meno costoso: paghi i consulenti (anche qui, qualche decina di migliaia, a seconda della complessità) e l’attestatore. Ma non c’è un commissario in mezzo che costa. C’è un piccolo contributo per il deposito (un contributo unificato fisso di €518 se ricordo per omologa). Quindi risparmi rispetto al concordato. Anche i tempi sono più rapidi: se i creditori sono concordi, dal deposito all’omologa a volte bastano 2-3 mesi. – Una composizione negoziata: qui i costi sono ancora più contenuti. L’esperto viene pagato secondo tariffe ministeriali (a carico dell’impresa, ma molto calmierate, spesso lordi €4-6k per tutta la procedura per PMI medie, integrati da eventuale bonus successo), c’è l’eventuale OCC se nominato. I consulenti te li paghi tu ma puoi tenerli minimi. Non c’è contributo unificato a meno che tu chieda misure protettive (in quel caso ~€98). Quindi è uno strumento abbastanza economico, per incoraggiare l’uso. Anche i tempi li decidi tu con l’esperto entro il max 180+180gg. – Liquidazione giudiziale (fallimento) ha i suoi costi (curatore, spese di giustizia) ma quelli sono pagati sulla massa attiva eventualmente ricavata. Se non c’è attivo, spesso finiscono a carico dell’erario. Per te imprenditore, il costo è la perdita dell’impresa, brand, ecc. (intangibili, ma valore economico magari altissimo). Chiudere e basta (“portare i libri in tribunale” passivamente) ti sembra meno costoso perché non spendi subito in consulenti, ma poi i danni collaterali (perdita azienda, possibili azioni di responsabilità, dover rispondere ai creditori insoddisfatti se sei socio illimitato) possono superare di gran lunga i risparmi. Senza contare l’impatto su dipendenti e territorio. Quindi a conti fatti, vale la pena tentare il risanamento se c’è una pur minima possibilità, anche investendo in professionisti di qualità. È come un intervento chirurgico: costa e fa male, ma ti ridà vita. Se non c’è nulla da fare (azienda decotta, mercato morto, ecc.), allora sì, meglio non fare procedure inutilmente e optare per la liquidazione ordinata (o fallimento) riducendo spese, e pensare a nuova attività. Ma attenzione: il dovere degli amministratori (art. 2086 c.c.) è di attivare misure, quindi se tu deliberatamente non fai niente e fai fallire quando potevi proporre un concordato, i creditori potrebbero imputartelo come mala gestio. Non è automatico, ma esiste il concetto di “mancata richiesta tempestiva di concordato” come possibile colpa. Quindi i costi vanno calibrati: di solito tribunali e professionisti cercano di tarare la complessità in base alla dimensione azienda, perché sanno che piccole realtà non reggono spese eccessive. Con l’esperto negoziatore e l’OCC (per piccoli) si sta cercando di offrire soluzioni low-cost. Valuta anche eventuali bandi pubblici: a volte le Camere di Commercio o le regioni stanziano contributi per le imprese che accedono a composizione negoziata o per pagare l’attestatore. Questo per incentivare il salvataggio di PMI. Informati localmente, potresti trovare sostegni.
Fonti normative, giurisprudenziali e bibliografiche (ottobre 2025)
(Le seguenti fonti supportano e approfondiscono i contenuti esposti nella guida. Sono elencate per categoria: normativa, giurisprudenza, prassi/autori. Tutte sono aggiornate e autorevoli nel contesto italiano.)
Normativa e prassi: 1. Codice Civile, art. 2086 comma 2 – Dovere di adeguati assetti e attivazione tempestiva dell’imprenditore . (Modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone agli amministratori obblighi organizzativi per prevenire la crisi.)
2. D.P.R. 29/09/1973 n.602, art. 36 – Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per debiti tributari . (Disciplina l’eccezionale responsabilità personale per imposte non pagate in caso di atti pregiudizievoli in liquidazione o omessa liquidazione.)
3. D.Lgs. 12/01/2019 n.14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) – articoli chiave:
– art. 23 e 24 – Composizione negoziata: nomina esperto e conclusione con accordi . (Include novità D.Lgs. 136/2024 su transazione fiscale durante negoziazione.)
– art. 56 – Piano attestato di risanamento: contenuto ed effetti (esenzione da revocatorie) .
– art. 57-60 – Accordi di ristrutturazione: quorum 60%; variante agevolata 30% .
– art. 61 – Accordo ad efficacia estesa: classi con ≥75% consensi vincolano dissenzienti .
– art. 63 – Transazione fiscale e contributiva: ristrutturazione debiti fiscali/INPS nei concordati e accordi .
– art. 84-94 – Concordato preventivo: requisiti (continuità vs liquidatorio con ≥20% ai chirografari) , esecuzione, effetti vincolanti .
– art. 111-118 – Effetti concordato: sospensione azioni esecutive e sorte contratti pendenti .
– art. 121-270 – Liquidazione giudiziale (ex fallimento): apertura, effetti (spossessamento e concorso), esdebitazione del debitore onesto .
(CCII introdotto da D.Lgs. 14/2019 e correttivi: D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 170/2023, D.Lgs. 136/2024.)
4. D.L. 24/08/2021 n.118, conv. L. 147/2021 – Introduzione Composizione Negoziata. (Cornice normativa iniziale per l’istituto, ora integrato nel CCII. Vedi Unioncamere e fonti ministeriali per linee guida.)
5. D.L. 16/06/2023 n.69, conv. L. 103/2023, art. 1-bis – Omologazione accordi di ristrutturazione e concordati “cram-down” fiscale. (Ha consentito l’omologa nonostante il dissenso del Fisco/INPS se proposta conveniente: vedi Trib. Vasto 11/12/2024).
6. Agenzia Entrate – Risposta a interpello n.222/2024 (29/11/2024) – Esenzione parziale delle sopravvenienze attive da riduzione debiti in piano attestato . (Conferma che i crediti annullati in un piano attestato pubblicato non concorrono interamente a formare reddito, ex art. 88 c.4-ter TUIR.)
7. CNDCEC (Consiglio Nazionale Dott. Comm.) – Principi di attestazione dei piani di risanamento (ed. 2024) . (Standard professionali per l’attestatore: definiscono la diligenza e la metodologia per valutare veridicità e fattibilità dei piani.)
Giurisprudenza: 8. Cass. Civ., Sez. I, ord. 19/12/2023 n. 35497 – Responsabilità ex amministratore per debiti fiscali – Necessità di atto di accertamento prima della cartella . (Caso in cui Equitalia aveva emesso cartella verso l’amministratore per IVA non versata dalla società fallita; la Cassazione ha annullato la cartella perché mancava la preventiva notifica di un atto motivato ex art.36 DPR 602/73, violando il diritto di difesa del contribuente.)
9. Cass. Pen., Sez. III, sent. 28/07/2023 n. 32967 – Omesso versamento contributi previdenziali – Crisi aziendale non esime dalla responsabilità penale . (Conferma che il datore di lavoro che, pur in difficoltà economica, paga altri costi e non i contributi commette reato ex art.2 L.638/83, dovendo semmai ridurre le retribuzioni pur di versare le ritenute).
10. Cass. Civ., Sez. I, ord. 27/08/2025 n. 23963 – Responsabilità amministratore S.r.l. per atti di mala gestio pregiudizievoli ai creditori (pagamenti preferenziali) . (Caso Gamma: amministratore condannato per aver favorito società estere di cui aveva interesse, effettuando compensazioni e pagamenti preferenziali in stato di crisi, lesivi del patrimonio sociale e della par condicio; Cassazione conferma inammissibilità del suo ricorso).
11. Tribunale di Vasto, sent. 11/12/2024 – Omologa accordo di ristrutturazione con cram-down fiscale ex DL 69/2023 . (Accordo ex artt.57 e 63 CCII omologato nonostante il dissenso dell’Erario, ritenuto soddisfatto meglio che nella liquidazione giudiziale. Conferma applicazione art.1-bis DL 69/23: se Fisco/INPS dissenzienti sono decisivi per quorum e proposta è conveniente, accordo omologabile comunque. Viene citata la clausola risolutiva ex lege di cui all’art.63 co.3 CCII per tutela Enti).
12. Cass. Civ., Sez. I, ord. 30/01/2025 n. 2223 – Soglia minima €30.000 debiti scaduti per fallibilità – Va accertata alla data decisione . (Richiamata come principio: un imprenditore non può essere dichiarato fallito se i debiti scaduti e non pagati risultano inferiori a 30mila euro; va valutato al momento dell’istruttoria prefallimentare conclusa. Ribadisce art.15 L.Fall, ora art. 49 CCII).
13. Corte di Cass., Sez. I, sent. 10/07/2024 n. 18826 – Proposta concordataria concorrente – limiti e condizioni. (In commenti dottrinali: affronta la possibilità di proposte alternative nel concordato preventivo e i limiti di ultrapetizione se la Corte d’Appello qualifica diversamente l’azione esercitata. Utile per capire dinamiche di eventuali offerte concorrenti e azioni dei creditori.)
14. Cass. Civ., Sez. I, sent. 24/12/2024 n. 34372 – Concordato preventivo – effetti della mancata contestazione di un credito al voto . (Stabilisce che se né debitore né altri creditori contestano durante l’adunanza il diritto di voto di un creditore, questi vota implicitamente ammesso, senza necessità di decreto formale. Ribadisce principi su contestazioni di crediti in sede di concordato.)
15. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 08/02/2018 n. 291/2018 – (precedente storico) Transazione fiscale nel concordato – vincolatività del voto Erario. (Sentenza antecedente la riforma, affermava che il Fisco dissenziente non poteva essere crammed down nel concordato; rilevante per comprendere il cambio di orientamento legislativo successivo.)
La tua azienda che si occupa di posa di pavimenti industriali, pavimenti in calcestruzzo, pavimenti in resina, pavimenti antiusura, pavimenti per capannoni, pavimenti antiacido, pavimentazioni per logistica, industria e retail, lisciature, quarzature, trattamenti superficiali o ripristini strutturali si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che si occupa di posa di pavimenti industriali, pavimenti in calcestruzzo, pavimenti in resina, pavimenti antiusura, pavimenti per capannoni, pavimenti antiacido, pavimentazioni per logistica, industria e retail, lisciature, quarzature, trattamenti superficiali o ripristini strutturali si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, sospensioni delle forniture o minacce di pignoramento da Fisco, INPS, banche, fornitori di materiali e attrezzature o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei pavimenti industriali richiede materiali costosi, grande manodopera specializzata, tempi stretti di posa, macchinari impegnativi e continui anticipi di spesa. Un ritardo nei pagamenti o un blocco dei fidi può generare una crisi di liquidità improvvisa.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e nel modo corretto.
Perché un’Azienda di Pavimenti Industriali Va in Debito
- aumento dei costi di calcestruzzi, resine, quarzi, additivi e primer
- ritardi nei pagamenti di imprese edili, capannoni, contractor e committenti
- anticipi elevati per materiali, attrezzature, manodopera e noleggi
- investimenti in macchinari (elicotteri, spianatrici, levigatrici)
- aumenti di carburante, trasporti e logistica
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- cantieri rallentati da permessi, meteo o varianti
Il problema vero non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti aziendali
- blocco dei fidi
- stop alle forniture di materiali e attrezzature
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di macchinari e mezzi
- impossibilità di rispettare tempi di posa e consegne
- perdita di cantieri strategici e clienti importanti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
È possibile fermare pignoramenti e richieste di rientro, proteggere i conti e impedire il blocco dell’attività.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso emergono irregolarità come:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte consistente del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti utili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate
4. Usare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per le crisi più serie:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Questi strumenti permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende con debiti.
Le sue qualifiche comprendono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un’insieme di competenze che permette di bloccare i creditori, ristrutturare debiti e salvare imprese operative nei cantieri.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di macchinari, materiali e cantieri
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di posa di pavimenti industriali non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, concreta e mirata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- proteggere mezzi, materiali e cantieri
- salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.