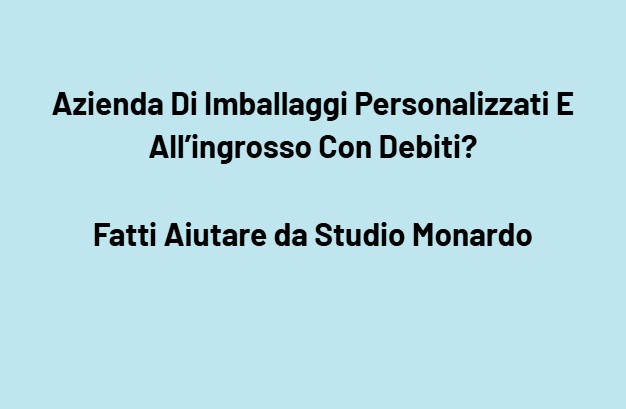Se la tua azienda produce o distribuisce imballaggi personalizzati, scatole, packaging su misura, imballaggi industriali, cartoni, film plastici, etichette, pallet, materiali per spedizioni e forniture all’ingrosso, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare un blocco improvviso dell’attività.
Nel settore dell’imballaggio, ritardi e mancate consegne possono compromettere intere catene logistiche, causare penali e far perdere clienti strategici nella produzione, nella distribuzione e nell’e-commerce.
Perché le aziende di imballaggi accumulano debiti
- costi elevati per materie prime (cartone, plastica, film, collanti, inchiostri)
- rincari delle materie prime e dell’energia
- pagamenti lenti da parte di aziende, logistiche e rivenditori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- gestione di magazzini ingombranti e costosi
- investimenti in macchinari di stampa, taglio, fustellatura e personalizzazione
- difficoltà ad ottenere fidi bancari sufficienti
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista
- verificare quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
- evitare piani di rientro insostenibili
- richiedere la sospensione di pignoramenti o procedure esecutive
- proteggere fornitori strategici di materiali e lavorazioni
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni rapidamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di cartone, film, etichette, materiali e personalizzazioni
- impossibilità di rispettare consegne e contratti
- perdita di clienti industriali, rivenditori, e-commerce e logistiche
- rischio reale di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può intervenire per:
- bloccare immediatamente pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti normativi più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, materiali, attrezzature e continuità produttiva
- salvare la tua azienda e prevenire la chiusura
Agisci ora
La maggior parte delle imprese non fallisce per i debiti, ma perché interviene troppo tardi.
Con l’aiuto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure in corso, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua azienda di imballaggi personalizzati e all’ingrosso.
Contesto: debiti aziendali e rischio d’insolvenza
Gestire un’azienda di imballaggi – soprattutto nel settore personalizzato e all’ingrosso – comporta costi operativi elevati (materie prime, macchinari, logistica) e margini spesso compressi dalla concorrenza. Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti o contrazione degli ordini possono rapidamente tradursi in mancati pagamenti ai propri fornitori, banche o allo Stato. L’accumularsi dei debiti espone l’azienda a diverse iniziative dei creditori, fino al rischio estremo di insolvenza e apertura di una procedura concorsuale (il cosiddetto fallimento, oggi liquidazione giudiziale).
Dal punto di vista del debitore, è fondamentale conoscere cosa fare per difendersi: quali rimedi legali attivare, come prevenire azioni esecutive e come sfruttare le procedure di composizione della crisi previste dall’ordinamento. Occorre inoltre comprendere chi risponde dei debiti (la società, i soci, gli amministratori) a seconda della forma giuridica (SRL, SNC o impresa individuale) e quali condotte possono comportare responsabilità personali (ad esempio una cattiva gestione può far ricadere sul patrimonio personale degli amministratori i debiti sociali in certi casi ).
Nei paragrafi che seguono analizzeremo le principali categorie di debiti aziendali e le relative conseguenze, per poi esaminare gli strumenti di tutela (dalle dilazioni di pagamento alle opposizioni giudiziali) e le soluzioni di ristrutturazione offerte dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). L’esposizione terrà conto delle novità normative fino al 2025 (es. riforma della riscossione 2024, correttivi al CCII 2022-2024, ultimo orientamento giurisprudenziale) e fornirà riferimenti a leggi e sentenze autorevoli. Al termine, una sezione FAQ riassumerà in forma di domanda e risposta i dubbi più comuni, e una serie di tabelle offrirà una visione schematica di concetti chiave per una rapida consultazione.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Non tutti i debiti commerciali sono uguali: a seconda della natura del credito e del soggetto creditore, cambiano sia le tutele legali del creditore sia le strategie difensive del debitore. Di seguito distinguiamo le principali categorie di debiti che una società di imballaggi potrebbe accumulare:
- Debiti fiscali e contributivi – Imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) o ritenute non pagate, contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, cartelle esattoriali emesse dall’Erario.
- Debiti verso fornitori – Fatture insolute verso fornitori di materie prime, imballaggi grezzi, servizi logistici, ecc.
- Debiti bancari e finanziari – Rate di mutui o leasing scadute, scoperti di conto non rientrati, finanziamenti a breve termine non restituiti.
- Debiti verso dipendenti – Stipendi o TFR non corrisposti, o ritardi nei pagamenti di paghe e contributi.
- (Eventuali altre passività potrebbero includere debiti verso locatori, verso società di leasing, sanzioni amministrative, ecc., ma i casi principali rientrano nelle categorie sopra.)
Ogni tipologia di debito attiva meccanismi giuridici differenti. Analizziamoli singolarmente per capire cosa può fare il creditore e come può difendersi il debitore in ogni caso.
Debiti fiscali e previdenziali: cartelle, sanzioni e riscossione coattiva
I debiti fiscali (imposte) e previdenziali (contributi INPS) sono tra i più delicati, perché il Fisco dispone di poteri e privilegi speciali per la riscossione. In Italia, se un’impresa non paga imposte dichiarate o accertate, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) iscrive a ruolo l’importo e notifica una cartella esattoriale. Ecco i punti chiave:
- Cartella di pagamento: È l’atto con cui si intima il pagamento entro 60 giorni. Contiene imposta, interessi e sanzioni amministrative (generalmente il 30% per omesso versamento oltre 90 giorni ). Se la cartella non viene pagata né contestata nei termini, diventa definitiva e l’Agente della riscossione può procedere con misure esecutive (fermo amministrativo di automezzi, ipoteca su immobili, pignoramento di conti correnti, stipendi, immobili, ecc.).
- Sanzioni e interessi: Il mancato pagamento delle imposte nei termini comporta sanzioni tributarie amministrative (es. 30% dell’imposta non versata oltre 90 giorni ) e interessi moratori (attualmente attorno al 3,5% annuo ). Tali oneri si sommano al debito originario e aumentano col tempo. Va evidenziato che queste sanzioni amministrative si cumulano con eventuali sanzioni penali: ad esempio, l’omesso versamento IVA oltre soglia comporta reato penale oltre alla sanzione del 30%, secondo la Cassazione .
- Poteri speciali del Fisco: I crediti erariali godono di privilegi sui beni del debitore (il Fisco è soddisfatto prima di creditori chirografari su mobili e immobili). Inoltre l’Agente di riscossione, dopo la notifica della cartella, può procedere ad atti esecutivi in via amministrativa (es. fermo auto) senza passare dal giudice. Per il pignoramento immobiliare, invece, deve attivare una procedura esecutiva giudiziaria, ma senza bisogno di un decreto ingiuntivo: la cartella stessa, trascorsi 60 giorni, è già titolo esecutivo .
- Termini e opposizioni: Se l’azienda ritiene erroneo il debito (es. perché l’accertamento è sbagliato o prescritt[o]), può proporre ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento o cartella, a seconda dei casi). In mancanza di ricorso, la cartella è definitiva. Successivamente, si potrà solo contestare vizi formali della riscossione (mediante opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi) ma non più il merito del tributo.
Come difendersi dai debiti fiscali? La strategia del debitore deve muoversi su due fronti: (1) impugnare quando possibile e (2) alleggerire/ritardare la riscossione tramite strumenti come la rateizzazione o le definizioni agevolate:
- Ricorso o autotutela: Se il debito non è dovuto (ad es. perché già prescritto o erroneamente calcolato), è fondamentale presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dall’atto impositivo, chiedendo eventualmente la sospensione. In alcuni casi, si può presentare istanza di autotutela all’Agenzia (ma questa non sospende i termini di ricorso).
- Rateizzazione ordinaria: L’ordinamento consente di dilazionare i debiti fiscali iscritti a ruolo presentando domanda all’Agenzia Entrate-Riscossione. Dal 1° gennaio 2025 la disciplina è divenuta più favorevole: per debiti fino a 120.000 € si ottiene in modo automatico un piano fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste nel 2025-2026 , senza dover dimostrare lo stato di difficoltà (basta un’auto-dichiarazione) . Il D.Lgs. 110/2024 (riforma riscossione attuativa del PNRR) ha infatti elevato il precedente limite di 72 rate a 84, prevedendo ulteriori incrementi a 96 rate per istanze nel 2027-28 e 108 rate dal 2029 . Per debiti oltre 120.000 €, o se occorrono più rate, si può chiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni), documentando la grave difficoltà economica . Ad esempio, con comprovata crisi, anche un debito di 200.000 € può essere diluito in 10 anni. Il piano ordinario decade se si saltano 5 rate anche non consecutive – soglia anch’essa ampliata dalla riforma (prima erano 8 rate, poi ridotte a 5) – ma è possibile una riammissione se si paga il dovuto entro certi limiti di tempo (il legislatore ha introdotto più flessibilità su questo con vari “milleproroghe” ).
- Rateazione e definizioni agevolate: Oltre alle rateazioni ordinarie ex art. 19 DPR 602/1973, negli ultimi anni vi sono state misure straordinarie (“rottamazioni” e “saldo e stralcio”). Ad esempio, la “Rottamazione-quater” 2023 ha permesso di estinguere i debiti fiscali eliminando sanzioni e interessi di mora, pagando solo imposte e aggio in 18 rate su 5 anni . Queste definizioni agevolate sono finestre legislative temporanee; attualmente (fine 2025) non ve ne sono di attive, ma conviene monitorare le leggi di bilancio annuali che spesso le prevedono. Attenzione: se un debito è ammesso a rottamazione o conciliazione, occorre comunque rispettare i pagamenti delle rate agevolate per non decadere dai benefici.
- Transazione fiscale e contributiva: Nell’ambito di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, è possibile negoziare stralci su debiti fiscali e contributivi attraverso la transazione fiscale (art. 63 CCII, ex art. 182-ter L.F.). Ciò consente all’impresa in crisi di proporre al Fisco un pagamento parziale delle somme dovute (comprendendo anche IVA e ritenute, che un tempo erano “inderogabili”), purché un esperto indipendente attesti che la proposta è più conveniente di una liquidazione fallimentare . La transazione fiscale deve essere omologata dal tribunale insieme al concordato o accordo di ristrutturazione, vincolando l’Erario se approvata. Esempio: una società potrebbe proporre di pagare il 40% dell’IVA dovuta dilazionato in 5 anni, evidenziando che in caso di fallimento il Fisco incasserebbe solo il 20% (grazie al privilegio sui beni). Se l’attestatore e il giudice ritengono credibile il piano, l’accordo può essere approvato e il debito fiscale ridotto di conseguenza.
- Sospensioni e moratorie emergenziali: In situazioni eccezionali (calamità naturali, pandemia da COVID-19, ecc.) il governo può disporre sospensioni dei termini di pagamento delle cartelle o moratorie sui pignoramenti. Ad esempio, durante il 2020 vi è stata una sospensione generalizzata della riscossione coattiva per alcuni mesi. Attualmente (2025) non ci sono sospensioni generalizzate, ma è bene verificare se normative speciali settoriali (es. per aree colpite da alluvioni) prevedano proroghe.
- Misure protettive del Codice della Crisi: Se l’impresa attiva una procedura di composizione negoziata o deposita un ricorso per concordato preventivo, può chiedere al tribunale misure protettive che bloccano temporaneamente le azioni esecutive dei creditori, Fisco compreso (tipicamente per la composizione negoziata lo stay iniziale è fino a 4 mesi, rinnovabile ). Questo congelamento offre respiro per trattare un accordo con i creditori. Inoltre, l’apertura di trattative assistite da un esperto comporta benefici fiscali premiali: riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari post-apertura, riduzione delle sanzioni al minimo se l’ufficio le irroga durante la procedura e l’azienda paga tempestivamente , dimezzamento degli interessi e sanzioni maturati prima se si perfeziona un piano attestato o accordo di ristrutturazione . Anche il numero di rate ottenibili per dilazione di nuove imposte dovute viene aumentato fino a 120 se l’esperto attesta la difficoltà e l’accordo raggiunto viene pubblicato . Queste premialità fiscali introdotte nell’art. 25-bis CCII incentivano il ricorso precoce a strumenti di risanamento.
- Conseguenze penali: Una preoccupazione specifica per l’imprenditore riguarda i possibili reati tributari. In particolare, l’omesso versamento di IVA e l’omesso versamento di ritenute certificate oltre certe soglie di importo costituiscono reato punibile con la reclusione (artt. 10-ter e 10-bis D.Lgs. 74/2000). Dal 2024 tali soglie sono state innalzate: oggi il reato scatta solo se l’IVA non versata supera € 250.000 per periodo d’imposta (prima era €50.000) , e se le ritenute non versate superano € 150.000 (prima €50.000) . Inoltre, il termine di consumazione del reato IVA è stato fissato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione (quindi, ad es., per l’IVA 2024 non versata, il reato si perfeziona il 31/12/2025) . Importante: la legge prevede cause di non punibilità se il mancato pagamento è dovuto a circostanze di forza maggiore sopravvenute. La riforma 2024 ha inserito nel D.Lgs. 74/2000 un comma che esclude la punibilità quando l’omissione dipende da una grave e non transitoria crisi di liquidità dovuta, ad esempio, all’insolvenza di un importante cliente . La Cassazione ha già applicato questa novità, affermando (sent. 30532/2024 Sez. III Pen.) che non è punibile l’imprenditore che non versa l’IVA per comprovata impossibilità finanziaria non imputabile, mentre non vale come scusa la scelta di pagare altri debiti al posto del Fisco . Inoltre, qualora sia avviato un procedimento penale, il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto meccanismi di estinzione del reato o riduzione di pena se il contribuente paga il debito tributario prima o durante il processo . Ciò significa che, ad esempio, attivare una rateizzazione e saldare l’IVA dovuta prima della sentenza può evitare la condanna penale. In sintesi: per difendersi sul fronte penale, è cruciale ridurre le somme non versate sotto soglia (mediante pagamenti o compensazioni), avvalersi di rateizzazioni entro l’anno successivo e documentare eventuali cause di forza maggiore che abbiano impedito il versamento.
Debiti verso Enti previdenziali: Simili ai debiti fiscali, includono INPS e INAIL. Il mancato versamento di contributi previdenziali dei dipendenti oltre una soglia (circa €10.000 annui di omissioni) è reato (art. 2 D.L. 463/1983 conv. L.638/83), ma la causa di non punibilità scatta se si paga integralmente quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione. Dunque, se l’azienda ha trattenuto contributi ai lavoratori senza versarli, occorre sanarli tempestivamente per evitare sanzioni penali. Anche i contributi possono essere iscritti a ruolo con cartella; valgono le stesse regole di rateizzo del Fisco (spesso gestite dall’Agenzia Riscossione per conto di INPS). Inoltre, in procedure concorsuali vige la transazione previdenziale simile a quella fiscale.
Debiti verso fornitori: decreti ingiuntivi e azioni ordinarie
I debiti commerciali verso fornitori (materie prime per imballaggi, servizi, utenze) sono debiti di diritto privato in cui il creditore (spesso un’altra impresa) non gode dei poteri speciali del Fisco, ma può agire tramite gli strumenti civilistici ordinari:
- Solleciti e messa in mora: Tipicamente il fornitore invia solleciti di pagamento e infine una lettera di messa in mora (ex art. 1219 c.c.) intimando il saldo entro un termine, spesso a mezzo PEC o raccomandata. La messa in mora formale può avere l’effetto di far decorrere gli interessi moratori (di solito interessi commerciali ex D.Lgs. 231/2002, tassi elevati) e costituisce presupposto per chiedere poi le spese legali.
- Decreto ingiuntivo: Se il debitore non paga, il fornitore può rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento (art. 633 c.p.c.), presentando prova scritta del credito (fatture, DDT firmati, contratti). Il decreto ingiuntivo è un provvedimento rapido e unilaterale: il giudice, verificata la documentazione, ingiunge al debitore di pagare entro 40 giorni. Può anche dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo (immediatamente eseguibile) se il credito ha particolari fondamenti (cambiali, o credito ammesso dall’azienda debitrice, o pericolo nel ritardo). In mancanza di indicazione, il decreto è esecutivo solo dopo la scadenza dei 40 giorni.
Difendersi da un decreto ingiuntivo: Il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 645 c.p.c.), cioè per contestare il credito davanti allo stesso tribunale che ha emesso il decreto . L’opposizione si propone con atto di citazione e apre un giudizio ordinario in cui il fornitore diventa attore (deve provare il credito) e il debitore opponente assume il ruolo di convenuto. Se nel decreto il giudice aveva concesso esecutorietà provvisoria, la presentazione dell’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione: bisogna chiedere al giudice una sospensione dell’esecutorietà nelle more del giudizio, dimostrando gravi motivi (ad esempio, eccependo che il credito è inesistente o già pagato, con prova). Se invece il decreto non era provvisoriamente esecutivo, durante i 40 giorni il fornitore non può procedere ad esecuzione forzata. Decorso il termine senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo (il creditore può apporre la formula esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c.) . Un decreto non opposto equivale a una sentenza passata in giudicato: il credito è accertato definitivamente .
È fondamentale dunque non ignorare un decreto ingiuntivo. Se l’azienda ha motivi di contestazione del debito (vizi della fornitura, errori di conteggio, prescrizione, ecc.), deve presentare opposizione nei 40 giorni. L’opposizione può anche basarsi su eccezioni procedurali (notifica invalida, difetto di prova sommaria, incompetenza del giudice, ecc.). Ad esempio, se la società debitrice contesta la qualità della merce consegnata o rileva che l’importo è già stato parzialmente pagato, tali questioni andranno sollevate nell’atto di citazione in opposizione.
Tempi e costi: Il giudizio di opposizione trasforma la procedura monitoria in un processo civile ordinario, che può durare anche alcuni anni in primo grado. Questo implica tempi più lunghi prima che il creditore ottenga una sentenza definitiva. Talvolta, il debitore, pur sapendo di dovere la somma, usa l’opposizione strategicamente per guadagnare tempo e magari cercare un accordo transattivo nel frattempo. Va però ponderato che, se l’opposizione è chiaramente pretestuosa, il giudice può concedere provvisoria esecuzione anche durante il giudizio, o condannare l’opponente a spese e ulteriori interessi.
Inoltre, il termine di 40 giorni per l’opposizione è soggetto a sospensione feriale (1-31 agosto) in materia civile ordinaria, tranne che per crediti di lavoro o altri casi espressamente esclusi . Dunque, se un decreto è notificato a luglio, il conteggio si ferma in agosto (salvo ingiunzioni su stipendi, che seguono rito lavoro con termini più brevi). Se l’azienda ha omesso l’opposizione per cause non imputabili (es. notifica mai giunta a conoscenza), esiste l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.): entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione, si può ancora opporre il decreto provando il vizio di notifica o la forza maggiore .
- Esecuzione forzata: Ottenuto un titolo esecutivo (decreto definitivo o provvisoriamente esecutivo, o sentenza), il fornitore può passare al pignoramento dei beni della società debitrice. Tipicamente, inizia con un atto di precetto (intimazione a pagare entro almeno 10 giorni), poi notifica il pignoramento: può colpire conti correnti aziendali, merci in magazzino (pignoramento mobiliare), crediti verso terzi (es. crediti della società verso i suoi clienti, tramite pignoramento presso terzi), oppure beni immobili (se l’azienda possiede capannoni, terreni, ecc.). Nel nostro caso, una società di imballaggi potrebbe subire il pignoramento di macchinari, automezzi o del saldo attivo di conto corrente.
Difese nell’esecuzione: Quando si riceve un precetto o un pignoramento, le strade principali sono: (a) concordare un piano di rientro stragiudiziale col creditore (che a volte accetta di sospendere l’esecuzione in cambio di pagamenti dilazionati – ma occorre rapidità, perché dopo il pignoramento i margini si riducono), (b) valutare vizi formali dell’atto per proporre opposizione agli atti esecutivi (entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, art. 617 c.p.c.), ad esempio contestando un’irregolarità nella notifica del titolo, o la pignorabilità di un certo bene, (c) in caso di inesistenza del debito o estinzione successiva, opporsi all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (ad esempio se si è già pagato il dovuto ma il creditore procede lo stesso, o se il titolo è stato sospeso). Queste opposizioni vanno fatte con l’assistenza legale e talora possono portare a una sospensione dell’esecuzione da parte del giudice, se i motivi appaiono fondati.
In pratica, però, se il debito è dovuto e l’azienda non ha liquidità né difese giuridiche, l’esecuzione forzata proseguirà fino alla vendita forzata dei beni pignorati e alla distribuzione del ricavato al creditore. Ciò può mettere in grave crisi un’azienda: basti pensare al pignoramento del conto corrente (che blocca operatività e pagamenti) o al pignoramento di un macchinario essenziale (che impedisce di lavorare). Per questo, affrontare per tempo i debiti dei fornitori tramite negoziazioni o piani di risanamento è cruciale per evitare di arrivare alle esecuzioni.
In sintesi, per difendersi dai debiti commerciali, l’imprenditore dovrebbe:
- Comunicare e negoziare: Spesso il fornitore preferisce trovare un accordo piuttosto che affrontare lunghe azioni legali. Proporre un piano di rientro amichevole (es. pagando gradualmente il dovuto con aggiunta di interessi) può evitare il decreto ingiuntivo. Meglio formalizzare l’accordo per iscritto (magari con riconoscimento di debito), così il fornitore è più tranquillo e attende.
- Verificare i crediti: Controllare se il credito del fornitore è contestabile (merce difettosa? importo errato? prescrizione – di solito 5 anni per forniture ordinarie, o 2 anni per piccole forniture tra privati, ecc.). Se c’è materia del contendere, farlo subito presente al creditore; questo può scoraggiare l’ingiunzione o comunque costituirà materia per l’eventuale giudizio di opposizione.
- Non ignorare le ingiunzioni: Come detto, opporsi entro 40 giorni è fondamentale se il debito è contestato. L’opposizione può anche semplicemente creare margine di trattativa: in molti casi, infatti, durante il giudizio le parti arrivano a una transazione (ad esempio, l’azienda paga il 70% subito e il fornitore rinuncia al restante, chiudendo la lite). Se invece si lascia decorrere il termine senza agire, il decreto diventa definitivo e a quel punto il debitore perde gran parte del potere contrattuale.
- Valutare procedure concorsuali: Se i debiti verso fornitori sono tali da minacciare la continuità aziendale e non si riesce a ottenere dilazioni extragiudiziali, può essere opportuno considerare gli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo – v. infra). In un concordato, ad esempio, si può proporre di pagare ai fornitori solo una percentuale del dovuto (es. 30%) ottenendo l’ok dal tribunale a condizione che la maggioranza dei creditori non opponga rifiuto e che ciò li soddisfi meglio di un fallimento. Questo può “imporre” ai fornitori una falcidia del credito, cosa che altrimenti non accetterebbero su base volontaria.
- Attenzione ai fornitori strategici: Un’azienda di imballaggi deve inoltre considerare che interrompere i rapporti con certi fornitori (es. fornitore esclusivo di materiale di confezionamento personalizzato) potrebbe bloccare la produzione. Mantenere una comunicazione trasparente col fornitore strategico e magari offrirgli garanzie (pagamenti anticipati per nuove forniture, pegni su merci finite, ecc.) può convincerlo a non interrompere le forniture e a essere paziente sui crediti pregressi. In caso contrario, si rischia l’arresto dell’attività per mancanza di materiali.
Debiti bancari e finanziari: mutui, fidi e garanzie personali
Le banche e gli altri finanziatori (società di leasing, factor, ecc.) vantano spesso crediti rilevanti verso le imprese, garantiti da contratti scritti dettagliati e talora da garanzie reali o personali. Esempi tipici per la nostra azienda di imballaggi:
- Mutuo ipotecario sul capannone o sul laboratorio.
- Finanziamenti chirografari a medio termine per acquisto macchinari.
- Leasing di impianti o automezzi.
- Affidamento in conto corrente (fido per liquidità) o anticipo fatture (factoring).
- Fideiussioni personali dei soci/amministratori a garanzia di detti finanziamenti.
Le banche hanno contrattualmente il diritto, se l’azienda salta una o più rate o sconfina dal fido, di risolvere il contratto e chiedere immediatamente tutto il dovuto (clausole di decadenza dal beneficio del termine). Inoltre godono di cause di prelazione (ipoteche, pegni) e spesso di titoli esecutivi già pronti (es. la fideiussione notarile è titolo esecutivo, così come i contratti di leasing possono essere esecutivi).
Cosa può fare la banca e come difendersi:
- Recesso e risoluzione: Se l’azienda è in difficoltà, la prima mossa della banca può essere il recesso dagli affidamenti (revoca del fido in conto) o la risoluzione del mutuo (dopo un certo numero di rate impagate, es. due trimestrali consecutive). Ciò rende immediatamente esigibile tutto il credito residuo. Il debitore potrebbe trovarsi richiesto di restituire, ad esempio, l’intero mutuo ancora non scaduto o di rientrare di colpo dell’esposizione di conto.
Difesa: Mantenere un dialogo costante con la banca è essenziale. Appena emergono tensioni finanziarie, è opportuno informare la banca e cercare una rinegoziazione (ad es. chiedere una moratoria temporanea delle rate, o l’allungamento del piano di ammortamento per ridurre l’importo della singola rata). Dal 2020 sono state attivate varie moratorie bancarie emergenziali (Covid-19) e accordi ABI per sospendere le rate delle PMI; benché quelle misure straordinarie siano scadute, alcune banche offrono piani di ristrutturazione “privata” del debito per aziende in crisi temporanea. Far percepire alla banca che la crisi è gestibile e la continuità è possibile può indurla a evitare la revoca immediata (che spesso comporta per la banca stessa il rischio di maggiori perdite, dovendo svalutare il credito).
- Garanzie reali – Esecuzione ipotecaria o pignoramento di beni in leasing: Se c’è un’ipoteca su un immobile, la banca può avviare esecuzione immobiliare in caso di insolvenza: notifica precetto e pignoramento, iscrive l’immobile a ruolo d’asta. Analogamente, in un leasing la mancata paga di canoni consente alla società di leasing di risolvere il contratto, riprendere il bene (leasing = il bene è di proprietà del lessor fino all’eventuale riscatto) e chiedere i canoni scaduti + un indennizzo. La difesa qui è limitata: se l’insolvenza è conclamata, la banca può far valere i suoi diritti reali. Tuttavia, attenzione: nell’ambito di procedure concorsuali come il concordato, i crediti assistiti da ipoteca o pegno (creditori privilegiati) possono subire una dilazione forzosa o anche uno stralcio se il valore del bene è inferiore al credito (la parte eccedente diventa chirografa). Ad esempio, se la banca ha ipoteca per €500.000 su un immobile che in concordato viene valutato €300.000, la banca avrà credito privilegiato per 300k (da soddisfare preferibilmente con la vendita di quell’immobile) e 200k chirografo che potrebbe venire pagato in percentuale ridotta come gli altri unsecured. Fuori da procedure concorsuali, invece, la banca può procedere normalmente: l’imprenditore può solo tentare di bloccare la vendita* offrendo una soluzione (ad esempio vendere privatamente l’immobile a prezzo migliore e saldare la banca, o trovare un investitore).
- Garanzie personali – Fideiussioni: Molto spesso i soci o amministratori della SRL forniscono fideiussioni o altre garanzie personali per ottenere credito bancario. Ciò significa che, se la società non paga, la banca può aggredire direttamente il patrimonio personale del garante (casa, conti personali) senza dover attendere gli esiti sul patrimonio sociale. Anzi, solitamente la fideiussione prevede la solidarietà immediata: la banca può scegliere se chiedere a te (società) o al garante, o a entrambi. Dal lato difensivo, il garante potrebbe eccepire eventuali vizi del contratto di fideiussione – in passato, alcune fideiussioni bancarie “omnibus” sono state ritenute nulle perché conformi a schemi anticoncorrenziali censurati da Banca d’Italia (c.d. fideiussioni ABI, Cass. 41994/2021) – ma si tratta di eccezioni tecniche. In genere, se la fideiussione è valida, il garante paga. L’unica salvaguardia è che, se l’azienda accede a una procedura concorsuale, di solito la procedura sospende le azioni solo verso la società, non verso i fideiussori (i quali sono terzi). Ad esempio, se viene ammesso un concordato preventivo, i creditori non possono agire contro la società durante la procedura, ma sono liberi di escutere le fideiussioni dei soci. Quindi, dall’ottica del socio-garante, può essere opportuno parallelamente trovare un accordo personale con la banca (es. ipotecare un immobile personale in cambio di una moratoria, o chiedere il beneficio della divisione se più garanti, ecc.). Nota: se la società viene dichiarata in liquidazione giudiziale (ex fallimento), il fideiussore non beneficia della liberazione dei debiti; tuttavia, se poi paga la banca, egli subentra (surroga) nel credito verso la società e potrà insinuarsi al passivo fallimentare come creditore.
- Strumenti legali di difesa: Nel contenzioso bancario, l’azienda debitrice può verificare se sussistono elementi per contestare il quantum dovuto, ad esempio: interessi usurari o anatocistici, commissioni non dovute, vizi nel contratto. In alcune cause contro banche, le società eccepiscono che il tasso effettivo superava la soglia antiusura, o che il conteggio del piano di ammortamento alla francese porta interessi composti non leciti. Se c’è margine, aprire un contenzioso civile (o anche solo prospettarlo) può portare la banca a più miti consigli o a transigere (ad esempio rinunciando a interessi e moratorie pur di rientrare del capitale). Tuttavia, queste strategie “aggressive” vanno maneggiate con cura e supportate da perizie di calcolo serie: attaccare la banca senza base può irrigidire i rapporti e far precipitare la revoca dei fidi.
- Segnalazione in Centrale Rischi: Un aspetto collaterale ma importante: il mancato pagamento di debiti finanziari porta spesso alla segnalazione a “sofferenza” dell’azienda (e a volte del garante) nella Centrale Rischi di Banca d’Italia. Questo rende praticamente impossibile ottenere nuovo credito bancario. Difendersi su questo fronte significa, ove possibile, evitare la segnalazione (che di solito scatta quando il credito è deteriorato gravemente): mantenere contatti con la banca e cercare una ristrutturazione formalizzata del debito può evitare la classificazione a sofferenza (la banca potrebbe tenerlo come “incaglio” ristrutturato se c’è un accordo in corso). In caso di segnalazione già avvenuta, l’unico rimedio è sanare la posizione (pagare o ristrutturare) e attendere l’aggiornamento, oppure contestare giudizialmente la segnalazione se ritenuta illegittima (ad es. per mancanza dei presupposti di sofferenza).
Riassumendo, i debiti bancari richiedono spesso approcci combinati: legale (contrattare la ristrutturazione del debito, magari con l’aiuto di un professionista attestatore se si fa un piano ex art. 67/56 CCII), finanziario (cercare nuova finanza per sostituire il debito oneroso, ad esempio tramite un investitore o factoring di crediti, se ancora possibile), e patrimoniale (capire se è opportuno cedere beni per pagare le banche e mettere in sicurezza l’operatività dell’impresa). Una soluzione concordataria formale (es. concordato preventivo) spesso prevede classi specifiche di creditori finanziari e può ad esempio proporre di rimborsare le banche in misura maggiore rispetto ad altri chirografari, sfruttando la preferenza di trattamento per ottenere il loro supporto al piano.
Debiti verso dipendenti: tutele privilegiate e intervento del Fondo di garanzia
I debiti verso i dipendenti (retribuzioni arretrate, trattamento di fine rapporto, straordinari, ferie non pagate) rappresentano un aspetto critico non solo per le conseguenze legali, ma anche per l’impatto sociale e produttivo: lavoratori non pagati potrebbero astenersi dall’attività o abbandonare l’azienda, aggravando la crisi.
Dal punto di vista giuridico, i lavoratori subordinati godono di tutele rafforzate:
- Crediti privilegiati: I crediti di lavoro hanno privilegio generale mobiliare sui beni mobili del datore (art. 2751-bis c.c.) e in parte anche immobiliare (ultimi 3 mesi di retribuzione hanno privilegio speciale su immobili aziendali, art. 2776 c.c.). Inoltre, il TFR (trattamento di fine rapporto) gode di privilegio. In sede di fallimento o liquidazione giudiziale, questi crediti sono soddisfatti con priorità rispetto ai crediti chirografari (e anche rispetto a molti altri privilegi di grado inferiore).
- Azione rapida in giudizio: Il lavoratore può rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per retribuzioni non pagate (art. 633 c.1 n.1 CPC consente ingiunzione provvisoria se il credito è da lavoro dipendente). Oppure può procedere con ricorso al tribunale del lavoro: le cause di lavoro seguono un rito più celere e i provvedimenti di primo grado sono provvisoriamente esecutivi. Quindi un dipendente potrebbe ottenere nel giro di pochi mesi un titolo e pignorare il conto aziendale.
Difesa: L’azienda potrà opporsi se vi sono contestazioni (es. ore contestate, richieste non dovute), ma deve considerare che i giudizi di lavoro tendono a tutelare il dipendente e che comunque scattano sanzioni per ritardato pagamento (mora, rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.). Meglio evitare di arrivare al contenzioso: se possibile, è auspicabile trovare accordi transattivi individuali con i dipendenti (ad esempio dilazionare gli arretrati in più tranche, magari con l’intervento dei sindacati se presenti).
- Fondo di Garanzia INPS: Se l’azienda arriva all’insolvenza conclamata, i dipendenti hanno una rete di salvataggio: il Fondo di Garanzia dell’INPS, che interviene – in caso di fallimento o esecuzione infruttuosa – per pagare TFR e ultime tre mensilità ai lavoratori, surrogandosi poi nei loro crediti. Nel dettaglio: qualora l’azienda venga assoggettata a liquidazione giudiziale (fallimento) o altra procedura concorsuale, o anche chiusa senza attivo, il dipendente può richiedere al Fondo il pagamento del TFR maturato e non versato, nonché delle retribuzioni degli ultimi 3 mesi di lavoro precedenti la data di deposito del ricorso per fallimento (o precedenti la cessazione del rapporto). Il Fondo interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro e richiede che sia accertato il mancato pagamento (di solito tramite stato passivo della procedura o decreto del giudice delegato). Se la società non è fallibile (es. piccola impresa sotto soglia), il Fondo interviene comunque purché ci sia stata un’esecuzione individuale tentata e risultata infruttuosa (pignoramento negativo).
Implicazione: I dipendenti, sapendo di questo paracadute, potrebbero essere incentivati a chiedere il fallimento dell’azienda se non ricevono stipendi per molti mesi, al fine di attivare il Fondo. In effetti, la legge riconosce legittimazione a chiedere il fallimento anche ai lavoratori-creditori, e non solo ai fornitori o banche. Quindi una pluralità di dipendenti può depositare istanza di liquidazione giudiziale se credono che l’azienda sia insolvente. Per l’imprenditore, ciò è pericoloso: un fallimento avviato su istanza dei dipendenti comporta la perdita del controllo e potenziali responsabilità (si pensi a possibili azioni per irregolarità, o addirittura profili penali di bancarotta). È quindi cruciale gestire con tatto il rapporto coi lavoratori in fase di crisi, cercando di non accumulare troppi arretrati.
- Sanzioni e aspetti penali: Non pagare regolarmente gli stipendi può integrare violazioni amministrative (sanzioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro) e in casi estremi penali: ad esempio, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni, oltre la soglia di €10.000 annui, è un reato come visto; inoltre, il reiterato mancato pagamento di retribuzioni potrebbe, se accompagnato da altre condotte, configurare reati come estorsione (ci sono state teorie su imprenditori che non pagano per costringere i dipendenti a condizioni peggiorative) o configurare violazioni in materia di sicurezza sociale. In generale però, non esiste un reato di “omesso pagamento dello stipendio” in sé; il datore moroso risponde civilmente e con interessi, ma non va in carcere per questo specifico fatto (salvo situazioni particolari).
Come difendersi o gestire i debiti verso dipendenti:
- Trasparenza e accordi: È spesso preferibile coinvolgere i dipendenti nella conoscenza della situazione aziendale. Molte crisi vengono gestite con accordi sindacali di sospensione o rateizzazione delle retribuzioni (es. cassa integrazione guadagni straordinaria se c’è calo di lavoro, oppure accordi interni in cui i dipendenti accettano di posticipare una parte del salario in cambio della garanzia del posto di lavoro). Un dipendente informato è più propenso a collaborare; uno tenuto all’oscuro e non pagato cercherà subito tutela legale.
- Priorità ai dipendenti strategici: Se le risorse sono scarse, da un punto di vista pratico potrebbe convenire pagare almeno alcune mensilità ai dipendenti chiave per evitare fughe o cali di produttività. Ricordiamo che il privilegio copre le ultime 3 mensilità: pagare quelle più vecchie oltre i 3 mesi finali può a volte risultare meno prioritario (perché comunque quelle più remote non godono di privilegio speciale, anche se sempre prededucibili come crediti di massa se per periodo concorsuale). Tuttavia, considerazioni etiche e di clima aziendale suggeriscono di non fare preferenze arbitrarie. In caso di concordato, spesso si prevede di pagare integralmente i dipendenti (almeno i privilegiati) per ottenere il loro supporto morale e perché tanto andrebbero pagati comunque in prededuzione/privilegio.
- Utilizzo del Fondo Garanzia: In situazioni irreversibili, il datore può agevolare i dipendenti nell’accesso al Fondo di Garanzia, ad esempio cooperando con il curatore fallimentare fornendo i conteggi del TFR, o con gli avvocati dei lavoratori nel dichiarare l’insolvenza. Ciò può sembrare contro i propri interessi (perché si affretta il fallimento), ma talvolta, quando la prosecuzione è impossibile, accelerare la liquidazione nell’ambito di un concordato preventivo o fallimento consente ai dipendenti di essere pagati dal Fondo e magari essere riassorbiti in un’eventuale ramo d’azienda ceduto a terzi.
In conclusione, i crediti di lavoro hanno una posizione di privilegio tanto legale quanto “morale” nella crisi d’impresa. L’imprenditore dovrebbe considerarli prioritari nel piano di risanamento: un’azienda può forse sopravvivere con qualche fornitore non pagato (trovandone altri), ma non senza i propri lavoratori. E dal lato legale, i dipendenti hanno vari modi per difendersi che, se messi in atto, possono precipitare la crisi (esecuzioni sul conto, istanze di fallimento, denunce all’ispettorato). Prevenire è meglio che curare: meglio cercare soluzioni concordate con loro, o ricorrere a strumenti di sostegno del reddito (CIG) se disponibili, piuttosto che accumulare mensilità insolute senza prospettive.
(Schema riassuntivo – Tipologie di debiti e difese)
Per chiarire le differenze tra i vari debiti aziendali e le relative azioni/rimedi, si propone la seguente tabella riepilogativa:
Tabella 1 – Debiti aziendali: creditori, azioni tipiche e difese del debitore
| Categoria debito | Creditori & privilegi | Azioni tipiche del creditore | Strumenti di difesa per il debitore |
|---|---|---|---|
| Fiscali e contributivi | Erario (Agenzia Entrate), INPS, etc. – Privilegi generali e speciali su beni mobili/immobili; poteri esattoriali. | – Cartella esattoriale (titolo esecutivo dopo 60 gg)<br/>– Fermo auto, ipoteca, pignoramento diretto<br/>– Possibile insinuazione in fallimento come privilegiati<br/>– Denuncia penale se omessi versamenti oltre soglia | – Ricorso tributario (entro 60 gg) se il debito è contestabile<br/>– Rateizzazione piano ordinario (fino 84–120 rate) <br/>– Adesione a rottamazioni/condoni se disponibili <br/>– Transazione fiscale nel concordato/accordo <br/>– Richiesta misure protettive (stay) nel CCII per bloccare riscossione<br/>– Pagamenti entro termini penali per evitare reato (es. saldo IVA entro 31/12 anno succ.) |
| Fornitori (commerciali) | Aziende fornitrici – Crediti chirografari (no privilegi, salvo riserva proprietà su beni). | – Solleciti e messa in mora<br/>– Decreto ingiuntivo (40 gg per opporsi) <br/>– Pignoramento beni (dopo titolo esecutivo)<br/>– Possibile richiesta fallimento se credito > soglia insolvenza | – Negoziazione privata: piani di rientro dilazionati<br/>– Opposizione a D.I. entro 40 gg se contestazioni <br/>– Opposizione all’esecuzione per vizi o sospensione ex art. 624 cpc<br/>– Eventuale transazione con stralcio (es. saldo a stralcio del 50%)<br/>– Inclusione in accordi di ristrutturazione o concordato (pagamento parziale e moratoria legale) |
| Banche/finanziarie | Banche, leasing, factor – Spesso crediti privilegiati (ipoteche, pegni) + fideiussioni personali di soci. | – Revoca fidi / risoluzione contratti per inadempimento<br/>– Esecuzione su beni dati in garanzia (es. pignoramento immobile ipotecato)<br/>– Escussione immediata di fideiussori (anche persone fisiche)<br/>– Segnalazione a Centrale Rischi (sofferenza) | – Rinegoziazione del debito (allungamento piani, nuove garanzie)<br/>– Moratorie concordate (es. richiesta 6-12 mesi di sospensione rate)<br/>– Azioni legali su tassi/usura se fondato<br/>– Concordato preventivo: possibile cram-down su privilegiati e falcidia sulla parte chirografa<br/>– Patrimonializzazione: cedere asset per ridurre esposizione (evitando escussioni su resto)<br/>– Difesa fideiussore: eccezioni su clausole nulle, beneficio escussione se previsto |
| Dipendenti | Lavoratori subordinati – Crediti privilegiati (ultimi 3 mesi + TFR) in prededuzione in concorso; tutela Fondo INPS. | – Decreto ingiuntivo immediato o causa lavoro (titolo esecutivo rapido)<br/>– Pignoramento conto aziendale o vendite forzate beni<br/>– Denuncia ad ITL (ispettorato) per violazioni<br/>– Istanza di fallimento (lavoratori legittimati) | – Accordi individuali o sindacali per dilazionare pagamenti<br/>– Richiesta ed utilizzo ammortizzatori sociali (CIG) per stipendi futuri<br/>– Pagamento parziale dei più urgenti per evitare cause<br/>– Concordato: pagamento integrale privilegiati del lavoro (di regola) e utilizzo Fondo di Garanzia per TFR/ultimi stipendi<br/>– In caso di vertenza: tentare conciliazione in sede sindacale o ITL per ridurre vertenzialità |
(Legenda: CCII = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza; D.I. = Decreto Ingiuntivo; CIG = Cassa Integrazione Guadagni; ITL = Ispettorato Territoriale Lavoro)
Responsabilità dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori di fronte ai debiti
Una domanda cruciale per l’imprenditore indebitato è: “Fin dove rispondo io personalmente dei debiti aziendali?”. La risposta dipende dalla forma giuridica dell’impresa e dalla condotta tenuta dagli amministratori nella gestione. In questa sezione analizzeremo la responsabilità patrimoniale per debiti sociali nelle SRL (società di capitali) e nelle SNC (società di persone) – le due forme citate nel quesito – senza tralasciare cenni all’impresa individuale e ad altre figure (es. liquidatori).
Società a Responsabilità Limitata (SRL) – autonomia patrimoniale e casi di responsabilità personale
La SRL è caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta: per legge i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale dei debiti della società (art. 2462 c.c.). I creditori sociali possono aggredire solo i beni intestati alla società. In linea generale, dunque, il patrimonio dei soci è al sicuro dai crediti verso la SRL . Anche se la società finisce i beni, i creditori non possono chiedere ai soci di ripianare, salvo l’obbligo dei soci di versare eventuali quote sottoscritte e non ancora liberate (conferimenti non eseguiti).
Esempio: Alfa SRL ha 3 soci che hanno interamente versato il capitale di 30.000 €. Alfa ha debiti per 500.000 € con fornitori ma nessun attivo rimasto. I fornitori non possono rivolgersi ai soci per quei 500k; dovranno insinuarsi nell’eventuale fallimento e subiranno la perdita. I soci perderanno semmai quanto investito (la società azzererà il capitale), ma non dovranno integrare col proprio patrimonio la soddisfazione dei creditori.
Tuttavia, questa regola ha importanti eccezioni. Sia la legge fallimentare (ora codice della crisi) sia il codice civile prevedono situazioni in cui amministratori e talvolta soci di SRL possono essere chiamati a rispondere in proprio dei debiti sociali. Le principali sono:
- Responsabilità “per mala gestio” degli amministratori verso i creditori sociali – L’art. 2476 c.c., comma 6, stabilisce che gli amministratori di SRL rispondono verso i creditori sociali quando con il loro inerzia o atti di gestione hanno pregiudicato l’integrità del patrimonio sociale, rendendolo insufficiente a soddisfare i creditori . Si tratta, in sostanza, del parallelo dell’art. 2394 c.c. per le SPA. Se la società va in decozione e il patrimonio non copre i debiti, i creditori (o il curatore fallimentare in loro vece) possono agire contro gli amministratori dimostrando che una cattiva amministrazione ha aggravato il dissesto.
- Esempio tipico: l’amministratore ha continuato ad operare e contrarre debiti pur essendo a conoscenza che la società era insolvente (quindi ha ritardato il fallimento bruciando risorse residue); oppure ha pagato preferenzialmente alcuni creditori a danno di altri (violando la par condicio), o ancora ha distratto beni sociali. In tali casi, all’esito del fallimento, il curatore può promuovere un’azione di responsabilità chiedendo ai manager di risarcire il danno corrispondente al deficit creatosi verso i creditori.
- Fondamento: la norma impone agli amministratori doveri di conservazione del patrimonio e oggi anche di rilevazione tempestiva della crisi (ex art. 2086 c.c. riformato). L’art. 2476 c.c. si coordina infatti con l’art. 2086 secondo comma c.c., introdotto nel 2019, che obbliga gli amministratori a dotare la società di assetti adeguati per prevenire la crisi e la perdita di continuità. La violazione di tali obblighi può costituire colpa grave. Se da ciò deriva l’aggravarsi dei debiti al punto che i creditori non vengano pagati, ecco la responsabilità personale. In pratica: se l’amministratore non ha istituito controlli di gestione, non ha convocato i soci per ricapitalizzare perdite, ha ignorato gli early warning di crisi, potrà essere chiamato in causa.
- Limiti e attivazione: Questo tipo di responsabilità è di natura aquiliana (extracontrattuale) verso i creditori, e sorge solo in caso di insolvenza conclamata con insufficienza del patrimonio. Non è che ogni credito impagato generi automaticamente causa contro l’amministratore. Inoltre, l’azione individuale del singolo creditore è ammessa solo se il patrimonio è insufficiente e se il danno deriva dalla violazione di obblighi verso la società (non dal mero inadempimento contrattuale) . In pratica, nella maggior parte dei casi, sarà il curatore fallimentare (in rappresentanza di tutti i creditori) ad esercitare l’azione sociale e quella verso creditori ex artt. 2476 e 2486 c.c. (quest’ultimo riguarda la gestione dopo scioglimento). Se non c’è fallimento, un creditore potrebbe tentare di agire (ad esempio se la società è cancellata senza attivo), ma dovrà provare specifici inadempimenti dolosi/colposi degli amministratori.
- Giurisprudenza: La Cassazione ha più volte confermato questa responsabilità. Di recente (Cass. 23963/2025), ha ribadito che integra illecito ex art. 2476 l’aver compiuto pagamenti facendo prevalere un interesse extra-sociale in conflitto di interessi pregiudizievole per la società . In quel caso, l’amministratore aveva favorito un terzo legato a sé invece di tutelare la società, ed è stato ritenuto responsabile. Inoltre Cass. 8069/2024 ha chiarito che la business judgment rule (discrezionalità nelle scelte gestionali) non protegge l’amministratore quando le decisioni sono irragionevoli, imprudenti o in palese violazione di legge . Quindi, scelte gestionali scellerate (es. indebitare la società senza prospettive di rimborso, distribuire utili simulati, non accantonare tasse dovute) possono costare care a chi le ha prese.
- Responsabilità verso la società (azione sociale) – Oltre che verso i creditori, gli amministratori rispondono verso la società per i danni cagionati al patrimonio sociale (art. 2476 co. 1 e 3 c.c.). Questa è l’azione tipica esercitata dai soci o dal curatore, per far rifondere agli amministratori le perdite subite dalla società per atti di mala gestio (spese imprudenti, distrazioni, violazioni di legge). È indirettamente utile anche ai creditori, perché quanto recuperato entra nel patrimonio sociale e dunque va a vantaggio anche loro. Anche l’azione sociale può essere promossa dal curatore in caso di fallimento (art. 246 L.F. previgente, ora confluito negli artt. 147-148 CCII). Se l’azione ha successo, gli amministratori condannati devono versare l’importo del danno: tali somme saranno poi distribuite ai creditori; se però restano insufficienze ulteriori, si guarda al punto 1 per l’eventuale responsabilità residua.
- Obblighi in caso di capitale azzerato – responsabilità da continuazione abusiva – Se le perdite erodono il capitale oltre certi limiti (sotto il minimo legale o più di 1/3 senza reintegro), gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per ricapitalizzare o trasformare/liquidare la società (art. 2482-bis e ter c.c.). Continuare l’attività ignorando l’obbligo di scioglimento espone gli amministratori a responsabilità: la prosecuzione abusiva può essere considerata di per sé un atto colposo che aggrava il dissesto. Anche qui, in sede fallimentare, spesso si contesta agli amministratori la violazione di questi articoli, richiedendo il risarcimento del peggioramento del passivo avvenuto dopo il momento in cui la società avrebbe dovuto essere sciolta.
- Obblighi di legge specifici – Ci sono casi in cui leggi speciali pongono a carico degli amministratori o liquidatori certe responsabilità patrimoniali o sanzionatorie. Ad esempio, in materia fiscale: gli amministratori di società che non versano IVA o ritenute certificate non sono di per sé obbligati al pagamento (il debito resta della società), ma l’art. 239, co.2, DPR 602/1973 prevede che, in caso di accertata insufficienza del patrimonio sociale per pagare tributi dovuti, l’Agenzia delle Entrate possa agire contro gli amministratori o liquidatori se questi hanno colpevolmente aggravato l’insufficienza distribuendo attivi ai soci o non pagando le imposte preferendo altri debiti. Inoltre, normative come l’art. 2560 c.c. (cessionario d’azienda responsabile dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori) possono indirettamente coinvolgere gli amministratori in responsabilità se cedono asset senza far fronte ai debiti.
- Garanzie personali prestate dai soci o amministratori – Questo non è tanto una “responsabilità per legge”, ma una conseguenza volontaria: se un socio o amministratore fideiussiona un debito sociale, ovviamente ne risponderà con i suoi beni secondo il contratto. Nelle SRL è comune che la banca chieda fideiussione personale ai soci di riferimento. Tali garanzie sono valide e autonome rispetto alle vicende societarie: anche se la società fallisce e i soci non risponderebbero in generale, il fideiussore è tenuto per obbligo proprio verso la banca. (Abbiamo trattato sopra le possibili difese del fideiussore, come l’eccezione di nullità di clausole ABI standard, ma restano ipotesi limitate).
- “Piercing the corporate veil” – In giurisprudenza italiana esiste, in casi eccezionali, la possibilità di non applicare la limitazione di responsabilità se la personalità giuridica è stata abusata dal socio per fini illeciti. Ad esempio, se la SRL è solo uno schermo fittizio, usato per frodare i creditori (magari svuotando l’attivo e poi liquidandola), si può arrivare a ritenere il socio responsabile illimitatamente. Sono situazioni limite (fraudolent conveyance, sottocapitalizzazione iniziale dolosa, confusione patrimoni). Le Sezioni Unite n. 6070/2013 hanno affermato il principio che, dopo l’estinzione della società, i debiti insoddisfatti si trasferiscono ai soci (nei limiti di quanto riscosso col bilancio finale) , configurando un fenomeno successorio sui generis. In particolare, per le sanzioni tributarie la Cassazione (ord. 23341/2024 sez. trib.) ha stabilito che i soci rispondono anche delle multe fiscali della società estinta, entro il limite dell’attivo distribuito , superando la tesi che le sanzioni “muoiono” con la società per il carattere personale . Ciò a tutela dei creditori pubblici: se così non fosse, i soci beneficerebbero di una sorta di condono implicito delle sanzioni al momento della cancellazione . Quindi, chiudere la SRL non fa magicamente sparire i debiti: i creditori possono attivarsi contro i soci (pro quota o nei limiti di cosa hanno ricevuto). Nella pratica, se una SRL viene cancellata senza attivo, un creditore può tentare di dimostrare che i soci hanno avuto delle somme (es. restituzione di finanziamenti soci o riparto illecito) e chiederne la restituzione per pagare i debiti rimasti. Anche il liquidatore può essere chiamato in causa se ha distribuito attivo senza soddisfare tutti i creditori (art. 2495 c.c.).
Riassumendo per la SRL:
- I soci sono al riparo dai debiti sociali, salvo post-liquidazione nei limiti di quanto ricevuto, o salvo garanzie personali e casi di abuso.
- Gli amministratori invece possono subire azioni di responsabilità se hanno gestito male e ciò ha danneggiato i creditori. La “responsabilità limitata” non li protegge dalla cattiva gestione: in caso di insolvenza, rischiano di dover risarcire sui propri beni il deficit creato .
- Entrambi (soci e amministratori) possono inoltre incorrere in responsabilità penale per atti illeciti connessi ai debiti: ad esempio, amministratori per bancarotta fraudolenta se distraggono beni prima del fallimento (punibile con reclusione fino a 10 anni), o soci stessi se concorrono in tali atti (un socio che preleva indebitamente denaro sapendo dello stato di insolvenza può essere correo). Anche l’omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore (amministratore legale rappresentante) comporta contravvenzione penale.
Per completezza, il caso della SRL unipersonale: se la SRL ha un socio unico, valgono le stesse regole di limitata responsabilità, a patto che siano state rispettate le formalità (iscrizione dell’unipersonalità nel registro imprese, conferimento intero del capitale). Se il socio unico non versa integralmente il capitale sociale, può perdere la limitazione e rispondere delle obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità (art. 2462 c.c.). Anche la commistione di patrimoni (conto personale confuso con quello della società) può far arguire un abuso della personalità giuridica.
In conclusione, la SRL offre un buon scudo patrimoniale per i soci onesti e diligenti, ma non è una tana per furbi: l’ordinamento prevede rimedi per colpire chi la usi per frodare i creditori o amministri in modo colpevole.
Società in nome collettivo (SNC) – responsabilità illimitata e solidale dei soci
La SNC è una società di persone in cui vige il principio opposto: i soci rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti sociali (art. 2291 c.c.). Ciò significa che ogni socio di SNC è obbligato solidalmente per tutte le obbligazioni assunte dalla società. I creditori possono chiedere il pagamento dell’intero debito indifferentemente a qualsiasi socio, oltre che alla società.
- Beneficio di escussione: La legge prevede un unico temperamento (art. 2304 c.c.): il creditore sociale deve prima escutere il patrimonio della società e solo se questo è insufficiente può rifarsi sui soci. In pratica però, questa tutela è labile: sta al socio convenuto eccepire il beneficio indicando beni sociali liberi su cui soddisfarsi . Se la società è insolvente, il creditore può subito aggredire i soci. Ad esempio, se la SNC “Packaging Imballaggi SNC” non paga un fornitore, quest’ultimo può notificare decreto ingiuntivo sia alla società sia ai soci illimitatamente responsabili. Se il patrimonio sociale non basta (o è irreperibile), potrà pignorare i beni personali dei soci (case, auto, conti). Ogni socio risponde per l’intero (salvo poi il diritto di regresso tra i soci per riequilibrare in base alle quote, ma è affare interno).
- Soci nuovi e uscenti: Attenzione che nella SNC i soci entranti rispondono anche dei debiti pregressi della società (salvo patto contrario con i creditori che li liberino) e i soci uscenti restano responsabili per i debiti assunti fino al momento dell’uscita per un periodo di 5 anni dallo scioglimento del rapporto (art. 2290 c.c.). Quindi, se un socio lascia la SNC nel 2025, potrà ancora essere chiamato a pagare un debito sorto nel 2024, purché il creditore agisca entro il 2029.
- Escussione e fallimento: Se una SNC viene dichiarata fallita (oggi si direbbe in liquidazione giudiziale), automaticamente falliscono anche i soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F., ora trasfuso nel CCII). Ciò per il principio di confusione dei patrimoni: il socio è considerato un coobbligato solidale sempre, per cui la procedura concorsuale coinvolge tutte le masse attive (società + soci) e passive (creditori sociali, e personali). Un socio di SNC dunque rischia tutto il suo patrimonio in caso di dissesto della società.
Come difendersi come socio di SNC: Dato il regime di responsabilità, la difesa è soprattutto sul piano preventivo. Chi è socio di SNC deve essere consapevole di mettere a rischio i propri beni; pertanto:
- Attenzione alla gestione: I soci di SNC spesso sono anche amministratori (salvo patto diverso). Devono quindi gestire con prudenza per non indebitare eccessivamente la società. Se uno dei soci amministra male e la società non paga, i creditori verranno anche dagli altri soci: questi ultimi potranno rivalersi sul socio negligente, ma intanto hanno dovuto pagare di tasca loro.
- Patti interni: I soci possono stipulare patti interni di manleva (es. Tizio si accolla i debiti X, Caio i debiti Y), ma tali patti non vincolano i creditori terzi. Servono solo per regresso dopo aver pagato. Quindi, servono fino a un certo punto: se Caio ha pagato un debito che secondo i patti era a carico di Tizio, Caio può chiedere rimborso a Tizio, ma se Tizio è insolvente, Caio subisce la perdita.
- Trasformazione societaria: Una strada per “difendere” il patrimonio personale è valutare la trasformazione della SNC in SRL, acquistando così il beneficio della responsabilità limitata. Tuttavia, ciò non libera i soci dalle obbligazioni già esistenti prima della trasformazione (art. 2500-quinquies c.c. mantiene per 5 anni la responsabilità illimitata per il periodo pre-trasformazione). Inoltre, se la società è già in difficoltà grave, trasformare in SRL rischia di essere considerato un atto in frode ai creditori (specie se contestualmente i soci riducono i conferimenti). Potrebbe essere annullato o comunque i creditori continuerebbero a perseguire i soci.
- Procedure concorsuali minori: Una SNC, se di piccole dimensioni, potrebbe rientrare nelle procedure di sovraindebitamento (oggi “concordato minore” o “liquidazione controllata” per l’imprenditore minore, disciplinate dal CCII). Ad esempio, se Packaging SNC non supera i limiti di fallibilità (attivo €300k, debiti €500k ecc. – soglie indicate nel vecchio art. 1 L.F., di massima ora le procedure minori sono per debiti < €300k salvo eccezioni), non può essere soggetta a liquidazione giudiziale, ma i soci/imprenditori possono proporre un concordato minore in tribunale per evitare aggressioni dei creditori. Ciò comporta la presentazione di un piano di ristrutturazione con eventualmente esdebitazione finale (liberazione dai debiti residui una volta eseguiti i pagamenti promessi). Tali procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012, ora integrate nel CCII) offrono un fresh start ai debitori civili e piccoli imprenditori onesti ma sfortunati. Dunque un socio di SNC che chiude l’attività può aspirare all’esdebitazione personale (anche da debiti sociali) se rispetta le condizioni di legge e cede tutto il suo patrimonio ai creditori nella liquidazione.
- Rapporto con amministratori e terzi: Se un socio non amministratore scopre che l’amministratore sta accumulando troppi debiti, può revocarlo o recedere per salvarsi? Il recesso (uscita volontaria) da SNC libera il socio solo per i debiti futuri, come detto. La revoca dell’amministratore (se diverso dai soci) non cancella comunque i debiti già creati. Quindi l’attenzione deve essere costante. Nel caso in cui uno dei soci abbia provocato dolosamente il dissesto (magari ha frodato), gli altri soci dopo aver pagato i debiti potranno fargli causa per danni.
In sintesi sulla SNC: i soci sono praticamente garanti in solido di tutti i debiti. L’ordinamento rende quasi inevitabile che il loro patrimonio sia coinvolto in caso di insolvenza sociale. Non a caso, oggi molte imprese evitano la SNC a favore di SRL semplificate: la SNC ha senso tra persone di grande fiducia reciproca e con patrimonio bilanciato, perché ciascuno “mette in gioco la casa” dell’altro. In una crisi della SNC, la separazione tra patrimonio aziendale e personale è sottile, anzi inesistente giuridicamente. L’unica via di uscita dopo aver pagato i debiti è, qualora si arrivi a liquidazione concorsuale o controllata, chiedere l’esdebitazione a proprio nome: il CCII prevede che il socio illimitatamente responsabile, una volta liquidato tutto il suo patrimonio ai creditori, possa ottenere dal tribunale la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti (ex art. 282 CCII), purché non vi siano stati atti in frode o violazioni. Questa è una importante ancora di salvezza: significa che, dopo la rovina, il socio può ripartire da zero senza debiti (ma anche senza nulla, avendo liquidato tutto). Ciò incoraggia l’assunzione del rischio imprenditoriale pur in contesti di responsabilità illimitata, con la garanzia di un secondo tentativo per l’imprenditore onesto ma sfortunato.
Altre figure: liquidatori e soci di fatto, brevi cenni
- Liquidatore di SRL/SNC: Il liquidatore nominato in sede di scioglimento ha il dovere di pagare i debiti con l’attivo sociale e non può ripartire nulla tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori (art. 2491 c.c.). Se viola questo obbligo, risponde lui personalmente dei debiti non saldati entro i limiti di quanto indebitamente distribuito. La Cassazione (ord. 15580/2024) ha ad esempio ritenuto responsabile un liquidatore che aveva pagato i soci lasciando impagate imposte: deve pagare egli al Fisco il dovuto . Quindi il liquidatore è un soggetto a rischio se gestisce male la fase finale.
- Socio accomandatario di SAS: Nella società in accomandita semplice, i soci accomandatari hanno stessa responsabilità illimitata e gestionale dei soci SNC, mentre gli accomandanti sono limitatamente responsabili (però non amministrano). La SAS è un misto: accomandatario = come socio SNC, accomandante = come socio SRL (ma con più rischi se ingerisce amministrazione, perché perde la limitazione).
- Impresa individuale: Il titolare di ditta individuale non ha separazione patrimoniale: tutti i debiti d’impresa sono debiti personali dell’imprenditore. Può tuttavia proteggere alcuni beni con strumenti come il fondo patrimoniale (se i debiti non sono contratti per bisogni familiari però difficilmente opponibile per debiti d’impresa) o il trust. Ma in sostanza, se un artigiano con ditta individuale fallisce, fallisce come persona fisica e tutti i suoi beni (presenti e futuri, quest’ultimi per 4 anni dall’esdebitazione) rispondono. Anche per lui esiste l’esdebitazione post-fallimento (art. 283 CCII), se ha collaborato e non ci sono atti di frode.
- Amministratore di fatto: Attenzione che obblighi e responsabilità degli amministratori possono estendersi a chi, pur non avendo carica formale, di fatto dirige l’impresa. Ad esempio, se Tizio risulta semplice socio ma in realtà prende tutte le decisioni gestionali (amministratore di fatto), la giurisprudenza lo equipara all’amministratore di diritto per responsabilità civile e penale (es. reati fallimentari). Quindi “nascondersi dietro un prestanome” non evita rischi: i creditori/curatore potranno citare anche l’amministratore di fatto (basta provare che era lui a impartire ordini). L’ordine di pagamento preferenziale in conflitto di interessi di cui dicevamo prima (Cass. 23963/2025) riguardava ad esempio anche la figura dell’amministratore di fatto confliggente .
Tabella 2 – Differenze di responsabilità tra SRL e SNC (soci e amministratori)
| Profilo | SRL (soc. cap. – es. Packaging Srl) | SNC (soc. pers. – es. Packaging Snc) |
|---|---|---|
| Responsabilità soci | Limitata al conferimento (capitale sottoscritto). Soci non obbligati per i debiti sociali con patrimonio personale . Eccezioni: post liquidazione (fino a concorrenza attivo ricevuto) ; socio unico se capitale non versato; soci-garanti (fideiussioni). | Illimitata e solidale. Ogni socio risponde con tutti i suoi beni di tutte le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Creditori escutono prima società poi possono aggredire soci . Soci nuovi responsabili anche dei debiti pregressi; soci uscenti responsabili per 5 anni per debiti sorti prima dell’uscita. |
| Fallimento (liq. giudiziale) | La società fallisce, soci non falliscono (perché non obbligati). Soci perdono solo quanto investito, salvo dover coprire conferimenti mancanti. (Se soci garanti, banche possono farli fallire individualmente per escussione su grandi somme non pagate.) | Fallimento esteso ai soci: dichiarata insolvente la società, sono trascinati nella procedura anche tutti i soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F.). Il loro patrimonio personale entra nel fallimento. |
| Amministratori | Non rispondono di regola dei debiti con patrimonio proprio. Ma: rispondono se con atti o omissioni hanno pregiudicato il patrimonio sociale, ex art. 2476 c.c. ; azionabili dai creditori (a mezzo curatore) per danno da mala gestio. Inoltre perseguibili per reati tributari, societari, fallimentari in caso di condotte illecite. | Nella SNC spesso tutti i soci sono amministratori. La loro responsabilità verso i creditori è già intrinseca (illimitata). Possono però avere responsabilità ulteriori se commettono violazioni (ad es. amministratore che truffa i creditori > anche reato). Un socio amministratore che causa danni alla società può essere chiamato dagli altri a risponderne internamente. In fallimento, possibile azione di responsabilità del curatore verso di loro, ma spesso inutile perché il loro patrimonio è comunque già coinvolto totalmente. |
| Soci non amministratori | Non gestiscono, non rispondono di atti gestione. Possibile azione di responsabilità verso amministratori se hanno danneggiato società (soci SRL > art. 2476 c.3). Soci di SRL non ammessi a gestione se non amministratori, tranne poteri di controllo. | Soci di SNC hanno diritto di amministrazione disgiunta/scongiunta salvo patto. Soci non amministratori comunque illimitatamente responsabili per gli atti compiuti dagli altri. Possono recedere se contrari a operato, ma restano responsabili per pregresse. |
| Patrimoni separati | Patrimonio società distinto: beni della società sono preferiti ai creditori sociali. Beni personali soci intoccabili dai creditori sociali (tranne ipoteche volontarie, ecc.). In liquidazione, liquidatore paga prima creditori poi può distribuire residuo ai soci. | Nessuna separazione effettiva: creditori sociali possono colpire patrimonio sociale e personale (dopo escussione). Quindi i beni personali soci sono in pratica garanzia generale anche dei crediti sociali. Se un socio paga debito sociale, subentra nel credito verso società (regresso) ma se la società è vuota ciò è poco utile. |
| Esdebitazione (liberazione debiti residui) | La società una volta estinta cessa di esistere, non c’è esdebitazione perché non serve (società cancellata = debiti insoddisfatti non più esigibili se non verso soci nei limiti attivo ricevuto). Soci persone fisiche non falliti con la società mantengono eventuali debiti personali (es. garanzie). Possono semmai tentare procedure di sovraindebitamento personali se rimasti esposti. | I soci illimitatamente resp. possono chiedere esdebitazione a fine procedura concorsuale (art. 282 CCII), ottenendo la cancellazione dei debiti non pagati dal fallimento, salvo eccezioni di legge. Questo li libera dal circolo vizioso dei debiti a vita, offrendo loro fresh start (se hanno cooperato e non fraudato). |
(N.B: la tabella semplifica alcuni concetti; casi specifici possono divergere, es. SRL unipersonale con conferimento non versato comporta responsabilità socio, etc.)
Strumenti di composizione della crisi d’impresa e procedure concorsuali
Quando un’azienda è gravata da debiti insostenibili, anziché subire passivamente l’esecuzione disordinata da parte dei creditori (o peggio un fallimento giudiziale non pilotato), l’ordinamento offre una serie di procedure legalmente regolate per comporre la crisi in modo ordinato. Negli ultimi anni, complice anche l’attuazione di una direttiva UE, l’Italia ha riformato profondamente questi strumenti tramite il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche – in vigore dal 15 luglio 2022 (con ulteriori correzioni nel 2023-2024).
Le soluzioni si dividono in stragiudiziali (private o semi-private) e concorsuali giudiziali (sottoposte all’autorità del tribunale). La scelta dipende dalla gravità della crisi e dal grado di consenso dei creditori che si può ottenere.
Di seguito illustreremo i principali strumenti, in ordine crescente di complessità e coinvolgimento dell’autorità:
- Risanamento stragiudiziale: accordi privati con i creditori (piani di rientro informali) – non disciplinati dalla legge, ma possibili in ogni momento.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.) – accordo stragiudiziale con attestazione di un esperto indipendente, che gode di protezioni indirette di legge.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII, ex art. 182-bis L.F.) – accordo omologato dal tribunale che diventa efficace anche verso creditori dissenzienti entro certi limiti.
- Composizione negoziata della crisi (artt. 17-25 CCII) – procedura volontaria e confidenziale di negoziazione assistita da un esperto terzo, con possibili misure protettive e sbocchi in accordi o soluzioni varie.
- Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) – procedura concorsuale formale in tribunale, in cui l’imprenditore propone ai creditori un piano di ristrutturazione (in continuità o liquidatorio) soggetto a voto dei creditori e omologazione del giudice.
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII) – analogo al concordato ma riservato a piccoli imprenditori non fallibili e debitori civili sovraindebitati (sostituisce i vecchi accordi e piani del consumatore della L.3/2012).
- Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) – procedura concorsuale per sovraindebitati non fallibili, equivalente al fallimento ma per chi non può essere soggetto a liquidazione giudiziale.
- Liquidazione giudiziale (artt. 121-270 CCII) – la procedura concorsuale classica (ex fallimento) per imprese insolventi soggette a fallibilità, con spossessamento e nomina di un curatore che liquida il patrimonio e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi.
- Strumenti minori/ibridi: Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO, art. 64-bis CCII), accordi di ristrutturazione agevolati o ad efficacia estesa (artt. 61-64 CCII), concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) – introdotto nel 2021 per casi di composizione negoziata fallita – e liquidazione coatta amministrativa (per enti particolari come banche, cooperative, ecc., fuori dal CCII).
Vista la complessità, ci concentreremo sugli strumenti più rilevanti per una PMI come un’azienda di imballaggi, cioè piano attestato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato preventivo, e un accenno al concordato semplificato (novità recente).
Accordi stragiudiziali informali (negoziazione privata)
Prima di esaminare gli strumenti legali codificati, ricordiamo che nulla vieta all’impresa debitrice di tentare una trattativa privata con i propri creditori, fuori dalle procedure ufficiali. Ad esempio, l’imprenditore può convocare i principali creditori (es. fornitori maggiori, banca, fisco) e proporre un accordo di rientro globale: “Vi pago il 50% dei vostri crediti in 12 mesi, se tutti rinunciate al resto e non mi aggredite nel frattempo”. Se tutti i creditori accettano, l’accordo ha valore contrattuale e vincolante tra le parti.
Pro: massima riservatezza, flessibilità (si può offrire a ciascuno condizioni ad hoc), nessun costo procedura o oneri di pubblicità. Contro: serve consenso unanime dei creditori coinvolti – basta un dissenziente perché questi possa far saltare l’accordo (iniziando azioni esecutive vanificando lo sforzo collettivo). Inoltre, eventuali pagamenti in esecuzione di accordi stragiudiziali, se poi la società fallisce entro 2 anni, possono essere revocati dal curatore come atti preferenziali (a meno che rientrino nelle esenzioni di legge, come vedremo per i piani attestati) perché fatti “in pre-dissesto”.
Quindi, gli accordi puramente privati funzionano bene quando ci sono pochi creditori, tutti collaborativi. Spesso però nelle crisi più serie ci sono decine di creditori e interessi divergenti. Per questo il legislatore ha creato strumenti che permettono di coinvolgere anche i dissenzienti e dare stabilità agli accordi, proteggendo al contempo l’impresa (ad es. sospendendo le azioni esecutive durante le trattative).
Vediamoli in ordine di formalità crescente.
Piano attestato di risanamento (PAR) – art. 56 CCII
Cos’è: Il piano attestato di risanamento è un piano di risanamento aziendale predisposto dall’imprenditore in crisi (o insolvente reversibile) e asseverato da un professionista indipendente, finalizzato a ristrutturare l’indebitamento e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa, al di fuori delle procedure concorsuali . In parole semplici, è un accordo “privato” con i creditori basato però su un documento tecnico certificato da un esperto circa la sua fattibilità e veridicità dei dati. È disciplinato sommariamente dall’art. 56 CCII (che riprende il vecchio art. 67, co.3, lett. d) L.F.), il quale lo inserisce tra gli “strumenti di regolazione della crisi”.
Funzione: Incentivare soluzioni negoziali e rapide senza passare dal tribunale, dando però ai partecipanti alcune tutele legali. La principale tutela è in materia di azioni revocatorie fallimentari: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti a revocatoria in caso di successivo fallimento (art. 56 co.3 CCII) . Inoltre, il piano attestato (se pubblicato facoltativamente nel registro imprese) rende esenti da certe imposte le riduzioni di debito (sopravvenienze attive non imponibili, ex art. 88 TUIR) e consente la prededuzione di eventuali finanziamenti eseguiti secondo piano. Infine, atti di gestione compiuti in attuazione del piano attestato non costituiscono reato di bancarotta preferenziale o semplice (vengono considerati in bonis al momento, se l’azienda poi fallisse ma aveva un piano ragionevole all’epoca) .
Requisiti: Il piano deve avere un contenuto minimo indicato dalla norma e sviluppato dalla prassi: descrivere la situazione di partenza, le cause della crisi, le strategie di rilancio, le risorse finanziarie apportate, la tempistica di pagamento dei debiti e in che misura verranno soddisfatti i creditori. Deve essere “idoneo a risanare” l’impresa. L’attestatore (un professionista indipendente iscritto all’albo dei revisori, con requisiti di indipendenza analoghi a quelli del commissario giudiziale) redige una relazione di attestazione in cui dichiara che i dati aziendali sono veritieri e il piano è fattibile e atto a superare la crisi .
Procedura: Non c’è una procedura formale. L’imprenditore propone ai creditori delle modifiche ai termini originari dei crediti (allungamenti, riduzioni, conversioni in capitale, ecc.) presentando il piano di risanamento. I creditori decidono liberamente se aderire o meno. Non serve unanimità totale: il piano può coinvolgere anche solo alcuni creditori rilevanti (es. solo le banche), mentre altri vengono pagati normalmente. Chi non aderisce rimane estraneo: i suoi diritti restano invariati (non è crammato down dal piano). Infatti il piano attestato non ha effetti coercitivi sui dissenzienti. Questo è un limite, ma anche una sua caratteristica di flessibilità.
Quando usarlo: È indicato se l’impresa in crisi ha un numero limitato di creditori cruciali con cui può trovare intesa relativamente agevole. Ad esempio, caso pratico: la nostra azienda di imballaggi ha principalmente un grosso debito con la banca (€500k di mutui) e con 2 fornitori strategici (€200k), mentre ha una miriade di altri debiti minori che però riesce a pagare. Potrebbe elaborare un piano con l’aiuto di un advisor in cui, ad esempio, un nuovo investitore apporta €100k di equity fresco, la banca accetta di rinunciare a €100k di interessi e di spostare le rate finali, i due fornitori accettano un pagamento del 80% in 24 mesi, in cambio l’azienda riduce costi e ottiene marginalità future. Un esperto attesta che il piano è realistico e sufficiente a riportare l’equilibrio. Banca e fornitori firmano accordi bilaterali attuando il piano. Gli altri creditori (es. Fisco e altri fornitori minori) vengono pagati normalmente alle scadenze, quindi non sono toccati. Il piano in questo modo salva l’azienda privatamente. Se per disgrazia due anni dopo la società fallisse, quei pagamenti alla banca e fornitori secondo piano (es. pagato 80% stralciando 20%) non potranno essere revocati perché effettuati in esecuzione di un piano attestato regolarmente formato .
Differenze rispetto ad altre procedure: Il piano attestato è unilaterale (lo elabora il debitore) e i contratti di attuazione sono privati (accordi transattivi, novazioni, rinegoziazioni con singoli creditori). Non c’è omologazione né coinvolgimento del tribunale. Non c’è voto dei creditori o maggioranze: serve l’accordo individuale di ciascun creditore coinvolto (nessuna imposizione ai dissenzienti) . Questo lo distingue dal concordato (che è giudiziale e con voto a maggioranza) e dall’accordo di ristrutturazione (che ha omologa e efficacia limitata sui non aderenti). In termini di costi e tempi: il piano attestato può essere realizzato in modo molto rapido (bastano poche settimane per predisporre il piano e farlo asseverare, poi la firma degli accordi). Non si paga il contributo unificato, non si nomina alcun commissario. Tuttavia i costi professionali possono essere comunque significativi (consulenti finanziari, attestatore, legali per predisporre contratti). Ma in genere inferiori a un concordato.
Punti critici:
- Nessuna protezione diretta dalle azioni individuali: Diversamente dalle procedure che vedremo, il piano attestato non sospende i creditori. Se un creditore estraneo volesse comunque pignorare, può farlo. L’imprenditore deve quindi stare al gioco di far aderire quelli pericolosi o comunque trovare intese di standstill (moratorie contrattuali). Per ovviare, a volte lo strumento è usato in parallelo con una composizione negoziata o con accordi per moratorie temporanee.
- Niente transazione fiscale formale: L’Erario e gli enti previdenziali non possono aderire ad uno stralcio formale nel piano attestato, perché la legge permette a Agenzia Entrate di rinunciare a parti di credito solo in concordati o accordi omologati . Ciò significa che se il debitore ha molti debiti fiscali, il piano attestato puro potrebbe non bastare: dovrà comunque pagarli integralmente o utilizzare una rottamazione. Spesso si fa un mix: piano attestato per banche/fornitori e, contestualmente, si chiede rateazione dei tributi (che è compatibile).
- Stabilità: Se il piano attestato fallisce (cioè l’azienda non riesce comunque a risanarsi), si ritorna al punto di partenza, senza aver vincolato tutti i creditori. Ad esempio, i creditori estranei che son rimasti in attesa potrebbero essere avvantaggiati perché i sacrifici li hanno fatti solo quelli aderenti. Per questo, di solito si cerca di includere nel piano almeno tutti i principali creditori. Se ce n’è uno significativo che rifiuta, forse occorre passare a uno strumento più coercitivo (accordo di ristrutturazione o concordato).
Novità 2024: Il correttivo al CCII (D.Lgs. 136/2024) ha apportato alcune migliorie procedurali. Ad esempio, ha previsto la possibilità di pubblicare il piano attestato nel registro delle imprese (che già c’era) estendendo alcuni effetti fiscali: le riduzioni di debito ottenute col piano non sono tassate come sopravvenienze, e le perdite generate dalla ristrutturazione (crediti inesigibili, beni dismessi) sono deducibili , equiparando il trattamento fiscale a quello del concordato. Inoltre, se il piano attestato avviene all’esito di una composizione negoziata, gli interessi sui debiti tributari pregressi sono dimezzati e si può avere fino a 120 rate per pagare i tributi, come visto .
Conclusione: il piano attestato è uno strumento snello e confidenziale per imprese che hanno prospettive di recupero e vogliono evitare la pubblicità di un concordato. Richiede però che i creditori chiave siano collaborativi. Per l’imprenditore debitore, è spesso il primo tentativo di risanamento: “Vediamo se, con un buon piano e una relazione di un esperto che dà fiducia ai creditori, riusciamo a sistemare la situazione fuori dal tribunale”. Se funziona, ottimo; se non funziona, sarà comunque servito a preparare il terreno per eventuali procedure più invasive (spesso il materiale del piano attestato si riutilizza per il concordato, se necessario).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) – art. 57 e segg. CCII
Cosa sono: Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) sono accordi negoziati con i creditori che, una volta raggiunti, vengono sottoposti all’omologazione del tribunale e diventano efficaci secondo le condizioni pattuite. Sono uno strumento semi-concorsuale: c’è un intervento del giudice per dare stabilità e alcuni effetti protettivi, ma la trattativa resta privata e basata sul consenso di una parte significativa dei creditori.
Requisito di consenso: Servono accordi con almeno il 60% dei creditori (per valore) . Questo implica che il debitore deve convincere una maggioranza qualificata a firmare l’accordo. I creditori non aderenti restano estranei (devono essere pagati integralmente, altrimenti non sono vincolati dall’accordo) , salvo eccezioni per categorie omogenee come spiegheremo.
Procedura: Il debitore deposita in tribunale l’accordo sottoscritto con i creditori aderenti, corredato da documentazione contabile, un piano industriale e la relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità e sull’integrale pagamento dei creditori estranei . Il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes verso i soli aderenti (i non aderenti rimangono con le loro pretese invariate, ma come detto devono essere previsti pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza ). Durante la fase di negoziazione e fino all’omologa il debitore può chiedere misure protettive (stay) fino a 6 mesi , simili a quelle del concordato.
Effetti: L’accordo omologato non ha votazione dei creditori come nel concordato, perché i consensi sono già raccolti privatamente. Ma l’omologazione serve a: – rendere inoppugnabile l’accordo da parte di aderenti e terzi (un creditore aderente non può tirarsi indietro dopo l’omologa, salvo clausole). – conferire titolo esecutivo all’accordo (se il debitore poi non adempie, i creditori aderenti possono eseguire forzatamente nei limiti dell’accordo). – dare protezione da revocatorie: i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione dell’accordo omologato non sono revocabili in un successivo fallimento (art. 59 CCII). – consentire la prededuzione (priorità di pagamento in caso di successivo fallimento) ai nuovi finanziamenti erogati in funzione dell’accordo se previsti e autorizzati dal tribunale.
Creditori estranei: Punto delicato – i creditori che non firmano devono, per legge, essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (se già scaduti) o dalla scadenza naturale (se successiva) . L’attestatore deve certificare che l’accordo consente queste integrali soddisfazioni. Questo vincolo spesso limita l’utilità: significa che non si può toccare il 40% non aderente se non con pagamento cash. Tuttavia, il CCII prevede possibili deroghe (“efficacia estesa”): – Se tra i creditori aderenti ci sono banche o finanziatori rappresentanti almeno il 75% dei crediti finanziari, l’accordo può chiedere al tribunale di estenderne gli effetti anche alle banche dissenzienti minoritarie (art. 61 CCII): è il c.d. cram-down settoriale. Questo evita che 1-2 banche su 10 fuori accordo facciano saltare tutto: se il 75% del sistema bancario è d’accordo, il 25% restante viene tirato dentro dall’omologazione, anche se non voleva (purché abbiano possibilità simili di recupero). – Con la riforma 2024, è stato introdotto il “accordo ad efficacia estesa” al 60%: se l’accordo è depositato subito dopo una composizione negoziata fallita, la soglia per estendere ai dissenzienti finanziari scende al 60% , incoraggiando l’uso rapido dopo trattative esperte.
Inoltre esiste una variante, l’accordo agevolato, con soglia ridotta al 30% ma solo se tutti i creditori estranei vengono comunque pagati entro 120 giorni dall’omologa senza necessità di attestare integrale pagamento (questo perché in teoria i grandi numeri ridotti indicano che quasi tutti sono dentro).
Differenze da piano attestato: – Maggioranza vs unanimità: L’ADR consente di procedere senza il consenso di tutti, bastando il 60%. Il piano attestato richiede di fatto l’ok di ciascun creditore coinvolto . – Intervento del tribunale: Nell’ADR c’è un giudice che omologa e controlla la regolarità e idoneità dell’accordo, compresa la verifica che i creditori estranei vengano pagati per legge . Questo controllo giudiziale rende l’accordo più solido (non impugnabile facilmente) . Il piano attestato invece resta un insieme di contratti privati che, volendo, un terzo potrebbe attaccare (anche se difficile se tutti sono consenzienti). – Misure protettive: come detto, con l’ADR si può ottenere dal tribunale un blocco delle azioni esecutive fino a 4-6 mesi , cosa che col piano attestato non è prevista (a meno di passare via composizione negoziata con misure cautelari specifiche). – Trattamento dei creditori pubblici: nell’ADR si può includere una transazione fiscale/contributiva (art. 63 CCII) per tagliare una parte di debiti fiscali e contributivi con l’adesione formale dell’ente , che poi viene omologata dal giudice. Nel piano attestato ciò non è fattibile perché difetterebbe il crisma legale (di norma AdE non firma riduzioni se non in contesto ADR o concordato). – Costi e tempi: L’ADR è più costoso e lento del piano attestato: serve depositare in tribunale, attendere i termini per eventuali opposizioni di creditori estranei (15-30 giorni) e l’udienza di omologa. Dura qualche mese mediamente (6-9 mesi in casi complessi, come segnalato da pratiche) . Ha costi di giustizia e possibili spese per eventuali ausiliari nominati dal giudice (a volte il tribunale nomina un esperto per verificare l’accordo, soprattutto se ci sono creditori dissenzienti che fanno opposizione). Il piano attestato può chiudersi in 1 mese, l’ADR raramente prima di 4-5 mesi. – Ambito soggettivo: L’ADR “ordinario” (non quello minore) è destinato a imprese soggette a fallimento (quindi con dimensioni non micro). I piccoli imprenditori non fallibili avevano la versione di accordo di composizione nella L.3/2012 (ora superata dal concordato minore). Quindi, se la nostra azienda di imballaggi è una microimpresa non fallibile, non può fare un ADR ex art.57, ma userà il concordato minore (che richiede il 10% di assenso o nessuno se liquidazione).
Quando conviene l’ADR: Se il nodo sono pochi creditori recalcitranti ma la maggioranza è d’accordo. Esempio: l’imprenditore ha 10 banche finanziatrici. 7 accettano un piano di ristrutturazione (rollover del debito), 3 no. Senza procedura, quelle 3 farebbero saltare tutto. Con un ADR, se le 7 rappresentano >60-75% del credito finanziario, il tribunale potrà omologare l’accordo vincolando anche le 3 dissenzienti . Altro caso: l’impresa ha troppi creditori per far firmare a tutti un piano attestato, ma vuole evitare un lungo concordato con classi e voto. Se però può garantirne il pagamento integrale di un pezzo (quelli estranei), l’ADR è un buon compromesso: si ristruttura il debito della parte principale con accordi (banca, grandi fornitori) e si pagano i piccoli per intero a scadenza (magari grazie al risparmio ottenuto con lo stralcio sui grandi). Così non serve fare votare decine di creditori.
Limiti: Un ADR non risolve problemi di insolvenza profonda in cui non c’è liquidità per i creditori estranei. In quei casi serve il concordato, dove anche gli estranei possono subire falcidia con le classi e i voti. L’ADR è quindi più adatto a crisi di liquidità o sovraindebitamento relativo, dove si può convincere la maggioranza e intanto onorare i restanti.
Esempio pratico: Packaging Srl ha debiti totali per 1 milione. 600k verso 5 banche, 200k verso 10 fornitori, 200k debiti vari minori (Fisco 50, leasing 50, piccoli fornitori 100). L’azienda non regge il piano di rimborso originario, ma può offrire (con attestazione): pagare 80% alle banche (480k) in 5 anni, 60% ai 10 fornitori (120k) in 2 anni, e pagare integralmente i 200k di vari minori alle scadenze (perché magari molti sono privilegiati come Fisco e leasing, o piccoli che preferisce non toccare). Banche e fornitori maggiori rappresentano 800k su 1M => 80%. Supponiamo che aderisca l’80% in valore (diciamo tutte le banche 600 e metà fornitori 60 su 200, per tot 660k, qui sarebbe 66% > 60% soglia). L’accordo viene presentato con questi numeri, il giudice omologa, e quell’80% di crediti viene ridotto secondo patti (banche prendono 480 su 600, fornitori aderenti 72 su 120, tot risparmio ~168k). I creditori estranei (quelli minoritari che non hanno aderito, e i piccoli che comunque avevano 200k) li paga come da origine (200k integrale più i fornitori non aderenti – supponiamo 8 fornitori su 10 hanno aderito e 2 no: quei 2 vanno pagati integrali 40k). L’attestatore ha certificato che i flussi permettono di pagare questi estranei. L’azienda respirerà per il taglio ottenuto e dilazione su 660k di debiti. L’accordo omologato impedisce a creditori aderenti e finanziatori in generale di iniziare o proseguire esecuzioni (grazie allo stay e poi all’impegno contrattuale omologato). Così l’impresa prosegue.
Accordo di ristrutturazione con riserva e agevolato: Il CCII consente di depositare una “riserva” similmente al concordato in bianco (art. 60 CCII) per bloccare azioni e avere tempo di negoziare l’accordo (massimo 8 mesi). Inoltre c’è la figura dell’accordo agevolato ex art. 61: se i creditori estranei sono al massimo il 25% del totale, il tribunale può omologare l’accordo anche con soli il 30% di consensi, purché estranei siano pagati entro 30 gg dall’omologa (una variante per casi in cui quasi tutti aderiscono, soglia ridotta per facilitare).
Confronto (Piano attestato vs ADR vs Concordato) in Tabella 3:
| Caratteristica | Piano attestato (art. 56) | Accordo ristrutturazione (art. 57) | Concordato preventivo (art. 84+) |
|---|---|---|---|
| Approvazione creditori | Consenso individuale di tutti i coinvolti (nessuna maggioranza; chi non firma rimane fuori con diritto intatto) . | Consenso di almeno 60% dei crediti totali (75% per efficacia estesa su banche dissenzienti) . Non aderenti: da pagare integralmente (120 gg) salvo transazioni fiscali . | Approvazione per classi e maggioranze: >50% dei crediti votanti in ogni classe (e altre regole di maggioranza). I dissenzienti sono vincolati se maggioranza approva (cram-down possibile su classi dissenzienti con condizioni). Tutti i creditori chirografari possono essere falcidiati secondo par condicio. Privilegiati possono subire decurtazione se incapienza garanzia o se accettano in classe. |
| Ruolo del Tribunale | Nessuno (strumento contrattuale puro, salvo eventuale pubblicazione registro imprese) . | Omologazione da parte del tribunale senza voto (controllo legalità, fattibilità, pagamento estranei) . Possibile opposizione di creditori estranei se pregiudicati. | Procedura giudiziaria piena: ammissione, eventuale commissario, voto dei creditori, omologa finale con giudizio di merito su convenienza e legalità. |
| Misure protettive (automatic stay) | Non previste specificamente. Possibile chiederle in composizione negoziata propedeutica o accordi standstill contrattuali. | Sì, fino 6 mesi su istanza (art. 54 CCII rinvia ad art. 55): sospensione azioni esecutive cautelari dei creditori durante trattativa e omologa . | Sì, automatiche dopo ricorso (art. 54 CCII): divieto azioni e scioglimento contratti in corso salvo autorizzati. Protezione di 120 gg prorogabile. |
| Efficacia sui creditori dissenzienti | Nessuna efficacia. Dissenziente non firmatario = resta con pieni diritti (può agire per intero). Piano deve prevedere pagamento integrale a chi non partecipa, altrimenti rischi. | Dissenzienti estranei: non toccati da riduzioni (devono essere pagati per intero nei termini di legge) . Tuttavia, se soddisfatte condizioni, banche dissenzienti sono obbligate alle stesse condizioni della maggioranza (efficacia estesa) . Fisco/INPS possono essere falcidiati se hanno aderito (transazione fiscale). | Vincola tutti i creditori anteriori (anche chi vota no o non vota), secondo quanto previsto nel piano omologato. I dissenzienti subiscono le eventuali falcidie approvate a maggioranza purché il piano rispetti la regola del miglior soddisfacimento rispetto a liquidazione (best interest test) e par condicio. Creditori privilegiati dissenzienti vanno pagati almeno quanto ricaverebbero da liquidazione su quella garanzia, altrimenti niente omologa forzata su di loro. |
| Continuazione azienda | Totalmente possibile: è uno strumento pro-concordato in bonis. Durante e dopo il piano l’impresa opera normalmente (nessuno spossessamento). | Idem: l’impresa mantiene piena gestione (solo se chieste misure protettive, ci può essere limitazione su straordinaria amministrazione). Mantenimento attività tipicamente previsto, salvo sia un accordo liquidatorio (raro). | Due tipi: concordato in continuità (azienda prosegue attività durante e dopo, anche vendendo ramo d’azienda a terzo) vs concordato liquidatorio (cessazione attività, liquidazione beni). Nel concordato in continuità l’imprenditore rimane in carica ma con vigilanza del commissario; nel liquidatorio generalmente c’è un commissario-liquidatore post omologa. |
| Vantaggi | – Riservato (nessuna pubblicità ufficiale obbligatoria, a parte eventuale registro imprese per esenzione revocatoria) .<br/>– Flessibile (adattabile a singoli creditori).<br/>– Rapido (nessun iter giudiziario, salvo tempi negoziali).<br/>– Protetto da revocatorie (atti esecutivi del piano esenti) .<br/>– Nessuna “etichetta” di insolvenza (azienda rimane “in bonis” formalmente). | – Coinvolge anche banche dissenzienti se maggioranza forte (evita veto minoranze) .<br/>– Sospende le azioni (respiro temporaneo) .<br/>– Stabilità legale: accordo omologato = titolo esecutivo e certezza.<br/>– Transazione fiscale possibile (taglio debiti fiscali con omologa) .<br/>– Atti protetti da revocatoria come nel concordato.<br/>– Meno costoso/complicato del concordato (no votazioni, no classi, iter più snello). | – Cram down generale: può imporre tagli anche a dissenzienti di qualsiasi tipo (non serve pagare tutti integrali).<br/>– Possibilità di ristrutturazione profonda: anche modifiche ai diritti dei privilegiati (se accettano o incapienza) e ai contratti in corso (es. scioglimento/revisione contratti onerosi su autorizzazione).<br/>– Esdebitazione finale dell’imprenditore individuale e soci illimitati, se persone fisiche, una volta eseguito.<br/>– Eventualmente cessione dell’azienda “pulita” a terzi via concordato (spesso formula di salvaguardia occupazionale).<br/>– Commissario e giudice assicurano controllo di legalità e correttezza, aumentando fiducia dei creditori. |
| Svantaggi | – Richiede consenso totale dei coinvolti (basta un rifiuto per segmentare fuori quel creditore).<br/>– Nessun blocco legale: un creditore estraneo può rovinare il piano agendo esecutivamente.<br/>– Non cravatta creditori pubblici su stralci formalizzati (devono comunque ricevere full o aderire informalmente con strumenti paralleli come rottamazione).<br/>– Successo dipende molto dalla buona volontà creditori. | – Necessita 60% adesione: se non si raggiunge, fallisce (non c’è cram generale come concordato).<br/>– Creditori estranei vanno comunque soddisfatti al 100% (impegno finanziario elevato) , il che limita casi d’uso a crisi non eccessive.<br/>– Procedimento giudiziale comporta costi, possibili opposizioni che allungano i tempi.<br/>– Pubblicità nel RI dell’accordo omologato: comunque diventa un fatto noto che l’azienda ha ristrutturato debiti (potenziale stigma).<br/>– Se i numeri cambiano, non c’è moratoria post omologa come nel concordato (dove eventuali piccoli scostamenti possono essere gestiti in esecuzione). Occorrerebbe rifare un nuovo accordo. | – Procedura più lunga e complessa: formalità, adempimenti, spese (contributo unificato, compenso commissario, eventuali advisor per classi, assemblee di voto).<br/>– Pubblicità e impatto reputazionale notevole (iscrizione presso Registro Imprese, notizia di pubblico dominio di stato crisi).<br/>– Perdita (anche se temporanea) di autonomia: attività gestoria sotto osservazione, atti straordinari richiedono autorizzazione del giudice/commissario.<br/>– Esiti incerti: serve approvazione di classi di creditori, possibili esito negativo se non si raggiungono maggioranze.<br/>– In continuità: difficile ottenere finanza esterna senza garanzie dello Stato (a differenza di strumenti emergenziali tipo composizione negoziata che prevede esoneri responsabilità per finanziatori in alcuni casi). |
(Legenda: RI = Registro delle Imprese; cram down = imposizione coattiva ai dissenzienti)
Come si vede, ognuno strumento ha un suo spazio. Nel nostro caso (azienda di medie dimensioni in difficoltà) si potrebbe percorrere questa “scala”: provare prima un piano attestato informale; se manca l’adesione di qualcuno importante, salire a un accordo di ristrutturazione; se ancora non basta (perché troppi dissensi o serve falcidiare anche chi non è d’accordo), passare al concordato preventivo.
Composizione negoziata della crisi – D.L. 118/2021 e art. 17-25 CCII
La composizione negoziata è un meccanismo introdotto di recente (prima col D.L. 118/2021, poi integrato nel CCII) per favorire l’emersione anticipata della crisi e il risanamento extragiudiziale assistito. Non è esattamente una procedura concorsuale, ma un percorso volontario in cui l’imprenditore, riconoscendo di trovarsi in squilibrio economico-finanziario che può evolvere in crisi o insolvenza, chiede aiuto a un esperto indipendente per negoziare con i creditori una soluzione .
Caratteristiche chiave:
- Accessibilità: Possono accedere imprese di qualsiasi dimensione (anche “sotto soglia” e agricole) , purché ci sia uno squilibrio patrimoniale o economico tale da rendere probabile la crisi o insolvenza (non è necessario essere già insolventi) . Quindi è uno strumento di allerta e intervento precoce. Non ci sono limiti legali su chi può attivarla: anche SRL piccolissime o ditte individuali possono, in teoria.
- Avvio: L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica (gestita dalle Camere di Commercio) fornendo i dati aziendali, bilanci, lista creditori, ecc. Se la piattaforma calcola alcuni indici di allerta oltre soglia, la camera di commercio nomina un Esperto indipendente (scelto da un elenco nazionale di professionisti con esperienza), entro 2 giorni dal decreto dirigenziale che accoglie l’istanza.
- Fase negoziale confidenziale: L’esperto nominato convoca l’imprenditore e analizza la situazione (ha 180 giorni prorogabili di 90). Incontri periodici con l’imprenditore e i creditori rilevanti vengono fissati per esplorare soluzioni (ristrutturazione del debito, accordi, nuove finanze, cessioni asset, ecc.) . Tutto avviene in modo riservato: l’apertura della composizione negoziata non è pubblica (salvo se si chiedono misure protettive al tribunale, allora viene iscritta al RI la concessione delle misure).
- Poteri dell’esperto: Non ha poteri coercitivi, né amministrazione dell’impresa. È un facilitatore: aiuta a far sedere le parti e a trovare un accordo. Redige minute degli incontri, sollecita proposte e contropiano dei creditori. Può proporre egli stesso soluzioni se l’imprenditore indugia (correttivo 2024 chiarisce che soluzioni possono maturare anche dopo la chiusura formale delle trattative, con firma postuma dell’esperto su accordi tardivi) . Se l’esperto rileva atti di frode o mancanza di prospettive concrete, può decidere di porre fine alla procedura.
- Misure protettive e cautelari: L’imprenditore può chiedere al tribunale di sospendere per la durata delle trattative le azioni esecutive e cautelari dei creditori (come nel concordato preventivo) – tipicamente per 4 mesi rinnovabili fino a 12 . Il tribunale concede queste misure se ritiene che le trattative abbiano possibilità di buon esito e che la sospensione non danneggi eccessivamente i creditori. Durante la composizione negoziata con misure, i creditori non possono acquisire prelazioni se non concordate, e i contratti essenziali (fornitura energia, ecc.) non possono essere interrotti per debiti pregressi. Si può anche chiedere al giudice autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (che verranno con precedenza in un eventuale fallimento successivo) per sostenere l’attività in crisi.
- Esito: Se le trattative hanno successo, possono concludersi con vari esiti (art. 23 CCII):
- Un contratto con uno o più creditori (anche investimento di terzi, modifica condizioni debiti, ecc.) ,
- un accordo di ristrutturazione ex art. 57 (omologato) ,
- un piano attestato ex art. 56,
- un concordato preventivo (l’esperto può a un certo punto dire: “serve un concordato”, e l’imprenditore deposita ricorso per concordato anche semplificato).
- Oppure, se non c’è soluzione di risanamento, l’imprenditore può optare per la liquidazione: a tal fine il D.L.118 ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) come sbocco per liquidare i beni in modo ordinato anche senza passare per voti dei creditori.
Se invece non si raggiunge alcun accordo, la procedura si chiude con una relazione finale dell’esperto in cui valuta le cause del fallimento delle trattative e lo stato di insolvenza se presente.
Perché è utile: La composizione negoziata è un ambiente protetto dove imprenditore e creditori dialogano con assistenza di un soggetto terzo super partes. Riduce sfiducia e incomprensioni, consente scambio di informazioni. Ha l’obiettivo di evitare il default trovando soluzioni prima che sia tardi. È uno strumento “early stage”: i migliori risultati li dà in situazioni di pre-crisi.
Esempio: Packaging Srl prevede di non poter pagare fornitori tra 6 mesi se non ristruttura. Attiva la procedura in anticipo. L’esperto aiuta l’imprenditore a convincere la banca a nuova finanza e i fornitori a dilazionare, evidenziando le prospettive di mercato e eventuali garanzie. Grazie allo stay concesso dal tribunale, nessun creditore precipitoso può pignorare mentre si discute. Dopo 3 mesi, si arriva a un accordo stragiudiziale con tutti (in pratica un piano attestato firmato da tutti i maggiori creditori) e l’esperto chiude positivamente. L’azienda esce dalla procedura risanata, senza essere mai entrata in concorso formale.
Misure premiali: Per incoraggiare l’uso, il legislatore ha previsto incentivi: come visto, riduzione interessi e sanzioni fiscali se risanamento ha esito , possibilità di chiedere finanziamenti prededucibili (che motiva banche a erogare credito ponte), esonero da responsabilità per banche che rinegoziano (le concessioni fatte in comp.negoz. non sono valutate come abuso di credito), esonero da revocatoria per pagamenti autorizzati dall’esperto. Persino profili giuslavoristici: l’azienda in comp.negoz. può ottenere CIGS per crisi, come da norme ad hoc.
Concordato semplificato: Merita una nota a parte questo strumento (art. 25-sexies CCII): se non si trova soluzione e l’esperto attesta che non è stato possibile, l’imprenditore entro 60 giorni può proporre un concordato per cessione dei beni senza il voto dei creditori . È “semplificato” perché: non c’è voto, decide tutto il tribunale in omologa (i creditori possono solo fare opposizione) ; non c’è commissario giudiziale durante la procedura (solo un eventuale ausiliario per valutare il piano) ; non c’è requisito di percentuale minima di pagamento ai chirografari (neppure quel 20% che un tempo serviva nei concordati liquidatori) . Serve però che ogni creditore ottenga dal concordato semplificato almeno l’utilità della liquidazione giudiziale, altrimenti il giudice non omologa – es: non si può dare zero a un creditore se in fallimento avrebbe preso qualcosa . In pratica è una procedura di liquidazione rapida sotto controllo giudice ma senza passare dal fallimento né dal voto: utile per evitare i costi e tempi del fallimento quando c’è il rischio di dispersione valore. Per la nostra azienda, significherebbe: vendiamo i beni e l’azienda in blocco al miglior offerente individuato con l’assistenza dell’esperto, e distribuiamo quello che c’è ai creditori, chiudendo la partita – il tutto con l’avallo giudiziario e la nomina di un liquidatore post omologa.
Quindi, la composizione negoziata può portare a: – risanamento (piano attestato, accordo stragiudiziale, ADR, concordato in continuità), – oppure se risanamento impossibile, a exit strategy ordinata (concordato semplificato liquidatorio).
Vantaggi: – Tempestività: Ideale attivarla presto, prima che il cash finisca del tutto. – Riservatezza iniziale: La sola apertura non appare pubblicamente (diversamente da un concordato in bianco che appare subito). – Flessibilità esiti: Non ingabbia in un solo percorso, si può virare in corso d’opera (l’imprenditore mantiene regia, l’esperto consiglia). – Immunità penale temporanea: Finché rispetta le regole, l’imprenditore non rischia da omessi pagamenti di IVA maturati in quel periodo (il termine penale slitta). Inoltre il correttivo 2024 ha previsto la non punibilità di eventuali atti dispositivi fatti con l’esperto per la continuità, che sarebbero bancarotta preferenziale se poi fallisse.
Svantaggi: – Non è garantito il successo: se i creditori non collaborano, l’esperto non ha poteri impositivi. Vi dev’essere volontà delle parti. – Può essere difficile da gestire per imprese molto piccole che non hanno contabilità ordinata: occorre presentare molti dati e stare in confronto costante (che però può essere un beneficio, in quanto si ricevono consigli su come migliorare gli assetti). – Se si chiede lo stay, allora viene iscritta la misura al Registro Imprese e i terzi sanno che sei in composizione negoziata (possibile stigmatizzazione, sebbene minore di un concordato).
Caso d’uso per Packaging Srl: a fine 2023 vede margini calare e primi insoluti con fornitori, prevede stress finanziario nel 2024. Attiva comp. negoziata a gennaio 2024. L’esperto analizza: c’è un business di base sano, ma serve riduzione costi e dilazione debiti. Ottiene, con i creditori, un accordo di moratoria di 6 mesi sui pagamenti e intanto l’azienda cede un ramo d’azienda non core per fare cassa. Con quella liquidità, a fine composizione paga gli arretrati ridiscussi. La comp. negoziata chiude con successo (un contratto stipulato con banche e fornitori). L’azienda prosegue e nessuno finisce in tribunale. Oppure, scenario peggiore: nessun accordo, l’esperto dichiara che l’azienda è insolvente. A quel punto Packaging Srl può rapidamente presentare un concordato semplificato vendendo le linee di produzione ad un concorrente e chiudendo, evitando il fallimento.
Concordato preventivo – art. 84 e segg. CCII
Il concordato preventivo è storicamente la procedura principe per evitare il fallimento, consentendo all’imprenditore di proporre ai creditori un concordamento (un compromesso) sui crediti. Con il CCII, il concordato viene disciplinato in modo più flessibile rispetto al passato, recependo la direttiva UE Insolvency, con accentuazione della possibilità di continuità aziendale.
Tipologie: – Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): l’impresa non cessa l’attività, anzi la prosegue durante la procedura e dopo l’omologazione, utilizzando i ricavi futuri per pagare i creditori . Può trattarsi di continuità diretta (la stessa azienda continua) o indiretta (si cede l’azienda a un terzo che la continua, e il prezzo serve a pagare creditori). Il CCII definisce concordato in continuità quello in cui la soddisfazione dei creditori avviene in misura anche non prevalente col ricavato dell’attività d’impresa in esercizio . – Concordato liquidatorio: la proposta prevede solo la liquidazione del patrimonio (vendita beni) e distribuzione del ricavato. In questo caso, la legge richiede di norma un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo disponibile per i creditori chirografari (come “premio” per accettare un concordato invece che fallimento), salvo i creditori siano soddisfatti al 20% almeno (nel CCII questa soglia rigida è stata eliminata ma rimane la regola del best interest test).
Procedura: – Si accede col deposito di un ricorso al tribunale; è possibile presentare inizialmente un concordato “in bianco” (prenotativo) con riserva di presentare il piano entro max 120 giorni, ottenendo intanto le misure protettive. – Il piano di concordato deve dettagliare lo stato patrimoniale, le cause di crisi, e la proposta di trattamento per ciascuna classe di creditori. Già, perché di solito si classano i creditori in categorie omogenee per posizione giuridica ed interesse economico. – Il tribunale all’ammissione nomina un Commissario Giudiziale (figura di controllo), e fissa l’adunanza dei creditori. – I creditori votano (per classi) la proposta. Se approvata dalle maggioranze di legge (e nel CCII è sufficiente che una classe di creditori di qualsiasi tipo approvi, se i dissenzienti sono trattati meglio della liquidazione – meccanismo di cram down interclassi che prima non c’era), si passa all’omologazione. Se non approvata, la procedura viene chiusa (e l’impresa di solito fallisce). – In sede di omologazione, il tribunale verifica legalità, fattibilità e rispetto del best interest test: nessun creditore dissenziente riceva meno di quanto otterrebbe in una ipotetica liquidazione giudiziale della società . Se questo è rispettato e ci sono le maggioranze, omologa (anche forzatamente su eventuali classi contrarie, applicando la regola di distribuzione del valore equa).
Esiti: Dopo omologa, se concordato in continuità, l’impresa (monitorata) esegue il piano sotto vigilanza del commissario e del giudice, finché tutti adempimenti sono completati (può durare anni). Nei concordati liquidatori, all’omologa viene nominato un liquidatore giudiziale che sostituisce l’imprenditore e vende i beni, poi ripartisce attivo e chiude.
Trattamento crediti: – Creditori privilegiati: in linea di massima vanno pagati integralmente nel concordato, altrimenti devono approvare la riduzione. Il CCII consente di alterare la regola se c’è continuità: si possono ad esempio soddisfare i privilegiati in tempi dilazionati oppure solo parzialmente se il valore di realizzo del bene non copre il credito (il residuo va in chirografo). Non pagare integralmente un ipotecario oltre il valore del bene è lecito, pagherai quanto vale quel bene (il concetto di cram down su privilegio incapiente). – Creditori chirografari: di regola subiscono un taglio (detto falcidia). Non c’è una percentuale minima fissa (il vecchio 20% per liquidatorii è stato abrogato). Può essere anche molto bassa (es. 5%), a patto che in scenario fallimentare essi avrebbero zero. In continuità, può accadere di pagarli pure sotto il 20% se il piano li convincerà che è il meglio ottenibile. – Debiti fiscali e contributivi: possono essere falcidiati nel concordato anche sull’IVA e ritenute (dal 2022 si è allineati alla direttiva UE, prima c’era divieto su IVA). Occorre però che l’Amministrazione esprima voto favorevole se chiede di ridurre il capitale di imposta. Il CCII semplifica: se Fisco/INPS rifiutano la proposta ma la maggioranza degli altri creditori l’ha approvata, il tribunale può omologare lo stesso se la soddisfazione offerta al Fisco è almeno pari a quella che avrebbe in fallimento (art. 88 CCII). Dunque, possibile cram down anche sul Fisco dissenziente, mentre prima il diniego fiscale era quasi insuperabile.
Esempio: Packaging Srl, completamente insolvente con attivo 500k e debiti 1,5M, propone concordato liquidatorio: vendere tutto (500k stimati), con apporto di un terzo di 50k, totale 550k da distribuire. I privilegiati (Fisco, dipendenti, banca su ipoteca) sommano 300k, li pagherà integralmente. Restano 250k per chirografari su 1,2M (circa 20.8%). Propone 20.8% ai chirografari in 2 anni. Se il tribunale stima che in fallimento avrebbero 10%, la proposta è conveniente. Creditori votano: se approvano, bene; se alcuni dissentono, il giudice guarderà che comunque prendono >10% e potrà forzarli. L’azienda cessa e liquida, i soci perdono partecipazioni, l’imprenditore evita la dichiarazione di fallimento e forse può ottenere esdebitazione residua se persona fisica.
Concordato in continuità: Packaging Srl invece vede commesse future promettenti se supera la crisi. Propone concordato in continuità: i debiti privilegiati li paga parzialmente su 5 anni (es. banca ipotecaria 80% ma su 5 anni – dovrà convincere banca a votare sì se non è coperta integralmente), i chirografari 30% su 5 anni. Prevede che restando in attività potrà generare liquidità sufficiente. I fornitori, sperando di continuare ad averla come cliente, votano a favore. I dipendenti mantengono il posto (il concordato in cont. consente pure di derogare a certe norme contrattuali con autorizzazione, es. riduzione personale se indispensabile). Il tribunale omologa. L’azienda ristruttura e continua operare, sorvegliata dal commissario. Dopo 5 anni, se tutto pagato come da piano, concordato eseguito e chiusura, l’impresa è risanata (o comunque libera dai debiti eccedenti pagati solo in parte).
Vantaggi: – Permette di gestire situazioni gravissime dove serve ridurre il debito in modo impositivo. – Può salvare l’attività (concordato in continuità) e i posti di lavoro . – Effetto esdebitatorio: la società concordataria, una volta eseguiti gli obblighi, viene liberata residualmente dai debiti chirografari falcidiati. Le persone fisiche garanti e soci illimitati, pur non esdebitate dal concordato della società, possono poi ottenere esdebitazione personale col meccanismo di legge. In generale il concordato è considerato soluzione ufficiale alla crisi, evitando il disonore del fallimento. – Durante il concordato, niente azioni esecutive dei creditori: la calma piatta consente di eventualmente anche ricostruire la situazione, vendere con ordine, recuperare crediti clienti, etc. – Possibilità di ottenere finanza interinale: il debitore in concordato può chiedere al giudice di autorizzare nuovi prestiti prededucibili o garantiti, per portare avanti l’attività o pagare fornitori critici (questo è di aiuto in continuità). Anche predisporre misure come accordi di pegno su beni futuri per chi finanzia, con benestare del giudice.
Svantaggi: – Procedimento complesso, pubblico (clienti e mercato lo sanno, può scalfire fiducia). – Non sempre i creditori collaborano: se la proposta non li convince possono bocciarla – e il fallimento dopo sarà quasi certo. Quindi il concordato è un po’ “make or break”. – Costi e tempi elevati. – Necessità di consulenti esperti per redigere un piano solido e seguire procedure (serve attestatore, legali, commissioni). – In concordato liquidatorio spesso ai creditori chirografari arriva poco, ergo preferiscono far fallire e tentare azioni di responsabilità. Occorre presentare proposte serie.
Normativa recente: Il CCII (aggiornato col correttivo 2024) ha ad esempio: – Eliminato l’obbligo del 20% minimo ai chirografari nel liquidatorio, per favorire più concordati ed evitare liquidazioni giudiziali. – Ridotto formalismi sul commissario giudiziale (non più automatico in ogni caso: nel concordato in continuità il giudice può anche decidere di non nominarlo se non serve, per ridurre costi , anche se appare raro). – Previsto espressamente la non applicazione della business judgement rule agli atti palesemente imprudenti come dicevamo (anche in contesto di concordato, i giudici valutano se il piano è plausibile, non si accontentano della discrezionalità). – Reso più agevole il cram down di classi dissenzienti, come già detto. – Introdotto il PRO (Piano di Ristrutturazione Omologato) come opzione di concordato “bloccato” se tutte le classi approvano all’unanimità – in tal caso, niente votazione giudiziale di merito approfondita, l’omologa è quasi automatica (visto che tutti concordi, giudice non deve fare paragone con scenari, a meno di violazioni par condicio e di diritti individuali). In pratica, se ottieni unanimità, non ti serviva il concordato… salvo per quell’effetto di deviare da par condicio come dice: si può distribuire il valore in deroga graduazioni se unanimità. PRO potrebbe essere utile se vuoi un cappello giudiziale a un accordo 100% consensi per non incorrere in future contestazioni.
Concordato preventivo rimane insomma lo strumento di ultima istanza per il debitore cooperativo: è preferibile al fallimento perché consente a lui di proporre la soluzione e gestire (almeno parzialmente) la crisi, però implica accettare la supervisione e il giudizio dei creditori.
Fallimento / Liquidazione giudiziale (per completezza): Se nessuna delle soluzioni sopra funziona, vi è la procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento). Qui l’imprenditore viene esautorato, un curatore liquidatore vende tutto e paga i creditori secondo prelazioni. L’impresa di norma viene chiusa. Per l’imprenditore scattano le conseguenze: interdizioni legali temporanee, possibile azione di responsabilità, rischi penali per eventuali condotte di bancarotta. L’unico lato positivo è l’esdebitazione post, se persona fisica, come detto: dopo la chiusura può chiedere di essere liberato dai debiti residui (tranne eccezioni come debiti alimentari, risarcimenti danni da illecito, etc.). Da notare, con CCII la procedura di liquidazione può essere anche controllata (ex sovraindebitamento) se il debitore non soggetto a liqu. giudiziale vi accede: simile al fallimento, ma volontaria.
Domande frequenti (FAQ) su difesa dai debiti aziendali
D1: La mia azienda è sommersa dai debiti: mi conviene fare finta di niente e aspettare che i creditori eventualmente chiedano il fallimento, o attivarmi io con una procedura?
R: È generalmente meglio attivarsi proattivamente. “Fare finta di niente” porta spesso a pignoramenti disordinati, aumento di interessi di mora e rischio di azioni pregiudizievoli (es. un creditore ottiene un pegno o il sequestro di un bene prima degli altri). Inoltre, un fallimento avviato dai creditori significa perdere il controllo: deciderà il tribunale e il curatore, e l’imprenditore subirà passivamente (con possibili accuse di ritardo nell’aver cercato soluzioni). Al contrario, attivare per tempo una composizione negoziata o presentare un concordato preventivo consente di gestire la crisi, negoziare condizioni migliori e magari salvare l’azienda. Il Codice della Crisi impone un dovere di rilevazione tempestiva dei segni di crisi: ignorarli può esporre l’amministratore a responsabilità. Ovviamente ogni caso è specifico: se l’azienda ha prospettive di recupero, vale la pena tentare piani di risanamento; se è decotta senza rimedio, presentare subito istanza di liquidazione o concordato liquidatorio può evitare aggravio di debiti (ad es. blocca maturazione interessi chirografari) e alleggerire le colpe degli amministratori. In sintesi, intraprendere per tempo uno strumento di composizione è quasi sempre preferibile all’inazione.
D2: Sono socio di una SRL indebitata. Possono togliermi la casa per i debiti della società?
R: In linea di massima no, i creditori sociali non possono aggredire i beni personali dei soci di SRL . La responsabilità limitata tutela il patrimonio personale del socio, che rischia al più la perdita del capitale investito. Eccezioni: se hai prestato fideiussioni personali (cosa comune con le banche), allora la banca sì può ipotecare/pignorare la tua casa secondo i termini della fideiussione. Inoltre, se la SRL viene liquidata e aveva debiti non pagati, i creditori possono chiedere a te socio di restituire quanto hai ricevuto in sede di liquidazione (es. il saldo di liquidazione) . Infine, condotte di abuso della personalità giuridica (es. usi la SRL come schermo per attività illecite o confondi i patrimoni) possono portare un giudice a decidere di non applicare la limitazione in casi estremi. Ma sono situazioni rare e di solito richiedono frode conclamata. Quindi, se sei socio non garante, la tua casa è al sicuro dal “normale” debito societario; assicurati però di non prelevare attivi prima di pagare i creditori in liquidazione, altrimenti saresti tenuto a restituirli.
D3: Sono amministratore di una SRL fallita: mi faranno causa per i debiti non pagati?
R: È possibile. Nel fallimento (liquidazione giudiziale), il curatore spesso esamina l’operato degli amministratori. Se riscontra che hai compiuto atti di mala gestio (spese spropositate, preferenze indebite, omesso reagire a perdite) e che ciò ha causato danno ai creditori, può promuovere un’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. per farti risarcire il deficit fallimentare. Ad esempio, se hai continuato a ordinare merci sapendo che la società era insolvente, aggravando il buco, il curatore può chiederti quei danni. Oppure se hai pagato solo i creditori “amici” lasciando zero per gli altri, anche questa è violazione. Tieni conto che per condannarti devono provare la colpa o dolo nella gestione e il nesso col danno. Non basta essere stati amministratori “sfortunati”: serve cattiva amministrazione. Se hai agito diligentemente e la crisi è dovuta a cause esterne (mercato, insolvenza di un cliente importante ecc.), difficilmente sarai condannato civilmente. In sintesi: non è automatico che faranno causa all’amministratore, ma è frequente quando c’è insolvenza vedere contestazioni di gestione. La miglior difesa è aver sempre documentato le scelte e dimostrato di aver agito nell’interesse sociale (non proprio). Notare che, in parallelo, potrebbero aprirsi procedimenti penali se dal fallimento emergono reati (es. bancarotta fraudolenta se mancano beni o libri contabili: in quel caso l’amministratore rischia sanzioni penali). Se invece hai agito correttamente e la sfortuna ha colpito, potresti comunque essere chiamato in causa, ma con buone probabilità di difenderti con successo dimostrando l’assenza di colpa grave.
D4: La mia società SNC non riesce a pagare un debito bancario. Io come socio posso essere dichiarato fallito per quel debito?
R: Sì. Nella SNC i soci hanno responsabilità illimitata e solidale , quindi se la società viene dichiarata fallita, anche i soci persone fisiche falliscono contestualmente (è la estensione del fallimento, ex art. 147 L.F.). Inoltre, una banca creditrice può chiedere il fallimento sia della società che direttamente dei soci (se il debito è abbastanza grande) presentando istanza congiunta. In pratica, la distinzione patrimoniale tra SNC e soci è minima: il tuo patrimonio è garanzia dei debiti sociali. Dunque la risposta è: se la società è insolvente, verrà verosimilmente dichiarata fallita e di riflesso tu e gli altri soci illimitati pure. Questo comporta che anche i tuoi beni personali (casa, conto, auto) entreranno nel fallimento. Puoi evitare ciò solo se regolarizzi il debito oppure, ad esempio, chiedi un concordato preventivo per la società (che, se ammesso e poi omologato, evita il fallimento e quindi salva i soci dal fallimento personale). Oggi c’è la possibilità per il socio di evitare l’estensione se la società opta per una procedura da sovraindebitamento (concordato minore) che non prevede il fallimento: in tal caso il socio coobbligato resterebbe fuori da quella procedura ma i creditori potrebbero poi perseguitarlo individualmente… insomma, è complesso. La sostanza: come socio SNC sei considerato un imprenditore tu stesso e puoi fallire per i debiti sociali. Perciò devi gestire la crisi con la stessa serietà con cui gestiresti le tue finanze, perché sono effettivamente la stessa cosa in questo contesto.
D5: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo per una fattura non pagata: posso contestarlo anche se effettivamente non ho pagato?
R: Puoi opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica, ma devi addurre un motivo legale di opposizione. Se semplicemente “non hai pagato perché non avevi soldi” ma il credito è certo, liquido ed esigibile, non hai una contestazione nel merito valida. In mancanza di ragioni di contestazione (merce non consegnata, importo errato, prescrizione del credito, incompetenza territoriale del giudice, ecc.), un’opposizione sarebbe temeraria e potenzialmente potrebbe aggravare le spese (il giudice ti condannerebbe agli interessi e spese legali). Tuttavia, a volte anche chi non ha vere contestazioni propone opposizione per guadagnare tempo: questo è tecnicamente possibile, ma bisogna ponderare i rischi. Potresti dover poi pagare comunque (il debito più interessi e spese) e intanto peggiorare i rapporti col creditore. Meglio, se ammetti il debito, cercare una transazione: ad esempio potresti chiedere al creditore (magari tramite l’avvocato) di concederti una rateazione o sconto, in cambio di non opporsi o di rinunciare all’opposizione se già fatta. Talvolta il creditore preferisce incassare a rate che impelagarsi in anni di causa. Se invece esistono motivi (anche parziali) – ad esempio la merce consegnata era difettosa e stimi di dover pagare meno – allora sì, fai opposizione e allega queste ragioni con prove. Ricorda però: l’opposizione trasforma il procedimento in una causa civile ordinaria, con relativi costi e tempi; potresti dover pagare un avvocato per anni, quindi ha senso se il controvalore del possibile vantaggio giustifica l’investimento (opporsi per 5.000 € di fattura certa è raramente utile, per 500.000 € forse sì, se speri in un esito migliore). In conclusione: puoi sempre formalmente fare opposizione, ma la convenienza dipende dalla fondatezza delle tue ragioni e dalla tua strategia di negoziazione. Se il debito è giusto e non ci sono errori, valuta soluzioni di saldo o piani di rientro col creditore, più che un’opposizione infondata.
D6: Si può fallire anche con debiti verso il Fisco o altri enti pubblici?
R: Sì, certamente. Il fallimento (liquidazione giudiziale) può essere richiesto da qualunque creditore (pubblico o privato) che abbia un credito certo, liquido ed esigibile e vi sia stato inadempimento persistente, e che l’impresa sia sopra soglia di fallibilità. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad esempio può – e spesso lo fa – presentare istanza di fallimento se una società ha cartelle esattoriali impagate di importo rilevante (decine di migliaia di euro) e non risultano beni aggredibili facilmente. Anche l’INPS lo fa per contributi non pagati, o i Comuni per tasse locali ingenti. Tra l’altro, i crediti tributari godono di privilegio e spesso superano la soglia di €30k (vecchio parametro empirico per vedere se un fallimento era proponibile). Quindi, non è affatto raro che sia un creditore pubblico a innescare il fallimento. Per l’azienda, anzi, il rischio può essere maggiore: perché magari i fornitori attendono, ma il Fisco no. Dunque la risposta: i debiti fiscali possono portare al fallimento come quelli privati, e anzi le procedure concorsuali spesso nascono da iniziative del Fisco. (Nota: nel Codice della Crisi era stata prevista una sorta di allerta con segnalazioni obbligatorie di INPS/Ade per certe soglie di debito scaduto; quell’allerta è stata sospesa fino a fine 2023 e poi rivista, però nulla toglie che l’ente creditore userà comunque gli strumenti ordinari come pignoramenti e istanze di liquidazione giudiziale per tutelarsi.)
D7: Che differenza c’è tra concordato preventivo e concordato semplificato di cui sento parlare?
R: Il concordato preventivo è la procedura “standard” prevista dalla legge fallimentare (ora CCII) in cui la proposta ai creditori viene votata dagli stessi e approvata se raggiunge le maggioranze; poi il tribunale omologa se tutto regolare. Il concordato semplificato per la liquidazione è una procedura speciale, introdotta nel 2021, utilizzabile solo all’esito negativo di una composizione negoziata . La differenza principale è che non c’è voto dei creditori: deciderà il tribunale se omologarlo, i creditori possono solo fare opposizione dopo. Inoltre è solo liquidatorio: serve per liquidare i beni rimasti dell’azienda in modo ordinato e rapido, non per continuare l’attività (infatti la legge specifica che non è ammessa continuità in questo concordato semplificato) . Perché “semplificato”? Perché elimina le fasi di adunanza e voto, non nomina di default un commissario, semplifica la distribuzione (nessuna percentuale minima) . In pratica, è una scorciatoia per chiudere un’impresa in crisi in maniera concorsuale ma veloce quando le trattative non hanno portato a un risanamento. Quando usarlo: immagina di aver provato la composizione negoziata ma i creditori non accettano stralci – l’azienda è decotta – invece di farla fallire, puoi proporre tu al tribunale di vendere tutti i beni alle migliori condizioni trovate e distribuire ai creditori secondo priorità, senza aspettare istanze di fallimento. I creditori rimangono liberi di lamentarsi (opposizioni) ma non possono proporre piani alternativi o pretendere il voto, perché quel treno è passato. Quindi, riassumendo: il concordato preventivo è un’ampia categoria di procedure, con possibili esiti di continuità o liquidazione, e prevede coinvolgimento attivo dei creditori (voto); il concordato semplificato è una sottospecie particolare, senza voto, usabile in circostanze limitate (post-composizione negoziata fallita) e finalizzata solo a liquidare rapidamente, sotto controllo giudice, con minori costi e formalità.
D8: Un concordato o un accordo di ristrutturazione cancellano i debiti?
R: Sì, in buona parte è quello lo scopo: ridurre il debito complessivo a carico dell’impresa. Tuttavia, non è un “colpo di spugna” unilaterale: è il risultato di una proposta approvata e omologata. Con il concordato preventivo, una volta omologato, i debiti sono novati secondo la proposta: ad esempio, un creditore chirografario che aveva €100k di credito e il piano prevede pagamento 30%, avrà diritto a €30k nei tempi stabiliti e per il resto (€70k) la sua pretesa viene estinta (non può più richiederla). Dunque sì, la quota falcidiata viene di fatto cancellata dopo l’omologazione definitiva. Anche gli accordi di ristrutturazione producono l’effetto di stralciare le parti di credito su cui c’è accordo di rinuncia: dopo l’omologa, il creditore aderente che ha accettato 80% non potrà mai reclamare il 20% abbuonato. Attenzione però a due aspetti: (1) in concordato, se il debitore non adempie al piano omologato (es. non paga quelle rate concordatarie del 30%), il concordato può venir risolto (annullato) su istanza dei creditori e i debiti originari “resuscitano” al netto di quanto eventualmente pagato. Quindi la cancellazione è definitiva solo a piano eseguito. (2) Alcuni debiti particolari non vengono eliminati neanche col concordato: ad esempio, le obbligazioni personali di terzi come i fideiussori – se la società fa concordato e paga al 30%, il fideiussore del debito sociale resta obbligato per l’eventuale differenza salvo che anche lui acceda a procedura o transi. Allo stesso modo, eventuali sanzioni penali o amministrative pecuniarie non comprimibili per legge (quelle aventi natura punitiva) rimangono fuori. Invece i debiti comuni commerciali e fiscali sì, vengono falcidiati se il piano lo prevede e l’esito è positivo: legalmente si ha la cosiddetta “esdebitazione dell’ente”, ovvero la società ne esce pulita dai debiti anteriori (i creditori ricevono solo quanto fissato dal piano e null’altro). Quindi, volendo semplificare: il concordato/accordo è come un “condono concordato” con i creditori: se completato, il resto dei debiti si condona. Da notare, come evidenziato, che l’esdebitazione del fallito persona fisica è un istituto distinto e ulteriore – in concordato non serve per la società perché la società, se continua, prosegue liberata da quell’obbligo per legge e se liquida scompare.
D9: Se la mia azienda va male ma io continuo a pagare alcuni fornitori lasciandone indietro altri, posso avere problemi personali?
R: Potenzialmente sì. Se poi la società sarà dichiarata insolvente, quei pagamenti selettivi potrebbero essere considerati atti preferenziali (pagamenti preferenziali a creditori a scapito di altri) passibili di azione revocatoria fallimentare e addirittura di bancarotta preferenziale sul piano penale se fatti dolosamente a vantaggio di alcuni creditori pregiudicandone altri. In un contesto di crisi conclamata, la legge impone di non alterare la par condicio creditori. Esempio: l’azienda sa di non poter soddisfare tutti, ma paga interamente il fornitore A (magari amico o essenziale) e nulla a B dello stesso grado. Se poi fallisce entro 6 mesi da quei pagamenti, il curatore potrà chiedere al fornitore A di restituire quanto ricevuto (revocatoria) per distribuirlo equamente , a meno che quel pagamento fosse fatto nell’ambito di un piano di risanamento attestato o accordo protetto. E tu amministratore potresti essere accusato di aver favorito un creditore causando un danno agli altri: bancarotta preferenziale, punita penalmente. Quindi attenzione: pagare “a macchia di leopardo” alcuni sì altri no verso la fine è rischioso. Ovviamente la gestione di tesoreria in crisi è difficile, devi mantenere forniture essenziali; per farlo in sicurezza, conviene perseguire strade come la composizione negoziata (dove i creditori accettano magari formalmente di essere pagati parzialmente in accordo e l’esperto sovrintende) oppure ottenere dal tribunale di autorizzare pagamenti pre-deducibili in un concordato in bianco per fornitori strategici. Tali autorizzazioni mettono al riparo da azioni revocatorie e censure. Se invece procedi autonomamente a pagare qualcuno e lasciare altri all’asciutto, tieni presente il rischio: se entro due anni c’è fallimento, quei pagamenti verranno scrutinati. Ci sono eccezioni: pagamenti a termine di uso normale, di beni correnti a prezzo di mercato, quelli difficilmente si revocano. Ma pagare arretrati di un solo fornitore grosso e non gli altri è textbook di preferenza ingiustificata. Quindi: meglio evitare favoritismi, oppure se devi farlo perché altrimenti si ferma tutto, fallo all’interno di un piano formale o consultando un legale su come minimizzare il rischio (es. attendi di essere in composizione negoziata e col beneplacito dell’esperto effettui quel pagamento, etc.).
D10: La società ha debiti, ma io come imprenditore ho anche debiti personali (per esempio mutuo di casa, o prestiti personali): esiste una procedura unica per sistemare tutto il mio indebitamento?
R: In linea di principio, le vicende della società e quelle personali sono separate, a meno che la forma imprenditoriale sia la stessa persona (ditta individuale). Se hai una SRL indebitata e tu come persona pure sei indebitato, devi affrontare su due piani: la società con gli strumenti visti (concordato, ecc.), e tu persona fisica con altri strumenti. Ad esempio, potresti valutare una procedura di sovraindebitamento (come il “piano del consumatore” se i tuoi debiti personali sono prevalentemente da esigenze di famiglia, oppure la liquidazione controllata del tuo patrimonio personale). Il CCII consente anche procedura di composizione gruppi di imprese, ma non è il caso tipico piccolo imprenditore. Se sei socio illimitatamente responsabile di SNC (quindi i debiti sociali sono anche tuoi personali), in un concordato minore o liquidazione controllata puoi affrontare contestualmente la tua esposizione includendovi i debiti sociali. Per un imprenditore individuale, invece, esiste una sovrapposizione: concordato o liquidazione intervengono su di lui e includono tutto. Quindi, se la tua impresa è individuale, sì, un concordato minore può risolvere in un colpo sia i debiti “aziendali” che i tuoi (che poi coincidono). Ma se la tua persona ha debiti estranei all’azienda (es. carte di credito personali, mutui casa) e al contempo l’azienda è, poniamo, una SRL distinta, potresti avere un doppio binario: la SRL fa concordato, e tu come persona magari fai un accordo con banche o un piano del consumatore. Non c’è una procedura unica per soggetti differenti. In alcuni casi, conviene aspettare la chiusura del fallimento e poi chiedere l’esdebitazione anche per le fideiussioni escusse. Ad esempio, garantivi la SRL, la SRL fallisce, la banca viene da te, tu finisci con debiti personali per quella fideiussione: potrai usare la tua insolvenza personale per accedere a liquidazione controllata ed esdebitazione personale. In sintesi: se sei persona giuridica separata, devi gestire separatamente; se sei imprenditore individuale o socio illimitato, esistono procedure che all’interno affrontano tutto il pacchetto del tuo patrimonio e debiti.
Conclusione
Affrontare una grave situazione debitoria in azienda richiede conoscenza approfondita degli strumenti legali e un’attenta pianificazione. Questa guida ha evidenziato che esistono numerose vie – dal dialogo informale alle procedura di crisis management come piani attestati, accordi, composizione negoziata e concordati – per evitare le soluzioni peggiori (fallimenti disordinati, chiusure traumatiche, azioni personali contro amministratori). La posizione del debitore (imprenditore, società, socio) va difesa con trasparenza, tempestività e competenza, preferibilmente con l’ausilio di professionisti esperti in diritto fallimentare.
Nel contesto italiano odierno (ottobre 2025), il quadro normativo incoraggia il risanamento anticipato e la responsabilizzazione dell’imprenditore: chi si attiva per tempo trova strumenti che gli offrono protezione (misure protettive, riduzioni sanzioni, ecc.), chi invece procrastina rischia sanzioni e minori opzioni. Importante è anche saper comunicare con i creditori – spesso un creditore informato e coinvolto è disponibile a soluzioni concordate piuttosto che andare allo scontro legale.
Per un’azienda di imballaggi personalizzati e all’ingrosso con debiti, come ipotizzato, le soluzioni concrete possono combinare più strumenti: ad esempio, composizione negoziata per guadagnare tempo e costruire un piano, poi accordo di ristrutturazione con i fornitori principali e banche, e contestualmente rateizzazione fiscale per i debiti tributari; oppure, se il mercato ha prospettive, un concordato in continuità per diluire e ridurre i debiti mantenendo l’attività in piedi. Se invece non c’è prospettiva di salvare l’impresa, l’obiettivo diventa limitare i danni: procedere a una liquidazione ordinata (concordato semplificato o liquidazione controllata) che magari consenta di cedere i macchinari a un concorrente e pagare almeno in parte i creditori, evitando lunghe procedure.
Dal punto di vista legale avanzato, abbiamo toccato anche le ultime pronunce giurisprudenziali – ad esempio, Cass. 23963/2025 sul conflitto di interessi degli amministratori , Cass. 30532/2024 sulla non punibilità dell’omesso versamento IVA per forza maggiore , Cass. 23341/2024 sulle sanzioni tributarie a carico dei soci post liquidazione – per far capire come la Cassazione stia interpretando queste norme a tutela sia dei creditori sia del debitore onesto.
In definitiva, “cosa fare per difendersi” in questi casi si riassume così: conoscere i propri diritti e doveri, non farsi prendere dal panico, ma elaborare un piano (meglio se con l’ausilio di consulenti legali e finanziari) e scegliere lo strumento legale più appropriato. Ogni situazione è a sé, ma con le informazioni di questa guida l’imprenditore debitore può avere una mappa per orientarsi nel complesso ma vitale percorso di uscita dai debiti, nella legalità e – si auspica – col miglior esito possibile per l’azienda e per i suoi stakeholder.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile – artt. 2086, 2392, 2394, 2476 c.c. (doveri degli amministratori, responsabilità verso società e creditori) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) – come modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 (disciplina di composizione negoziata, strumenti di allerta, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.) .
- D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – (norme transitorie sulla Composizione Negoziata, introduzione concordato semplificato).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 – art. 19 (Rateizzazione delle cartelle esattoriali, come modificato da D.Lgs. 110/2024: 84 rate fino 2026, ecc.) .
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – artt. 10-bis, 10-ter (Reati di omesso versamento ritenute e IVA; soglie di punibilità elevate da D.Lgs. 87/2024 a €150k e €250k) ; art. 13 (cause di non punibilità per crisi di liquidità introdotte nel 2024) .
- L. Fallimentare (R.D. 267/1942) – norme transitorie ancora applicabili e corrispondenze con CCII (es. art. 147 L.F. fallimento esteso ai soci SNC).
- Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 2025 n. 23963 – Conflitto d’interessi dell’amministratore SRL e responsabilità ex art. 2476 c.c. .
- Cass. civ. Sez. Trib., 29 agosto 2024 n. 23341 – Successione dei soci nei debiti tributari (sanzioni comprese) di società estinta .
- Cass. pen. Sez. III, 25 ottobre 2024 n. 30532 – Omesso versamento IVA: non punibilità se crisi di liquidità incolpevole sopravvenuta (applicazione nuovo art. 13 co.3-bis D.Lgs.74/2000) .
- Cass. civ. Sez. VI, 10 marzo 2023 n. 7279 – Condotta in conflitto d’interessi dell’amministratore come violazione degli obblighi verso società (richiamata da Cass. 2025) .
- Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2025 n. 19814 – Opposizione a decreto ingiuntivo: termine decorre da valida notifica (conferma principio in tema di termini processuali) .
- Tribunale di Bergamo, decr. 6 giugno 2023 – Concordato semplificato: ogni creditore deve ricevere un’utilità non inferiore all’alternativa fallimentare (cited in Monardo concordato semplificato guide) .
- Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e insolvenza – recepita dal CCII (introduzione early warning e strumenti come PRO, cram-down interclasse).
- Circolari Agenzia Entrate-Riscossione 2023-2025 – (su nuove soglie e rateazioni: ad es. circ. 5/2023 AE-R).
La tua azienda che produce o distribuisce imballaggi personalizzati, scatole su misura, packaging industriale, imballaggi in cartone, imballaggi in legno, imballaggi in plastica, materiali protettivi, pluriball, nastri adesivi, imballaggi per e-commerce, forniture all’ingrosso o servizi di stampa e fustellatura è in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce o distribuisce imballaggi personalizzati, scatole su misura, packaging industriale, imballaggi in cartone, imballaggi in legno, imballaggi in plastica, materiali protettivi, pluriball, nastri adesivi, imballaggi per e-commerce, forniture all’ingrosso o servizi di stampa e fustellatura è in difficoltà a causa dei debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore degli imballaggi ha margini ridotti, costi di approvvigionamento elevati e flussi di cassa complessi: basta un ritardo nei pagamenti dei clienti, l’aumento delle materie prime o una riduzione dei fidi per generare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e in modo strutturato.
Perché un’Azienda di Imballaggi Va in Debito
- aumenti dei costi di cartone, carta, legno, plastica, film protettivi
- ritardi nei pagamenti da parte di industrie, e-commerce e distributori
- magazzino immobilizzato tra scorte, bobine, fogli, scatole e semilavorati
- investimenti in macchine da taglio, stampa, fustellatura o confezionamento
- aumento dei costi di logistica e trasporti
- linee di credito bancarie ridotte o revocate
- necessità di anticipare grandi quantità di materia prima
Il problema principale non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di materiali
- decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti
- impossibilità di evadere ordini e consegne
- sequestro di macchinari e scorte
- perdita di clienti importanti e contratti ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può interrompere pignoramenti, bloccare richieste di rientro e tutelare i conti aziendali.
2. Controllare e correggere i debiti
Molti debiti includono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Entrate-Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni più efficaci includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Utilizzare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per situazioni più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Questi strumenti permettono di continuare l’attività pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più competenti in Italia nella gestione delle crisi aziendali.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Una combinazione di competenze che lo rende tra i più efficaci in Italia nel bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende commerciali e produttive come quella del settore imballaggi.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, scorte, macchinari e flusso di produzione
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela dell’imprenditore e della continuità aziendale
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di imballaggi personalizzati e all’ingrosso non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata ed efficace puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- salvaguardare magazzino, produzione e clienti
- proteggere la continuità dell’azienda
Il momento di intervenire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il salvataggio della tua azienda può iniziare oggi stesso.