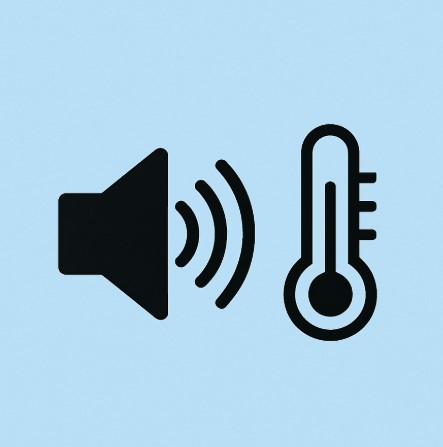Se la tua azienda si occupa di coibentazioni acustiche, coibentazioni termiche, isolamento industriale, pannelli isolanti, lane minerali, cappotti termici, barriere fonoassorbenti e interventi per capannoni, industrie, edifici civili e impianti, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare il blocco dell’attività.
Il settore delle coibentazioni richiede materiali costosi, manodopera specializzata, sicurezza in cantiere, mezzi adeguati, puntualità nelle consegne e una gestione precisa dei lavori. Un fermo può generare penali, ritardi nei cantieri, perdita di clienti e difficoltà economiche gravi.
Perché le aziende di coibentazioni accumulano debiti
- costi elevati per isolanti, pannelli, lane minerali, materiali ignifughi
- rincari dei materiali edili e dei trasporti
- pagamenti lenti da parte di imprese edili e clienti industriali
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- investimenti continui in attrezzature, DPI, ponteggi e mezzi
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera esposizione debitoria da un professionista
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi
- richiedere immediatamente la sospensione di pignoramenti
- proteggere fornitori e materiali essenziali
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o ridurre i debiti
I rischi se non intervieni
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di isolanti, pannelli e materiali critici
- fermo dei cantieri, ritardi e penali
- perdita di imprese edili, clienti privati, condomìni e industrie
- impossibilità di pagare personale e fornitori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
È inoltre:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
- bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
- ristrutturare o ridurre i debiti con strumenti normativi specifici
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere materiali, attrezzature e continuità dei cantieri
- evitare la chiusura e stabilizzare la tua impresa
Agisci ora
Molte aziende non falliscono per i debiti, ma perché arrivano troppo tardi a chiedere aiuto.
Con l’assistenza dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ridurre i debiti e salvare davvero la tua azienda.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e inizia subito a difendere la tua attività di coibentazioni acustiche e termiche.
Introduzione
Un’azienda specializzata in coibentazioni acustiche e termiche può trovarsi ad affrontare una situazione di sovraindebitamento, con debiti accumulati verso vari creditori (Erario, banche, fornitori, INPS, ex dipendenti, ecc.). Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, è fondamentale conoscere gli strumenti legali disponibili per gestire la crisi finanziaria, difendersi dalle azioni dei creditori e – quando possibile – risanare l’impresa o perlomeno limitare i danni personali. Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha introdotto significative novità in materia di crisi d’impresa, culminate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore nel 2022 e costantemente aggiornato (da ultimo con il terzo decreto correttivo del settembre 2024). Queste riforme segnano il passaggio da un approccio meramente liquidatorio/punitivo ad un approccio che privilegia la prevenzione della crisi e la ristrutturazione del debito, incoraggiando l’imprenditore ad attivarsi “senza indugio” ai primi segnali di difficoltà.
In questa guida, rivolta a professionisti del diritto, imprenditori e privati cittadini coinvolti nella crisi di un’azienda indebitata, forniremo un’analisi avanzata ma dal taglio pratico e divulgativo delle opzioni disponibili nell’ordinamento italiano (aggiornate a Ottobre 2025). Esamineremo i vari tipi di debiti e le relative conseguenze, le possibili strategie stragiudiziali e le procedure di regolazione della crisi (dalla composizione negoziata agli accordi di ristrutturazione, dal concordato preventivo alle soluzioni per il sovraindebitamento, fino all’eventuale liquidazione fallimentare). Verranno evidenziati i profili di responsabilità personale per l’imprenditore e gli amministratori, così da comprendere in quali casi i debiti aziendali possono “colpire” il patrimonio personale. La trattazione include tabelle riepilogative, una sezione di domande e risposte frequenti, nonché simulazioni pratiche basate su casi reali (nell’ambito esclusivo della normativa italiana) per illustrare l’applicazione concreta degli strumenti giuridici.
Nota sul metodo: Tutte le informazioni fornite sono corredate da riferimenti a fonti normative aggiornate, pronunce giurisprudenziali recenti e commenti autorevoli. Le fonti complete (leggi, sentenze, articoli specialistici) sono elencate in fondo alla guida. Ciò garantisce l’accuratezza e la verificabilità dei contenuti, nonché l’aderenza alle novità più recenti (fino alla fine del 2024 e 2025) in materia di diritto della crisi d’impresa. L’obiettivo è fornire un quadro completo ed avanzato, ma di agevole consultazione, che metta il debitore al centro: cosa può fare un imprenditore di una società di coibentazioni in crisi per difendersi dai creditori e gestire i debiti? Procediamo con ordine, partendo dalla mappatura dei debiti e dei rischi associati.
Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi
Una corretta strategia di risanamento deve tenere conto della natura dei debiti accumulati dall’azienda, poiché ogni tipologia di credito ha un regime giuridico e delle conseguenze peculiari. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debiti che una società può avere (focalizzandoci sul contesto italiano), con i relativi rischi per l’azienda e per l’imprenditore.
- Debiti fiscali (verso l’Erario): includono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali operate e non versate, ecc.) e relativi interessi e sanzioni. Questi debiti godono di cause di prelazione (privilegi) che li rendono prioritari in caso di procedure concorsuali. Il mancato pagamento di talune imposte può comportare, oltre a sanzioni amministrative, anche responsabilità penale per gli amministratori: ad esempio, l’omesso versamento di IVA per importi superiori a una certa soglia (oggi €250.000 annui) configura reato tributario, così come l’omesso versamento di ritenute fiscali oltre €150.000. Inoltre, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – ex Equitalia) può attivare procedure esecutive rapide: iscrizione di ipoteche su immobili aziendali, fermo amministrativo di automezzi, pignoramenti di conti correnti, fino alla possibilità di chiedere il fallimento della società se il debito supera una certa soglia significativa. Da notare che l’ordinamento consente strumenti specifici per gestire i debiti fiscali in crisi, come la “transazione fiscale”, di cui tratteremo approfonditamente più avanti (tale istituto permette di definire con l’Erario un pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi dovuti, anche con tagli che superano l’80% in certi casi).
- Debiti verso banche e istituti finanziari: comprendono esposizioni per mutui, finanziamenti, scoperte di conto corrente, leasing non pagati, ecc. Questi creditori di solito dispongono di garanzie reali (es. ipoteche su immobili aziendali, pegni su beni o crediti) o di garanzie personali (fideiussioni) spesso sottoscritte dall’imprenditore o dai soci. In caso di inadempimento, la banca può escutere le garanzie: ciò significa che, ad esempio, se l’azienda non paga le rate di un mutuo ipotecario, la banca potrà agire esecutivamente sull’immobile ipotecato; se un socio ha prestato garanzia personale, la banca potrà aggredire il suo patrimonio personale. I debiti bancari garantiti da ipoteca o pegno rientrano tra i crediti privilegiati (creditori prelatizi) in caso di procedure concorsuali: ciò li pone in posizione di favore nel riparto rispetto ai crediti chirografari (non garantiti). Tuttavia, l’imprenditore indebitato con banche ha interesse a negoziare ristrutturazioni del debito (ad esempio accordi di moratoria o di riscadenzamento del piano di ammortamento) per evitare la precipitazione delle escussioni. Da notare che se la banca ha emesso fideiussioni o avalli (es. in favore di fornitori dell’azienda), il loro eventuale escussimento in caso di crisi aziendale può generare nuovi debiti verso la banca (regresso).
- Debiti verso fornitori commerciali: sono i debiti chirografari per eccellenza (senza garanzie, salvo patto di riservato dominio sui beni forniti, se pattuito). Il rischio principale è la perdita di forniture essenziali (il fornitore smetterà di consegnare materiali all’azienda insolvente) e l’azione legale per il recupero del credito (ingiunzioni di pagamento, pignoramenti di beni aziendali, istanza di fallimento se il credito è cospicuo e l’insolvenza manifesta). I fornitori, in caso di fallimento, vengono soddisfatti in coda dopo privilegiati e prededucibili; per questo potrebbero essere incentivati ad aderire a piani di rientro o stralcio prima di un fallimento, se intravedono la possibilità di recuperare almeno una parte significativa del loro credito. Un rischio per l’imprenditore è rappresentato dalle azioni revocatorie fallimentari: pagamenti preferenziali fatti a taluni fornitori nei mesi antecedenti un fallimento potrebbero essere revocati dal curatore, obbligando il fornitore a restituire le somme (questo però riguarda la fase concorsuale e sarà trattato più avanti).
- Debiti verso il personale dipendente ed ex dipendenti: includono stipendi arretrati, TFR (trattamento di fine rapporto) non versato, indennità varie. Questi crediti godono di uno status privilegiato massimo nella legge fallimentare (privilegio di grado elevato, spesso insieme ai crediti da lavoro degli ultimi 12 mesi e ai contributi). In caso di insolvenza, i lavoratori hanno diritto all’intervento del Fondo di Garanzia INPS che anticipa TFR e ultime mensilità per poi surrogarsi nel credito (diventando creditore dell’azienda). Gli stipendi non pagati possono portare rapidamente a decreti ingiuntivi e pignoramenti (es. pignoramento di beni aziendali o crediti presso terzi, come crediti verso clienti). Inoltre più lavoratori insoddisfatti possono presentare istanza di fallimento. È importante sottolineare che l’amministratore che ometta deliberatamente il pagamento di retribuzioni e contributi può incorrere in sanzioni: ad esempio, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (contributi INPS a carico dipendente, trattenuti in busta paga ma non versati) per importi oltre circa €10.000 annui costituisce reato (art. 2 D.L. 12/09/1983 n.463 conv. in L.638/1983). Il rischio reputazionale inoltre è elevato: la tensione con ex dipendenti può sfociare in vertenze di lavoro e segnalazioni agli enti.
- Debiti verso enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, Casse di previdenza): si tratta di contributi obbligatori non versati. Questi debiti hanno natura privilegiata nei confronti del patrimonio aziendale (sono equiparati ai crediti erariali come grado, spesso con privilegio generale sui mobili ex art. 2753 c.c. per i contributi) e possono portare a iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali. L’INPS in particolare ha poteri di accertamento e recupero, e de iure può anche promuovere istanza di fallimento per contributi rilevanti non pagati (anche se nella prassi tende a utilizzare la riscossione coattiva tramite Agenzia Entrate-Riscossione). Come per i debiti fiscali, esiste la possibilità della “transazione previdenziale” (disciplinata in parallelo alla transazione fiscale) per definire in sede concorsuale un pagamento parziale/dilazionato dei contributi dovuti. Attenzione: l’amministratore di una società che omette il versamento delle ritenute previdenziali operate ai dipendenti (oltre la soglia di legge) può essere chiamato a risponderne personalmente sia sul piano penale che civile. In generale, i debiti contributivi si comportano in modo simile a quelli tributari quanto a trattamento nelle procedure.
- Altre passività: possibili ulteriori categorie includono debiti verso soci finanziatori (finanziamenti soci da restituire), debiti per sanzioni amministrative o tributi locali (IMU, TARI), esposizioni per canoni di locazione non pagati, ecc. Ciascuna va valutata: ad esempio, le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie (multe) in sede concorsuale sono trattate come chirografarie, ma spesso non esdebitabili (il Codice prevede limiti alla remissione delle sanzioni pecuniarie per sanzionare condotte illecite). I canoni di affitto non pagati possono portare allo sfratto dell’immobile aziendale, aggravando la crisi.
In Tabella 1 riportiamo una sintesi delle principali tipologie di debito e delle caratteristiche salienti:
<table> <tr><th>Tipologia di debito</th><th>Prelazione/Grado</th><th>Azioni tipiche del creditore</th><th>Rischi per l’azienda</th><th>Rischi personali per imprenditore/amm.</th></tr> <tr><td>Debiti fiscali (IVA, imposte dirette, ecc.)</td><td>Privilegio generale (imposte), privilegi speciali se iscritti (es. ipoteche su beni per ruoli)</td><td>Cartella esattoriale, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, istanza di fallimento (se insolvenza conclamata)</td><td>Sanzioni e interessi in crescita; blocco beni essenziali (veicoli); possibile insolvenza pilotata da Erario</td><td>Responsabilità penale per omessi versamenti sopra soglie; responsabilità personale del liquidatore ex art.36 DPR 602/1973 se paga altri creditori lasciando imposte insolute</td></tr> <tr><td>Debiti verso banche (finanziamenti, mutui)</td><td>Ipoteche/pegni: privilegio speciale su beni dati in garanzia; chirografo per parte eccedente</td><td>Decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi; esecuzione su beni ipotecati/pegno; escussione fideiussioni personali</td><td>Perdita dei beni dati a garanzia (es. sede ipotecata); revoca fidi e linee credito, peggiorando liquidità</td><td>Escussione di garanzie personali (fideiussioni) su patrimonio privato; segnalazione in centrale rischi su nominativi garanti</td></tr> <tr><td>Debiti verso fornitori (commerciali)</td><td>Nessuna garanzia (chirografari) salvo patti riserva proprietà; eventuale privilegio artigiani/agenti su specifici crediti</td><td>Diffida e sospensione forniture; decreto ingiuntivo e pignoramento merci/conti; azione revocatoria su pagamenti anomali; istanza di fallimento (se insolvenza e importi elevati)</td><td>Interruzione filiera produttiva per stop forniture; esecuzioni che bloccano beni o conti; eventuale revoca pagamenti a fornitori “favoriti” prima del fallimento</td><td>In genere nessuna se società di capitali (debito resta sociale); possibili contestazioni per pagamenti preferenziali (responsabilità da mala gestio); se impresa individuale o socio illimitato, debito ricade sul patrimonio personale</td></tr> <tr><td>Debiti verso dipendenti (retribuzioni, TFR)</td><td>Privilegio generale mobiliare di massimo grado (ultimi 12 mesi retribuzioni e TFR) e super-privilegio sulle somme garantite da Fondo INPS</td><td>Vertenze di lavoro presso DTL; decreto ingiuntivo immediato; insinuazione al Fondo di Garanzia INPS; scioperi o vertenze collettive; istanza di fallimento se più dipendenti insoddisfatti</td><td>Perdita di capitale umano (dimissioni); intervento INPS che poi agirà come creditore surrogato; danno reputazionale; possibile fallimento spinto da dipendenti</td><td>Responsabilità penale per omesso versamento contributi previdenziali trattenuti (>€10k); sanzioni civili per ritardato pagamento stipendi; se ditta individuale, obbligo personale di pagare i dipendenti</td></tr> <tr><td>Debiti previdenziali (INPS, INAIL) e verso Fisco locale</td><td>Privilegio generale (contributi obbligatori); privilegi speciali se iscritti su beni; crediti enti locali spesso privilegiati (es. IMU su immobili)</td><td>Avvisi di addebito immediatamente esecutivi (INPS); iscrizione a ruolo e cartelle; recupero crediti tramite Agente Riscossione; azioni esecutive simil-fisco</td><td>Accumulo interessi di mora; possibile blocco DURC (Documento Regolarità Contributiva) con impossibilità partecipare ad appalti o ottenere bonus; azioni esecutive aggressive simil-tributarie</td><td>Reati per omesso versamento contributi dipendenti; responsabilità liquidatore ex art.36 DPR 602/73 anche per contributi erariali non versati; nei consorzi tra imprese, obblighi in solido per contributi comuni</td></tr> <tr><td>Altri debiti (sanzioni amm.ve, debiti verso soci, canoni locazione)</td><td>Variano: sanzioni amm.ve chirografe; soci postergati se finanziamenti in società capitale; canoni locazione chirog. (eventuale privilegio per ultimi 2 anni su mobilio locato)</td><td>Per sanzioni: iscrizione a ruolo (se Stato) o ingiunzione enti locali; per soci: richiesta rimborso (ma postergazione se società di capitali); per locatore: sfratto per morosità e decreto ingiuntivo per canoni</td><td>Perdita dell’immobile aziendale in locazione (sgombero); azioni legali su crediti vari; nel caso di sanzioni, impossibilità di definizione se non pagando in misura ridotta se previste sanatorie normative</td><td>Se società di capitali: di regola no responsabilità personale (sanzione amm.va resta a carico ente salvo eccezioni); se ditta individuale o socio illimitato: piena responsabilità personale su tutte queste obbligazioni</td></tr> </table>
Osservazione: la gravità della situazione dipende non solo dall’ammontare totale dei debiti, ma anche dalla struttura degli stessi. Ad esempio, €500.000 di debiti tutti chirografari (fornitori, banche senza garanzie, ecc.) potrebbero essere gestibili tramite una proposta di stralcio al 40-50% in concordato, mentre €500.000 di debiti in prevalenza verso Erario e INPS (privilegiati) lasciano meno margine di manovra poiché questi creditori vanno soddisfatti in misura maggiore (salvo transazione fiscale). Nel valutare “cosa fare per difendersi”, l’imprenditore deve quindi anzitutto avere un quadro chiaro: chi sono i suoi creditori, per quali importi, e quali poteri hanno.
Un’azienda di coibentazioni acustiche e termiche, come PMI tipicamente strutturata in forma di società di capitali (es. S.r.l.), potrebbe avere esposizioni diversificate: mutui bancari per capannoni o attrezzature, scoperti di conto per liquidità, debiti con fornitori di materiali isolanti, debiti fiscali per IVA non versata su lavori effettuati, contributi arretrati per operai specializzati, ecc. Ognuna di queste voci va inserita in una scala di priorità. Nella fase introduttiva è utile elaborare un elenco completo dei creditori e verificare la presenza di eventuali procedure esecutive in corso (pignoramenti già avviati, decreti ingiuntivi non opposti, ipoteche iscritte). Questa mappa sarà la base per decidere il percorso migliore di difesa o ristrutturazione.
Verifica dello stato dell’azienda: continuare l’attività o avviarsi alla liquidazione?
Prima di scegliere gli strumenti per affrontare i debiti, l’imprenditore deve valutare lo stato di salute effettivo dell’azienda e stabilire se esistono prospettive realistiche di risanamento e prosecuzione dell’attività (continuità aziendale) oppure se la situazione è compromessa al punto da dover considerare la cessazione dell’attività e la liquidazione. Questa valutazione incide profondamente sulla strategia:
- Azienda ancora redditizia o risanabile (stato di crisi reversibile): se la società ha un core business valido, commesse in corso, know-how e mercato, ma attraversa una crisi di liquidità o un sovraindebitamento gestibile, l’obiettivo primario sarà evitare l’interruzione dell’attività e puntare a un risanamento in continuità. In questo scenario, strumenti come la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione o un concordato preventivo in continuità risultano indicati. L’azienda può provare a rinegoziare i debiti preservando la propria operatività, magari reperendo nuova finanza o investitori. Il Codice della Crisi definisce lo “stato di crisi” come il probabile futuro stato di insolvenza, distinguendolo dall’insolvenza conclamata (art. 2, c.1, lett. a, CCII): in questa zona grigia la continuità è ancora possibile. Ad esempio, un’impresa di coibentazioni con portafoglio ordini in crescita ma appesantita da debiti tributari e qualche perdita pregressa potrebbe rientrare in tale categoria.
- Azienda insolvente e non risanabile (dissesto irreversibile): se invece l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni (stato di insolvenza attuale) e non vi sono prospettive di ripresa (es. mercato in calo irreversibile, know-how obsoleto, perdita dei principali clienti), allora continuare l’attività potrebbe solo aggravare la posizione debitoria. In tal caso occorre considerare procedure liquidatorie come il concordato preventivo liquidatorio o direttamente la liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento) per chiudere ordinatamente l’impresa, vendere gli asset e ripartire il ricavato ai creditori. Continuare a operare in perdita in questa situazione espone gli amministratori a gravi rischi: proseguire l’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (ad esempio perdita del capitale sociale) fuori dai limiti della conservazione del patrimonio li rende responsabili verso i creditori per l’aggravamento del passivo. La Cassazione ha ribadito che, una volta maturate le condizioni per lo scioglimento della società (tipicamente ex art. 2484 c.c.), gli amministratori devono limitarsi ad atti conservativi e funzionali alla liquidazione; se compiono nuova attività d’impresa che aumenta il dissesto, possono essere chiamati a risponderne. In una recente pronuncia (Cass. civ. Sez. I n.8069/2024) è stato confermato il risarcimento dei danni a carico dell’amministratore che aveva proseguito la gestione nonostante la perdita integrale del capitale, non avendo egli provato che gli atti compiuti fossero necessari alla liquidazione o al mantenimento del valore aziendale. Dunque, in presenza di insolvenza irreversibile, prima si interrompe la gestione ordinaria e si adotta una procedura concorsuale, minori saranno i rischi per l’imprenditore.
Un elemento chiave da verificare è lo squilibrio patrimoniale rispetto all’attivo disponibile. Ad esempio, se l’azienda ha debiti totali per 2 milioni a fronte di un attivo realizzabile di soli 500 mila euro, si profila un deficit grave: salvarla richiederebbe interventi esterni (nuovi capitali) o forti decurtazioni del debito via accordi. Se invece i debiti sono 2 milioni ma l’attivo (tra impianti, magazzino, crediti verso clienti) vale 1,5 milioni e c’è un trend operativo che genera utili, la situazione è meno compromessa. Bilanci aggiornati, rendiconti finanziari e previsioni di flussi di cassa sono strumenti indispensabili per questa diagnosi. Il nuovo Codice all’art. 3 impone all’organo amministrativo di dotarsi di “assetti organizzativi adeguati” per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio: in pratica significa monitorare costantemente indici finanziari e segnali di allerta (indebitamento in aumento, liquidità insufficiente, ecc.) e prendere misure.
In sintesi, il debitore deve chiedersi: “La mia azienda può ancora stare in piedi se alleggerisco/riscadenzio il debito, o sto tenendo in vita un’impresa decotta?”. Dal punto di vista legale, entrambe le situazioni possono essere gestite, ma con strumenti diversi. Nel prosieguo, affronteremo prima le soluzioni che puntano alla composizione della crisi con prosecuzione dell’attività, e successivamente quelle orientate alla liquidazione dell’azienda. Va evidenziato che alcune procedure (es. composizione negoziata e accordi di ristrutturazione) possono essere avviate anche da imprese che sono già tecnicamente insolventi, non solo in stato di crisi incipiente: il recente Decreto Correttivo 136/2024 ha chiarito che la composizione negoziata è accessibile sia in crisi che in insolvenza, o addirittura già in semplice squilibrio economico-finanziario. Ciò amplia le possibilità di intervento anche per aziende in gravi difficoltà, prima di ricorrere alla liquidazione giudiziale.
Strumenti stragiudiziali di gestione della crisi
Una volta valutato lo stato dell’azienda, l’imprenditore può tentare inizialmente approcci stragiudiziali, ovvero soluzioni negoziate privatamente con i creditori, senza l’immediato ricorso a procedure concorsuali formali. Questi strumenti hanno il vantaggio di evitare la pubblicità di una procedura giudiziaria e spesso di ridurre i costi e i tempi, ma richiedono un elevato grado di cooperazione da parte dei creditori coinvolti e non offrono di per sé “scudi” automatici contro iniziative individuali dei creditori dissenzienti (salvo alcune eccezioni). Vediamo le principali opzioni:
- Rinegoziazione individuale dei debiti e accordi transattivi: l’imprenditore (direttamente o tramite un advisor legale/finanziario) può contattare singolarmente i principali creditori per patti di rientro. Ad esempio, si può chiedere ai fornitori una dilazione di pagamento (rateizzando l’arretrato su più mesi) o uno “stralcio” (saldo a fronte di uno sconto sul dovuto). Similmente, con la banca si può tentare una moratoria (sospensione temporanea dei pagamenti dei mutui) o un refinancing (nuovo prestito per pagarne uno vecchio, spesso con ipoteca aggiuntiva). Queste soluzioni non seguono schemi rigidi di legge: tutto dipende dalla contrattazione privata. Vantaggi: sono flessibili e confidenziali; se pochi creditori hanno peso dominante (es. una banca principale e un paio di fornitori chiave), può funzionare. Svantaggi: manca un effetto vincolante collettivo – un creditore non disponibile può vanificare gli sforzi degli altri; inoltre, pagamenti selettivi fatti in questa fase potrebbero essere soggetti a revocatoria se poi l’azienda fallisce entro 6 mesi/1 anno (pagamenti a fornitori) o 2 anni (pagamenti a creditori collegati). Consiglio: in questa fase, muoversi con cautela e documentare che eventuali pagamenti o concessioni avvengono nell’ottica di un piano di risanamento, così da difendersi in seguito dall’accusa di preferenze indebite.
- Piano di risanamento attestato (art. 56 CCII, ex art. 67 LF): si tratta di un accordo stragiudiziale con i creditori basato su un piano industriale e finanziario di risanamento, asseverato da un professionista indipendente (un attestatore) che ne certifichi la fattibilità e la veridicità dei dati. Il piano attestato non richiede omologazione giudiziaria né il voto dei creditori: è un contratto privato tra il debitore e tutti o alcuni creditori che accettano le proposte in esso contenute. Il vantaggio principale di formalizzare un piano attestato risiede negli effetti protettivi in caso di successivo fallimento: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti a revocatoria fallimentare (art. 166, co.3, lett. d CCII). Ciò significa che, se il piano fallisce e l’azienda viene dichiarata fallita, i creditori non rischiano di vedersi revocare i pagamenti ricevuti secondo il piano, e l’imprenditore non subisce l’azione revocatoria su atti coerenti col piano. Per ottenere questo “safe harbour”, il piano deve però essere concreto e credibile, basato su dati completi e su ipotesi realistiche di recupero dell’equilibrio economico-finanziario. Un esempio di piano attestato: l’azienda di coibentazioni elabora, con l’aiuto di un commercialista, un piano triennale in cui prevede la vendita di un immobile non strumentale e l’ingresso di un socio finanziatore, e con le risorse così ottenute propone ai creditori il pagamento del 60% dei loro crediti nell’arco di 24 mesi. Un professionista indipendente (es. un revisore) attesta che con queste misure l’azienda tornerebbe solvibile. Se le banche e fornitori principali aderiscono e la società esegue il piano, si evitano procedure concorsuali. Se anche poi qualcosa andasse storto, i creditori che hanno partecipato non devono restituire i soldi incassati – beneficio non da poco. Limiti: il piano attestato vincola solo i creditori aderenti; eventuali creditori estranei possono agire ugualmente per conto proprio. Inoltre non produce effetti di sospensione legale delle azioni (a differenza del concordato), anche se in pratica un creditore che conosce un serio piano di risanamento potrebbe astenersi dall’aggressione per dare tempo all’azienda.
- Accordi stragiudiziali plurilaterali: in alcuni casi, soprattutto quando vi è un gruppo coeso di creditori finanziari, si stipulano accordi consortili o “standstill agreements” in cui più creditori si impegnano con il debitore a non intraprendere azioni esecutive e a negoziare ristrutturazioni (ad esempio le banche di un pool concedono tempo e congelano le rate). Questi accordi hanno natura privatistica e possono essere utili prima di passare a strumenti giudiziari più strutturati, fungendo da “ponte”. Spesso si sottoscrive un MOU (memorandum of understanding) con i termini base, riservandosi di formalizzare poi un accordo di ristrutturazione omologato. Da soli, però, non risolvono il problema se non sfociano in un piano formale: sono un modo per guadagnare tempo evitando il default conclamato immediato.
- Strumenti di allerta interna e composizione stragiudiziale assistita: vale la pena ricordare che il Codice della Crisi prevedeva un sistema di allerta gestito da OCRI (organismi istituiti presso le Camere di Commercio) per aiutare le imprese in crisi ad emergere e trovare soluzioni. Questo sistema di allerta obbligatoria è stato sostituito (dall’entrata in vigore nel 2022) dalla più flessibile composizione negoziata (trattata nella sezione successiva). Oggi comunque permangono obblighi per gli organi di controllo societari di segnalare ai vertici aziendali gli indizi di crisi. L’uso di indicatori finanziari e di sistemi di controllo di gestione adeguati (come richiede l’art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) fa parte degli strumenti di prevenzione stragiudiziale: un commercialista interno o sindaco diligente può spingere l’imprenditore ad attivarsi prima che i creditori perdano la pazienza.
In generale, se la situazione non è ancora degenerata in contenziosi multipli, vale sempre la pena tentare un approccio stragiudiziale iniziale. Ciò consente, in caso di successo, di evitare l’“etichetta” della procedura concorsuale, che spesso comporta perdita di fiducia sul mercato. Tuttavia, l’imprenditore deve essere pronto a fare il passo successivo – ossia rivolgersi a strumenti giudiziari – se i creditori non collaborano o se il piano stragiudiziale non decolla. Molto importante: parallelamente ai tentativi stragiudiziali, occorre prestare attenzione al rischio di azioni esecutive e cautelari individuali. Se ad esempio un creditore sta per ottenere un pignoramento critico (magari bloccando i conti aziendali), può essere necessario ricorrere tempestivamente a una procedura concorsuale per ottenere uno stay delle azioni (sospensione), come quella che viene concessa nella composizione negoziata o nel concordato preventivo.
Nei prossimi capitoli, analizzeremo gli strumenti giudiziali o para-giudiziali per la gestione della crisi d’impresa, i quali offrono maggiori tutele normative (ma comportano anche l’ingresso del controllo dell’autorità giudiziaria). Iniziando da quello di più recente introduzione e oggi centrale nel nuovo Codice: la Composizione Negoziata della Crisi.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è una procedura volontaria “ibrida” – a metà tra stragiudiziale e giudiziale – introdotta inizialmente nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021) e ora disciplinata dal Codice della Crisi (artt. 12-25 quinquies CCII, come modificati dal D.Lgs 83/2022 e dal D.Lgs 136/2024). Si tratta di uno strumento innovativo pensato per assistere l’imprenditore in crisi o insolvenza incipiente nel negoziare con i creditori una soluzione sostenibile, con l’aiuto di un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione. La composizione negoziata è caratterizzata da riservatezza e flessibilità: non è una procedura concorsuale pubblica, ma un percorso di trattative protetto (ove necessario) da misure di tutela.
Chi vi può accedere e quando: tutte le imprese, di qualsiasi dimensione (incluse le piccole sotto soglia che non sarebbero fallibili), possono accedere alla CNC quando si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o finanziario, di crisi o anche già di insolvenza (purché reversibile). Il recente correttivo 2024 ha esplicitamente chiarito che la CNC è accessibile anche all’imprenditore in insolvenza attuale, non solo in fase di pre-crisi. È un’importante differenza rispetto ad altre procedure di regolazione della crisi, che richiedono lo stato di crisi o insolvenza ma non ammettevano il semplice “squilibrio” come requisito: per la composizione negoziata basta anche un rischio concreto di insolvenza, potendosi attivare con maggiore anticipo.
Come funziona in sintesi: l’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio, allegando informazioni sull’azienda (ultimo bilancio, situazione debitoria aggiornata, budget di tesoreria a 6-12 mesi, etc.). Una commissione nomina un esperto indipendente (tipicamente un professionista con esperienza in risanamenti) entro 5 giorni. L’esperto, accettato l’incarico, studia la situazione e inizia a facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori: il tutto in un arco di tempo di base di 180 giorni, prorogabili su richiesta motivata. Durante questo periodo, su istanza dell’imprenditore, il Tribunale può emanare misure protettive a tutela del patrimonio: in pratica un provvedimento che sospende o vieta l’inizio di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (la moratoria temporanea). Dalla nascita della CNC a fine 2024, circa il 78% delle imprese che vi hanno fatto ricorso ha richiesto misure protettive al Tribunale, segno che spesso è necessario bloccare le aggressioni per portare avanti le trattative.
L’esperto svolge un ruolo di mediatore tecnico: analizza la sostenibilità dell’azienda, individua possibili soluzioni (piani di ristrutturazione, accordi, nuovi investitori) e guida le parti verso un’intesa. Non ha poteri sostitutivi, ma la sua presenza qualificata e “super partes” aiuta a ricostruire la fiducia tra debitore e creditori. Inoltre, l’esperto riferisce periodicamente sull’andamento delle trattative e può, se riscontra atti in frode o mancanza di collaborazione dall’imprenditore, segnalare la necessità di chiudere la procedura.
Esiti possibili: la composizione negoziata si può concludere essenzialmente in tre modi: (a) con un accordo stragiudiziale tra debitore e uno o più creditori, eventualmente formalizzato in contratti o piani attestati; (b) con l’accesso a una procedura concorsuale vera e propria (ad esempio l’azienda deposita un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti, beneficiando del lavoro preparatorio svolto durante la CNC); (c) con un esito negativo (nessun accordo raggiunto). In quest’ultimo caso, il legislatore ha previsto la possibilità, all’esito della composizione negoziata fallita, per l’imprenditore di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Il concordato semplificato è una procedura introdotta nel 2021 e confermata nel Codice: consente all’imprenditore, se le trattative sono state condotte correttamente ma non hanno prodotto soluzioni praticabili, di proporre al Tribunale una cessione dei beni ai creditori, senza necessità di passare per il voto dei creditori. In sostanza, è una scorciatoia per liquidare l’impresa evitando il fallimento, ma è accessibile solo se si è tentata prima la composizione negoziata e l’esperto attesta la buona fede delle trattative. Approfondiremo meglio questo istituto più avanti.
Vantaggi della composizione negoziata:
- Tempestività e riservatezza: la procedura può essere attivata rapidamente, anche in fasi iniziali di difficoltà, e le trattative sono coperte da riservatezza (non vi è una dichiarazione ufficiale di insolvenza). Fino all’eventuale richiesta di misure protettive, l’accesso alla CNC non è pubblicizzato, evitando allarme su clienti e fornitori. Questo ha aiutato a ridurre lo stigma del fallimento, come evidenziato dal crescente numero di imprese che vi fanno ricorso: solo in Lombardia nel 2024 ci sono state 258 nuove istanze, +87% rispetto al 2023. A livello nazionale, dal 2021 a fine 2024, si registrano 1.723 istanze presentate, segno di una fiducia crescente in questo strumento come alternativa concreta al fallimento.
- Protezione del patrimonio: le misure protettive, se concesse, congelano le azioni esecutive, impedendo ad esempio che durante le trattative un creditore pignori i macchinari vitali o i crediti verso clienti. Questo “respiro” è fondamentale per negoziare efficacemente. Nel 2024, solo in Lombardia, oltre il 22% delle istanze nazionali con misure protettive proveniva da imprese lombarde, a conferma della frequente richiesta di tutela.
- Flessibilità delle soluzioni: a differenza di un concordato preventivo, la composizione negoziata non predefinisce lo schema della soluzione. Le parti, assistite dall’esperto, possono escogitare la soluzione più adatta: può essere un aumento di capitale da parte di un nuovo socio, la cessione di un ramo d’azienda a un investitore, una moratoria dei debiti per tot mesi, una conversione dei crediti in quote societarie (debt-equity swap), ecc. Persino lo Stato e gli enti previdenziali possono partecipare ad accordi in questa sede: dal 2024, il correttivo-ter ha introdotto esplicitamente la possibilità di una transazione fiscale e contributiva all’interno della composizione negoziata (nuovo art. 23 CCII). Ciò significa che l’imprenditore, con l’ausilio dell’esperto, può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS il pagamento parziale e dilazionato dei debiti erariali e contributivi come parte delle soluzioni concordate nella CNC. Prima questa opzione non era chiara, ora lo è: l’Erario può accordarsi anche in questa sede, secondo linee guida interne (ad esempio, l’AdE valuterà proposte con falcidie elevate tramite un’apposita unità centrale se superano il 70% di taglio e €30 milioni di importo).
- Continuità aziendale assistita: la CNC consente all’azienda di proseguire l’attività sotto supervisione, evitando l’effetto paralizzante di un fallimento immediato. L’imprenditore rimane alla guida (salvo comportamenti scorretti), coadiuvato dall’esperto e dai suoi consulenti. In alcuni casi, i risultati sono concreti: solo nel 2024, la CNC ha permesso il risanamento di 38 imprese lombarde salvando oltre 2.100 posti di lavoro. A livello nazionale, la percentuale di casi con esito positivo è in crescita con l’esperienza. Ciò dimostra che, se attivato tempestivamente, lo strumento può davvero favorire la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
- Neutralità e competenza dell’esperto: la presenza dell’esperto nominato dalla CCIAA garantisce che qualcuno con competenze multidisciplinari (legali, economiche) analizzi la situazione senza pregiudizi e proponga soluzioni eque. L’esperto, tenuto all’indipendenza, funge da garante di buona fede delle trattative. Le recenti modifiche normative puntano a migliorare ulteriormente il suo ruolo: per esempio, il D.Lgs 136/2024 richiede agli esperti di aggiornare il proprio CV e indicare le composizioni seguite e l’esito, così che le commissioni di nomina possano selezionare profili con esperienza pertinente e valutarne l’efficacia. Insomma, si vuole creare una “classe” di esperti della crisi d’impresa sempre più preparati.
Svantaggi o limiti della CNC:
- Adesione volontaria dei creditori: la composizione negoziata non è impositiva. Se uno o più creditori chiave rifiutano ogni ipotesi di accordo, l’esperto non può obbligarli. La riuscita dipende dalla convenienza percepita dalle parti. Per questo, spesso, se un creditore è totalmente dissenziente, la via d’uscita sarà passare a un concordato preventivo (dove certe decisioni possono essere imposte a maggioranza).
- Costi e impegno: sebbene meno costosa di un concordato (non ci sono organi come commissari o giudice delegato fissi, oltre all’esperto) la CNC richiede comunque all’impresa di dotarsi di consulenti (legale, finanziario) per predisporre dati e piani, e possibili costi di attestazioni. L’esperto ha diritto a un compenso, anche se modesto rispetto ad altre procedure (determinato secondo parametri ministeriali). Inoltre la gestione delle trattative intense per 6 mesi richiede tempo e impegno da parte dell’imprenditore, che deve essere collaborativo e trasparente (e continuare nel frattempo a gestire l’azienda).
- Mancato automatic stay iniziale: diversamente dal concordato, dove il semplice deposito della domanda in Tribunale attiva lo stay (protezione temporanea), nella CNC le misure protettive vanno richieste ad hoc e convalidate dal giudice. C’è quindi un periodo iniziale (qualche giorno o settimana) in cui l’impresa potrebbe essere esposta all’azione dei creditori prima che il tribunale emetta il decreto di protezione. Questo rischio va gestito coordinando l’istanza di CNC con eventuali accordi di standstill informali con i creditori per evitare attacchi nel frattempo.
In definitiva, la composizione negoziata è oggi considerata lo strumento di elezione per tentare un salvataggio aziendale precoce. La cultura d’impresa italiana sta iniziando a recepirlo: nel 2025 la CNC è entrata a regime ed è percepita non più come un “marchio di crisi” ma come segno di gestione responsabile. L’imprenditore che si attiva tempestivamente tramite la CNC viene visto come qualcuno che tutela proattivamente l’impresa, i lavoratori e i creditori, e non più come un fallito che dilapida patrimoni. Per il caso della nostra azienda di coibentazioni indebitata, la CNC potrebbe rappresentare il tavolo attorno al quale sedersi con la banca (per rinegoziare i mutui), con il Fisco (per proporre una transazione fiscale), con i fornitori (per concordare pagamenti parziali dilazionati magari garantiti da future commesse) e con eventuali investitori interessati a rilevare una quota dell’azienda. Sotto la guida dell’esperto, l’imprenditore mantiene il timone ma con un navigatore esperto al fianco.
Esempio pratico – Composizione negoziata in azione: “Isotec S.r.l.”, azienda toscana di coibentazione termica, con 12 dipendenti, in crisi di liquidità post-pandemia: debiti bancari €500k (mutuo su capannone), debiti fiscali €300k (IVA e ritenute non versate), debiti fornitori €200k. Il titolare vede arrivare intimazioni di pagamento dall’AdE e ingiunzioni dai fornitori. A luglio 2023 attiva la composizione negoziata. Il Tribunale gli concede misure protettive bloccando le esecuzioni. L’esperto nominato scopre che l’azienda ha buone commesse future (grazie ai bonus edilizi per isolamento acustico) e individua come soluzione: la banca accetta di allungare il mutuo di 5 anni e abbassare la rata; l’AdE accetta una transazione fiscale con pagamento del 50% del debito in 6 anni (grazie anche alla previsione di incassi futuri, attestata come realistica); i fornitori ottengono il 40% a saldo, garantito da un nuovo finanziamento prededucibile (confermato dal tribunale) erogato da un investitore locale in cambio del 30% di quote societarie. A dicembre 2023 si perfeziona un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale (strumento che vedremo nel prossimo paragrafo) che rende vincolanti queste intese. Isotec S.r.l. evita il fallimento, prosegue l’attività, e dopo 2 anni è in regolare adempimento del piano, avendo salvato l’azienda e i posti di lavoro.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)
Quando la soluzione negoziata privata appare insufficiente o vi è la necessità di vincolare anche i creditori dissenzienti entro certi limiti, uno strumento previsto dalla legge è l’accordo di ristrutturazione dei debiti. Questo istituto, introdotto già nel 2005 e ora disciplinato dagli artt. 57-64 CCII, consiste in un accordo fra il debitore e una parte qualificata dei creditori che viene poi omologato (approvato) dal Tribunale, assumendo efficacia legale verso tutti i creditori aderenti e – in talune ipotesi – anche verso alcuni non aderenti. Si può considerare un “mix” tra la negoziazione privata e il concordato: non c’è voto di tutti i creditori, ma serve il consenso di una maggioranza qualificata; il tribunale interviene per valutare legalità e fattibilità, ma la gestione resta in mano al debitore e ai creditori concordatari.
Quorum e struttura dell’accordo: per proporre un ADR, l’imprenditore deve aver raggiunto un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (percentuale calcolata sul totale passivo). Questo è il quorum ordinario. Il Codice della Crisi, in attuazione della direttiva UE 2019/1023, ha però introdotto nuove varianti: l’accordo di ristrutturazione “agevolato” che richiede solo il 30% di consensi (art. 60 CCII) e l’accordo ad efficacia estesa che permette di estendere gli effetti a creditori non aderenti appartenenti a una certa categoria (ad es. banche dissenzienti minoritarie, se il 75% delle esposizioni finanziarie ha aderito – art. 61 CCII). L’accordo agevolato al 30% è ammesso a condizioni stringenti: in particolare, il debitore non deve chiedere una moratoria superiore a 120 giorni per i creditori estranei privilegiati e deve assicurare a eventuali creditori non aderenti il pagamento di almeno il 10% del loro credito chirografario. Questa forma riduce drasticamente il quorum, ma implica in sostanza che i non aderenti vengano soddisfatti in misura significativa (non può essere un taglio “estremo” imposto a chi non firma). Tali previsioni mirano a rendere più accessibili gli accordi nelle situazioni in cui ottenere il 60% di consensi sarebbe impossibile.
L’accordo di ristrutturazione richiede la relazione di un esperto attestatore (un professionista indipendente) che asseveri la veridicità dei dati aziendali e l’idoneità dell’accordo a assicurare il pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (ad esempio, che i non aderenti riceveranno almeno quanto avrebbero ottenuto da una liquidazione giudiziale dell’impresa). L’accordo viene poi depositato in Tribunale insieme a tutta la documentazione (bilanci, elenco creditori, relazione attestatore ecc.) e il Tribunale, se tutto regolare, omologa l’accordo con decreto. Da notare che non c’è votazione da parte di tutti i creditori in udienza come nel concordato; i consensi vanno raccolti prima (manifestazioni di assenso scritte). I creditori che hanno aderito restano vincolati nei termini pattuiti (ad es. accettano un pagamento parziale dilazionato e rinunciano a eventuali azioni esecutive individuali), mentre i creditori estranei (non firmatari) rimangono liberi di agire: per questo il debitore spesso contesta eventuali loro iniziative chiedendo misure protettive contestuali al deposito dell’accordo (possibile ex art. 54 CCII per congelare azioni sino all’omologa).
Trattamento dei crediti particolari (Erario, INPS): un tempo, per includere il Fisco e gli enti previdenziali in un accordo di ristrutturazione, era necessario ricorrere alla transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. (ora ripresa negli artt. 63 e 88 CCII per accordi e concordati). Oggi l’accordo può contenere la proposta di pagamento parziale/dilazionato dei tributi e contributi, che dev’essere approvata da Agenzia Entrate e INPS secondo le loro procedure. Importante novità: se l’Erario (o l’INPS) rifiuta ingiustificatamente l’adesione e il suo credito è determinante, il debitore può chiedere al Tribunale di omologare ugualmente l’accordo (cram-down fiscale) purché il piano offra al Fisco almeno il valore di mercato che otterrebbe nella liquidazione. Questa omologazione forzosa, introdotta nel 2020 e confermata dal Codice, consente di superare eventuali dinieghi arbitrari del Fisco. Tuttavia, il legislatore nel 2023-2024 ha stabilito un controllo più centralizzato per falcidie fiscali molto elevate: se la proposta al Fisco prevede di tagliare oltre il 70% del debito fiscale e più di €30 milioni, deve esprimersi la Direzione generale centrale delle Entrate, non la sede locale. Ciò per assicurare uniformità nelle decisioni su grandi esposizioni erariali.
Effetti dell’omologazione: con il decreto di omologa, l’accordo di ristrutturazione diviene vincolante per le parti che vi hanno aderito e cristallizza la posizione: i creditori aderenti non possono più agire esecutivamente se rispettate le condizioni dell’accordo, e l’eventuale violazione dell’accordo sarà gestibile solo come azione contrattuale. I creditori estranei, invece, rimangono liberi di agire per conto loro (salvo l’eventuale protezione temporanea concessa fino all’omologa). Per questo è cruciale che l’accordo copra la maggior parte del ceto creditorio e che per i pochi estranei siano previste risorse a parte per soddisfarli (ad esempio, l’imprenditore può decidere di pagarli integralmente a scadenza per eliminarli dal tavolo).
Misure protettive e gestione interim: similmente al concordato, l’imprenditore che deposita un accordo di ristrutturazione può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive dei creditori per tutelare l’impresa fino all’omologazione (art. 54 CCII). Inoltre, il correttivo 2024 ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere l’autorizzazione dal tribunale a pagare fornitori strategici o continuare contratti in corso nonostante la pendenza dell’omologa, allo scopo di non distruggere la continuità aziendale prima che l’accordo produca effetti (questo era previsto già nel D.L. 118/2021 per il periodo di composizione negoziata; ora è consolidato).
Confronto con la composizione negoziata: spesso la linea di demarcazione è la formalità e il coinvolgimento del tribunale. La composizione negoziata è volontaria e stragiudiziale, l’accordo di ristrutturazione è volontario ma con sigillo giudiziale. Può capitare che una CNC ben avviata sfoci proprio in un ADR: si negozia con tutti sotto l’egida dell’esperto e poi si formalizza un accordo con la maggioranza dei creditori e lo si omologa, in modo da dargli forza esecutiva. Questo consente, tra l’altro, di usufruire di talune agevolazioni fiscali: ad esempio, in passato i concordati preventivi godevano di esenzioni da alcune imposte, mentre per la composizione negoziata l’Agenzia Entrate inizialmente negava i benefici (confermato nel 2023), spingendo i debitori a preferire accordi omologati o concordati per avere un miglior trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da stralcio.
Varianti particolari di ADR nel CCII: oltre all’accordo agevolato (30%) e all’accordo esteso, esistono:
- La convenzione di moratoria (art. 62 CCII): un accordo stipulato con banche e intermediari finanziari per moratorie o standstill, che può essere omologato ed esteso anche agli altri finanziatori dissenzienti della stessa categoria, se la maggioranza ha aderito. È uno strumento di nicchia per gestire in modo uniforme l’accordo con il ceto bancario.
- Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): introdotto dal correttivo 2022 (artt. 64-bis e seguenti CCII), è una procedura assimilabile a un concordato semplificato nei quorum, in cui il debitore propone un piano ai creditori divisi in classi, con eventuale omologazione anche in caso di dissenso di classi minoritarie (cram-down interclassi). Il PRO è destinato a imprese medio-grandi (non PMI sotto soglia) e richiede l’approvazione del piano da parte di tutte le classi di creditori votanti, salvo la possibilità di forzare il dissenso di alcune classi con l’intervento del tribunale se certe condizioni sono rispettate. Di fatto, il PRO rappresenta l’attuazione delle procedure di ristrutturazione preventiva richieste dalla direttiva UE: consente di derogare alle regole ordinarie di distribuzione dell’attivo e di alterare la parità di trattamento, purché si raccolgano consensi qualificati in ciascuna classe. È un tema tecnico che esula dal caso della nostra PMI tipo, ma va menzionato come ulteriore opzione avanzata. Nel PRO il tribunale nomina un Commissario Giudiziale che vigila sulle operazioni e riferisce (un elemento di controllo pubblico in più rispetto ad un ADR). Se volessimo collocarlo in uno spettro, il PRO sta a metà tra un accordo e un concordato: è definito “strumento ibrido” dalla dottrina.
Perché usare un accordo di ristrutturazione? Per un’azienda come la nostra (coibentazioni, PMI), un ADR può essere preferibile al concordato quando: (i) si ha già il supporto della maggior parte dei creditori chiave (quindi è fattibile contrattualmente), (ii) si vogliono evitare le complessità di un voto esteso a centinaia di piccoli creditori (nel concordato tutti votano, direttamente o in classi), (iii) si desidera maggiore riservatezza (l’accordo, pur essendo pubblico all’omologa, può essere gestito più lontano dai riflettori rispetto a un concordato che inizia con un ricorso pubblicato subito). Inoltre, l’ADR non richiede le soglie di soddisfacimento minime previste per il concordato liquidatorio (20% ai chirografari) – in teoria si potrebbe omologare un accordo dove i chirografari prendono meno del 20%, se essi stessi lo hanno accettato e i non aderenti vengono comunque pagati almeno quanto avrebbero in fallimento (che potrebbe essere anche zero). Quindi l’ADR offre più flessibilità di contenuto.
Esempio pratico – Accordo di ristrutturazione: “TermoAcustica S.p.A.” ha debiti totali €5 milioni. Dopo trattative in composizione negoziata, riesce a farsi firmare un accordo da creditori rappresentanti il 65% del debito (banche e fornitori maggiori). Il piano prevede che banche e fornitori firmatari accettino un pagamento del 60% in 4 anni. I piccoli creditori (35% del debito) rimangono fuori dall’accordo, ma il piano prevede che saranno pagati integralmente entro 6 mesi dall’omologa, grazie a un apporto di finanza esterna di un investitore (che entra nel capitale della società). L’attestatore assevera che i creditori estranei verranno soddisfatti al 100%, ben più di quanto avrebbero in un fallimento (stimato 40%). Si deposita l’accordo di ristrutturazione “agevolato” ex art. 60 CCII, usufruendo del quorum ridotto al 30% (ampiamente superato dal 65% ottenuto) e nessuna moratoria sui privilegiati (infatti i piccoli creditori estranei vengono pagati subito e in più al 100%). Il Tribunale omologa l’accordo. Risultato: i grandi creditori si vincolano a incassare 3 milioni su 5 (accettando lo sconto), i piccoli prendono tutto ma dilazionato di qualche mese; l’investitore nuovo socio mette liquidità fresca. L’azienda evita il fallimento e risana i conti. Se qualche piccolo creditore avesse provato nel frattempo a pignorare, l’azienda aveva ottenuto dal giudice la sospensione temporanea delle azioni esecutive fino all’omologa.
In conclusione, gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento potente quando c’è coesione tra i creditori principali. Offrono una cornice legale robusta con relativa snellezza procedurale. Per contro, se i creditori sono molti e conflittuali, o l’accordo non raggiunge le maggioranze richieste, bisogna ricorrere al più strutturato concordato preventivo, di cui ora parleremo.
Concordato preventivo (in continuità e liquidatorio)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza per evitare la liquidazione fallimentare, presente da decenni nel nostro ordinamento (già nel R.D. 267/1942, ora disciplinata dagli artt. 84-120 CCII). Si tratta di una procedura giudiziale in cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai propri creditori un piano e una percentuale di soddisfacimento in alternativa al fallimento; i creditori votano la proposta e, se approvata dalle maggioranze di legge e omologata dal tribunale, il piano viene attuato sotto controllo degli organi della procedura. Il concordato preventivo può avere due finalità fondamentali: la continuità aziendale (salvare l’impresa come attività in esercizio) oppure la liquidazione del patrimonio (chiudere l’impresa ma evitando il fallimento, garantendo ai creditori un soddisfacimento concordato). La distinzione è cruciale perché la legge prevede condizioni e incentivi diversi a seconda del tipo.
Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): il debitore propone un piano che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia direttamente dalla stessa società (continuità diretta) sia tramite un terzo (ad es. cessione o affitto d’azienda a un soggetto che prosegue l’attività – continuità indiretta). In un concordato in continuità, l’azienda viene mantenuta in vita e i creditori vengono soddisfatti in gran parte o in misura prevalente attraverso i flussi di cassa generati dalla gestione corrente e futura (e/o dalla cessione di asset non essenziali). Il Codice della Crisi incoraggia la continuità come strumento per preservare il valore economico e i posti di lavoro: ad esempio, non fissa una soglia minima di pagamento per i creditori chirografari nel concordato in continuità (diversamente dal liquidatorio), purché sia rispettato il cosiddetto “test di convenienza” (i creditori non devono ricevere meno di quanto otterrebbero nella liquidazione fallimentare). Nel piano in continuità, è possibile la falcidia (riduzione) anche dei crediti privilegiati, a condizione di garantire che ricevano almeno il valore del bene su cui hanno prelazione o il valore di liquidazione (art. 84, co.5 CCII). Ciò consente, per esempio, di pagare parzialmente anche il Fisco o le banche ipotecarie, purché un perito valutatore attesti che la percentuale offerta è pari o superiore a quanto quei creditori otterrebbero vendendo il bene su cui hanno garanzia. Inoltre, nel concordato in continuità diretta, la legge consente al debitore di chiedere di mantenere attivi i contratti in corso essenziali e di ottenere autorizzazioni per nuova finanza interinale (prededucibile) durante la procedura, al fine di agevolare la prosecuzione aziendale.
Concordato liquidatorio: il debitore propone di soddisfare i creditori attraverso la cessione o liquidazione di tutti i propri beni (spesso la società poi verrà sciolta). In pratica, è un’alternativa pilotata al fallimento: l’imprenditore offre ai creditori di vendere l’attivo e distribuire il ricavato secondo certe percentuali concordate, eventualmente integrato da risorse esterne. Per evitare concordati “liquidatori” opportunistici che paghino pochissimo, il legislatore ha imposto alcune condizioni: (1) nel concordato liquidatorio puro, i creditori chirografari non possono ricevere meno del 20% del loro credito, salvo che vengano apportate risorse esterne che aumentino in modo significativo la soddisfazione (se almeno il 10% dell’attivo proviene da finanza esterna, la percentuale minima può essere ridotta); (2) è obbligatorio liquidare tutto il patrimonio (a differenza del concordato in continuità dove puoi tenere i beni funzionali all’esercizio); (3) se ci sono debiti fiscali, per legge vanno pagati almeno in misura pari a quanto ricaverebbe l’Erario dalla liquidazione (quindi in un liquidatorio standard, spesso significa pagarli quasi interamente, essendo privilegiati). Il concordato semplificato di cui parlavamo prima è di fatto una forma di concordato liquidatorio (si cede il patrimonio) ma semplificato perché senza voto dei creditori e attivabile solo dopo composizione negoziata fallita.
Procedura di concordato in breve: l’imprenditore presenta un ricorso al Tribunale proponendo il concordato, allegando il piano e tutti i documenti (situazione patrimoniale, elenco creditori, relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità e sulla capienza del piano, ecc.). Può anche presentare inizialmente una domanda “in bianco” o con riserva (art. 40 CCII) se ha bisogno di tempo per perfezionare la proposta: in tal caso il tribunale dà un termine (di norma 60-120 giorni) per depositare il piano definitivo, e nel frattempo vengono concesse misure protettive e nominato un commissario giudiziale provvisorio. Una volta depositata la proposta definitiva, il tribunale verifica la completezza e l’ammissibilità (ad esempio controllo che siano rispettate le soglie del 20% se liquidatorio, che il piano non sia manifestamente infeasible, ecc.). Se ammette il concordato, nomina un Commissario Giudiziale (un professionista che vigila sull’operato del debitore durante la procedura) e dispone la convocazione dei creditori per il voto. I creditori vengono suddivisi in classi se hanno posizioni giuridico-economiche differenti (es. separare fornitori chirografari dalle banche chirografarie, o distinguere tra privilegiati per grado se ve ne sono molti). La proposta concordataria può anche prevedere che i soci effettuino un certo apporto, o che alcuni beni vengano liquidati immediatamente a un acquirente individuato (offerta irrevocabile allegata). Il Commissario redige una relazione per i creditori. All’adunanza (o via voto scritto) i creditori votano: serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza per teste se non si fanno classi, oppure maggioranza in ogni classe più la maggioranza assoluta sul totale se ci sono classi). Se la proposta ottiene i voti richiesti, si passa all’omologa: il Tribunale omologa con decreto, verificato il rispetto delle norme (in particolare il “test di soddisfazione comparativa”, cioè che nessun creditore dissenziente prenda meno di quanto otterrebbe in liquidazione fallimentare). In caso di opposizioni di creditori dissenzienti, decide la Corte d’Appello. Una volta omologato, il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori (anche quelli che hanno votato contro o non votato): questi non potranno più agire per pretese diverse da quanto stabilito nel concordato. Il debitore sotto supervisione esegue il piano; il tribunale dichiara la chiusura una volta attuato.
Misure a tutela durante il concordato: dall’inizio il debitore gode dello stay delle azioni esecutive (nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti, né acquisire privilegi se non concordati) – condizione essenziale per lavorare al risanamento. Gli amministratori restano in carica ma sotto l’osservazione del Commissario e con atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione del giudice delegato (per evitare esodi di beni o favoritismi in pendenza della procedura). Nel caso di concordato in continuità, il debitore può chiedere al tribunale di poter pagare fornitori strategici o di poter continuare contratti essenziali (es. un leasing su macchinario produttivo) per non interrompere l’attività. Può anche ottenere finanziamenti prededucibili (che verranno cioè rimborsati prima di altri debiti) per sostenere la gestione interim – previa perizia che certifichi che questi finanziamenti sono necessari e a condizioni di mercato. Queste possibilità sono state ampliate con la riforma, per rendere più praticabile la via della continuità.
Esdebitazione dell’imprenditore: se parliamo di una società di capitali, l’eventuale debito residuo dopo l’esecuzione del concordato rimane a carico della società, ma se l’attività cessa, di fatto quei debiti insoddisfatti restano inesigibili (la società verrà poi cancellata). Se invece l’imprenditore è una persona fisica (impresa individuale), in caso di concordato liquidatorio c’è la possibilità di chiedere l’esdebitazione per liberarsi dai debiti residui (era prevista solo post-fallimento fino a qualche anno fa, ora il CCII la estende anche alla chiusura di concordati e liquidazioni controllate per sovraindebitamento). Nel concordato in continuità, idealmente, tutti i debiti concorsuali dovrebbero essere pagati secondo il piano, quindi non residuano esposizioni da esdebitare.
Concordato semplificato (post Composizione Negoziata): va menzionato che, se la composizione negoziata fallisce, l’imprenditore può – entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto – presentare un concordato semplificato liquidatorio: qui non c’è voto dei creditori, decide solo il Tribunale se omologarlo, valutando che ai creditori venga offerto almeno il ricavato della liquidazione più eventuale extra, e che le trattative precedenti siano state condotte correttamente. È uno strumento eccezionale, da usare come ultima spiaggia, e che sacrifica il diritto di voto dei creditori in nome di un risparmio di tempo (utile se c’è urgenza di vendere beni che altrimenti perderebbero valore, ad esempio).
Costi e tempi del concordato: è la procedura più complessa, per cui i costi professionali (avvocati, commercialisti, attestatori, compenso del commissario) e i tempi sono significativi. Dati empirici indicavano che un concordato preventivo richiedeva in media 1-2 anni dalla domanda all’omologa e altrettanto per la fase di esecuzione finale. Le riforme hanno cercato di accelerare, ma resta un iter formalizzato. È il prezzo da pagare per ottenere un effetto universale (tutti i creditori sono coinvolti e vincolati).
Confronto con altri strumenti: il punto di forza del concordato è l’universalità: a differenza di un piano attestato o un accordo ADR, qui tutti i creditori (anche i dissenzienti) sono coinvolti e vincolati dalla soluzione, se approvata a maggioranza qualificata. Inoltre, il concordato consente di gestire situazioni di conflitto estremo dove solo un intervento eteronomo può risolvere (pensiamo a creditori litigiosi tra loro, o necessità di cram-down su classi dissenzienti: nel concordato con classi, il tribunale può anche omologare nonostante il voto contrario di una classe se ritiene rispettato l’equilibrio distributivo e la convenienza per quella classe). Lo svantaggio è che, essendo procedura concorsuale pubblica, comporta perdita di reputazione e fiducia commerciale (clienti e fornitori vengono a sapere, contratti in corso possono risentirne, ecc.), oltre alla rigidità di certe norme (ad esempio obbligo di depositare subito il 20% dell’attivo in caso di concordato con riserva liquidatorio – requisito aggiunto per scoraggiare i concordati dilatori, anche se il correttivo l’ha mitigato). Inoltre, le procedure concorsuali sospendono o fanno decadere alcuni benefici: ad esempio, i contratti pubblici spesso vengono risolti se l’appaltatore chiede il concordato salvo autorizzazioni alla continuità; oppure i bonus fiscali (come il credito d’imposta) possono essere non fruibili in costanza di concordato.
Esempio pratico – Concordato preventivo in continuità: “AcustiCoibenti S.r.l.” ha debiti totali 1 milione e l’attività può essere profittevole se alleggerita dal debito. Presenta un concordato di continuità: prevede di pagare integralmente IVA e INPS (€200k) in 4 anni con i flussi di cassa futuri, pagare al 30% i chirografari (€800k di fornitori, che quindi riceveranno €240k in 4 anni), mantenendo aperta l’azienda. Offre anche ai creditori un’“utile” futura: se nei 5 anni successivi la società torna in utile, una percentuale di utili sarà destinata ad aumentare i pagamenti concordatari. I creditori votano: l’Erario (privilegiato) non vota ma è soddisfatto integralmente, i fornitori votano e, persuasi che il 30% è meglio del presumibile 5% in caso di fallimento, approvano all’80% di maggioranza. Il concordato è omologato. La società, protetta durante la procedura, continua a lavorare; il commissario supervisiona che venga accantonata ogni anno la liquidità per pagare le rate ai creditori. Dopo 4 anni, la società è ancora attiva e ha onorato il piano: i creditori chirografari hanno ricevuto 0,30€/€ di credito – non l’ideale, ma meglio di nulla.
Esempio pratico – Concordato liquidatorio: “ThermoSilent S.p.A.” è insolvente senza rimedio. Presenta un concordato liquidatorio: cederà tutti i beni (capannone, macchinari, crediti) e un investitore esterno offre €100k per rilevare un brevetto aziendale. Il totale attivo stimato da liquidare è €500k; i debiti superano 2 milioni. I creditori privilegiati (Fisco, banca con ipoteca) verranno pagati per il 70% (non c’è abbastanza attivo per pagarli al 100%); i chirografari riceveranno il 20% esatto grazie anche ai €100k dell’investitore (rispettando il minimo di legge). I creditori votano: i privilegiati, pur perdendo un 30%, accettano considerando che in fallimento forse avrebbero preso anche meno; i chirografari vedono garantito il 20% contro il probabilissimo zero in fallimento, quindi approvano. Concordato omologato e beni venduti in 6 mesi; la società poi viene cancellata. I debiti residui si estinguono in capo alla società cessata, mentre l’imprenditore (persona fisica, in questo caso socio di riferimento) non ha obblighi diretti residui se non per eventuali fideiussioni personali (che lui dovrà gestire separatamente, magari con una procedura di sovraindebitamento personale se incapiente).
Riassumendo, il concordato preventivo è lo strumento principe per affrontare in modo organizzato l’insolvenza quando serve coinvolgere tutti i creditori. Richiede un iter più lungo e complesso, ma offre l’unico quadro che consente di imporre soluzioni a eventuali minoranze dissenzienti (nel rispetto delle garanzie). Va intrapreso con il supporto di legali e consulenti esperti, dati i tecnicismi. Nel contesto della nostra guida, l’imprenditore con azienda indebitata potrebbe considerarlo se: i debiti sono troppo alti per ottenere consensi informali, oppure se ci sono molti creditori disallineati, oppure se serve il potere di cram-down (forzare qualcuno ad accettare il piano). È spesso l’ultima spiaggia prima del fallimento, ma può concludersi in un rilancio aziendale se in continuità, o in una chiusura meno traumatica se liquidatorio.
Strumenti per il sovraindebitamento (piccole imprese e privati)
Finora abbiamo parlato di strumenti destinati in genere alle imprese commerciali soggette al fallimento (ossia quelle sopra certe soglie dimensionali, tipicamente società di capitali o imprese individuali non micro). Ma cosa accade se l’azienda indebitata è molto piccola o se a essere oberato dai debiti è direttamente l’imprenditore persona fisica (ad es. l’artigiano, il socio illimitatamente responsabile, o il garante escusso dalla banca)? In questi casi entrano in gioco le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate ora dagli artt. 65-83 CCII (che hanno sostituito la Legge 3/2012). Il sovraindebitamento è definito come la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte, di soggetti non fallibili (piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, consumatori, start-up innovative, imprenditori agricoli, ecc.).
Gli strumenti previsti (aggiornati dal correttivo 2024) sono principalmente tre:
- Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-68 CCII): riservato ai consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. È l’erede del “piano del consumatore” della L.3/2012, ma ampliato. Ora anche il socio illimitatamente responsabile di una snc o sas, limitatamente ai debiti personali estranei all’impresa sociale, può essere considerato consumatore e accedere a questa procedura. Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori: è il giudice che omologa se ritiene la proposta fattibile e conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, verificata anche l’assenza di colpa grave del consumatore nell’indebitamento. Il consumatore deve offrire una percentuale di rimborso dei debiti compatibile col suo reddito e patrimonio (ad es., può proporre di pagare il 50% dei debiti chirografari in 5 anni attingendo al suo stipendio futuro). Con il correttivo 2024, è stata prevista la possibilità di inserire nel piano una moratoria fino a 2 anni per pagare i crediti privilegiati o con ipoteca, elemento prima controverso. Il giudice, sentito l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e i creditori (che possono fare opposizione), decide se omologare. In caso positivo, il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Se il consumatore adempie regolarmente, al termine otterrà l’esdebitazione dei debiti residui non pagati (tranne quelli non falcidiabili, es. debiti da risarcimento danni per fatti illeciti, mantenimenti familiari, ecc.).
- Il concordato minore (artt. 74-83 CCII): destinato ai debitori non fallibili che siano imprenditori o soggetti diversi dal consumatore. È analogo al concordato preventivo ma per piccole realtà. Richiede il voto dei creditori (maggioranza dei crediti) e prevede un piano che può essere in continuità o liquidatorio. È una versione semplificata perché gestita dall’OCC e pensata per dimensioni ridotte, ma nella sostanza funziona come un concordato: offre una percentuale ai creditori, possibilmente diversa per classi, e se approvata viene omologata dal tribunale. Ad esempio, un artigiano indebitato che non fallisce può proporre un concordato minore offrendo il 30% ai creditori chirografari grazie all’aiuto di parenti che mettono liquidità. I creditori votano (non sono adunati in tribunale ma esprimono voto scritto all’OCC). Serve sempre un giudizio di convenienza ex “best interest test”. Il concordato minore è utile perché consente anche a chi sta sotto soglia di chiudere la crisi in modo negoziale con l’accordo della maggioranza creditori. Non vi è soglia fissa del 20% come nel concordato preventivo, ma il piano deve comunque garantire ai chirografari qualcosa e rispettare il test di convenienza.
- La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): è il corrispondente del fallimento per i soggetti non fallibili. Si attiva su richiesta del debitore sovraindebitato (o di un creditore, in certi casi) e comporta la liquidazione di tutti i beni da parte di un liquidatore nominato dal giudice, con riparto ai creditori secondo le cause di prelazione. La differenza rispetto al vecchio fallimento è che la liquidazione controllata è pensata per piccole masse attive, con una procedura semplificata e costi ridotti tramite l’OCC. Al termine, la persona fisica può chiedere l’esdebitazione dai debiti residui, liberandosi (fresh start). Il Codice prevede che la liquidazione controllata duri al massimo 3 anni dall’apertura – un limite temporale per non protrarre troppo la situazione.
Esiste inoltre l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII, ex L.3/2012 “esdebitazione di nullatenente”): se una persona fisica sovraindebitata non ha alcun patrimonio liquidabile né redditi pignorabili, può chiedere comunque al giudice di essere liberato dai debiti residui senza offrire nulla ai creditori, a patto di aver meritato questa clemenza (non deve aver frodato creditori e non deve poter effettivamente pagare nulla). È una sorta di beneficio una tantum, concesso non più di una volta ogni 5 anni, per dare la possibilità di ripartire da zero a chi è totalmente schiacciato dai debiti senza colpa grave. Il correttivo-ter del 2024 ha peraltro eliminato un precedente limite, stabilendo che aver già utilizzato altre procedure da sovraindebitamento nei 5 anni precedenti non è più ostativo all’accesso (conta solo se si è già ottenuta un’esdebitazione nei 5 anni). Ciò amplia la platea dei possibili beneficiari.
Procedura OCC: tutte le procedure di sovraindebitamento prevedono il coinvolgimento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), di solito un organismo istituito presso Ordini professionali o Camere di Commercio, che nomina un gestore (professionista) per assistere il debitore nel predisporre la proposta e per fungere da ausilio del giudice. Il ruolo dell’OCC è simile a quello del curatore/commissario ma con funzione più di consulenza e verifica. Il correttivo 2024 ha potenziato gli OCC ad esempio dando loro accesso alle banche dati per ricostruire le esposizioni e attivi del debitore.
Rilevanza per l’imprenditore della nostra azienda in crisi: se la società di coibentazioni è, poniamo, una S.n.c. o S.a.s. artigiana sotto soglia di fallibilità (fatturato, attivo e debiti molto bassi), allora essa non potrebbe chiedere un concordato preventivo normale, ma può accedere al concordato minore. Se invece si tratta di un imprenditore individuale (artigiano edile specializzato in coibentazioni), e i debiti superano il suo patrimonio, potrà fare un piano del consumatore (per i debiti personali, magari di famiglia) o un concordato minore (per quelli attinenti all’attività, se la prosegue), oppure direttamente una liquidazione controllata se intende chiudere bottega. Ad esempio, Mario, artigiano, ha debiti per 200.000€ tra fisco e fornitori, non è fallibile. Potrebbe proporre un piano del consumatore se la gran parte sono debiti personali (es. prestiti, carte di credito) – magari offre il 30% usando la pensione integrativa o aiuti familiari. Oppure se i debiti sono dell’attività, propone un concordato minore liquidatorio offrendo ai creditori il ricavato della vendita del furgone e dell’attrezzatura (diciamo 50.000€) – i creditori votano e se approvano, lui paga quell’importo e viene esdebitato del resto.
Novità 2024 su procedure minori: il decreto correttivo ha introdotto importanti novità: una già detta è che non è più ammessa la domanda in bianco per concordato minore o piano consumatore – quindi occorre presentare fin da subito la proposta completa (per evitare che si usi la riserva solo per dilatare i tempi senza controllo). Altra modifica: la definizione di consumatore è stata ampliata (socio illimitato può essere consumatore per debiti estranei all’impresa). Inoltre, i membri di una stessa famiglia sovraindebitati possono presentare un unico progetto di composizione familiare se la causa dell’indebitamento è comune: ad es. marito e moglie coobbligati possono fare un unico piano per la famiglia, semplificando il procedimento. Questo aiuta soprattutto le famiglie travolte da crisi (pensiamo a mutui e finanziamenti cointestati).
Esdebitazione e tempi: come accennato, dopo la chiusura di una liquidazione controllata o di un concordato minore liquidatorio, la persona fisica ottiene la cancellazione dei debiti non soddisfatti. Il Codice ha reso di fatto automatica l’esdebitazione se non ci sono opposizioni dei creditori, eliminando l’onere di una causa separata e il potere discrezionale eccessivo del giudice. Inoltre, ha ridotto a 3 anni la durata massima di una procedura liquidatoria, trascorsi i quali comunque deve arrivare l’esdebitazione (anche se la liquidazione non ha pagato nulla). Questo recepisce il principio europeo del fresh start: nessuno deve restare debitore a vita incapacitato, se ha agito onestamente e ha subito un fallimento.
Conclusione su sovraindebitamento: dal punto di vista dell’imprenditore, è cruciale sapere che esistono vie d’uscita anche per i debiti personali derivanti dal fallimento dell’impresa. Spesso chi gestisce una PMI si indebita anche personalmente (garanzie personali, prestiti personali immessi in azienda, debiti fiscali personali, ecc.). Le procedure di sovraindebitamento permettono di affrontare il cumulo di debiti residui in modo ordinato e con possibilità di stralcio significativo, una volta liquidato il possibile. La prospettiva di un “fresh start” dopo gli errori imprenditoriali è ormai parte integrante dell’ordinamento, in linea con la filosofia di dare una seconda chance all’imprenditore sfortunato ma onesto.
La transazione fiscale e contributiva: come trattare i debiti verso Erario e INPS
Un capitolo a sé merita la gestione dei debiti fiscali e previdenziali in situazioni di crisi d’impresa, poiché questi crediti per legge hanno un trattamento rigoroso ma – proprio per questo – il legislatore ha previsto strumenti ad hoc per trovare compromessi. La transazione fiscale (e la parallela transazione previdenziale) è l’istituto che consente all’impresa in procedura concorsuale o in composizione negoziata di proporre allo Stato di accontentarsi di una parte del credito tributario o contributivo, rinunciando a sanzioni e interessi e talvolta anche a quota di imposta, oppure di accettare un pagamento dilazionato più lungo di quello ordinario.
Ambito di applicazione: come riepilogato dal portale specializzato “Transazione Fiscale”, possono usare la transazione fiscale tutte le imprese in crisi nel contesto di specifiche procedure: composizione negoziata, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), concordato preventivo (anche semplificato) e accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché nell’ambito della liquidazione giudiziale tramite un concordato fallimentare (ora chiamato “concordato nella liquidazione giudiziale”). Fuori da queste situazioni, non è possibile “trattare” discrezionalmente con il Fisco: in bonis l’Erario può solo concedere rateazioni standard (max 6 anni, salvo eccezioni) o aderire a rottamazioni/cartelle se previste da norme generali.
Oggetto della transazione: l’impresa può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato di tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IVA, imposte sui redditi, IRAP, ritenute, registro, accise, ecc.) e dei relativi accessori (sanzioni e interessi), nonché dei contributi previdenziali INPS/INAIL (tramite transazione previdenziale). Sono inclusi anche i debiti affidati all’Agente Riscossione (cartelle) e quelli accertati ma non ancora in riscossione. In passato c’era una limitazione: l’IVA e le ritenute non potevano essere falcidiate per un presunto divieto europeo, ma la giurisprudenza – e ora il Codice – consentono di includerle, a condizione che la proposta sia conveniente (meglio di quanto lo Stato otterrebbe in caso di fallimento). Quindi tutti i debiti fiscali e contributivi possono essere oggetto di transazione.
Vantaggi ottenibili: secondo gli esperti, si possono ottenere sconti importanti – in alcuni casi l’Erario accetta stralci oltre l’80%, quindi pagare meno del 20% del dovuto – se risulta che nella liquidazione fallimentare esso incasserebbe zero (tipico quando l’attivo è assorbito da ipoteche di banche prioritarie o non ci sono beni). Inoltre, si può allungare la dilazione ben oltre i piani ordinari: si vedono transazioni con pagamento in 10-15 anni, laddove normalmente l’Agenzia Entrate Riscossione non va oltre 6 anni (72 rate). Questo può fare la differenza per la sostenibilità di un concordato.
Procedura: la proposta di transazione fiscale è inserita nel piano di concordato o nell’accordo di ristrutturazione presentato. Parallelamente, il debitore la trasmette all’ente creditore (Agenzia Entrate o INPS) con la documentazione economica. L’Agenzia la valuta tramite un ufficio specializzato (“ufficio tutela del credito erariale e crisi aziendali”): se la falcidia proposta supera il 70% e €30 milioni, decide la Direzione Centrale come visto, altrimenti la Direzione Regionale. L’ente risponde con atto formale di adesione o diniego. Nel concordato, questo atto vale come voto del creditore pubblico; nell’accordo ADR, vale come sottoscrizione.
Criteri di valutazione: l’Erario applica un principio base: massimizzazione del recupero rispetto all’alternativa liquidatoria. Ciò significa che normalmente approverà la transazione se il piano offre più soldi (o in tempi non peggiori) di quanti ne incasserebbe dal fallimento del debitore. A tal fine, il piano di concordato deve contenere un’analisi comparativa dettagliata di cosa otterrebbero Fisco e INPS nel “scenario di liquidazione giudiziale” e assicurare che la proposta è quantomeno pari. Un caso tipico: l’Erario ha un privilegio generale sul circolante che però in fallimento, dopo le spese e i superprivilegi dei lavoratori, frutterebbe il 5%; l’impresa propone di pagare il 15%. L’Erario dovrebbe accettare (tre volte tanto). Se però l’Erario è ipotecario su un immobile, e in concordato lo si liquida, si dovrebbe garantirgli il valore di perizia di quell’immobile (non lo si può pagare meno se quell’immobile è dedicato a lui). Quindi, i margini di sconto sono ampi quando il Fisco sarebbe altrimenti in gran parte insoddisfatto.
Limitazioni normative: per evitare abusi, è previsto che la totalità delle somme offerte in transazione vadano prima a coprire il capitale dell’imposta e i contributi, poi eventualmente una parte di interessi, mentre le sanzioni possono essere abbattute integralmente (nella prassi spesso vengono azzerate le sanzioni e ridotti gli interessi, pagando solo una frazione del tributo). Inoltre, durante le trattative di composizione negoziata, il D.Lgs 83/2022 aveva temporaneamente introdotto la possibilità di chiedere la sospensione di alcuni versamenti fiscali per facilitare l’esito delle trattative: oggi, con la transazione possibile nella CNC, l’imprenditore può includere la proposta direttamente lì.
Esempio di transazione fiscale in concordato: la nostra azienda ha €300k di debiti IVA e IRPEF. In fallimento, stima che il Fisco prenderebbe 50k (perché i beni valgono poco e ci sono altri privilegiati). Propone in concordato di pagarne 100k in 5 anni, cioè circa il 33%. L’Agenzia Entrate valuta che 100k a 5 anni (magari attualizzati a 80k) è meglio di 50k incerti e tardivi: aderisce. Le sanzioni per 50k e interessi per 20k vengono stralciati completamente. L’INPS, se aveva 50k di contributi, magari riceve 20k (40%) dilazionati. Tali percentuali, se coerenti col criterio della convenienza rispetto alla liquidazione, verranno approvate dagli enti.
Attenzione alle garanzie personali: la transazione fiscale approvata vincola l’ente pubblico nei confronti dell’azienda debitrice, ma non libera eventuali coobbligati (es. fideiussori). Se l’imprenditore ha una garanzia personale sul debito fiscale (casi rari ma possibili, ad esempio l’ex amministratore che ha subito un accertamento su una società estinta), quella posizione va valutata a parte. In genere, ottenuto l’accordo nel concorso principale, si cerca poi di rifletterlo anche sui garanti (Equitalia spesso sospende la riscossione verso il fideiussore se l’azienda paga il concordato regolarmente).
Differenza con “rottamazioni” delle cartelle: la definizione agevolata delle cartelle (cd. “rottamazione”) è uno strumento generale, non mirato al singolo debitore in crisi ma aperto a tutti in certi periodi per alleggerire il magazzino ruoli dello Stato. Esempio: la “rottamazione-quater” del 2023 permetteva di pagare il capitale delle cartelle senza sanzioni né interessi di mora, in 18 rate. Queste misure sono molto utili se aperte: l’imprenditore indebitato con il Fisco dovrebbe sempre controllare se il legislatore ne ha attiva una (nel 2023-2024 c’è stata, nel 2025 vedremo, spesso le leggi di bilancio ne introducono). Se ne usufruisce, in pratica è come una “transazione fiscale di massa” decisa per legge, con condizioni spesso anche più favorevoli (es. stralcio totale sanzioni). Tuttavia, la rottamazione non consente di ridurre il capitale d’imposta (salvo casi particolari come il “saldo e stralcio” del 2019 per contribuenti in difficoltà economica). Quindi, se il debito è enorme e l’azienda non può nemmeno pagare il capitale, la rottamazione potrebbe non bastare, mentre un concordato con transazione fiscale può ridurre anche il capitale da pagare (pagandone magari solo una parte minima). D’altra parte, nelle procedure concorsuali le sanzioni tributarie sono debiti chirografari postergati (ultimi a essere pagati) e spesso nei concordati vengono proprio azzerate di fatto (in quanto i chirografari prendono una percentuale piccola, quindi le sanzioni come crediti chirografari finiscono per non ricevere nulla).
Novità normative: abbiamo già evidenziato alcune: con il D.Lgs 136/2024, la transazione fiscale è espressamente prevista anche in composizione negoziata, colmando un vuoto. Inoltre, si è affinata la governance interna: le proposte con tagli oltre 70% e 30 milioni passano per l’ok centrale AdE (questo per evitare sperequazioni territoriali su grandi concordati, e probabilmente per garantire maggior rigore su grandi evasori). Un altro dettaglio: la Legge 103/2023 ha stabilito che per le proposte presentate dal 2024 l’ufficio competente è uno specifico ufficio ad hoc, e ha eliminato un possibile contenzioso: prima c’era discussione se servisse l’iscrizione a ruolo del debito per poter attivare la responsabilità del liquidatore e per far votare l’Erario; ora la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 32790/2023) ha chiarito che il liquidatore risponde verso il Fisco anche dei tributi non ancora iscritti a ruolo e che il Fisco può agire in sede fallimentare senza attendere la formazione del ruolo. Ciò significa che in concordato l’Agenzia vota per l’intero credito risultante dagli accertamenti, non solo per quello a ruolo.
Conclusione sulla transazione fiscale: è uno strumento indispensabile per risanare aziende con forti esposizioni verso l’Erario o INPS. Senza di esso, il Fisco avrebbe diritto a essere pagato integralmente prima dei chirografari, rendendo spesso impossibili piani di concordato equilibrati. Con la transazione, anche il Fisco “siede al tavolo” e può accettare soluzioni ragionevoli. Dal lato dell’imprenditore, occorre preparare con cura la documentazione per convincere lo Stato: la proposta deve essere motivata con numeri, perizie, scenari comparativi. L’Agenzia non farà sconti per compassione ma per convenienza obiettiva e accertata. Se ben utilizzata, però, la transazione fiscale può letteralmente salvare un’impresa: ad esempio, casi in cui riduce milioni di debiti fiscali a poche centinaia di migliaia pagabili in 6-7 anni, rendendo sostenibile la continuazione dell’attività.
Infine, segnaliamo che anche dopo il fallimento, se interviene un terzo a rilevare l’azienda dal curatore, è possibile nel concordato fallimentare proporre una falcidia di debiti fiscali con transazione: in tal modo, pure in extremis, a volte si chiudono fallimenti con un accordo (recenti norme agevolano la esdebitazione dell’imprenditore fallito anche se i crediti erariali sono parzialmente pagati).
Responsabilità personali dell’imprenditore e degli amministratori
Uno degli aspetti più delicati per chi conduce un’azienda indebitata è capire se – e fino a che punto – i debiti sociali possano “ricadere” sul patrimonio personale dell’imprenditore o degli amministratori. In generale, vige il principio della separazione patrimoniale per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.): i debiti della società dovrebbero essere pagati solo con il patrimonio sociale, e i soci/amministratori non ne rispondono con i propri beni (salvo conferimenti sottoscritti non versati). Tuttavia, esistono numerose eccezioni e situazioni in cui la barriera tra patrimonio della società e quello personale dell’imprenditore si rompe, volontariamente o involontariamente. Analizziamole:
- Garanzie personali (fideiussioni, avalli): questa è la via più comune con cui l’imprenditore, pur avendo una società di capitali, si obbliga personalmente per debiti della società. Le banche quasi sempre richiedono ai soci di maggioranza o agli amministratori di firmare fideiussioni personali a garanzia di finanziamenti concessi alla società. Anche fornitori strategici a volte chiedono una fideiussione del titolare (specie se la società è di nuova costituzione o poco capitalizzata). Inoltre, se la società è parte di un gruppo, potrebbero esservi fideiussioni incrociate tra società controllate e holding. Effetto: se la società non paga quel debito garantito, il creditore può escutere direttamente il garante sul suo patrimonio personale (casa, conti bancari personali, etc.). Nel contesto di una crisi aziendale, ciò significa che l’imprenditore potrebbe vedersi aggredire i beni privati per debiti sociali, in forza del contratto di garanzia. Purtroppo, anche una procedura concordataria della società non libera automaticamente il garante (a meno che il creditore rinunci volontariamente alla garanzia in sede di accordo – cosa rara). Ad esempio, se la banca accetta nel concordato della società di prendere il 50% del credito, salvo patto contrario, conserverà diritto di chiedere al fideiussore il restante 50%. Come difendersi? L’imprenditore potrebbe parallelamente avviare una propria procedura di sovraindebitamento o concordato personale per gestire quei debiti di garanzia (come si diceva prima). In alcuni casi, si cerca in sede di concordato di società di negoziare anche per il garante (ad es. offrendo qualcosa in più alla banca in cambio della liberazione della fideiussione).
- Imprenditore individuale o socio di società di persone: qui non vi è scudo: l’imprenditore è il debitore, quindi tutti i debiti (aziendali e personali) fanno capo alla stessa persona. Il titolare di una ditta individuale risponde con tutti i suoi beni (presenti e futuri, ex art. 2740 c.c.). I soci di una S.n.c. rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali; i soci accomandatari di una S.a.s. rispondono illimitatamente (gli accomandanti no, ma se interferiscono nella gestione perdono il beneficio della responsabilità limitata). Ciò significa che se la società di persone non paga, il creditore può aggredire direttamente i beni personali dei soci. Inoltre, il fallimento della società di persone comporta ipso iure il fallimento personale di tutti i soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F., ora art. 256 CCII). Quindi in questi casi l’unica difesa è fare in modo che la società paghi, o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento o liquidazione controllata per chiudere la partita (nel nuovo Codice, se una società “minore” di persone fa liquidazione controllata, possono includersi anche i soci illimitati, evitando il paradosso di prima che essendo non fallibili dovevano essere gestiti a parte). Un socio di S.n.c. fortemente indebitata potrebbe ad esempio fare un concordato minore unitario includendo società e soci insieme grazie alla nuova possibilità di procedure familiari o di gruppo.
- Responsabilità patrimoniale degli amministratori verso la società o i creditori sociali: questo tema riguarda le azioni di responsabilità civile. Se la società fallisce o comunque non paga i debiti, i creditori (o il curatore in caso di fallimento) possono cercare di rivalersi sugli amministratori sostenendo che la loro cattiva gestione ha provocato il danno. Il codice civile prevede: gli amministratori rispondono verso la società per gli atti compiuti in violazione dei doveri (azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. o 2476 c.c. per S.r.l.), e verso i creditori sociali se colposamente hanno conservato il patrimonio sociale inadeguato a soddisfare i debiti (azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., che però in fallimento viene esercitata dal curatore). Con la crisi d’impresa, spicca l’art. 2486 c.c.: quando si verifica una causa di scioglimento (es. perdite che azzerano il capitale), gli amministratori devono astenersi da nuove operazioni e gestire la società ai soli fini conservativi. Se violano tale obbligo, sono responsabili del pregiudizio cagionato al patrimonio. La riforma del 2019 ha reso più agevole la prova di tale danno, stabilendo un criterio legale di liquidazione: salvo prova contraria degli amministratori, il danno è pari alla differenza tra patrimonio netto alla data in cui avrebbero dovuto attivarsi (o ridurre il capitale o liquidare) e patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura concorsuale (o alla data di cessazione della gestione). Insomma, i manager che ritardano il fallimento facendo aggravare i debiti possono essere condannati a risarcire il “buco” incrementale. Esempio: amministratore di S.r.l. che continua per 2 anni l’attività in perdita dopo aver dimezzato il capitale: i debiti verso fornitori passano da 100k a 400k. In fallimento il curatore ottiene la condanna dell’amministratore a risarcire, poniamo, 300k (l’aggravamento). Ciò crea un nuovo debito personale dell’amministratore verso la massa dei creditori (azione di responsabilità). Cassazione (ordinanza n.8069/2024) ha chiarito che l’onere di provare l’assenza di danno o che le operazioni compiute erano in offerta ai creditori spetta all’amministratore convenuto. È quindi una seria minaccia: molte procedure concorsuali si concludono con transazioni in cui gli amministratori (o i sindaci) versano somme al curatore per evitare cause costose.
- Responsabilità per violazione di norme fiscali/previdenziali: qui abbiamo due piani. Sul piano amministrativo-tributario, esiste la citata responsabilità del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973: se un liquidatore (o amministratore che di fatto liquida l’azienda, anche senza formale liquidazione) ha pagato altri debiti e lasciato impagate le imposte dovute, è personalmente e solidalmente tenuto verso il Fisco per il pagamento di queste imposte, nei limiti di ciò che ha pagato ad altri creditori. Non è una responsabilità per tutto il debito fiscale, ma per l’importo che, dovendo pagare prima le imposte in sede di liquidazione, è stato invece destinato altrove. Ad esempio, se in cassa c’erano 50k che il liquidatore ha usato per pagare fornitori e invece c’era un debito IVA di 50k, il liquidatore può essere chiamato a rispondere di quei 50k verso l’Erario. La norma serve a impedire che in liquidazione “volontaria” gli amministratori preferiscano pagare soggetti vicini o meno pericolosi, sacrificando il Fisco. La Cassazione SS.UU. 32790/2023 ha definito questa responsabilità come “autonoma e sussidiaria”: autonoma perché non è la stessa obbligazione del contribuente, ma un obbligo nuovo del liquidatore; sussidiaria nel senso che il Fisco deve prima insinuare il credito nel fallimento (se c’è) e poi può agire sul liquidatore per la parte insoddisfatta. Hanno anche chiarito che non serve l’iscrizione a ruolo per notificarla: il liquidatore può essere chiamato in causa direttamente. Dunque, un amministratore che chiude maldestramente la società lasciando cartelle non pagate e distribuendo magari attivi ai soci o pagando altri, rischia grosso. Sul piano penale, i reati tributari e fallimentari colpiscono l’amministratore personalmente: per dire, l’omesso versamento IVA > soglia porta a processo penale con potenziale condanna a multa e reclusione, e in caso di condanna la società non paga nulla ma l’amministratore avrà una sanzione penale (e dovrà pagare una multa penale eventualmente). Così pure per la bancarotta fraudolenta o preferenziale: se in vista del fallimento l’amministratore distrae beni o favorisce taluni creditori pagando fuori regole, commette reato fallimentare, punibile con la reclusione e con pene accessorie (interdizione da attività d’impresa). Anche senza dolo, la bancarotta semplice punisce condotte come aver aggravato il dissesto con imprudenza (es. ricorso abusivo al credito quando già insolventi): l’art. 330 CCII configura la bancarotta impropria per violazione degli obblighi di adeguati assetti e di tempestiva emersione della crisi, se dal ritardo deriva il fallimento.
- Responsabilità dei soci finanziatori e di gruppo: se i soci hanno erogato prestiti alla società in una fase in cui avrebbero dovuto capitalizzarla (ad es. hanno fatto finta di essere creditori quando la società era sottocapitalizzata), quei crediti dei soci sono postergati per legge (art. 2467 c.c.): significa che in caso di fallimento o concordato, i soci verranno pagati solo dopo tutti gli altri creditori (spesso quindi nulla). Questo non è tanto un obbligo a pagare, ma una perdita del diritto a concorrere. Simile concetto per i gruppi: se una capogruppo ha abusato di una controllata, può scattare una responsabilità ex art. 2497 c.c. verso i creditori della controllata per averne cagionato lo stato di decozione con direttive imprudenti (responsabilità da direzione e coordinamento). Sono casi più sofisticati e rari, ma vanno segnalati: l’imprenditore non può pensare di spolpare la propria società su cui ha controllo senza rischiare ripercussioni sul suo patrimonio attraverso queste norme.
Come difendersi a livello personale?
Dal punto di vista preventivo, l’imprenditore dovrebbe: scegliere la forma giuridica adatta (una S.r.l. o S.p.A. offre la protezione, a patto di non inquinare le acque con garanzie personali ovunque), capitalizzare adeguatamente la società (per evitare di doverla finanziare con prestiti postergati e per evitare cause di scioglimento frequenti), tenere una contabilità regolare (per non incorrere in sanzioni e per monitorare la crisi), rispettare i doveri di segnalazione e reazione alla crisi (in modo da non aggravare il dissesto), e ovviamente non confondere i patrimoni (no prelievi indebiti, spese personali sul conto aziendale, ecc., che poi configureranno distrazioni).
Se la crisi arriva comunque, l’imprenditore deve evitare mosse istintive ma illegali: ad es. non vendere sottocosto beni a parenti per toglierli ai creditori (sarebbe bancarotta fraudolenta patrimoniale), non creare falsi crediti (bancarotta fraudolenta preferenziale), non pagare solo chi fa più pressioni lasciando il resto (oltre al reato di bancarotta preferenziale, anche sul piano civile quelle somme potrebbero essere revocate). Conviene piuttosto attivare le procedure concorsuali regolari: la legge premia l’imprenditore che agisce in buona fede e con trasparenza. Ad esempio, se in un concordato il debitore espone correttamente tutti i suoi beni, paga il possibile e poi rimangono debiti insoddisfatti, potrà ottenere l’esdebitazione e nessun’azione ulteriore lo colpirà; se invece avesse occultato dei beni, perderebbe l’esdebitazione e rischierebbe denunce.
Dal punto di vista del debitore persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitato), il miglior scudo è la già citata procedura di sovraindebitamento: una volta chiusa la vicenda aziendale, dedicarsi a ripulire la posizione personale con un piano del consumatore o liquidazione controllata e poi esdebitazione. Questo permette di non restare inseguiti a vita dai creditori personali (banche per fideiussioni, Fisco per coobblighi, ecc.).
Case law e giurisprudenza recente: abbiamo menzionato Cass. Sez. Unite 32790/2023 sulla responsabilità dei liquidatori verso il Fisco, Cass. 8069/2024 sulla prosecuzione illegittima dell’attività oltre la perdita del capitale, Cass. 11324/2024 sull’onere della prova nell’azione di responsabilità del curatore vs amministratori (ha precisato che una volta allegato l’inadempimento agli obblighi, spetta agli amministratori provare l’assenza di nesso causale col danno). Inoltre, va citata la Cassazione penale n.11620/2018 (un po’ datata ma fondamentale) che ha stabilito che l’imprenditore che paga selettivamente alcuni creditori in situazione di insolvenza può commettere bancarotta preferenziale anche se pensava di evitare il fallimento: in altre parole, nelle fasi di pre-crisi bisogna stare attenti a non fare favoritismi.
Un’altra pronuncia interessante è la Cass. civ. Sez. I 18011/2025 (ipotizzata dall’elenco di articoli recenti) che pare affermi un principio su società in liquidazione: “In caso di fallimento di società in liquidazione, il giudice deve verificare se il patrimonio sociale è sufficiente a soddisfare integralmente i creditori” – suona come un monito agli amministratori liquidatori: se sanno che il patrimonio non basta, dovrebbero considerare di chiedere il fallimento prima di dissiparlo.
Riassumendo in parole semplici: l’imprenditore deve distinguere due piani: i debiti dell’azienda e la propria esposizione personale. In teoria, con una società di capitali, potrebbe far fallire l’azienda e tenere al sicuro il patrimonio personale. In pratica, raramente accade: tra garanzie e norme di responsabilità, l’imprenditore rischia comunque di rispondere di qualche fetta. Pianificare la crisi significa anche limitare l’impatto personale: ad esempio, negoziare con la banca la liberazione dalle fideiussioni in cambio di una percentuale extra; oppure utilizzare la liquidazione concordataria per chiudere anche le posizioni personali correlate (talvolta, presentando concordato “di gruppo familiare” se le norme lo consentono).
Esempio finale: il titolare della nostra ipotetica azienda di coibentazioni, Mario, ha messo ipoteca sulla casa a garanzia del mutuo aziendale e ha firmato fideiussione alle banche e a due fornitori importanti. L’azienda purtroppo deve liquidare in concordato, pagando i creditori al 30%. La banca ha incamerato il 30% dal concordato, ma ora minaccia di prendere il restante dal ricavato della vendita della casa di Mario (ipotecata). Mario, per evitare di perdere l’abitazione, potrebbe convincere la banca a rinunciare alla procedura esecutiva offrendo, ad esempio, un ulteriore 10% ottenuto grazie a un prestito familiare – se la banca accetta, libera l’ipoteca e Mario salva casa. Altrimenti, Mario potrebbe valutare un piano del consumatore personale in cui offre alla banca, con ipoteca, il valore di mercato forzato della casa (magari tramite rifinanziamento) e ai fornitori garanti un 10% come a tutti. Se il giudice omologa questo piano, la casa di Mario viene forse venduta o rifinanziata, la banca soddisfatta al giusto, e tutti i debiti di Mario – derivati dalle garanzie – vengono poi cancellati. Mario riparte senza casa (o con un mutuo nuovo) ma senza più debiti.
In conclusione, la difesa dell’imprenditore indebitato implica giocare su due scacchiere: quella dell’impresa, per salvare il salvabile e trattare i debiti in sede concorsuale, e quella personale, per parare i colpi che travalicano l’azienda. Con gli strumenti giusti e una guida professionale, è possibile limitare fortemente l’impatto negativo e talvolta ricominciare da capo liberati dai debiti, cosa impensabile in passato senza subire infamanti fallimenti personali di durata decennale.
Domande e risposte frequenti
Di seguito, presentiamo una serie di Q&A (domande e risposte) sintetiche su temi che frequentemente si pongono gli imprenditori e i professionisti quando un’azienda è schiacciata dai debiti. Questa sezione riprende concetti esposti ma in forma di risposta diretta, per chiarire dubbi comuni in maniera mirata.
D: La mia azienda ha molti debiti con il fisco (IVA e tasse non pagate). Posso evitare il fallimento se l’Agenzia delle Entrate mi fa istanza?
R: L’Agenzia Entrate-Riscossione può chiedere il fallimento di un’impresa se ha un credito sopra certe soglie (in passato €30.000, oggi la valutazione è più discrezionale ma con importi rilevanti tendono a intervenire). Per evitare il fallimento indotto dal Fisco, l’imprenditore dovrebbe attivarsi prima: ad esempio presentando domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, ottenendo così la protezione dalle azioni dei creditori. Una volta in concordato, l’AdE non può proseguire l’istanza di fallimento. Inoltre, si può proporre una transazione fiscale: se il piano di concordato è serio e prevede per il Fisco un pagamento migliore che in fallimento, c’è buona chance che l’AdE lo accetti. Importante: rimanere passivi aumenta il rischio di iniziative ostili; invece, agendo per primi con una procedura, si tiene il controllo.
D: Che succede ai debiti verso fornitori e banche se presento concordato o accordo di ristrutturazione?
R: Dal momento del deposito della domanda di concordato (anche “in bianco”) o della pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione, scatta una moratoria legale: fornitori e banche non possono iniziare o continuare pignoramenti né risolvere i contratti in essere per il solo fatto dell’insolvenza. I debiti vengono “cristallizzati” e saranno trattati secondo il piano: ad esempio, un fornitore chirografario potrebbe ricevere una percentuale concordataria (es. 40%) e dovrà rinunciare al resto; una banca con mutuo ipotecario continuerà a essere pagata col ricavato di vendita dell’immobile, ma se residua scoperto chirografario, ne avrà la percentuale come gli altri. Se invece fai un accordo stragiudiziale senza procedure, fornitori e banche non sono bloccati: solo quelli con cui trovi l’intesa aspetteranno, gli altri potrebbero agire comunque. Ecco perché spesso serve passare a una procedura formale per “ingabbiare” tutti i creditori in un’unica trattativa ordinata. Nel concordato, la banca può vedersi ridurre il credito (falcidia) se il valore del bene ipotecato è inferiore al debito (in continuità anche i privilegiati possono essere soddisfatti parzialmente). Nei concordati liquidatori invece i garantiti in genere prendono il valore pieno del bene fino a capienza.
D: La mia SRL è insolvente, ma vorrei evitare il fallimento per non avere accuse di bancarotta. Posso fare direttamente la liquidazione volontaria e chiudere la società?
R: Se la società è insolvente in modo rilevante, la liquidazione volontaria (ossia scioglimento e nomina di un liquidatore) non mette al riparo da responsabilità: anzi, se durante la liquidazione l’attivo non basta per i debiti, il liquidatore (o amministratore) ha l’obbligo di chiedere il concordato o la liquidazione giudiziale. Continuare la liquidazione volontaria distribuendo quel poco ai creditori “come viene” può portare a responsabilità ex art. 2486 c.c. e al rischio di fallimento su istanza di creditori rimasti insoddisfatti (il fallimento può essere dichiarato entro 1 anno dalla cancellazione dal Registro Imprese, se risultava insolvente). Inoltre, se paghi alcuni creditori e non altri, potresti incorrere in bancarotta preferenziale se poi fallisci. Quindi, meglio non affidarsi solo alla liquidazione volontaria in caso di insolvenza grave: è più sicuro usare una procedura concorsuale minore (concordato semplificato, concordato minore) che chiude la società in modo trasparente e porta all’esdebitazione, piuttosto che una chiusura “fai da te” rischiosa.
D: Ho dato garanzie personali (fideiussioni) per i debiti aziendali. Se l’azienda risolve i debiti col concordato, io come garante sono libero?
R: No, purtroppo. Il concordato o l’accordo vincolano solo il debitore e i suoi creditori diretti. Il garante (fideiussore) è un diverso soggetto obbligato: se il concordato dell’azienda paga, ad esempio, il 50% a un creditore, quel creditore può ancora pretendere dal garante il restante 50%, a meno che in sede di concordato non abbia espressamente rinunciato. La legge lo consente: l’art. 88, comma 2 CCII dice che il concordato non libera i coobbligati (salvo concordo del creditore). Quindi, come discusso, il garante dovrà occuparsi separatamente dei suoi impegni. Può cercare di inserirli in un unico pacchetto se, ad esempio, anche lui è in una sua procedura (un caso: azienda in concordato, imprenditore in sovraindebitamento e si fa omologa incrociata – difficile ma concettualmente possibile). In mancanza, dopo il concordato il creditore potrà inviarti richiesta per la differenza. Ciò detto, spesso in pratica i creditori maggiori (banche) in sede di trattativa pre-concordataria discutono anche delle garanzie: può darsi che la banca, convinta dalla convenienza del concordato, sia disponibile a non infierire sul garante, specie se è socio e rimarrà a gestire l’impresa risanata. Ma è volontario, non obbligato.
D: Qual è la differenza tra un accordo di ristrutturazione e un concordato preventivo, per me debitore?
R: Dal tuo punto di vista di debitore, le differenze principali sono: (i) Consensi richiesti – l’accordo ADR richiede il sì di una parte dei creditori (60% o 30% se agevolato) mentre il concordato richiede il voto (e dunque il coinvolgimento) di tutti, con maggioranze di legge; (ii) Pubblicità e organi – nel concordato avrai un commissario nominato e un iter in Tribunale con udienze e decreto di omologa, nell’accordo c’è solo l’omologa finale e niente commissario (fino a omologa rimani tu a gestire, con eventuale ausilio dell’attestatore); (iii) Vincolo sui dissenzienti – il concordato vincola anche i dissenzienti (tutti i creditori sono dentro), l’accordo vincola solo chi ha firmato, tranne i casi speciali di efficacia estesa in cui comunque serve soglia 75% per alcune categorie. (iv) Flessibilità – nell’accordo sei libero di trattare diversamente creditori della stessa categoria purché chi firma è d’accordo; nel concordato devi rispettare parità di trattamento all’interno delle classi e regole di graduazione dei privilegi a meno di consenso di classi su deroghe. (v) Tempi – un ADR può essere più rapido (anche 4-6 mesi) perché non devi fare adunanza e tutto il lungo processo di voto; un concordato spesso richiede un anno o più. In sintesi, se hai pochi creditori e concordi con la maggior parte di essi, l’ADR è snello e ti consente di evitare la trafila concorsuale; se hai tanti creditori e discordanti, il concordato è l’unica via per imporre la soluzione.
D: Ho sentito parlare di “crisi da sovraindebitamento” per i privati: se la mia azienda (ditta individuale) è indebitata, posso liberarmi dei debiti come persona fisica?
R: Sì. Se sei un imprenditore individuale non fallibile (cioè di dimensioni sotto soglia) o se, pur fallibile, hai anche debiti personali estranei all’impresa, puoi utilizzare gli strumenti di sovraindebitamento. Ad esempio, se la tua ditta individuale edile ha chiuso e hai debiti per 200k, potresti proporre un concordato minore ai creditori, offrendo magari 50k (derivanti dalla vendita di attrezzature e un aiuto familiare) – se approvano, avrai pagato quel che potevi e il giudice ti esdebiterà del resto. Oppure, se i debiti sono in parte privati (carte di credito, prestiti personali usati per l’azienda, etc.), potresti sotto certi aspetti rientrare nel piano del consumatore per quelli, e nel concordato minore per altri. Lo scenario peggiore: non hai nulla da offrire ma sei sommerso di debiti – in tal caso esiste la procedura di liquidazione controllata (si liquidano i pochi beni, se ci sono, e dopo 3 anni puoi ottenere l’esdebitazione) oppure, se davvero non possiedi nulla, puoi addirittura chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente immediata. Questo cancellerà i tuoi debiti (eccetto quelli esclusi ex lege) dandoti un fresh start. Naturalmente, per ottenere questo beneficio devi dimostrare di non avere colpe gravi nell’aver contratto quei debiti o nel non poter pagare (ad es. perdita del lavoro, malattia, crisi economica generalizzata… non l’acquisto di beni di lusso incurante del rimborso).
D: Se chiedo la composizione negoziata o presento un concordato, potrò continuare a gestire la mia azienda o rischio che me la tolgano?
R: Nel concordato preventivo, soprattutto in continuità, di regola rimani in possesso (procedura debtor in possession): conservi l’amministrazione sotto la vigilanza del commissario e con eventuali atti straordinari da autorizzare, ma non vieni spossessato. Solo se ci sono irregolarità gravi o istanze di creditori potrebbe il tribunale revocare l’ammissione o nominare un amministratore giudiziario (ma accade raramente e in situazioni di frode). Nella composizione negoziata, assolutamente continui tu a gestire: l’esperto ha ruolo consultivo, non amministrativo. Anche qui il tribunale potrebbe, se tu agissi in mala fede o violando le misure protettive, dichiarare cessata la protezione, ma l’esperto non può costringerti a decisioni: può solo riferire. Diverso è il fallimento/liquidazione giudiziale: lì sì che perdi subito la gestione, nominano un curatore e tu esci di scena. Quindi tutte le procedure di risanamento (CNC, accordi, concordati) ti lasciano al comando, seppur con oversight. C’è un caso particolare: nel piano di ristrutturazione omologato (PRO), pur essendo di solito debtor in possession, il tribunale nomina un commissario che ha poteri di vigilanza e riferisce (più intrusivo di un semplice attestatore). Ma comunque l’imprenditore rimane nella gestione ordinaria fino all’omologa (dopo l’omologa, se il piano prevede nuovi amministratori o cessione azienda, ovviamente subentra chi previsto). In sintesi: se vuoi restare alla guida e provare a salvare l’azienda, le procedure di composizione/crisi sono fatte apposta e ti lasciano lì, a patto che tu collabori e segua le regole.
D: La società di cui ero amministratore è fallita. Devo temere di pagare i debiti con i miei beni personali?
R: Dipende. Se era una società di capitali e tu non hai firmato garanzie personali e non hai commesso irregolarità, in linea di massima no: i creditori sociali dovranno accontentarsi del fallimento della società. Tuttavia, il curatore fallimentare sta sicuramente valutando se esistono estremi per un’azione di responsabilità a tuo carico (mala gestio) o per atti distrattivi. Se ritiene che tu abbia aggravato il dissesto o violato i doveri, potrebbe citarti in giudizio. Anche il Fisco potrebbe attivarsi via Agenzia Entrate con la già citata responsabilità da liquidatore per imposte non versate – ad esempio se hai chiuso male. Inoltre, se sei socio unico o di maggioranza, il curatore potrebbe controllare pagamenti a te o parti correlate e chiederne la restituzione (azioni di restituzione su finanziamenti soci rimborsati nell’anno ante fallimento, o utili prelevati in maniera illegittima). Quindi, se tutto regolare, la risposta è “no, i debiti restano in capo alla società fallita”; se invece emergono fatti di gestione anomali, potresti essere chiamato a rispondere. Vale inoltre quanto detto: se dopo il fallimento restano in piedi debiti personali tuoi (per esempio, la banca del leasing aveva anche la tua garanzia, o ci sono cartelle a tuo nome per cui rispondevi come amministratore), quelli li devi gestire separatamente con sovraindebitamento tuo, perché il fallimento della società non li copre.
D: Quanto tempo occorre per chiudere queste procedure? Rischio di trascinarmi i debiti per decenni?
R: L’intento delle riforme è proprio evitare lungaggini infinite. Una composizione negoziata dura 6 mesi (prorogabile al massimo di altri 6). Un accordo di ristrutturazione, da quando depositi a quando hai l’omologa, in genere 4-8 mesi. Un concordato preventivo, diciamo 6-12 mesi per arrivare a omologa e poi se è in continuità gli adempimenti possono protrarsi per gli anni previsti dal piano (ma formalmente la procedura si chiude all’omologa, poi c’è la fase di esecuzione monitorata dal commissario/giudice). La liquidazione giudiziale (fallimento) purtroppo può durare anni (anche >5) se il patrimonio da liquidare è complesso; però l’esdebitazione dell’ex fallito ora può arrivare già dopo 3 anni dall’apertura (non più attendere la chiusura), quindi il debitore persona fisica può essere liberato prima che il fallimento finisca. Nel sovraindebitamento: piano del consumatore o concordato minore – generalmente 4-6 mesi per avere l’omologa, poi tempi di pagamento secondo il piano (magari altri pochi anni); liquidazione controllata – deve chiudersi in 3 anni, e l’esdebitazione scatta subito dopo. Dunque, non parliamo di decenni: se segui la strada legale, in un orizzonte di pochi anni puoi mettere una pietra sopra i debiti, nel bene (pagandoli in parte) o nel male (liquidando beni e chiudendo). Ciò che invece può trascinarsi decenni è non affrontare il problema: lasciare i debiti insoluti, subire decreti ingiuntivi, pignoramenti, continuerà a erodere la vita finanziaria tua e dell’azienda a lungo, con interessi e more crescenti e blocchi sull’attività (es. ganasie su conti). Le procedure di crisi sono come un intervento chirurgico: doloroso nell’immediato ma risolutivo, contro un’agonia più lenta e lunga.
D: Conviene aprire una nuova società e spostare l’attività lì, lasciando la vecchia coi debiti?
R: Questa fuga in avanti viene spesso istintivamente in mente, ma è piena di rischi legali. Se trasferisci l’attività a una nuova società e lasci i debiti nella vecchia, i creditori potrebbero agire per successio a titolo particolare d’azienda (art. 2560 c.c., l’acquirente d’azienda risponde dei debiti aziendali risultanti dai libri contabili) o intentare azioni revocatorie per il trasferimento d’azienda a titolo gratuito o sottovalutato (bancarotta fraudolenta patrimoniale se poi fallisci la vecchia). Il risultato potrebbe essere che i debiti “inseguono” la nuova società (specie i debiti erariali legati all’azienda ceduta) e in più tu incappi in responsabilità penali. Ci sono casi leciti di “phoenix company” (risorgere in nuova entità) ma vanno strutturati con attenzione e trasparenza: ad esempio, si può vendere l’azienda dal concordato a un terzo a valore di mercato (in quel caso la nuova prosegue senza quei debiti, che restano nel concordato come crediti soddisfatti dal prezzo di cessione – questo è legittimo). Ma farlo di nascosto, spogliando la vecchia società, è pericolosissimo. Quindi, di regola, non conviene giocare d’astuzia: conviene piuttosto usare la cornice di legge (es. concordato con affitto d’azienda a una newco, poi concordato liquidatorio in cui la newco compra l’azienda – così hai salvato la continuità in modo regolare, e i creditori della vecchia prendono qualcosa dall’incasso). Chi ha provato diversivi spesso ha aggravato la sua posizione.
D: Dopo aver fatto tutto questo (concordato o liquidazione), potrò ancora fare l’imprenditore o avrò restrizioni?
R: Una bella domanda. Prima la legge fallimentare prevedeva l’interdizione legale dell’ex fallito fino alla chiusura e niente nuova attività per lui. Oggi è molto più morbido: se fai un concordato preventivo, non diventi un “fallito” (giuridicamente non esiste stigma): puoi continuare a fare l’amministratore di società, partecipare a gare pubbliche (salvo che alcune stazioni appaltanti chiedano comunque rating di solvibilità), etc. In caso di liquidazione giudiziale (fallimento), la riabilitazione avviene con l’esdebitazione, che viene concessa in tempi rapidi (anche 3 anni). Ottenuta l’esdebitazione, cessano le incapacità personali (es. non hai più l’interdizione dai pubblici uffici, puoi tornare a partecipare a SRL come socio e a costituirle, mentre durante il fallimento non potevi senza informare il tribunale). Quindi, se segui la procedura e la chiudi regolarmente, potrai tornare in pista. Un piccolo limite: se hai beneficiato dell’esdebitazione come ex fallito o sovraindebitato, per 5 anni se vuoi accedere di nuovo a una procedura concorsuale hai qualche restrizione (ad es. l’esdebitazione del nullatenente è una sola volta nella vita e devi attendere 5 anni per riprovare altre soluzioni). Ma nulla ti impedisce di lavorare o avviare business: l’importante è, direi, farne tesoro e evitare di ricadere negli errori che hanno portato alla prima crisi.
Simulazioni pratiche (casi di studio)
Infine, per dare un quadro ancora più concreto, presentiamo alcune simulazioni pratiche basate su scenari tipici di un’azienda di coibentazioni acustiche e termiche con debiti. Sono esempi semplificati ma utili a illustrare come potrebbero svolgersi le soluzioni discusse:
Caso 1: Risanamento in continuità tramite composizione negoziata e concordato
Scenario: EcoSound S.r.l. ha 15 dipendenti e si occupa di installazioni per l’isolamento acustico. Dopo un calo di commesse, accumula €800.000 di debiti: €200k con banca (scoperto e leasing), €150k con il Fisco (IVA non versata), €100k INPS, €300k fornitori, €50k altri. Ha anche crediti verso clienti per €200k e un magazzino materiali di €100k. L’azienda è ancora attiva e con nuovi contratti in vista, ma la liquidità è zero e i fornitori minacciano lo stop. L’amministratore attiva subito la Composizione Negoziata e ottiene misure protettive. L’esperto constata che EcoSound potrebbe risollevarsi se riduce l’onere del debito e ottiene un socio finanziatore. Vengono condotte trattative: la banca accetta di convertire lo scoperto in un mutuo 5 anni e di ridurre il tasso, il fornitore principale (100k di credito) accetta uno stock option insolito – fornitura di servizi futuri scontati invece di incassare il passato – e gli altri fornitori accettano 50% a saldo. Un investitore locale si dice disposto a mettere €200k in cambio del 30% delle quote. Si studia un piano di concordato preventivo in continuità: l’investitore apporta €200k freschi (prededucibili in concordato), con cui pagare parzialmente i debiti. Il piano prevede: pagamento integrale di IVA e INPS (150+100 = €250k) in 4 anni; pagamento del 40% ai fornitori (€120k su 300k) in 4 anni; banca chirografaria 40% (sul leasing unsecured per €50k = 20k); la banca ipotecaria sul capannone è fuori perché quell’immobile l’azienda lo mantiene pagando le rate. Il valore aggiunto? L’investitore con i 200k consente di saldare subito parte del Fisco e dare un acconto ai fornitori. I creditori votano in concordato: il Fisco (privilegiato) non vota ma aderisce via transazione fiscale a prendere €250k su €250k in 4 anni (nessun taglio su imposte, solo dilazione); i chirografari (fornitori) vedono il 40% invece di un 5% stimato in fallimento e votano sì convinti. Concordato omologato. EcoSound riprende fiato: l’investitore porta anche competenze di marketing, arrivano più commesse, e l’azienda riesce a rispettare il piano. I debiti residui dopo concordato sono cancellati. L’imprenditore ha salvato la sua azienda e i posti di lavoro. La sua quota societaria è diminuita, ma ora l’impresa è risanata e con nuova linfa.
Caso 2: Liquidazione dell’azienda e impatto personale dell’imprenditore
Scenario: TermoSilent di Rossi Mario & C. S.a.s. – l’attività di coibentazione non è più sostenibile causa perdita di un appalto chiave e errori gestionali. Debiti totali €600k (di cui €100k banca con garanzie personali di Mario Rossi, €200k fornitori, €50k dipendenti arretrati, €150k Fisco, €50k INPS, €50k altri). Attivo: pochi macchinari (valore €50k), un furgone (€10k), magazzino €20k. È insolvente. Mario vorrebbe mollare tutto. Avvia una composizione negoziata, ma l’esperto riscontra che non c’è prospettiva di risanamento in continuità (nessuna commessa, dipendenti licenziati). Suggerisce quindi la via del concordato semplificato liquidatorio per evitare la lunga trafila del fallimento. L’esperto nelle conclusioni attesta che Mario ha cooperato e provato soluzioni ma senza esito, quindi ci sono i presupposti per il semplificato. Mario, entro 60 giorni, presenta al tribunale un concordato semplificato (art.25-sexies): propone di vendere tutti i beni (50k+10k+20k = €80k stimati) e far entrare un acquirente che offre €20k per rilevare marchio e avviamento residuo. Totale €100k da distribuire. Il piano offre: pagamento di tutte le spese procedure e crediti lavoratori (superprivilegiati) 100% (€50k dipendenti+TFR); pagamento di €50k a parziale soddisfacimento di privilegiati Fisco e INPS (€200k crediti tra fisco/inps, 25% soddisfatti – comunque più che in fallimento dove quei beni avrebbero realizzato forse 15%); chirografari zero (non rimane niente per fornitori). Il tribunale sente il commissario nominato ad hoc e valuta che comunque i creditori chirografari avrebbero preso zero anche in fallimento, e i privilegiati prendono tutto l’attivo disponibile. Omologa il concordato anche senza voto creditori. La S.a.s. cessa, i beni sono liquidati rapidamente. Mario, come socio accomandatario, rimane debitore personalmente per eventuali debiti non soddisfatti, ma qui interviene la sua procedura personale: Mario attiva una liquidazione controllata del sovraindebitato per liberarsi dei debiti personali (compresi quelli di garanzia). Il suo patrimonio personale consiste in un appartamento cointestato con la moglie (prima casa non ipotecata). Essendo prima casa, per legge nell’esecuzione individuale l’Agente Riscossione non l’avrebbe potuta pignorare, ma in liquidazione controllata teoricamente sì; tuttavia Mario propone ai creditori un accordo: la moglie di Mario paga €50k (ottenuti da un parente) per evitare la vendita della casa. I creditori personali di Mario (in gran parte sono gli stessi già parzialmente soddisfatti nel concordato semplificato) accettano l’accordo in sede OCC. Mario ottiene l’esdebitazione e conserva la casa grazie al contributo familiare. In sintesi, TermoSilent è stata chiusa con concordato semplificato, Mario ha chiuso i propri debiti con un accordo di sovraindebitamento e riparte da zero (forse cambierà mestiere). Nessuna azione penale perché ha seguito la legge e non ha fatto distrazioni.
Caso 3: Utilizzo dell’accordo di ristrutturazione per evitare il fallimento
Scenario: Silenzio S.r.l., azienda individuale di medie dimensioni (fatturato 5 milioni), entra in crisi per un cantiere finito male. Debiti: €4 milioni (banche €2M con garanzie, fornitori €1M, Fisco €500k, altri €500k). Ha attivo immobiliare e commesse in corso. I soci credono nella ripresa e vogliono evitare la parola “concordato” per non spaventare il mercato. Scelgono l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) per rimettere ordine. Attraverso incontri diretti, ottengono l’adesione di banche e fornitori rappresentanti il 65% del debito: il piano ADR prevede nuova finanza di €500k dai soci, con cui pagare in parte il Fisco (€300k su €500k) e dare un 20% subito ai fornitori estranei per convincerli a stare calmi; alle banche aderenti all’accordo allungano i finanziamenti di 5 anni; ai fornitori aderenti pagheranno il 70% in 2 anni. I creditori che non aderiscono (35% del debito) verranno pagati integralmente in scadenze originali grazie alla stabilizzazione aziendale (per sicurezza, li hanno messi da parte con un fido dedicato). Si deposita l’accordo agevolato ex art. 60 CCII con il 65% di adesioni (sopra il 30% richiesto). L’attestatore conferma che i creditori estranei (non aderenti) sono comunque pagati per intero fuori accordo, quindi non subiscono danno. Il tribunale omologa. Silenzio S.r.l. esce dalla procedura senza troppa pubblicità (una sola nota nel Registro Imprese sull’omologa ADR). Nessun cliente importante lo viene a sapere nei dettagli, l’azienda onora i nuovi patti e in 2 anni è fuori dalla crisi. In questo caso, l’accordo è servito a risolvere la crisi in modo “discreto” e mirato, coinvolgendo solo i principali creditori disponibili e garantendo comunque gli altri, evitando il default totale.
Caso 4: Sovraindebitamento del garante
Scenario: Gino Bianchi, ex titolare di una ditta individuale chiusa per troppi debiti. Rimangono su di lui debiti personali: €80k con Equitalia (tasse personali e contributi), €50k con una banca (gli aveva fatto da garante leasing), €20k vari. Gino ora lavora come dipendente a 1.500€/mese. Non ha immobili, solo un’auto modesta. Gino ricorre all’OCC e prepara un piano del consumatore: propone di pagare €300 al mese per 5 anni, che sull’arco sono €18k, da ripartire proporzionalmente tra i creditori (circa il 15% di soddisfo medio). Dimostra che la causa del suo indebitamento fu la chiusura dell’attività e non spese voluttuarie, che vive modestamente, e che 300€ è il massimo sostenibile lasciandogli il minimo vitale. Il giudice omologa senza voto creditori, considerando che in 5 anni di pignoramenti i creditori avrebbero forse preso ancora meno (perché il suo stipendio è al limite pignorabile di 1/10). Gino paga regolarmente i 300€/mese. Al termine, ottiene l’esdebitazione: i residui di quei debiti sono cancellati. Gino ha riacquistato piena capacità finanziaria (il suo C.R. risulta “pulito” da sofferenze) e può pensare di rifarsi una vita. Questo mostra come anche un privato schiacciato da debiti legati all’impresa può risollevarsi con gli strumenti giusti.
Simulazioni come queste evidenziano che ogni situazione di crisi ha la sua “strategia ottimale” a seconda della configurazione dei debiti, degli attivi disponibili, della prospettiva di continuità e delle caratteristiche del debitore. Non esiste una soluzione unica, ma un ventaglio di opzioni da combinare. Il punto di vista del debitore deve essere lungimirante: a volte sacrificare qualcosa (cedere un asset, far entrare un socio, rinunciare a una parte di attività) è necessario per salvare il resto o evitare guai peggiori. La normativa attuale offre strumenti più che sufficienti per difendersi dai creditori e gestire i debiti, ma richiede di essere attivata in modo competente e tempestivo.
Conclusioni
Affrontare una crisi da sovraindebitamento aziendale è come navigare in acque tempestose: servono strumenti adeguati (le procedure e gli accordi descritti), conoscenza delle rotte legali (norme e sentenze aggiornate) e spesso anche un pilota esperto (consulenti specialisti, OCC, esperti nominati). La legislazione italiana, specialmente con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e le sue modifiche fino al 2025, ha messo a disposizione un sistema articolato di vie d’uscita dalla crisi, privilegiando, ove possibile, la continuità aziendale e il risanamento, senza trascurare però la necessità di sanzionare abusi e scorrettezze.
Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, alcuni principi guida emersi sono:
- Tempestività: prima ci si muove, maggiori sono le opzioni. Attendere le azioni dei creditori porta spesso a soluzioni forzate (es. fallimento). Gli obblighi di attivazione “senza indugio” previsti dall’art. 3 CCII non sono solo un dovere giuridico, ma anche un consiglio pratico.
- Trasparenza e buona fede: collaborare con organi e creditori in modo onesto paga. Le procedure concordatarie puniscono chi nasconde informazioni (rischio di revoca o di reati) e premiano chi è corretto (omologhe più agevoli, fiducia dei creditori, misure protettive concesse).
- Personalizzazione delle soluzioni: come visto, un piano efficace è quello tarato sulla specifica impresa – non esistono due crisi uguali. Occorre valutare la combinazione di strumenti (es. CNC + concordato, accordo + transazione fiscale, liquidazione + esdebitazione…) più adatta caso per caso.
- Protezione del patrimonio personale: l’imprenditore deve tener conto dell’effetto boomerang dei debiti aziendali sul proprio patrimonio. Pianificare un’uscita significa anche mettere in sicurezza (legalmente) la famiglia e il minimo vitale, usando all’occorrenza le procedure di sovraindebitamento per sé stesso.
- Coinvolgimento di professionisti: gestire queste procedure richiede competenze tecniche (giuridiche, contabili) avanzate. Affidarsi a un avvocato specializzato in crisi d’impresa e a un commercialista esperto può fare la differenza tra un esito positivo e uno fallimentare. Il Codice stesso incoraggia la creazione di “team multidisciplinari” per affiancare l’impresa.
In un’economia dinamica e non priva di shock (si pensi alle crisi pandemiche o energetiche recenti), la normativa concorsuale moderna punta a dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti e capaci, filtrando al contempo chi abusa del credito altrui senza prospettive. Le sentenze più recenti – alcune citate in questa guida – mostrano un orientamento di rigore verso le malgestioni (si pensi alla linea dura sulle responsabilità ex art.2486 o sui liquidatori inadempienti) ma anche di apertura verso soluzioni innovative (cram-down del Fisco, esdebitazione più veloce, ecc.).
Per l’azienda di coibentazioni acustiche e termiche con debiti, il messaggio finale è di speranza prudente: cosa fare per difendersi e come dipende dalla situazione concreta, ma l’ordinamento offre scudi e armi negoziali potenti. Occorre agire con consapevolezza, guidati dalle norme e con l’appoggio delle istituzioni (tribunali, OCC, Camere di Commercio) che oggi hanno la missione non solo di sanzionare, ma di prevenire la dispersione di valore economico e sociale che ogni fallimento comporta.
In altre parole, non esiste debito dal quale non ci si possa difendere con gli strumenti giuridici appropriati, purché si sia disposti ad affrontare la crisi in modo strutturato, sacrificando magari una parte per salvarne un’altra, e facendo tesoro degli errori per il futuro.
Fonti e riferimenti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, e successive modifiche: D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024). Articoli citati: artt. 12-25-sexies (composizione negoziata e concordato semplificato), artt. 23 (transazione fiscale in CNC), 25-sexies e septies (concordato semplificato), 54 (misure protettive), 56 (piano attestato), 57-64 (accordi di ristrutturazione), 60 (accordo agevolato al 30%), 61 (accordo ad efficacia estesa), 64-bis e segg. (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – PRO), 84-120 (concordato preventivo), 88 (transazione fiscale nel concordato), 120-quater CCII (norme penali, bancarotta impropria da ritardata crisi), 65-83 (procedure sovraindebitamento: piano consumatore, concordato minore), 268-277 (liquidazione controllata), 283 (esdebitazione del debitore incapiente).
- Relazione illustrativa e Note esplicative al Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n.136) – Novità in materia di composizione negoziata e sovraindebitamento. Unioncamere, Rapporto semestrale CNC novembre 2024, allegato sulle modifiche introdotte.
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 27/11/2023, n. 32790 – Liquidatore di società ed obblighi verso l’Erario ex art.36 DPR 602/1973. Le SS.UU. chiariscono la natura autonoma della responsabilità del liquidatore per il pagamento delle imposte e che l’azione può essere esercitata senza necessità di previo ruolo.
- Cassazione Civile, Sez. I, 25/03/2024, n. 8069 – Responsabilità dell’amministratore per aver continuato l’attività dopo perdita capitale (violazione art.2486 c.c.). Conferma che, provata la causa di scioglimento e la continuazione di attività non conservativa, spetta agli amministratori dimostrare l’assenza di aggravio del dissesto.
- Cassazione Civile, Sez. I, 03/08/2023, n. 11324 – Azione di responsabilità del curatore contro amministratori ex art. 2394 c.c.: onere della prova. Stabilisce che allegato l’inadempimento agli obblighi gestori e il deficit patrimoniale, incombe agli amministratori l’onere di provare che la gestione post scioglimento non ha aggravato il passivo.
- Cassazione Penale, Sez. V, 24/01/2024, n. 2803 – Bancarotta preferenziale e amministratori non esecutivi. (Ribadisce che anche i consiglieri privi di deleghe rispondono se omettono di prevenire atti distrattivi o preferenziali, in quanto corresponsabili della vigilanza).
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 21447 del 29/01/2024: regole per adesione alla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (in attuazione DL 69/2023 conv. L.103/2023). Fissa soglia >70% e >€30 mln per parere centrale.
- Dati statistici: dal Report Annuale CNC 2025 – Camera Arbitrale Milano citato in fiscoetasse; dati Ministero Giustizia su concordati e fallimenti (non direttamente citati, background: calo fallimenti 2020-21 per misure pandemia, poi risalita; poche CNC iniziali poi in aumento).
La tua azienda che realizza coibentazioni acustiche, coibentazioni termiche, isolamenti per capannoni, cappotti industriali, pannelli isolanti, materiali fonoassorbenti, barriere acustiche, isolamenti termici per impianti, coibentazioni per tubazioni e serbatoi, interventi anti-condensa, pannelli sandwich e lana minerale si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che realizza coibentazioni acustiche, coibentazioni termiche, isolamenti per capannoni, cappotti industriali, pannelli isolanti, materiali fonoassorbenti, barriere acustiche, isolamenti termici per impianti, coibentazioni per tubazioni e serbatoi, interventi anti-condensa, pannelli sandwich e lana minerale si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, sospensioni delle forniture o minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle coibentazioni è costoso e complesso: materiali speciali, manodopera qualificata, mezzi e ponteggi, DPI, logistica di cantiere e anticipi continui. Un ritardo nei pagamenti o un blocco dei fidi può creare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni rapidamente e con la strategia giusta.
Perché un’Azienda di Coibentazioni Acustiche e Termiche Va in Debito
- aumento dei costi di pannelli isolanti, lana di roccia, materiali acustici e termici
- ritardi nei pagamenti di imprese edili, appaltatori e aziende industriali
- anticipi elevati per materiali, ponteggi, manodopera e noleggi
- costi di sicurezza, DPI e formazione
- spese impreviste per lavorazioni extra o varianti di cantiere
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- logistica complessa e costi di trasporto elevati
Il problema principale è quasi sempre la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi
- sospensione di forniture critiche (pannelli, isolanti, materiali)
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di mezzi, attrezzature e ponteggi
- impossibilità di portare avanti cantieri e lavori programmati
- perdita di appalti e clienti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere la liquidità aziendale.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso i debiti includono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili
Strumenti possibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Utilizzare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Nei casi più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Consentono di continuare l’attività pagando solo una parte dei debiti.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia nella difesa delle aziende con debiti.
Le sue credenziali includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Una combinazione di competenze che lo rende tra i più efficaci nel bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare aziende operative nei cantieri.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- ristrutturazione dei debiti su misura
- protezione di materiali, attrezzature e cantieri
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di coibentazioni acustiche e termiche non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia mirata e tempestiva puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- proteggere materiali, ponteggi e cantieri
- salvare la continuità del tuo lavoro
Agire ora è fondamentale.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.