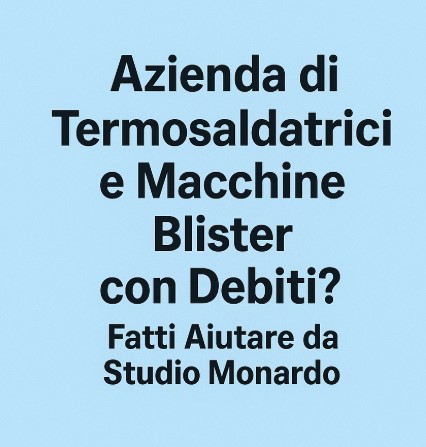Se la tua azienda produce, importa o distribuisce termosaldatrici, macchine blister, confezionatrici automatiche, sigillatrici, linee di packaging e ricambi tecnici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare il blocco dell’attività.
Nel settore del packaging le fermate operative sono critiche: anche un ritardo può bloccare linee produttive dei clienti, generare penali, sospendere consegne e far perdere importanti commesse industriali.
Perché le aziende di termosaldatrici e macchine blister accumulano debiti
- costi elevati di componenti elettronici, meccanici e parti specialistiche
- rincari dei materiali importati e dei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di imprese alimentari, farmaceutiche e manifatturiere
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- scorte costose per ricambi, schede e parti su misura
- difficoltà ad ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro che non puoi sostenere
- richiedere la sospensione di pignoramenti e procedure esecutive
- proteggere fornitori strategici e componenti critici
- utilizzare gli strumenti legali idonei per ridurre e ristrutturare i debiti
I rischi se non intervieni
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di schede, motori, resistenze, stampi e componenti elettronici
- fermo di macchine, linee di collaudo e laboratori tecnici
- impossibilità di assistere i clienti e rispettare i contratti di manutenzione
- perdita di clienti industriali, distributori e integratori
- rischio reale di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario, è gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e ha ottenuto l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021).
Può aiutarti a:
- bloccare subito pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con strumenti normativi specifici
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, macchinari, attrezzature e continuità operativa
- evitare la chiusura e salvare la tua azienda
Agisci ora
Molte imprese non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure in corso e costruire un piano concreto per salvare la tua attività.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e inizia subito a difenderti.
Introduzione
Immaginiamo un’azienda manifatturiera attiva nella produzione di termosaldatrici e macchine blister – una tipica PMI italiana – che si trova ad affrontare una grave situazione debitoria. I debiti possono riguardare il fisco, le banche, i fornitori, i dipendenti e altri soggetti. Quando i creditori iniziano a bussare alla porta, l’imprenditore si chiede: come posso difendere la mia impresa e me stesso da fallimenti e azioni legali? In Italia esistono strumenti giuridici avanzati per gestire la crisi d’impresa, aggiornati di recente (fino a ottobre 2025), che puntano a salvare l’azienda ove possibile o quantomeno a regolare i debiti in modo ordinato.
In questa guida – pensata per avvocati, imprenditori e privati informati – esploreremo in dettaglio cosa può fare un’azienda indebitata per difendersi, con un taglio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo. Partiremo dall’analisi delle diverse tipologie di debiti aziendali e delle loro conseguenze legali, per poi illustrare le strategie di risanamento o ristrutturazione del debito disponibili (dai piani di risanamento attestati ai concordati preventivi, incluse transazioni fiscali e accordi con i creditori). Verranno evidenziati anche i profili di responsabilità degli amministratori e gli eventuali rilievi penali-tributari connessi alla crisi d’impresa.
Troverete inoltre tabelle riepilogative che confrontano i vari strumenti, nonché una sezione di domande e risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni con simulazioni pratiche riferite all’ordinamento italiano. Il tutto dal punto di vista del debitore, cioè dell’azienda in difficoltà, che vuole conoscere i propri diritti e le mosse possibili per evitare il tracollo e le sanzioni.
Nota: La guida è aggiornata alle ultime novità normative e giurisprudenziali (incluso il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le relative modifiche fino al 2024) e cita fonti autorevoli (leggi, sentenze, circolari) che troverete elencate in fondo . Si raccomanda all’imprenditore di muoversi tempestivamente: il legislatore impone ormai agli amministratori di attivarsi senza indugio per adottare strumenti di superamento della crisi , a pena di gravi responsabilità.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Non tutti i debiti sono uguali. A seconda della natura del credito, la legge prevede differenti tutele per il creditore e diversi gradi di priorità in caso di insolvenza dell’azienda. Dal punto di vista del debitore, è importante capire che alcuni debiti comportano conseguenze più immediate o severe (si pensi ai debiti fiscali che possono sfociare in azioni esecutive dell’Erario, o ai debiti verso i lavoratori tutelati con privilegio). In questa sezione analizziamo le principali categorie di debito che un’azienda di termosaldatrici e blister può aver accumulato – fiscali, bancari, commerciali (fornitori), verso il personale, ecc. – e vediamo cosa accade se non vengono pagati e quali strumenti di difesa esistono in ciascun caso.
Debiti fiscali e tributari
I debiti fiscali comprendono imposte dovute all’Erario (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali operate sulle buste paga, ecc.) e tributi dovuti agli enti previdenziali (contributi INPS e premi INAIL) o enti locali. Per loro natura, questi debiti sono considerati “qualificati” e godono spesso di privilegi nel recupero. Se un’azienda non paga le imposte, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) può emettere cartelle esattoriali e attivare procedure esecutive specifiche: ad esempio l’iscrizione di ipoteca su immobili aziendali, il fermo amministrativo su veicoli, il pignoramento di conti correnti o beni mobili, fino a richiedere (in casi estremi) il fallimento dell’impresa debitrice. In caso di società di capitali (come una S.r.l.), il debito fiscale resta in capo alla società; i soci non ne rispondono con il patrimonio personale, salvo abbiano prestato garanzie personali o salvo casi di responsabilità specifica (ad es. amministratori colpevoli di frodi tributarie).
Conseguenze del mancato pagamento: Il mancato pagamento di imposte comporta sanzioni pecuniarie (sanzioni amministrative tributarie) e interessi di mora, che fanno lievitare l’importo dovuto. Inoltre, oltre alle azioni esecutive patrimoniali, vi sono soglie oltre le quali scatta la responsabilità penale degli amministratori per omesso versamento: ad esempio, non versare l’IVA per un importo annuo superiore a €250.000 costituisce reato punito con la reclusione (6 mesi – 2 anni) . La legge di riforma del 2024 (D.Lgs. 87/2024) ha peraltro esteso i termini entro cui è possibile ravvedersi: il reato di omesso versamento IVA si perfeziona ora solo se l’imposta dovuta (dichiarata) non viene versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (prima il termine era il 27 dicembre dell’anno successivo) . Ciò significa, ad esempio, che per l’IVA 2023 il pagamento andrà effettuato entro il 31 dicembre 2025 per evitare conseguenze penali, mentre prima bisognava provvedere entro il 27 dicembre 2024 . Analogamente, non versare le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni configura reato sopra €150.000 annui , e non versare i contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti è reato sopra €10.000 annui . In tutti questi casi, se l’omissione viene sanata (pagando il dovuto) prima che inizi il processo penale, il reato non è punibile . Inoltre, avere un piano di rateizzazione in corso con il Fisco blocca la punibilità: la legge prevede che finché il debito è rateizzato e si rispettano le rate, non c’è reato; solo in caso di decadenza dalla rateazione, e se residua un importo oltre €75.000, il reato si “riattiva” .
Strumenti di difesa/rimedi: Cosa può fare l’azienda debitore per gestire debiti fiscali? In via amministrativa, è possibile chiedere una rateizzazione del debito iscritto a ruolo all’Agente della riscossione: ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 si possono ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni) automaticamente se si dimostra temporanea difficoltà di pagamento, e in casi di grave e comprovata crisi l’ente può estendere fino a 120 rate (10 anni). Il rispetto del piano di rateazione evita nuove azioni esecutive e, come visto, evita le sanzioni penali finché si paga regolarmente. Talvolta lo Stato vara misure eccezionali di “definizione agevolata” (cd. rottamazione delle cartelle): ad esempio, con la Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta la “rottamazione-quater” che consente di pagare solo l’imposta senza sanzioni e interessi per cartelle antecedenti a certe date. Queste misure sono sporadiche e dipendono dalla legge del momento: se ve ne sono, l’azienda farebbe bene a valutarle.
Al di fuori delle procedure concorsuali, non è possibile “stralciare” discrezionalmente i debiti fiscali (il Fisco non può accordare riduzioni ad hoc del debito tributario, se non previste da norme generali). Tuttavia, in presenza di una procedura di composizione della crisi (come un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo), si può ricorrere alla transazione fiscale, di cui diremo oltre, che consente di proporre il pagamento parziale dei tributi (inclusa IVA e contributi) . In estrema sintesi: fuori dalle procedure concorsuali, l’Erario può concedere solo dilazioni, mentre dentro una procedura concorsuale è possibile ottenere riduzioni dell’importo dovuto a titolo di imposte e contributi, a condizione di rispettare requisiti di legge (sostanzialmente, dimostrare che il Fisco ottiene almeno quanto otterrebbe in un fallimento) . Se tali condizioni sono rispettate, il giudice può omologare il piano anche senza l’assenso del Fisco (il cosiddetto cram-down fiscale) .
Dal punto di vista pratico, dunque, un’azienda con debiti fiscali dovrebbe attivarsi prontamente: verificare l’ammontare esatto (magari tramite un estratto di ruolo), valutare se può sostenere un piano di rateizzo ordinario o se occorre imbastire un piano di ristrutturazione complessivo, eventualmente comprensivo di transazione fiscale. Ignorare il problema aggraverebbe solo la situazione: l’Agente della riscossione accumulerà more e sanzioni e potrebbe arrivare a pignorare macchinari o crediti verso clienti, paralizzando l’attività. Inoltre, come visto, superate certe soglie temporali e di importo, gli amministratori rischiano imputazioni penali personali, per cui non è consigliabile far finta di nulla. Al contrario, mostrare collaborazione (ad esempio chiedendo subito la rateazione prima che scadano i termini penalmente rilevanti) può evitare conseguenze peggiori . Va ricordato che la normativa più recente ha mostrato apertura verso chi vuole regolarizzare: il D.Lgs. 87/2024 ha allungato i termini per mettersi in regola e ha previsto che persino il ricevimento di una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) da parte dell’Agenzia Entrate, seguito da un pagamento rateale avviato entro il 30 settembre successivo, è sufficiente ad evitare il reato di omesso versamento IVA . In breve, muoversi per tempo può fare la differenza tra una situazione risolvibile e una catastrofe legale.
Debiti bancari e finanziari
Le esposizioni debitorie verso banche o altri finanziatori (es. società di leasing, società di factoring) rappresentano spesso una quota importante dell’indebitamento di un’azienda industriale. Si pensi a mutui contratti per acquistare macchinari, aperture di credito in conto corrente per finanziare il capitale circolante, leasing per i beni strumentali o scoperti su anticipo fatture. Ciascuno di questi rapporti è regolato da un contratto che tipicamente prevede clausole a tutela della banca: ad esempio, se l’azienda ritarda i pagamenti o peggiora i propri indici finanziari, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato (decadenza dal beneficio del termine). Inoltre, spesso le banche hanno ottenuto garanzie: reali (ipoteche su immobili, pegni su beni o su crediti) oppure personali (fideiussioni dei soci o degli amministratori, garanzie del Fondo PMI, ecc.).
Conseguenze del mancato pagamento: Se l’impresa smette di pagare le rate di un mutuo o va “in rosso” sul conto oltre i limiti fidi, la banca in genere invia una segnalazione interna (e talora alla Centrale Rischi Bankitalia) e può procedere a revocare il credito. Ciò significa che somme prima disponibili diventano immediatamente esigibili. In mancanza di un accordo, la banca può: – Escutere le garanzie: ad esempio, se c’è un’ipoteca, avviare un’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato; se c’è una fideiussione personale, chiedere il pagamento ai garanti (mettendo così a rischio il patrimonio personale degli imprenditori). – Agire per decreto ingiuntivo e pignorare beni aziendali non specificamente gravati da privilegio: ad es. il conto corrente aziendale, i crediti verso clienti, le scorte di magazzino (tramite pignoramento mobiliare presso la sede). – In taluni casi, presentare istanza di fallimento se il credito è scaduto e rilevante. Va detto che per legge (art. 121 CCII) un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale se il debito scaduto supera €30.000 circa e ci sono insoluti persistenti: le banche raramente lo fanno subito, preferendo azioni esecutive singole, ma in situazioni disperate non è escluso.
Quando una banca escute una garanzia reale, ha un vantaggio: ad esempio il creditore ipotecario è soddisfatto con prelazione sul ricavato dell’immobile. Se però tale ricavato non copre tutto il debito, la parte restante diventa chirografaria (non garantita) e concorre con gli altri creditori sul resto del patrimonio aziendale. Se una banca attiva una causa o un pignoramento isolato, questo potrebbe accelerare la crisi: ad esempio il pignoramento del conto corrente aziendale può bloccare di fatto la gestione quotidiana.
Difesa e gestione del debito bancario: In primo luogo, è essenziale comunicare tempestivamente con la banca in caso di difficoltà. Spesso gli istituti, se avvisati prima che la situazione degeneri, possono accordare una moratoria o una rinegoziazione. Negli ultimi anni ABI e associazioni di categoria hanno sottoscritto protocolli di sospensione delle rate per le PMI in difficoltà (ad esempio, moratorie sui mutui). L’imprenditore dovrebbe valutare di chiedere alla banca una rimodulazione del piano di rientro (allungamento delle scadenze, periodo di pre-ammortamento) presentando un piano finanziario che dimostri la sostenibilità dei pagamenti ridotti. Se più banche sono coinvolte, può essere saggio cercare un accordo coordinato: ad esempio, tramite un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, di cui diremo più avanti, che vincola tutte le banche aderenti contemporaneamente . In alcuni casi, quando l’indebitamento bancario è eccessivo rispetto al patrimonio, i soci potrebbero valutare un ricapitalizzazione straordinaria o l’ingresso di un investitore (nuove risorse equity per ridurre il debito).
Se la banca ha una fideiussione personale dei soci o un pegno su azioni/quote, questi strumenti ampliano le opzioni di difesa della banca ma anche le leve di negoziazione: ad esempio, il socio garante, per evitare l’escussione personale, potrebbe trattare con la banca un accordo transattivo (come un pagamento parziale a saldo e stralcio, se la banca prevede altrimenti di non recuperare tutto dall’azienda). Da notare che se l’azienda poi accede a una procedura concorsuale, il garante (socio) che paga il debito subentra nel diritto di credito verso l’azienda, ma tale credito di regresso è postergato (subordinato) per legge se il garante è anche un socio controllante.
In sede giudiziale, uno strumento “difensivo” è la richiesta di sospensione dell’esecuzione: ad esempio, se la banca pignora un macchinario essenziale, l’azienda può chiedere al giudice un termine per tentare la ristrutturazione (oggi questo si ottiene più formalmente attivando la composizione negoziata o presentando domanda di concordato con “misure protettive”). Infatti, presentando una domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, il tribunale su richiesta può congelare le azioni esecutive dei creditori per la durata della procedura (automatic stay).
In sintesi, per i debiti bancari la parola d’ordine è negoziare e prevenire. Le banche, diversamente dal Fisco, hanno margine contrattuale per ristrutturare un credito (possono rinunciare a quote di interessi o anche a parte del capitale in un accordo se ritengono sia l’opzione più conveniente). Inoltre, essendo spesso creditori “forti” (magari con garanzie), conviene coinvolgerli in modo organico in un eventuale piano di risanamento: a tal proposito, un Piano Attestato di Risanamento spesso ha come attori principali proprio le banche, che accettano di supportare l’impresa (ad esempio convertendo crediti in medio termine, o concedendo nuova finanza protetta da esenzione revocatoria ) in cambio di un’attestazione professionale sulla fattibilità del piano stesso . Nel capitolo successivo vedremo i dettagli di questo strumento.
Se infine l’azienda non è più salvabile e la posizione bancaria è completamente deteriorata, potrebbe essere valutata la cessione del credito ad un terzo (es. società di recupero) o, dal lato azienda, sfruttare la leva della procedura concorsuale: in un concordato liquidatorio, la banca ipotecaria concorrerà fino a capienza del valore dei beni ed eventualmente come chirografo sul resto. L’azienda potrebbe allora proporre un concordato offrendo alla banca il valore di realizzo atteso del bene a garanzia, chiudendo così la partita in via concordataria senza subire l’intera esecuzione.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
Molte imprese in crisi presentano debiti commerciali verso fornitori di materie prime, subfornitori, prestatori di servizi, ecc. Spesso sono debiti non garantiti (chirografari) e, per il principio della par condicio tra creditori, tutti costoro hanno pari diritto di essere soddisfatti sui beni dell’azienda (subito dopo i privilegiati). In situazione di tensione finanziaria, l’azienda può ritardare i pagamenti ai fornitori, ma questo ha conseguenze: i fornitori potrebbero interrompere le forniture (mettendo a rischio la produzione) e/o agire legalmente per il recupero del credito.
Conseguenze del mancato pagamento: Il primo segnale è l’invio di solleciti e diffide da parte del fornitore. Se il debito persiste, il fornitore può richiedere un decreto ingiuntivo dal tribunale (un’ingiunzione di pagamento) presentando le fatture non pagate. Il decreto, se non opposto entro 40 giorni, diventa esecutivo e consente al fornitore di procedere con pignoramenti (presso la sede dell’azienda, presso terzi debitori dell’azienda, conti correnti, ecc.). Nella pratica, i fornitori spesso mirano a pignorare denaro in banca o crediti verso clienti (es.: bloccano pagamenti che i clienti dell’azienda debitrice dovevano fare). Tali azioni, oltre a mettere pressione, possono aggravare la crisi di liquidità dell’impresa. Se poi più fornitori agiscono simultaneamente, si può generare un effetto domino di pignoramenti e atti di sequestro dei beni aziendali.
In alcuni casi, i fornitori insoddisfatti possono coalizzarsi e presentare istanza di fallimento. Basta un creditore commerciale con credito certo, scaduto e superiore alla soglia di legge (€30.000) per legittimare l’istanza, purché ci sia uno stato di insolvenza (incapacità della società di pagare regolarmente). Gli amministratori devono prendere molto sul serio eventuali convocazioni innanzi al tribunale fallimentare su iniziativa di un fornitore: se ignorate, c’è il rischio concreto che venga aperta d’ufficio la liquidazione giudiziale (il “fallimento”).
Difesa e soluzioni verso i fornitori: La gestione dei debiti commerciali richiede abilità negoziale. Spesso i fornitori, soprattutto se hanno interesse a mantenere rapporti con l’azienda, sono disposti a concordare piani di rientro. Un piano di rientro può consistere in pagamenti dilazionati del dovuto (magari garantiti da effetti cambiari per formalizzare l’impegno) oppure in un parziale saldo e stralcio (il fornitore accetta di ridurre l’importo se riceve subito una percentuale). È importante mettere tali accordi per iscritto, eventualmente facendoli omologare (confermare) dal tribunale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, per avere certezza che tutti i creditori aderenti vi siano vincolati .
Nel breve termine, un imprenditore può classificare i fornitori in base alla criticità: quelli strategici vanno pagati con precedenza, cercando di non interrompere la supply chain; quelli meno cruciali potrebbero essere temporaneamente ritardati, ma con un dialogo costante per evitare azioni legali improvvise. Se un fornitore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, l’azienda può verificare se ci siano motivi validi di opposizione (vizi nella fornitura, contestazioni sulla qualità del bene): un’opposizione, se non pretestuosa, può guadagnare tempo spostando la questione su un binario giudiziale ordinario. Tuttavia, opporsi senza fondamento espone solo a ulteriori spese legali, perciò va usato con cautela.
Uno strumento utile può essere la composizione negoziata assistita (introdotta nel 2021, v. oltre): all’interno di quel tavolo, l’esperto terzo può aiutare a raggiungere intese con gruppi di fornitori, magari prevedendo che tutti accettino uno stralcio parziale del credito in cambio di continuità degli ordinativi futuri. Ad esempio, i fornitori potrebbero preferire una soluzione concordata (prendere il 50% subito e continuare a lavorare con l’azienda risanata) piuttosto che spingerla al fallimento e forse recuperare molto meno, molto più tardi.
Va ricordato che durante una procedura di concordato preventivo i creditori commerciali non possono agire individualmente: il deposito della domanda, se accompagnato da misure protettive ex art. 54 CCII, blocca le azioni esecutive individuali. Dunque una strategia può essere anche quella di avviare un concordato per congelare gli attacchi e poi trattare all’interno della procedura collettiva.
Un aspetto delicato: se nei mesi prima dell’eventuale fallimento l’azienda paga selettivamente qualche fornitore, quei pagamenti potrebbero essere soggetti a azione revocatoria fallimentare (pagamenti preferenziali). Tuttavia, se tali pagamenti avvengono in esecuzione di un piano attestato di risanamento regolarmente attestato, sono esenti da revocatoria . Questo è un incentivo a inserire i fornitori critici in un piano attestato o accordo formale, anziché pagarli “di nascosto”, perché così sia l’imprenditore sia il fornitore saranno tutelati qualora poi la crisi sfoci in fallimento. L’art. 56 CCII disciplina proprio gli “atti esecutivi di piani attestati” come non revocabili .
Debiti verso dipendenti e verso enti previdenziali
I debiti verso il personale dipendente riguardano tipicamente retribuzioni non pagate, trattamento di fine rapporto (TFR) maturato e non versato, indennità varie e contributi previdenziali dovuti a INPS (quota a carico datore) e ritenute previdenziali (quota trattenuta al lavoratore). Questa categoria di crediti gode, nel nostro ordinamento, di una tutela preferenziale per ragioni sociali. In caso di procedura concorsuale, i lavoratori subordinati vantano un privilegio generale sui mobili dell’azienda per le ultime mensilità di stipendio e per il TFR, oltre a un privilegio speciale (super-privilegio) su determinati beni per alcune componenti (es.: ultimi 3 mesi di retribuzione) ai sensi dell’art. 2751-bis n.1 c.c. Ciò significa che, in sede di riparto fallimentare o di concordato, i dipendenti vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari e anche prima di alcuni privilegiati minori.
Conseguenze del mancato pagamento dei dipendenti: Oltre all’evidente impatto negativo sul morale e sulla capacità produttiva (un dipendente non pagato tenderà a cessare la prestazione, scioperare o dimettersi), vi sono conseguenze legali. Il dipendente può presentare un ricorso al giudice del lavoro per ottenere un decreto ingiuntivo per le somme dovute (di solito molto rapido trattandosi di crediti di lavoro documentati da buste paga). Con il decreto, può procedere a pignorare conti aziendali o beni, analogamente a un fornitore, benché spesso i dipendenti privilegino altre strade. Una via frequente, infatti, è la messa in mora collettiva assistita dai sindacati e, in parallelo, la segnalazione all’Ispettorato del lavoro. Se l’azienda appare insolvente e non vi sono prospettive, i dipendenti (o i sindacati per loro conto) possono presentare istanza di fallimento dell’azienda, per attivare il Fondo di Garanzia INPS. Quest’ultimo interviene infatti solo in caso di apertura di una procedura concorsuale o di insolvenza legale del datore: in pratica, se l’azienda fallisce o va in concordato liquidatorio, l’INPS paga ai lavoratori il TFR e le ultime mensilità arretrate (fino a un massimale), surrogandosi poi nel credito verso l’azienda.
Non pagare i contributi previdenziali dovuti all’INPS ha inoltre riflessi penali: come accennato, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali (cioè la parte trattenuta dalle buste paga del lavoratore) è depenalizzato fino a €10.000 annui, ma oltre tale soglia costituisce reato punito con la reclusione fino a 3 anni . Anche qui, il datore può evitare la punibilità pagando il dovuto prima del processo. L’omesso versamento della quota datoriale dei contributi (quella non trattenuta) è sanzionato amministrativamente ma non penalmente; tuttavia, l’INPS può emanare avvisi di addebito immediatamente esecutivi e procedere a recupero coattivo (simile alle cartelle dell’Agenzia Entrate).
Strategie e tutele: È prioritario, per quanto possibile, assicurare ai dipendenti almeno le retribuzioni correnti. In situazioni di crisi, esistono strumenti come la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o altri ammortizzatori sociali che, se attivabili, possono coprire temporaneamente parte degli stipendi. Ad esempio, se l’azienda ha cali di lavoro, può chiedere la CIG straordinaria per crisi, evitando di accumulare altro debito verso i dipendenti. Se invece i debiti verso i lavoratori già esistono, una strada è coinvolgerli nel piano di risanamento: in qualche caso i dipendenti (specie quadri o dirigenti) potrebbero accettare di posticipare il pagamento di alcune voci (es. TFR) se vedono un serio piano di salvataggio. Legalmente, in un concordato preventivo, i crediti dei lavoratori possono essere trattati separatamente in classi e spesso vengono pagati integralmente (quanto meno per le componenti privilegiate) per ottenere il loro voto favorevole. Il Codice della crisi prevede comunque che ai lavoratori possa essere imposto al massimo una moratoria di 6 mesi dal decreto di omologa per i crediti con privilegio ex art. 2751-bis n.1 c.c. , niente di più. Quindi un concordato in continuità aziendale non può, ad esempio, dilazionare i pagamenti ai dipendenti oltre 6 mesi dopo l’omologa senza il loro consenso.
Dal lato dei lavoratori, sapere che esiste il Fondo di garanzia INPS spesso li spinge – se perdono fiducia – a provocare l’apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione giudiziale). Dal lato dell’azienda, paradossalmente, aprire una procedura può diventare la soluzione anche per loro: ad esempio in un concordato l’azienda può prevedere che subito dopo l’omologa i dipendenti riceveranno TFR e arretrati (grazie all’intervento del Fondo INPS per il TFR e ad eventuali risorse allocate nel piano), restituendo un minimo di serenità. Inoltre, l’apertura di un concordato o di una composizione negoziata impedisce che i singoli dipendenti procedano con cause individuali e pignoramenti, concentrando la vicenda in un alveo comune.
In sintesi, il consiglio in presenza di debiti verso i dipendenti è di mantenere un dialogo trasparente. Dal punto di vista umano prima che legale, i lavoratori informati sulla crisi e coinvolti – per quanto possibile – nelle prospettive di soluzione, saranno più propensi a collaborare (magari evitando dimissioni di massa o azioni legali immediate) in vista di salvare l’impresa e quindi i posti di lavoro. Viceversa, tagliarli fuori o tardare eccessivamente nei pagamenti porterà quasi certamente a vertenze e istanze esterne.
Altre categorie di debito
Ulteriori debiti che un’azienda può avere includono: – Debiti verso soci o parti correlate: ad esempio finanziamenti soci. Questi in genere sono postergati per legge (art. 2467 c.c. per S.r.l.): significa che in caso di insolvenza si rimborsano solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori. Dunque, per definizione, non costituiscono una priorità e spesso vengono sacrificati integralmente nei piani di risanamento (i soci convertendo il credito in capitale o perdendolo). – Debiti da leasing: il lessor (società di leasing) se l’azienda non paga le rate può risolvere il contratto e riprendere il bene in leasing (macchinario, veicolo) rapidamente. In sede concorsuale, i crediti da leasing possono essere trattati come crediti privilegiati sul bene o come crediti prededucibili se si prosegue il contratto. L’azienda in crisi potrebbe valutare di rinegoziare i leasing (ad esempio chiedendo sospensione canoni) oppure restituire i beni inutili per ridurre costi. – Debiti verso l’erario locale: es. IMU, TARI verso il Comune. Questi seguono regole simili ai tributi erariali quanto a riscossione (ruoli, ingiunzioni fiscali comunali). Nella transazione fiscale (art. 63 CCII) le imposte locali non sono incluse per espressa esclusione , quindi vanno negoziate a parte (in un concordato se non si pagano integralmente, l’ente locale può votare contro, ma non ha potere di veto se classe minoritaria). – Debiti per sanzioni e multe amministrative: normalmente in procedure concorsuali le sanzioni pecuniarie tributarie si possono stralciare al 100% (lo consente la transazione fiscale, considerando che il Fisco deve avere almeno il capitale e interessi in comparazione liquidatoria, le sanzioni essendo postergate spesso non vengono pagate). Per altre multe, valgono i privilegi eventuali di legge o sono chirografarie e di solito nei piani non vengono soddisfatte per intero.
Ogni tipologia di debito ha quindi peculiarità, ma il debitore in crisi deve concepire una strategia unitaria: non si può risolvere la crisi pagando solo alcuni creditori e ignorando altri. Questo perché, a parte questioni etiche, i creditori trascurati agiranno e vanificheranno gli sforzi. È fondamentale quindi valutare il quadro completo dei debiti e scegliere uno strumento (informale o concorsuale) che consenta di affrontarli tutti insieme con un disegno organico.
Nel seguito, analizziamo gli strumenti di risanamento e ristrutturazione del debito disponibili nell’ordinamento italiano (profondamente riformati negli ultimi anni), evidenziando per ciascuno come funzionano, i vantaggi offerti (ad es. esenzione da revocatorie, protezioni penali, agevolazioni fiscali) e i limiti. Si passerà dai rimedi stragiudiziali (negoziali, volontari) a quelli concorsuali (giudiziali o para-giudiziali), con riferimenti alla normativa vigente del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche fino al D.Lgs. 136/2024).
Strategie di risanamento e strumenti di regolazione della crisi
Di fronte a una situazione debitoria importante, un imprenditore sostanzialmente ha due strade: accordarsi privatamente con i creditori (soluzioni stragiudiziali) oppure ricorrere a procedure concorsuali o para-concorsuali previste dalla legge. La scelta dipende dalla gravità della crisi, dal numero di creditori coinvolti e dal livello di collaborazione che questi sono disposti a offrire.
Di seguito esamineremo, in ordine, i principali strumenti oggi a disposizione: – Gestione stragiudiziale negoziata: piani di rientro informali, moratorie volontarie, composizione negoziata assistita (ex D.L. 118/2021). – Piano attestato di risanamento (strumento negoziale con attestazione professionale, art. 56 CCII). – Accordo di ristrutturazione dei debiti (accordo omologato con una maggioranza di creditori, art. 57 e ss. CCII). – Concordato preventivo (procedura concorsuale vera e propria, con diverse possibili declinazioni: in continuità o liquidatorio, art. 84 e ss. CCII). – Strumenti particolari collegati: transazione fiscale e contributiva (art. 63 e 88 CCII), concordato semplificato post-composizione negoziata (art. 25-sexies CCII), procedure per soggetti minori (concordato minore, piano di ristrutturazione del sovraindebitato) e l’eventuale liquidazione giudiziale come ultimo step.
Per ognuno valuteremo quando è indicato, quali effetti produce e come si colloca nel contesto normativo attuale. Al termine, forniremo anche una tabella comparativa per riepilogare le differenze chiave tra piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato.
Soluzioni stragiudiziali informali (negoziazione privata)
Prima di coinvolgere il tribunale, molte crisi d’impresa possono (e dovrebbero) essere affrontate cercando accordi diretti con i creditori. La soluzione stragiudiziale classica è il piano di rientro extragiudiziale: l’imprenditore elabora un piano di pagamenti dilazionati e/o parziali e lo propone ai creditori, magari supportato dai propri consulenti. Se tutti o la gran parte dei creditori accettano, l’azienda evita procedure formali e continua l’attività cercando di rispettare il piano. Questa strada ha il pregio della riservatezza (non diventa pubblica) e della flessibilità (non è vincolata dai formalismi di legge).
Tuttavia, presenta anche notevoli rischi e limiti: – Mancanza di vincolo per i dissenzienti: ogni accordo ha efficacia contrattuale solo tra chi lo firma. I creditori che non aderiscono, o anche quelli aderenti ma insoddisfatti, possono comunque avviare azioni esecutive. Non c’è una moratoria legale generale. In pratica, basta un solo creditore “aggressivo” per far saltare il tavolo. – Revocatoria fallimentare: se poi l’azienda dovesse fallire entro i due anni, i pagamenti effettuati ai creditori in base ad un piano informale potrebbero essere revocati dal curatore (come atti preferenziali). A meno che l’accordo non sia elevato a Piano Attestato ex art. 56 CCII e pubblicato, quei pagamenti non godono di protezione e i creditori correrebbero il rischio di dover restituire le somme . – Difficoltà di coordinamento: con molti creditori, senza un quadro normativo di riferimento, è difficile ottenere consenso unanime. Ognuno potrebbe cercare di migliorare la propria posizione (il free rider problem, per cui conviene a ciascun creditore non aderire e sperare che altri aderiscano e risanino l’azienda, così poi lui potrà pretendere per intero).
Ciò premesso, l’accordo stragiudiziale può funzionare in casi relativamente semplici: – Pochi creditori, magari principalmente banche, già disposte a collaborare. – Un’arretratezza temporanea (es. crisi di liquidità momentanea) risolvibile con dilazioni brevi, che i creditori possono concedere senza dover ricorrere a un giudice. – Presenza di un garante terzo o di un fondo di investimento pronto a intervenire se i creditori accettano un certo taglio (in questi casi il deal può chiudersi come un contratto privato complesso).
Per strutturare un buon piano extragiudiziale, l’imprenditore dovrebbe: – Presentare ai creditori una situazione economico-finanziaria trasparente (magari asseverata da un professionista per dare credibilità). – Pari trattamento: di regola offrire condizioni proporzionalmente eque a tutti i chirografari, per evitare che qualcuno si senta discriminato e faccia saltare l’accordo. – Inserire, se possibile, clausole di standstill: tutti sospendono le azioni legali durante l’esecuzione del piano, salvo in caso di inadempimento. A volte le banche firmano accordi di standstill in pool, impegnandosi a non revocare fidi durante le trattative. – Prevedere eventuali garanzie aggiuntive a supporto del piano (es. i soci garantiscono nuovi apporti se l’azienda non rispetta una scadenza, o rilasciano fideiussioni): questo può convincere i creditori della serietà dell’intento.
Un’evoluzione “assistita” delle trattative stragiudiziali è la Composizione Negoziata della Crisi, in vigore dal novembre 2021 (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021) e ora integrata nel CCII (artt. 12-25). Si tratta di una procedura volontaria in cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto indipendente (spesso un commercialista esperto di crisi) che lo affianca nel negoziare con i creditori. La composizione negoziata è riservata (non viene inizialmente pubblicizzata) e si svolge in un arco temporale di qualche mese. L’esperto convoca i creditori principali e cerca di facilitare un accordo “di sistema”. Durante questa procedura, il debitore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee (ad es. sospensione delle azioni esecutive per la durata delle trattative) . Ciò crea un contesto simile a quello concorsuale (una sorta di ombrello temporaneo) senza però dichiarare l’insolvenza né coinvolgere formalmente tutti i creditori.
La composizione negoziata può sfociare in diversi esiti: – Un contratto o accordo transattivo con taluni creditori (es. le banche che rischedulano il debito, alcuni fornitori che accettano un taglio). Questi accordi restano stragiudiziali ma beneficiano dell’opera di mediazione dell’esperto. – Un Piano Attestato di Risanamento formalizzato e pubblicato, se la situazione lo permette (spesso l’esperto stesso suggerisce di far attestare il piano concordato). – Un Accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoporre a omologa, se si raggiunge la maggioranza richiesta (60% dei crediti). – Se nessuna di queste soluzioni si rivela praticabile, l’imprenditore può – al termine della composizione negoziata – accedere in via straordinaria a un Concordato preventivo “semplificato” per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) di cui diremo oltre, oppure sarà costretto alla liquidazione giudiziale.
In definitiva, la via stragiudiziale è preferibile all’inizio perché evita il pregiudizio reputazionale che un procedimento concorsuale comporta e riduce costi e tempi. Ma bisogna saperla gestire: tempestività, trasparenza e correttezza sono fondamentali. Inoltre, è consigliabile coinvolgere consulenti legali e finanziari per redigere accordi solidi e prevedere gli effetti anche in caso di successivo fallimento (ad esempio, includere nei contratti eventuali condizioni risolutive o clausole che tengano conto della possibile apertura di procedure, e predisporre il piano in modo da poter essere eventualmente trasformato in un accordo ex art. 57 CCII). Se la soluzione privata fallisce o non è praticabile, occorre passare agli strumenti concorsuali, dove interviene il tribunale a imporre regole uguali per tutti i creditori.
Passiamo ora a esaminare nel dettaglio gli strumenti concorsuali e para-concorsuali previsti dalla legge per regolare la crisi d’impresa, iniziando dal Piano attestato di risanamento.
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)
Il Piano attestato di risanamento è un piano di risanamento aziendale extragiudiziale (fuori dalle procedure concorsuali) caratterizzato dall’intervento di un professionista indipendente che “attesta” la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Questo istituto, introdotto nel 2005 e ora disciplinato compiutamente dall’art. 56 del Codice della crisi, offre all’imprenditore in crisi la possibilità di raggiungere un equilibrio finanziario evitando di passare per il tribunale, ma con alcuni benefici legali concessi dalla legge in cambio dell’attestazione indipendente .
Presupposti e finalità: Il piano attestato può essere utilizzato da qualsiasi imprenditore commerciale (individuale o societario) che si trovi in stato di crisi o insolvenza . La crisi è intesa come probabilità di futura insolvenza o forte squilibrio, l’insolvenza come incapacità conclamata di pagare i debiti in modo regolare . Sorprendentemente, la norma consente l’uso del piano anche se l’impresa è già insolvente, purché vi sia concreta possibilità di risanamento: in pratica può essere tentato fino all’ultimo, prima di arrendersi al fallimento, se c’è un progetto credibile di recupero. Lo scopo del piano attestato è evitare il dissesto irreversibile attraverso un accordo con (alcuni o tutti) i creditori che rimetta in sesto l’azienda. Contrariamente al concordato, il piano attestato non coinvolge automaticamente tutti i creditori: è un piano che l’imprenditore rivolge ai creditori che intende coinvolgere (tipicamente quelli principali) per ottenere da loro accordi di ristrutturazione del debito, nuova finanza o altre operazioni utili al riequilibrio . I creditori non coinvolti restano estranei e mantengono i loro diritti, il che come visto è un limite ma anche una flessibilità (posso far un piano con una banca anche se le altre non aderiscono, ad esempio).
Contenuto del piano e attestazione: L’art. 56 CCII richiede che il piano sia messo per iscritto e con data certa, e ne definisce un contenuto minimo obbligatorio. In particolare, il piano deve indicare: – la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; – le cause della crisi e le strategie di intervento per porvi rimedio; – la descrizione delle misure da adottare (operazioni straordinarie, aumenti di capitale, cessioni di asset, taglio costi, ecc.); – i creditori coinvolti e le intese raggiunte o proposte (es: banca X allunga il mutuo, fornitore Y accetta il 80% a saldo, ecc.); – un piano finanziario pluriennale con proiezioni, da cui risulti che l’impresa è risanabile.
Elemento chiave è la relazione di attestazione redatta da un attestatore indipendente, iscritto all’albo dei revisori e munito dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all’art. 2 CCII. L’attestatore verifica la veridicità dei dati aziendali e giudica la fattibilità del piano, cioè se realisticamente esso permetterà di pagare i debiti e riequilibrare la situazione . L’indipendenza dell’attestatore è cruciale (non deve aver conflitti di interesse né legami con l’azienda) e le sue conclusioni non garantiscono matematicamente il successo, ma costituiscono una perizia terza che dà conforto ai creditori sulla serietà del piano.
Benefici legali del piano attestato: Pur essendo un accordo volontario, il piano attestato pubblicato (è facoltativa ma consigliata la pubblicazione in Registro delle Imprese) produce alcuni effetti protettivi se poi l’azienda dovesse cadere in fallimento: – Gli atti, pagamenti e garanzie eseguiti in esecuzione del piano non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare . Ciò significa che, se io ho pagato un fornitore durante il piano attestato (in conformità al piano stesso) e dopo un anno fallisco, il curatore non potrà chiedere la restituzione di quel pagamento al fornitore, purché il piano fosse all’epoca idoneo e attestato regolarmente. Questo rassicura sia il debitore che i creditori aderenti: i primi possono pagare ciò che è previsto senza timore, i secondi non rischiano di dover restituire somme. – Esenzione da reati di bancarotta semplice e preferenziale: L’art. 324 CCII stabilisce che non si applichino i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice impropria per gli atti compiuti durante l’esecuzione di un piano attestato . In pratica, se poi la società fallisce, non saranno punibili penalmente: – i pagamenti preferenziali fatti in attuazione del piano (pagare alcuni creditori a scapito di altri di solito è reato di bancarotta preferenziale, ma il piano funge da “zona franca” perché quei pagamenti erano finalizzati al risanamento) ; – le condotte che sarebbero bancarotta semplice (ad es. aver aggravato il dissesto, aver tardato a chiedere il fallimento) se tali condotte sono state funzionali all’esecuzione del piano . Esempio: l’imprenditore che ritarda la dichiarazione di fallimento perché sta tentando un piano attestato non sarà incriminato per bancarotta semplice da ritardata convocazione, a differenza di chi ritarda per inerzia colpevole . – Importante: questa esenzione penale non copre i reati di bancarotta fraudolenta (distrazione di beni, false scritture, ecc.) . Quindi non è un salvacondotto totale: se qualcuno approfittasse del piano per frodare, verrebbe comunque perseguito per i reati più gravi. L’esenzione tutela solo chi in buona fede compie atti altrimenti rischiosi (preferenze, decisioni gestionali difficili) nel tentativo onesto di risanare . Questa norma di civiltà giuridica mira a eliminare la “paura” che spesso frenava imprenditori e banche dal tentare un salvataggio: ora se la banca concede nuova finanza con garanzia durante un piano e poi l’azienda fallisce, né la banca né l’amministratore saranno accusati di bancarotta preferenziale per quella garanzia . – Detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione del debito: Il successo di un piano spesso comporta che alcuni creditori rinuncino a una parte dei loro crediti (abbuoni). Normalmente, la legge fiscale considererebbe questo come un “ricavo” straordinario tassabile (sopravvenienza attiva). Ma l’art. 88, comma 4-ter TUIR prevede che le sopravvenienze attive derivanti da concordati, accordi di ristrutturazione omologati e piani attestati di risanamento non concorrono a formare il reddito imponibile . Quindi, se grazie al piano l’azienda ottiene uno stralcio di €100.000 di debiti, non dovrà pagare tasse su quel “guadagno” contabile . Questo è essenziale: altrimenti l’azienda risanata si troverebbe subito un debito fiscale per le tasse sulle somme condonate (sarebbe paradossale). Nel 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente (Risoluzione 222/E del 13 novembre 2024) che l’agevolazione si applica anche ai piani attestati ex CCII, purché siano pubblicati nel Registro delle Imprese . Dunque è opportuno pubblicare il piano per beneficiare della detassazione. (Nota: l’agevolazione vale solo per la parte di riduzione non già dedotta dal creditore come perdita, ma ciò esula dagli scopi di questa guida.)
In sintesi, il legislatore incentiva il piano attestato offrendo scudi legali: niente revocatorie, niente bancarotta semplice/preferenziale, niente tasse sulle riduzioni di debito. Questi benefici si ottengono a fronte della serietà del piano attestato, garantita dall’attestazione di un professionista indipendente.
Limiti del piano attestato: Il piano attestato rimane uno strumento contrattuale e volontario. Ciò implica alcuni limiti: – I creditori non aderenti non sono vincolati. Il piano potrebbe riguardare, ad esempio, solo le banche (che accettano di ristrutturare) e lasciare fuori alcuni fornitori che magari decidono di agire per conto proprio. Non esiste un effetto erga omnes come nelle procedure omologate . Di norma, per sicurezza, si cerca di ottenere almeno un impegno informale dai principali creditori estranei a non intraprendere azioni durante l’esecuzione del piano (accordi di standstill paralleli). – Non c’è alcuna cristallizzazione del debito né sospensione automatica delle azioni. Il piano attestato di per sé non “freeza” i debiti: se un creditore cambia idea o un nuovo creditore compare, possono far partire cause o pignoramenti in qualsiasi momento (a meno di misure protettive richieste in composizione negoziata, come detto). Questa instabilità rende il piano attestato adatto soprattutto a situazioni in cui i creditori coinvolti sono pochi e controllabili, oppure quando l’azienda ha un paracadute (es. pronta a presentare un concordato se qualcuno aggredisce). – Non comporta scarico automatico dei debiti insostenibili: se, ad esempio, un creditore non vuole scontare nulla, il piano non può imporglielo. Si può al più decidere di non pagarlo e considerarlo estraneo, col rischio però che quello inizi un’azione legale. – Infine, anche se la legge non pone limiti di durata, è intuitivo che un piano attestato troppo lungo (oltre 3-5 anni) difficilmente verrà accettato dai creditori, i quali preferirebbero in tal caso le tutele formali di un concordato.
Quando usare un piano attestato: Nella pratica, il piano attestato è indicato quando: – L’impresa ha prospettive concrete di ripresa, magari con un supporto finanziario nuovo (soci pronti a investire, vendita di un ramo d’azienda per far cassa, ecc.), e necessita solo di tempo e respiro dai creditori. – I creditori chiave (tipicamente le banche e qualche fornitore strategico) sono disponibili alla collaborazione senza bisogno di coercizione giudiziale. Ad esempio, se ho 5 banche e 4 sono d’accordo, posso fare un piano attestato con quelle 4 e trattare singolarmente la quinta; se ne avessi 10 con differenti visioni, forse sarebbe meglio un accordo di ristrutturazione omologato. – Si vuole evitare la pubblicità e la stigmatizzazione di una procedura concorsuale, ad esempio per non perdere commesse (molti clienti evitano di ordinare a un’azienda “in concordato” temendo inadempimenti, mentre se l’azienda è in piano attestato ciò potrebbe neppure essere noto all’esterno se non viene pubblicato). – Si desidera tutelare l’affidabilità: un piano attestato non comporta, ad esempio, l’esclusione dalle gare pubbliche, mentre il concordato preventivo in certi casi sì (anche se su questo il nuovo Codice è più flessibile, prevedendo la possibilità di partecipare se in continuità).
Profilo procedurale: Non c’è una procedura giudiziaria da descrivere per il piano attestato, perché il tribunale non interviene né omologa nulla. Tipicamente, l’iter è: 1. L’azienda elabora (magari con un advisor finanziario) un piano industriale e finanziario di risanamento. 2. Viene individuato un attestatore indipendente, il quale esamina il piano, fa verifiche (due diligence) sui dati contabili e sui presumibili risultati futuri, e stende una relazione di attestazione in cui dichiara che il piano è idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare l’azienda . 3. Nel frattempo l’azienda negozia con i creditori coinvolti le specifiche modifiche: ad es. firma accordi bilaterali con ciascuno (contratti di ristrutturazione del debito, nuove linee di credito). 4. Formalizzato il tutto, il piano e la relativa attestazione vengono “portati a conoscenza” dei creditori (spesso firmati dagli stessi per accettazione). La legge non impone la pubblicazione, ma è possibile depositare il piano e la relazione presso il Registro delle Imprese per avere data certa e attivare le esenzioni di legge. La pubblicazione serve anche per la detassazione fiscale delle sopravvenienze, come detto . 5. L’azienda quindi esegue il piano sotto la propria responsabilità. Non c’è un commissario o un giudice delegato: l’imprenditore rimane completamente in carica. È buona norma comunque informare periodicamente i creditori sull’avanzamento, per mantenere la fiducia.
Esempio pratico: La nostra azienda di termosaldatrici potrebbe fare un piano attestato in questo modo: i soci immettono €200.000 freschi; la banca principale accetta di non chiedere rientro e anzi estende la durata del mutuo di 5 anni; due fornitori strategici accettano di falcidiare il 30% del credito e ricevere il 70% in 12 mesi; l’azienda cede un capannone non più usato e con il ricavato paga i debiti minori. Un professionista attesta che così l’azienda tornerà solvibile e redditizia entro 2 anni. Il piano viene firmato e pubblicato. I creditori estranei (es. altri fornitori che rappresentano il 10% dei debiti) vengono tutti pagati regolarmente alle scadenze per evitare problemi, magari usando parte della nuova finanza dei soci. In tal modo l’azienda evita il default, regolarizza la posizione col Fisco (magari usando la nuova liquidità per saldare cartelle in rateazione) e riparte più leggera di debiti. Se tutto va bene, il piano attestato rimane “invisibile” e concluso con successo. Se sfortunatamente dopo un anno l’azienda fallisse lo stesso, i pagamenti fatti secondo il piano comunque non potranno essere revocati e nessuno potrà accusare i dirigenti per aver continuato l’attività durante il tentativo di risanamento .
Rapporto con altri strumenti: Il piano attestato non preclude l’uso successivo di procedure concorsuali. Se, ad esempio, alcuni creditori importanti non aderiscono al piano, l’imprenditore può convertirlo in un accordo di ristrutturazione o in un concordato (presentando ricorso in tribunale). Viceversa, a volte il piano attestato viene dopo un concordato “in bianco” ritirato: ciò è accaduto in casi come Tribunale di Venezia 2021, dove un imprenditore aveva avviato un concordato ma poi, ottenuto un finanziamento nuovo, ha preferito eseguire un piano attestato e il tribunale ha riconosciuto la legittimità di questa successione . La legge specifica comunque che non c’è consecuzione tra il piano e l’eventuale procedura successiva (il piano attestato non essendo una procedura concorsuale), quindi il periodo sospetto delle revocatorie fallimentari riparte da zero se dopo si apre un fallimento o un concordato . Inoltre, i creditori che hanno aderito al piano e ricevuto pagamenti, se poi arriva un fallimento, conservano quanto incassato (grazie all’esenzione) e gli altri concorreranno sul residuo .
Novità normative recenti: Dal 2019 ad oggi il piano attestato è stato oggetto di alcune modifiche. Il D.Lgs. 83/2022 (correttivo) e il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) hanno parzialmente integrato la disciplina: – È stato chiarito che il piano deve avere data certa e che l’attestazione va allegata integralmente. – Sono stati definiti meglio i requisiti dell’attestatore e le sue responsabilità civili e penali (può rispondere di false attestazioni). – Con il correttivo 2024 si è introdotta (all’art. 23 CCII) la possibilità, durante la composizione negoziata, di effettuare accordi in esecuzione di piani attestati che includano anche la transazione fiscale . In pratica, oggi il piano attestato può comprendere una proposta di saldo di debiti fiscali con stralcio, da convalidare tramite omologa semplificata se avviene all’esito della composizione negoziata. È una innovazione importante: prima, fuori dal concordato, l’Erario non poteva essere falcidiato; ora pare possibile inserirlo in un piano attestato integrato nella composizione negoziata (resta però un tema complesso e in evoluzione interpretativa). – La prassi fiscale, come detto, ha evoluto l’applicazione della detassazione delle sopravvenienze anche ai piani attestati CCII .
In conclusione, il piano attestato di risanamento è uno strumento potente ma delicato. Richiede fiducia tra imprenditore e creditori e competenza tecnica nella redazione e attestazione. Offre benefici unici (protezione da revocatorie e da alcuni reati concorsuali ) e, se sostenuto da buone prospettive aziendali, può evitare la pubblica gogna del tribunale. Di contro, se la situazione è troppo compromessa o con troppi attori in gioco poco cooperativi, può rivelarsi insufficiente: in tal caso, bisogna considerare gli strumenti giudiziali come l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato, di cui ora ci occupiamo.
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ARD, art. 57-64 CCII)
L’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (abbreviato ARD) è uno strumento introdotto anch’esso nel 2005 e ora disciplinato dagli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi. Si tratta di un accordo negoziale tra il debitore e una parte sostanziale dei suoi creditori, che però acquista efficacia generale tramite l’omologazione del tribunale . In altre parole, è un ibrido tra piano privato e procedura concorsuale: – Il debitore deve ottenere l’adesione di almeno il 60% dei crediti totali (per valore) , calcolati su base concordataria (escludendo quelli eventualmente postergati). I creditori aderenti firmano un accordo scritto con il debitore, che contiene le misure di ristrutturazione (dilazioni, stralci, conversioni di crediti in capitale, ecc.). – Viene nominato un attestatore indipendente che certifica che l’accordo è idoneo a soddisfare integralmente i creditori estranei entro determinati termini . – Il debitore presenta ricorso al tribunale per far omologare l’accordo. Il tribunale verifica la regolarità (percentuale di adesioni, ecc.) e l’assenza di pregiudizio per i creditori non aderenti. Non c’è un voto formale dei creditori (già espresso con l’adesione), ma i creditori estranei possono fare opposizione. – Se tutto è in regola, il giudice omologa con decreto. Da quel momento l’accordo è efficace e vincolante tra le parti e – limitatamente ad alcuni effetti – anche verso terzi.
Vantaggi dell’ARD rispetto al piano attestato: – Moratoria legale limitata: Su richiesta del debitore, il tribunale può vietare o sospendere per max 120 giorni le azioni esecutive dei creditori non aderenti, dopo il deposito del ricorso di omologazione . Ciò offre un respiro durante la fase di omologa (anche se più breve e condizionato rispetto al concordato). – Cram-down settoriale: L’ARD base vincola solo i firmatari. Tuttavia, esistono varianti come l’accordo esteso (art. 61 CCII) in cui, se i crediti bancari/finanziari aderenti sono almeno 75% di quella categoria, il debitore può chiedere al giudice di estendere gli effetti dell’accordo anche alle banche dissenzienti minoritarie . Ad esempio, se 3 banche su 4 hanno firmato (80% del debito bancario) e la quarta no, il tribunale può imporre alla quarta le stesse condizioni pattuite con le altre (purché non sia trattata peggio di quel che avrebbe in fallimento). Questa è una forma di cram-down per evitare che poche banche guastino un accordo sostenuto dalla maggioranza. Similmente, con il correttivo 2022 sono stati introdotti gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60-bis CCII) dove la soglia di adesione è ridotta al 30%, ma senza effetti verso estranei – utili come passo intermedio verso un concordato, ad esempio. – Trattamento dei creditori estranei: L’accordo, per legge, deve prevedere che i creditori non aderenti vengano integralmente soddisfatti entro 120 giorni dall’omologa (per i chirografari) o 180 giorni (se privilegiati per la parte non coperta da garanzia) . Questa clausola è per assicurare che chi non firma non subisca alcun sacrificio (a differenza del concordato dove anche i dissenzienti possono dover accettare una falcidia). Dunque, se c’è qualcuno che non si vuole aggregare, bisogna comunque pagarlo per intero in tempi brevi: ciò pone un limite di fattibilità. Spesso i creditori estranei sono pochi e di modesto importo, e vengono pagati cash; se invece c’è un “grosso” estraneo, di fatto l’ARD funziona solo se anche lui sta al gioco (o si trasforma l’operazione in un concordato per poterlo forzare). – Pubblicità & effetto sugli estranei: Il ricorso per omologazione è pubblicato al Registro Imprese, quindi i terzi vengono a conoscenza che l’impresa è in fase di ristrutturazione ex art. 57. Ciò può avere impatti reputazionali, sebbene minori rispetto al concordato (che è più noto). A omologa avvenuta, l’accordo viene inserito nel Registro delle procedure di insolvenza. – Flessibilità negoziale: Non essendoci classi né votazioni, l’imprenditore può negoziare con ciascun aderente condizioni ad hoc, a patto di rispettare la par condicio per gli estranei (che tanto saranno pagati per intero). Questa flessibilità consente soluzioni creative e mirate, in genere più rapide da formalizzare di un concordato che richiede documenti più complessi.
Svantaggi e limiti dell’ARD: – Soglia di adesione elevata: Raggiungere il 60% del passivo è oneroso. Se il debito è molto frammentato tra tanti piccoli creditori, è quasi impossibile. L’ARD si presta quindi a situazioni in cui pochi creditori detengono la maggior parte del debito (es. banche). – Nessun effetto per dissenzienti rilevanti: Se un creditore grande (supponiamo 30% del totale) non vuole aderire, l’ARD standard non può vincolarlo e quello potrà far saltare il banco (chiedendo fallimento o rifiutando di attendere 120 giorni il pagamento integrale). In tal caso, come suggerito anche dalla prassi, conviene “cambiare gioco”: ossia convertire il percorso in un concordato, dove invece anche quel 30% potrà essere travolto se c’è il voto della maggioranza. – Tempi legali comunque presenti: Un’omologazione, specie se ci sono opposizioni, può durare diversi mesi (3-6 mesi). L’accordo però è già stipulato, per cui nel frattempo l’azienda deve tenere duro finanziariamente. C’è meno rischio di esecuzioni grazie alla moratoria ottenibile , ma va comunque considerato il fattore tempo. – Costo dell’attestazione e procedimento: Bisogna pagare un attestatore e le spese legali per l’omologa. Sono inferiori a quelle di un concordato (niente commissario giudiziale, niente adunanza dei creditori, ecc.), ma non nulle.
Quando è indicato l’accordo di ristrutturazione: – Quando l’azienda ha una struttura di debito concentrata (es. poche banche principali) con cui si può raggiungere un’intesa e magari qualche creditore minore che sarà pagato integralmente comunque. – Quando occorre una blindatura legale che un semplice piano attestato non dà: ad esempio, se servono finanziamenti esterni che vogliono la certezza dell’omologa (in un ARD omologato i nuovi finanziatori possono ottenere lo status di prededuzione e i privilegi ex art. 91 CCII come per il concordato). – Quando è desiderabile la moratoria legale per congelare le azioni (soprattutto se c’è pericolo di aggressioni da creditori isolati prima di riuscire a pagare tutti gli estranei). – Talvolta, un piano attestato evolve in ARD: si inizia come piano volontario ma, avendo già ad esempio l’adesione del 70% dei creditori, si opta per presentarlo in omologa così da includere magari il cram-down fiscale (l’ARD può includere una transazione fiscale, e la normativa recente consente l’omologa anche senza il voto del Fisco se il trattamento è conveniente per esso) .
Esempio: La nostra azienda ha debiti per 1 milione, di cui 700k con 3 banche, 100k con fornitori vari e 200k col fisco. Potrebbe fare un accordo ex art. 57 così: 2 banche (che sommano 60% dei crediti totali) accettano di trasformare i loro affidamenti in un nuovo mutuo decennale, la terza banca (15% crediti) per ora non aderisce ma verrà pagata integralmente entro 120 giorni dall’omologa con un nuovo finanziatore; il Fisco accetta una transazione fiscale (ad esempio pagamento del 50% del dovuto in 5 anni) e i fornitori piccoli vengono pagati cash dal nuovo apporto dei soci. Si raccoglie adesione formale delle 2 banche e dell’Erario (che formalmente aderisce tramite il voto interno alla transazione fiscale). Si deposita il ricorso con attestazione che i non aderenti (la terza banca e quei pochi fornitori) saranno soddisfatti al 100% entro 120 giorni . Il tribunale concede immediatamente lo stop delle azioni esecutive, omologa l’accordo e grazie al cram-down fiscale reso possibile dalla normativa 2020-2023, omologa anche senza l’adesione formale dell’Erario purché questo risulti non pregiudicato . A omologa, la terza banca viene pagata (grazie a una linea ponte fornita dal nuovo investitore in base all’accordo) e l’azienda riparte con soli i debiti ristrutturati verso le prime due banche e un debito fiscale dimezzato e dilazionato.
Si noti come in questo esempio l’accordo di ristrutturazione ha integrato la transazione fiscale: infatti la legge consente di inserire nell’accordo anche il trattamento di tributi e contributi (art. 63 CCII). Nel 2023-2024, la disciplina della transazione fiscale negli accordi si è evoluta: la normativa (art. 63 CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024) prevede che per ottenere l’omologazione forzosa senza adesione del Fisco bisogna offrire a quest’ultimo almeno certe percentuali minime. In origine il D.L. 69/2023 le aveva fissate al 30% o 40% del debito pubblico a seconda dei casi, poi il correttivo 2024 le ha alzate e infine mediate: attualmente servirebbe offrire circa il 37%–44% del debito fiscale complessivo (a seconda che altri creditori privati abbiano un certo peso) per poter ottenere l’omologa anche senza assenso dell’Erario . Nel nostro esempio, offrendo 50% sul Fisco saremmo sopra tali soglie, quindi il tribunale può omologare comunque. Questa possibilità di cram-down è un plus enorme dell’ARD (e del concordato) rispetto al passato: prima, se il Fisco diceva no, l’accordo saltava; oggi il giudice può imporglielo se è equo .
Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale classica per la regolazione della crisi d’impresa. A differenza del piano attestato e dell’accordo, qui si tratta di un vero e proprio procedimento giudiziale, con coinvolgimento collettivo di tutti i creditori. Il debitore formula una proposta di concordato accompagnata da un piano e la sottopone al voto dei creditori; se approvata a maggioranza e omologata dal tribunale, diventa vincolante per tutti, anche per i dissenzienti.
Il concordato preventivo ha diverse finalità possibili: può essere finalizzato alla continuità aziendale (salvare in tutto o in parte l’impresa come attività economica funzionante) oppure alla liquidazione del patrimonio (chiudere l’impresa ma in modo ordinato, distribuendo un attivo ai creditori meglio di quanto farebbe un fallimento). Queste due modalità sono disciplinate diversamente dal Codice: – Il concordato in continuità aziendale (art. 84 co.2 CCII) presuppone che l’azienda resti in attività (gestita dallo stesso debitore o tramite un assuntore che subentra) e che tale prosecuzione produca valore a beneficio dei creditori . Esempio: l’azienda ottiene di ridurre i debiti e continua a operare, pagando i creditori col denaro generato negli esercizi successivi. La continuità può essere diretta (il debitore prosegue) o indiretta (si vende l’azienda a un terzo che garantisce la continuità di almeno parte dei posti di lavoro). – Il concordato con liquidazione del patrimonio (art. 84 co.4 CCII) invece prevede che l’azienda cessi e tutti i beni siano liquidati (venduti) per pagare i creditori, eventualmente con la cessione a un assuntore che prende tutto in blocco. È simile a un fallimento pilotato, ma richiede che vi siano benefici aggiuntivi per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale standard .
Requisiti di ammissibilità: – Soglia dimensionale: possono accedere al concordato gli imprenditori commerciali sopra le soglie di fallibilità (in realtà nel nuovo CCII la distinzione fallibile/non fallibile ha lasciato il posto a procedure diverse: gli “imprenditori minori” usano il concordato minore, mentre chi supera le soglie usa il concordato preventivo ordinario). Dunque, la nostra società di capitali può accedere certamente. – Stato di crisi o insolvenza: serve trovarsi in stato di crisi (difficoltà prospettica) o insolvenza attuale . Questo presupposto è più ampio che in passato (prima occorreva lo stato di insolvenza conclamato per il concordato, ora basta anche la crisi prospettica). – Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale: Il concordato deve assicurare ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile da una liquidazione giudiziale (art. 84 co.1 CCII) . È il cosiddetto test di convenienza: va attestato e valutato dal giudice che la proposta offre almeno tanto quanto un fallimento (altrimenti non c’è ragione di preferirla). – Requisiti speciali per il concordato liquidatorio: Il legislatore, per scoraggiare concordati “liquidatori” troppo penalizzanti, ha introdotto due paletti importanti (art. 84 co.4 CCII): (1) il piano deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi almeno del 10% l’attivo disponibile rispetto a un fallimento, e (2) deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari (e privilegiati degradati) . In pratica, se l’imprenditore vuole liquidare tutto e chiudere, deve “metterci qualcosa di tasca propria” (o trovare un terzo che lo faccia) pari ad almeno il 10% in più di quanto i creditori avrebbero dalla mera liquidazione, e garantire ai chirografari almeno 20 centesimi. Queste soglie sono inderogabili: se non si raggiungono, il concordato liquidatorio è inammissibile. Eccezione: il concordato liquidatorio semplificato post-composizione negoziata (art. 25-sexies CCII) è esente da questi requisiti e non prevede né voto dei creditori né commissario , ma è riservato al caso in cui, al termine di una composizione negoziata andata male, l’imprenditore non abbia alternative e proponga al tribunale la cessione dei propri beni. È una procedura di nicchia, pensata per accelerare la chiusura di crisi irreversibili con minima burocrazia, ma soggetta comunque a controllo rigoroso del tribunale sull’equità della distribuzione .
Procedimento in sintesi: 1. Domanda di concordato: Può essere “con riserva” (concordato in bianco) o completa. Se con riserva, l’azienda deposita un ricorso manifestando l’intenzione di presentare un concordato e chiede un termine (fino a 120 + 60 gg) per presentare piano e proposta. Durante questo periodo beneficia subito delle misure protettive (stay) e nomina di un commissario giudiziale provvisorio. Se domanda completa, invece, insieme al ricorso si deposita l’intero piano, la proposta ai creditori e la documentazione (attestazione di un professionista circa la veridicità dei dati e fattibilità del piano). 2. Fase iniziale – ammissione: Il tribunale valuta se la domanda è ammissibile (presenza dei requisiti minimi). In caso di concordato liquidatorio, verifica ad esempio che sia previsto l’apporto esterno 10% e il 20% minimo ai chirografari: se mancano, rigetta subito . Per il concordato in continuità, valuta che il piano non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali . Se supera queste verifiche, il tribunale ammette il concordato, nomina il giudice delegato e un commissario giudiziale (figura di controllo) , e fissa i termini per il voto dei creditori. 3. Moratoria delle azioni: Dalla data di pubblicazione del ricorso e del decreto, scatta per legge il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di acquisire prelazioni sul patrimonio del debitore (salvo autorizzazioni speciali per crediti prededucibili) – l’azienda è protetta dal fuoco esterno. 4. Gestione durante la procedura: L’impresa di norma rimane in possesso (debtor-in-possession), cioè l’organo amministrativo continua a gestire, ma sotto la supervisione del commissario e con atti straordinari soggetti ad autorizzazione del tribunale. In un concordato in continuità, l’azienda prosegue l’attività sotto monitoraggio; in un liquidatorio, di solito l’attività caratteristica cessa e ci si prepara alla liquidazione dei beni (il tribunale può nominare un liquidatore speciale dopo l’omologa, o anche prima se c’è un’offerta irrevocabile di acquisto). 5. Adunanza e voto dei creditori: I creditori vengono raggruppati in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (es: banca ipotecaria in una classe, fornitori chirografari in un’altra, Fisco in un’altra, dipendenti – se falcidiati – in un’altra, ecc.). Il commissario redige una relazione e convoca i creditori per esprimere il voto (oggi spesso in forma scritta/telematica). Per l’approvazione, serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza per teste non conta più, conta solo il valore ≥ 50%). Se ci sono più classi, occorre maggioranza in tutte o, se alcune boccianti, si può chiedere al tribunale il cram-down interclassi, cioè l’omologa nonostante il dissenso di classi minoritarie, a certe condizioni (una classe votante ha approvato e le dissenzienti non sono pregiudicate rispetto all’alternativa). 6. Omologazione: Se i creditori approvano il concordato, il tribunale tiene udienza di omologazione dove eventualmente i creditori dissenzienti possono proporre opposizioni (ad esempio lamentando il difetto di convenienza). Il tribunale verifica il rispetto di tutte le condizioni e, se non emergono cause ostative, omologa con decreto. Con l’omologa, il concordato diviene vincolante per tutti i creditori anteriori (anche chi ha votato no o chi non ha partecipato).
Effetti del concordato: – I creditori anteriori (ossia i crediti sorti prima dell’ammissione) sono obbligati al trattamento previsto in concordato e perdono il diritto di agire separatamente. Ad esempio, se il concordato prevede che i fornitori chirografari prendano il 40% a saldo, essi devono accontentarsi di quello; non possono pretendere di più né agire per il resto. Il debito pregresso si intende estinto secondo le modalità del concordato. – Eventuali garanti o co-obbligati dei debiti non sono liberati verso i creditori, salvo rinuncia: il concordato vincola solo il debitore e i creditori nei rapporti reciproci, ma un fideiussore del debitore continua ad essere tenuto per intero. (Tuttavia, in pratica, se il debitore va in concordato spesso i garanti vengono escussi durante la procedura; inoltre, se il debitore soddisfa parzialmente il credito in concordato, il garante beneficerà di una corrispondente riduzione per evitare surroghe complicate). – I crediti privilegiati di norma vanno soddisfatti integralmente. È possibile degradarli parzialmente a chirografo se il valore del bene su cui insiste la prelazione è inferiore al credito (la parte in capienza diventa chirografaria) . Ed è anche possibile pagare in misura non integrale un credito privilegiato col consenso del titolare, purché comunque non meno di quanto otterrebbe dalla vendita del bene (principio della soddisfazione non inferiore alla liquidazione). – Nel concordato in continuità, i contratti in corso non si sciolgono (salvo richiesta di scioglimento autorizzata ex art. 94 CCII per contratti particolarmente onerosi). L’attività va avanti, quindi fornitori e clienti contrattuali continuano i rapporti. – Nel concordato liquidatorio, tipicamente i contratti si risolvono o si cedono; l’azienda cessa l’attività salvo quella minima per preservare il valore di realizzo.
Concordato in continuità vs liquidatorio: Vale la pena evidenziare alcune differenze chiave: – Conservazione dei posti di lavoro: Il concordato in continuità punta a salvare occupazione e avviamento. Il CCII specifica che la “vantaggiosità” della continuità si presume se si prevede la salvaguardia di almeno metà dei posti per 2 anni (indicazione che guida la valutazione, introdotta dal correttivo 2022). Nella continuità, i dipendenti generalmente proseguono e i loro crediti vengono pagati per intero, ma possono essere dilazionati fino a 6 mesi post-omologa . – Durata del piano: In continuità può estendersi su più anni (pagamenti dilazionati fino a 5 anni per chirografari, salvo eccezioni) . Nel liquidatorio, la durata coincide con il tempo di liquidare i beni – di solito 1-2 anni. – Nuova finanza: In continuità è comune ottenere finanza interinale o finanza esterna per supportare l’attività. La legge permette al tribunale di autorizzare finanziamenti in prededuzione (o garantiti) per far funzionare l’azienda durante la procedura (DIP financing). Nel liquidatorio, la nuova finanza serve solo a massimizzare i valori in vendita (meno comune perché l’attività cessa). – Percentuale minima ai chirografari: Come detto, 20% obbligatorio nel liquidatorio , invece nessun minimo percentuale nella continuità: potrebbe anche essere offerto 0% se è comunque il valore di recupero migliore rispetto al fallimento. Di fatto però, offrire 0% in continuità è raro, almeno qualcosa viene dato. – Apporto esterno: Non richiesto in continuità (anche se spesso c’è). Nel liquidatorio classico serve almeno +10% sul realizzo fallimentare di provenienza esterna (per incentivare proposte serie). – Omologazione forzata col Fisco: Nel concordato in continuità, fino al 2022 c’era un dubbio interpretativo se fosse possibile omologare il concordato nonostante il voto contrario del Fisco sulla transazione fiscale (poiché l’art. 180 L.F. previgente lo vietava). Questo dubbio è stato risolto dalla modifica dell’art. 88 CCII nel 2023-24: ora è esplicito che il tribunale può omologare il concordato anche senza adesione di Agenzia Entrate e INPS, se il trattamento offerto non è deteriore rispetto alla liquidazione . In pratica, il cram-down fiscale è ammesso sia in continuità sia in liquidatorio nel CCII (prima era certo solo per il concordato liquidatorio, ora lo è anche per la continuità) . Ovviamente devono essere rispettate le condizioni di legge sulle percentuali minime per far scattare l’omologa forzosa (che come visto sono state aggiornate nel 2024 attorno a 37-44% del debito pubblico a seconda dei casi) . L’ultima riforma ha quindi uniformato il potere del giudice di superare il dissenso del Fisco, con due possibili calcoli delle maggioranze (escludendo il Fisco dalle classi o considerando il suo voto come favorevole ai fini del conteggio) . Non entriamo nei tecnicismi, ma il succo per l’imprenditore è: anche se il Fisco vota no, il concordato può essere approvato ugualmente, purché la proposta a Erario/INPS sia equa (non inferiore al valore di liquidazione) .
Conclusione sul concordato: È la procedura più strutturata e garantista, ma anche la più complessa e costosa. Richiede un forte lavoro di preparazione (piano dettagliato, relazione attestatore, inventari, elenco creditori, ecc.), l’intervento di diversi organi (tribunale, commissario, GD) e tempi che spesso si aggirano su 6-12 mesi dall’ammissione all’omologa (salvo concordati semplificati post-negotiation). In compenso, offre al debitore la protezione integrale da azioni esecutive e la possibilità di imporre un sacrificio a tutti i creditori, discaricando parte significativa dei debiti alla fine. Per i creditori, d’altro canto, il concordato è accettabile solo se prendono almeno quanto avrebbero in un fallimento – principio cardine e inderogabile.
La decisione di ricorrere al concordato va ponderata: spesso è l’ultima risorsa, quando: – Le misure minori (piani attestati, accordi) sono fallite o impraticabili. – L’azienda rischia il fallimento e ha bisogno di un blocco immediato delle azioni (depositare un concordato, anche in bianco, ottiene subito la protezione). – Ci sono tanti creditori con interessi divergenti, per cui solo la votazione a maggioranza può portare a una soluzione. – Si vuole sfruttare istituti propri del concordato: es. ramo d’azienda da trasferire ad un investitore liberandolo dai debiti (nel concordato si può vendere un ramo “pulito” dai debiti, trasferendo passività nel concordato), oppure risolvere contratti sfavorevoli (il debitore in concordato può chiedere lo scioglimento di contratti onerosi per alleggerirsi).
Una volta omologato e adempiuto il concordato, l’azienda ne esce “risanata” giuridicamente: i debiti anteriori restano definiti come da piano (eventuali debiti residui falcidiati sono estinti). Se però l’azienda non adempie agli obblighi concordatari, il concordato può essere risolto e i creditori tornano liberi di agire (salvo che nel frattempo l’insolvenza non porti al fallimento). Dopo l’omologa, l’azienda è comunque soggetta per un certo periodo alla vigilanza di un liquidatore o commissario (nel liquidatorio c’è un liquidatore che fa le vendite e distribuzioni; in continuità spesso lo stesso debitore esegue il piano sotto controllo di un commissario fino a esecuzione completata). Con il completamento del piano, l’impresa può proseguire la sua vita, auspicabilmente con successo e senza l’onere insostenibile dei vecchi debiti.
Transazione fiscale e contributiva (art. 63 e 88 CCII)
Un capitolo particolare, già più volte citato, è la transazione fiscale. Si tratta di uno strumento accessorio che può innestarsi nelle procedure di accordo di ristrutturazione o concordato, permettendo il trattamento dei debiti tributari e previdenziali con modalità agevolate. Storicamente, il Fisco era il creditore più inflessibile: fino a qualche anno fa non era consentito falcidiare l’IVA o le ritenute (considerate risorse “protette”), e spesso i concordati fallivano per il veto dell’Erario. La situazione è cambiata: – L’istituto nasce nel 2006 (art. 182-ter l. fall.) e inizialmente escludeva espressamente lo stralcio dell’IVA (si poteva solo dilazionare) . – Dal 2008 al 2010 alcune norme avevano confermato il divieto di falcidia su IVA e ritenute . – Nel 2017 è stata aperta la transazione anche ai debiti previdenziali (INPS) . – La svolta è con la legge di conversione del DL 137/2020 (“Decreto Ristori”), che ha ammesso la falcidia del capitale delle imposte, IVA inclusa, purché un attestatore certifichi che la proposta concordataria è conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione . Inoltre ha previsto la possibilità di omologa anche senza adesione del Fisco (il cram-down fiscale appunto) alle condizioni già spiegate: il giudice può approvare se ritiene che l’Erario non prenderebbe di più dalla liquidazione . – Queste innovazioni sono state recepite nel CCII, agli artt. 63 (per gli accordi) e 88 (per il concordato). Nel tempo, i correttivi hanno calibrato i dettagli: ad esempio la Legge 103/2023 ha introdotto soglie minime di soddisfo per imporre la transazione (come visto, poi modificate dal D.Lgs. 136/2024 a 50% e 60% dei tributi esclusi interessi, rideterminate in 37% e 44% del totale debito pubblico) . L’art. 88 CCII, modificato dal correttivo 2024, ora recita chiaramente che in ogni caso il tribunale omologa il concordato (sia in continuità sia liquidatorio) anche senza il voto del Fisco se questi non è trattato peggio che nel fallimento . Similmente l’art. 112 CCII (sulle maggioranze) consente di escludere le classi pubbliche dal computo o di calcolare la maggioranza contando come favorevole il loro voto mancante, pur di non far fallire concordati validi .
Cosa comporta la transazione fiscale? In un piano di concordato o accordo, l’imprenditore può proporre: – Stralcio (riduzione) di imposte e contributi, anche sul capitale (es: pagamento del 50% dell’IVA, abbuono del restante 50%). Le sanzioni tributarie generalmente vengono annullate al 100% nei concordati, considerato che sono crediti chirografari postergati (il CCII lo consente espressamente). – Dilazione del pagamento su più anni (es: pagamento in 5 anni rate semestrali). – Eventualmente, mix di stralcio e dilazione.
La proposta va dettagliata e accompagnata da relazione dell’attestatore che certifichi la convenienza: cioè, confronti quanto il Fisco prenderebbe con la proposta rispetto a quanto prenderebbe in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) . Se nel concordato liquidatorio puro il Fisco avrebbe preso, poniamo, 20% sul suo credito, e la proposta è pagargli il 30%, l’attestatore darà atto che conviene. Nel concordato in continuità si valuta anche l’apporto di risorse dalla prosecuzione, ma il principio è lo stesso.
Adesione dell’Erario/Enti: L’Agenzia delle Entrate e l’INPS partecipano al voto in classe separata di solito. Esprimono il proprio assenso o dissenso secondo le regole interne: per l’Agenzia Entrate esisteva una circolare (16/E 2018) che prevedeva criteri per accettare o meno le proposte (ad esempio, se il piano pagava almeno il 10% e non c’erano profili di frode, etc.). Oggi, con la normativa del 2020-2024, l’Agenzia ha in parte l’obbligo di accettare (o meglio, il suo rifiuto può essere superato) se sono rispettate certe condizioni minime. Rimane però la formalità che l’Agenzia dovrebbe rispondere entro 90 giorni alla proposta di transazione (silenzio=diniego implicito, ma irrilevante poi se il giudice può superarlo). In pratica, attualmente la mancata adesione dell’ente pubblico non blocca più la procedura se la proposta è equa . Esempio concreto: nel 2024 il Tribunale di Piacenza ha omologato un concordato in continuità nonostante il voto contrario dell’INPS, ritenendo soddisfatta la condizione della non deteriore soddisfazione; tale pronuncia del 26/11/2024 ha evidenziato che dopo l’omologa l’importo concordatariamente dovuto al Fisco è cristallizzato e il residuo stralciato è inesigibile .
Effetti di una transazione fiscale omologata: – I debiti fiscali e contributivi inclusi nella transazione si considerano definitivamente estinti nell’importo concordato . Il residuo stralciato non potrà più essere preteso dall’Erario (diventa inesigibile per legge). L’atto di omologa funziona come “quittanza giudiziale” per la parte condonata. – Eventuali ipoteche o pegni iscritti dallo Stato rimangono a garanzia del pagamento nei limiti del piano; se il piano li soddisfa parzialmente, occorrerà poi liberare tali garanzie sui beni una volta pagata la quota pattuita (in pratica, l’ipoteca potrebbe essere ridotta proporzionalmente). – I contenziosi tributari pendenti relativi ai debiti transatti vengono meno secondo la giurisprudenza: la Cassazione ha affermato in più occasioni che l’adesione dell’ente pubblico alla transazione fiscale fa cessare la materia del contendere nei processi tributari in corso su quegli atti impositivi . Occorre fare attenzione: se c’è un ricorso tributario su un annullamento parziale, bisognerà verificare se la transazione lo copre integralmente. In genere, nel piano di concordato si inserisce una clausola che prevede la rinuncia ai ricorsi tributari pendenti su imposte incluse nella transazione (e viceversa l’Agenzia rinuncia alle liti). – Fino all’omologa, se con la domanda di concordato sono state chieste misure protettive, anche le azioni esecutive per debiti erariali sono sospese. Il CCII (art. 54 e 55) prevede che lo stay valga per tutti i creditori, pubblici compresi . Dunque, ad esempio, un pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia Entrate Riscossione deve fermarsi. – Importante: la transazione fiscale non è obbligatoria. Il debitore può anche presentare un concordato senza chiederla, decidendo di pagare integralmente il Fisco (magari dilazionando solo). La legge attuale però spinge ad usarla come strumento di regolazione, tant’è che l’art. 88 CCII afferma che nel piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati da AE e dei contributi . Non c’è più quell’antico timore che “se non offri 100% al Fisco, il piano è inammissibile”: oggi è normale offrire percentuali minori e la legge lo consente espressamente (salvo imposte locali, quelle vanno trattate a parte). – Se il debitore non rispetta la transazione (es. non paga le rate concordate), l’omologa del concordato rimane valida ma l’Erario potrà agire per riscuotere la parte dovuta secondo il piano. Se anche il concordato dovesse essere risolto, il Fisco riacquista il diritto sull’intero originario al netto di quanto eventualmente incassato (come tutti i creditori del resto).
In definitiva, la transazione fiscale è diventata uno snodo cruciale nelle strategie di ristrutturazione in Italia . Un buon piano di risanamento di un’azienda indebitata con il Fisco deve quasi sempre prevedere una transazione fiscale: raramente l’impresa in crisi riesce a pagare tutto l’arretrato fiscale (che spesso porta sanzioni e interessi pesanti) – ed economicamente non avrebbe senso che i creditori privati accettino sacrifici se il Fisco prendesse il 100%. La legge ha compreso ciò e oggi mette sullo stesso piano creditori pubblici e privati per certi versi, permettendo di coinvolgere il Fisco nel haircut generale.
Va ricordato però che l’Erario resta un creditore “istituzionale”: qualsiasi trattamento deteriore (ad esempio offrire al Fisco il 5% quando i chirografari privati prendono il 50%) sarebbe probabilmente considerato un abuso e porterebbe il tribunale a negare l’omologa per mancanza di convenienza o per violazione della buona fede. Anche se formalmente si possono discriminare i creditori in classi, il CCII richiede che il trattamento delle classi sia giustificato da ragioni meritorie. Dunque in pratica al Fisco si cerca di offrire pro quota quello che viene offerto agli altri creditori chirografari, salvo differenze motivate (es. i crediti erariali potrebbero essere pagati un po’ meno perché altrimenti non c’è fattibilità, ma entro limiti accettati).
Esempio: la nostra azienda deve €200.000 tra IVA e ritenute. Se fallisse, si stima che l’Erario otterrebbe forse 20% (perché privilegi dopo i lavoratori e beni insufficienti). Nel concordato in continuità proponiamo di pagarne €60.000 (30%) in 5 anni. L’attestatore certifica che 30% è meglio di 20% ; l’Agenzia Entrate potrebbe anche esprimere diniego, ma il tribunale può comunque omologare perché la convenienza è dimostrata e le maggioranze di legge sono raggiunte . Dopo l’omologa, l’azienda pagherà le rate concordate e il residuo €140.000 sarà annullato. L’Agenzia non potrà più pretendere quel residuo (nemmeno eventualmente in via sussidiaria sugli amministratori, a meno di provare reati di frode fiscale antecedenti, il che è altra storia). I procedimenti esecutivi per quelle somme cesseranno. E l’azienda potrà ripartire pulita anche sul fronte tributario, se adempie il piano.
Strumenti per PMI “minori” e sovraindebitamento
Prima di concludere la rassegna degli strumenti, una breve parentesi su quelle procedure destinate a soggetti che, per dimensione o natura, esulano dal concordato preventivo ordinario. Nel nostro caso parliamo di una società di capitali (azienda di termosaldatrici), quindi soggetta alle procedure sopra trattate. Ma se avessimo un imprenditore individuale di piccole dimensioni (sotto soglie di fallibilità) o un socio illimitatamente responsabile o un privato che ha garantito i debiti, entrano in gioco le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (la cosiddetta *legge “salva suicidi” 3/2012, ora assorbita nel CCII agli artt. 65-83 e 268-277 per il “concordato minore” e strumenti affini).
In particolare: – Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è una versione semplificata del concordato preventivo per debitori non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori con debiti d’impresa). Richiede soglie di debito contenute e procedure snelle (ad esempio, non c’è una votazione delle classi, il tribunale decide sentiti i creditori). L’idea è permettere anche al piccolo imprenditore sovraindebitato di proporre un piano ai creditori con falcidie, simile al concordato, ed uscire dall’insolvenza. – L’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (prima piano del consumatore, ora chiamato piano di ristrutturazione soggetto sovraindebitato, art. 67 CCII) consente a persone fisiche non imprenditori di ridurre i propri debiti con l’omologa del tribunale, senza necessità di voto dei creditori (utilissimo ad esempio per ex imprenditori che hanno garantito prestiti bancari e si trovano personalmente insolventi). – La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è l’equivalente del fallimento per le persone fisiche sovraindebitate o piccole imprese sotto soglia: consente la liquidazione del patrimonio e, una volta chiusa, l’esdebitazione totale dai debiti residui (il cosiddetto fresh start). Per una società di capitali la questione non si pone (la società si estingue e non c’è “esdebitazione” perché non esiste più); ma per un imprenditore individuale o un ex socio, questa procedura consente di cancellare i debiti non pagati nella liquidazione, purché abbia cooperato lealmente.
Perché è rilevante citarlo? Perché spesso nelle crisi d’impresa il confine tra azienda e persona si assottiglia: ad esempio, i soci garanti di una S.r.l. possono trovarsi essi stessi sommersi dai debiti dopo la crisi dell’azienda (dovendo onorare fideiussioni verso le banche, etc.). Ebbene, questi soci-persone fisiche, una volta definita la posizione aziendale (magari con un concordato che paga solo in parte le banche, lasciando i garanti esposti per il resto), possono a loro volta ricorrere ai procedimenti da sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione personale. Addirittura, dal 2021 esiste una forma di esdebitazione “senza utilità” per il debitore meritevole che non ha nulla da offrire (art. 283 CCII): in casi estremi, il privato nullatenente può chiedere la cancellazione dei suoi debiti residui immediatamente, per ripartire da zero. Questo però esula dal nostro scenario, dove ci concentriamo sull’azienda. Era giusto segnalare che l’ordinamento prevede soluzioni a 360°, includendo la liberazione del debitore onesto che abbia comunque fallito.
Responsabilità degli amministratori e profili penali nella crisi d’impresa
Dal punto di vista del debitore imprenditore, gestire la crisi non significa solo occuparsi dei rapporti coi creditori: significa anche proteggersi da eventuali responsabilità personali che possono sorgere per come si è condotta l’azienda durante la difficoltà. In una società di capitali, vige il principio della separazione patrimoniale: i debiti sociali si pagano col patrimonio sociale (art. 2740 c.c.), e i soci non rischiano oltre il capitale conferito. Tuttavia, gli amministratori di una società (siano essi soci o manager esterni) possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio se violano i doveri verso la società, i creditori o l’erario. Inoltre, certe condotte durante la crisi possono integrare reati penali (come visto per la sfera tributaria o fallimentare). Vediamo quindi quali sono i profili di responsabilità più rilevanti:
Doveri degli amministratori in caso di crisi
Gli amministratori di società hanno, per legge, l’obbligo generale di agire con diligenza e prudenza nella gestione, nell’interesse sociale (artt. 2392 c.c. per S.p.A., estensibile a S.r.l.). Dal 2019, con la riforma della crisi d’impresa, il legislatore ha enfatizzato il dovere di prevenzione della crisi. In particolare l’art. 2086 c.c. comma 2 (introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi) recita che l’imprenditore collettivo deve istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e la perdita della continuità, nonché di attivarsi prontamente per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi e recupero della continuità . Questa norma – apparentemente generica – in realtà crea uno standard di comportamento ben preciso: – L’azienda deve dotarsi di sistemi di controllo di gestione, flussi informativi e indicatori tali da far emergere subito eventuali squilibri. – Se tali indicatori segnalano una crisi incipiente (es: indici di liquidità sotto soglia, perdite rilevanti), gli amministratori devono attivarsi senza indugio: convocare l’assemblea se necessario (in caso di perdita del capitale oltre 1/3 o di capitale sotto il minimo legale, artt. 2482-bis e ter c.c.), e valutare l’accesso a misure di composizione negoziata, piani o concordati.
In altri termini, è finita l’era dell’imprenditore che “nasconde la polvere sotto il tappeto” finché può. Oggi, se non attua assetti adeguati e non affronta la crisi per tempo, l’amministratore può essere dichiarato inadempiente ai propri doveri. Ad esempio, se la società va in default e si scopre che già da due anni c’erano segnali chiari di crisi ignorati, ciò potrà costituire colpa grave degli amministratori. La giurisprudenza recente e la legge (art. 378 CCII) hanno creato meccanismi per sanzionare l’inerzia colpevole: – L’art. 2486 c.c., come modificato nel 2019, stabilisce che quando gli amministratori proseguono l’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (come il perdite oltre il capitale), essi rispondono dei danni causati e il danno si presume pari al peggioramento del patrimonio netto tra il momento in cui avrebbero dovuto cessare e la data di liquidazione concorsuale . In pratica, c’è una presunzione per legge: se i fondi propri erano -100 e diventano -300, quella differenza 200 è il danno imputabile agli amministratori che hanno tardato a prendere provvedimenti (salvo prova contraria) . E se le scritture mancano o sono inattendibili, il danno è presumibilmente l’intero deficit attivo/passivo . Questa norma è potentissima, perché facilita le azioni di responsabilità: il curatore fallimentare può citare gli amministratori e dire “hanno violato l’obbligo di conservazione del patrimonio continuando l’attività oltre il dovuto, quindi devono almeno 200 (il peggioramento)” . Saranno gli amministratori a dover provare che magari quel peggioramento non è colpa loro (onere difficile). – La Cassazione, con varie sentenze, ha affermato in modo netto che l’amministratore di S.r.l. che compie nuove operazioni dopo la causa di scioglimento (perdita totale capitale) risponde verso i creditori sociali dei danni arrecati. In particolare la recente Cass. 6893/2023 ha statuito che in caso di scioglimento di una S.r.l. per perdita integrale del capitale, l’amministratore risponde verso i creditori ex art. 2486 c.c. per gli atti di gestione non conservativi compiuti successivamente . E ha chiarito che: – I creditori, per ottenere il risarcimento, non devono provare il dolo o la colpa dell’amministratore: basta che l’amministratore fosse consapevole della causa di scioglimento e che abbia compiuto atti non finalizzati alla conservazione del patrimonio . La colpa si presume perché l’obbligo di gestione conservativa è oggettivo. – Spetta invece all’amministratore convenuto provare che gli atti compiuti dopo la perdita capitale erano necessari ai fini liquidatori o conservativi del patrimonio . In pratica, c’è un’inversione dell’onere della prova: il creditore deve solo dire “eri in scioglimento e hai continuato, hai fatto operazioni X e Y che non hanno conservato il patrimonio (magari un nuovo contratto che ha aggravato i debiti)”, e l’amministratore per scagionarsi deve dimostrare che quelle operazioni in realtà erano svolte nell’interesse dei creditori (es. vendere scorte per pagare debiti). Questa pronuncia conferma un orientamento rigoroso: l’amministratore non può permettersi inerzia o azzardi dopo che l’impresa è andata in rosso oltre il capitale. Deve o mettere in liquidazione la società o attivare un rimedio (piano, concordato) immediatamente. Se tira avanti “come nulla fosse” e intanto brucia cassa o fa preferenze, ne risponderà personalmente verso i creditori .
- Anche i sindaci e i revisori possono rispondere se non segnalano per tempo la crisi (posizione di garanzia nel vigilare sugli adeguati assetti). Non è raro che nelle azioni di responsabilità il curatore citi in solido amministratori e organo di controllo.
- Qualora vi siano state operazioni dolose che hanno danneggiato i creditori (es. spostare asset a un’altra società sottraendoli alle garanzie dei creditori), i creditori possono promuovere un’azione risarcitoria individuale ex art. 2395 c.c. (per S.p.A.) o 2476 c.c. co. 6 (per S.r.l.). Di solito però tali azioni le esercita il curatore per conto di tutti (evitando iniziative singole).
In sintesi, dovere principale: quando l’azienda è in crisi, l’amministratore deve massimizzare la tutela del patrimonio a beneficio dei creditori: si parla di dovere di gestione conservativa. Da quel momento in poi, ogni decisione sarà sindacabile in base a se ha preservato o peggiorato la situazione dei creditori: – Continuare a comprare materia prima e produrre invenduto peggiorando i debiti = violazione, se non c’era ragionevole prospettiva di risanamento. – Pagare un solo fornitore “amico” lasciando altri a bocca asciutta = violazione (preferenza). – Non attivarsi per fare un piano o un concordato = potenziale violazione, perché l’ordinamento offriva strumenti e non li hai usati, lasciando il dissesto incancrenirsi.
Al contrario, attivare in tempo un concordato o un piano attestato può mettere l’amministratore al riparo: es. l’art. 324 CCII che esenta dalla bancarotta semplice chi ha tardato la dichiarazione di fallimento per tentare un piano è un’ancora di salvezza. Significa: se tu amministratore ci provi, in buona fede, a sistemare l’azienda con gli strumenti di legge, non sarai punito (né civilmente né penalmente in genere) se poi va male. Ma se stai fermo o fai di testa tua al di fuori delle regole, le conseguenze ricadranno su di te.
Azione di responsabilità verso gli amministratori
Chi può agire contro gli amministratori? In caso di fallimento (liquidazione giudiziale), la curatela fallimentare è legittimata a promuovere l’azione sociale di responsabilità (per danni alla società) e l’azione verso gli amministratori per danno ai creditori (ex art. 2394 c.c. per S.p.A., principio applicato analogicamente alle S.r.l.). Spesso le due azioni sono esercitate congiuntamente dal curatore. Il risarcimento ottenuto entra nella massa e va ai creditori.
Se invece non c’è fallimento (ad es. l’azienda va in concordato o in liquidazione non giudiziale), i creditori potrebbero agire individualmente ex art. 2394 c.c. in caso di insufficienza del patrimonio sociale (quando il capitale sociale risulta incapiente per soddisfarli). La Cassazione aveva in passato discusso se i creditori sociali avessero azione diretta in costanza di concordato, ma in generale è ammissibile se il concordato non paga integralmente i creditori privilegiati o comunque c’è un’insufficienza patrimoniale dovuta a condotte degli amministratori anteriori. Tuttavia, va provato il nesso causale tra l’illecito dell’amministratore e l’insufficienza patrimoniale: tipicamente, è necessario dimostrare un atto di mala gestio specifico (distrazione di beni, operazione imprudente, violazione di legge) che ha aggravato il passivo o diminuito l’attivo.
L’azione sociale (ex art. 2476 c.c. per S.r.l.) può essere esercitata dalla società stessa o dai soci della nuova gestione se l’azienda si risana. Nel nostro contesto, meno rilevante perché la guida è dal lato debitore. Dal lato debitore amministratore, va detto: se la società fallisce, quasi sicuramente il curatore valuterà se ci sono estremi per far causa agli ex amministratori. Pertanto, un amministratore accorto, oltre a cercare di salvare la società, documenterà anche di averlo fatto diligentemente, per difendersi poi in questi giudizi.
La giurisprudenza degli ultimi anni offre strumenti anche in favore dei creditori particolari: per esempio, Cass. 8898/2021 ha ammesso che un singolo creditore possa agire contro l’amministratore di S.r.l. che ha pagato preferenzialmente altri creditori quando la società era già insolvente, configurando ciò come atto illecito ai suoi danni, distinto dall’azione generale. Però si tratta di ipotesi complesse e non di routine.
In definitiva, per un amministratore la miglior difesa è: 1. Avere assetti adeguati: se può dimostrare di aver predisposto sistemi di allerta interna e di aver reagito subito ai segnali (ad esempio convocando assemblea per ricapitalizzare, o presentando tempestivamente domanda di concordato), ridurrà molto la sua esposizione a colpa. 2. Agire in trasparenza e buona fede: niente prelievi ingiustificati, niente patrimoni occultati. Coinvolgere subito i professionisti (commercialisti, legali) per affrontare la crisi in modo ordinato. Questo, oltre a essere la cosa giusta per cercare di salvare l’azienda, fornisce anche prova documentale del suo comportamento diligente. 3. Documentare la continuità aziendale ragionevole: se decide di proseguire l’attività durante la crisi, deve poter mostrare che c’era un ragionevole piano di rilancio (es. attesa di un grosso pagamento, oppure ordinativi nuovi all’orizzonte) che giustificava il tentativo. Se invece prosegue alla cieca, appare come “testardo” e sarà responsabile di aver aggravato il dissesto.
Come citato, l’art. 2486 c.c. prevede criteri presuntivi per quantificare il danno . La Cassazione a Sezioni Unite n. 9100/2015 aveva già delineato il criterio del “netto patrimoniale differenziale” poi fatto proprio dalla legge. Oggi quei principi sono nero su bianco: quando c’è responsabilità ex 2486, salvo prova contraria, il danno è la differenza tra patrimonio netto a inizio e fine periodo abusivo . Cass. 6893/2023, richiamata sopra, conferma pure che questa responsabilità non è qualificabile come torto generico ex art. 2043 c.c., ma come responsabilità speciale verso i creditori disciplinata dall’art. 2486 c.c., e non richiede prova del dolo o colpa se non la consapevolezza dello stato di scioglimento . In altre parole: agli amministratori è richiesto di diventare creditori-centrici quando la società è in decozione – non più azionisti-centrici.
Profili penali-tributari e fallimentari
Abbiamo accennato in precedenza ai principali reati che possono rilevare in situazioni di debiti non pagati. Riepiloghiamoli sistematicamente dal punto di vista dell’impresa debitrice e dei suoi organi.
Reati tributari da omesso versamento: previsti dal D.Lgs. 74/2000. I tre casi più comuni: – Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis): non versare entro il termine previsto (di solito 16 del mese successivo o 30 giugno dell’anno successivo per il saldo) le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni, per un ammontare > €150.000 annui, è reato punito con reclusione fino a 2 anni . Sotto €150.000 è illecito amministrativo (sanzione del 20-30%). Quindi un’azienda che trattiene le ritenute IRPEF dei dipendenti e non le versa, rischia grosso se la somma supera tale soglia. Difesa: Pagare prima che il PM chieda il rinvio a giudizio estingue il reato . Rateizzare con Agenzia Entrate pure evita la punibilità (finché non decade) . – Omesso versamento IVA (art. 10-ter): non versare l’IVA annuale dovuta (come da dichiarazione) oltre €250.000 è reato (6 mesi – 2 anni di reclusione) . La soglia prima del 2015 era €50.000, poi alzata. Come visto, la consumazione ora avviene se al 31 dicembre dell’anno successivo la dichiarazione l’IVA non è stata pagata . C’è quindi un “anno di tempo” di fatto per regolarizzare. Anche qui, se si paga prima del dibattimento, niente pena . Importante: la presenza di un concordato non estingue automaticamente il reato, se l’IVA condonata in concordato eccede la soglia penalmente rilevante; però il D.Lgs. 74/2000 art. 13 prevede la non punibilità in caso di integrale pagamento anche tramite procedure conciliative, e la giurisprudenza ha discusso se il concordato con pagamento parziale equivalga a causa estintiva. Nel dubbio, conviene comunque ottenere il più possibile il pagamento dell’IVA sopra soglia (magari prededucibile) per non incorrere nel penale. – Omesso versamento di contributi previdenziali (art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983): il datore di lavoro che non versa i contributi INPS trattenuti al lavoratore, per un importo > €10.000 annui, commette reato punibile con reclusione fino a 3 anni e multa fino a €1.032 . Sotto €10.000, solo sanzione amministrativa. Termine di consumazione: in teoria, immediatamente alla scadenza di legge (16 del mese successivo, ma c’è possibilità di ravvedimento entro 3 mesi per evitare la procedibilità). Anche per questo reato, il pagamento integrare dei contributi prima del giudizio estingue la pena (art. 13-bis D.Lgs 74/2000 estende la causa di non punibilità anche qui per analogia – normative successive lo hanno previsto). Nota: questo reato punisce solo la parte di contributi che il datore ha trattenuto al dipendente e non versato; la giurisprudenza ha infatti distinto la quota a carico datore (non penalmente rilevante se non versata, ma sanzionata amministrativamente con maxi-sanzione) e la quota a carico lavoratore (penale). Comunque, tipicamente chi non versa una, non versa neanche l’altra.
Gli amministratori e legali rappresentanti sono i soggetti attivi di questi reati. Se cambiano amministratore, rimane responsabile chi era in carica alla scadenza del versamento fiscale.
Reati fallimentari (bancarotta): scattano se viene dichiarata la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Il concordato preventivo invece non comporta procedimenti penali per bancarotta, perché non è dichiarazione di fallimento. Quindi, se un’azienda riesce a evitare il fallimento tramite un concordato, gli amministratori non saranno incriminati per bancarotta in relazione a quella crisi. Diversamente, se fallisce, si apre la procedura penale per verificare se ci sono state condotte di bancarotta fraudolenta o semplice.
Principali fattispecie: – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: se prima del fallimento l’amministratore ha distratto, occultato, dissipato beni sociali, o li ha sottratti fraudolentemente ai creditori (ad esempio vendendoli sottoprezzo a compiacenti, o creando crediti fittizi), è reato gravissimo, punito con reclusione 3-10 anni (artt. 322-323 CCII, ex art. 216 l.f.). Esempio: portare la cassa in nero all’estero e far sparire i soldi = bancarotta fraudolenta. Idem pagare sistematicamente solo se stessi o parti correlate a scapito degli altri. – Bancarotta fraudolenta documentale: l’amministratore che occulta o falsifica le scritture contabili, o le tiene in modo da non capire niente, per procurare a sé o altri un vantaggio o recare pregiudizio ai creditori, è punito come sopra. Quindi la contabilità “sparita” al fallimento è indice di bancarotta fraudolenta. Tenere le scritture caotiche è un forte rischio (se c’è dolo, è fraudolenta; se è per negligenza, può ricadere nella bancarotta semplice documentale con pena minore). – Bancarotta preferenziale: punisce l’imprenditore fallito che, in stato di insolvenza, paga o colloca garanzie a favore di qualche creditore a detrimento di altri. In pratica è il reato di aver fatto preferenze. Pena: reclusione 1-5 anni (art. 322 co.3 CCII). Attenzione: l’art. 324 CCII esonera da bancarotta preferenziale i pagamenti e garanzie compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento omologato . Quindi, se paghi Tizio al 100% e Caio zero, è bancarotta preferenziale in fallimento; ma se lo hai fatto perché rientrava nel piano attestato attestato e ragionevole, non è punibile . Nei concordati invece non c’è bancarotta preferenziale perché non c’è fallimento (e comunque i pagamenti nel concordato sono autorizzati dal giudice). – Bancarotta semplice: punisce condotte meno gravi ma imprudenti, ad esempio aver aggravato il dissesto con spese personali eccessive, o non aver tenuto i libri (art. 323 CCII, ex art. 217 l.f., pena fino a 2 anni). Anche qui, l’art. 324 CCII esenta dalla bancarotta semplice l’imprenditore che ha aggravato il dissesto ma in esecuzione di un piano attestato – classico caso: ha ritardato il fallimento tentando di salvarsi, non sarà punito per il ritardo. Ma se ha tardato senza far nulla, lo sarà. – Altri reati: ce ne sono vari (pagamento di dividendi fittizi, infedeltà patrimoniale, omessa dichiarazione fiscale – art. 5 D.Lgs 74/2000 se non presenta proprio la dichiarazione sopra €50k imposta evasa – etc.). Nel contesto del debito, vale la pena menzionare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): se durante la riscossione coattiva o in vista di essa, il debitore aliena o simula la cessione di beni per evitare il pagamento di imposte, è reato penale. Soglia di punibilità: deve trattarsi di un debito > €50.000 e la condotta volta a frustrarne il recupero. Esempio: l’amministratore sapendo di avere cartelle esattoriali, vende un immobile di proprietà della società a un prezzo irrisorio a un amico per renderlo inattaccabile dal Fisco: è reato (anche se la società non fallisce). Oppure sposta la sede all’estero fittiziamente per non farsi pignorare – reato. Questo spesso colpisce gli amministratori che “svuotano” l’azienda trasferendo i beni ad altra società per non farli pignorare dal Fisco o creditori: configurazione tipica di bancarotta fraudolenta se c’è fallimento, ma se la società non fallisce e resta solo il Fisco danneggiato, può rientrare nell’art. 11 come sottrazione fraudolenta.
Procedura penale: Va sottolineato che se l’impresa evita il fallimento (es. fa concordato), tutti i reati di bancarotta sono evitati, mentre rimangono quelli tributari (che prescindono dal fallimento). Viceversa, se fallisce, l’amministratore può subire diverse incriminazioni in parallelo: tipicamente il curatore segnala eventuali fatti di reato al PM e viene aperto un fascicolo. Non è raro che un imprenditore fallito si veda imputato per bancarotta fraudolenta (per distrazioni o preferenze) e contestualmente per i reati fiscali (omessi versamenti). Le pene possono cumularsi.
Molti amministratori credono erroneamente di essere al sicuro finché la società è di capitali: “è la società che deve, io non c’entro”. Questo è vero civilmente per il pagamento dei debiti (salvo eccezioni di responsabilità personale come visto), ma non è affatto vero penalmente: la responsabilità penale è personale. Se tu in qualità di legale rappresentante non versi l’IVA o distrai i beni, non importa che fosse “colpa della società”, la sanzione colpisce te. Perciò, la gestione criminale della crisi (tentare di salvarsi con stratagemmi illeciti) porta quasi sempre a peggiorare la posizione dell’imprenditore, non a salvarlo.
Linee guida per non incorrere in reati: – Evitare manovre occulte: qualsiasi atto che sembri volto a frodare i creditori può avere rilevanza penale, meglio agire alla luce del sole nelle procedure. – Se non si riesce a pagare le imposte, comunicare con Fisco/INPS: chiedere rate, non omettere dichiarazioni (l’omessa dichiarazione fiscale > €50k imposte evase è reato art. 5 D.Lgs 74/2000). Dichiarare onestamente e poi semmai non pagare (è un reato minore rispetto a dichiarare falso). – Non falsificare i bilanci nel tentativo di coprire la crisi: potrebbe sembrare di sistemare l’immagine dell’azienda per ottenere credito in più (anche reato di false comunicazioni sociali), ma poi peggiora il dissesto e aggiunge profili penali. Meglio presentare la realtà e negoziare crediti onestamente. – Attingere al patrimonio personale: in certe situazioni, l’amministratore disperato potrebbe usare i soldi aziendali per pagare debiti personali, o viceversa. Entrambe le cose possono creare problemi: la prima è appropriazione indebita e bancarotta, la seconda può configurare indebita sottoscrizione o postergazione non rispettata. In generale, mantenere separate le casse e se si attinge per necessità, farlo con trasparenza (ad esempio facendolo deliberare dai soci come prestito). – Tenere i libri contabili aggiornati fino all’ultimo giorno e consegnarli in ordine al curatore se si va a fallimento. La cooperazione col curatore post-fallimento può attenuare il giudizio su eventuali condotte borderline, mentre sparire lasciando caos è il modo per assicurarsi un’imputazione certa.
A margine, va detto che dal 2015 esiste nel nostro ordinamento la figura dell’esdebitazione post-fallimentare per l’imprenditore persona fisica (non per le società, che cessano). Se l’imprenditore persona fisica fallito collabora e non ha commesso atti di frode, dopo la chiusura del fallimento può chiedere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. Ciò ha riflessi sui reati di bancarotta semplice: se hai i requisiti di esdebitazione, spesso significa che non ti hanno condannato per bancarotta fraudolenta, etc. Comunque, quell’istituto serve a dare una seconda chance all’imprenditore onesto ma sfortunato, liberandolo dai debiti residui una volta liquidato tutto. Questo concetto di fresh start è molto caro alla legislazione recente: incoraggia l’imprenditore a non intraprendere azioni disperate/illegali, garantendogli che se fa le cose per bene potrà ripartire senza essere schiavo a vita dei debiti.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande e risposte pratiche che ricapitolano, sotto forma di quesiti puntuali, i dubbi più comuni di imprenditori e amministratori alle prese con un’azienda indebitata. Le risposte richiamano i concetti esposti nella guida, applicandoli a casi concreti tipici.
D: La mia azienda ha debiti ingenti e poca liquidità: mi conviene portare subito i libri in tribunale (dichiarare fallimento) o tentare qualche soluzione?
R: Dichiarare fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dev’essere l’ultima ratio, quando ogni altra soluzione è impraticabile. Se l’azienda ha ancora prospettive di risanamento (ad es. ordini in corso, asset valorizzabili, soci disposti a investire), conviene attivarsi subito per una procedura di ristrutturazione del debito: ad esempio un piano attestato, una composizione negoziata o un concordato preventivo in continuità. Il fallimento è un procedimento liquidatorio che porta alla cessazione dell’attività, mentre strumenti come il concordato mirano a evitare questo esito preservando l’azienda come going concern. Inoltre, finché si persegue una soluzione concordataria, gli amministratori restano in carica e possono tentare di salvare l’impresa; col fallimento, la gestione passa al curatore e l’imprenditore perde il controllo. Naturalmente, se la situazione è irreversibile (azienda ferma, debiti enormi senza alcuna possibilità di ripianarli, nessun investitore) e non si riesce a predisporre un piano credibile, allora è doveroso presentare istanza di fallimento per evitare ulteriori aggravamenti. Ma in generale è preferibile presentare un concordato preventivo (anche “in bianco”) piuttosto che far fallire subito: il concordato sospende le azioni dei creditori e offre l’opportunità di proporre ai creditori una soluzione (che può includere anche la liquidazione dell’azienda, ma in modo più ordinato e con eventuali esenzioni da responsabilità personali). Va inoltre ricordato che l’imprenditore che non prova soluzioni prima del fallimento rischia accuse di aver aggravato il dissesto; viceversa, tentare un piano o concordato è visto positivamente sia civilmente che penalmente . Dunque, in sintesi: tentare il salvataggio con strumenti di crisi è consigliabile quando esiste una minima chance, mentre il fallimento va anticipato solo se continuare l’attività arrecherebbe ulteriore danno ai creditori senza reali prospettive di inversione di rotta.
D: Se non riesco a pagare le imposte e i contributi della mia azienda, cosa rischio personalmente e cosa posso fare?
R: Sul piano personale, il legale rappresentante rischia: – Sanzioni amministrative e interessi sul debito fiscale/previdenziale non pagato, a carico dell’azienda (che aumentano il debito stesso). – Azioni esecutive da parte dell’Erario (pignoramenti di beni aziendali). Se l’azienda è una società di capitali, in genere il Fisco non può aggredire i beni personali dell’amministratore o soci, salvo questi abbiano prestato garanzie personali o salvo casi di frode (ad es. responsabilità solidale per il liquidatore che paga alcuni creditori invece del Fisco in fase di liquidazione). Tuttavia, se ci sono beni personali dati in garanzia (es. ipoteca su casa del socio a fronte di cartelle), possono essere escussi. – Conseguenze penali: come spiegato, omessi versamenti di IVA sopra €250.000 annui e di ritenute sopra €150.000 annui sono reati penali ; anche non versare oltre €10.000 di contributi INPS trattenuti è reato . Le pene non sono altissime (massimo 2-3 anni di reclusione), ma comportano comunque procedimenti penali a carico dell’amministratore/datore di lavoro. C’è la possibilità di evitare la punibilità se si paga il dovuto prima del processo o se si chiede e rispetta una dilazione . Quindi, il rischio principale è il penale oltre naturalmente al fatto che il debito cresce e blocca l’azienda (fermo amministrativo beni, ecc.).
Cosa fare: – Chiedere subito una rateizzazione all’Agenzia Entrate-Riscossione per le cartelle esattoriali (fino a 72 o 120 rate). Questo congela le azioni esecutive e, finché paghi le rate, impedisce la configurazione del reato di omesso versamento (il debito è in corso di estinzione) . È fondamentale presentare la domanda di dilazione prima della soglia di decadenza (ad es. per IVA entro il 31 dicembre dell’anno successivo). – Valutare se vi sono le condizioni per aderire a qualche definizione agevolata (rottamazione cartelle, saldo e stralcio): periodicamente lo Stato le offre, condonando sanzioni e interessi. – Se il debito fiscale è troppo grande per essere pagato integralmente, considerare la transazione fiscale all’interno di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione . In un concordato puoi proporre di pagare solo una percentuale delle imposte e dilazionarla, il tutto con l’approvazione del tribunale, e questo ti mette al riparo da pretese penali future sul residuo perché quel residuo viene annullato . Attenzione però: la transazione fiscale non estingue i reati già commessi di omesso versamento (per la legge penale serve il pagamento integrale). Quindi, se hai già superato la soglia penale, per evitare la condanna devi comunque pagare quell’importo soglia (magari inserendolo come pagamento integrale nel piano concordatario). – Comunicare con gli enti: ad esempio, se sai di non poter versare ritenute e IVA in arrivo, contatta l’Agenzia per valutare il ravvedimento operoso o forme di compensazione. Non nascondere la testa sotto la sabbia: omettere di presentare la dichiarazione IVA nel tentativo di guadagnare tempo è un reato (omessa dichiarazione) ben più grave dell’omesso versamento. – Per i contributi INPS, chiedere subito una dilazione al’INPS per evitare la denuncia. L’INPS solitamente segnala alla Procura gli omessi versamenti sopra soglia scaduto il termine di tolleranza. Anche qui, il pagamento prima del giudizio estingue il reato, quindi magari integra quell’importo prima possibile. Se la tua azienda va in concordato, inserisci una classe apposita per l’INPS con pagamento almeno parziale e entro i limiti di non punibilità.
In breve, difendersi significa: rateizzare, negoziare e, se necessario, concorsualizzare il debito fiscale. Così eviti misure estreme (ipoteche, blocco conti) e congeli la situazione. Nel contempo, come amministratore, devi attuare misure per non accumulare altro debito fiscale: tagliare costi, liquidare personale in eccesso (meglio licenziare che avere decine di mensilità non pagate con potenziale reato). Ricorda che l’amministratore che non paga ripetutamente stipendi e contributi rischia anche incriminazioni per violazione di norme sulla sicurezza o lo Statuto dei Lavoratori (ci sono fattispecie di sfruttamento punite penalmente se l’omissione è sistematica, sebbene raramente applicate se c’è crisi conclamata e non dolo di arricchimento). Infine, se vedi che non riuscirai comunque a far fronte, valuta con il legale un eventuale patteggiamento con la Procura per i reati tributari (spesso prevedibile, ma è materia penale oltre lo scopo qui).
D: Un fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la mia società per mancato pagamento: devo pagare subito, posso oppormi o ci sono alternative?
R: Se il credito del fornitore è effettivamente dovuto (merce consegnata, fattura non pagata, nessuna contestazione sulla fornitura), opporsi al decreto ingiuntivo senza ragioni fondate servirebbe solo a prendere tempo e generare spese legali ulteriori. L’opposizione è utile solo se hai motivi validi di contestazione (es. la merce era difettosa, o il fornitore stesso ti deve qualcosa in compensazione). Se questi motivi non ci sono, le opzioni principali sono: – Trovare un accordo con il fornitore: anche ora che ha un decreto esecutivo, molti fornitori preferiscono un pagamento concordato che l’incertezza di un’esecuzione. Puoi proporre un piano di rientro (es: 50% subito e 50% entro 6 mesi) o uno sconto a saldo e stralcio (es: pagare 80% subito, in cambio di chiudere la partita). Formalizzate l’accordo in un atto scritto, magari con clausola di rinuncia all’esecuzione del decreto se rispetti i pagamenti. Finché trovi un’intesa, il fornitore potrà sospendere i pignoramenti. – Chiedere una dilazione giudiziale: la legge consente, in casi eccezionali, di chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione o termine di grazia (ad es. art. 41 TUB per crediti fondiari, o 269 c.p.c. per dilazioni), ma sono ipotesi limitate. Di solito se c’è titolo esecutivo, il creditore è libero di agire. – Includere il fornitore in un piano o procedura concorsuale: se stai predisponendo un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, comunicaglielo subito e magari chiedi al tribunale un provvedimento d’urgenza per sospendere quell’esecuzione in attesa di presentare la domanda di concordato. Infatti, presentando la domanda di concordato (con misure protettive) ottieni automaticamente il blocco di tutte le esecuzioni, compresa quella di quel fornitore . Dovrai poi trattare il suo credito nel concordato, proponendogli il pagamento parziale differito come a tutti i chirografari. – Pagare se possibile i crediti strategici: se quel fornitore è cruciale (ti fornisce componenti indispensabili), può essere sensato cercare i fondi per pagarlo e ripristinare il rapporto, piuttosto che perderlo. Ricorda però di non favorire un fornitore a scapito di altri in periodo di insolvenza conclamata, se poi andrai in fallimento: sarebbe un pagamento preferenziale revocabile e anche penalmente rilevante. Però se stai in concordato, puoi chiedere al giudice di autorizzare il pagamento di crediti strategici anteriori (lo consente l’art. 100 CCII) per garantire la continuità aziendale: se il tribunale autorizza, quel pagamento poi non sarà revocabile.
In ogni caso, non ignorare il decreto ingiuntivo: se non hai beni aggredibili, forse il fornitore non troverà nulla da pignorare subito, ma accumulerai interessi e il segnale di insolvenza pubblica (pignoramenti a vuoto, eventuale istanza di fallimento). Meglio affrontare il problema di petto e negoziare, mostrando al fornitore che vuoi pagarlo seppur con respiro. Spesso un creditore commerciale è disposto ad aspettare un po’ in più se vede serietà, piuttosto che spendere soldi in avvocati per pignoramenti incerti.
D: Che differenza c’è tra un piano attestato e un concordato preventivo, e come scelgo l’uno o l’altro?
R: Si tratta di due approcci molto diversi: – Il piano attestato di risanamento è un accordo privato (stragiudiziale) tra l’azienda e alcuni creditori, accompagnato da una relazione di un esperto indipendente che ne attesta la fattibilità . Non coinvolge il tribunale per omologhe o voti. È rapido e riservato, e offre benefici come la protezione dalle revocatorie e da certe responsabilità penali (niente bancarotta preferenziale per i pagamenti eseguiti nel piano) . Tuttavia, non vincola i creditori estranei: chi non aderisce rimane libero di agire . Inoltre non c’è una moratoria legale: il successo dipende dalla volontà di cooperazione di tutti i creditori importanti. Quando sceglierlo: se hai pochi creditori rilevanti (es: banche principali già d’accordo) e prevedi di poterle pagare/regolarizzare in modo consensuale, e magari vuoi evitare la pubblicità del tribunale, il piano attestato è indicato. Anche se hai bisogno di agire velocemente senza attendere voti, il piano attestato è più snello. – Il concordato preventivo invece è una procedura giudiziale: viene aperta dal tribunale, tutti i creditori ne sono informati e coinvolti, c’è un commissario nominato e i creditori votano la proposta . Offre un “ombrello” protettivo (nessuno può farti esecuzioni durante il concordato) e, se approvato, obbliga tutti i creditori secondo i termini della proposta (anche i dissenzienti) . È quindi adatto quando devi gestire molti creditori e hai necessità di imporre una ristrutturazione generale del debito. Il rovescio della medaglia è che è pubblico (il mondo saprà che sei “in concordato”) e richiede tempo e costi (professionalità varie, procedure di voto). Quando sceglierlo: se l’azienda è in dissesto grave con tanti creditori e solo un approccio collettivo può funzionare; se prevedi di dover falcidiare crediti di soggetti che non accetterebbero individualmente (es: il Fisco, grandi fornitori rigidi) – nel concordato puoi farlo in modo coattivo, purché la maggioranza approvi . Inoltre, se ti serve l’automatic stay (blocco immediato dei pignoramenti), questo lo hai solo con concordato o accordo ex art.57, non col piano attestato puro (a meno di passare dalla composizione negoziata, comunque giudice).
In breve, possiamo dire: – Piano attestato = volontario, extragiudiziale, flessibile, adatto se i creditori chiave collaborano. Minor impatto reputazionale e niente procedure lunghe. Però fragile rispetto ai creditori esterni. – Concordato preventivo = ufficiale, collettivo, vincolante, necessario se hai bisogno di cram-down (forzare i dissenzienti) e protezione legale estesa. Ti permette di risolvere i debiti in modo globale e definitivo con efficacia verso tutti. Però è più lento, costoso e sotto i riflettori (anche i clienti/fornitori sapranno del concordato, con possibili diffidenze commerciali).
Molte volte, l’imprenditore tenta inizialmente il piano attestato: se riesce, bene. Se vede che non riesce (ad esempio perché qualche creditore importante non aderisce), allora “scala di intensità” e passa a un accordo di ristrutturazione o direttamente a un concordato preventivo . Non c’è nulla di male in questo: spesso un piano attestato si trasforma in concordato quando servono gli effetti erga omnes . Viceversa, in alcuni casi rarissimi, un concordato presentato viene convertito in un piano attestato (se il debitore trova fuori soluzione prima del voto, può rinunciare al concordato e formalizzare un piano, come accaduto in un caso a Venezia menzionato) .
D: La mia società andrà in liquidazione concordataria. Gli amministratori (me incluso) rischiano qualcosa personalmente?
R: Dipende dal loro operato pregresso. Se il concordato preventivo viene omologato e la società adempie, i creditori non potranno più avanzare pretese né verso la società né verso gli amministratori, salvo abbiano titolo per responsabilità separate. Esempio: se gli amministratori hanno commesso reati (fiscali o di false comunicazioni), risponderanno penalmente indipendentemente dal concordato. Ma i crediti civilistici dei creditori verso la società restano chiusi nella procedura. In genere, l’omologa di un concordato non libera gli amministratori da possibili azioni di responsabilità per danni: se la gestione è stata scorretta, la società (o il liquidatore nominato per eseguire il concordato) potrebbe ancora citarli. Tuttavia, spesso nei concordati in continuità gli stessi amministratori restano in carica e le azioni di responsabilità non vengono promosse a meno che i creditori (o nuovi soci) non le spingano.
C’è poi il fronte penale: – Nel concordato preventivo non vi è dichiarazione di fallimento, quindi non scattano automaticamente i reati di bancarotta. Dunque gli amministratori evitano le accuse di bancarotta fraudolenta o semplice che sarebbero scattate in caso di fallimento. (Attenzione però: se prima del concordato hanno fatto atti illeciti come distrazioni, potrebbero essere imputati di altre fattispecie come appropriazione indebita o sottrazione fraudolenta al pagamento imposte, ma bancarotta no perché la società non fallisce). – I reati tributari eventualmente compiuti (omessi versamenti, frodi fiscali se ve ne sono state) non vengono cancellati dal concordato. Se però nel concordato il debito fiscale viene pagato o l’Erario è soddisfatto al meglio, questo può evitare la punibilità in base alle cause di non punibilità (pagamento integrale prima del dibattimento) . Ad esempio, se c’era reato di omesso IVA per €300k, ma nel concordato l’azienda paga integralmente quell’IVA, l’amministratore potrà invocare l’estinzione del reato. Viceversa, se il concordato falcidia quell’IVA, formalmente il reato rimane (anche se spesso le procure sono meno propense a perseguire in tali casi). Nel 2023 un disegno di legge valutava di introdurre la non punibilità degli omessi versamenti se il debitore completa un concordato o accordo con soddisfacimento parziale del Fisco, ma ad ottobre 2025 non mi risulta approvato: quindi la regola resta che per non essere puniti bisogna pagare integralmente.
Gli amministratori di società di capitali in concordato non rischiano azioni personali dei creditori sociali, perché i creditori sono soddisfatti secondo il piano e rinunciano a eccedenze. Fanno eccezione i casi in cui l’amministratore abbia commesso un illecito particolare verso un creditore, non assorbito dal concordato: ad esempio, se ha garantito personalmente il debito col creditore, allora quella garanzia può essere escussa. Oppure se un creditore lo accusa di dolo extracontrattuale (truffa, ecc.), potrebbe tentare un’azione fuori dal concordato (ma sono situazioni limite).
In generale, se come amministratore hai rispettato i doveri (ti sei attivato per il concordato tempestivamente, hai gestito onestamente la crisi), il concordato dovrebbe metterti al riparo da gravi conseguenze: – I creditori vengono soddisfatti in base all’omologa e non avranno motivo di farti causa (non possono per i crediti inclusi). – Il tribunale, omologando, di fatto certifica che non c’è stata frode nella proposta, quindi non ci sono state condotte distrattive altrimenti non avrebbe omologato (o sarebbero state sanzionate). – Tu avrai agito in buona fede, quindi difficilmente qualcuno avanzerà un’azione di responsabilità (a meno di contestare che la tua gestione ha causato la crisi – ma servono prove di violazioni specifiche).
Tieni però presente: se mai il concordato non venisse adempiuto e la società venisse dichiarata fallita successivamente, allora i benefici salta e potresti sottoporti a bancarotta (anche post-concordataria, figura prevista per chi fallisce dopo un concordato non adempiuto).
D: Ho dato una fideiussione personale alla banca per i debiti della società. Ora la banca minaccia di escuterla perché la società non paga: posso tutelarmi in qualche modo?
R: La fideiussione è un’obbligazione personale e autonoma: se la società non paga, la banca ha pieno diritto di chiedere a te, garante, l’intero importo garantito, senza dover attendere altre procedure. Quindi la banca può escutere la fideiussione (ad esempio, addebitando i tuoi conti personali, pignorando i tuoi beni) appena la società è in inadempimento e dopo eventuale messa in mora.
Cosa puoi fare: – Negoziare con la banca prima che escuta: spiega la situazione e magari proponi un accordo di rientro a tuo nome (es: pagherò X al mese io personalmente). Le banche spesso preferiscono accordi di pagamento piuttosto che lunghe esecuzioni su garanti, specie se percepiscono buona fede. Potresti offrire un saldo e stralcio personale: ad esempio, se la banca pensa che comunque la società fallirà e da te recupererebbe con difficoltà, potresti proporre di pagare il 50% del garantito attingendo a risparmi o con un prestito, in cambio di liberarti dalla garanzia. Questo dipende dalla tua capacità economica personale. – Coinvolgere la banca nella ristrutturazione: se stai predisponendo un piano di risanamento o un concordato, includi quella banca e la sua esposizione. Se riesci a farle votare un concordato dove magari è prevista la soddisfazione parziale del suo credito, la fideiussione segue la sorte del credito per la parte soddisfatta: ad esempio, se la banca accetta 80 su 100 in concordato, normalmente deve liberare il garante pro quota (non potrebbe prendere 80 dal concordato e poi chiedere a te il restante 20; il pagamento concorsuale libera la garanzia per la parte soddisfatta). Tuttavia, attenzione: legalmente il garante risponde per l’intero finché il credito non è integralmente estinto, quindi se il concordato non paga il 100% alla banca, questa potrebbe pretendere dal fideiussore la parte falcidiata. Ci sono state dispute su questo in passato, ma la giurisprudenza recente tende a escludere che la banca possa recuperare dal garante la parte tagliata in concordato, a patto che la banca abbia espresso voto favorevole al concordato accettando la falcidia (diverso sarebbe se ha votato contro; in tal caso potrebbe provare a escutere il garante per il residuo, anche se eticamente discutibile). Nel dubbio, a volte i concordati contengono clausole di release dei garanti se i creditori aderiscono. Ti conviene quindi negoziare con la banca un impegno: se sostiene il piano concordatario, tu magari fornisci garanzie aggiuntive su quanto prende in concordato, e la banca rinuncia ad escuterti per il residuo. – Patrimonio personale: se hai beni attaccabili (casa, stipendio), valuta se puoi metterli al riparo legalmente prima dell’escussione. Ad esempio, se la casa è cointestata col coniuge, la banca potrà pignorarla per intero e poi liquidare la metà. Se però il debito è enorme e inevitabile, potresti valutare di vendere volontariamente certi beni per fare cassa e transare con la banca (meglio tu venda la casa a valore di mercato per pagare il debito, che farla vendere all’asta al 50%). – Procedure da sovraindebitamento: come accennato, se tu come persona fisica, dopo aver eventualmente onorato per quanto possibile la fideiussione, rimani indebitato oltre le tue possibilità, puoi pensare al concordato minore o piano del consumatore per liberarti dei debiti personali residuali. Ad esempio, se la banca escute e resta ancora un debito, potresti proporre ai tuoi creditori personali un piano di ristrutturazione ex L.3/2012 (ora CCII) su misura.
In sintesi, come garante sei in posizione delicata: agisci proattivamente con la banca per evitare l’escussione giudiziale, mostrando che anche per loro conviene trovare un accordo (perché magari se ti aggrediscono ma tu non hai liquidità, rischiano tempi lunghi e incerti). Se la garanzia è stata data a più banche (fidi multipli garantiti personalmente), può essere opportuno un accordo unico di ristrutturazione in cui tutte le banche accettano una certa percentuale e liberano le fideiussioni contestualmente (questo può avvenire in un accordo ex art.57 CCII, ad esempio, con un omologa che preveda la liberazione dei garanti – ciò è possibile includerlo come condizione contrattuale).
D: I dipendenti della mia azienda non sono stati pagati negli ultimi mesi. Cosa succede ai loro crediti se faccio un concordato? E possono causare il fallimento prima?
R: I crediti dei dipendenti (stipendi, TFR, ecc.) sono privilegiati e godono anche di un Fondo di Garanzia INPS. Se i dipendenti decidono di agire, potrebbero: – Mettere in mora l’azienda, ottenere decreti ingiuntivi rapidi e anche tentare un’istanza di fallimento. Sovente, il solo fatto di non pagare più gli stipendi è considerato sintomo di insolvenza (specie se protratto per più mesi), quindi un tribunale potrebbe dichiarare il fallimento su istanza di alcuni dipendenti-creditori privilegiati se vede che l’azienda non ha prospettive di pagamento. – Tuttavia, se presenti un concordato preventivo prima che ciò accada, la procedura concorsuale “maggiore” (concordato) prevale sull’istanza di fallimento e i dipendenti verranno soddisfatti in quella sede. I dipendenti nel concordato formano tipicamente una classe a sé di crediti privilegiati e, per legge, possono anche essere pagati integralmente (in molti concordati, i dipendenti prendono il 100% di stipendi e TFR, magari dilazionato di qualche mese) per ragioni sociali e anche pratiche (altrimenti voterebbero contro). La normativa permette al massimo di dilazionare di 6 mesi dal decreto di omologa il pagamento dei crediti di lavoro privilegiati . Quindi nel piano concordatario dovrai prevedere che, entro 6 mesi dall’omologa, i lavoratori ricevano quanto dovuto (almeno le parti privilegiate). Spesso, a pagarli interviene in anticipo il Fondo di Garanzia: in un concordato liquidatorio, l’INPS può anticipare ai lavoratori il TFR e gli ultimi 3 stipendi, e poi surroga come creditore privilegiato nel concordato. – Dunque, i dipendenti in concordato sono tutelati: o li paghi tu in corso di procedura (spesso chiedendo al giudice l’autorizzazione a pagarli subito come crediti strategici, perché far lavorare dipendenti non pagati è difficile) oppure li paga l’INPS Fondo Garanzia una volta aperta la procedura. Un esempio: se la tua azienda va in concordato e poi in liquidazione, gli operai possono chiedere al Fondo il TFR e 3 mensilità arretrate; l’INPS paga e subentra al loro posto nel concordato. Il tribunale di solito pretende che i piani di concordato prevedano il pagamento integrale dei lavoratori per essere approvati (quantomeno delle componenti privilegiate). – Se il concordato è in continuità, di solito il trattamento dei dipendenti è: pagamento degli arretrati a fine procedura (spesso col ricavato di un finanziamento, o con incassi futuri). I dipendenti votano in una classe separata: se gli offri il 100% (anche se dilazionato), voteranno a favore e proseguiranno a lavorare, se offrissi meno del 100% potrebbero opporsi. In pratica, quasi tutti i concordati in continuità offrono integrale soddisfo ai dipendenti (salvo forse per dirigenti con TFR altissimi, a cui magari si applica un taglio oltre il privilegio). – Nota: durante il concordato, i nuovi stipendi correnti devono essere pagati regolarmente come crediti prededucibili (cioè spese della procedura). Non puoi pensare di non pagare anche quelli: se no i dipendenti giustamente scappano e il giudice potrebbe anche revocare l’ammissione se vede che non rispetti gli obblighi correnti.
Riassumendo: nel concordato i lavoratori sono creditori privilegiati di rango molto alto e dunque: – Riceveranno almeno la parte privilegiata (stipendi ultimi 12 mesi e TFR fino al massimale) al 100%. – Il concordato può prevedere anche di non pagare eventuali parti non privilegiate (ad esempio, il TFR eccedente il massimale può diventare chirografo e forse prendere una percentuale come gli altri chirografi). Ma spesso i crediti da lavoro sono interamente privilegiati a parte interessi e poche voci. – Possono anticipare le somme tramite l’INPS se tu non puoi pagarle subito. – La loro istanza di fallimento può essere fermata depositando prima il concordato. È sempre una corsa contro il tempo: se i dipendenti presentano istanza di fallimento prima e tu non hai nulla in mano, il tribunale potrebbe dichiarare il fallimento (salvo magari dare un breve rinvio se informato che stai per depositare un concordato). L’ideale è comunicare con i dipendenti: spiegare che stai preparando un concordato che garantirà loro il pagamento e chiedere di pazientare un attimo senza intraprendere azioni distruttive. La trasparenza e, se possibile, coinvolgere un sindacato in un accordo, può aiutare. Ad esempio, potresti proporre di riconoscere comunque le retribuzioni e pagarle non appena vendi un certo bene, con gli interessi, e far sottoscrivere l’accordo ai lavoratori (questo non impedisce di presentare loro istanza, ma ne riduce la propensione). – Dal lato penale: attento a non oltrepassare i 3 mesi di stipendi non pagati; oltre può configurarsi il reato di estorsione o intermediazione illecita (il cd. caporalato) se costringi i lavoratori a lavorare senza paga sotto minaccia implicita di licenziarli. È un reato più teorico in situazioni di crisi, ma conviene prevenire.
D: Un’ultima domanda – quali sono le normative chiave e le ultime sentenze di riferimento che dovrei conoscere in questo ambito (crisi d’impresa e debiti)?
R: In ambito normativo, i riferimenti principali (aggiornati al 2025) sono: – Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) e i suoi correttivi: D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, che hanno modificato varie parti. Questo Codice ha sostituito la vecchia legge fallimentare e disciplina concordato, accordi, composizione negoziata, allerta, liquidazione giudiziale, ecc. – Il Codice Civile per gli articoli modificati: art. 2086 c.c. comma 2 (adeguati assetti) , art. 2486 c.c. comma 3 (criteri di calcolo danno) , art. 2477 c.c. (collegio sindacale obbligatorio per srl sopra soglie, legato anche alla crisi), art. 2482-bis e ter c.c. (perdite rilevanti). – Il D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 per la Composizione Negoziata (ora integrata nel CCII ma con decreti attuativi propri). – Il D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) che fissa soglie e fattispecie di reato per IVA, dichiarazione fraudolenta, omessi versamenti, ecc. – Il D.Lgs. 8/2016 e D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983 per i reati contributivi (soglia 10.000). – Il TUIR (DPR 917/86) art. 88 co.4-ter che prevede la detassazione delle sopravvenienze attive da concordati, accordi e piani attestati . – La Legge 3/2012 (ora abrogata e assorbita nel CCII) per il sovraindebitamento, e ora le sezioni del CCII su concordato minore e liquidazione controllata (artt. 65-83 e 268-277 CCII). – Normativa del Codice Penale e procedura penale correlata: es. art. 216-217 legge fall. ora trasfusi negli artt. 322-323 CCII (bancarotte), art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta imposte), ecc.
Come giurisprudenza recente autorevole, citerei: – Cass. Civ. Sez. I, 8 marzo 2023 n. 6893: responsabilità ex art. 2486 c.c. verso i creditori sociali, con inversione onere prova a carico amministratore sulle operazioni compiute dopo scioglimento . – Cass. Civ. Sez. I, 8 marzo 2016 n. 4915 (un po’ datata ma sempre valida) sulle condizioni di omologabilità della transazione fiscale, poi superate dal legislatore nel 2020, ma rilevante storicamente. – Tribunale di Piacenza, decreto 26/11/2024 (omologa concordato): ha sancito il cram-down fiscale in continuità e l’effetto di “cristallizzazione” del debito fiscale post-omologa . – Cass. Pen. SS.UU. n. 22474/2016: su rapporti tra reati tributari e procedure concorsuali, afferma che il concordato preventivo non estingue il reato di omesso versamento, ma l’estinzione penale esige il pagamento integrale (orientamento prevalso). – Cass. Pen. Sez. V, 5 luglio 2021 n. 25631: ha escluso la punibilità per bancarotta preferenziale nel caso di pagamenti effettuati durante trattative di risanamento se funzionali e trasparenti (interpretazione ancor prima dell’art. 324 CCII). – Corte di Giustizia UE: se rileva, direi il caso C-198/15 (Eurofood) sulla parità di trattamento del Fisco in procedure concorsuali (che influì sulla riforma 2020). – Cass. Civ. SS.UU. 9100/2015: in tema di criteri di liquidazione del danno da prosecuzione abusiva (codificata poi dall’art. 2486 c.c. nuovo) . – Cass. Civ. Sez. Un. 8500/2014: sulla possibilità di falcidiare l’IVA nel concordato (all’epoca disse di no per contrasto con norme UE; questo portò al legislatore a modificare la legge nel 2020 perché la CGUE nel frattempo ha ritenuto compatibile la falcidia IVA se con convenienza). – Cass. Pen. Sez. V, 24 maggio 2022 n. 20572: ha chiarito che l’ammissione al concordato preventivo non preclude la confisca penale per reati tributari (quindi se uno ha beni sequestrati per reati fiscali non se li “riporta in concordato”), punto di nicchia ma interessante se capitasse.
Tutto sommato, però, per un imprenditore non giurista è più importante conoscere i principi pratici (emergere la crisi presto, non fare il furbo col Fisco, ecc.) che memorizzare sentenze. Per questo abbiamo inserito in guida i concetti chiave con i riferimenti alle fonti . In fondo alla guida trovi un elenco di normative e pronunce aggiornate che puoi consultare per approfondire ogni aspetto.
Conclusione: Affrontare i debiti di un’azienda, specie in settori industriali come quello delle macchine termosaldatrici e blister, richiede una visione strategica e multidisciplinare: giuridica, finanziaria e gestionale. La legge italiana, specie dopo la riforma del 2022-2024, offre un ventaglio di strumenti per aiutare l’imprenditore onesto a superare la crisi o quantomeno a gestirla evitando il tracollo disordinato. È cruciale agire con tempestività, trasparenza e l’ausilio di professionisti esperti (commercialisti, legali). Come visto, esistono vie per ristrutturare il debito (piani, accordi, concordati), per proteggere il patrimonio (esenzioni da revocatorie, accordi omologati), e per limitare la responsabilità personale (seguendo le regole, beneficiando delle esenzioni penali se si opera in un piano attestato ). Dall’altro lato, la normativa non esita a punire chi persevera in gestioni allegre o scorrette: gli amministratori negligenti o scorretti possono risponderne civilmente e penalmente .
Il punto di vista adottato è stato quello del debitore, ma non bisogna dimenticare che l’intento finale è l’equilibrio con i diritti dei creditori. La giustizia concorsuale mira infatti a trovare soluzioni eque: il debitore meritevole viene aiutato a uscire dai debiti, ma i creditori devono ricevere almeno quanto avrebbero altrimenti . In questo bilanciamento, strumenti come la transazione fiscale – che un tempo parevano un’eresia – oggi realizzano compromessi pragmatici: l’Erario incassa il possibile, l’impresa evita la morte.
Per concludere, un’azienda indebitata ha davanti a sé varie strade: la peggiore è l’inazione (lasciar andare tutto in decozione fuori controllo); la migliore è la ristrutturazione consensuale; quella di mezzo è la procedura concorsuale che, se ben gestita, porta magari a sacrifici ma salva il salvabile. Ogni caso è a sé, ma la parola d’ordine è una: attivarsi subito. Come recita il nuovo art. 2086 c.c., l’imprenditore deve “attivarsi senza indugio” per il superamento della crisi . Questa guida ha offerto gli strumenti conoscitivi per farlo in modo consapevole, con supporto di fonti normative e precedenti.
Fonti e Riferimenti
Normativa italiana di riferimento:
- Codice Civile: art. 2086 co.2 (obbligo di assetti adeguati e attivazione per superare la crisi) ; art. 2484 (cause di scioglimento); art. 2485-2486 (obblighi conseguenti e responsabilità degli amministratori – novellato dall’art. 378 CCII, che introduce il co.3 sull’onere probatorio e criteri di quantificazione del danno) ; artt. 2482-bis e 2482-ter (riduzione del capitale per perdite); art. 2476 (azione responsabilità verso amministratori S.r.l.); art. 2394 (azione dei creditori sociali verso amministratori); art. 2447 (riduzione capitale sotto minimo).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche: disciplina organica di piani attestati (art. 56) , accordi di ristrutturazione (artt. 57-64) , composizione negoziata (artt. 12-25) , concordato preventivo (artt. 84-120) , liquidazione giudiziale (artt. 121-270), strumenti di sovraindebitamento (artt. 65-83 per concordato minore; 268-277 liquidazione controllata). Correttivo D.Lgs. 83/2022 (attuazione Dir. UE 2019/1023) e D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) – hanno introdotto ad es. la moratoria di 5 anni nei concordati in continuità, modifiche sulle percentuali per cram-down fiscale , ecc.
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – abrogata dal 15/7/2022, ma rilevante per fatti pregressi e per la giurisprudenza formatasi su di essa. Art. 67 l.f. (revocatorie, esenzione piani attestati lett. d) – ora trasfusa in art. 56 CCII; art. 160-173 l.f. (concordato preventivo previgente); art. 182-bis e 182-ter l.f. (accordi e transazione fiscale previgenti) .
- D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021 – Istituzione della Composizione Negoziata della Crisi, con le figure dell’esperto e misure protettive (ora integrate nel CCII, artt. 12-25, ma decreto origine come norma emergenziale Covid).
- D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) – art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150k) , art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250k) , art. 10-quater (indebite compensazioni); art. 5 (omessa dichiarazione > €50k imposta evasa); art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte > €50k) – reato di chi simula/occulta per evadere riscossione . Art. 13 e 13-bis dispongono cause di non punibilità se pagamento integrale prima del dibattimento . D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie penali) – ha posticipato la soglia temporale di consumazione dei reati di omesso versamento al 31 dicembre anno successivo dichiarazione , e previsto che rateizzazioni in corso/esiti di controlli automatizzati rilevino ai fini penali .
- D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983 art. 2 (omesso versamento contributi previdenziali) – depenalizzato fino €10.000 annui, reato oltre tale soglia (reclusione fino 3 anni, multa) .
- D.P.R. 602/1973 art. 19 (rateizzazione cartelle esattoriali fino 72 rate ordinarie, 120 straordinarie) e art. 48 (privilegi fiscali su mobili). D.M. Min. Finanze 6/11/2021 (nuovi criteri rateazione) ecc.
- TUIR (D.P.R. 917/1986) art. 88 co.4-ter – Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in procedure concorsuali non imponibili . Ris. Agenzia Entrate n. 222/E 13.11.2024 – ha chiarito che l’agevolazione si applica anche ai piani attestati ex CCII, se pubblicati .
- Leggi di Bilancio recenti (es. L. 197/2022 art. 1 commi 231-252) – Definizioni agevolate (rottamazione-quater, stralcio mini-debiti) per cartelle fiscali.
- Legge 155/2017 (delega riforma insolvenza) – base del CCII.
- Legge 3/2012 (composizione crisi sovraindebitamento) – abrogata e confluita nel CCII, ma giurisprudenza pregressa ancora utile; introdusse il “piano del consumatore” e liquidazione ex L.3, ora concordato minore e liquidazione controllata.
Giurisprudenza e prassi (sentenze, circolari):
- Cass. Civ. Sez. I, 08/03/2023 n. 6893 – Responsabilità amministratori post scioglimento S.r.l.: niente prova di colpa richiesta ai creditori, onere sull’amministratore di provare che le operazioni erano a fini conservativi . Riconduce l’azione alla disciplina speciale ex art. 2486 c.c. e non a 2043 c.c. .
- Cass. Civ. Sez. I, 18/03/2022 n. 8969 – (Concordati preventivi) Ha ammesso la “cram down fiscale” anche nel concordato in continuità prima della riforma, aprendo la via interpretativa poi confermata dal legislatore (cit. come precedenti influenti).
- Cass. Civ. SS.UU., 15/04/2015 n. 6070 e n. 6071 – Sulla falcidiabilità dell’IVA nel concordato: inizialmente contrarie per vincolo UE, poi superate da Cass. SS.UU. 27/12/2016 n. 26988 a seguito Corte Giustizia; queste evoluzioni hanno portato alla L.159/2020 .
- Cass. Civ. SS.UU., 06/05/2015 n. 9100 – Criteri di determinazione del danno da indebita prosecuzione attività: ha stabilito i due criteri presuntivi (differenza netti patrimoniali e differenza attivo/passivo se contabilità inattendibile), poi recepiti dall’art. 2486 c.c. .
- Cass. Pen. SS.UU., 27/01/2011 n. 22474 (Caso Gyps) – Principio: il pagamento integrale del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento estingue i reati omissivi (art.13 D.Lgs 74/2000) . Fondamentale per prassi, consolidato anche dopo D.Lgs 158/2015.
- Cass. Pen. Sez. III, 17/01/2019 n. 26302 (Caso Piscopo) – Omesso versamento IVA: conferma che il termine consumativo è quello dell’acconto dell’anno successivo (27 dic) per fatti pre-riforma; ora modificato dalla norma 2024 .
- Cass. Pen. Sez. Unite, 31/03/2016 n. 22474 – Ha risolto contrasti sull’applicazione art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) ai reati omissivi tributari, affermando la possibilità in casi < soglia di poco; indica orientamento di clemenza su soglie modeste.
- Cass. Pen. Sez. V, 24/02/2020 n. 14241 – Bancarotta preferenziale: ribadisce che pagamenti selettivi in prossimità dell’insolvenza configurano reato se dolosi, salvo fossero necessari per tentare risanamento (anticipando spirito art.324 CCII) .
- Cass. Pen. Sez. V, 04/05/2022 n. 18448 – Conferma non punibilità ex art. 324 CCII per atti in esecuzione piano attestato: prima applicazione pratica della norma penale di esenzione (che richiama art. 217-bis l.f. ora abrogato e sostanzialmente ripreso nel CCII).
- Tribunale di Piacenza, 26 novembre 2024 (decr. omologa) – Concordato in continuità cram-down fiscale: omologa forzata nonostante voto contrario INPS, ritenendo rispettato criterio di convenienza; evidenzia che post-omologa il debito è cristallizzato nell’importo ridotto . Prima applicazione concreta del nuovo art. 88 CCII correttivo-ter.
- Tribunale di Milano, 10 gennaio 2023 – (Composizione negoziata) Ha omologato un accordo con transazione fiscale all’interno di una composizione negoziata, sfruttando l’art. 23 CCII nuovo: case study sull’estensione della transazione ai piani attestati in sede negoziata .
- Corte di Cassazione (ord. int.) 30/05/2023 n. 15200 – Rimetteva alle SS.UU. questione su postergazione ex art. 2467 c.c. in concordato, in particolare se la rinuncia del socio al credito comporta sopravvenienza tassabile o meno; citata per interesse fiscale (poi chiarita da Ris. AE 63/2023).
- Agenzia Entrate – Circolare 16/E del 23/07/2018 – Istruzioni operative all’AdE per valutare adesione alle proposte di transazione fiscale: es. necessità di ottenere almeno quanto in fallimento, previsione di pagamento almeno di una certa percentuale ecc. (In parte superata da L.159/2020 che rende facoltativa ma “cram-downabile” la mancata adesione).
- Agenzia Entrate-Riscossione – Circolare 2/2021 – sulle sospensioni di pignoramenti e dilazioni in caso di presentazione domanda concordato (recepisce art. 54 CCII misure protettive).
La tua azienda che produce, integra, ripara o distribuisce termosaldatrici, macchine blister, impacchettatrici, linee di confezionamento, macchine flow-pack, macchine per packaging medicale, saldatrici a caldo, sistemi di chiusura blister termoformati o ricambi e assistenza tecnica è finita in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, integra, ripara o distribuisce termosaldatrici, macchine blister, impacchettatrici, linee di confezionamento, macchine flow-pack, macchine per packaging medicale, saldatrici a caldo, sistemi di chiusura blister termoformati o ricambi e assistenza tecnica è finita in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni con Fisco, INPS, banche, fornitori elettronici e meccanici, trasportatori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore delle macchine per il confezionamento è tecnico e molto costoso: richiede componenti elettronici, motoriduttori, PLC, sensori, sistemi di riscaldamento, carpenterie, ricambi specifici, personale qualificato e continui investimenti. Un ritardo nei pagamenti o un calo dei fidi può scatenare una crisi immediata.
La buona notizia è che puoi salvare la tua azienda, ma devi agire subito e con il metodo corretto.
Perché un’Azienda di Termosaldatrici e Blisteratrici Va in Debito
- aumento dei costi di componenti elettronici e meccanici, schede, resistenze, motori
- ritardi nei pagamenti di clienti industriali e packaging contractor
- costi elevati di R&D, collaudi, assistenza tecnica e pezzi di ricambio
- magazzino immobilizzato tra ricambi, blister, resistenze, piastre, elettroniche
- investimenti in software, aggiornamenti, certificazioni e fiere
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema vero non è quasi mai la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi e delle linee bancarie
- sospensione delle forniture di componenti elettronici e meccanici
- decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
- sequestro di macchine, ricambi e strumenti tecnici
- impossibilità di completare consegne, avviamenti e assistenza clienti
- perdita di clienti strategici e rischio di chiusura attività
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare i creditori
Con un avvocato specializzato è possibile fermare pignoramenti, richieste di rientro e blocchi dei conti, evitando che la situazione degeneri.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso ci sono errori come:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori di Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte dei debiti può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Tra le soluzioni:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Attivare strumenti legali che proteggono l’azienda
Per le crisi più gravi si possono usare strumenti che bloccano tutti i creditori:
- PRO (Piano di Ristrutturazione dei Debiti)
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Queste soluzioni permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Detto questo, l’Avv. Monardo:
- è Avvocato Cassazionista
- coordina avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
In breve: uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende con debiti, bloccare creditori e ristrutturare situazioni complesse.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e azioni dei creditori
- ristrutturazione dei debiti su misura per la tua azienda
- protezione di magazzino, ricambi, macchine e attrezzature
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di termosaldatrici e macchine blister non significa che l’attività sia destinata a chiudere.
Con una strategia semplice, rapida e mirata puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre concretamente i debiti
- proteggere produzione, ricambi e assistenza tecnica
- salvaguardare la continuità dell’azienda
Il momento di agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il salvataggio e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.