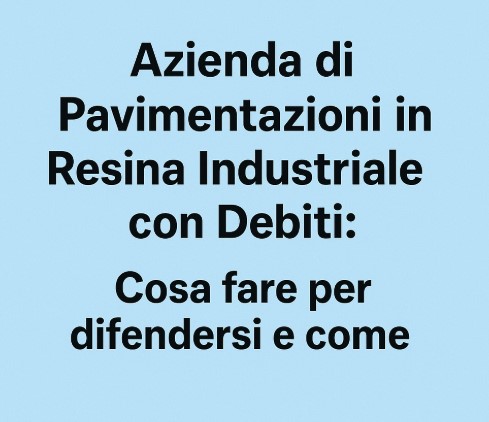Se gestisci un’azienda che realizza pavimentazioni in resina industriale, pavimenti in poliuretano-cemento, rivestimenti epossidici, resinature antiacido, finiture per magazzini, industrie, capannoni, garage, laboratori, ospedali e superfici ad alta resistenza, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la tua attività è a forte rischio.
Il settore delle pavimentazioni in resina richiede manodopera specializzata, materiali tecnici costosi, attrezzature per la preparazione dei fondi, cicli applicativi complessi, tempi stretti e alta precisione nelle fasi di posa. Un blocco dovuto ai debiti può fermare cantieri, causare ritardi critici, generare contestazioni e penali e farti perdere clienti industriali e professionali.
La buona notizia è che puoi ancora proteggerti, ridurre i debiti e salvare la tua azienda, se intervieni subito con la strategia giusta.
Perché le aziende di pavimentazioni in resina industriale accumulano debiti
Le cause più frequenti sono:
- costi elevati per resine epossidiche, poliuretaniche, aggregati, primer e materiali speciali
- rincari significativi di chimici, solventi e prodotti tecnici
- pagamenti lenti da parte di imprese, industrie e appaltatori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi INPS
- gestione complessa del magazzino con materiali sensibili e soggetti a scadenza
- investimenti continui in macchinari per preparazione fondi, aspiratori, levigatrici e DPI
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli dei cantieri
- fornitori strategici che chiedono pagamenti anticipati o immediati
Questi problemi, sommati, generano crisi di liquidità e un indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
La cosa più importante è intervenire immediatamente. Ecco i primi passi da compiere:
- fai analizzare l’intera situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verifica quali debiti sono corretti e quali invece possono essere contestati, ridotti o prescritti
- evita rateizzazioni o piani di rientro non sostenibili
- richiedi subito la sospensione di pignoramenti o procedure esecutive
- valuta rateizzazioni davvero sostenibili con Agenzia delle Entrate e INPS
- proteggi i rapporti con fornitori critici (resine, primer, attrezzature, abrasivi)
- previeni il blocco del conto corrente e la riduzione dei fidi bancari
- utilizza gli strumenti legali per ridurre, rinegoziare e ristrutturare i debiti
Solo una valutazione professionale consente di capire quali debiti si possono realmente ridurre, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Senza un intervento rapido, i rischi diventano molto seri:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di attrezzature come levigatrici, aspiratori, pompe e strumenti applicativi
- blocco delle forniture di resine, primer e materiali fondamentali
- impossibilità di completare pavimentazioni in corso o nuove commesse
- perdita di clienti industriali, imprese edili, aziende alimentari, chimiche o logistiche
- danni alla reputazione professionale e contestazioni per difetti di posa
- crisi di liquidità e ritardi nei pagamenti
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Nel settore della resina industriale anche un piccolo ritardo può compromettere interi cicli applicativi, generando degrado superficiale e contestazioni costose.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e altre azioni esecutive
- ridurre l’importo dei debiti tramite trattative con Fisco, INPS e creditori privati
- ottenere rateizzazioni sostenibili basate sui flussi di cassa reali
- far annullare debiti prescritti, irregolari o calcolati male
- negoziare con banche e fornitori per evitare blocchi delle consegne
- proteggere attrezzature, magazzino, know-how e continuità operativa
- stabilizzare la situazione mentre l’azienda ristruttura i debiti
- evitare procedure concorsuali e rischio di insolvenza
Una strategia legale solida può fare la differenza tra chiusura e rilancio.
Come evitare il blocco dell’attività
Per non interrompere il lavoro della tua azienda devi:
- intervenire subito, non quando è troppo tardi
- evitare di negoziare da solo con i creditori
- proteggere materiali e fornitori indispensabili
- ristrutturare i debiti prima che scattino pignoramenti o blocchi bancari
- contestare debiti irregolari o non più esigibili
- concentrare la liquidità sulle commesse più urgenti e redditizie
Così puoi evitare ritardi, penali, contestazioni e perdita di clienti chiave.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo immediatamente se:
- hai ricevuto cartelle, intimazioni, avvisi o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS, banche o fornitori sono diventati ingestibili
- temi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità sta calando rapidamente
- i fornitori minacciano di sospendere consegne o materiali
- pensi che la situazione possa portare alla chiusura dell’impresa
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e ristabilire la stabilità della tua azienda.
Attenzione
Molte aziende di pavimentazioni in resina non falliscono per i debiti in sé, ma perché intervengono troppo tardi.
Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare davvero il futuro della tua attività.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e tutela di imprese edili, industriali e specialistiche – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di pavimentazioni in resina industriale.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Gestire un’azienda specializzata in pavimentazioni in resina industriale può comportare, come in ogni attività d’impresa, l’esposizione a debiti di varia natura: debiti fiscali verso l’Erario, contributivi verso enti previdenziali, debiti commerciali verso fornitori, finanziari verso banche o leasing, e persino debiti verso i dipendenti (stipendi, TFR). Quando tali passività diventano gravose, l’imprenditore-debitore deve conoscere gli strumenti di tutela per difendersi dalle azioni dei creditori e cercare soluzioni per il risanamento o, nei casi estremi, per un’uscita ordinata dal mercato. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi approfondita e avanzata di cosa fare e come agire, dal punto di vista del debitore, nel contesto italiano.
Affronteremo tutte le categorie di debiti aziendali, non solo quelli fiscali e contributivi. Infatti, un piano efficace di difesa e ristrutturazione deve considerare l’intero spettro dei debiti: dalle cartelle esattoriali alle fatture dei fornitori, dalle rate di mutuo ai salari arretrati. Per ciascun tipo di debito esamineremo le conseguenze legali, le eventuali responsabilità personali di amministratori o soci, e le possibili strategie di gestione, sia extragiudiziali (piani di rientro, transazioni, accordi privati) sia giudiziali (procedimenti di composizione della crisi d’impresa come la composizione negoziata, il concordato preventivo, ecc.).
Dal luglio 2022 il quadro normativo è radicalmente cambiato con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, spesso abbreviato in CCII), che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942 . Questo nuovo codice, ulteriormente modificato da decreti “correttivi” fino al 2024, introduce strumenti innovativi di allerta e gestione della crisi, volti a salvare le imprese ancora vitali e a limitare gli impatti di un eventuale dissesto. Parleremo quindi anche degli strumenti introdotti da questa riforma – ad esempio la composizione negoziata della crisi d’impresa – e delle più recenti novità normative (come il D.Lgs. 136/2024, noto come “terzo correttivo”, in vigore dall’ottobre 2024 ).
Il taglio della guida è giuridico ma divulgativo: forniremo i riferimenti normativi essenziali e citeremo le sentenze più aggiornate della Cassazione e altre fonti autorevoli, in modo da dare solidità alle informazioni, pur mantenendo un linguaggio chiaro. L’obiettivo è aiutare avvocati, consulenti, imprenditori e privati a orientarsi nella difesa di un’azienda indebitata, comprendendo diritti, obblighi e opzioni concrete. Ampio spazio sarà dedicato a domande e risposte comuni, a tabelle riepilogative che confrontano le soluzioni disponibili, nonché a casi pratici simulati riguardanti imprese (in particolare società di capitali come S.r.l. o S.p.A., ma con cenni anche alle imprese individuali o società di persone) alle prese con debiti rilevanti.
Importante: questa guida adotta sempre la prospettiva del debitore. Il focus è quindi sulle strategie per proteggere il patrimonio dell’azienda e dei suoi titolari, garantire la continuità aziendale quando possibile e minimizzare le conseguenze negative del sovraindebitamento. Si ricorda che ogni situazione va valutata caso per caso con professionisti qualificati (legali e consulenti d’impresa), ma le informazioni seguenti forniscono un quadro di riferimento aggiornato e completo per prendere decisioni informate.
Tipologie di debiti aziendali e relative implicazioni
Debiti fiscali (imposte e tributi)
Ogni azienda ha obblighi fiscali periodici verso l’Erario: IVA sulle vendite, ritenute fiscali sui dipendenti (IRPEF), imposte sui redditi (IRES per le società, IRPEF per ditte individuali) e altre tasse come IRAP, IMU, ecc. Il mancato pagamento di tali tributi genera debiti tributari, tipicamente accertati e riscossi tramite cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia). Le implicazioni principali dei debiti fiscali sono:
- Sanzioni e interessi: Il fisco applica interessi di mora e sanzioni amministrative per i versamenti omessi o ritardati. In assenza di interventi legislativi di “condono” o definizione agevolata, queste somme accessorie possono far lievitare significativamente l’importo dovuto.
- Azioni esecutive del Fisco: L’Agente della Riscossione può attivare misure cautelari e esecutive senza passare dal giudice ordinario. Ad esempio, può iscrivere ipoteca su immobili aziendali, disporre il fermo amministrativo di veicoli, o pignorare direttamente conti correnti e beni mobili dopo la notifica della cartella e del preavviso. In casi di debiti ingenti, l’Agenzia Entrate-Riscossione può anche pignorare crediti verso terzi (es. crediti che l’impresa vanta verso clienti) o chiedere al tribunale misure come il sequestro conservativo dei beni.
- Blocco del DURC e benefici pubblici: Se l’azienda opera in settori dove è richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o certificati fiscali di regolarità, il mancato pagamento di imposte può comportare la perdita della regolarità contributiva/fiscale e l’impossibilità di partecipare ad appalti pubblici, ottenere autorizzazioni o beneficiare di contributi pubblici.
- Possibili conseguenze penali: In alcune ipotesi, i debiti fiscali possono sfociare in responsabilità penali a carico degli amministratori. Ad esempio, l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori a una certa soglia (attualmente soglia di punibilità €250.000 per periodo d’imposta) costituisce reato tributario, così come l’omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni oltre la soglia di €150.000 annui. Pur trattandosi di casi specifici, la presenza di debiti fiscali di tale natura richiede un’attenta gestione per evitare di aggravare la posizione dell’imprenditore.
- Segnalazioni di allerta: Con la riforma del 2022, alcuni creditori pubblici hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente le imprese con gravi debiti fiscali. In particolare, l’Agenzia delle Entrate segnala se l’IVA trimestrale non versata supera determinate soglie (es. il maggiore tra €5.000 e il 10% del volume d’affari dell’anno precedente, con tetto massimo €20.000) . Tali segnalazioni mirano a far emergere precocemente la crisi d’impresa, potenzialmente attivando percorsi come la composizione negoziata (ne parleremo oltre).
Un aspetto peculiare dei debiti tributari è la possibilità, prevista dalla legge, di accedere a rateizzazioni o definizioni agevolate. Ad esempio, l’art. 19 del DPR 602/1973 consente di rateizzare le cartelle fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi ordinari, e fino a 120 rate (10 anni) in caso di temporanea grave difficoltà comprovata. Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse “rottamazioni” delle cartelle esattoriali, l’ultima delle quali (nel 2023) ha permesso alle imprese di estinguere i carichi affidati al riscossore pagando solo imposte e interessi legali, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Questi strumenti possono ridurre il peso dei debiti fiscali, ma vanno colti entro finestre temporali precise e non sono sempre disponibili.
Infine, è importante sapere che il Fisco, in quanto creditore privilegiato, ha una posizione preminente in molte procedure concorsuali. Ciò significa che in un eventuale concordato preventivo o liquidazione giudiziale, l’Erario (insieme agli enti previdenziali) deve ricevere un trattamento almeno conforme alla legge. Ad esempio, nel concordato liquidatorio i crediti tributari privilegiati devono essere soddisfatti almeno nella misura realizzabile in caso di liquidazione fallimentare, salvo accordo transattivo. Approfondiremo oltre il tema della transazione fiscale, ossia la possibilità di stralciare parzialmente i debiti fiscali all’interno di procedure concorsuali.
Debiti contributivi e previdenziali
Analogamente ai debiti fiscali, le imprese possono accumulare debiti contributivi verso enti come l’INPS (contributi previdenziali dei dipendenti e del titolare artigiano/commerciante) e l’INAIL (premi assicurativi contro gli infortuni). Il mancato versamento di contributi comporta sanzioni civili (che fungono da interessi di mora, spesso con aliquote elevate) e può pregiudicare la continuità aziendale sotto vari profili:
- DURC irregolare: Il mancato pagamento di contributi impedisce il rilascio di un DURC regolare. Senza DURC, l’impresa non può, in molti settori (edilizia, servizi pubblici, forniture), stipulare nuovi contratti né ricevere pagamenti da enti pubblici. Tuttavia, se l’azienda ottiene un piano di rateazione e paga puntualmente le rate, la normativa consente il rilascio di un DURC regolare in corso di rateizzazione.
- Azioni esecutive dell’INPS: L’INPS ha poteri di riscossione analoghi al Fisco. I debiti contributivi sono infatti iscritti a ruolo e affidati all’Agente Riscossione che può procedere con ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi. L’INPS può inoltre emettere avvisi di addebito immediatamente esecutivi.
- Conseguenze penali: Il diritto penale punisce l’omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti oltre una soglia (oggi €10.000 annui). Gli amministratori che non versano i contributi trattenuti ai lavoratori rischiano quindi denunce per il reato di omesso versamento di contributi (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983) se superano il predetto importo.
- Segnalazioni d’allerta INPS: Come per il Fisco, anche l’INPS ha obblighi di segnalazione: un debito contributivo superiore a certe soglie e anzianità (>90 giorni) fa scattare una comunicazione all’impresa invitandola a reagire (allerta esterna). Per le imprese con dipendenti la soglia è di €15.000 di arretrato (purché rappresenti almeno il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente), mentre per quelle senza dipendenti è €5.000 .
Le possibilità di difesa per i debiti contributivi includono anch’esse rateizzazioni (l’INPS concede piani fino a 24 rate mensili per debiti in fase amministrativa, ed è allineato ai piani fino a 72/120 rate se il debito è già a ruolo presso Agenzia Riscossione) e, in alcuni casi, sgravi su sanzioni. Esistono inoltre istituti come la “rottamazione” dei contributi analoghi a quelli fiscali, varati con leggi di bilancio recenti, che permettono di ridurre l’onere complessivo. Una gestione accorta di questi strumenti è fondamentale per riequilibrare la posizione debitoria dell’azienda e recuperare la regolarità contributiva, indispensabile per operare in molti settori.
Debiti verso fornitori e altri creditori non privilegiati
Un’azienda manifatturiera o edile come quella di pavimentazioni in resina accumula facilmente debiti commerciali verso i fornitori di materie prime, attrezzature, servizi (es. fornitori di resina, attrezzature di cantiere, società di trasporti, consulenti, ecc.). Questi creditori, a differenza di Fisco e INPS, non godono di privilegi generali sui beni dell’impresa, ma possono comunque mettere in difficoltà l’azienda con azioni legali individuali:
- Decreti ingiuntivi e pignoramenti: Il fornitore non pagato può ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo dal tribunale (anche provvisoriamente esecutivo) e procedere a pignorare conti correnti aziendali, beni mobili (macchinari, veicoli) o crediti verso clienti. A differenza dell’Agente pubblico, il creditore privato deve passare per un giudice, ma una volta ottenuto un titolo esecutivo, i suoi poteri di esecuzione forzata sono analoghi (pignoramento presso terzi, vendita all’asta dei beni, ecc.).
- Interessi moratori e sospensione forniture: I contratti commerciali spesso prevedono interessi di mora (talora superiori al tasso legale) in caso di ritardo nei pagamenti. Inoltre, fornitori essenziali (es. fornitori di materiali) potrebbero sospendere le forniture in essere se l’azienda accumula insoluti, aggravando la crisi di liquidità.
- Deterioramento reputazionale e rapporti commerciali: L’impresa con ritardi nei pagamenti può vedere compromessa la fiducia del mercato: altri fornitori iniziano a chiedere pagamenti anticipati, i clienti percepiscono difficoltà (rischio di non completamento dei lavori), si innesca un circolo vizioso che peggiora la crisi.
Dal punto di vista giuridico, i debiti verso fornitori rientrano tra i crediti chirografari (non garantiti) in eventuali procedure concorsuali. Ciò significa che, in un concordato o fallimento, tali creditori spesso subiscono delle falcidie (riduzioni) essendo pagati pro-quota dopo i privilegiati. Questo può incentivare i fornitori, in sede di trattative stragiudiziali, ad accettare transazioni a saldo e stralcio (pagamento parziale) se l’alternativa è il rischio di incassare molto meno o nulla in caso di default dell’impresa.
Tuttavia, bisogna considerare che un singolo fornitore (o altro creditore chirografario) ha facoltà di chiedere esso stesso il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’azienda se esiste uno stato d’insolvenza. La legge prevede una soglia minima di debiti scaduti complessivi (€30.000) perché un creditore possa ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale . Dunque anche i debiti verso fornitori possono, se di importo rilevante e non pagati, mettere in moto la procedura concorsuale più grave. Per il debitore è essenziale prevenire ciò con accordi o con l’accesso a procedure di composizione della crisi (che congelano le azioni esecutive individuali, come vedremo).
Debiti bancari e finanziari
Le imprese spesso finanziano la propria attività con debiti finanziari: fidi di cassa, mutui, leasing per macchinari o immobili, scoperti di conto, anticipazioni salvo buon fine, ecc. Tali debiti presentano caratteristiche peculiari:
- Presenza di garanzie: Molti debiti bancari sono assistiti da garanzie reali (es. ipoteche su beni immobili dell’azienda o dei garanti) o personali (fideiussioni dei soci o degli amministratori). In caso di insolvenza, la banca può escutere la garanzia: ad esempio, procedere alla vendita dell’immobile ipotecato o aggredire il patrimonio personale del fideiussore (tipicamente l’imprenditore stesso o un socio che abbia garantito). Ciò amplia il fronte del rischio, coinvolgendo il patrimonio personale dei garanti.
- Scadenze e covenant: I finanziamenti bancari hanno scadenze precise e talora clausole finanziarie (covenant) che, se violate, rendono il debito immediatamente esigibile. In caso di tensione finanziaria, la banca può revocare gli affidamenti a revoca (fidi bancari) o considerare decaduto dal beneficio del termine il mutuo, chiedendo il rientro immediato di tutto il capitale.
- Procedure esecutive speciali: Se il debitore non paga, la banca può avviare procedure esecutive. Ad esempio, per i mutui ipotecari vi è l’esecuzione immobiliare sul bene dato in garanzia; per leasing, l’ente lessor può riprendere possesso del bene e chiedere il pagamento a titolo risarcitorio; per il fido bancario, ottenuto un decreto ingiuntivo, la banca può pignorare conti e altri beni.
- Interessi composti e spese: L’esposizione verso le banche cresce con interessi passivi e spese di insoluto (commissioni di istruttoria veloce, interessi di mora spesso superiori al tasso ordinario). Ciò rende oneroso il protrarsi del debito in sofferenza.
Nei confronti delle banche, l’azienda debitrice ha interesse a esplorare soluzioni negoziali per evitare l’azione giudiziale. Spesso si possono concordare piani di rientro del debito, ad esempio trasformando lo scoperto di conto in mutuo a medio termine, o rinegoziando la durata del mutuo esistente per abbassare la rata. Se l’impresa ha più istituti finanziatori, può essere opportuno cercare un accordo collettivo di ristrutturazione dei debiti finanziari (magari nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, come vedremo). Da notare che la presenza di più banche creditrici a volte rende complessa la trattativa (ciascuna tenderà a tutelare la propria posizione), ed è in queste situazioni che gli strumenti concorsuali formali (accordi omologati o concordati) possono risultare necessari per imporre un trattamento uniforme.
Debiti verso il personale dipendente
Infine, un’impresa in difficoltà può trovarsi nell’impossibilità di pagare regolarmente gli stipendi e gli altri crediti dei dipendenti (es. trattamento di fine rapporto, straordinari, ferie maturate, rimborsi). Questi debiti hanno alcune particolarità:
- I crediti di lavoro dipendente sono assistiti da privilegio generale mobiliare e in parte da privilegio speciale (es. TFR garantito da fondo INPS) sui beni dell’impresa, il che significa che in caso di procedure concorsuali essi vengono soddisfatti con precedenza sui crediti chirografari.
- I lavoratori possono ottenere decreti ingiuntivi per salari non pagati ed eventualmente agire esecutivamente, ma spesso la tutela concreta dei dipendenti passa per strumenti come l’insinuazione al passivo in fallimento o l’accesso al Fondo di Garanzia INPS (che copre TFR e ultime mensilità entro massimali, se l’azienda fallisce).
- La presenza di arretrati retributivi crea gravissimi problemi operativi: i dipendenti potrebbero astenersi dalla prestazione (scioperi per salario), oppure dimettersi se possibile. Inoltre l’imprenditore rischia denunce penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assicurative relative a quegli stipendi (aspetto già accennato) e, in caso di mancato pagamento delle ultime tre mensilità prima di una procedura concorsuale, potrebbe configurarsi il reato di mancata corresponsione di retribuzioni (L. 18/2020).
- Nei piani di risanamento o concordati, i debiti verso i dipendenti devono essere generalmente soddisfatti integralmente (almeno nei limiti coperti dal privilegio) per poter ottenere l’approvazione. Ad esempio, in concordato preventivo i lavoratori votano in classe separata e beneficiano di trattamento di favore. Inoltre, una crisi aziendale che coinvolga lavoratori richiede spesso la gestione degli esuberi con accordi sindacali o l’intervento di ammortizzatori sociali (es. Cassa Integrazione Straordinaria in caso di concordato in continuità).
In sintesi, tutte le tipologie di debito – fiscali, contributivi, finanziari e commerciali – concorrono a definire lo stato di crisi di un’azienda. Un piano di difesa efficace deve mappare l’ammontare e la natura di ogni debito, perché ciascuno ha implicazioni legali diverse (priorità di pagamento, possibilità di stralcio, rischi di azioni esecutive differenti). Nei paragrafi successivi vedremo come il nostro ordinamento offre strumenti di composizione della crisi per affrontare in modo organico l’insieme dei debiti, cercando di evitare il collasso dell’impresa o perlomeno gestendolo in modo ordinato.
Strategie difensive extragiudiziali
Le prime mosse per un’azienda indebitata spesso si giocano fuori dalle aule di tribunale. Le strategie extragiudiziali mirano ad ottenere accordi o dilazioni con i creditori, evitando – o quantomeno posticipando – procedure concorsuali formali. È sempre consigliabile tentare queste vie nei primi stadi della crisi, quando l’insolvenza non è ancora conclamata e si può ancora trattare da una posizione negoziale relativamente forte.
Rateizzazioni di debiti fiscali e contributivi
Come accennato, il nostro ordinamento consente piani di rateazione per i debiti fiscali e previdenziali, che possono essere attivati con relativa facilità se si rispettano certe condizioni. Far ricorso alla rateazione prima che il debito diventi oggetto di azioni esecutive è fondamentale. Ad esempio, l’azienda può presentare istanza all’Agenzia Entrate-Riscossione per dilazionare le cartelle: fino a €120.000 di debito è concessa di diritto una rateazione ordinaria in 72 rate; per importi superiori occorre provare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ma in genere l’ente concede ugualmente piani di rientro strutturati (anche con garanzie aggiuntive se il debito è molto elevato). Analogamente, l’INPS può accordare piani di dilazione sui contributi dovuti.
Vantaggi: la rateazione blocca le azioni esecutive per i debiti inclusi nel piano (l’Agente della Riscossione sospende i pignoramenti una volta concesso il piano e finché le rate sono pagate regolarmente) e permette all’impresa di pianificare i flussi di cassa. Inoltre, come già detto, un piano di rateazione attivo consente il rilascio del DURC regolare, rimuovendo un grave ostacolo operativo. Sul piano strategico, impegnarsi in un pagamento dilazionato può migliorare la percezione di affidabilità dell’impresa verso altri creditori (dimostrando la volontà di pagare).
Svantaggi e cautele: la rateazione fiscale/contributiva implica comunque il pagamento integrale (salvo riduzioni di sanzioni in alcune definizioni agevolate) del dovuto, più interessi dilatori. Se la crisi è molto grave, un piano di rate da solo potrebbe non essere sostenibile. Inoltre, se l’azienda decade dalla rateazione (ad esempio saltando più di 5 rate anche non consecutive nel piano con Agente Riscossione), perde i benefici e gli importi residui tornano immediatamente riscuotibili in un’unica soluzione . La Cassazione ha chiarito che la concessione di una rateizzazione non estingue né “congela” il debito ai fini del conteggio complessivo dell’insolvenza: se l’impresa ha debiti fiscali dilazionati che comunque superano la soglia di rilevanza (€30.000), resta possibile aprire una procedura concorsuale . Ciò significa che la rateazione è utile ma non sufficiente, da sola, a evitare le conseguenze legali più estreme in caso di crisi profonda.
Va ricordato che periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi (ad esempio “rottamazione delle cartelle” o “saldo e stralcio”). Nel 2023, ad esempio, molte imprese hanno aderito alla c.d. rottamazione-quater, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni e interessi di mora sulle cartelle 2000-2017. Queste opportunità vanno tenute sotto controllo, perché possono alleggerire significativamente la posizione debitoria. Tuttavia, finché la legge non le prevede, il debitore non può pretenderle unilateralmente: se non ci sono misure straordinarie attive, l’unica via di alleggerimento dei debiti verso l’Erario/INPS è negoziare nell’ambito di strumenti concorsuali (transazione fiscale, vedi oltre) o confidare in uno stralcio parziale nel concordato.
Accordi stragiudiziali con creditori privati (fornitori, banche)
Oltre al Fisco, un’azienda in crisi deve confrontarsi con i creditori privati – tipicamente fornitori e banche – per evitare azioni legali e cercare soluzioni di rientro sostenibili. Le strade extragiudiziali possibili includono:
- Piani di rientro rateali: Si tratta di accordi in cui l’impresa debitrice si impegna a pagare il dovuto in più tranche, spesso entro un orizzonte di 6-12 mesi, a volte anche 24. È un accordo informale (o formalizzato in scrittura privata) tra debitore e singolo creditore. Può essere accompagnato da garanzie reali o personali aggiuntive per rassicurare il creditore. Dal lato del debitore, è cruciale prevedere un piano realistico: offrire rate sostenibili e magari prevedere che in caso di pagamento puntuale il creditore rinunci a parte degli interessi di mora maturati. Un piano di rientro sottoscritto costituisce un riconoscimento di debito (interrompendo la prescrizione) e se autenticato in certe forme può valere come titolo esecutivo (ad esempio, accordo stipulato per atto di notaio).
- Transazioni a saldo e stralcio: Se il debito non è integralmente pagabile, si può proporre al creditore un pagamento parziale immediato (o in breve tempo) in cambio dell’esenzione del resto. Ad esempio, offrire al fornitore il pagamento del 50% del suo credito entro 30 giorni a saldo e stralcio definitivo. Questo strumento è spesso efficace con i creditori chirografari, specie se capiscono che l’alternativa potrebbe essere il default dell’azienda e il loro incasso in fallimento sarebbe minore. Anche le banche, in presenza di posizioni ormai deteriorate (non-performing loans), possono accettare stralci significativi, a volte preferendo incassare subito una percentuale piuttosto che avviare lunghe azioni legali dall’esito incerto. Va però considerato che il pagamento parziale di un creditore può esporre l’azienda al rischio di azioni revocatorie fallimentari nei successivi due anni, se poi si dovesse fallire (perché quel creditore ha ricevuto un trattamento preferenziale rispetto agli altri). Quindi le transazioni devono essere parte di un disegno complessivo di risanamento, non favoritismi isolati.
- Rinegoziazione dei debiti bancari: Con le banche è possibile rinegoziare tassi e piani di ammortamento. Ad esempio, se l’azienda non riesce a sostenere la rata di mutuo, può chiedere una moratoria temporanea (sospensione delle rate per 6-12 mesi) oppure un “piano di ristrutturazione” del mutuo allungandone la durata per ridurre la singola rata. In certi casi le banche concedono queste modifiche, specie se l’alternativa è vedere il cliente fallire (nel qual caso la banca dovrebbe insinuarsi al passivo con tempistiche lunghe e possibile perdita di capitale). Esistono anche accordi interbancari, come il “Accordo per il credito” promosso dall’ABI, che periodicamente offre alle PMI in difficoltà la possibilità di richiedere il congelamento o l’allungamento dei finanziamenti.
- Accordi globali multilaterali: Se l’impresa ha molti creditori, può tentare un accordo plurilaterale, cioè far sedere attorno a un tavolo (fisico o virtuale) tutti i principali creditori per concordare una manovra unitaria (es. tutti accettano una riduzione del 30% dei rispettivi crediti, o attendono un piano di pagamento in 5 anni senza azioni esecutive). Questo è molto difficile da realizzare in via puramente privata, perché basta un piccolo creditore dissenziente per far saltare l’accordo. Tuttavia, i casi di successo spesso vedono l’intervento di un advisor finanziario o legale che predispone un piano industriale di rilancio e lo sottopone ai creditori chiedendo di aderire. In tale contesto, la minaccia implicita è: “se non accettate, l’alternativa è il concordato preventivo o la liquidazione, dove potreste prendere di meno”. Una volta che una percentuale consistente di creditori accetta, vi può essere un effetto traino sugli indecisi. Resta ferma però la regola che un accordo stragiudiziale ha efficacia solo tra chi vi aderisce: il creditore che rimane fuori conserva intatti i suoi diritti e può agire per conto proprio.
Pro e contro delle soluzioni extragiudiziali: Il vantaggio principale è la rapidità e riservatezza: si evita la pubblicità di una procedura concorsuale e si può mantenere il controllo totale della gestione. Inoltre si risparmiano i costi procedurali e si può modulare creativamente ogni accordo secondo le esigenze (cosa che nelle procedure formali, più rigide, è meno flessibile). Di contro, le soluzioni private soffrono di un problema di stabilità: un singolo creditore può, in qualsiasi momento, sottrarsi all’accordo e agire individualmente (a meno che l’accordo non sia munito di qualche garanzia o condizione risolutiva). Inoltre, accordi multipli separati rischiano di creare disparità di trattamento che, come detto, potrebbero sfociare in azioni revocatorie se più tardi si aprisse un fallimento (ogni pagamento preferenziale entro l’anno prima del fallimento è a rischio revoca, due anni se verso parti correlate o se a saldo e stralcio). Per questo motivo, quando l’indebitamento è diffuso tra tanti creditori e non tutti appaiono collaborativi, conviene valutare il passaggio a strumenti concorsuali che impongano un trattamento uniforme a tutti (come il concordato preventivo o gli accordi omologati), evitando così che qualche creditore “fuori dal coro” rovini gli sforzi di risanamento.
Strumenti giudiziali di gestione della crisi d’impresa
Quando la crisi non può essere risolta con le sole trattative private, occorre fare ricorso agli strumenti giuridici formali previsti dal Codice della Crisi. Essi comprendono sia procedure di regolazione concordata (accordi omologati e concordati preventivi) sia la procedura liquidatoria (liquidazione giudiziale). L’accesso a questi strumenti comporta l’intervento del tribunale e produce effetti legali molto incisivi (sospensione dei pagamenti, congelamento dei debiti, ecc.), ma al contempo offre il vantaggio di poter vincolare anche i creditori dissenzienti a una soluzione collettiva.
Prima di analizzare le singole procedure, menzioniamo un istituto ibrido:
Piani attestati di risanamento
Un istituto particolare, a metà strada tra il piano extragiudiziale e lo strumento legale, è il piano attestato di risanamento disciplinato dall’art. 56 CCII (già art. 67 L.Fall.). Si tratta di un piano predisposto dall’imprenditore per il risanamento dell’azienda, asseverato da un professionista indipendente (attestatore) che ne certifica l’attendibilità e la ragionevole capacità di rimediare alla crisi. Il piano attestato non richiede l’approvazione del tribunale né dei creditori: è un accordo unilaterale o plurilaterale formalizzato in un documento, che l’azienda può decidere di pubblicare presso il Registro delle Imprese per ottenere alcuni effetti protettivi.
Caratteristiche principali: Il piano attestato contiene la descrizione delle cause della crisi, le strategie di rilancio (es. ristrutturazione del debito, aumento di capitale, dismissioni di asset, riorganizzazione operativa) e le previsioni economico-finanziarie conseguenti. L’attestatore, soggetto terzo come un commercialista o revisore esperto in crisi, deve dichiarare che il piano è idoneo a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e a assicurare l’equilibrio finanziario. L’effetto legale principale è che gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato (pagamenti, garanzie concesse, cessioni di beni) sono esenti da azione revocatoria fallimentare in caso di successiva insolvenza . Ciò dà ai terzi contraenti (creditori ristrutturati, nuovi finanziatori) maggiore sicurezza nel trattare con l’azienda in crisi.
Limiti: Poiché non coinvolge il tribunale né vincola i creditori dissenzienti, il piano attestato funziona solo se tutti i principali creditori sono consensualmente soddisfatti o comunque nessuno agisce per vie legali. In pratica, l’impresa utilizza il piano attestato in situazioni non ancora di insolvenza conclamata, dove si riesce a trovare un consenso informale molto ampio. Il piano attestato è quindi indicato per crisi reversibili e relativamente semplici da gestire in privato (ad es. pochi creditori, magari uno principale come una banca che concorda una ristrutturazione del proprio credito). Se invece l’esposizione debitoria è polverizzata tra molti soggetti o vi sono creditori non collaborativi, il piano attestato rischia di non bastare.
Negli ultimi correttivi normativi, il legislatore ha richiesto che il piano attestato tenga conto anche di alcuni obblighi, ad esempio i costi relativi alla sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori (questo per evitare piani che risanino i conti a scapito dei diritti dei dipendenti) . Rimane comunque uno strumento di natura privatistica. Spesso il piano attestato viene utilizzato come base preparatoria: se fallisce, l’azienda può ripiegare su strumenti più incisivi come il concordato preventivo.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) sono strumenti regolati dal CCII (artt. 57-64) che prevedono un accordo giuridico tra l’imprenditore e una parte significativa dei creditori, con l’avallo del tribunale. A differenza del piano attestato, qui è richiesto il consenso di una percentuale minima di creditori e l’omologazione da parte del tribunale, rendendo l’accordo efficace anche verso eventuali creditori non aderenti (nei limiti di legge).
Accordo ordinario (art. 57 CCII): occorre l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali dell’impresa . I creditori aderenti sottoscrivono l’accordo accettando l’eventuale riduzione o dilazione dei propri crediti secondo i termini concordati (ad es. pagamento del 80% in 5 anni, ecc.). I creditori non aderenti restano estranei all’accordo, il che significa che l’azienda deve comunque pagarli integralmente alle scadenze originarie (salvo diversi accordi individuali) – non subiscono stralci contro la loro volontà. Tuttavia, l’omologazione da parte del tribunale comporta alcuni effetti protettivi: ad esempio, sospende o vieta azioni esecutive individuali finché l’accordo è in esecuzione e consente al debitore di ottenere nuovi finanziamenti prededucibili.
Accordi ad efficacia estesa e agevolati: Il CCII prevede varianti come l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61) per i debiti finanziari: se almeno il 75% dei crediti di una certa categoria (tipicamente banche) aderisce, l’accordo può essere esteso anche ai dissenzienti di quella categoria, con autorizzazione del tribunale. Ciò supera la regola della unanimità nel settore bancario, evitando che un singolo istituto holdout blocchi l’operazione. C’è poi l’accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60) in cui è sufficiente il consenso del 30% dei crediti, ma in tal caso l’accordo produce effetti solo dopo l’omologazione (nel frattempo il debitore può chiedere misure protettive). L’idea dell’accordo agevolato è favorire una trattativa in cui anche una minoranza qualificata di creditori possa dare avvio a un processo di omologazione, stimolando gli altri ad adeguarsi.
Transazione fiscale negli accordi: Un elemento cruciale è che l’accordo di ristrutturazione può includere la transazione con il Fisco e gli enti previdenziali, cioè la proposta di pagare parzialmente o in forma dilazionata i tributi e contributi. Fino al 2022 l’adesione dell’Erario era discrezionale e spesso complicava il raggiungimento del 60%. Con i correttivi, è stato chiarito che anche il debito fiscale può essere trattato nell’accordo e omologato dal tribunale anche senza adesione formale dell’ente, purché siano rispettate certe condizioni di soddisfacimento minimo. In particolare, per ottenere l’omologazione forzata di un accordo non approvato dall’Erario (c.d. cram-down fiscale), occorre assicurare che il pagamento offerto al Fisco non sia inferiore al 50% del credito al netto di sanzioni e interessi, fermo il pagamento integrale degli interessi legali di dilazione; tale soglia sale al 60% se i creditori privati aderenti sono meno del 25% del totale crediti . Inoltre, il piano deve offrire al creditore pubblico un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (principio generale di convenienza). Queste soglie, introdotte dal D.Lgs. 136/2024, garantiscono che la transazione fiscale negli accordi avvenga solo entro limiti accettabili per l’Erario.
Vantaggi degli ARD: rispetto al concordato, l’accordo di ristrutturazione è una procedura più snella: non c’è il voto di tutti i creditori, ma solo l’adesione volontaria di alcuni; l’impresa rimane in bonis (non perde l’amministrazione dei beni) e l’intera vicenda può restare relativamente riservata (sebbene l’omologazione sia pubblica). È un ottimo strumento quando si ha già il consenso della maggioranza dei creditori e si vuole cristallizzare tale accordo, impedendo azioni dei dissenzienti durante l’esecuzione del piano. Inoltre può essere utilizzato in modo mirato, ad esempio accordo con sole banche ad efficacia estesa, lasciando fuori i piccoli fornitori che verranno pagati a parte.
Limiti: raggiungere il 60% di adesioni non è semplice se i creditori sono molti e variegati. Per questo, spesso l’accordo di ristrutturazione viene combinato con la composizione negoziata (che aiuta a negoziare protetti) o come esito di un piano attestato che ha già raccolto supporto. I creditori non aderenti restano un problema: se rappresentano più del 40% del debito, l’accordo non è fattibile; ma anche se fossero pochi, bisogna comunque disporre delle risorse per soddisfarli fuori accordo. Infine, l’accordo di ristrutturazione non consente di modificare unilateralmente i diritti dei creditori privilegiati senza il loro consenso integrale: questi vanno pagati per intero, salvo diverso accordo (a differenza del concordato, dove è possibile degradare i privilegi in parte).
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è probabilmente lo strumento concorsuale più noto e complesso, destinato a risolvere la crisi quando l’accordo extragiudiziale o l’ARD non sono percorribili. Si tratta di una procedura giudiziale vera e propria, in cui l’imprenditore propone ai creditori un piano di regolazione della crisi soggetto al voto di questi ultimi e all’approvazione del tribunale. Il concordato ha subìto diverse modifiche con il CCII, ma mantiene i tratti essenziali: è un “contratto” tra debitore e creditori, mediato dal tribunale, che consente di superare l’insolvenza evitando la liquidazione giudiziale.
Tipologie di concordato: Il CCII distingue principalmente due categorie di concordato preventivo:
- il concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII), in cui l’impresa, pur ristrutturata, prosegue l’attività (direttamente o tramite un soggetto terzo che subentra, ad es. con affitto o cessione d’azienda in esercizio). In tal caso l’obiettivo è conservare i valori produttivi e i posti di lavoro. Il piano può prevedere che i creditori vengano soddisfatti col ricavato della continuità (utili futuri, vendita di beni non strategici, ecc.), eventualmente in più esercizi.
- il concordato liquidatorio (art. 85 CCII), in cui invece l’impresa cessa l’attività e mette a disposizione il proprio patrimonio per una liquidazione controllata a beneficio dei creditori. È simile a un fallimento pilotato, ma con la differenza che è il debitore a proporre come distribuire il ricavato e può condizionare l’esito (spesso apportando risorse esterne per aumentare il soddisfacimento dei creditori, ad esempio tramite un assuntore).
Nel concordato i creditori votano suddivisi in classi (quando previsto): classi di crediti con posizione giuridica ed economica omogenea. Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (nel concordato con classi, la maggioranza in valore di ogni classe e almeno la metà +1 delle classi, salvo cram-down come sotto) per approvare la proposta. Se approvata e omologata dal tribunale, il concordato preventivo diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti (salvo alcune eccezioni per crediti con privilegio speciale che non abbiano alterato il loro diritto).
Contenuto della proposta: La legge richiede che la proposta di concordato assicuri un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (principio della convenienza). Inoltre, nel concordato liquidatorio puro, è richiesto un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo, a meno che non si paghi almeno il 20% ai chirografari (requisito introdotto per disincentivare concordati liquidatori “troppo poveri”). Nel concordato in continuità, invece, è permesso falcidiare i crediti con privilegio (es. garantiti da ipoteca) purché i creditori privilegiati ricevano almeno quanto otterrebbero liquidando le garanzie (viene cioè introdotta la possibilità di degradare in parte i privilegi se ciò è giustificato e la continuità offre migliore soddisfazione). Per i crediti fiscali e previdenziali, la legge prevede la possibilità di trattamento falcidiato solo entro i limiti della transazione fiscale: in pratica, IVA e ritenute non possono essere falcidiate nel concordato se non attraverso l’adesione dell’ente o il cram-down con le percentuali minime sopra viste .
Iter procedurale: L’imprenditore può presentare direttamente la proposta di concordato con il piano e la documentazione necessaria (bilanci, elenco creditori, relazione dell’attestatore indipendente ex art. 87 CCII). Oppure può presentare un ricorso “con riserva” (concordato prenotativo) depositando i soli bilanci e riservandosi di presentare il piano entro 60-120 giorni. Ricevuta l’istanza, il tribunale verifica i requisiti di ammissibilità (ad esempio, assenza di condanne per bancarotta fraudolenta a carico degli amministratori, rispetto delle soglie di fallibilità se impresa minore, ecc.) e concede le misure protettive (automatic stay delle azioni esecutive dei creditori). Viene nominato un commissario giudiziale che vigila sull’impresa durante la procedura. I creditori vengono invitati a depositare le loro prove del credito e il tribunale indice un’udienza di adunanza dei creditori per il voto (oggi spesso espletato in forma telematica o con voto anticipato scritto). Se il piano raggiunge le maggioranze richieste, si passa all’omologazione; in caso contrario, il tribunale dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale).
Cram-down e omologazione forzata: Con le novità introdotte dal 2022-2024, è ora possibile omologare un concordato preventivo anche in caso di voto contrario di una o più classi di creditori (cross-class cram-down). Il tribunale può cioè approvare d’ufficio il concordato nonostante il dissenso di classi dissenzienti, purché ritenga la proposta globalmente conveniente e conforme alla legge, e vi sia almeno un’altra classe di creditori non garantiti che abbia votato a favore . Restano comunque esclusi i casi in cui la classe dissenziente sia l’unica ad essere pregiudicata (non si può imporre l’unanimità a una sola classe di creditori senza loro consenso). Questo avvicina il concordato italiano ai modelli internazionali di ristrutturazione forzata previsti dalla normativa UE.
Esiti del concordato: Se omologato, il concordato viene eseguito sotto la vigilanza del commissario o di un liquidatore (nel caso liquidatorio). I creditori ricevono quanto previsto dal piano (in denaro o altri attivi come azioni/quote se è un concordato con ristrutturazione societaria) e alla fine il debitore ottiene l’esdebitazione residua, cioè la liberazione dai debiti pregressi non soddisfatti, salvo eccezioni di legge. Se invece il concordato non viene eseguito correttamente, i creditori possono chiederne la risoluzione e a quel punto normalmente segue la liquidazione giudiziale.
Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio
Una novità introdotta nel 2021 e resa strutturale con i correttivi del CCII è il cosiddetto concordato semplificato (art. 25-sexies CCII). Questo strumento è riservato all’ipotesi in cui l’imprenditore abbia tentato la composizione negoziata della crisi senza riuscire a concludere accordi con i creditori. In tal caso, per evitare di vanificare il lavoro svolto, la legge consente al debitore di proporre direttamente un concordato liquidatorio “semplificato”, senza passare per il voto dei creditori. In pratica, l’imprenditore deposita un piano che prevede la mera liquidazione del patrimonio sotto controllo del tribunale (analogamente a un fallimento) ma con una proposta di riparto ai creditori, e chiede al tribunale di omologarlo anche senza il loro consenso. Il tribunale, sentiti i creditori e verificati i presupposti (soprattutto che dalla composizione negoziata non sia emerso un migliore accordo per i creditori), può omologare questo concordato anche in assenza di voto. Si tratta di una soluzione di chiusura rapida e semplificata della crisi: i creditori di fatto subiscono la liquidazione ma con la garanzia di un controllo giudiziario e di criteri di distribuzione equi proposti dal debitore e valutati dal giudice. Il concordato semplificato è esente da azioni revocatorie sui pagamenti effettuati nel suo ambito , per favorire la liquidazione celere dei beni. Questo strumento è di ultima istanza, da usare solo se fallisce ogni altra trattativa.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Se tutte le opzioni di risanamento falliscono, o se si arriva troppo tardi quando l’insolvenza è irreversibile e aggravata, l’epilogo è la liquidazione giudiziale – l’equivalente di ciò che prima si chiamava fallimento. La liquidazione giudiziale viene aperta dal tribunale su ricorso del debitore stesso, di creditori o su iniziativa del Pubblico Ministero, quando l’impresa si trova in stato di insolvenza attuale. Ricordiamo che per le imprese di piccole dimensioni valgono le soglie di non fallibilità già viste (attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) e la soglia generale di debiti scaduti > €30.000 . Se tali limiti non sono superati, non si può aprire la procedura (restano possibili solo le procedure di sovraindebitamento, come il concordato minore o la liquidazione controllata, destinate a piccoli debitori non fallibili).
Effetti della liquidazione: Con la sentenza dichiarativa, l’imprenditore viene spossessato dell’azienda: il tribunale nomina un curatore che amministra i beni, e un giudice delegato sovrintende la procedura. I creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo; il curatore forma lo stato passivo che viene esaminato in udienza e approvato (insinuazione dei crediti). Segue la liquidazione di tutti i beni dell’impresa (vendite all’asta o assegnazioni) e infine la distribuzione del ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. L’impresa di fatto cessa di esistere come attività: la procedura punta solo a convertire ogni asset in denaro per pagare i creditori, salvo eventuali esercizi provvisori autorizzati dal tribunale per vendere l’azienda intera o completare commesse in corso.
Responsabilità degli amministratori: L’apertura della liquidazione giudiziale spesso porta con sé azioni di responsabilità del curatore verso gli amministratori e i soci (se hanno abusato della società). Ad esempio, il curatore può agire contro gli amministratori per atti di mala gestio che hanno aggravato il dissesto (si pensi alla prosecuzione temeraria dell’attività in perdita): in base all’art. 2486 c.c., come modificato dal Codice della crisi, il danno causato dall’amministratore che ha violato i doveri di conservazione del patrimonio sociale in presenza di una causa di scioglimento è liquidato in via equitativa nella differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si sarebbe dovuto liquidare la società e quello alla data dell’apertura della liquidazione . Inoltre, eventuali atti anomali compiuti prima del fallimento (pagamenti preferenziali, distrazioni di beni, false comunicazioni) possono portare a responsabilità penali (bancarotta semplice o fraudolenta).
Esdebitazione: Una volta chiusa la liquidazione giudiziale, se il patrimonio non è bastato a pagare tutti i creditori, il debitore persona fisica (ad esempio un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) può chiedere l’esdebitazione delle residue posizioni debitorie insoddisfatte. È il beneficio della liberazione dai debiti, accordato dal tribunale a chi ha cooperato nella procedura e non ha commesso atti di frode. Nel nuovo Codice, l’esdebitazione per il debitore meritevole può essere concessa anche immediatamente a chi non ha distribuzione di attivo (c.d. esdebitazione di diritto), e per le società di capitali, pur non essendo necessaria (la società estinta cessa di esistere, quindi i debiti residuali sono inesigibili), rileva per i coobbligati e fideiussori societari. L’esdebitazione segna l’ultimo step di una crisi: permette al fallito onesto di ripartire senza l’handicap dei vecchi debiti (fresh start).
Per completezza, ricordiamo che per i debitori non fallibili (ad esempio, imprese minori sotto soglia che non raggiungono i requisiti dimensionali, o persone fisiche consumatrici) esistono procedure analoghe nell’ambito del sovraindebitamento: ad esempio il concordato minore (simile al concordato preventivo ma destinato ai piccoli debitori non fallibili) e la liquidazione controllata (liquidazione dei beni su istanza del debitore o creditori minori, erede della liquidazione ex L.3/2012) destinate ai sovraindebitati. Queste procedure hanno logiche simili ma adattate alla scala ridotta e alla diversa natura dei soggetti (si pensi al consumatore sovraindebitato). Nel contesto di una società di pavimentazioni industriali, però, tipicamente parliamo di attività imprenditoriali soggette alle procedure maggiori descritte sopra.
Responsabilità di amministratori, soci e garanti dell’azienda debitrice
Un aspetto delicato, per chi gestisce un’azienda indebitata, è capire in quali casi amministratori, soci o garanti possano essere chiamati a rispondere dei debiti dell’impresa con il proprio patrimonio personale. La regola generale, nelle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), è la separazione patrimoniale: la società risponde soltanto con i propri beni delle obbligazioni contratte, e i soci rischiano al massimo il capitale versato. Tuttavia, esistono importanti eccezioni e situazioni particolari in cui amministratori o soci possono subire conseguenze patrimoniali dirette. Vediamole distintamente.
Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): autonomia patrimoniale e sue eccezioni
In una S.r.l. o S.p.A., i soci godono di responsabilità limitata: non rispondono dei debiti sociali oltre la quota sottoscritta. Ciò significa che se l’azienda fallisce, i creditori sociali non possono chiedere ai soci il pagamento dei crediti residui. Anche gli amministratori non sono personalmente debitori verso i creditori sociali per il solo fatto di ricoprire la carica. Tuttavia, vi sono ipotesi specifiche in cui questa schermatura salta:
- Fideiussioni e garanzie personali: La situazione più comune è quella contrattuale: molti soci o amministratori rilasciano garanzie personali (fideiussioni, avalli) a favore di banche o fornitori strategici per ottenere credito alla società. In tal caso, se l’azienda non paga, il creditore può escutere direttamente il garante, a prescindere dalla forma societaria. Questo non è un “obbligo di legge” ma una scelta negoziale: chi ha firmato la fideiussione risponde con il proprio patrimonio secondo i termini del contratto di garanzia.
- Responsabilità per mala gestio (azione di responsabilità): Se gli amministratori hanno violato i loro doveri gestionali causando danni alla società o ai creditori, possono essere citati in giudizio. Ad esempio, nel fallimento, il curatore spesso promuove l’azione di responsabilità ex art. 146 L.Fall. (oggi art. 255 CCII) contro gli amministratori per atti di mala amministrazione. Come visto, uno degli addebiti tipici è la prosecuzione illegittima dell’attività in perdita aggravando il passivo: in questi casi i giudici calcolano il danno confrontando il patrimonio netto quando si doveva cessare l’attività e quello al fallimento, imputando la differenza agli amministratori . Anche soci di controllo o amministratori di fatto che abbiano diretto la società in modo imprudente possono essere chiamati a rispondere in solido dei danni.
- Violazione di obblighi patrimoniali specifici: La legge prevede alcune ipotesi in cui amministratori e soci sono responsabili verso creditori particolari. Un caso è l’obbligo di conservare l’integrità del capitale sociale: se, a causa di perdite, il capitale si riduce sotto il minimo legale, gli amministratori devono o ripianarlo o liquidare la società (artt. 2482-bis e 2484 c.c.). In caso di inerzia, i creditori sociali danneggiati potrebbero rivalersi sugli amministratori. Ancora, i soci che deliberino distribuzioni illegittime di utili o patrimoni sociali (art. 2476 c.c.) ne rispondono personalmente, dovendo restituire quanto ricevuto se ciò pregiudica la solvibilità verso i creditori.
- Responsabilità fiscale e contributiva ex art. 36 DPR 602/1973: Questa norma importante stabilisce che, in fase di liquidazione della società, i liquidatori sono personalmente tenuti a pagare prima i debiti tributari e contributivi, prima di soddisfare altri creditori o di distribuire attivi ai soci. Se violano quest’obbligo (cioè pagano altri lasciando impagate imposte o contributi, o assegnano beni ai soci senza saldare il Fisco), i liquidatori rispondono in proprio dei debiti tributari non pagati. La stessa norma prevede responsabilità per gli amministratori che, pur in presenza di cause di scioglimento, non abbiano provveduto alla messa in liquidazione della società e abbiano compiuto operazioni pregiudizievoli (ad esempio svuotando l’azienda di beni), e per i soci che abbiano ricevuto nell’ultimo biennio somme o beni dalla società poi fallita/liquidata. In sostanza, è una responsabilità sussidiaria: non rende automaticamente soci e amministratori coobbligati per i debiti fiscali, ma li colpisce se hanno concorso a far sì che l’Erario rimanesse insoddisfatto, beneficiando di atti di liquidazione in loro favore .
- Presunzione di distribuzione utili occulti: In alcune circostanze, specialmente per società a ristretta base (pochi soci), il Fisco presume che utili non dichiarati o beni sociali usciti irregolarmente siano andati ai soci. Così, se una società di capitali viene cancellata dal Registro Imprese lasciando debiti tributari, l’Agenzia delle Entrate spesso notifica avvisi ai soci, ritenendoli successori nei debiti fino a concorrenza di quanto incassato. La Cassazione inizialmente inclinava a vedere i soci come successori universali delle società estinte (in base all’art. 2495 c.c.), ma gli orientamenti più recenti (anche a Sezioni Unite) sono più garantisti verso i soci: hanno stabilito che il Fisco può agire contro l’ex socio solo se prova che questi ha percepito attivi dalla liquidazione, e comunque deve notificargli un atto impositivo specifico (non basta la cartella intestata alla società) . In altre parole, niente responsabilità “automatica” solo perché si era soci: occorre un concreto arricchimento indebito a danno del Fisco, provato e contestato ritualmente. Ad esempio, nell’ordinanza Cass. 20840/2023 la Suprema Corte ha ritenuto responsabili quattro ex soci di una S.r.l. a ristretta base per debiti IVA non versati, ma in quanto dagli elementi emersi (operazioni antieconomiche e occultamento di utili) risultava che di fatto essi avevano beneficiato degli utili sottratti al Fisco . Viceversa, la più recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3625/2025 ha escluso pretese automatiche: l’Agenzia non può semplicemente usare la visura camerale per chiedere ai soci i debiti sociali, ma deve emettere un nuovo avviso di accertamento verso ciascun socio individuando somme o beni da questi ricevuti .
- Reati fiscali e fallimentari: Sebbene esulino dalla responsabilità civilistica diretta verso i creditori, va menzionato che gli amministratori possono incorrere in responsabilità penali personali per condotte connesse ai debiti. L’omesso versamento di IVA o ritenute oltre le soglie di punibilità (come detto), ovvero distrazioni di beni a danno dei creditori (bancarotta fraudolenta), false comunicazioni per ottenere credito (truffa, false scritture contabili), sono tutte ipotesi di reato che comportano processi penali a carico degli amministratori (e talora dei soci se partecipi). Ciò non comporta che i creditori possano chiedere loro il pagamento dei debiti, ma certamente sono conseguenze da tenere presenti perché possono influire sulla strategia: ad esempio, regolarizzare il pagamento dell’IVA entro i termini di soglia per evitare la denuncia, o evitare di compiere atti distrattivi che, oltre a danneggiare i creditori, porterebbero a incriminazioni.
Società di persone (S.n.c., S.a.s.) e ditte individuali
Ben diversa è la situazione delle imprese prive di autonomia patrimoniale perfetta. Nelle società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice) tutti o alcuni soci rispondono illimitatamente per i debiti sociali. In una S.n.c. ogni socio ha responsabilità personale sussidiaria: significa che se il patrimonio sociale non è sufficiente a pagare i creditori, questi possono escutere i soci (previa escussione del patrimonio sociale). Nelle S.a.s., i soli soci accomandatari (quelli che amministrano) hanno responsabilità illimitata, mentre gli accomandanti no (rischiano solo il conferimento, a meno che perdano la limitazione ingerendosi nella gestione). Di conseguenza, per i creditori di una società di persone, l’insolvenza dell’azienda si ripercuote automaticamente sui soci illimitatamente responsabili: essi possono subire pignoramenti sui propri beni personali per soddisfare debiti dell’azienda. Non c’è distinzione tra patrimonio dell’impresa e dei soci ai fini sostanziali (anche se procedimentalmente i creditori devono prima aggredire la società).
Nei lavori in proprio (impresa individuale), vale lo stesso principio: l’imprenditore è la stessa persona dei debiti aziendali, quindi risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, delle obbligazioni assunte nell’attività. L’unica protezione parziale introdotta di recente è la possibilità di impignorabilità della casa di abitazione dell’imprenditore individuale se questi l’ha destinata a “patrimonio separato” ex art. 41-bis Codice Civile (cd. vincolo di destinazione d’uso per l’immobile, a certe condizioni) – istituto però poco utilizzato. In generale, chi esercita in forma non societaria non ha “scudo”: una crisi d’impresa coincide con una crisi personale.
Importanza della tempestività e delle buone pratiche
Visti i rischi sopra elencati, si può capire quanto sia importante, per amministratori e soci, agire con tempestività e correttezza nelle situazioni di difficoltà. Ad esempio:
- Adottare subito “adeguati assetti organizzativi” (come richiesto dall’art. 2086 c.c. modificato): sistemi di controllo che segnalino perdite e squilibri finanziari. Ciò aiuta a non ignorare i segnali di allarme e ad attivarsi prima che la situazione precipiti.
- Nel momento in cui emerge una perdita rilevante di capitale, convocare immediatamente l’assemblea e prendere provvedimenti (ricapitalizzazione o liquidazione) per evitare di incorrere in violazioni di legge. Questo tutela gli amministratori da accuse di tardiva reazione.
- Conservare la documentazione contabile e commerciale in modo ordinato: uno degli elementi che aggravano la posizione dell’amministratore nel fallimento è la mancanza di libri e registri, che fa presumere irregolarità (e integra il reato di bancarotta semplice documentale).
- Evitare di favorire alcuni creditori a scapito di altri quando si è in stato di insolvenza conclamata, se non nel quadro di una strategia concordata con consulenti legali: pagare “fuori sacco” un solo creditore in crisi può esporre a revocatoria, oltre che essere indice di potenziale preferenza ingiusta verso quel creditore.
- Valutare l’accesso tempestivo agli strumenti di composizione della crisi (composizione negoziata, accordi, concordato): come evidenziato anche dalle statistiche, muoversi presto aumenta le chance di successo del risanamento e può anche dare accesso a “premialità” di legge (ad esempio, nella composizione negoziata è prevista la riduzione di interessi e sanzioni se si raggiunge un accordo ).
In sintesi, la responsabilità personale di soci e amministratori si può in molti casi evitare rispettando gli obblighi legali e gestionali (diligenza, corretto patrimonio, parità di trattamento dei creditori). Quando però l’impresa ha assunto debiti con garanzie personali o appartiene a forme giuridiche senza schermo (società di persone, ditte individuali), allora la difesa del patrimonio personale diventa parte integrante della strategia di crisi: ciò può comportare scelte come rinegoziare le fideiussioni, valutare soluzioni liquidatorie che liberino i garanti (un concordato che preveda la soddisfazione del creditore garantito, liberando così il fideiussore), o in casi estremi separare il patrimonio personale tramite strumenti leciti (trust, fondi patrimoniali, polizze assicurative sulla vita) prima che la situazione degeneri – tenendo conto però che se fatti in frode ai creditori tali atti potranno essere revocati o considerati nulli.
Domande frequenti (FAQ)
D: La guida vale solo per debiti fiscali e contributivi, o anche per debiti verso fornitori, banche e dipendenti?
R: La trattazione è generale e copre tutte le tipologie di debiti aziendali. Abbiamo infatti esaminato i debiti fiscali e previdenziali (verso Erario e INPS), ma anche i debiti verso fornitori, banche e lavoratori dipendenti. Ognuno di essi presenta peculiarità (ad es. i debiti fiscali comportano sanzioni e privilegi legali, i debiti bancari spesso sono garantiti da fideiussioni, i debiti verso dipendenti godono di privilegi di legge, ecc.), e la guida spiega come affrontarli. Nella realtà, un piano di risanamento efficace deve considerare tutti i debiti insieme, perché strumenti come il concordato o gli accordi di ristrutturazione forniscono soluzioni collettive. Pertanto, questa guida offre indicazioni utili per gestire l’intero spettro dei debiti di un’azienda in crisi.
D: Quando un’azienda può essere dichiarata insolvente dal tribunale (liquidazione giudiziale)?
R: Un’azienda può subire l’apertura di una liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento) se ricorrono due condizioni: (1) è soggetto fallibile (cioè un imprenditore commerciale non piccolo: abbiamo visto i limiti dimensionali di attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k , oltre agli esclusi di legge come imprenditori agricoli); (2) versa in stato d’insolvenza, ossia non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti. Inoltre dev’esserci un ammontare minimo di debiti scaduti > €30.000 . Se queste condizioni sussistono, il tribunale, su ricorso del debitore, di un creditore o del PM, può dichiarare la liquidazione giudiziale. Va sottolineato che l’insolvenza è uno stato attuale di incapacità finanziaria: se l’impresa è solo in temporanea crisi ma sta pagando seppur con sforzo, non dovrebbe essere dichiarata insolvente. In pratica però spesso l’insolvenza si manifesta con inadempimenti protratti verso più creditori, pignoramenti infruttuosi, ecc. Un modo per prevenire la dichiarazione d’insolvenza è attivarsi con strumenti come la composizione negoziata o chiedere il concordato prima che siano i creditori a chiedere il fallimento.
D: Che differenza c’è tra la composizione negoziata e il concordato preventivo?
R: Sono due strumenti molto diversi per scopi e procedura. La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale, nel quale l’imprenditore chiede l’assistenza di un esperto indipendente per negoziare con i creditori. È riservata a situazioni di crisi reversibile (o insolvenza non ancora irreversibile) e mira a trovare un accordo fuori dal tribunale, benché con la possibilità di ottenere dal giudice alcune tutele (come lo stop ai pignoramenti durante le trattative) . Il concordato preventivo, invece, è una procedura concorsuale giudiziale a tutti gli effetti: prevede l’intervento del tribunale, la nomina di un commissario e soprattutto il voto dei creditori su un piano proposto dal debitore. Nel concordato si può imporre una ristrutturazione anche a creditori dissenzienti, cosa non possibile nella composizione negoziata (dove serve l’accordo di ciascun creditore per modificare le sue pretese). In sintesi, la composizione negoziata è uno strumento di assistenza alla negoziazione in extremis, meno formalizzato, adatto se c’è margine di accordo; il concordato è una vera procedura concorsuale che si usa quando serve una soluzione autoritativa e collettiva sotto l’egida del tribunale.
D: L’azienda con troppi debiti può evitare di fallire utilizzando questi strumenti?
R: L’obiettivo di strumenti come accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o composizione negoziata è proprio evitare la fine disordinata dell’impresa (fallimento), trovando soluzioni alternative. Se il piano è credibile e sostenibile finanziariamente, i creditori spesso preferiranno un accordo (anche con sacrifici parziali) piuttosto che il fallimento, dove i tempi di recupero sono lunghi e l’attivo si disperde. Tuttavia, non tutte le aziende si possono salvare: se i debiti superano di gran lunga le capacità di rimborso, e non ci sono investitori o nuovi capitali, può non esserci altra via che la liquidazione. Quindi, la risposta è: sì, è possibile evitare il fallimento se si attiva in tempo un percorso di risanamento serio e se vi è ancora un nucleo di azienda sano (ad esempio commesse in corso, know-how valorizzabile, mercato); diversamente, gli strumenti concorsuali serviranno quantomeno a chiudere la vicenda in modo ordinato (ad es. con un concordato liquidatorio che eviti istanze di fallimento plurime e assegni qualcosa ai creditori) e a limitare i danni (si pensi all’esdebitazione post-fallimento per l’imprenditore individuale meritevole). Dunque, ogni caso è a sé: molti fallimenti si possono prevenire con un intervento tempestivo, altri purtroppo sono inevitabili perché la situazione è compromessa.
D: I fornitori e le banche devono rispettare la moratoria nel piano di composizione negoziata?
R: Nella composizione negoziata, i creditori non sono obbligati per legge a sospendere le azioni o a accettare dilazioni, a meno che il tribunale non emetta misure protettive. Se il debitore richiede e ottiene dal tribunale le misure protettive ex art. 18-19 CCII, allora tutti i creditori (anche quelli che non partecipano alle trattative) sono temporaneamente bloccati: non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e non possono acquisire prelazioni se non concordate . Fuori da questo caso, però, fornitori e banche sono liberi di rifiutare la proposta negoziale e agire comunque. In pratica, all’apertura della composizione negoziata l’imprenditore spesso chiede subito al tribunale la concessione di queste misure di “standstill” per avere un po’ di respiro e poter negoziare senza il fiato sul collo dei pignoramenti. Se concesse, esse vincolano i creditori per la durata stabilita (in genere inizialmente 4 mesi, prorogabili). È bene ricordare che le misure protettive devono essere confermate dal giudice entro 30 giorni, che verifica che la situazione non sia abusiva . Dunque sì, con le dovute formalità i creditori vengono bloccati temporaneamente, ma la loro adesione al piano negoziale resta volontaria.
D: Quali sono i vantaggi della composizione negoziata per il debitore?
R: Oltre a sospendere le azioni esecutive (come sopra), la composizione negoziata offre altri vantaggi: (1) riservatezza – la procedura non è pubblica (salvo la pubblicazione delle misure protettive, ma senza il discredito di un fallimento); (2) flessibilità – non ci sono soluzioni preconfezionate, l’esperto aiuta a trovare accordi su misura (possono includere aumento di capitale, intervento di nuovi investitori, conversione di crediti in quote, ecc.); (3) protezione dagli obblighi societari – durante la composizione l’imprenditore può ottenere la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite e delle cause di scioglimento per perdita capitale , evitando di dover mettere la società in liquidazione formale mentre cerca il risanamento; (4) benefici fiscali – se la composizione negoziata si conclude con successo, la legge premia il debitore con la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti fiscali, la dilazione fino a 10 anni dei tributi dovuti e la non tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti . Tali incentivi rendono la soluzione negoziale ancora più interessante perché, ad esempio, tagliare un debito fiscale del 30% non genera un reddito imponibile (normalmente invece il condono di un debito sarebbe tassato come sopravvenienza attiva). In breve, la composizione negoziata è pensata per dare all’imprenditore un’ultima chance di risanare la propria azienda fuori dalle procedure concorsuali, con l’aiuto di un esperto e con qualche “carota” normativa per facilitare l’accordo.
D: Un concordato preventivo può ridurre i debiti fiscali e contributivi?
R: Sì, ma con limiti stringenti. I debiti tributari e previdenziali nel concordato possono essere falciati o dilazionati solo tramite la cosiddetta transazione fiscale (artt. 63-64 CCII). In sostanza, il piano di concordato deve prevedere il trattamento di tali crediti privilegiati: normalmente, IVA e ritenute non possono essere pagate meno del 100% salvo che l’ente acconsenta (o intervenga il cram-down). Con la riforma 2022-24, se l’Erario o l’INPS rifiutano la proposta, il tribunale può comunque omologare il concordato (cram-down fiscale) a patto che al Fisco sia riconosciuto almeno il 50% del suo credito (sanzioni escluse) e all’INPS lo stesso (per i contributi) . Questa percentuale sale al 60% se i crediti chirografari estranei (non aderenti) rappresentano più del 25% dei crediti totali . Inoltre, va garantito che lo Stato non prenda meno di quanto otterrebbe in caso di fallimento (principio di miglior soddisfacimento). Quindi, in pratica, un concordato può prevedere ad esempio di pagare il 50% dell’IVA e dei contributi e ottenere lo stralcio del resto, ma solo rispettando queste soglie e se il giudice ritiene equo il trattamento. Nella composizione negoziata o negli accordi di ristrutturazione, invece, lo stralcio fiscale è oggetto di libera negoziazione (sempre con il vincolo di un trattamento congruo, ma senza voto formale: è un accordo). In conclusione, il debitore può ridurre i debiti col fisco in concordato, ma non quanto vuole: c’è un “pavimento” normativo per tutelare l’Erario.
D: Se la società viene liquidata, i debiti spariscono? E i garanti?
R: Se parliamo di società di capitali, con la cancellazione della società le obbligazioni non si estinguono ma diventano inesigibili perché il soggetto è estinto. I creditori insoddisfatti potranno tentare azioni verso gli eventuali soci o liquidatori nei casi consentiti (vedi art. 36 DPR 602/73 per debiti fiscali, azione verso soci nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione ex art. 2495 c.c., ecc.). In mancanza di tali presupposti, il debito di fatto non viene pagato da nessuno (il creditore lo dedurrà a perdita). I garanti personali (es. soci fideiussori) invece non sono liberati dalla liquidazione della società: anzi, è proprio nello scenario della liquidazione che il creditore, non potendo più rivalersi sulla società, di solito escute la fideiussione. Dunque, la chiusura della società non libera i garanti, a meno che nell’ambito di un concordato o accordo non si sia previsto espressamente il loro discarico. Ad esempio, se un concordato paga interamente la banca garantita, la fideiussione del socio si estingue perché il debito principale è soddisfatto; oppure, qualche volta i creditori acconsentono a liberare il garante in cambio di un pagamento parziale da parte sua (accordo transattivo sul lato personale). Ma di default, il fallimento o la liquidazione della società lasciano intatti gli obblighi dei coobbligati.
D: Cosa succede ai dipendenti in caso di concordato o fallimento?
R: In caso di concordato preventivo, se è in continuità, l’azienda prosegue e i dipendenti normalmente continuano la loro attività (salvo necessità di riduzione di personale, che andrà gestita con accordi sindacali e autorizzazione del tribunale). I debiti pregressi per stipendi maturati prima del concordato vengono inclusi nel piano e di solito vengono pagati al 100% (grazie al privilegio che li assiste), magari poco dopo l’omologazione, oppure attingendo al Fondo di Garanzia INPS per il TFR e ultime mensilità. Se il concordato è liquidatorio, l’attività cessa e i dipendenti vengono licenziati (con procedura collettiva autorizzata dal tribunale). Potranno insinuarsi al passivo per le spettanze e TFR, e chiedere all’INPS il pagamento tramite Fondo di Garanzia dei loro crediti privilegiati non soddisfatti dalla liquidazione. In caso di fallimento (liquidazione giudiziale), la procedura prevede il blocco dei rapporti di lavoro: il curatore entro 4 mesi decide se subentrarvi o scioglierli. Nella prassi quasi sempre si procede ai licenziamenti collettivi dei dipendenti, salvo si eserciti un temporaneo esercizio provvisorio. I dipendenti licenziati accedono alla NASpI (indennità di disoccupazione) e, come detto, recuperano TFR e arretrati attraverso l’INPS se la massa attiva fallimentare non basta. Da notare che nelle nuove procedure esistono strumenti per attenuare l’impatto sociale: ad esempio, in concordato in continuità l’azienda può accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria per crisi, in modo da sospendere temporaneamente i lavoratori eccedentari in attesa del risanamento o di una cessione.
D: Un piccolo imprenditore (sotto soglia di fallibilità) con debiti cosa può fare?
R: Se l’imprenditore individuale o la società sono sotto le soglie di fallibilità (quelle viste di attivo, ricavi, debiti) e dunque non possono essere dichiarati falliti, restano comunque responsabili verso i creditori con tutti i loro beni, e i creditori possono agire con pignoramenti individuali. Però quel debitore “non fallibile” ha a disposizione le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal CCII: in particolare può proporre un concordato minore (simile al concordato preventivo ma semplificato e senza alcune rigidità, destinato a piccoli imprenditori o anche professionisti) oppure può optare per la liquidazione controllata dei beni (parallela del fallimento per il sovraindebitato) e poi chiedere l’esdebitazione. Inoltre, dal 2023 anche un debitore sotto-soglia può accedere volontariamente alla composizione negoziata semplificata (con percorsi più snelli). Quindi, l’assenza di fallibilità non significa che debba “tenersi i debiti a vita”: può usare queste procedure per trovare accordi o liquidare il poco patrimonio in modo ordinato e poi ripartire pulito. Certo, i creditori in questi casi non possono essere coattivamente obbligati come nel fallimento “maggiore” (nel concordato minore comunque serve l’approvazione dei creditori votanti). In sintesi, il piccolo imprenditore ha strumenti simili, benché su scala ridotta, e non è abbandonato a sé stesso – anzi, il legislatore ha voluto dargli una chance di esdebitazione anche senza passare dal vecchio fallimento.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali strumenti per la gestione della crisi d’impresa (confronto)
| Strumento | Natura & accesso | Condizioni / Quorum | Vincolatività per i creditori | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Percorso extragiudiziale assistito da un esperto indipendente; volontario, riservato. Tribunale coinvolto solo per misure protettive o autorizzazioni. | Impresa in crisi o insolvenza reversibile; nessuna soglia dimensionale (accessibile anche sotto-soglia). Esperto nominato da commissione CCIAA. | Nessun accordo imposto: serve il consenso di ogni creditore per modificare le proprie pretese. Misure protettive disponibili bloccano temporaneamente le azioni di tutti i creditori . | D.L. 118/2021 conv. L.147/2021; artt. 12-25 CCII (Capo I). |
| Piano attestato di risanamento | Accordo extragiudiziale unilaterale o plurilaterale, con attestazione indipendente. Possibilità di pubblicazione al RI. | Nessun quorum di legge: accordi con creditori su base consensuale. Necessaria attestazione sulla fattibilità e idoneità a risanare. | Vincola solo i creditori che aderiscono. Gli atti compiuti in esecuzione del piano sono protetti da revocatoria (se piano pubblicato) . | Art. 56 CCII (già art. 67 L.Fall.). |
| Accordo di ristrutturazione | Procedura concorsuale semplificata: accordo privato con alcuni creditori, sottoposto a omologazione del tribunale. | Adesione di creditori ≥ 60% dei crediti . Possibili varianti: agevolato (≥30%) e ad efficacia estesa (75% banche). Stato di crisi o insolvenza. | Vincola solo aderenti, ma dopo omologazione impedisce azioni individuali contro il debitore. Creditori non aderenti: da pagare per intero salvo cram-down fiscale (50-60%) . | Artt. 57-64 CCII. Varianti: artt. 60 (agevolato), 61 (esteso), 64-bis (PRO). |
| Concordato preventivo | Procedura concorsuale giudiziale con proposta del debitore e voto dei creditori. Gestione sotto controllo del tribunale (commissario, ecc.). | Stato d’insolvenza o crisi. Ammissibilità: requisiti soggettivi fallibilità, debiti scaduti ≥ €30.000 . Approvazione: maggioranza >50% dei crediti votanti (o altre maggioranze per classi). | Vincola tutti i creditori anteriori all’omologazione (dissenzienti compresi), secondo il piano omologato. Possibile cram-down giudiziale su classi dissenzienti (con condizioni di legge) . Debiti fiscali falcidiabili solo in conformità alla transazione fiscale e relative soglie . | Artt. 84-120 CCII (disciplina unit. concordato continuità / liquidatorio). |
| Concordato “semplificato” | Procedura concorsuale senza voto dei creditori, riservata a esito negativo di composizione negoziata. Liquidazione giudiziale semplificata sotto controllo del tribunale. | Ammissibile solo se composizione negoziata non ha prodotto accordi (art. 25-sexies). Piano esclusivamente liquidatorio dei beni. | Vincola tutti i creditori senza necessità di voto. I creditori possono far osservazioni al tribunale, ma la decisione di omologa è giudiziale. Atti e pagamenti nel concordato semplificato non sono soggetti a revocatoria . | Art. 25-sexies CCII (introdotto dal D.L. 118/2021, confermato dal D.Lgs. 83/2022). |
| Liquidazione giudiziale (Fallimento) | Procedura concorsuale di insolvenza avviata dal tribunale su istanza di creditore, debitore o PM. Nomina di un curatore che liquida tutto il patrimonio. | Stato di insolvenza conclamata. Soglie fallibilità: impresa > soglie dimensionali (attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k) e debiti scaduti > €30k . Insussistenza di soluzioni alternative approvate. | Procedura coattiva: i creditori perdono i diritti individuali, vengono soddisfatti in massa secondo prelazioni. La società viene spossessata. Al termine, debitore persona fisica liberato dai debiti con esdebitazione (se meritevole). Garanti e coobbligati restano obbligati. | Artt. 121-270 CCII (sostituiscono Legge Fallimentare). |
Nota: Esistono anche il “concordato minore” e la “liquidazione controllata” per i debitori non fallibili (sovraindebitati), con caratteristiche simili rispettivamente al concordato preventivo e al fallimento, ma adattate ai piccoli debitori.
Tabella 2 – Responsabilità patrimoniale di soci e imprenditori per i debiti d’impresa
| Forma giuridica dell’impresa | Responsabilità per i debiti | Note |
|---|---|---|
| Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) | Società = unico soggetto obbligato. Soci non rispondono con patrimonio personale (responsabilità limitata ai conferimenti). Amministratori non responsabili per debiti sociali salvo eccezioni di legge. | Eccezioni: obblighi ex art. 36 DPR 602/73 (liquidatori, amm. e soci coinvolti se violano ordine di pagamento fiscale) ; soci che ricevono attivi in liquidazione rispondono fino a concorrenza di quanto avuto (art. 2495 c.c.) . Garanzie personali (fideiussioni) prestate da soci/amm. restano valide. |
| Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | Soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali (in solido, con beneficio di escussione del patrimonio sociale). Nella S.a.s. gli accomandanti sono esclusi dalla responsabilità illimitata (salvo abbiano agito da amministratori). | Creditori possono agire sui patrimoni personali dei soci se la società non paga spontaneamente. Il fallimento della società trascina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Soci accomandanti rispondono limitatamente (perdono solo il conferimento). |
| Impresa individuale (ditta individuale) | Imprenditore = debitore unico: risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, senza alcuna limitazione. Non c’è distinzione tra patrimonio “impresa” e personale. | Possibile tutelare beni personali solo con strumenti di separazione patrimoniale (es. fondo patrimoniale, trust) effettuati prima della crisi e validi se non in frode. L’imprenditore fallisce personalmente con l’impresa. |
Fonti normative e giurisprudenziali principali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (in vigore dal 15 luglio 2022) e successive modifiche (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024) .
- Legge Fallimentare 1942 (R.D. 267/1942) – non più applicabile alle procedure aperte dopo il 15/7/2022, sostituita dal CCII.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, art.36 – Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per il pagamento delle imposte in caso di liquidazione societaria .
- Codice Civile, artt. 2485-2486 – Obblighi degli amministratori in caso di perdita del capitale; responsabilità per continuazione dell’attività oltre la soglia di legge (criterio differenza patrimoni netti introdotto dal D.Lgs. 14/2019) .
- Cass., Sez. Unite Civili, 18 febbraio 2025 n. 3625 – Esclude automatismi di responsabilità degli ex soci per debiti fiscali di società estinte; necessità di accertamento individuale e prova di benefici ricevuti .
- Cass., Sez. I Civ., 18 febbraio 2025 n. 4201 – Soglia di €30.000 per l’apertura del fallimento: la rateizzazione di un debito fiscale non impedisce di conteggiarlo tra i debiti scaduti rilevanti ai fini della soglia .
- Cass., Sez. I Civ., 30 gennaio 2025 n. 2223 – La condizione di indebitamento >€30.000 va verificata al momento della dichiarazione di fallimento; irrilevante in sede di reclamo l’adesione tardiva a definizioni agevolate .
- Cass., Sez. V Civ., 18 luglio 2023 n. 20840 – In caso di cancellazione di S.r.l. a ristretta base dal Registro Imprese, i soci possono essere ritenuti responsabili dei debiti tributari sociali se emergono presunzioni di distribuzione di utili occulti a loro favore .
- Cass., Sez. V Civ., 21 settembre 2021 n. 25530 – L’ex amministratore di S.r.l. estinta non risponde personalmente dei debiti fiscali sociali (IRES), essendo l’art.36 DPR 602/73 una obbligazione propria civilistica e non una coobbligazione tributaria diretta .
- Cass., Sez. V Civ., 19 dicembre 2023 n. 35497 – Necessario avviso di accertamento al socio/amministratore per imputargli debiti fiscali ex art.36 DPR 602/73; omessa notifica comporta nullità della cartella a suo carico .
- Rapporto Unioncamere sulla Composizione Negoziata (VIII ed., 2025) – Dati statistici sull’uso dello strumento: incremento istanze, 81% con misure protettive richieste .
- Camera Arbitrale Milano – Report CNC 2024 – Analisi regionale (Lombardia) sulla composizione negoziata: +87% istanze nel 2024, maggioranza S.r.l. micro-imprese; 38 imprese risanate e 2100 posti di lavoro salvati .
- Linee guida CNDCEC 2022 – Principi di attestazione dei piani di risanamento emanati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti: requisiti di indipendenza dell’attestatore e importanza dell’assenza di conflitti (Cass. 20059/2024 sull’indipendenza) .
La tua azienda che realizza pavimentazioni in resina industriale, rivestimenti in resina per capannoni, pavimenti antiscivolo, pavimenti alimentari certificati HACCP, pavimenti autolivellanti, pavimentazioni antiacido, pavimenti in poliuretano cemento, resine epossidiche, pavimenti per industrie, magazzini e laboratori, o interventi di ripristino e manutenzione si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che realizza pavimentazioni in resina industriale, rivestimenti in resina per capannoni, pavimenti antiscivolo, pavimenti alimentari certificati HACCP, pavimenti autolivellanti, pavimentazioni antiacido, pavimenti in poliuretano cemento, resine epossidiche, pavimenti per industrie, magazzini e laboratori, o interventi di ripristino e manutenzione si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni con Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori di resine e materiali chimici, trasportatori, noleggiatori, finanziarie o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste urgenti di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore delle pavimentazioni in resina è complesso e costoso: richiede materiali speciali, prodotti chimici certificati, attrezzature professionali, personale formato, preparazione del supporto, tempi tecnici precisi, cantieri programmati e continui anticipi di spesa.
Basta un ritardo nei pagamenti di un cantiere, un intervento sospeso o una riduzione dei fidi bancari per generare una crisi anche molto seria.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata e rilanciata, se intervieni nel modo corretto e con tempestività.
Perché un’Azienda di Pavimentazioni in Resina va in Debito
Le cause più frequenti includono:
- aumento dei costi di resine epossidiche, poliuretaniche, additivi, primer e materiali chimici
- rincari di attrezzature, smerigliatrici, levigatrici, miscelatori, trasporti e noleggi
- ritardi nei pagamenti da parte di imprese edili, industrie, magazzini e general contractor
- cantieri bloccati da supporti non idonei, meteo, permessi, contenziosi
- spese anticipate per preparazione superficie, primer, materiali e manodopera
- magazzino immobilizzato tra resine, additivi, attrezzature e ricambi
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- investimenti in formazione, test, sicurezza e certificazioni
Il vero problema non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per un’Azienda di Pavimentazioni in Resina con Debiti
Senza interventi immediati rischi:
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di resine, additivi e attrezzature
- decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
- sequestro di macchinari, attrezzature e materiali
- impossibilità di completare cantieri pianificati
- perdita di clienti, appalti e collaborazioni strategiche
- rischio concreto di fermo totale dell’attività
Una crisi non gestita può paralizzare rapidamente tutta la produzione e l’operatività dei cantieri.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti e azioni esecutive
- fermare richieste di rientro improvvise
- proteggere i conti correnti
- impedire la sospensione delle forniture critiche
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si procede alla ristrutturazione del debito.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso nei debiti emergono errori e irregolarità come:
- interessi non dovuti
- sanzioni calcolate male
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Entrate-Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili
Le opzioni più efficaci sono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione delle linee di credito
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
L’obiettivo è ripristinare la liquidità e mantenere attivi i cantieri.
4. Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Per crisi più complesse si possono adottare:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- accordi di ristrutturazione
- concordato minore
- liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Queste procedure:
- bloccano tutti i creditori
- sospendono pignoramenti e precetti
- permettono di pagare solo una parte del debito
- consentono di continuare l’attività con protezione legale
5. Proteggere materiali, attrezzature e cantieri
Per un’azienda di pavimentazioni in resina è fondamentale salvaguardare:
- resine, additivi, primer, colori e materiali chimici
- macchinari e attrezzature: levigatrici, smerigliatrici, miscelatori, aspiratori
- mezzi e furgoni per i cantieri
- documentazione tecnica e schede tecniche dei materiali
- continuità dei cantieri aperti e delle manutenzioni urgenti
Un blocco del magazzino o dei mezzi può fermare del tutto l’operatività.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- Elenco completo dei debiti (fiscali, bancari e commerciali)
- Estratti conto aggiornati
- Estratto di ruolo
- Bilanci e documentazione fiscale
- Lista fornitori strategici (resine, attrezzature, noleggi)
- Inventario del magazzino
- Atti giudiziari ricevuti
- Cantieri attivi e contratti in essere
Tempistiche di Intervento
- Analisi preliminare in 24–72 ore
- Blocco dei creditori in 48 ore – 7 giorni
- Piano di ristrutturazione in 30–90 giorni
- Eventuale procedura giudiziaria in 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
- Stop immediato ai pignoramenti
- Riduzione concreta dei debiti
- Protezione di materiali, mezzi, macchinari e magazzino
- Trattative efficaci con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Continuità dei cantieri e delle consegne
- Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
- Ignorare solleciti e atti giudiziari
- Fare nuovi debiti per pagare quelli vecchi
- Pagare solo alcuni fornitori
- Lasciare avanzare pignoramenti
- Affidarsi a società senza competenza reale
Ogni errore aumenta il rischio di fermo aziendale.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- Analisi completa della tua situazione debitoria
- Blocco immediato delle azioni dei creditori
- Elaborazione di piani di ristrutturazione su misura
- Attivazione degli strumenti giudiziari più efficaci
- Trattative mirate con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di pavimentazioni in resina industriale non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e strutturata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre in modo significativo i debiti
- proteggere materiali, macchinari, mezzi e cantieri
- garantire la continuità operativa
- salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.