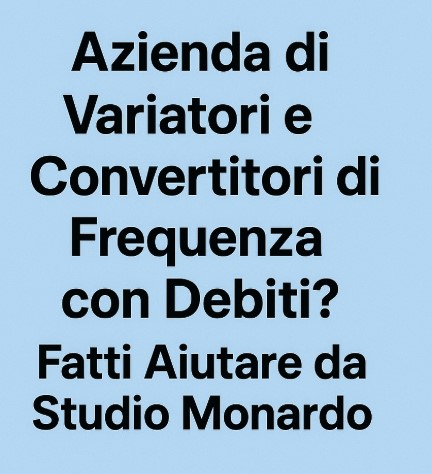Se gestisci un’azienda che produce, importa o distribuisce variatori di velocità, inverter, convertitori di frequenza, azionamenti elettronici, motori controllati, pannelli di comando, soft starter e soluzioni per automazione industriale, HVAC, macchine utensili e impianti produttivi, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la continuità della tua attività è davvero in pericolo.
Il settore dei variatori e dei convertitori di frequenza richiede componentistica elettronica avanzata, schede di potenza, moduli IGBT, sistemi di dissipazione, firmware aggiornati, certificazioni e test funzionali rigorosi. Un blocco dovuto ai debiti può fermare produzioni, rallentare assistenze tecniche, annullare consegne e farti perdere clienti strategici nel settore dell’automazione industriale.
La buona notizia è che puoi ancora proteggerti, ridurre i debiti e salvare la tua azienda, se intervieni subito con la strategia giusta.
Perché le aziende di variatori e convertitori di frequenza accumulano debiti
Le cause più frequenti sono:
- costi elevati per componenti elettronici, IGBT, schede, alimentatori e moduli di potenza
- rincari dei semiconduttori, delle parti importate e della componentistica specializzata
- pagamenti lenti da parte di integratori, impiantisti e clienti industriali
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi con molti modelli, firmware e versioni diverse
- investimenti continui in R&D, collaudi, test EMC, certificazioni e sviluppo firmware
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli produttivi
- fornitori strategici che richiedono pagamenti anticipati o più rapidi
Senza interventi tempestivi, questi fattori generano crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
La parola d’ordine è agire immediatamente. Ecco le azioni fondamentali:
- fai analizzare l’intera situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verifica quali debiti sono corretti e quali possono essere contestati, ridotti o prescritti
- evita accordi affrettati o rateizzazioni che non puoi sostenere nel tempo
- richiedi la sospensione di pignoramenti o procedure esecutive in corso
- valuta rateizzazioni realmente sostenibili con Agenzia delle Entrate e INPS
- metti in sicurezza i fornitori critici di componenti elettronici
- previeni il blocco del conto corrente e la riduzione dei fidi bancari
- utilizza gli strumenti legali disponibili per ridurre, ristrutturare o negoziare i debiti
Solo un’analisi professionale può indicarti quali debiti ridurre, sospendere o contestare davvero.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Senza un intervento rapido e mirato, i rischi possono essere gravissimi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di banchi prova, postazioni di test e attrezzature elettroniche
- blocco delle forniture di schede, moduli di potenza, componenti elettronici e firmware
- impossibilità di completare commesse, retrofit o assistenze urgenti
- perdita di clienti industriali, integratori e partner strategici
- danni alla reputazione tecnica e commerciale
- crisi di liquidità e difficoltà nel pagare fornitori e dipendenti
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Nel settore degli inverter e dei convertitori anche un ritardo minimo può bloccare intere linee produttive dei clienti, generando costi ingenti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre l’importo totale dei debiti tramite trattative mirate con Fisco, INPS e creditori privati
- ottenere rateizzazioni sostenibili basate sui reali flussi di cassa
- far annullare debiti prescritti, irregolari o calcolati in modo errato
- negoziare con banche e fornitori per evitare blocchi nelle forniture
- proteggere magazzino, attrezzature, schede, componenti e continuità operativa
- stabilizzare temporaneamente la situazione mentre l’azienda ristruttura il debito
- evitare procedure concorsuali e il rischio di insolvenza
Una strategia legale efficace può davvero fare la differenza tra chiusura e rilancio.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere la tua azienda operativa devi:
- intervenire subito, non quando il danno è già fatto
- evitare di negoziare da solo con i creditori
- proteggere fornitori e componenti critici (schede, moduli IGBT, alimentatori)
- ristrutturare i debiti prima che scattino pignoramenti o blocchi bancari
- contestare debiti irregolari o non più esigibili
- preservare la liquidità concentrandola sulle attività strategiche
In questo modo puoi evitare fermi, ritardi, penali e perdita di clienti importanti.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo subito se:
- hai ricevuto cartelle, solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS, banche o fornitori stanno diventando ingestibili
- temi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità si sta riducendo rapidamente
- i fornitori minacciano di sospendere consegne o componenti
- ritieni che la situazione possa portare alla chiusura dell’impresa
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e riportare stabilità alla tua azienda.
Attenzione
Molte aziende elettroniche e di automazione non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare davvero il futuro della tua attività.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese elettroniche e industriali – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di variatori e convertitori di frequenza.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Immaginiamo un’azienda italiana specializzata nella produzione di variatori e convertitori di frequenza – componenti elettronici essenziali per macchinari industriali. Negli ultimi anni l’impresa ha accumulato debiti consistenti per ragioni diverse: prestiti bancari contratti per investimenti in nuovi macchinari, imposte non versate a causa di cali di liquidità, fatture insolute verso fornitori di componenti, e contributi previdenziali INPS arretrati per i dipendenti. Questa situazione di sovraindebitamento aziendale espone l’impresa a rischi gravi: dai solleciti di pagamento e le azioni di recupero crediti da parte di banche e fornitori, fino alla prospettiva estrema di una procedura concorsuale (il fallimento, oggi chiamato liquidazione giudiziale nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa).
Cosa può fare un imprenditore in questa situazione per difendere la propria azienda e tentare di risanare i debiti? Quali strumenti legali offre l’ordinamento italiano – aggiornati a ottobre 2025 – per gestire una crisi d’impresa ed evitare la chiusura forzata? In questa guida approfondiremo, dal punto di vista del debitore, le strategie di difesa e di ristrutturazione del debito aziendale previste dalla normativa italiana vigente. Adotteremo un linguaggio giuridico ma chiaro e divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto sia a imprenditori e privati interessati a comprendere le proprie opzioni.
Esamineremo innanzitutto le varie tipologie di debiti che un’azienda può accumulare (fiscali, bancari, verso fornitori, previdenziali) e le relative conseguenze legali. Vedremo poi gli strumenti di soluzione della crisi oggi disponibili: dai piani di risanamento stragiudiziali e la composizione negoziata della crisi (introdotta di recente) agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati dal tribunale, fino al concordato preventivo (incluso il concordato minore per le piccole imprese) e, in caso estremo, la liquidazione giudiziale. Analizzeremo anche istituti cruciali come la transazione fiscale (che consente di trattare i debiti tributari all’interno dei piani) e l’esdebitazione, cioè la possibilità per l’imprenditore onesto di ottenere la liberazione dai debiti residui a fine procedura.
La guida include tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti, per riassumere i punti chiave e chiarire i dubbi comuni. Tutte le informazioni sono aggiornate a ottobre 2025, tenendo conto delle ultime riforme normative e delle più recenti sentenze della giurisprudenza italiana. Il nostro obiettivo è fornire un quadro avanzato e completo su “Azienda di variatori e convertitori di frequenza con debiti: cosa fare per difendersi e come“, aiutando il debitore a orientarsi tra rischi e soluzioni e a scegliere la strategia più adatta per salvaguardare l’attività e il proprio patrimonio.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Prima di scegliere la strategia di risanamento, è fondamentale capire che tipo di debiti gravano sull’azienda e quali rischi specifici essi comportano. In genere, i debiti di un’impresa in difficoltà rientrano in queste categorie principali:
Debiti fiscali (verso Erario e Agenzia delle Entrate)
I debiti fiscali comprendono imposte statali non versate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su redditi di lavoro, ecc.). Quando un’impresa non paga queste somme nei termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER, ex Equitalia) procede al recupero coattivo iscrivendo a ruolo gli importi dovuti e notificando le cartelle esattoriali. Se il debitore non paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione può avviare azioni esecutive senza ulteriore avviso: ad esempio pignoramenti di conti correnti, fermi amministrativi su automezzi aziendali, iscrizioni di ipoteca su immobili dell’impresa o dei soci garanti. Va sottolineato che i debiti tributari possono mettere in crisi la continuità aziendale molto rapidamente: un’ipoteca iscritta dal fisco su un capannone o un pignoramento sul conto bancario possono paralizzare l’operatività quotidiana.
Inoltre, l’ordinamento prevede soglie di rilevanza penale per l’omesso versamento di talune imposte. In particolare, non versare l’IVA annuale per un importo superiore a €250.000 costituisce reato tributario, così come non versare le ritenute operate sui compensi ai dipendenti per oltre €150.000 annui. Ciò significa che, oltre al danno economico, l’imprenditore rischia conseguenze penali (reclusione fino a 3 anni) se accumula grossi debiti fiscali senza provvedere al pagamento. Questo spinge ancor di più a trovare una soluzione strutturale al debito fiscale, prima che esso sfoci in denunce penali o in iniziative aggressive di recupero.
Da ultimo, i debiti erariali di importo elevato attivano meccanismi di allerta pubblica introdotti dal nuovo Codice della Crisi: ad esempio, se un’impresa ha cartelle esattoriali scadute per oltre €500.000 (nel caso di società di capitali), l’Agenzia Entrate-Riscossione è obbligata a inviare al debitore una comunicazione formale sollecitando di attivarsi per la composizione della crisi. Simili soglie (più basse) valgono per ditte individuali e società di persone (ad esempio €100.000 di cartelle per le imprese individuali). Ricevere una segnalazione d’allerta dal Fisco non comporta di per sé azioni immediate, ma è un chiaro segnale che la situazione debitoria è critica e richiede interventi (come vedremo, ignorare questi avvisi può condurre l’ente a perdere fiducia e ad irrigidirsi nelle trattative).
In sintesi, i debiti fiscali sono tra i più pericolosi: il Fisco dispone di poteri incisivi di riscossione e non esita a usarli se non intravede collaborazione o prospettive di rientro. Per difendersi, l’impresa debitrice dovrà valutare strumenti come la rateizzazione amministrativa del debito (quando possibile) o includere l’Erario in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo tramite l’istituto della transazione fiscale (di cui diremo in seguito).
Debiti previdenziali e verso enti (INPS e altri)
Accanto alle imposte, molte imprese accumulano debiti contributivi verso l’INPS (contributi previdenziali per i dipendenti o per il titolare) e talvolta verso l’INAIL (premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni). Questi debiti hanno natura pubblicistica analoga a quella tributaria e sono spesso riscossi con le medesime modalità delle imposte: l’INPS notifica avvisi di addebito immediatamente esecutivi e, trascorsi i termini, procede tramite Agenzia Entrate-Riscossione a emettere cartelle e atti di pignoramento. Anche per i contributi esistono soglie penali: omettere il versamento delle ritenute previdenziali per oltre €10.000 annui configura reato (punito con la reclusione fino a 3 anni). Ciò tipicamente riguarda le aziende che trattengono in busta paga i contributi ai dipendenti (le ritenute) ma non li versano all’INPS: superata la soglia di €10.000 l’anno, il fatto diventa penalmente rilevante.
I rischi legati ai debiti previdenziali sono simili a quelli dei debiti fiscali: ingiunzioni, pignoramenti e aggiunta di sanzioni civili (le somme dovute infatti maturano interessi di mora e sanzioni per omesso versamento, che aumentano il debito nel tempo). Anche l’INPS rientra tra i creditori pubblici che inviano segnalazioni di allerta: ad esempio, omessi versamenti di contributi che superino il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e almeno €15.000 fanno scattare una comunicazione obbligatoria dell’INPS ai sensi dell’art. 25-novies CCII. L’impresa indebitata verso l’INPS rischia inoltre ripercussioni sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): un’azienda non in regola con i contributi non può ottenere un DURC regolare, perdendo la possibilità di partecipare ad appalti pubblici o di accedere a benefici e agevolazioni.
In breve, i debiti previdenziali vanno trattati con la stessa attenzione dei debiti fiscali. Ignorarli può portare a blocchi operativi (ad esempio impossibilità di contrattare con la P.A. senza DURC) e ad azioni esecutive sugli asset aziendali. Anche qui, strumenti come la rateizzazione amministrativa dei contributi o l’inclusione del debito INPS in piani di ristrutturazione saranno strade da considerare per difendersi.
Debiti bancari e finanziari
Molte imprese in crisi accumulano debiti verso banche o altri finanziatori. Si pensi ai mutui contratti per comprare immobili o macchinari, ai fidi di cassa e scoperti di conto, ai leasing finanziari per i mezzi di produzione, o agli anticipi su fatture. Quando l’impresa non riesce a rispettare le scadenze (ad es. saltare le rate di un mutuo o “sconfinare” oltre il fido accordato), la banca generalmente revoca gli affidamenti e chiede il rientro immediato di tutte le esposizioni. Ciò può avvenire anche in modo unilaterale e repentino: ad esempio, la revoca di un fido di cassa può lasciare l’azienda senza liquidità da un giorno all’altro. Una volta decaduti i termini di pagamento, la banca può agire per via legale: richiedere un decreto ingiuntivo per il credito insoluto e poi passare al pignoramento dei beni dati in garanzia (es. espropriare l’immobile ipotecato o escutere un pegno su macchinari). Se i finanziamenti erano assistiti da garanzie personali (fideiussioni) dei soci o da garanzie pubbliche (es. Fondo PMI o SACE), anche i garanti verranno escussi, estendendo la crisi dal patrimonio aziendale a quello personale degli imprenditori.
Un debito bancario elevato è spesso il principale campanello di allarme dello stato di crisi di un’azienda. Le banche dispongono di sistemi di controllo (centrali rischi, covenant finanziari) che segnalano immediatamente il deterioramento dell’affidamento. Oltre alle azioni giudiziarie, il default bancario comporta l’esclusione dai circuiti creditizi: l’azienda viene segnalata come cattiva pagatrice in Centrale Rischi di Banca d’Italia, rendendo pressoché impossibile ottenere nuovi finanziamenti o linee di credito da altri istituti. In pratica, i rubinetti del credito si chiudono proprio quando se ne avrebbe più bisogno.
Di fronte a ciò, come può difendersi l’azienda debitrice verso le banche? In alcuni casi è possibile negoziare ristrutturazioni del debito bancario stragiudiziali (ad esempio accordi di moratoria, riscadenzamento delle rate, consolidamento dei debiti con nuove garanzie). Le banche, se vedono un serio piano di risanamento, possono preferire una rinegoziazione piuttosto che portare l’impresa al fallimento (con il rischio di incassare meno). Non di rado, però, serve l’ombrello di una procedura concorsuale: attraverso un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, l’impresa può cristallizzare il debito verso le banche e imporre un trattamento anche alle eventuali banche dissenzienti, evitando l’azione esecutiva immediata. Lo vedremo meglio più avanti parlando di accordi ad efficacia estesa, che consentono di superare il veto di alcune banche qualora la maggioranza sia favorevole alla ristrutturazione.
In sintesi, i debiti finanziari richiedono spesso una trattativa articolata: l’impresa deve da un lato tamponare le azioni immediate (evitando, se possibile, che la banca aggredisca le garanzie prima di aver esplorato soluzioni) e dall’altro lato predisporre un piano credibile da sottoporre ai creditori finanziari, eventualmente avvalendosi di esperti o di procedure legali di composizione della crisi.
Debiti verso fornitori e altri creditori
Un’ulteriore categoria critica sono i debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi. Quando l’azienda non paga i propri fornitori, rischia di perdere forniture essenziali (i fornitori possono sospendere le consegne per inadempimento) e vede incrinarsi la propria reputazione commerciale. I fornitori insoddisfatti possono attivarsi legalmente per recuperare il credito: spesso iniziano con solleciti e piani di rientro informali, ma se il debitore non onora gli impegni, passano alle vie giudiziarie (richiesta di decreto ingiuntivo, precetto e quindi pignoramento). A differenza delle banche o del Fisco, i fornitori non godono di garanzie particolari né di poteri speciali: tuttavia, in gruppo possono ugualmente mettere in grave difficoltà l’impresa debitrice. Immaginiamo più fornitori che ottengono decreti ingiuntivi e avviano pignoramenti contemporaneamente: uno blocca il conto corrente aziendale, un altro fa pignorare i beni in magazzino, un altro ancora chiede il pignoramento presso terzi dei crediti che i clienti dovevano pagare all’impresa. Questa moltiplicazione di azioni esecutive individuali può condurre alla paralisi operativa e spingere l’imprenditore verso una situazione di insolvenza conclamata.
Va evidenziato che qualsiasi creditore, fornitore compreso, se munito di un credito scaduto e rilevante, può anche presentare istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) contro l’azienda debitrice. Non sono solo le banche o il Fisco a poterlo fare: anzi, spesso è proprio un fornitore esasperato, magari di dimensioni minori ma fortemente esposto, a avviare la procedura concorsuale nel tentativo di recuperare qualcosa prima che sia troppo tardi. Per farlo, ovviamente, devono essere soddisfatti i presupposti di legge (lo stato di insolvenza e le soglie dimensionali, di cui diremo a breve).
Difendersi dai debiti verso fornitori significa anzitutto gestire la relazione commerciale: è fondamentale comunicare con i fornitori critici, evitare sorprese e cercare accordi transattivi (ad esempio: pagamento parziale immediato e saldo dilazionato, magari offrendo garanzie). Se la situazione è già degenerata in decreti ingiuntivi e pignoramenti, l’impresa può valutare strumenti di conciliazione giudiziale o l’ombrello di una procedura concorsuale che sospenda le azioni esecutive. Infatti, l’accesso a procedure come il concordato preventivo comporta la sospensione di tutte le azioni individuali dei creditori (automatic stay), impedendo che singoli fornitori si soddisfino a scapito di altri durante il tentativo di risanamento. Questa “parità di trattamento” è uno dei motivi per cui spesso conviene convogliare il contenzioso diffuso con i fornitori in una soluzione unitaria come un accordo di ristrutturazione o un concordato.
Altri debiti e passività
Oltre alle categorie principali sopra descritte, un’azienda può avere altre passività: ad esempio debiti fiscali locali (tributi comunali, regionali), debiti verso dipendenti (stipendi arretrati, TFR non versato), debiti legati a sanzioni o danni (multe, risarcimenti in seguito a sentenze). Queste situazioni possono aggravare ulteriormente la crisi se non affrontate. In particolare, i debiti verso i dipendenti (retribuzioni non pagate) sono molto critici: i lavoratori hanno diritto di procedere rapidamente per decreto ingiuntivo e, nel caso di insolvenza, possono accedere al Fondo di Garanzia INPS per TFR e stipendi, con surroga dell’INPS nei confronti dell’azienda.
È importante sottolineare che, indipendentemente dalla natura del debito, lo stato di insolvenza dell’impresa deriva dall’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con i mezzi finanziari disponibili. Dunque tutti questi debiti, se non vengono ristrutturati o pagati, concorrono a determinare la crisi e possono condurre, nei casi peggiori, all’apertura di una procedura concorsuale da parte del tribunale (su istanza di un creditore o dell’imprenditore stesso). Nella sezione seguente esamineremo proprio i presupposti legali dell’insolvenza e come capire se un’azienda è “fallibile” oppure può evitare il fallimento perché di dimensioni minori.
Soglie di fallibilità e presupposti per la liquidazione giudiziale
Non tutte le imprese possono essere assoggettate a fallimento (oggi liquidazione giudiziale): la legge esclude infatti i debitori di piccole dimensioni dal fallimento, riservando loro procedure semplificate di sovraindebitamento. È quindi cruciale stabilire se l’“azienda di variatori e convertitori di frequenza” del nostro esempio rientri tra le imprese fallibili oppure no. I criteri sono principalmente due: la natura imprenditoriale e la dimensione economica.
Chi è soggetto a fallimento e chi no
In base alla normativa vigente (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII), sono assoggettabili a liquidazione giudiziale solo gli imprenditori commerciali non piccoli. Restano esclusi per legge, ad esempio:
- gli imprenditori agricoli (che svolgono attività agro-coltivativa);
- gli enti pubblici;
- le start-up innovative nei primi 5 anni dalla costituzione (come previsto dall’art. 31 DL 179/2012, per favorire le nuove imprese tecnologiche);
- soprattutto, le imprese “minori”, cioè quelle sotto determinate soglie dimensionali.
I parametri attuali per definire un’impresa minore (non fallibile) sono fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Un’impresa è considerata minore se, nei tre esercizi antecedenti la data in cui si chiede l’apertura di una procedura (o dall’inizio dell’attività se attiva da meno tempo), non ha superato alcuno dei seguenti limiti:
- Attivo patrimoniale annuo: €300.000;
- Ricavi lordi annui: €200.000;
- Debiti totali (anche non scaduti): €500.000.
In altre parole, se l’azienda negli ultimi tre anni ha sempre operato al di sotto di tutti questi parametri (attivo ≤ 300k, ricavi ≤ 200k, debiti ≤ 500k), viene qualificata come “impresa minore” e non può essere dichiarata fallita. In caso contrario, basta aver superato anche solo uno dei limiti (ad esempio ricavi di 250.000 € in un anno) perché l’impresa sia considerata fallibile.
Oltre ai requisiti dimensionali, la legge prevede un’ulteriore soglia oggettiva: per aprire una liquidazione giudiziale occorre che vi siano almeno €30.000 di debiti scaduti e non pagati. Questo filtro – introdotto per evitare fallimenti per importi bagatellari – era previsto dall’art. 15, comma 9 della vecchia Legge Fallimentare ed è confermato nell’art. 49, comma 5 CCII. La giurisprudenza ha chiarito che tale soglia di €30.000 va riferita al debito complessivo scaduto dell’impresa e non al singolo credito del singolo istante che chiede il fallimento. Ad esempio, un creditore con credito di €10.000 non potrebbe da solo causare il fallimento se il totale degli arretrati dell’impresa rimane sotto €30.000; viceversa se l’impresa ha debiti scaduti verso vari creditori per complessivi €50.000, la soglia è superata anche se nessun singolo creditore vanta più di €30k.
Esempio: la nostra azienda produttrice di convertitori di frequenza presenta un attivo di €1 milione, ricavi annui di €800.000 e debiti totali per €600.000: questi numeri superano nettamente le soglie di legge, quindi l’impresa è fallibile. Se invece fosse un piccolo laboratorio artigianale con attivo €100.000, ricavi €150.000 e debiti €400.000, rientrerebbe sotto tutte le soglie e sarebbe tecnicamente non fallibile (pur restando esposta ad azioni esecutive individuali dei creditori, come vedremo).
Determinare la fallibilità è fondamentale perché solo le imprese fallibili possono essere assoggettate alle procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione standard). Le imprese non fallibili invece, in caso di insolvenza, accedono alle procedure di sovraindebitamento oggi disciplinate dal CCII (il concordato minore, l’accordo di ristrutturazione minore e la liquidazione controllata). Approfondiremo più avanti queste differenze.
Va notato che restare “sotto soglia” non significa affatto essere al riparo dai creditori: significa solo che non potrà essere aperto un fallimento, ma i singoli creditori possono comunque agire individualmente con decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc. per recuperare i propri crediti. Ad esempio, un fornitore di una micro-impresa non fallibile può comunque pignorarle i macchinari; ciò che non potrà fare è chiedere al tribunale l’apertura di una procedura concorsuale liquidatoria.
L’accertamento dello stato di insolvenza
Oltre alle soglie quantitative, il presupposto centrale per ogni procedura concorsuale rimane lo stato di insolvenza. Si ha insolvenza quando l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, a causa di una mancanza strutturale di liquidità o di un grave squilibrio patrimoniale (incapacità di far fronte ai debiti con il patrimonio disponibile). Accertare l’insolvenza è compito del tribunale, che valuta i sintomi di incapacità finanziaria dell’impresa: mancati pagamenti reiterati, protesti, pignoramenti infruttuosi, fuga dei fornitori, bilanci con perdite gravissime, ecc.
In sede di istruttoria pre-fallimentare (il procedimento che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale), il giudice verifica sia i requisiti soggettivi (natura commerciale e non piccola dell’impresa, superamento delle soglie di cui sopra) sia la sussistenza di uno stato di insolvenza attuale. È importante sottolineare che anche un’impresa grande e teoricamente “fallibile” non verrà dichiarata insolvente se riesce comunque, magari con ritardi, a pagare i debiti e a mantenere la continuità. Viceversa, un’impresa può divenire insolvente anche prima di esaurire tutto il patrimonio, se il flusso di cassa è talmente compromesso da non consentirle di onorare sistematicamente gli impegni.
La giurisprudenza ha fornito alcuni chiarimenti interessanti sui criteri di valutazione dello stato d’insolvenza ai fini della procedura:
- Debiti contestati: il fatto che l’impresa contesti un debito (ad esempio perché oggetto di causa civile o arbitrato in corso) non basta a escluderlo dal computo dei debiti ai fini della soglia o dell’insolvenza. Tuttavia, il giudice dovrà compiere un accertamento incidentale sulla fondatezza e l’entità di quel debito contestato, potendolo anche escludere o ridimensionare se dagli atti risulta che probabilmente non sarà dovuto per intero. In pratica, vanno conteggiati solo i debiti “certi” ed esigibili: ad esempio, in una recente pronuncia la Cassazione ha escluso dal calcolo un credito di leasing perché, a seguito della risoluzione del contratto e della restituzione del bene, l’esposizione effettiva era inferiore a quella originaria.
- Debiti fiscali rateizzati: come accennato sopra, la concessione di una dilazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non fa venir meno lo stato di insolvenza né incide sul calcolo delle soglie di fallibilità. La Cassazione (ord. n. 4201/2025) ha chiarito che un debito tributario già scaduto per oltre €30.000, sebbene poi rateizzato, resta computabile come debito scaduto ai fini della soglia, dato che in caso di mancato pagamento di una rata il Fisco può immediatamente esigere l’intero importo residuo. Dunque la rateazione dà sollievo temporaneo ma non “cancella” l’insolvenza originaria né rende il debitore automaticamente non fallibile.
- Crediti prescritti o inesigibili: la Corte di Cassazione ha di recente affermato che i crediti ormai prescritti non vanno conteggiati nel calcolo del passivo ai fini della fallibilità. Ciò per rispettare la ratio di escludere dal fallimento chi ha passività effettive modeste: un debito formalmente a bilancio ma giuridicamente non più esigibile (perché prescritto) non deve concorrere a far superare la soglia dei €500.000 di debiti.
- Onere della prova e bilanci: in caso di contestazione sulla fallibilità, spetta all’imprenditore debitore l’onere di provare di rientrare nelle soglie di non fallibilità (ad esempio producendo i bilanci degli ultimi tre esercizi). I bilanci depositati sono considerati una prova privilegiata dei requisiti dimensionali, salvo che vengano contestati con elementi contrari dai creditori o dal curatore. Le Sezioni Unite hanno sancito già nel 2015 questo principio (Cass. SU 9935/2015) e la prassi è confermata: chi vuol sottrarsi al fallimento perché “sotto soglia” deve dimostrare i propri numeri.
In sintesi, un’azienda indebitata deve capire se può essere trascinata in una procedura concorsuale maggiore oppure no. Se fallibile, il rischio concreto è che un creditore o un P.M. chiedano al tribunale la liquidazione giudiziale dell’azienda, con perdita del controllo e conseguenze drastiche. Se invece l’azienda è non fallibile, quel rischio specifico viene meno (nessun fallimento), ma rimane comunque l’esigenza di gestire la crisi perché i creditori potranno attaccarla individualmente e, in caso d’insuccesso delle soluzioni negoziali, l’epilogo potrebbe essere la liquidazione controllata dell’impresa (un procedimento semplificato in cui è il debitore stesso a chiedere la liquidazione dei propri beni per chiudere i debiti). Nel prossimo paragrafo passeremo in rassegna proprio gli strumenti di composizione della crisi, dai più “soft” e volontari fino a quelli giudiziali, tenendo conto di questa distinzione tra piccole e grandi imprese.
Gestione della crisi d’impresa: strumenti di risanamento e difesa del debitore
Di fronte a una situazione di crisi conclamata, l’imprenditore ha a disposizione una gamma di strumenti per cercare di risolvere o attenuare l’indebitamento e salvaguardare la continuità aziendale. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa enfatizza l’importanza di intervenire tempestivamente: gli amministratori devono dotare la società di “assetti organizzativi adeguati” per rilevare i segnali di difficoltà ed attivarsi prima che l’insolvenza diventi irreversibile (art. 3 CCII e art. 2086 c.c. riformato). Ad esempio, vanno monitorati indicatori interni come il ritardo nei pagamenti degli stipendi oltre 30 giorni, l’ammontare dei debiti scaduti verso fornitori rispetto a quelli a scadere, gli sconfinamenti bancari persistenti e il peso di debiti fiscali/previdenziali scaduti. Se questi campanelli d’allarme suonano, rimandare è l’errore peggiore: non solo perché il debito cresce (interessi di mora, sanzioni) ma anche perché gli amministratori potrebbero incorrere in responsabilità personali per gestione non diligente.
La normativa attuale incentiva quindi una gestione attiva della crisi. In caso di difficoltà, l’imprenditore dovrebbe:
- Valutare la gravità della crisi – con l’aiuto di professionisti (commercialisti, avvocati d’impresa) per capire se si tratta di un problema temporaneo di liquidità o di un’insolvenza conclamata.
- Dialogare con i creditori – cercare nell’immediato di bloccare le azioni più aggressive (ad esempio chiedendo sospensioni o moratorie informali) e sondare la disponibilità a soluzioni negoziali.
- Predisporre un piano di risanamento – elaborare un progetto credibile per ristrutturare l’azienda e il debito (ad esempio attraverso nuove finanze, dismissione di asset non strategici, conversione di debiti in capitale, ecc.), possibilmente corredato da una verifica indipendente sulla fattibilità.
- Scegliere lo strumento legale più adatto per dare esecuzione a quel piano: a seconda dei casi si potrà agire in via privata (accordi stragiudiziali) o attivare una procedura di composizione della crisi (dal piano attestato di risanamento alla composizione negoziata, fino agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo). L’importante è utilizzare per tempo gli strumenti offerti dalla legge, perché alcuni benefici (come la protezione dalle azioni esecutive dei creditori) scattano solo all’attivazione formale di queste procedure.
Negli sviluppi che seguono passeremo in rassegna i principali strumenti di risanamento del debito, dal meno invasivo (interamente stragiudiziale) al più strutturato (giudiziale concorsuale). Ciascuno ha pro e contro, e la scelta dipenderà dalla situazione specifica dell’impresa (entità dei debiti, numero di creditori, prospettive di continuità, necessità di ottenere nuova finanza, ecc.). Riporteremo per ognuno gli aspetti salienti, con riferimenti normativi aggiornati al 2025.
Piani di risanamento stragiudiziali e accordi privati
Negoziare privatamente con i creditori è sempre il primo approccio da tentare per un’azienda indebitata. Se la crisi non è troppo grave, spesso si riesce a ottenere dai creditori chiave delle dilazioni o rischedulazioni del debito senza bisogno di procedure formali. Ad esempio, si possono stipulare accordi transattivi con singoli creditori: il debitore propone un piano di rientro (magari pagando solo una percentuale del dovuto, o con un certo taglio degli interessi e sanzioni) e il creditore, valutando il rischio di non vedere nulla in caso di fallimento, può accettare la transazione. Questi accordi informali, tuttavia, vincolano solo le parti che li sottoscrivono e non impediscono ad altri creditori di agire separatamente. Inoltre, un creditore potrebbe sempre sottrarsi all’accordo e iniziare un’azione esecutiva, vanificando gli sforzi fatti.
Per dare maggiore solidità e coerenza a un accordo stragiudiziale, l’ordinamento prevede lo strumento del piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 l.f.). Si tratta di un piano di risanamento aziendale, redatto dall’imprenditore con l’ausilio di un professionista indipendente che lo attesta (assevera) quanto a veridicità dei dati e fattibilità. Il piano attestato rimane un accordo privatistico: non richiede l’approvazione del tribunale né il voto formale dei creditori. Può essere costruito su misura: coinvolgere tutti o solo alcuni creditori, prevedere pagamento integrale di alcuni e parziale di altri, secondo ciò che le trattative ottengono. Non esiste una soglia minima di adesioni: teoricamente il debitore potrebbe predisporre un piano attestato anche unilateralmente, confidando poi di convincere almeno i principali creditori ad aderirvi. In pratica, ovviamente, serve il consenso dei creditori più significativi affinché il piano abbia efficacia.
I vantaggi del piano attestato sono la rapidità e riservatezza: non vi è apertura di procedura pubblica (anche se per usufruire di alcune tutele il piano viene facoltativamente depositato al Registro delle Imprese), e si evita il possibile stigma di un concordato. Inoltre, gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato godono di alcune protezioni legali: in caso di successivo fallimento, tali atti non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare (art. 166, co. 3, lett. d CCII), il che rassicura molto i creditori che partecipano (possono accettare ad esempio un pagamento parziale sapendo che non dovranno restituirlo se la società fallisce in seguito). Anche sul piano fiscale, le riduzioni di debito conseguenti al piano non sono tassate come sopravvenienze attive per la parte esonerata, entro certi limiti. Infine, va menzionato che sia il piano attestato sia l’accordo di ristrutturazione (di cui diremo sotto) offrono uno scudo penale: gli atti e i pagamenti compiuti in loro esecuzione non costituiscono reato di bancarotta preferenziale o semplice (art. 324 CCII), purché il piano abbia successo. Questa esimente penale tutela l’imprenditore che, ad esempio, paga alcuni creditori in attuazione del piano senza incorrere nell’accusa di averli preferiti dolosamente.
Di contro, il limite principale del piano attestato di risanamento è che non vincola i creditori estranei: chi non aderisce al piano non è coinvolto e conserva tutti i diritti per agire autonomamente. Non è prevista alcuna moratoria legale: se un creditore “fuori dal piano” decide di iniziare un pignoramento, il debitore non ha strumenti per bloccarlo, se non convincimenti personali o accordi ad hoc con quel creditore. Anche i creditori aderenti restano in una posizione contrattuale: se il debitore non rispetta le scadenze del piano, l’accordo con quel creditore può essere risolto e il creditore tornerà a poter pretendere il 100% del suo credito originario. Insomma, il piano attestato vive e muore sul consenso volontario: funziona bene quando c’è adesione pressoché unanime o quando i pochi creditori non aderenti vengono comunque pagati integralmente (per evitare attriti). Se invece vi è una platea ampia e diversificata di creditori con interessi contrastanti, il piano attestato può rivelarsi inadeguato a imporre disciplina: in tal caso si deve ricorrere a strumenti con forza cogente, come l’accordo omologato o il concordato, che permettono di forzare anche i dissenzienti ad accettare un trattamento.
La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa
Nel solco della prevenzione precoce dell’insolvenza, il legislatore ha introdotto di recente (dal novembre 2021) la Composizione Negoziata della crisi, disciplinata oggi dagli artt. 12-25 octies CCII. Si tratta di una procedura volontaria e confidenziale, attivata dall’imprenditore in crisi tramite una piattaforma telematica (presso le Camere di Commercio). Non è una procedura concorsuale vera e propria, bensì un percorso assistito di negoziazione: all’impresa viene assegnato un esperto indipendente (di norma un commercialista o esperto di ristrutturazioni nominato da una commissione apposita) con il compito di facilitare le trattative tra debitore e creditori. L’obiettivo è aiutare le parti a individuare una soluzione concordata che eviti l’insolvenza, il tutto senza le rigide formalità di un tribunale.
Caratteristiche chiave della composizione negoziata:
- Durata e riservatezza: ha una durata iniziale di 180 giorni (prorogabile) durante i quali l’esperto conduce riunioni con debitore e creditori. La procedura è riservata: l’avvio non è pubblicato, a meno che il debitore non richieda misure protettive (vedi oltre).
- Ruolo dell’esperto: l’esperto, terzo e imparziale, analizza la situazione aziendale e propone possibili soluzioni. Redige inizialmente una checklist sulla fattibilità di risanamento e poi un protocollo di conduzione delle trattative. L’esperto non ha poteri decisori, ma la sua presenza favorisce la buona fede delle parti e la circolazione delle informazioni.
- Misure protettive: il debitore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee, ossia un decreto che blocca o sospende le azioni esecutive dei creditori durante le trattative. Ad esempio, può essere sospeso un pignoramento in corso o impedito l’avvio di nuove cause. Tali misure sono concesse dal tribunale se ritiene che le trattative abbiano concrete possibilità di successo (vengono negate in caso di abuso). Le misure protettive durano inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili di altri 4, e sono pubblicate nel Registro delle Imprese (rendendo di pubblico dominio l’esistenza della composizione negoziata).
- Coinvolgimento del tribunale: è limitato. Oltre a decidere sulle misure protettive, il tribunale può essere chiamato a omologare specifici accordi se le parti lo richiedono (ad esempio, potrebbe omologare un accordo di moratoria ex art. 23 co. 1 CCII per dare esecutività ad accordi con banche dissenzienti). Ma non c’è una procedura giudiziaria strutturata né la nomina di organi concorsuali.
- Conclusione: la composizione negoziata può concludersi in vari modi. Nella migliore delle ipotesi, debitore e creditori raggiungono una soluzione concordata: può trattarsi di un contratto di ristrutturazione vero e proprio (accordo transattivo con tutti o con i principali creditori), oppure l’ingresso di nuovi investitori, la cessione dell’azienda a terzi, etc. Tale accordo può rimanere privato oppure, se ne ricorrono i presupposti, essere formalizzato come accordo di ristrutturazione omologato o come concordato (ad esempio, l’accordo può essere fatto omologare dal tribunale ai sensi dell’art. 48 CCII, oppure il debitore può presentare domanda di concordato sulla base delle intese raggiunte). Se invece le trattative falliscono e l’impresa è insolvente, il debitore – entro 60 giorni dalla chiusura negativa – può presentare un concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) senza passare per il voto dei creditori, come extrema ratio per evitare il fallimento puro. Infine, la composizione negoziata può chiudersi senza esito se l’esperto rileva che non ci sono più margini (in tal caso il debitore resta libero di attivare altre procedure concorsuali oppure, se non lo fa, i creditori potranno agire nelle forme ordinarie).
La composizione negoziata ha rappresentato una svolta nella gestione delle crisi d’impresa in Italia, perché colma il vuoto tra la contrattazione puramente privata e le procedure concorsuali giudiziali. Offre un ambiente controllato di negoziazione, con la supervisione di un esperto, ma lasciando l’imprenditore alla guida dell’azienda (non c’è spossessamento). Sono previsti anche incentivi per chi vi ricorre tempestivamente: ad esempio, la legge prevede misure premiali come la non punibilità per alcuni reati fallimentari minori e la postergazione attenuata dei finanziamenti dei soci effettuati durante la composizione negoziata. Dal 2024, inoltre, è stato chiarito che anche nell’ambito della composizione negoziata è possibile concludere accordi di “transazione fiscale” con il Fisco e gli enti previdenziali, in pratica anticipando all’interno delle trattative stragiudiziali la definizione agevolata dei debiti tributari e contributivi (su questo si veda il paragrafo dedicato alla transazione fiscale più avanti).
In sintesi, la composizione negoziata è consigliabile quando l’impresa ha ancora prospettive di risanamento e vuole evitare il formale accesso a procedure concorsuali. Non sempre porta a un accordo, ma costituisce un tentativo protetto di trovare una soluzione consensuale. L’assistenza dell’esperto e la possibilità di ottenere uno standstill temporaneo dai creditori sono elementi che possono fare la differenza nel salvare aziende altrimenti avviate al dissesto.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati)
Se la situazione è troppo complessa per un semplice accordo stragiudiziale, ma c’è ancora la possibilità di ottenere il consenso da una parte consistente dei creditori, uno strumento intermedio è l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dagli artt. 57-64 CCII (e artt. 65-73 per varianti particolari). Si tratta di un accordo negoziato dal debitore con i creditori, che però acquista efficacia solo dopo l’omologazione da parte del tribunale. In sostanza, l’imprenditore deve accordarsi con almeno il 60% dei crediti totali (quota di legge per l’accordo ordinario) e presentare questo accordo in tribunale; dopo aver verificato la regolarità della procedura, l’attestazione di fattibilità rilasciata da un professionista indipendente e l’adesione della maggioranza richiesta, il tribunale omologa l’accordo rendendolo vincolante secondo i suoi termini.
Vantaggi: rispetto a un piano puramente privato, l’accordo omologato gode di diversi punti di forza:
- Innanzitutto, la legge consente di estendere alcuni effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti, superando in parte il problema degli holdout (creditori che potrebbero rifiutare sperando di essere pagati per intero). In passato ciò era limitato alle banche (art. 182-septies L.F.), oggi il CCII prevede i “accordi ad efficacia estesa” (art. 61 CCII) applicabili a diverse categorie di crediti. Ad esempio, se i creditori aderenti rappresentano almeno il 75% di una certa categoria omogenea (es. obbligazionisti, banche, fornitori) e l’accordo soddisfa equamente quella categoria, il debitore può chiedere al tribunale di estenderne gli effetti anche ai creditori dissenzienti di quella categoria. In questo modo una larga maggioranza può vincolare la minoranza, evitando che pochi creditori facciano saltare il risanamento per pretese individuali. La ratio è favorire soluzioni negoziali equilibrate, impedendo comportamenti opportunistici dei singoli creditori.
- L’omologazione tribunale dell’accordo consente di ottenere una moratoria legale delle azioni esecutive: dal momento della pubblicazione della domanda di omologazione al Registro delle Imprese, i creditori per legge non possono iniziare o proseguire pignoramenti né acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII). Si crea quindi uno standstill simile a quello del concordato preventivo, che protegge l’azienda durante l’implementazione dell’accordo.
- Come il piano attestato, anche l’accordo omologato gode delle esenzioni dalle azioni revocatorie e delle agevolazioni fiscali sulle riduzioni di debito. Inoltre, è espressamente previsto che i pagamenti e le operazioni effettuate in esecuzione dell’accordo omologato non costituiscono reati di bancarotta preferenziale (art. 324 CCII), offrendo un ulteriore scudo penale.
- L’accordo di ristrutturazione è relativamente flessibile: non coinvolge tutta la rigidità di un concordato preventivo (niente votazioni in classi, niente percentuali minime di legge da assicurare ai chirografari se non quelle pattuite, ecc.), mantenendo una logica negoziale.
Di contro, gli svantaggi e limiti sono:
- Servono consensi molto elevati: convincere il 60% dei creditori (in valore) può essere arduo, specie se i creditori sono numerosi e di natura eterogenea. Per agevolare i debitori in alcuni casi, il CCII ha introdotto l’accordo di ristrutturazione “agevolato” in cui la soglia di adesione può essere abbassata al 30% (ad esempio quando vi sia un elevato numero di piccoli creditori), ma resta comunque necessario un nucleo consistente di consenso.
- I creditori non aderenti, se non rientrano nelle categorie per cui è ammessa l’efficacia estesa, restano estranei: ciò significa che conservano intatti i loro diritti e possono anche portare l’azienda al fallimento se i loro crediti non vengono soddisfatti. Ad esempio, un fornitore strategico non aderente potrebbe comunque depositare istanza di liquidazione giudiziale. Questo impone al debitore di coprire integralmente o soddisfare adeguatamente i creditori fuori accordo per evitare che sabotino l’operazione.
- L’accordo, pur meno complesso di un concordato, richiede comunque un procedimento giudiziario di omologazione: ciò comporta tempi e costi (deposito della domanda, eventuali opposizioni da creditori dissenzienti davanti al tribunale, nomina di un ausiliario o attestatore, spese legali, ecc.). Il procedimento è più snello del concordato (non c’è voto, solo omologa), ma non è immediato.
- I creditori pubblici (Erario e enti previdenziali) possono presentare criticità: fino a poco tempo fa, se il Fisco o l’INPS rifiutavano la proposta di accordo, l’omologazione falliva anche con il 60% di altri crediti. Oggi la legge consente il cram-down fiscale, ovvero l’omologazione forzata dell’accordo anche senza adesione del Fisco/INPS, a certe condizioni: ad esempio se la loro adesione era determinante per raggiungere il 60% e la proposta è conveniente per l’ente. Le norme più recenti (D.L. 69/2023 conv. L. 103/2023) hanno però richiesto che vi sia almeno un’altra classe di creditori consenzienti oltre al Fisco e che il trattamento del Fisco non preveda decurtazioni eccessive in percentuale rispetto agli altri. Quindi, se da un lato oggi l’accordo può essere omologato anche con il Fisco dissenziente (quando lo merita), dall’altro il debitore deve garantire che l’Erario non sia l’unico a subire lo stralcio e che riceva un pagamento proporzionato.
In pratica, l’accordo di ristrutturazione ha senso quando si ha un numero limitato di creditori decisivi disposti a negoziare (es. le banche principali, alcuni fornitori strategici), e si vogliono vincolare tutti gli altri a una soluzione sostenibile una volta raggiunto il consenso qualificato. Se invece il consenso è frammentato o incerto, spesso si deve optare per il concordato preventivo, che – come vedremo – offre strumenti coercitivi maggiori (imponendo la soluzione anche alle minoranze) a fronte però di maggiori complessità.
(Si noti che esistono vari tipi particolari di accordi di ristrutturazione previsti dal Codice, come quelli ad efficacia estesa già menzionati, gli accordi di ristrutturazione del debito tributario (art. 63 CCII) dedicati solo a piani con Fisco/INPS, e perfino accordi di ristrutturazione destinati a risolvere crisi di gruppi di imprese. Per brevità ci concentriamo sul funzionamento generale).
La transazione fiscale e contributiva
Un capitolo importante, trasversale alle procedure di accordo e concordato, è la transazione fiscale (e contributiva). Questo istituto, introdotto nell’ordinamento prima nel 2006 e oggi disciplinato dall’art. 63 CCII (per gli accordi) e dall’art. 88 CCII (per i concordati), consente al debitore di proporre al Fisco e agli enti previdenziali un trattamento agevolato dei loro crediti nell’ambito di un piano di risanamento. In parole semplici, significa che anche i debiti per imposte e contributi possono essere pagati in parte e/o dilazionati dal piano, anziché integralmente ed immediatamente, previa adesione (o cram-down) da parte delle relative Amministrazioni.
Prima delle riforme, i crediti fiscali e contributivi erano “intoccabili” in concordato (in particolare l’IVA e le ritenute erano considerati crediti “privilegiati indisponibili” da soddisfare integralmente). Dal 2017 in poi le cose sono cambiate: oggi è ammesso proporre il pagamento parziale dei tributi e dei contributi maturati fino alla data della proposta di accordo/concordato, purché il trattamento offerto sia migliore di quello che i crediti pubblici avrebbero in caso di liquidazione. Questo principio della convenienza per l’Erario è centrale: lo Stato accetta di rinunciare a una parte del credito solo se ciò è giustificato da un ritorno più alto rispetto alla liquidazione giudiziale (dove spesso incasserebbe poco o nulla). Non solo: nel concordato in continuità aziendale, la legge richiede anche che il trattamento del Fisco e dell’INPS non sia deteriore rispetto a quello degli altri creditori di pari grado (in sostanza, non si possono discriminare eccessivamente i crediti erariali rispetto ad altri chirografari, devono ricevere almeno lo stesso % di soddisfacimento degli altri chirografari o delle classi inferiori).
La transazione fiscale avviene solitamente così: il debitore inserisce nel piano un certo pagamento (ad esempio, il 40% del debito IVA dilazionato in 5 anni) e presenta la proposta all’Agenzia delle Entrate e/o all’INPS. Queste, tramite uffici e commissioni interne, valutano la proposta. Dal 2021 vige l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di motivare un eventuale diniego comparando il risultato del piano con quello ipotizzabile in fallimento: se il piano offre di più, il Fisco non dovrebbe rifiutare per ragioni pretestuose (pena vedersi scavalcato dal giudice). Come accennato, le ultime riforme hanno anche specificato le competenze: dal settembre 2024 la decisione sull’adesione alle transazioni fiscali spetta ai Direttori regionali delle Entrate e ai Comitati regionali INPS, con tempi procedimentali fissati (90 giorni per rispondere). Ciò per uniformare e responsabilizzare le risposte degli enti pubblici.
Se l’Erario e l’ente previdenziale aderiscono, la transazione fiscale confluisce nell’accordo o concordato e diventa vincolante: in pratica il Fisco accetta di essere pagato nella percentuale X e nei tempi Y, rinunciando al resto. Se uno dei due (Agenzia Entrate o INPS) non aderisce, vi sono due possibilità:
- Nell’accordo di ristrutturazione: il debitore può chiedere comunque l’omologazione forzata (cram-down) se l’adesione dell’ente dissenziente era determinante per la maggioranza e se la proposta è conveniente per l’ente. Il tribunale può omologare l’accordo nonostante il diniego, legando comunque il Fisco/INPS ai termini offerti. Questo, come visto, è subordinato a garanzie di equità (presenza di altri creditori consenzienti, rispetto di soglie minime di soddisfazione per il Fisco) introdotte nel 2023.
- Nel concordato preventivo: se il Fisco o l’INPS votano contro, il concordato potrebbe comunque essere omologato d’ufficio dal giudice ex art. 88 CCII, a patto che sia rispettato il doppio criterio di convenienza e non deteriorità del loro trattamento (oltre, ovviamente, all’approvazione del concordato da parte delle altre classi di creditori). Ad esempio, se il Fisco prende 30% nel concordato e in caso di fallimento stimato ne prenderebbe 10%, il tribunale può omologare anche contro il voto contrario dell’Erario, ritenendo soddisfatto il requisito di convenienza.
In definitiva, la transazione fiscale è uno strumento essenziale per risolvere le crisi dove vi siano forti debiti fiscali o contributivi. Senza di essa, molti piani sarebbero impossibili perché imporre il pagamento integrale di IVA, ritenute e contributi renderebbe il piano insostenibile. Grazie alla transazione, invece, anche il Fisco “partecipa al sacrificio” nei limiti del ragionevole. Va da sé che la credibilità del piano e dell’imprenditore giocano un ruolo: l’Amministrazione finanziaria tende ad aderire se vede concrete chance di risanamento e se il debitore offre tutto il possibile (magari coinvolgendo terzi garanti o offrendo pagamento cash di una parte). Una volta perfezionata la transazione, peraltro, il debitore dovrà rispettarla rigorosamente: il mancato pagamento anche di una sola rata della transazione fiscale può far decadere i benefici e precipitare nuovamente la situazione.
Il concordato preventivo (e il concordato minore)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale vera e propria a cui il debitore può accedere per evitare la liquidazione giudiziale, proponendo un piano di ristrutturazione con il coinvolgimento di tutti i creditori. È disciplinato dagli artt. 84-120 CCII. Può accedervi qualsiasi imprenditore commerciale insolvente o in crisi (anche non ancora insolvente, grazie alla finalità di prevenzione), purché fallibile secondo i parametri visti. Per le imprese non fallibili esiste invece il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che è concettualmente simile ma rientra tra le procedure di sovraindebitamento.
La caratteristica del concordato è di essere una procedura giudiziale: il tribunale supervisiona sin dall’inizio. Il debitore deposita una domanda di concordato con un piano e una proposta dettagliata di pagamento ai creditori, corredata dei documenti previsti (stato patrimoniale, elenco creditori, relazione di un professionista indipendente che attesta la fattibilità del piano, etc.). Il tribunale, verificati i requisiti iniziali, ammette la società al concordato e nomina un commissario giudiziale, figura terza incaricata di vigilare sulla gestione durante la procedura e di riferire ai creditori e al giudice. Dalla data di pubblicazione del ricorso in concordato nel Registro delle Imprese scatta un effetto automatico di blocco: i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari né acquisire ipoteche sui beni del debitore (la cosiddetta automatic stay concorsuale ex art. 54 CCII). L’impresa continua la gestione ordinaria, ma per gli atti straordinari deve essere autorizzata dal tribunale (su parere del commissario).
Il piano di concordato può prevedere diverse soluzioni: proseguimento dell’attività (concordato in continuità aziendale) oppure cessazione dell’attività e liquidazione dei beni (concordato liquidatorio), o formule miste. Spesso il piano contempla la suddivisione dei creditori in classi omogenee (facoltativa in generale, obbligatoria se si trattano diversamente creditori di posizione giuridica equivalente) e può offrire ai creditori soddisfazioni differenziate (es: pagare 100% i fornitori strategici in continuità e 20% gli altri chirografari; oppure, in un liquidatorio, pagare 5% i chirografari). Il vincolo di legge è che, se il concordato è di tipo liquidatorio puro (cioè senza prosecuzione dell’azienda), deve assicurare almeno il 20% di soddisfacimento ai creditori chirografari; se è in continuità, non c’è una percentuale fissa minima, ma il piano deve comunque garantire che ai creditori chirografari arrivi una quota non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione giudiziale (principio di convenienza). In ogni caso, non si possono mai alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione: i creditori privilegiati vanno pagati integralmente salvo che rinuncino in parte al privilegio o che il valore dei beni su cui vantano garanzia sia insufficiente (in tal caso la parte eccedente diventa chirografaria e può essere falcidiata).
Una volta depositato il piano, il tribunale lo sottopone al voto dei creditori: si indice un’adunanza dei creditori in cui il debitore illustra la proposta e i creditori possono discuterla. I creditori poi votano (anche per corrispondenza o PEC, non è necessario siano presenti fisicamente). Per l’approvazione serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se vi sono più classi, occorre anche la maggioranza delle classi, ma è previsto un meccanismo di cram-down di classe per cui il tribunale può omologare il concordato anche con il dissenso di classi minoritarie, purché almeno una classe di creditori non privilegiati abbia approvato e la proposta sia comunque conveniente per i creditori dissenzienti. Superata la fase del voto (eventualmente con contestazioni e astensioni), il tribunale passa all’omologazione: verifica il rispetto delle norme (ad es. che i privilegiati non siano pregiudicati, che la percentuale minima ai chirografari sia garantita, ecc.) e omologa il concordato rendendolo efficace per tutti i creditori, anche per quelli che hanno votato contro o non si sono presentati. Da quel momento il piano concordatario diventa vincolante: i creditori riceveranno i pagamenti secondo le tempistiche e le percentuali previste e non potranno agire oltre quanto stabilito.
Vantaggi per il debitore:
- Il concordato preventivo offre la più ampia protezione: congela le azioni dei creditori immediatamente e per tutta la durata della procedura, salvaguardando l’azienda mentre si attuano le misure di risanamento.
- Consente di ridurre e ristrutturare i debiti anche senza l’unanimità: una volta ottenuto il voto della maggioranza, tutti i creditori sono obbligati a subire le eventuali riduzioni o dilazioni stabilite dal piano (principio maggioritario).
- Nel concordato in continuità, l’imprenditore può mantenere la gestione (sia pure sotto controllo del commissario) e provare a proseguire l’attività, conservando valore aziendale e posti di lavoro.
- È possibile anche l’intervento di terzi (soci, nuovi investitori) che apportino finanza durante il concordato con il beneficio della prededuzione (cioè verranno rimborsati prima degli altri creditori, se il concordato va a buon fine).
- Una volta omologato il concordato, l’impresa risanata riparte libera dai debiti residui secondo quanto previsto nel piano.
Svantaggi e rischi:
- Il concordato è una procedura complessa e costosa: richiede una mole di documenti, il coinvolgimento di legali e consulenti, l’attestazione di un professionista, e prevede la nomina di organi (commissario, eventuale giudice delegato) con relative spese. Non tutte le imprese in crisi hanno le risorse finanziarie e organizzative per affrontare un concordato (paradossalmente, serve un minimo di “tenuta” per gestire la procedura concorsuale stessa).
- È un procedimento pubblico: l’iscrizione al Registro imprese e la comunicazione ai creditori fanno sì che la notizia diventi di dominio pubblico, con possibili riflessi negativi su reputazione, rapporti commerciali, ecc. (anche se ormai l’uso del concordato è abbastanza destigmatizzato rispetto al passato).
- L’esito non è garantito: bisogna ottenere il voto favorevole dei creditori. Se i creditori bocciano la proposta (oppure se il tribunale non omologa per qualche motivo di legge), l’azienda molto probabilmente finirà in liquidazione giudiziale. Quindi il concordato è un “tutto o niente”: se fallisce, spesso scatta il fallimento vero e proprio (anche su iniziativa del P.M.).
- Durante la procedura, la gestione dell’impresa è vincolata e sottoposta a scrutinio. Il commissario giudiziale deve autorizzare atti di gestione straordinaria e può segnalare al tribunale eventuali irregolarità o peggioramenti (in casi gravi, il tribunale può anche revocare la procedura e aprire il fallimento in anticipo). Insomma, l’imprenditore perde la piena autonomia decisionale nel tentativo di risanamento.
- I tempi possono essere non brevissimi: tra ammissione, voto e omologa possono passare diversi mesi (6-12 mesi tipicamente), durante i quali l’azienda vive in una sorta di limbo concorsuale.
Il concordato minore merita un breve cenno: è la procedura di concordato riservata ai debitori non fallibili (sovraindebitati non consumatori, quindi piccole imprese sotto soglia, professionisti, start-up innovative in periodo protetto, ecc.). Dal punto di vista sostanziale, ricalca il concordato preventivo: il debitore propone un piano ai creditori, c’è un voto (maggioranza calcolata sul totale crediti; se vi è un unico creditore è il tribunale a valutare la meritevolezza della proposta ex art. 79 CCII), e poi l’omologazione. Anche nel concordato minore vale la regola del 20% minimo ai chirografari in caso liquidatorio. Le differenze sono procedurali: il concordato minore si gestisce davanti al giudice di tribunale in composizione monocratica (non il collegio), e soprattutto il debitore sovraindebitato viene affiancato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un organismo previsto per assistere i sovraindebitati (spesso istituito presso gli Ordini professionali locali). L’OCC svolge funzioni simili al commissario, aiutando nella predisposizione del piano e nella gestione della procedura. In generale, però, gli effetti per il debitore e i creditori sono analoghi al concordato “maggiore”: stay delle azioni esecutive, pagamento parziale dei debiti secondo il piano omologato, ecc. Il concordato minore è dunque uno strumento prezioso per il piccolo imprenditore in crisi, che prima della riforma non aveva accesso al concordato preventivo tradizionale.
Il concordato semplificato post-composizione negoziata
Abbiamo accennato al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII): si tratta di una particolare forma di concordato, introdotta dapprima in via transitoria nel 2021 e poi stabilizzata nel Codice, attivabile solo dall’imprenditore che abbia esperito senza successo una composizione negoziata. Se le trattative assistite dall’esperto non portano ad alcuna soluzione e l’impresa è insolvente, il debitore può, entro 60 giorni, presentare questa proposta di concordato semplificato al tribunale. La caratteristica dirompente è che non è previsto il voto dei creditori: il piano viene comunicato ai creditori, i quali hanno solo la facoltà di fare opposizione in sede di omologazione, ma non c’è una votazione. Il piano deve prevedere necessariamente la liquidazione di tutto il patrimonio del debitore da effettuarsi sotto il controllo del tribunale (quindi di fatto è un concordato liquidatorio puro, senza continuità). Il tribunale omologa il concordato semplificato solo se ritiene che la proposta sia più vantaggiosa per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (c.d. test di convenienza), tenuto conto delle eventuali opposizioni dei creditori.
Il concordato semplificato è dunque una sorta di “paracadute” finale: evita alcuni passaggi (voto, maggioranze) per accelerare la liquidazione concordataria dell’impresa quando è ormai chiaro che non c’è altra via. È semplificato perché manca la fase deliberativa dei creditori e il piano può essere molto essenziale (basta indicare come si intende liquidare e distribuire l’attivo, rispettando le priorità dei creditori). Tuttavia, i creditori sono tutelati dal controllo rigoroso del giudice: se la proposta non garantisce loro un ritorno almeno pari a quello fallimentare, l’omologa sarà negata. Inoltre, nel concordato semplificato non è ammessa la continuità aziendale: l’impresa viene liquidata e cessata. Anche la transazione fiscale è ammessa solo nei limiti della liquidazione (non avrebbe senso prevedere stralci ulteriori, essendo già un realizzo totale).
In pratica, il concordato semplificato si è visto raramente finora, perché è uno scenario di chiusura: molte imprese che approdano al semplificato finiscono per essere di fatto liquidate come in un fallimento, ma con la piccola differenza che è il debitore a gestire (in parte) la procedura propositiva e può magari scegliere il liquidatore o modulare la vendita degli asset. Per i creditori cambia poco rispetto a un fallimento, se non che risparmiano i tempi della dichiarazione di insolvenza iniziale e partecipano direttamente alla ripartizione secondo il piano.
La liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Se nessuno degli strumenti di risanamento o concordato ha successo – o se ci si attiva troppo tardi, quando la situazione è compromessa e i creditori non sono più disponibili a trattare – l’esito naturale è l’insolvenza irreversibile e l’apertura di una liquidazione giudiziale (ciò che in passato si chiamava fallimento). Questa procedura, disciplinata dagli artt. 121-270 CCII, viene aperta dal tribunale su ricorso di un creditore, del debitore stesso (cosiddetto fallimento in proprio) o su iniziativa del P.M. in certi casi, quando accerta che il debitore è insolvente e fallibile. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale determina per l’imprenditore effetti dirompenti:
- Spoglio della gestione: gli amministratori perdono potere di amministrazione e disposizione del patrimonio; viene nominato un Curatore fallimentare che si occupa di amministrare e liquidare i beni nell’interesse di tutti i creditori. La società fallita prosegue in vita solo per gli atti del curatore, finalizzati alla liquidazione.
- Sospensione delle azioni individuali: tutti i creditori devono portare i loro crediti nel passivo fallimentare (presentando domanda di insinuazione); non possono più iniziare o proseguire pignoramenti né cause esecutive autonome (si attua il principio della parità di trattamento).
- Liquidazione dell’attivo: il curatore, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, trasforma in denaro tutto il patrimonio dell’impresa: vende immobili, macchinari, merci, crediti, eventuali rami d’azienda. Può anche proseguire temporaneamente l’esercizio d’impresa se funzionale a una migliore vendita (es. completare commesse in corso).
- Riparto ai creditori: una volta raccolto il ricavato (detratte le spese della procedura), il curatore distribuisce le somme ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima i creditori prededucibili (spese di procedura, nuovi finanziamenti autorizzati, ecc.), poi i privilegiati (dipendenti, erario, banche ipotecarie, etc.) nell’ordine dei privilegi, e infine, se resta qualcosa, ai creditori chirografari in proporzione. Molto spesso i creditori chirografari non ricevono nulla o solo pochi centesimi per euro di credito.
- Controlli e azioni di responsabilità: nella liquidazione giudiziale vengono esaminati gli atti compiuti prima del fallimento: il curatore può promuovere azioni revocatorie (per recuperare pagamenti o atti dispositivi fatti dal debitore nei periodi sospetti pre-fallimento, a tutela della par condicio) e azioni di responsabilità verso amministratori o soci (se hanno commesso illeciti che hanno aggravato il dissesto). Inoltre, la sentenza dichiarativa d’insolvenza viene comunicata alla Procura e può dare impulso a indagini per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta, preferenziale, documentale, ecc. in caso di distrazione di beni o favori ad alcuni creditori prima del fallimento).
Per l’imprenditore, la liquidazione giudiziale rappresenta la sconfitta finale: l’attività viene spazzata via (salvo rarissimi casi di esercizio provvisorio con successiva cessione a terzi che la continuino), il patrimonio residuo è liquidato e lui perde la disponibilità dei beni. Se si tratta di una società di capitali (es. una S.r.l.), la procedura si conclude con la cancellazione della società dal registro imprese: la società cessa di esistere e i debiti non soddisfatti restano inesigibili (i creditori non possono più nulla, salvo far escutere eventuali fideiussioni personali di soci o terzi). Se invece è un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile (S.n.c., S.a.s.), la procedura coinvolge anche il patrimonio personale, ma – attenzione – in tal caso dopo la chiusura esiste la possibilità di liberarsi dei debiti residui tramite l’esdebitazione.
Da un lato, la liquidazione giudiziale tutela i creditori garantendo un processo ordinato e controllato di liquidazione e riparto, evitando la “corsa al bottino” tra creditori. Dall’altro, raramente massimizza il valore: i beni venduti in ambito fallimentare spuntano prezzi spesso inferiori al valore di mercato, i costi di procedura erodono parte dell’attivo, e i tempi lunghi fanno perdere valore all’avviamento. È per questo che tutte le procedure descritte prima puntano a evitare il fallimento, come recita una massima: il concordato preventivo si propone di distribuire fra i creditori una torta più grande di quella che avrebbero in fallimento.
L’esdebitazione del debitore
Una delle poche note positive, per l’imprenditore onesto ma sfortunato che abbia subito la liquidazione giudiziale, è la possibilità di ottenere l’esdebitazione, cioè l’effetto di liberazione dai debiti residui non pagati nella procedura. Questo meccanismo, introdotto già dal 2006 e confermato nel CCII, consente al debitore persona fisica di avere un fresh start dopo il fallimento: chiusa la procedura, i debiti rimasti vengono cancellati e il debitore può ripartire senza l’oppressione delle vecchie esposizioni (salvo poche eccezioni come debiti per mantenimenti familiari, risarcimenti da illecito e sanzioni penali/amministrative, che per legge restano comunque dovuti).
Nel Codice della Crisi l’esdebitazione opera in due forme:
- Esdebitazione “ordinaria” (artt. 278-279 CCII): il debitore fallito (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) ottiene di diritto l’esdebitazione di tutti i debiti concorsuali al termine della liquidazione giudiziale, senza necessità di una specifica istanza, purché non vi siano opposizioni dei creditori o cause ostative (es: condanne per bancarotta) e abbia cooperato lealmente. Questo è un progresso rispetto al passato, dove occorreva una domanda formale di esdebitazione e un giudizio apposito. Ora la liberazione dai debiti è quasi automatica per il fallito meritevole. Il tribunale può comunque revocarla su ricorso di creditori se emergono comportamenti fraudolenti.
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): questa è una novità assoluta introdotta dalla riforma. Riguarda quei debitori (sempre persone fisiche) che non hanno alcun patrimonio da liquidare e dunque in procedura concorsuale i creditori non ottengono nulla. In passato costoro non potevano beneficiare dell’esdebitazione perché non avevano “pagato” nulla ai creditori; oggi invece la legge consente, una sola volta nella vita, di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui anche se il debitore non ha contribuito a soddisfarli affatto. È una sorta di “grazia” per il debitore veramente disperato (definito appunto incapiente). Le condizioni sono molto stringenti: può accederVi solo il debitore persona fisica (le società sono escluse) che sia meritevole (ossia che non abbia colpa grave o dolo nel proprio indebitamento, né abbia violato i doveri di collaborazione nella procedura) e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno futura. In pratica deve essere nullatenente e senza prospettive reddituali apprezzabili. Inoltre non deve aver già beneficiato di un’esdebitazione in passato. Se queste condizioni sono provate, il tribunale – su istanza del debitore – emette un decreto di esdebitazione totale immediata. È una seconda chance per il debitore civile onesto ma sfortunato: ad esempio piccoli imprenditori che si sono indebitati per la loro attività, hanno perso tutto e non hanno modo di pagare, possono tornare cittadini “puliti” sul piano debitorio dopo la chiusura della liquidazione controllata.
L’esdebitazione (in entrambe le forme) non cancella eventuali responsabilità penali per fatti di bancarotta, né tocca le garanzie di terzi: se ad esempio un socio aveva garantito un debito sociale, quel socio (se non fallito personalmente) ne risponde ancora. Cancella però i debiti civili del debitore principale verso i creditori concorsuali, i quali non potranno più pretendere nulla oltre a quanto ricevuto in procedura.
Per fare un esempio: immaginiamo che la nostra azienda di convertitori finisca in liquidazione giudiziale e, su €600.000 di debiti, i creditori ne ricavino solo €100.000 dalla vendita dei beni. Resterebbero €500.000 di debiti insoddisfatti. Ebbene, se il titolare era un imprenditore individuale, dopo la chiusura potrà ottenere l’esdebitazione: quei €500.000 non potranno più essergli richiesti, permettendogli magari di ripartire con una nuova attività (o cercare un impiego) senza dover destinare tutto ai vecchi creditori. Se invece la forma era una S.r.l., l’esdebitazione non serve perché la società una volta liquidata si estingue e quei debiti “muoiono” con essa; i soci persone fisiche non avevano debito diretto (salvo fideiussioni, che però sono debiti personali extra-fallimentari). Discorso diverso per i soci di società di persone: essi falliscono insieme alla società e possono chiedere anch’essi l’esdebitazione da tutti i debiti sociali rimasti.
Va segnalato che l’orientamento moderno, in linea con l’UE, è di favorire il fresh start degli imprenditori onesti: la Direttiva UE 2019/1023 ha spinto molto su questo concetto. L’Italia con il CCII ha recepito tale impostazione, semplificando l’accesso all’esdebitazione e introducendo quella dell’incapiente per i casi più drammatici. Di fatto, oggi la crisi d’impresa non è più una “condanna a vita” per il debitore: se si agisce correttamente, o si riesce a risanare con gli strumenti preventivi, oppure – se proprio si fallisce – c’è comunque la possibilità di ripartire da zero senza i fantasmi dei debiti passati.
Domande frequenti (FAQ) sulla difesa delle aziende indebitate
D: La mia azienda è sommersa dai debiti: rischio il fallimento immediato?
R: Non necessariamente immediato. Il fallimento (liquidazione giudiziale) richiede che l’impresa sia insolvente e superi certe soglie dimensionali (attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k). Se la tua è una piccola impresa sotto questi parametri, non può essere dichiarata fallita (sarà eventualmente soggetta a procedure minori di sovraindebitamento). Se invece è sopra soglia, i creditori potrebbero chiedere il fallimento, ma di solito lo fanno come ultima ratio. Spesso preferiscono tentare prima recuperi individuali o soluzioni negoziali. In ogni caso, finché riesci a pagare anche parzialmente i debiti (magari con ritardi), potresti non essere considerato insolvente dal tribunale. Il consiglio è: non aspettare di essere trascinato in tribunale. Se vedi che la situazione debitoria peggiora, attivati tu stesso con un piano di risanamento o una procedura concorsuale prima che i creditori perdano la pazienza e depositino un’istanza di fallimento.
D: Che differenza c’è tra un piano attestato di risanamento e un accordo di ristrutturazione omologato?
R: Entrambi sono strumenti per regolare la crisi evitando il fallimento, ma hanno diversa natura. Il piano attestato è un accordo stragiudiziale al 100%: non coinvolge il tribunale, richiede solo il consenso (informale) dei creditori che il debitore riesce a coinvolgere e l’attestazione di un professionista indipendente sulla fattibilità. È rapido e riservato, ma non vincola i creditori dissenzienti né offre protezione legale dalle azioni esecutive. L’accordo di ristrutturazione invece è un procedimento omologato dal tribunale: serve il consenso di una maggioranza (di regola il 60% dei crediti) e l’omologazione giudiziaria, dopodiché l’accordo diventa vincolante per i partecipanti e consente di bloccare eventuali azioni esecutive durante l’iter. Vantaggi: nell’accordo omologato puoi anche costringere alcuni creditori dissenzienti a rispettare l’intesa (grazie all’efficacia estesa) e ottieni uno stay legale. Svantaggi: è più lento e pubblico rispetto al piano attestato, e se non raggiungi la soglia di adesioni richiesta, non si perfeziona. In breve, piano attestato = approccio contrattuale flessibile, accordo omologato = approccio semi-concorsuale, più vincolante.
D: In cosa consiste esattamente la composizione negoziata? Vale la pena tentarla?
R: La composizione negoziata è una procedura introdotta di recente per aiutare le imprese in crisi a trovare un accordo con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente. Si svolge fuori dal tribunale (tranne che per eventuali misure protettive) ed è riservata. Vale la pena tentarla se l’azienda ha ancora possibilità di recupero ma ha bisogno di tempo e di negoziare a 360° con i creditori. I benefici sono: la nomina di un esperto che analizza la situazione e media le trattative, e la possibilità di ottenere dal tribunale una protezione temporanea (blocco dei pignoramenti) mentre si cerca l’accordo. Inoltre, se le trattative riescono, potrai formalizzare il risultato in un accordo legalmente valido (anche omologato, se necessario). Se invece non riescono, hai comunque evitato nel frattempo azioni aggressive e puoi ancora accedere ad altre procedure, inclusa quella speciale del concordato semplificato (senza voto dei creditori). In definitiva, la composizione negoziata è consigliabile come tentativo preliminare quando c’è apertura al dialogo: ha costi contenuti e in caso di insuccesso non ti preclude altre opzioni successive. Se però la situazione è già gravemente compromessa (creditori ostili, insolvenza conclamata), potrebbe rivelarsi un passaggio inutile, e conviene passare direttamente a un concordato preventivo o altra procedura formale.
D: Posso includere i debiti fiscali nel mio piano di ristrutturazione? L’Agenzia delle Entrate accetterà stralci del mio debito?
R: Sì, oggi è possibile includere i debiti tributari e contributivi in un piano, prevedendo anche un pagamento parziale e/o dilazionato di essi, attraverso la cosiddetta transazione fiscale. Ad esempio, puoi proporre di pagare il 50% del tuo debito IVA in 5 anni. L’adesione dell’Agenzia delle Entrate (o dell’INPS per i contributi) dipende dalla convenienza della proposta: per legge, queste enti possono accettare una riduzione se mostrI che nel fallimento percepirebbero meno (o nulla). Dal 2021 l’Amministrazione finanziaria è tenuta a confrontare la tua proposta con l’alternativa liquidatoria e a non rifiutare irragionevolmente se la tua offerta è più vantaggiosa. In caso di accordo di ristrutturazione, se il Fisco non aderisce ma la tua proposta è oggettivamente valida e hai il restante consenso richiesto, puoi chiedere al tribunale di omologare comunque l’accordo (imponendolo anche al Fisco dissenziente). Nel concordato preventivo, similmente, il giudice può omologare d’ufficio malgrado il voto contrario del Fisco se la percentuale che offri è migliore di quella ricavabile dalla liquidazione. In pratica l’Agenzia delle Entrate di solito accetta transazioni fiscali quando: (a) la proposta è seria, ben documentata e superiore al presumibile incasso in caso di fallimento; (b) il debitore ha un comportamento collaborativo e trasparente. Non aspettarti però “sconti” eccessivi se hai patrimoni occultabili: il Fisco esige che tu metta sul piatto tutto il possibile. Ricorda infine che la transazione fiscale diventa vincolante solo con l’omologazione del concordato/accordo: se poi non rispetti i pagamenti concordati, tornerai debitore dell’intero importo originario al netto di quanto eventualmente già pagato.
D: Ho già dei decreti ingiuntivi e pignoramenti in corso da parte di fornitori e banche. Posso fermarli avviando una procedura concorsuale?
R: Sì. Sia l’accordo di ristrutturazione sia, ancor di più, il concordato preventivo prevedono la sospensione delle azioni esecutive individuali. In pratica, dal momento in cui presenti ricorso per concordato (o domanda di omologazione di un accordo) e questo viene pubblicato, scatta un divieto per i creditori di procedere con pignoramenti o di proseguirli se già avviati. Dunque, ad esempio, un pignoramento immobiliare in corso viene “congelato” durante il concordato. Questo effetto protettivo dura per tutta la procedura (nel concordato) o per il tempo necessario all’omologazione (nell’accordo). Nel frattempo, dovrai trovare una soluzione per quei creditori all’interno del piano. Se poi la procedura va a buon fine, quei creditori saranno soddisfatti secondo il piano omologato; se invece la procedura dovesse saltare, i pignoramenti riprenderanno da dove si erano fermati. Nota che anche la composizione negoziata consente di ottenere, con decreto del tribunale, la sospensione dei pignoramenti per qualche mese: quindi può essere uno strumento da usare subito per guadagnare tempo e poi magari presentare un concordato. In ogni caso, avviare formalmente una procedura è l’unico modo per obbligare legalmente i creditori a fermarsi: fuori da queste, puoi solo chiedere volontariamente una pausa ai creditori (che però non sono tenuti a concederla).
D: Qual è la differenza tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale?
R: Sono due percorsi molto diversi. Il concordato preventivo è una procedura che tu, debitore, scegli volontariamente per risanare o liquidare l’azienda sotto il tuo controllo, proponendo un piano e mantenendo un certo grado di gestione (specialmente se in continuità). Ha come scopo di evitare il fallimento, e infatti se viene omologato l’impresa non è dichiarata insolvente e può proseguire l’attività (se in continuità) o comunque il debitore beneficia dell’esdebitazione a fine piano. La liquidazione giudiziale (fallimento) invece è una procedura subita, tipicamente avviata dai creditori o d’ufficio: il tribunale ti dichiara insolvente e nomina un curatore che liquida tutto il patrimonio. Il controllo passa interamente nelle mani degli organi della procedura, tu perdi la disponibilità dei beni e l’azienda normalmente cessa l’attività (salvo brevi esercizi provvisori per vendere meglio). In sintesi, nel concordato hai ancora l’iniziativa e speri di salvare il salvabile concordando coi creditori; nella liquidazione giudiziale hai perso l’iniziativa e subisci una liquidazione forzata secondo regole legali. Ovviamente, dal punto di vista di difesa del debitore, il concordato è preferibile perché consente maggiori margini di manovra e la conservazione di valore, mentre il fallimento è l’extrema ratio quando non c’è più nulla da fare.
D: Se la mia società (S.r.l.) fallisce, i soci o amministratori rischiano responsabilità personali?
R: In generale, una società di capitali risponde delle obbligazioni sociali solo col suo patrimonio, quindi i soci non sono personalmente responsabili dei debiti della S.r.l. (a meno che avessero prestato garanzie personali come fideiussioni: in tal caso, il creditore escuterà la garanzia anche se la società fallisce). Tuttavia, gli amministratori e i sindaci potrebbero essere chiamati a rispondere di atti di mala gestio: nel fallimento, come accennato, il curatore può promuovere un’azione di responsabilità verso gli amministratori se hanno compiuto violazioni di legge o gestione imprudente che hanno aggravato il dissesto. Questo è sul piano civilistico (risarcitorio). Sul piano penale, se emergono condotte distrattive o fraudolente (ad esempio libri contabili falsificati, patrimoni fatti sparire, pagamenti preferenziali intenzionali), gli amministratori possono essere perseguiti per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta, preferenziale, documentale, ecc.) e, in caso di condanna, subire pene detentive e interdittive. I soci non amministratori di regola non hanno responsabilità penale per il fallimento (salvo casi di concorso se hanno beneficiato di distrazioni). Quindi, per riassumere: i soci di S.r.l. perdono il capitale investito ma non pagano i debiti sociali con beni propri (salvo fideiussioni); gli amministratori invece possono dover risarcire danni se hanno colpe nella gestione e rischiano incriminazioni penali se hanno commesso illeciti nella crisi. Per questo, una “difesa” del debitore in crisi passa anche dal comportarsi correttamente: niente uscite illegali di denaro, massima trasparenza con l’esperto o il tribunale, e attivarsi presto per evitare di erodere il patrimonio a danno dei creditori.
D: Dopo il fallimento (liquidazione giudiziale), dovrò continuare a pagare i debiti non soddisfatti?
R: Se sei una persona fisica, probabilmente no. La maggior parte dei debiti concorsuali residui, come visto, vengono cancellati tramite l’esdebitazione, a patto che tu abbia collaborato e non abbia commesso irregolarità gravi. Quindi, ad esempio, se il fallimento paga solo il 5% ai chirografari, il restante 95% del loro credito viene spazzato via e tu non dovrai ripagarlo in futuro. L’esdebitazione ordinaria oggi è quasi automatica a fine procedura (salvo opposizioni). Addirittura, se dal fallimento i creditori non ottengono nulla perché non c’era proprio patrimonio, puoi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente e liberarti dei debiti ugualmente. Se invece sei una società, la domanda non si pone: la società una volta liquidata si estingue e i debiti insoddisfatti muoiono con essa, senza bisogno di formale esdebitazione. Attenzione però: l’esdebitazione non copre eventuali debiti personali fuori dal fallimento (es. multe, debiti fiscali per periodi post-fallimentari, fideiussioni escusse) né i debiti derivanti da illecito extra-contrattuale o alimentare. Inoltre può essere revocata se si scoprono poi asset nascosti o frodi. In ogni caso, l’ordinamento tende a dare al fallito onesto la possibilità di ripartire senza uno zaino di debiti impagabili sulle spalle.
Tabelle riepilogative
Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive che condensano le informazioni chiave esposte nella guida.
Tabella 1 – Soglie di rilevanza penale per omessi versamenti fiscali e contributivi
| Tipo di omesso versamento | Soglia oltre la quale scatta il reato | Norma violata | Sanzione |
|---|---|---|---|
| IVA annuale non versata (per ciascun periodo d’imposta) | > €250.000 | Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 | Reclusione fino a 3 anni (oltre multa) |
| Ritenute fiscali operate e non versate (annue) | > €150.000 | Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 | Reclusione fino a 3 anni (oltre multa) |
| Contributi previdenziali trattenuti e non versati (annui) | > €10.000 | Art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983 (conv. L. 638/83) | Reclusione fino a 3 anni (oltre multa) |
Nota: La soglia per contributi si riferisce alle ritenute previdenziali dovute per i lavoratori dipendenti. Il mancato versamento di contributi propri (ad esempio i contributi artigiani/commercianti) non costituisce reato ma comporta solo sanzioni civili.
Tabella 2 – Confronto sintetico tra principali strumenti di composizione della crisi d’impresa
| Strumento | Carattere | Coinvolgimento del tribunale | Adesione dei creditori richiesta | Effetti sui creditori |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Stragiudiziale puro (negoziale) | Nessuno (salvo deposito volontario al Registro imprese) | Nessuna soglia legale (si punta al massimo consenso possibile) | Vincola solo i creditori aderenti; nessuna protezione automatica: creditori non aderenti possono agire liberamente. Atti esecutivi del piano non revocabili in fallimento. |
| Accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57-60 CCII) | Stragiudiziale con omologazione giudiziaria | Sì, limitatamente alla fase di omologazione (tribunale interviene ex post) | 60% dei crediti (accordo ordinario). Possibile accordo agevolato al 30% in casi particolari. | Vincola i creditori aderenti; stay legale dalle azioni esecutive dopo deposito e fino a omologazione. Possibile estensione ai dissenzienti di determinate classi (efficacia estesa). Transazione fiscale possibile (cram-down Enti dissenzienti con condizioni). |
| Composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII) | Procedura volontaria assistita (non concorsuale) | Minimo (solo per misure protettive, autorizzazioni e eventuale omologa di accordi accessori) | Nessuna percentuale predeterminata: si negozia liberamente con chiunque necessario. | Non vincolante di per sé (esito dipende dagli accordi che si riusciranno a concludere). Possibile decreto di misure protettive che sospende temporaneamente le azioni esecutive dei creditori. Se si raggiunge un accordo, può essere reso efficace con omologazione o con concordato. |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale | Sì, fin dall’inizio (tribunale ammette e nomina commissario; controllo su tutta la procedura) | Nessuna adesione preventiva; dopo, serve approvazione dei creditori in maggioranza (>50% crediti votanti). Voto per classi se previste. | Vincola tutti i creditori anteriori (cram-down generale). Tutte le azioni esecutive sospese dall’ammissione. Pagamenti secondo il piano omologato (possibili stralci anche significativi, rispettando il 20% min ai chirografari se liquidatorio). Transazione fiscale ammessa (Fisco vincolato se concordato omologato anche se dissenziente, requisiti art. 88 CCII). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria | Sì, totale spossessamento del debitore e gestione affidata a curatore nominato dal tribunale | Non richiede consenso del debitore né dei creditori (è avviata d’ufficio su insolvenza accertata) | Vincola tutti i creditori. Esecuzioni individuali vietate, patrimonio liquidato e distribuito secondo la legge. Debitore persona fisica liberato dai debiti residui dopo chiusura (esdebitazione). Società estinta a fine procedura. |
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, in vigore dal 15 luglio 2022 e successive modifiche. In particolare: art. 2, c.1, lett. d) CCII (definizione di impresa minore, soglie dimensionali €300k/€200k/€500k); art. 3 CCII (obbligo di adeguati assetti e rilevazione tempestiva della crisi); art. 25-novies CCII (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, soglie allerta); Art. 25-decies CCII (obblighi di comunicazione delle banche ai debitori in previsione di revoca degli affidamenti); art. 25-sexies CCII (concordato semplificato post-composizione negoziata); artt. 12-25-octies CCII (composizione negoziata della crisi); art. 56 CCII (piano attestato di risanamento); artt. 57-64 CCII (accordi di ristrutturazione dei debiti); art. 61 CCII (accordi ad efficacia estesa); art. 63 CCII (transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione); art. 64-bis CCII (piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, introdotto da D.Lgs. 83/2022); art. 84 CCII (presupposti del concordato preventivo, requisiti di fattibilità e soddisfacimento minimo 20% ai chirografari nei concordati liquidatori); art. 88 CCII (trattamento dei crediti tributari e previdenziali nel concordato preventivo, criteri di convenienza e non-deteriorità); art. 94 CCII (classi di creditori nel concordato); art. 112 CCII (votazione e approvazione del concordato preventivo); art. 121 CCII (presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale); artt. 278-279 CCII (esdebitazione di diritto del debitore fallito meritevole); art. 283 CCII (esdebitazione del debitore incapiente: requisiti e condizioni).
- Decreto-Legge 24 agosto 2021 n. 118 (conv. in L. 147/2021) – Introduzione della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e del concordato semplificato (misure urgenti post-pandemia).
- D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 – Primo correttivo al Codice della Crisi, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023: ha introdotto il nuovo concordato semplificato a regime, modificato la disciplina della transazione fiscale e adeguato il concordato preventivo (inserendo il criterio di trattamento non deteriore per Fisco/INPS nei concordati in continuità).
- D.L. 13 maggio 2023 n. 69 (conv. in L. 103/2023) – Ulteriori misure urgenti in materia di crisi d’impresa: ha abbassato al 30% la soglia di adesione per taluni accordi di ristrutturazione (accordi agevolati) e ha rafforzato i requisiti per l’omologazione forzosa in caso di mancata adesione del Fisco (richiesta pluralità di creditori aderenti e soglie minime di soddisfacimento).
- D.Lgs. 13 ottobre 2023 n. 136 – Secondo correttivo al CCII (“terzo correttivo” complessivo): ha riscritto l’art. 63 CCII (transazione fiscale negli accordi), chiarendo le competenze decisionali degli enti (Direttore regionale AE, comitati INPS) e ribadendo la possibilità di proporre il pagamento anche parziale dei tributi e contributi nel piano di ristrutturazione. Ha inoltre espressamente incluso la facoltà di concludere accordi di transazione fiscale nel corso della composizione negoziata.
- Codice Penale e Leggi Tributarie/Penal-tributarie: Art. 216 R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale); Art. 217 L.F. (bancarotta semplice e preferenziale, ora trasfusi negli artt. 322-323 CCII); D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000) e art. 10-ter (omesso versamento IVA oltre €250.000); Art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983 (omesso versamento contributi previdenziali oltre €10.000 annui).
- Cass., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935 – Onere della prova dei requisiti di non fallibilità a carico del debitore (ex art. 1 L.F., ora art. 2 CCII): spetta all’imprenditore dimostrare la sussistenza delle soglie di esenzione, tipicamente tramite i bilanci.
- Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018, n. 24138 – I bilanci depositati rappresentano prova privilegiata per determinare se un’impresa è “piccola” e non fallibile, ferma restando la possibilità di prova contraria sulla loro attendibilità.
- Cass., Sez. I, 13 novembre 2017, n. 26926 – Soglia minima di indebitamento (€30.000) per l’apertura del fallimento: va considerato il totale dei debiti scaduti e non pagati, non l’importo del singolo credito del creditore istante.
- Cass., Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 8965 – Potere-dovere del tribunale di escludere dal computo dei debiti rilevanti ai fini della fallibilità i crediti ormai prescritti, in quanto non più giuridicamente esigibili (principio confermato da Cass. Sez. I, 13 ottobre 2024, n. 29008).
- Cass., Sez. I, 27 luglio 2024, n. 20671 – La contestazione di un debito non ne impedisce l’inclusione nel passivo ai fini della soglia di fallibilità; il giudice deve però accertare incidentalmente se e in che misura tale debito vada conteggiato, tenendo conto di eventuali eventi riduttivi (nel caso, risoluzione di un leasing e vendita del bene avevano ridotto l’esposizione).
- Cass., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4201 – La concessione di una rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non esclude la qualificazione del debito tributario come “scaduto e non pagato” ai fini del superamento della soglia di €30.000 (art. 15, co.9 L.F., ora art. 49, co.5 CCII). Il debito va conteggiato per l’intero importo originario iscritto a ruolo, poiché l’Ente conserva il diritto di agire per l’immediato recupero integrale in caso di inadempimento al piano di rateazione.
- Cass., Sez. I, 1° giugno 2024, n. 1587 – Le start-up innovative non sono assoggettabili a fallimento nei primi 5 anni dalla costituzione ex art. 31 DL 179/2012; la cessazione anticipata dello status speciale (es. cancellazione dal registro delle start-up) non incide sull’esenzione quinquennale automatica prevista dalla legge.
- Cass., Sez. I, 6 maggio 2024, n. 12156 – Stato d’insolvenza in impresa posta in liquidazione volontaria: anche se l’impresa è in liquidazione, può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione se emerge che era insolvente (confermata fallibilità post-fusione entro un anno dalla cancellazione).
- Cass., Sez. I, 11 giugno 2025, n. 26370 – Sull’istanza di un creditore per la liquidazione giudiziale: il tribunale deve verificare incidentalmente l’esistenza del credito vantato (anche se contestato) e può desumere lo stato d’insolvenza dalla presenza di crediti certi e scaduti non onorati (anche se di un unico creditore, se significativo).
- Tribunale di Milano, sez. fall., 12 aprile 2023 (decreto) – Composizione negoziata: concesso il mantenimento delle misure protettive a fronte di trattative avanzate con potenziali investitori, ritenendo percorribile un accordo in continuità; rigettata l’istanza di fallimento pendente in attesa dell’esito delle negoziazioni (applicazione dell’art. 20, co. 3 CCII, che consente al tribunale di posticipare la decisione sull’istanza di liquidazione quando è in corso una composizione negoziata promettente).
- Corte d’Appello di Brescia, 11 giugno 2025 – In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII: confermata la possibilità di estendere gli effetti di un accordo ai creditori finanziari non aderenti appartenenti alla medesima categoria omogenea, quando l’accordo sia stato approvato dalla maggioranza qualificata (75%) di tale categoria e il loro trattamento non risulti deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Messaggio INPS n. 3553 del 25 ottobre 2024 – Indicazioni operative in seguito al D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo CCII) sulla transazione dei crediti contributivi: le proposte di transazione fiscale e contributiva presentate dopo il 28 settembre 2024 vanno decise dal Direttore regionale competente entro 90 giorni; l’adesione alla proposta, espressa dal Direttore regionale con firma dell’accordo, vincola l’INPS e vale come sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
La tua azienda che produce, integra, ripara o distribuisce variatori di velocità, convertitori di frequenza (inverter), azionamenti per motori elettrici, soft starter, drive AC/DC, controlli di potenza, pannelli di comando, sistemi di automazione e componenti per impianti industriali si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, integra, ripara o distribuisce variatori di velocità, convertitori di frequenza (inverter), azionamenti per motori elettrici, soft starter, drive AC/DC, controlli di potenza, pannelli di comando, sistemi di automazione e componenti per impianti industriali si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni con Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori, finanziarie o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore degli inverter e dei variatori è altamente tecnico e competitivo: richiede componenti elettronici costosi, schede di potenza, semiconduttori, firmware dedicati, collaudi approfonditi, certificazioni, un magazzino ben fornito e personale qualificato.
Basta un rallentamento degli incassi o una riduzione delle linee di credito per innescare una crisi seria.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata e rilanciata, se intervieni nel modo giusto e con rapidità.
Perché un’Azienda di Variatori e Convertitori di Frequenza Finisce in Debito
Le cause più diffuse includono:
- aumento dei costi di componenti elettronici, IGBT, schede di controllo, moduli di potenza
- difficoltà di approvvigionamento e prezzi elevati dei semiconduttori
- ritardi nei pagamenti da parte di OEM, EPC, integratori e industrie
- investimenti in software, firmware, testing, R&D e sistemi di diagnosi
- magazzino immobilizzato tra inverter, drive, ricambi, schede e moduli
- assistenza tecnica, installazioni e manutenzioni prima dell’incasso
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- progetti complessi con incassi posticipati e varianti continue
Il problema vero, nella quasi totalità dei casi, è la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per un’Azienda di Automazione con Debiti
Se non intervieni velocemente rischi:
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di componenti elettronici critici
- decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
- sequestro di inverter, variatori, drive, strumenti di collaudo e schede elettroniche
- impossibilità di completare commissioning, avviamenti e assistenze urgenti
- ritardi nelle consegne e perdita di clienti strategici
- rischio concreto di fermo totale dell’attività
Una crisi non gestita può fermare produzione, assistenza e consegne.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste di rientro urgente
- proteggere conti correnti e liquidità
- evitare il blocco delle forniture elettroniche strategiche
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si avvia la ristrutturazione.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molti debiti presentano irregolarità, ad esempio:
- interessi non dovuti o calcolati in modo errato
- sanzioni eccessive
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Entrate-Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni più efficaci comprendono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione delle linee bancarie
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- uso delle definizioni agevolate quando disponibili
L’obiettivo è ristabilire liquidità e mantenere la continuità operativa.
4. Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Per le crisi più gravi possono essere utilizzati:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- accordi di ristrutturazione
- concordato minore
- liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Questi strumenti:
- bloccano tutti i creditori
- sospendono pignoramenti e azioni esecutive
- permettono di pagare solo una parte dei debiti
- consentono di continuare a lavorare regolarmente
5. Proteggere produzione, materiali e assistenza
Per un’azienda di variatori e inverter è essenziale tutelare:
- inverter, variatori, drive AC/DC, schede, moduli IGBT
- strumenti di collaudo, software, licenze e firmware
- documentazione tecnica, manuali, certificazioni e log file
- rapporti con fornitori critici
- continuità delle commesse, commissioning e assistenze urgenti
Un blocco del magazzino può fermare subito l’intero reparto tecnico.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- Elenco completo dei debiti (fiscali, bancari, finanziari e commerciali)
- Estratti conto aggiornati
- Estratto di ruolo
- Bilanci e documentazione fiscale
- Elenco fornitori critici con relativi insoluti
- Inventario del magazzino (inverter, schede, moduli, drive, ricambi)
- Atti giudiziari ricevuti
- Commesse aperte e piani di consegna
Tempistiche di Intervento
- Analisi preliminare in 24–72 ore
- Blocco dei creditori in 48 ore – 7 giorni
- Piano di ristrutturazione in 30–90 giorni
- Eventuale procedura giudiziaria in 3–12 mesi
Le protezioni si attivano già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
- Stop immediato a pignoramenti
- Riduzione consistente dei debiti
- Protezione di magazzino, schede, strumenti di collaudo e materiali elettronici
- Trattative efficaci con banche, fornitori e Fisco
- Continuità produttiva, tecnica e commerciale
- Protezione, per quanto possibile, del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
- Ignorare solleciti e atti giudiziari
- Accendere nuovi debiti per pagare i vecchi
- Pagare alcuni fornitori ignorandone altri
- Lasciare avanzare pignoramenti senza reagire
- Affidarsi a società senza reale competenza legale
Ogni errore aumenta il rischio di fermo aziendale.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- Analisi completa della situazione debitoria
- Blocco immediato delle azioni dei creditori
- Creazione di piani di ristrutturazione personalizzati
- Attivazione degli strumenti giudiziari più efficaci
- Trattative mirate con banche, fornitori e Agenzia Entrate-Riscossione
- Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di variatori e convertitori di frequenza non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e mirata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre in modo significativo i debiti
- proteggere produzione, testing, assistenza e magazzino
- mantenere la continuità aziendale
- salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.