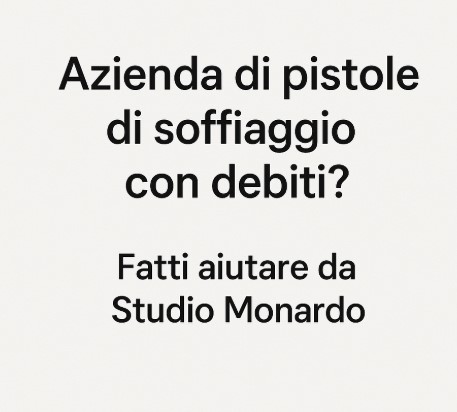Se gestisci un’azienda che produce, importa o distribuisce pistole di soffiaggio, ugelli, lance, accessori pneumatici, pistole industriali per aria compressa e componenti per linee produttive, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la tua attività rischia di fermarsi improvvisamente.
Il settore delle pistole di soffiaggio richiede continuità delle forniture, componenti certificati, prezzi competitivi e puntualità nelle consegne. Un blocco dovuto ai debiti può interrompere ordini, rallentare lavorazioni e compromettere rapporti con clienti industriali, manutentori e impiantisti.
La buona notizia è che, se intervieni subito, puoi bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua azienda.
Perché le aziende di pistole di soffiaggio accumulano debiti
Le cause più frequenti includono:
- aumenti dei costi di ottone, alluminio, polimeri tecnici e componentistica pneumatica
- pagamenti lenti da parte di industrie, distributori e officine
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti, ugelli speciali e scorte costose
- difficoltà ad accedere a credito e fidi bancari adeguati
- investimenti necessari per stampi, attrezzature, collaudi e certificazioni
- fornitori strategici che pretendono pagamenti immediati
Questi fattori generano facilmente crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
Per evitare blocchi operativi e danni irreversibili, devi agire immediatamente:
- far analizzare la situazione debitoria da un avvocato esperto
- verificare quali debiti sono corretti, irregolari o prescritti
- evitare accordi di rientro affrettati o non sostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili con AE e INPS
- proteggere fornitori essenziali e componenti indispensabili
- prevenire blocchi del conto corrente e riduzioni del fido bancario
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Solo una diagnosi professionale permette di capire quali debiti puoi ridurre, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni subito rischi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di attrezzature e mezzi
- blocco delle forniture di pistole, ugelli e componenti
- impossibilità di completare ordini e consegne
- perdita di clienti industriali e distributori
- danni alla reputazione commerciale
- crisi di liquidità e mancato pagamento di dipendenti e fornitori
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore pneumatico basta un ritardo minimo per far perdere commesse importanti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato può:
- bloccare subito pignoramenti e misure esecutive
- ridurre l’importo dei debiti tramite trattative mirate
- ottenere rateizzazioni sostenibili con AE e INPS
- far annullare debiti irregolari, mal calcolati o prescritti
- dialogare con fornitori e banche evitando sospensioni
- proteggere magazzino, continuità operativa e attrezzature
- stabilizzare l’azienda mentre si ristruttura il debito
- evitare che la crisi sfoci in insolvenza o chiusura
Una strategia professionale può salvare l’impresa anche in situazioni molto difficili.
Come evitare il blocco dell’attività
Per non rischiare il fermo produttivo devi:
- intervenire subito
- non trattare con i creditori senza una strategia definita
- salvaguardare fornitori e materiali critici
- ristrutturare i debiti prima dell’arrivo dei pignoramenti
- identificare debiti contestabili o calcolati male
- preservare la liquidità per garantire produzione e consegne
Così puoi evitare ritardi, penali e perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
D è il momento di farlo se:
- hai ricevuto solleciti o avvisi di pignoramento
- i debiti con AE, INPS o fornitori sono diventati ingestibili
- rischi il blocco del conto corrente
- la liquidità sta diminuendo rapidamente
- fai fatica a rispettare pagamenti e scadenze
- vuoi evitare la chiusura dell’azienda
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
Attenzione: molte aziende pneumatiche non falliscono per i debiti, ma per aver aspettato troppo prima di intervenire. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare una parte dei debiti, salvando davvero l’impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in debiti aziendali e difesa di imprese meccaniche e pneumatiche – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di pistole di soffiaggio.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Un’azienda produttrice di pistole di soffiaggio (strumenti industriali utilizzati ad esempio per la pulizia con aria compressa) si trova in difficoltà finanziaria: debiti accumulati verso fornitori, banche, Fisco e enti previdenziali minacciano la sua sopravvivenza. Cosa può fare il titolare o l’amministratore per difendersi e salvare l’attività? In Italia esistono strumenti legali avanzati per gestire la crisi d’impresa, evitando quando possibile la liquidazione giudiziale (il fallimento) e proteggendo, nei limiti della legge, il patrimonio personale dell’imprenditore. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un approfondimento completo, con linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo, pensato sia per avvocati e professionisti del settore sia per imprenditori e privati coinvolti in situazioni di debito aziendale.
Si esamineranno i diversi tipi di debiti che un’azienda può contrarre (tributari, bancari, verso fornitori, previdenziali, leasing), evidenziando le conseguenze legali e le possibili strategie difensive dal punto di vista del debitore. Verranno illustrati gli strumenti di risanamento e ristrutturazione del debito previsti dall’ordinamento italiano (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata della crisi), inclusi i più recenti aggiornamenti normativi (fino ai correttivi del 2022 e 2024 al Codice della Crisi d’Impresa) e le ultime sentenze di rilievo. Saranno fornite tabelle riepilogative per un confronto rapido delle soluzioni, oltre a esempi pratici e una sezione Domande & Risposte che affronta i dubbi più comuni. Infine, un elenco di fonti normative e giurisprudenziali autorevoli sarà posto a conclusione della guida, a garanzia dell’affidabilità delle informazioni (con riferimenti a leggi e sentenze aggiornate).
Importante: questa guida adotta il punto di vista del debitore (l’azienda indebitata e i suoi titolari/gestori), evidenziando come difendersi dalle azioni dei creditori e quali scelte compiere per evitare responsabilità personali, sanzioni o, nei casi peggiori, conseguenze penali. Si ricorda tuttavia che ogni situazione ha aspetti particolari: è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista (avvocato o commercialista) esperto in crisi d’impresa per valutare le mosse migliori nel caso concreto.
1. Struttura societaria e responsabilità per i debiti
Il primo aspetto da considerare è la forma giuridica dell’azienda, poiché da essa dipende il regime di responsabilità verso i debiti. In Italia, le imprese possono operare sotto diverse forme (società di capitali, società di persone, ditta individuale, ecc.), ciascuna con implicazioni differenti sul piano dei debiti.
1.1 Società a responsabilità limitata (SRL) vs società di persone (SNC)
- SRL (Società a Responsabilità Limitata): È una società di capitali in cui per legge i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni sociali, ma solo nei limiti del capitale sottoscritto. In caso di debiti dell’azienda, i creditori possono aggredire unicamente i beni della società, non quelli personali dei soci, salvo casi eccezionali. Queste eccezioni includono: fideiussioni personali o garanzie che il socio/amministratore abbia volontariamente prestato (ad esempio alle banche), oppure condotte illegali dell’organo amministrativo (si pensi a distrazione di beni sociali, sottocapitalizzazione fraudolenta, o altre cause di responsabilità personale). Se la società non è in grado di pagare i propri debiti, i soci non vengono automaticamente coinvolti sul piano patrimoniale; l’eventuale procedura concorsuale (concordato o liquidazione) si svolge sul patrimonio della SRL. Attenzione: dopo la chiusura o liquidazione di una SRL, eventuali crediti insoddisfatti non “spariscono”: i creditori possono comunque agire, ma tendenzialmente solo verso i liquidatori (se colpevoli di irregolarità nella chiusura) o verso i soci limitatamente a quanto questi ultimi avessero eventualmente ricevuto in sede di liquidazione . In mancanza di attivi distribuiti, il debito sociale residuo rimane inesigibile (salvo responsabilità specifiche).
- SNC (Società in Nome Collettivo) e altre società di persone: Nelle società di persone, i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c. per SNC). Ciò significa che, se la società non paga, ogni socio può essere chiamato a pagare l’intero debito con il proprio patrimonio personale. Un creditore della SNC può escutere i beni sociali e, se questi non bastano, aggredire direttamente i beni personali dei soci (previa escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.). Questa responsabilità persiste anche dopo l’eventuale scioglimento o cancellazione della società: la Corte di Cassazione ha chiarito che i soci illimitatamente responsabili restano obbligati per i debiti sociali pure dopo la cancellazione dal Registro Imprese, subentrando nei rapporti attivi e passivi non definiti della società . Ad esempio, se una SNC viene cancellata ma lascia debiti tributari, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà notificare ai soci cartelle di pagamento in quanto coobbligati solidali e successori ex lege dell’ente estinto . Inoltre, in caso di insolvenza di una SNC, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) si estende automaticamente anche ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F., ora art. 256 CCII) con procedure parallele sui patrimoni personali.
Tabella di confronto tra SRL e SNC riguardo ai debiti:
| Caratteristica | S.R.L. (società di capitali) | S.N.C. (società di persone) |
|---|---|---|
| Responsabilità dei soci | Limitata al capitale sottoscritto (nessuna responsabilità personale per debiti sociali, salvo garanzie prestate o condotte illecite) | Illimitata e solidale (ogni socio risponde con tutti i suoi beni dei debiti sociali) |
| Escussione dei creditori | Creditori possono aggredire solo i beni della società; i beni personali dei soci sono al sicuro, salvo eccezioni di legge. | Creditori possono rivolgersi anche ai soci (dopo patrimonio sociale), chiedendo a ciascuno l’intero importo dovuto, con successivi rapporti di regresso tra soci. |
| Dissoluzione della società | Debiti insoddisfatti dopo liquidazione: soci responsabili solo entro eventuali somme ricevute in liquidazione. Liquidatori potenzialmente responsabili se hanno distribuito attivi violando la par condicio. | Debiti insoddisfatti dopo cancellazione: restano a carico illimitato dei soci (successione nei debiti). Cancellazione non estingue l’obbligazione sociale . |
| Procedure concorsuali | La società può accedere a concordato preventivo, ristrutturazione debiti, liquidazione giudiziale. I soci non falliscono (a meno che abbiano garanzie escusse o commesso reati). | In caso di insolvenza, liquidazione giudiziale coinvolge automaticamente i soci (fallimento esteso). I soci possono essere parte di piani di sovraindebitamento se persone fisiche, ma normalmente l’intera SNC entra in procedura concorsuale unitamente ai soci. |
Imprese individuali e altre forme: Se l’attività è svolta da una ditta individuale (imprenditore persona fisica) o da una società semplice/associazioni non riconosciute, la distinzione tra patrimonio dell’impresa e personale spesso non esiste: il titolare risponde di tutti i debiti d’impresa con i propri beni. Tuttavia, in caso di impresa individuale insolvente, possono applicarsi procedure come il concordato minore o la liquidazione controllata (ex “fallimento” dell’imprenditore non grande), o gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento se i requisiti sono soddisfatti.
1.2 Tipologie di debiti aziendali più comuni
Un’azienda manifatturiera come quella dell’esempio può accumulare diversi tipi di debiti, ciascuno disciplinato da norme specifiche e con differenti poteri per i creditori. Vediamo i principali:
- Debiti tributari (verso Erario): imposte non pagate (IVA, IRES/IRPEF, IRAP), ritenute non versate, accertamenti fiscali. Questi debiti sono riscossi di norma tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) che emette cartelle esattoriali. Hanno spesso natura privilegiata (lo Stato è creditore privilegiato per molte imposte) e danno al Fisco poteri di riscossione coattiva rapidi: iscrizione di ipoteche su beni dell’azienda (o, se ditta individuale, anche su beni personali), fermi amministrativi su veicoli, pignoramenti di conti correnti o crediti, fino all’eventuale istanza di fallimento (se il debito supera determinate soglie). Inoltre, per alcuni tributi sono previste sanzioni amministrative elevate e, in casi gravi, sanzioni penali (ad esempio l’omesso versamento IVA oltre soglia, v. infra).
- Debiti verso fornitori commerciali: insoluti verso altri operatori (forniture di materie prime, merci, servizi). I fornitori sono creditori chirografari (senza garanzie) salvo patto di riservato dominio o altri accordi; in caso di mancato pagamento possono agire in giudizio per ottenere decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, iscrivere ipoteca giudiziale o pignorare beni aziendali. Un singolo fornitore non pagato per importi rilevanti potrebbe anche presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice. Va ricordato che, secondo la normativa vigente, non si può aprire la liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti è inferiore a €30.000 : questa soglia (già prevista nella vecchia legge fallimentare e confermata dal Codice della Crisi) evita procedure concorsuali per insolvenze minime, ma sopra tale limite qualsiasi creditore insoddisfatto può teoricamente provocare l’apertura della procedura.
- Debiti bancari e finanziari: esposizioni derivanti da mutui, finanziamenti, anticipazioni bancarie, affidamenti di conto corrente, ecc. Le banche di norma operano con contratti che prevedono garanzie (reali come ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari, e spesso fideiussioni personali dei soci o degli amministratori, in particolare nelle PMI). In caso di insolvenza, la banca potrà:
- Escutere le garanzie reali (es. avviare un’esecuzione immobiliare su un capannone ipotecato, o rivendere un macchinario dato in pegno).
- Chiamare i garanti in solido: ad esempio, se il titolare o i familiari hanno firmato una fideiussione omnibus, la banca potrà pretendere da loro l’intero importo dovuto, aggredendo il patrimonio personale (in deroga alla separazione tipica della SRL).
- Segnalare l’inadempimento alla Centrale Rischi di Bankitalia, con impatto negativo sulla reputazione creditizia dell’azienda e dei garanti.
- Avviare azioni legali ordinarie (decreto ingiuntivo e pignoramento) per i crediti non assistiti da garanzia.
Il debitore può difendersi cercando una rinegoziazione del debito (es. un piano di rientro concordato) o opporsi legalmente se vi sono irregolarità nel contratto (talvolta si contestano interessi usurari o anatocismo, per ridurre il dovuto). Tuttavia, in mancanza di basi di contestazione, l’obbligo di pagamento è difficilmente evitabile se non tramite un accordo o una procedura concorsuale.
- Debiti verso il personale dipendente: retribuzioni arretrate, TFR (trattamento di fine rapporto) non accantonato, rimborsi e indennità non pagate. Questi debiti sono particolarmente sensibili: i lavoratori hanno tutele legali forti. Possono ottenere decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per stipendi non pagati e vantano privilegio generale mobiliare sui beni mobili e immobili dell’azienda (per gli ultimi 2 anni di retribuzioni e TFR). Inoltre, l’INPS gestisce un Fondo di Garanzia che in caso di insolvenza del datore di lavoro anticipa ai lavoratori TFR e ultime mensilità, surrogandosi poi nei loro diritti (quindi l’INPS diventerà creditore dell’azienda). Se l’azienda non paga gli stipendi, questo può creare pressione per soluzioni della crisi: scioperi, dimissioni collettive, o anche istanze di fallimento promosse dai dipendenti stessi (spesso tramite i sindacati) sono possibili. Dal punto di vista penale, va ricordato che non esiste un reato specifico per il mancato pagamento dello stipendio, ma esistono sanzioni amministrative e penali per omesso versamento delle ritenute previdenziali sullo stipendio (vedi debiti previdenziali sotto) e, in casi limite, potrebbe configurarsi il reato di appropriazione indebita se il datore trattiene indebitamente somme spettanti al dipendente.
- Debiti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL): contributi obbligatori non versati per i dipendenti o per i titolari (gestione previdenziale, premi assicurativi INAIL). L’INPS e l’INAIL hanno poteri di riscossione analoghi all’Erario (cartelle esattoriali tramite Agenzia Entrate-Riscossione, con privilegi sui beni del debitore) e anche sanzioni civili elevate (interessi e sanzioni aggiuntive per omesso versamento). In particolare, il mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore (la quota di contributi trattenuta dallo stipendio) sopra una certa soglia costituisce reato: se l’importo omesso supera €10.000 annui, il datore di lavoro commette reato punito con fino a 3 anni di reclusione e multa ; se l’importo è inferiore, la condotta è depenalizzata in illecito amministrativo. Ad esempio, se un’azienda non versa le trattenute INPS ai dipendenti per €15.000, superando il tetto annuale, rischia un procedimento penale (a meno che non sani la posizione prima dell’eventuale giudizio, poiché il pagamento integrale dei contributi prima dell’apertura del dibattimento estingue il reato). Anche l’omissione dei contributi propri dell’azienda (la quota a suo carico) non è reato di per sé, ma comporta sanzioni civili e il rischio di misure esecutive. L’impresa indebitata con INPS/INAIL può chiedere una rateazione del debito contributivo (generalmente fino a 24 rate mensili ordinariamente, o piani straordinari fino a 36/60 rate in certi casi gravi) per evitare azioni esecutive e ottenere il DURC regolare (Documento Unico Regolarità Contributiva, necessario per partecipare ad appalti, ricevere pagamenti dalla PA, ecc.). In caso di concordato o accordo di ristrutturazione, i debiti contributivi rientrano nella “transazione fiscale e contributiva”, di cui diremo oltre, potendo essere oggetto di falcidia o dilazione se l’ente è d’accordo o mediante cram-down giudiziale.
- Debiti da leasing e altri finanziamenti di beni: molte aziende, specie manifatturiere, acquisiscono macchinari e automezzi in leasing. Il leasing è un contratto in cui un soggetto (utilizzatore) ha la disponibilità di un bene pagando canoni periodici a una società di leasing, con possibilità di riscattare il bene a fine contratto. Se l’azienda utilizzatrice non paga i canoni, la società di leasing può risolvere il contratto, riprendere possesso del bene (che rimane di sua proprietà fino al riscatto) e richiedere all’utilizzatore il pagamento dei canoni scaduti e di una penale contrattuale. Ciò può mettere in ginocchio un’impresa, specie se il bene in leasing è essenziale per la produzione (si pensi a un costoso impianto industriale). Il leasing non pagato non porta di per sé al fallimento, ma la società di leasing può agire per decreto ingiuntivo e pignorare altri beni se il ricavato dalla rivendita del bene non copre l’esposizione. In alcuni casi, anche per i leasing i soci possono avere firmato garanzie personali. Una difesa per l’azienda è tentare una rinegoziazione del contratto (ad esempio chiedere una moratoria dei canoni in caso di crisi temporanea: negli ultimi anni, anche grazie a interventi normativi durante emergenze come il Covid-19, molte imprese hanno ottenuto sospensioni o dilazioni dei canoni leasing). In procedura concorsuale, i contratti di leasing possono essere mantenuti o sciolti a seconda del piano; nel concordato preventivo l’azienda può chiedere di proseguire il leasing (continuando a pagare i canoni) oppure restituire il bene (la società di leasing avrà un credito per eventuali scoperti, in parte privilegiato).
- Debiti fiscali locali e altre passività: da citare anche eventuali debiti per tasse locali (IMU, TARI) o sanzioni amministrative, debiti verso fornitori di utenze (energia, gas) – questi ultimi possono mettere pressione tagliando forniture essenziali se non pagati, per cui l’azienda deve cercare accordi per evitare l’interruzione dell’attività. Anche i debiti verso eventuali soci finanziatori o verso società collegate vanno gestiti, sebbene spesso questi siano “subordinati” (ad esempio, un socio può decidere di non richiedere immediatamente il rimborso di un finanziamento soci per non aggravare la crisi).
In sintesi, un’azienda indebitata deve affrontare un attacco multi-frontale: il Fisco e gli enti pubblici con poteri esecutivi speciali e sanzioni; i fornitori e banche con azioni legali e richieste di pagamento; i dipendenti con pretese privilegiate; e nel frattempo mantenere operative le forniture e i servizi essenziali. Il punto di vista del debitore impone di cercare soluzioni che contemperino due esigenze: guadagnare tempo e respiro finanziario, e al contempo riorganizzare l’azienda o il debito in modo sostenibile per superare la crisi. Nella sezione successiva vedremo quali strumenti l’ordinamento offre per ottenere questo risultato.
2. Affrontare le azioni dei creditori: strumenti di difesa immediata
Prima di passare agli strumenti strutturati di risanamento (piani e procedure concorsuali), consideriamo come un’azienda debitrice possa difendersi nell’immediato dalle azioni dei creditori, tentando di mitigare gli effetti dei debiti scaduti.
2.1 Moratorie, accordi transattivi e piani di rientro stragiudiziali
Non sempre la via giudiziaria è inevitabile. Un imprenditore accorto, appena si rende conto di non riuscire a far fronte a tutti i pagamenti, dovrebbe attivarsi proattivamente contattando i creditori principali per negoziare soluzioni temporanee. Molti creditori preferiscono trovare un accordo piuttosto che avviare costose azioni legali il cui esito può essere incerto se l’azienda ha pochi asset liquidabili.
- Moratoria o dilazione con le banche: Le banche, soprattutto in momenti di crisi economica generale, spesso aderiscono a protocolli (anche promossi da associazioni di categoria o dal governo) per la sospensione delle rate di mutui e leasing alle PMI. Ad esempio, in passato sono state varate moratorie sui mutui aziendali durante la pandemia Covid-19. Indipendentemente da misure di sistema, una banca può volontariamente concedere un periodo di grazia, una dilazione dei pagamenti o una rinegoziazione del tasso o delle condizioni, se ritiene che l’azienda abbia prospettive di ripresa. È nell’interesse della banca evitare di dover svalutare il credito o escutere garanzie dall’esito incerto. Consiglio per il debitore: presentare un piano di rientro credibile, magari assistito dal proprio commercialista, mostrando flussi di cassa futuri e garanzie aggiuntive (ad es. impegno dei soci a ricapitalizzare, o garanzie statali come il Fondo PMI per nuovi finanziamenti) può convincere la banca a negoziare.
- Accordi con fornitori: Per i fornitori commerciali, soprattutto quelli strategici (forniscono materie prime indispensabili, o costituiscono partner di lungo termine), è utile cercare un accordo di dilazione del debito. Questo può assumere la forma di un piano di rientro rateale (ad es. pagamento del pregresso in 6-12 mesi, magari contestualmente al continuare a fornire il servizio/prodotto corrente), oppure di uno sconto a saldo stralcio (il fornitore accetta di ridurre l’importo dovuto se riceve immediatamente una percentuale del credito – tipico nei casi in cui preferisce incassare qualcosa subito anziché rischiare di più in un fallimento futuro). È essenziale formalizzare questi accordi per iscritto, prevedendo la rinuncia del creditore a iniziative esecutive purché il debitore rispetti il piano concordato. Talora, un accordo quadro può coinvolgere più fornitori (es. accordo con i 5 fornitori principali per pagare tutti in modo proporzionale), evitando disparità di trattamento – ma ciò è complesso da gestire senza una procedura concorsuale se i creditori sono numerosi.
- Rateizzazioni con il Fisco e gli enti: Come accennato, esistono strumenti normativi per rateizzare i debiti fiscali e contributivi. Ad esempio, con l’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile chiedere un piano fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 senza dover dare prova di difficoltà finanziaria, o piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) per importi maggiori o per chi documenti grave e comprovata situazione di difficoltà (art. 19 DPR 602/1973, modificato da vari interventi normativi). Durante il pagamento dilazionato, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive e il debitore ottiene il DURC provvisorio regolare. Importante: il mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive) fa decadere la dilazione, quindi occorre essere realistici nel chiedere rate compatibili col flusso di cassa dell’azienda. Nel 2023-2024, inoltre, vi sono state edizioni di definizioni agevolate (c.d. “rottamazione delle cartelle”) che consentivano di pagare i debiti fiscali senza sanzioni e interessi: l’imprenditore dovrebbe sempre informarsi se vi siano norme di condono o rottamazione attive, poiché aderirvi può ridurre notevolmente il carico debitorio fiscale. Ad ottobre 2025, per esempio, è in fase attuativa la “rottamazione-quater” introdotta dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che consente la definizione agevolata dei carichi affidati fino al 30 giugno 2022, con pagamento del solo tributo e interessi ridotti, in massimo 18 rate.
- Opposizioni legali ove possibile: Qualora i creditori abbiano già avviato azioni (es. decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento), il debitore deve valutare con il legale se esistono motivi di opposizione. Un decreto ingiuntivo non ancora definitivo può essere opposto entro 40 giorni, sollevando contestazioni sul merito del credito (ad esempio, merce contestata, fatture non dovute, prescrizione del credito, anatocismo su interessi, ecc.). L’opposizione apre un giudizio ordinario e, se ammessa con sospensione, può guadagnare tempo al debitore. Tuttavia, opporsi senza fondati motivi può solo rinviare l’inevitabile e aggravare le spese. Similmente, se viene notificato un atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni pena esecuzione), il debitore può evitare il pignoramento chiedendo al giudice la sospensione in casi estremi (vizi formali o pericolo di danno grave e irreparabile), oppure trovare un accordo col creditore nei 10 giorni. Una volta partito il pignoramento, gli spazi di difesa si restringono: ci sono le opposizioni all’esecuzione (se il debito è stato pagato o manca titolo) o agli atti esecutivi (per irregolarità formali), ma in mancanza di tali vizi, l’esecuzione farà il suo corso. Dunque, il focus deve essere sul prevenire l’esecuzione con accordi o sospensioni.
- Conservare liquidità per le priorità: Un consiglio pratico per il debitore è dare priorità ai pagamenti che mantengono in vita l’azienda: stipendi (per non perdere forza lavoro chiave), fornitori critici, materie prime essenziali, e quelle spese la cui omissione causerebbe danni immediati (es. tasse il cui mancato pagamento comporta blocco di licenze o sanzioni penali oltre soglia). Al contrario, potrebbe decidere di ritardare alcuni pagamenti meno critici se prevede di includerli in un accordo di ristrutturazione globale. Questa scelta però è rischiosa: scegliere chi pagare e chi no, in prossimità di un possibile fallimento, può essere visto come atto in frode o causare azioni revocatorie. In un eventuale fallimento successivo, pagamenti fatti a creditori non privilegiati nei sei mesi antecedenti possono essere revocati dal curatore (art. 164 CCII, ex art. 67 L.F.), salvo che rientrino nei limiti di esenzione (pagamenti per prestazioni contestuali, ecc.). Dunque, massima trasparenza e cautela: se la crisi sta precipitando, è preferibile incanalare tutti i creditori in una soluzione concordata (accordo o procedura) invece che pagare solo alcuni a scapito di altri. Questo è difficile da gestire da soli: ecco perché spesso, quando i debiti diventano insostenibili, si passa agli strumenti di regolazione della crisi descritti nel capitolo seguente, che consentono di trattare collettivamente con tutti i creditori sotto un ombrello legale.
2.2 Misure protettive temporanee: il “blocco” delle azioni esecutive
Una caratteristica comune delle procedure concorsuali (concordato, ristrutturazione con omologa, composizione negoziata con misure protettive) è la possibilità di ottenere dal tribunale un blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori per un certo periodo. Fuori da queste procedure, l’ordinamento offre poche possibilità di bloccare i creditori se non via accordo o pagando.
Tuttavia, dal 2021 con il D.L. 118/2021 (e ora col nuovo Codice della Crisi) è stato introdotto uno strumento pre-concorsuale importante: la composizione negoziata della crisi (di cui diremo in dettaglio più avanti). Contestualmente alla nomina dell’esperto negoziatore, l’imprenditore può chiedere al tribunale le cosiddette misure protettive ex art. 18 CCII: in pratica un decreto che impedisce o sospende l’inizio di procedure esecutive, cautelari (pignoramenti, sequestri) e dichiarative (istanze di fallimento) da parte dei creditori, per la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, estensibili). Questo “scudo” non è automatico – va richiesto motivando che la protezione è funzionale al buon esito delle trattative – ma offre una boccata d’ossigeno all’azienda in crisi, simile a quella che si ottiene presentando una domanda di concordato preventivo. Nota: se l’azienda poi abusa di questo scudo (ad esempio lo ottiene in malafede, o lo viola pagando di nascosto qualche creditore a scapito di altri), il tribunale può revocare le misure protettive e far precipitare la situazione.
Fuori dalle ipotesi sopra, uno stratagemma (lecitamente previsto) per bloccare sul filo di lana un’azione esecutiva è la presentazione di una domanda di concordato preventivo “in bianco” (con riserva). Infatti, dal momento in cui il tribunale ammette la domanda di concordato con riserva, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquisire privilegi se non autorizzati (art. 54 CCII, ex art. 168 L.F.). Molte aziende ricorrono al concordato in bianco proprio per congelare le azioni in corso e guadagnare tempo (fino a 120 giorni, prorogabili di 60) per predisporre un piano di ristrutturazione. Ovviamente, presentare una domanda del genere senza la reale intenzione o capacità di presentare poi un piano è un comportamento in mala fede che può configurare un abuso (e portare al fallimento immediato). Pertanto, va usato solo come extrema ratio e con il supporto di un professionista che abbia già impostato soluzioni di concordato o accordo.
Riassumendo questa parte: difendersi nell’immediato dai creditori significa negoziare dilazioni, sfruttare le possibilità di legge di rateazione e standstill, e se necessario ricorrere tempestivamente a strumenti concorsuali che offrono protezione temporanea. Il capitolo seguente esplorerà proprio tali strumenti strutturati di risanamento e come utilizzarli in modo appropriato.
3. Strumenti di risanamento della crisi d’impresa
Quando i debiti superano la capacità dell’azienda di farvi fronte regolarmente, e le misure tampone non bastano, occorre valutare l’accesso ai veri e propri strumenti di regolazione della crisi previsti dalla normativa italiana (riformata di recente). Questi strumenti hanno l’obiettivo di evitare la liquidazione distruttiva, attraverso la ristrutturazione del debito o la ricerca di soluzioni concordate con i creditori, oppure, se il salvataggio non è possibile, di gestire l’uscita dal mercato in modo ordinato e legalmente regolamentato. Di seguito esamineremo in ordine crescente di coinvolgimento giudiziario: dal piano di risanamento puramente stragiudiziale, passando per gli accordi con omologa, fino alle procedure concorsuali vere e proprie come il concordato e la liquidazione giudiziale.
3.1 Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale)
Cos’è: Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento negoziale, volontario e stragiudiziale (fuori dal tribunale) che consente all’imprenditore in crisi o in stato di insolvenza di predisporre un piano di risanamento dell’azienda, con l’obiettivo di riequilibrare la situazione finanziaria ed evitare il dissesto . Questo piano deve essere attestato da un professionista indipendente che ne verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità. La prima introduzione normativa risale al 2005, quando fu aggiunta una disposizione (art. 67, co.3, lett. d) L.F.) che esentava da revocatoria fallimentare gli atti compiuti in esecuzione di un piano idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria attestato da un esperto . Oggi la disciplina organica si trova nell’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in vigore dal luglio 2022, che ha sostanzialmente recepito e sviluppato quell’istituto .
Come funziona: Il piano attestato è essenzialmente un accordo privato tra il debitore e tutti o alcuni dei suoi creditori, supportato dalla relazione di un esperto indipendente (iscritto in albi specifici) che assevera che il piano è realistico e che la sua attuazione consentirà all’impresa di uscire dalla crisi (o comunque di migliorare la propria situazione evitando il fallimento). A differenza di altre procedure: – Non richiede l’intervento del tribunale per essere avviato né omologato. Va però pubblicato nel Registro delle Imprese se il debitore vuole ottenere taluni effetti (è facoltativa la pubblicazione, ma farlo dà data certa e opponibilità ai terzi). – Non è una procedura concorsuale: l’imprenditore rimane totalmente alla guida della sua azienda, non c’è nomina di commissari o organi esterni. Non vi è una “procedura” giudiziaria, quindi minori costi e nessuna pubblicità negativa ufficiale (il che aiuta a non allarmare clienti e fornitori). – La partecipazione dei creditori è volontaria: solo i creditori che aderiscono all’accordo previsto dal piano saranno coinvolti nelle modifiche (es: stralcio di parte del credito, dilazioni, conversione di crediti in capitale, ecc.). I creditori che non vogliono aderire mantengono intatti i loro diritti e vanno pagati regolarmente fuori piano. Questo è un limite: non si possono imporre sacrifici ai dissenzienti (a differenza di un concordato che vincola la totalità dei creditori una volta omologato). – Il vantaggio principale per il debitore e i creditori consenzienti è l’esenzione da azioni revocatorie in caso di successivo fallimento: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non potranno essere revocati dal curatore se malauguratamente l’azienda dovesse fallire dopo (art. 166, co.3, lett. d) CCII) . Ciò dà sicurezza a chi, ad esempio, concede nuova finanza o accetta pagamenti nel contesto del piano – non rischierà di dover restituire quanto ricevuto. – Inoltre, la legge prevede una causa di non punibilità penale per alcune condotte di bancarotta semplice o preferenziale relative ad atti compiuti in esecuzione del piano attestato (già l’art. 217-bis L.F. esentava da bancarotta semplice e preferenziale alcune operazioni se compiute sotto un piano attestato). In sostanza, se l’imprenditore, seguendo il piano attestato, paga preferenzialmente alcuni creditori per salvare l’azienda, non incorre nel reato di bancarotta preferenziale; oppure se ha continuato l’attività confidando nel piano, ciò non sarà considerato negligente ai fini della bancarotta semplice. Questo “scudo penale” incentiva a perseguire soluzioni concordate .
Quando utilizzarlo: Il piano attestato è indicato quando: – La crisi è ancora gestibile coinvolgendo principalmente alcuni creditori chiave disponibili a negoziare. Ad esempio, l’azienda ha 4-5 banche finanziatrici e alcuni fornitori importanti con cui riesce a trovare un accordo di ristrutturazione del debito, mentre può continuare a pagare regolarmente gli altri creditori minori. – Si vuole evitare la pubblicità e la rigidità di una procedura concorsuale. È ideale per aziende che credono di poter risolvere la crisi in modo relativamente rapido e con il consenso informale dei creditori, mantenendo l’immagine intatta (nessun marchio di “azienda in concordato”). – Si riesce a predisporre un business plan attendibile di risanamento, con misure concrete (nuovi apporti di capitale dai soci, dismissione di asset non strategici, rilancio commerciale, etc.) tali da convincere l’esperto attestatore e i creditori sulla fattibilità. Se il piano consiste solo in dilazioni di pagamento senza un reale rilancio, sarà poco credibile e difficilmente attestabile.
Esempio pratico: L’azienda di pistole di soffiaggio ha debiti per 500.000€ con le banche, 300.000€ con fornitori, 200.000€ tra fisco e INPS, ma ha ancora mercato e ordini in crescita. I soci sono disposti a investire liquidità nuova e l’azienda ha alcuni macchinari vendibili per fare cassa. Si può costruire un piano a 5 anni in cui: – I soci apportano subito 100.000€ freschi. – Si vende un impianto non essenziale incassando 150.000€. – Con queste risorse, si paga una parte dei debiti tributari e si ottiene la rateazione per il resto. – Le banche accettano di ristrutturare i prestiti allungandone la durata e riducendo il tasso (magari grazie a garanzie aggiuntive). – I fornitori strategici accettano un taglio del 20% dei loro crediti e il resto lo incassano a rate in 2 anni (preferendo ciò al rischio di perdere un cliente o vederlo fallire). – Il piano prevede anche il lancio di un nuovo prodotto di “pistola di soffiaggio ecologica” che secondo le stime farà aumentare il fatturato del 30% in 3 anni, generando utili per ripagare i debiti dilazionati.
Un professionista attestatore (ad esempio un commercialista esperto in crisi nominato dall’azienda) verifica i numeri, li trova veritieri e realistici, e attesta che il piano è idoneo a risanare l’impresa e riequilibrarne la situazione finanziaria. Il piano viene sottoscritto dai creditori coinvolti e pubblicato nel Registro Imprese per renderlo ufficiale. Da quel momento, l’azienda esegue il piano: paga le rate secondo accordi, compie gli atti (apporti, vendite) previsti. Se tutto va bene, in un paio d’anni la crisi è superata senza mai entrare in tribunale. Se invece il piano fallisce e l’azienda finisse in liquidazione giudiziale, almeno le operazioni fatte in esecuzione di quel piano (pagamenti, garanzie concesse, ecc.) sarebbero esenti da revocatorie e l’amministratore non verrebbe accusato di aver aggravato dolosamente il dissesto, avendo operato in buona fede su un piano attestato .
Limiti del piano attestato: Il rovescio della medaglia è: – Nessuna protezione automatica dai creditori: mentre si prepara e si negozia il piano, legalmente ogni creditore potrebbe comunque attaccare (a meno di accordi di standstill). Non c’è automatic stay come nel concordato . Perciò serve un certo equilibrio: se alcuni creditori ostili vogliono essere soddisfatti per primi, il piano rischia di saltare. È consigliabile avere un dialogo preventivo con i creditori principali prima di lanciare formalmente il piano . – Non vincola i non aderenti: come detto, chi non firma l’accordo va pagato normalmente. Dunque, se la platea di creditori è molto ampia e non c’è consenso generalizzato, il piano potrebbe non risolvere l’intera crisi. Ad esempio, se su 100 creditori 5 non ci stanno e ottengono decreti ingiuntivi, l’impresa rischia comunque aggressioni. In tal caso, strumenti più coercitivi (concordato) sarebbero indicati . – Attestazione: trovare un professionista disponibile e che attesti responsabilmente non è mera formalità. L’attestatore risponde civilmente e può avere anche conseguenze penali se assevera cose false o gravemente errate. Egli deve fare una due diligence seria. Questo comporta costi (la parcella dell’attestatore) e tempi. – Validità temporale: Il piano attestato è per sua natura un’istantanea. Se le cose vanno diversamente dalle previsioni, bisogna eventualmente rinegoziare o passare ad altro strumento. Non c’è un’autorità che “modifica” il piano in corso d’opera – è un contratto privato.
In conclusione, il piano attestato è uno strumento flessibile e discreto, adatto a crisi reversibili con accordo tra poche parti, e gode di benefici legali (niente revocatoria, meno rischi di reato) che lo rendono attraente. Ma richiede fiducia reciproca e sostanziale collaborazione dei creditori, oltre che un’azienda ancora “salvabile” come going concern (di regola non si fa un piano attestato per un’azienda decotta da liquidare – in tal caso meglio accordi di altro tipo o concordato liquidatorio). La normativa attuale ne incoraggia l’uso, tanto da prevedere anche principi di attestazione elaborati da Consigli Nazionali (CNDCEC) per uniformarne le prassi .
3.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (con omologazione)
Un gradino più su nella scala delle formalità ci sono gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ARD), disciplinati dagli artt. 57-64 CCII (che riprendono l’istituto introdotto nel 2005 con l’art. 182-bis L.F.). Si tratta di accordi negoziati con i creditori ma con il cruciale intervento dell’autorità giudiziaria nella fase finale: l’accordo viene infatti omologato dal Tribunale, acquisendo efficacia vincolante e alcuni effetti protettivi.
Caratteristiche principali: – È essenzialmente un accordo contrattuale tra il debitore e una parte dei creditori, che deve però rappresentare almeno il 60% dei crediti (sommatoria). Questa soglia è prevista per poter presentare l’accordo in tribunale per l’omologazione (art. 60 CCII). Significa che occorre il consenso di creditori che detengano 3/5 del totale esposizione debitoria. Gli altri creditori non aderenti rimangono estranei all’accordo (dovranno essere pagati integralmente, fuori dall’accordo, entro i termini di legge – o soddisfatti diversamente se anche loro beneficiano di qualche piano concomitante). – Procedura: il debitore può inizialmente chiedere al tribunale misure protettive (simili a quelle del concordato) mentre negozia l’accordo, depositando un ricorso ex art. 54 CCII e indicando che sta trattando un accordo di ristrutturazione. Una volta raggiunto l’accordo scritto con i creditori pari almeno al 60%, il debitore deposita la domanda di omologazione dell’accordo, allegando documentazione contabile aggiornata e la relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità dell’accordo e sulla capacità di adempiere integralmente ai creditori estranei (quest’ultima è fondamentale: chi resta fuori deve essere pagato normalmente, quindi l’attestatore deve confermare che le risorse ci sono). Il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo con decreto (se non ci sono opposizioni rilevanti). Da quel momento l’accordo ha efficacia anche verso eventuali creditori dissenzienti che però avevano aderito per iscritto? – in realtà, tecnicamente vincola solo i consenzienti, ma ci sono varianti. – Varianti introdotte di recente: Il CCII ha previsto alcune forme speciali: – Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): se l’accordo è approvato da creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una certa categoria omogenea (es. banche), il debitore può chiedere che l’accordo sia esteso anche ai creditori non aderenti di quella categoria, purché siano soddisfatti non meno degli aderenti. Questo recepisce il “cram-down” previsto dalla Direttiva UE 2019/1023. Significa, ad esempio, che se 80% di banche ha accettato una certa ristrutturazione, il tribunale può imporla anche al 20% che non ha firmato, evitando “free rider” che potrebbero sabotare. – Accordo agevolato (art. 64 CCII): abbassa la soglia al 30% di consensi se il debitore offre ai non aderenti il pagamento integrale ma dilazionato entro 120 giorni dall’omologa (per chirografari) o 30 giorni (per privilegiati). È un caso particolare di accordo che serve solo a prendere tempo per il pagamento integrale dei pochi dissenzienti. – Accordi misti o con intermediari finanziari: la legge ammette che l’accordo riguardi anche solo determinate posizioni (es. solo banche, con stralcio dei loro crediti, mentre agli altri si paga il 100%). Sono possibili anche le “convenzioni di moratoria” (art. 62 CCII) dove alcune categorie di creditori finanzieri differiscono scadenze di comune accordo. – Protezione dai creditori: quando si deposita l’accordo per omologa, il tribunale su richiesta può sospendere le azioni esecutive per un periodo (fino all’omologa). Inoltre, dopo il deposito, i creditori non possono acquisire ipoteche giudiziali né privilegiare le proprie posizioni (scatta la protezione ex art. 54 come per il concordato). Questo evita corse alle armi. – Effetti dell’omologazione: l’accordo omologato ha efficacia tra le parti e, nei casi di accordo esteso, anche sui non aderenti della categoria coinvolta. In generale, comunque, i creditori estranei restano liberi di agire (ma tanto devono essere pagati per intero). L’omologazione inoltre cristallizza la situazione: eventuali atti compiuti in esecuzione dell’accordo sono protetti da revocatorie fallimentari (similmente al piano attestato). Sul piano reputazionale, l’accordo di ristrutturazione è pubblico (registro imprese, e il decreto di omologa è un provvedimento pubblicato), ma è percepito come meno “stigmatizzante” di un concordato, poiché segno di un’intesa raggiunta con i creditori.
Quando conviene un accordo ex art. 57 CCII: – Quando l’impresa ha un indebitamento concentrato (ad esempio poche banche e pochi soggetti detengono la gran parte del debito) e quindi raggiungere il 60% di adesioni è fattibile, mentre magari c’è qualche creditore minore che non si riesce a contattare o convincere – lo si può lasciare estraneo, tanto è marginale. – Quando c’è un sostegno forte da parte dei finanziatori: spesso gli ARD sono usati dalle banche per ristrutturare prestiti deteriorati di un’azienda ancora vitale, evitando il fallimento. In tal caso, le banche (che magari rappresentano >60% del debito) si accordano (es. trasformano debito in strumenti partecipativi, o tagliano interessi, concedono nuovi fondi) e l’omologa serve per dare efficacia e “blindare” l’accordo. – Vantaggio su concordato: non serve il voto di tutti i creditori o per classi, basta la percentuale sul totale. Inoltre i crediti estranei devono essere pagati al 100%, quindi in principio l’accordo è percepito come più equo dai terzi (nessuno viene falcidiato contro la sua volontà). – L’accordo è solitamente più rapido di un concordato: si negozia privatamente e la fase in tribunale si limita all’omologa (che, se non ci sono opposizioni, può arrivare in tempi brevi). Non c’è tutta la procedura di ammissione, voto, ecc.
Esempio pratico: La nostra azienda di pistole di soffiaggio ha una situazione tale che 3 banche detengono il 50% del debito totale, i fornitori un 30%, Fisco e INPS 20%. Riesce a far sottoscrivere a tutte le banche e ad alcuni fornitori un accordo di ristrutturazione in cui: – Le banche convertono una parte dei crediti in una linea di finanziamento partecipativo (cioè li “congelano” e verranno ripagati solo se l’azienda torna profittevole oltre una soglia), e allungano la scadenza del resto. – I fornitori aderenti accettano un pagamento all’80% del dovuto in 12 mesi. – L’azienda si impegna a pagare integralmente i fornitori piccoli non aderenti (che sommati sono, poniamo, il 10% del debito) entro 120 giorni dall’omologa, e saldare anche il Fisco tramite rateazione (nel rispetto di eventuali norme sulla transazione fiscale, di cui dopo). – Un attestatore redige relazione che conferma la sostenibilità del piano e che i creditori estranei verranno soddisfatti regolarmente. – Raggiungendo magari il 65% di adesioni in valore, si deposita l’accordo con richiesta di omologa. Il tribunale verifica, concede la protezione nel frattempo e poi omologa perché tutto quadra. I pochi creditori che non avevano firmato vengono comunque pagati come da piano (integralmente o secondo quanto la legge consente).
L’azienda così evita il fallimento, sistemando il debito con un numero ristretto di “sacrifici” concordati, e può proseguire l’attività.
Transazione fiscale e contributiva: Un punto particolare negli accordi (e anche nel concordato) è il trattamento dei crediti fiscali e previdenziali. In passato, l’Erario aveva un potere di veto: se non aderiva a una proposta di stralcio delle imposte o IVA, l’accordo non era omologabile. La riforma ha attenuato ciò: oggi col CCII l’Erario (e gli enti) possono essere crammati down in certe condizioni (art. 63 CCII per ARD, art. 88 CCII per concordato). In breve, se la proposta è conveniente (il Fisco prenderebbe almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione dell’azienda) e se il diniego appare irragionevole, il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco . Questo è importante perché l’esperienza mostrava enti a volte rigidi che impedivano accordi. Adesso, ad esempio, se l’azienda propone in accordo di pagare il 40% del debito fiscale ma in caso di fallimento il Fisco prenderebbe zero, il tribunale può approvare l’accordo anche contro il “no” dell’Agenzia Entrate, soddisfacendo coattivamente il Fisco al 40%. Questo è il cram down fiscale introdotto dagli ultimi correttivi, ispirato alla normativa europea.
Limiti e rischi degli ARD: – Trovare il 60% di consenso non è semplice in contesti frammentati (molti piccoli creditori). – I creditori estranei vanno pagati per intero – ciò richiede liquidità o comunque impegni certi. Se l’azienda è troppo decotta, potrebbe non riuscire a garantirlo, quindi quell’opzione salta (in tal caso meglio un concordato che può imporre perdite anche ai dissenzienti, purché a maggioranza). – Se un creditore importante rifiuta di aderire (es. una banca col 25% dei crediti), non la si può ignorare: va soddisfatta integralmene. Questo spesso porta i debitori a preferire il concordato dove anche quella banca sarebbe dentro e soggetta a voto (a meno di contare sul cram down, ma è un giudizio non garantito). – Durante la negoziazione, prima di depositare l’accordo, l’impresa è vulnerabile (simile al piano attestato) salvo chiedere misure protettive in via anticipata. Serve quindi gestire la tempistica con attenzione.
In sintesi, gli Accordi di Ristrutturazione sono uno strumento intermedio, adatto a crisi dove c’è un ampio consenso di massima tra creditori principali, e si vuole coinvolgere il tribunale solo per dare forza legale all’intesa e beneficiare di qualche tutela (blocco azioni e protezione da revocatorie). Frequentemente, vengono usati per ristrutturazioni finanziarie di medio-grandi imprese. Per PMI meno strutturate, spesso si salta direttamente al concordato preventivo se serve coinvolgere tutti i creditori indistintamente.
3.3 Concordato preventivo (continuità e liquidatorio)
Il Concordato Preventivo è la tradizionale procedura concorsuale (giudiziaria) di risanamento o liquidazione concordata dell’impresa in crisi. Disciplinato dagli artt. 84-120 CCII (che sostituiscono gli artt. 160 e segg. della vecchia legge fallimentare), il concordato preventivo è una procedura complessa, sottoposta al controllo del tribunale e al voto dei creditori, che consente all’imprenditore di proporre un accordo concorsuale vincolante per tutti i creditori in alternativa alla liquidazione giudiziale (fallimento).
Tipologie di concordato: – Concordato in continuità aziendale (art. 84 co.2 CCII): quando il piano prevede che l’azienda continui, in tutto o in parte, l’attività d’impresa. La continuità può essere diretta (l’impresa prosegue con lo stesso soggetto debitore) o indiretta (si cede/transfoma l’azienda a un altro soggetto che prosegue l’attività, ad es. affitto d’azienda con successiva vendita a un terzo che la mantiene operativa). Nel concordato in continuità, l’obbiettivo è salvare la parte sana del business, ristrutturando i debiti. I creditori vengono soddisfatti nel tempo coi flussi generati dall’attività futura, eventualmente integrati da apporti di terzi. La legge incentiva la continuità perché preserva posti di lavoro e valore economico: ad esempio, consente di pagare i creditori chirografari (non garantiti) anche oltre l’anno dall’omologa e in percentuale inferiore ai privilegiati, purché un esperto dichiari che otterranno almeno il valore di liquidazione . – Concordato liquidatorio (art. 84 co.3 CCII): prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio sotto controllo del tribunale, ma in modo concordato con i creditori. Rispetto alla liquidazione giudiziale, avviene con un piano proposto dal debitore, spesso includendo l’apporto di risorse esterne per aumentare il recupero dei creditori. La legge pone vincoli più stringenti: nel concordato liquidatorio puro, occorre garantire un soddisfacimento minimo del 20% ai creditori chirografari (salvo che vengano apportati beni o somme esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10% – in tal caso la soglia può essere ridotta) . Ciò per evitare concordati liquidatori “troppo penalizzanti”. In pratica, se l’azienda non ha prospettive di rilancio ma solo beni da vendere, il debitore può comunque tentare un concordato offrendo ad es. il 25% ai chirografari, magari grazie a un socio disponibile a mettere soldi propri pur di evitare il fallimento (spesso per non incorrere in responsabilità). – Tra le sottovarianti citiamo il concordato preventivo con riserva (art. 44 CCII, ex “concordato in bianco”): una procedura dove il debitore deposita un ricorso manifestando l’intenzione di proporre concordato ma chiedendo un termine (da 60 a 120 giorni prorogabili) per presentare il piano e la proposta definitiva. Serve a sfruttare la protezione immediata dagli attacchi dei creditori mentre si finalizza il piano. – Introdotto di recente (col D.L. 118/2021 e confermato nel CCII) vi è anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII): è un istituto speciale cui può accedere il debitore solo se abbia prima tentato senza successo la composizione negoziata della crisi. In tal caso, all’esito negativo delle trattative, l’imprenditore può proporre al tribunale un concordato liquidatorio senza voto dei creditori: sarà il tribunale a valutare la proposta e, se equa, omologarla anche senza il consenso dei creditori. È un meccanismo di emergenza per evitare il fallimento quando c’è il rischio che nessun concordato “classico” sarebbe approvato dai creditori – bypassandoli (da usare con cautela e sotto controllo giudiziale). Torneremo su questo se pertinente.
Procedura in breve: 1. Il debitore (con delibera dell’organo amministrativo e autorizzazione assembleare se società) deposita ricorso di concordato con il piano, la proposta ai creditori e tutti i documenti previsti (bilanci, elenco creditori, attestazione di un professionista indipendente sulla fattibilità del piano e sulla veridicità dei dati). Se è una domanda “con riserva” depositata senza piano, il tribunale nomina subito un commissario giudiziale e dà il termine per presentare il piano definitivo. 2. Il tribunale verifica la completezza e i requisiti legali della proposta. Se li ritiene idonei, ammette l’azienda alla procedura di concordato e nomina il Commissario Giudiziale (un professionista terzo che vigila sull’impresa durante la procedura e relaziona ai creditori). Da questa ammissione derivano gli effetti protettivi: blocco delle azioni esecutive dei creditori e divieto di pagare debiti anteriori (salvo autorizzazioni), mentre l’impresa continua la gestione sotto la supervisione del commissario. 3. I creditori vengono informati e convocati per esprimersi sulla proposta. Nelle procedure attuali, spesso il voto avviene per scritto senza assemblee fisiche, o telematicamente, soprattutto per creditori numerosi. I creditori sono suddivisi in classi se ci sono situazioni giuridiche differenziate (es. privilegiati, uno o più classi di chirografari a seconda di interessi comuni, creditori strategici con trattamenti diversi, ecc.). Per l’approvazione serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza per valore; non serve maggioranza numerica, ma è necessario il 50%+1 in valore totale, calcolando anche eventuali astenuti come contrari, salvo che siano in classi – i dettagli tecnici sono complessi ma semplificando, serve più del 50%). 4. Se la maggioranza vota a favore, il tribunale passa alla fase di omologa: verifica la regolarità, che il concordato non danneggi i creditori dissenzienti (test del “best interest of creditors”: ogni classe dissenziente deve ricevere almeno quanto otterrebbe in una liquidazione fallimentare) e che siano rispettate le norme (ad es. priorità dei crediti privilegiati, salvo diverse classi con consenso). Se tutto è a posto, omologa il concordato con decreto, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori (anche quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato). 5. Segue la fase di esecuzione del concordato: l’azienda, sotto monitoraggio (spesso lo stesso commissario diventa liquidatore giudiziale per vigilare sull’esecuzione), attua il piano: paga i creditori secondo le percentuali e scadenze previste, effettua eventuali dismissioni di beni, ecc. Una volta eseguito, il tribunale dichiara chiuso il concordato.
Vantaggi (dal lato debitore): – È uno strumento potente: può anche imporre tagli del debito significativi a tutti i creditori chirografari, con il consenso della maggioranza. Ad esempio, la società può proporre di pagare solo il 40% ai chirografari, se questo è più di quanto essi otterrebbero in caso di fallimento; se la maggioranza accetta, la minoranza dissenziente è comunque obbligata a subire la falcidia. – Il debitore in continuità rimane normalmente in possesso della gestione (debtor in possession): l’amministratore continua a gestire l’impresa (sotto sorveglianza), non c’è spossessamento totale come nel fallimento. Solo in casi di abuso o irregolarità il tribunale può nominare un amministratore giudiziario al posto degli organi (ipotesi rare). – Sospende le azioni esecutive e accumulative (nessuno può portare via i beni, il che dà respiro e preserva l’integrità aziendale). – Permette operazioni sul personale: in concordato si possono anche recedere da contratti onerosi, sciogliere contratti (con autorizzazione) e fare licenziamenti collettivi con procedura agevolata (previa autorizzazione del giudice delegato, equiparati a licenziamenti per cessazione attività). – Possibilità di finanza interinale: la legge consente di contrarre finanziamenti durante il concordato con privilegio speciale, per sostenere l’attività, con autorizzazione giudiziale. Ad esempio, i soci o banche possono finanziare la prosecuzione dell’impresa sapendo di avere prelazione in rimborso. – Trattamento dei privilegiati: i creditori con privilegio/garanzia devono ricevere integrale soddisfazione nel concordato (salvo che rinuncino o accettino diversa condizione). Tuttavia se l’attivo non basta a pagarli al 100%, è ammesso di dividerli in classi e offrire loro il ricavato effettivo dei beni su cui vantano prelazione. I crediti privilegiati non soddisfatti integralmente diventano chirografari per la parte eccedente e votano anch’essi. – Transazione fiscale nel concordato: come per gli accordi, nel concordato si può proporre il pagamento parziale di IVA e ritenute (cosa un tempo vietata). Oggi il CCII permette di includere tributi e contributi con falcidia o dilazione, e se l’Erario vota contro irragionevolmente ma la proposta è migliore del fallimento, il tribunale può omologare lo stesso (cram-down fiscale) . Questo è stato chiarito dalle modifiche del 2022-2023. Dunque, il debito fiscale non è più intoccabile nel concordato, fermo restando che almeno l’IVA e le ritenute possono essere solo dilazionate ma non falcidiate nel concordato in continuità (per legge vanno pagate integralmente, ma posticipate). In un concordato liquidatorio invece è possibile anche la falcidia di IVA se il Fisco approva o se c’è cram-down, grazie alle nuove norme. – Effetto esdebitativo per l’imprenditore individuale: se il debitore è persona fisica imprenditore e adempie il concordato, ottiene l’esdebitazione anche per l’eventuale parte di debiti chirografari non soddisfatta (art. 120 CCII), liberandolo dalle obbligazioni residue. (Per le società, l’esdebitazione non serve perché con l’esecuzione del concordato si estinguono le obbligazioni sociali nei termini stabiliti e poi la società prosegue la sua esistenza se era in continuità, oppure si scioglie se era liquidatorio).
Svantaggi e difficoltà: – Costi elevati e formalità: Il concordato è oneroso: bisogna pagare consulenti per predisporre il piano, l’attestatore, oltre alle spese di procedura (commissario, eventuali legali, contributo unificato, ecc.). È giustificabile per debiti di certa entità; per situazioni modeste potrebbe non valerne la pena. – Tempi: la procedura può richiedere molti mesi (dall’ammissione all’omologa spesso passa 1 anno circa). Durante questo periodo, l’impresa è sotto monitoraggio e spesso con liquidità ridotta (non può pagare debiti pregressi se non autorizzato, i fornitori potrebbero pretendere pagamento anticipato per fornire ancora merce, ecc.). Mantenere in vita l’azienda in concordato richiede abilità e spesso finanziamenti urgenti. – Rigidità del piano una volta proposto: Non è semplice modificarlo in corsa. Se emergono fatti nuovi, occorre formulare eventualmente un piano modificato e farlo votare, salvo piccole variazioni autorizzate dal giudice. Dunque, occorre un’attenta pianificazione ex ante. – Rischio di esito negativo: Se i creditori votano no, il concordato fallisce e tipicamente il tribunale dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda. Dunque è un’arma a doppio taglio: esporsi a un voto senza avere abbastanza sostegno può peggiorare la situazione. Prima di depositare un concordato, di norma, si sonda il terreno con i maggiori creditori per evitare brutte sorprese. – Perdita parziale di controllo: Pur restando in possesso, l’imprenditore è limitato: ogni atto di straordinaria amministrazione dev’essere autorizzato dal giudice, i pagamenti di debiti anteriori sono congelati, e di fatto il commissario e il giudice vigilano e possono riferire irregolarità (in casi gravi, come detto, si può essere spossessati se non ci si attiene alle regole). – Impatti reputazionali: Un concordato è pubblico e noto nel settore; clienti e fornitori ne vengono a conoscenza e questo può generare sfiducia, perdita di ordini, richieste di pagamento anticipato, ecc. L’azienda deve gestire bene la comunicazione e cercare di rassicurare stakeholders che il concordato è uno strumento di rilancio, non una fine mascherata. Non sempre facile.
Esempio pratico (concordato in continuità): L’azienda di pistole di soffiaggio elabora un piano di concordato in continuità dove: – Propone di pagare integralmente i debiti privilegiati (per es. mutuo ipotecario, TFR e salari arretrati, debiti fiscali privilegiati) magari con dilazioni (entro 2 anni dall’omologa per i fiscali, come consentito) e usando liquidità generata dalla gestione e dalla cessione di un ramo non strategico. – Ai creditori chirografari (fornitori non garantiti, banche per la parte scoperta, ecc.) propone il 50% dei loro crediti, da pagarsi in 4 rate semestrali nell’arco di 2 anni a partire dall’omologa. Questo 50% è superiore a quanto risulterebbe da una liquidazione forzata (stimata dal perito attorno al 20%). Inoltre i soci si impegnano a versare un finanziamento postergato di 100.000€ per contribuire ai pagamenti. – Prevede la continuità: l’azienda resterà attiva, con un business plan che mostra utile annuale di cui una parte andrà ai creditori concordatari. Vengono mantenuti i dipendenti, anzi viene presentata come soluzione per salvare i posti di lavoro (cosa che spesso rende i creditori più ben disposti). – L’attestatore indipendente certifica che il piano è realistico e che i creditori avranno il 50% che è meglio del 20% in scenario liquidatorio. – Il tribunale ammette il concordato. Durante la procedura, i creditori (banche, fornitori) valutano e alla fine l’80% in valore dei crediti vota favorevole (molti pensano che 50% sia un buon recupero visto il rischio altrimenti). Il concordato viene omologato. L’azienda continua a operare e in 24 mesi paga le rate concordatarie; al termine, esce dalla procedura avendo ridotto il debito a metà e potendo proseguire l’attività con più solidità.
Esempio pratico (concordato liquidatorio): Se invece l’azienda fosse decisa a chiudere l’attività: – Potrebbe proporre un concordato liquidatorio offrendo la vendita di tutti i beni (magazzino, macchinari, immobili) e la distribuzione pro-quota ai creditori. Ad esempio, stimando di ricavare 300.000€ da tutto, offrirebbe il 30% ai chirografari (se ciò soddisfa il minimo di legge) con pagamento in unica soluzione non appena venduti i beni. Spesso qui c’è l’intervento di un terzo: es. un investitore o i soci stessi offrono essi di mettere sul piatto un tot (diciamo 50.000€) a beneficio dei creditori purché la procedura concordataria si chiuda rapidamente e senza strascichi penali. Questo migliora la percentuale per i creditori. – I creditori votano sì perché preferiscono questo 30% subito piuttosto che il 20% incerto del fallimento in anni. L’omologa prevede la nomina di un liquidatore che in pochi mesi realizza l’attivo e paga il dovuto. La società viene poi cancellata e i soci (se illimitatamente responsabili, in caso di SNC, otterrebbero pure loro l’esdebitazione per la parte residua forse). – Con il concordato si ottiene anche l’effetto di chiudere pendenze come ad esempio evitare azioni revocatorie potenziali contro chi ha ricevuto pagamenti: perché il concordato approvato ed eseguito impedisce successive azioni revocatorie, consolidando gli atti compiuti in esso.
In conclusione sul concordato: è lo strumento più articolato e garantito legalmente, ma impegnativo. Dalla prospettiva del debitore, intraprendere un concordato significa ammettere la crisi in un contesto ufficiale, ma anche prendere in mano l’iniziativa per risolverla in modo controllato, anziché subirla passivamente con un fallimento. Spesso la scelta concordato vs fallimento è anche influenzata da eventuali responsabilità del management: in concordato, di norma, i procedimenti per bancarotta vengono sospesi (non essendoci fallimento dichiarato, non c’è titolo per indagare per bancarotta, salvo reati societari autonomi). Se invece si andasse in liquidazione giudiziale, la Procura e il curatore potrebbero avviare azioni di responsabilità e segnalare reati concorsuali. Dunque, per un amministratore che ha fatto qualche errore, salvare l’azienda con un concordato evita il marchio di fallito e riduce l’esposizione penale (fermo restando che atti distrattivi o fraudolenti emergerebbero comunque se fatti). Più avanti tratteremo nel dettaglio gli aspetti penalistici e di responsabilità.
3.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Novità assoluta introdotta nel 2021 e oggi integrata nel CCII (artt. 12-25 CCII) è la Composizione Negoziata della Crisi. Si tratta di una procedura volontaria e riservata di assistenza all’imprenditore in crisi tramite un esperto indipendente, finalizzata a facilitare la negoziazione di accordi con i creditori o altre soluzioni (anche concorsuali) per superare la crisi, evitando quando possibile la soluzione giudiziale.
In cosa consiste: – L’imprenditore (sia grande che piccolo, di qualsiasi forma giuridica, anche imprenditore agricolo che prima era escluso da fallimento) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e ritiene di avere prospettive di risanamento, può presentare istanza tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio per l’accesso alla composizione negoziata. – Un’apposita commissione nomina un Esperto indipendente (di solito un commercialista, avvocato o consulente con specifica formazione sulla crisi) che, entro 2 giorni dall’accettazione, convoca l’imprenditore per iniziare a esaminare la situazione. L’esperto svolge un ruolo di mediatore qualificato: aiuta a individuare possibili soluzioni e a condurre le trattative con i creditori, ma non ha poteri decisionali vincolanti. – La procedura è riservata: l’accesso non viene pubblicizzato (salvo che l’imprenditore chieda misure protettive al tribunale, in tal caso l’istanza e i provvedimenti di protezione sono pubblicati al RI). L’idea è di consentire all’impresa di lavorare sottotraccia alla soluzione, per evitare l’effetto stigma prematuro. – Durante la composizione negoziata, l’imprenditore rimane al timone della società. L’esperto può solo formulare raccomandazioni. Se l’imprenditore non le segue, l’esperto può dimettersi o segnalare chiusura anticipata. – L’esperto incontra periodicamente i creditori (in riunioni congiunte o separate) cercando di far convergere su un accordo. Quali possibili esiti? – Un contratto di ristrutturazione ad hoc con taluni creditori (es. intesa privata con le banche per riscadenzare debiti, con i fornitori per riduzioni, ecc.). – Un piano attestato di risanamento (l’esperto può aiutare a predisporlo). – Un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (l’esperto facilita la stesura e le adesioni, poi si va in omologa). – Un concordato preventivo (magari semplificato, come detto, se la negoziazione fallisce su un risanamento ma c’è margine per evitare il fallimento). – Oppure la conclusione senza accordo, e in tal caso l’imprenditore valuterà la liquidazione ordinaria o la domanda di liquidazione giudiziale.
- Misure protettive e cautelari: l’imprenditore in composizione negoziata può chiedere al tribunale di disporre misure protettive temporanee del patrimonio (tipicamente, sospensione o divieto di iniziare azioni esecutive da parte dei creditori). Di norma, la presentazione dell’istanza produce un effetto protettivo automatico per 30 giorni pubblicato su Registro Imprese , che può essere confermato e prorogato dal giudice per periodi fino a 4+4 mesi. Queste misure, come già accennato, impediscono ai creditori di agire individualmente mentre si tenta la trattativa. Il tribunale può anche emettere provvedimenti cautelari (es. per ottenere nuova finanza prededucibile, o per autorizzare atti urgenti di straordinaria amministrazione).
- Vantaggi per l’imprenditore diligente: se l’imprenditore segue le indicazioni dell’esperto e conduce le trattative in buona fede, la legge prevede alcuni benefici. Ad es.: eventuali finanziamenti effettuati dai soci o da terzi durante la composizione negoziata per supportare l’impresa sono considerati prededucibili (quindi preferiti se poi si andasse in concordato o fallimento). Inoltre, dal punto di vista delle responsabilità civili e penali, l’imprenditore che ricorre tempestivamente alla composizione negoziata adempie al dovere di adottare misure per superare la crisi (come richiesto dall’art. 2086 c.c. e dal Codice Crisi), il che può proteggerlo da accuse di aver aggravato il dissesto. Anche i creditori che partecipano attivamente possono evitare poi contestazioni di aver ritardato indebitamente l’emersione.
- Conclusione: la composizione negoziata termina entro un tempo relativamente breve (non c’è un termine fisso per legge, ma è pensata per soluzioni in pochi mesi, di solito 3-6 mesi). Può terminare con:
- Esito positivo: accordo raggiunto (allora quell’accordo potrà essere un semplice accordo privato o sfociare in un piano attestato, accordo omologato o concordato semplificato).
- Esito negativo: l’esperto dichiara che le trattative non hanno portato a soluzione. In tal caso, come detto, il debitore può scegliere di depositare un concordato semplificato liquidatorio entro 60 giorni oppure, se non fa nulla, i creditori potrebbero a quel punto attivarsi (ma avranno comunque beneficiato della trasparenza del processo e magari ridotto conflittualità).
- L’esperto redige una relazione finale sugli esiti.
Efficacia e utilizzo: Essendo uno strumento relativamente nuovo, la composizione negoziata è stata utilizzata in diverse decine di casi nel 2022-2023, spesso evitando fallimenti di piccole imprese. Per esempio, in un comunicato del Ministero della Giustizia del 2023 si evidenziava che un buon numero di imprese micro (anche con debiti entro €30000) hanno sfruttato la composizione negoziata trovando accordi stragiudiziali e salvando l’attività .
Quando considerarla: Sempre! Nel senso che il legislatore ormai si aspetta che l’imprenditore in crisi ricorra per tempo a strumenti di allerta interna o esterna. La composizione negoziata è volutamente non stigmatizzante e poco invasiva, per incoraggiare gli amministratori a non aspettare l’ultimo minuto. Quindi, un’azienda come la nostra, appena intuisce di non riuscire a pagare regolarmente i debiti nei prossimi mesi, potrebbe rivolgersi alla composizione negoziata. Non ci sono particolari controindicazioni: se la situazione è recuperabile, l’esperto aiuterà; se non lo è, l’esperto stesso glielo farà notare e allora tanto vale prepararsi al concordato o alla liquidazione.
Relazione con gli altri strumenti: La composizione negoziata può sfociare in un piano attestato, accordo ex art.57 o concordato, come illustrato, quindi non è alternativa ma complementare. Un aspetto chiave è che, a differenza delle misure concorsuali, il percorso è reversibile: l’imprenditore può decidere di interrompere la composizione negoziata se non la ritiene più utile, senza per questo finire automaticamente in procedura concorsuale (salvo che l’insolvenza sia ormai manifesta e i creditori agiscano). Ciò la rende una sorta di “zona protetta” temporanea per trovare soluzioni creative: ad esempio, l’esperto può aiutare a negoziare la cessione dell’azienda ad un concorrente solido che si accolla i debiti (soluzione di mercato), oppure la ricerca di un investitore che ricapitalizzi la società in crisi. Queste sono ipotesi extra-procedurali che un concordato non consente con la stessa flessibilità.
Esempio pratico: L’azienda di pistole di soffiaggio si iscrive alla piattaforma di composizione negoziata. Viene nominato un esperto, il dott. Rossi, che esamina i conti e dice: “vedo che avete ordini in calo e un debito con banche e fornitori alto, ma se riducete certi costi e convertite quel capannone inutilizzato in liquidità vendendolo, potreste farcela”. L’esperto convoca le banche: queste, vedendo la situazione, accettano di sospendere le rate di mutuo per 6 mesi e poi allungare i piani di ammortamento (grazie anche al fatto che l’esperto certifica che così facendo hanno più chance di recuperare tutto). I fornitori maggiori vengono coinvolti: alcuni accettano un pagamento parziale a saldo del dovuto (taglio del 20%) purché l’azienda continui a comprar da loro. Si mette tutto per iscritto: ne risulta un accordo stragiudiziale firmato da tutti, senza bisogno di omologazione perché tutti i principali creditori sono d’accordo. L’azienda in 4 mesi ha ristrutturato il suo debito in via amichevole, e la composizione negoziata termina con successo. Nessuno all’esterno (clienti, media) è venuto a saperlo, l’azienda continua e i debiti scendono a un livello sostenibile.
In un caso meno fortunato, invece, se alcuni creditori fossero stati restii, l’esperto avrebbe potuto suggerire: “trasformiamo questo lavoro in un accordo ex art.57 da portare in tribunale: siete al 70% di adesioni, usiamo il cram-down per forzare i restanti”. Oppure: “non c’è più speranza, preparate un concordato preventivo; almeno deciderete voi come liquidare, magari vendendo la licenza e il marchio al miglior offerente per dare qualcosa ai creditori, usando il concordato semplificato visto che siamo in negoziata”.
Quindi, la composizione negoziata funge un po’ da “centrale di smistamento” della crisi: cerca la via meno traumatica, ma è pronta a indirizzare verso le procedure formali se necessario.
3.5 Liquidazione giudiziale (ex fallimento) ed esdebitazione
Se nessuna delle soluzioni di cui sopra riesce o è praticabile, si giunge alla liquidazione giudiziale, che è il nuovo nome del fallimento nel Codice della Crisi (artt. 121-270 CCII). Questa è la procedura concorsuale distruttiva, che ha lo scopo di liquidare il patrimonio del debitore insolvente e distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione, accertando nello stesso tempo le responsabilità eventualmente connesse all’insolvenza.
Dal punto di vista dell’azienda debitrice, la liquidazione giudiziale significa: – Perdita della gestione: gli amministratori sono spossessati; il tribunale nomina un Curatore che amministra i beni dell’impresa, procede alla vendita di asset, risolve i contratti pendenti se del caso, gestisce il contenzioso. Viene nominato anche un Giudice Delegato e un Comitato dei Creditori che vigilano sul curatore. – Sospensione delle azioni individuali: con la sentenza di apertura, tutti i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (devono far valere i loro crediti nella procedura collettiva). – Cristallizzazione dei debiti: i crediti maturano solo fino alla data di apertura, poi cessano gli interessi (salvo privilegiati se il patrimonio basta). – Licenziamento del personale: in genere il curatore interrompe l’attività a meno che vi sia convenienza a esercitarla provvisoriamente per vendere l’azienda in esercizio (esercizio provvisorio). Nella maggior parte dei casi di PMI, il fallimento porta allo stop immediato dell’attività e ai licenziamenti, con i lavoratori che poi chiederanno al Fondo di Garanzia INPS i loro crediti. – Accertamento del passivo: i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo; il curatore forma lo stato passivo e il giudice delegato lo verifica e rende esecutivo. Questo definisce chi partecipa e come (privilegi, importi ammessi, eventuali esclusi). – Liquidazione dell’attivo: il curatore vende i beni (per asta o trattativa autorizzata) e raccoglie crediti (anche promuovendo cause, azioni revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori se opportuno). Il ricavato viene poi distribuito secondo i gradi di privilegio: prima le spese di procedura, poi i crediti con pegno/ipoteca (fino a capienza del valore del bene), poi i privilegi generali (es. dipendenti, fisco per IVA e ritenute, ecc.), e infine se residua qualcosa i chirografari. – Chiusura: quando non ci sono più attivi da realizzare, il tribunale dichiara chiusa la liquidazione. Se qualcosa è stato pagato ai chirografari, bene; spesso però costoro prendono poco o nulla.
Per la società giuridica dichiarata fallita, la chiusura del fallimento ne comporta la cancellazione definitiva (morte societaria). Per l’imprenditore individuale fallito o i soci illimitatamente responsabili falliti, la chiusura non cancella i debiti residui automaticamente (a differenza delle società, la persona rimarrebbe debitrice). Tuttavia, la legge prevede l’esdebitazione del debitore persona fisica: il fallito può ottenere, ricorrendone le condizioni, la liberazione dai debiti non soddisfatti, come “fresh start”. Nel CCII l’esdebitazione è in parte automatica: il debitore persona fisica che ha cooperato con la procedura ottiene di diritto l’esdebitazione salvo opposizione di creditori o cause ostative (es: condanne per bancarotta, mancanza di collaborazione, aver beneficiato già di esdebitazione nei 5 anni precedenti, ecc.) . Ad esempio, se un piccolo imprenditore individuale viene liquidato e i creditori ricevono solo il 10%, con l’esdebitazione lui non dovrà più il restante 90%, potendo ripartire da zero (tranne alcune eccezioni come debiti per alimenti, risarcimenti da illecito extra-contrattuale e sanzioni penali/amministrative che restano comunque dovuti).
Perché preferire soluzioni diverse dal fallimento: Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è un evento traumatico: si perde il controllo, l’azienda spesso viene spazzata via (a meno di improbabili esercizi provvisori o vendite unitarie a terzi), la reputazione personale e aziendale ne esce distrutta, e si rischia di incorrere in responsabilità penali (poiché con la sentenza di fallimento scatta la verifica di eventuali reati concorsuali, vedi infra sezione penale). I creditori chirografari recuperano generalmente molto poco. Insomma, è la “sconfitta” di tutte le parti in un certo senso, necessaria solo quando davvero non c’è accordo o risorsa sufficiente per un’alternativa.
Va però detto che in alcune situazioni estreme, anche per il debitore può essere conveniente lasciar andare in liquidazione giudiziale, specialmente se: – Si è un imprenditore individuale senza patrimonio personale rilevante da perdere, e con l’esdebitazione potrà ripartire pulito in pochi anni. – Si è amministratore di una società che ormai è decotta e non ha prospettive, e si vuole evitare di aggravare la situazione: auto-dichiarare la liquidazione può limitare i danni e far partire il “contatore” della procedura, sottraendo la gestione e congelando i debiti. – Esistono gravi irregolarità passate che renderebbero difficile l’omologa di un concordato (es. mancanza di scritture contabili – in tal caso i creditori non si fiderebbero e il tribunale non potrebbe attestare la veridicità dei dati, quindi tanto varrebbe rassegnarsi al fallimento e affrontarne le conseguenze).
Rapporto con l’allerta e obblighi organizzativi: Segnaliamo che il CCII aveva previsto anche meccanismi di allerta (segnalazioni obbligatorie di crisi da parte di organi societari o creditori pubblici qualificati) per anticipare gli interventi, ma tali misure sono state rinviate e in parte superate dalla composizione negoziata volontaria. Ad ogni modo, l’art. 3 CCII afferma il principio per cui la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio, da evitare ove possibile privilegiando soluzioni di risanamento.
Chiusura anticipata e semplificazioni: In alcuni casi, il CCII consente la chiusura “anticipata” del fallimento senza riparto se non ci sono attivi e creditori (cd. chiusura per insufficienza dell’attivo) – rilevante per micro imprese. E per le imprese minori non fallibili (quelle sotto le soglie dell’art. 2 CCII), è prevista la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), molto simile al fallimento ma in sede di tribunale civile come evoluzione della vecchia procedura di sovraindebitamento (L.3/2012). Queste sono finezze procedurali che confermano: ogni impresa, grande o piccola, ha comunque uno strumento liquidatorio applicabile.
Esempio riassuntivo: se la nostra azienda di pistole di soffiaggio proprio non riesce a risollevarsi, potrebbe finire in liquidazione giudiziale. Il curatore venderà i macchinari all’asta, rescinderà il contratto di affitto del capannone, incasserà eventuali crediti verso clienti, e liquiderà tutto. Forse un concorrente comprerà i brevetti o il marchio dall’attivo fallimentare. I dipendenti verranno licenziati e pagati in privilegio (con intervento INPS per il TFR). I creditori ipotecari (banca) prenderanno dal ricavato degli immobili (se c’erano), l’Erario e INPS qualcosa se resta, i fornitori quasi nulla. L’amministratore potrebbe subire un’azione di responsabilità se ha commesso errori di gestione che hanno aggravato il buco (il curatore la valuterà). Dopo due anni la procedura chiude, la società è estinta. L’amministratore e i soci (se erano di SNC) chiederanno l’esdebitazione personale per non avere ulteriori strascichi. Fine della storia di quell’impresa.
Nota sulle sanzioni amministrative e interdittive: Da segnalare che la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale comporta per l’imprenditore individuo o per gli amministratori di società alcune conseguenze come l’incapacità a esercitare attività d’impresa per una certa durata, la perdita di cariche (non si può essere amministratore di altre società durante la procedura) e altre interdizioni (non si può espatriare senza autorizzazione, ad esempio). Inoltre se vi sono indizi di reato il curatore li segnala al PM obbligatoriamente.
Abbiamo così esaminato l’intero ventaglio di strumenti formali e informali per affrontare i debiti di un’azienda in difficoltà. Nella prossima sezione, sposteremo il focus sulle responsabilità personali dell’imprenditore o degli amministratori in questi scenari: cosa si rischia civilmente e penalmente quando un’azienda non paga i propri debiti e va in insolvenza, e come difendersi da tali conseguenze.
4. Responsabilità dell’imprenditore e difesa legale
Dal punto di vista del debitore (titolare o amministratore dell’azienda), non è sufficiente gestire i rapporti coi creditori: occorre anche proteggersi da eventuali responsabilità che possono derivare dalla situazione di indebitamento e insolvenza. In questa sezione affrontiamo: – La responsabilità civile degli amministratori o dei soci per i debiti sociali o per l’aggravamento della crisi. – Le conseguenze penali in caso di insolvenza conclamata e comportamenti illeciti (i reati fallimentari e tributari). – Come un imprenditore può prevenire o attenuare tali rischi agendo con diligenza e in conformità alla legge (es. adottando adeguati assetti organizzativi, usando tempestivamente gli strumenti di cui sopra).
4.1 Doveri dell’organo amministrativo in situazione di crisi
Il Codice Civile (art. 2086, comma 2) impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi adeguati ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della continuità aziendale, e – una volta rilevati segnali di crisi – di attivarsi senza indugio per adottare e attuare uno degli strumenti previsti per il suo superamento. Questo principio, introdotto con la riforma del 2019, significa in pratica che gli amministratori hanno il dovere legale di monitorare la salute aziendale (con strumenti contabili, flussi di cassa previsionali, indicatori di crisi) e di reagire prontamente se qualcosa va storto (ad esempio convocando i soci per ricapitalizzare, o attivando la composizione negoziata, ecc.). La violazione di questo dovere può costituire un atto di mala gestio e fonte di responsabilità.
Inoltre, permane l’obbligo classico per le società di capitali di attivare le procedure di riduzione del capitale o scioglimento in caso di perdita rilevante: – Se la società perde oltre 1/3 del capitale sociale e questo scende sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare l’assemblea (artt. 2447 per SpA, 2482-ter c.c. per Srl) per deliberare la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento. Proseguire l’attività senza capitali è illecito e causa responsabilità per gli amministratori. – Anche senza scendere sotto il minimo, la perdita di oltre 1/3 del capitale obbliga a misure (art. 2446, 2482-bis c.c.). Queste norme servono a evitare che un’impresa decotta continui ad accumulare debiti a danno dei creditori.
Se gli amministratori omettono di adempiere a tali obblighi formali e sostanziali, possono incorrere in: – Responsabilità verso la società (azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. o 2476 c.c.) per mala gestio. – Responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), quando dal mancato rispetto dei doveri di conservazione del patrimonio sociale deriva l’insufficienza di quest’ultimo a soddisfare i creditori. Ad esempio, se non convocano l’assemblea per perdite e continuano a fare affari che aggravano il deficit, i creditori sociali potranno chiedere i danni agli amministratori. – In sede fallimentare, queste azioni di responsabilità vengono esercitate dal curatore (art. 146 L.F., ora art. 255 CCII). La giurisprudenza ha affinato i criteri: la Cassazione ha chiarito che anche il semplice aggravamento del dissesto costituisce un danno risarcibile e un presupposto di responsabilità, non occorrendo che gli amministratori abbiano causato da zero il dissesto . In altre parole, se l’impresa era in difficoltà e gli amministratori, tardando a prendere misure, hanno aumentato il buco, risponderanno di quell’aggravamento. Una pronuncia del 2023 della Cassazione ha confermato che l’aggravamento del dissesto societario, anche in assenza di dolo specifico, è sufficiente a configurare il reato di bancarotta impropria e la relativa responsabilità (nel caso, amministratore che occultava perdite in bilancio per proseguire l’attività causando ulteriori perdite) . – Criterio di valutazione del danno: la legge (art. 2486 c.c., come modificato dall’art. 378 CCII) prevede che, quando la gestione prosegue illegittimamente dopo la causa di scioglimento (come il capitale azzerato), il danno da mala gestio può essere quantificato come la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui doveva essere adottata la misura (liquidazione) e il patrimonio netto alla data in cui essa è effettivamente intervenuta, oppure in subordine come differenza tra attivo realizzato e passivo al momento della procedura . Questo introduce una sorta di presunzione: se gli amministratori tardano a fermare il gioco, rispondono dell’erosione ulteriore del patrimonio. Essi possono difendersi provando che l’aggravamento non è dipeso dalla loro inerzia ma da altri fattori inevitabili.
In pratica, un amministratore diligente di fronte alla crisi dovrebbe: – Non occultare la situazione ma anzi informare i soci e il collegio sindacale (se c’è) tempestivamente. – Documentare di aver tentato le soluzioni ragionevoli (taglio costi, ricerca investitori, attivazione di composizione negoziata, etc.). – Se capisce che non c’è nulla da fare, non contrarre nuovi debiti se non quelli indispensabili e con prospettiva di essere pagati (contrarre debiti senza speranza di rimborso può essere considerato abuso di credito e anche penalmente rilevante). – Non “giocare d’azzardo” col patrimonio residuo (ad esempio evitando di lanciare in extremis operazioni rischiosissime sperando di salvare tutto: questo in inglese si chiama gambling for resurrection e può configurare atti dolosi di bancarotta). – Rispettare la par condicio creditorum, evitando di favorire qualche creditore particolare con pagamenti preferenziali ingiustificati.
4.2 Responsabilità dei soci e garanti
Abbiamo già trattato la responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti (illimitata nelle società di persone, limitata nelle SRL salvo conferimenti). Aggiungiamo alcune situazioni tipiche: – Soci garanti (fideiussori): Molte volte nelle PMI i soci o l’imprenditore stesso firma garanzie personali a favore di banche, fornitori (fideiussioni, avalli su cambiali, polizze a prima richiesta). In caso di default della società, il creditore ovviamente escuterà la garanzia. Il socio-garante diventa debitore a titolo personale e dovrà pagare col proprio patrimonio. Una volta pagato, avrà diritto di regresso verso la società, ma se questa è insolvente, sarà una magra consolazione. Dunque per chi ha prestato fideiussioni, difendersi significa eventualmente trattare anche a titolo personale con i creditori per ottenere liberatorie o transazioni (ad es. pagando una parte in cambio della liberazione dalla fideiussione). – Soci finanziatori: se i soci hanno fatto prestiti alla società (finanziamenti soci), in crisi questi crediti sono postergati per legge (art. 2467 c.c. per Srl): vengono dopo tutti gli altri, e in caso di fallimento spesso non prendono nulla. Quindi, tali debiti “verso soci” non sono un vero problema per i creditori terzi, ma per i soci stessi che li perderanno; i soci non possono pretendere di essere pagati prima degli altri (anzi, se hanno restituzioni avvenute nell’anno precedente, il curatore le può restituire ai creditori). – Cessione d’azienda e continuazione in altra forma: a volte i soci pensano di “salvarsi” trasferendo l’attività (macchinari, know-how, dipendenti) a una newco pulita, lasciando i debiti nella vecchia società destinata al fallimento. Attenzione: operazioni del genere, se fatte sottocosto o per frodare i creditori, possono essere dichiarate inefficaci (azione revocatoria fallimentare) e possono integrare reati (bancarotta fraudolenta per distrazione). Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto in certi casi la figura di società di fatto tra vecchia e nuova impresa, estendendo il fallimento ad entrambe, soprattutto se di fatto c’è la stessa proprietà e continuità. Quindi è una strada pericolosissima se non percorsa in modo trasparente (un’alternativa legale è fare un concordato con cessione dell’azienda al nuovo soggetto che si accolla parte dei debiti; oppure vendere l’azienda a valori di mercato e usare i proventi per pagare i creditori – se tutto è a valori reali, non c’è frode, ma bisogna poterlo dimostrare).
- Ex soci di società estinta: se una SRL viene chiusa senza pagare tutti i creditori, i creditori possono agire verso i soci fino a concorrenza di quanto riscosso in liquidazione (spesso zero). Se una SNC viene chiusa, i soci restano illimitatamente responsabili come visto. Ma cosa succede se i soci hanno venduto le loro quote prima che la società fallisse? La L. Fall. e ora il CCII prevedono che i soci illimitatamente responsabili usciti nei 2 anni precedenti il fallimento restano coinvolgibili (possono essere dichiarati falliti personalmente entro 2 anni dall’uscita). Per i soci di capitali, invece, chi cede la partecipazione non risponde dei debiti futuri, salvo impegni contrattuali presi (caveat: spesso nelle vendite di aziende indebitate si inseriscono clausole di manleva o i creditori chiedono comunque ai vecchi soci garanzie).
In sintesi, il socio di una società di capitali che non abbia prestato garanzie né preso distribuzioni indebite è abbastanza al riparo: se l’azienda fallisce, lui perde il capitale investito ma non rischia la casa (salvo fideiussioni). Il socio di società personale rischia tutto, come abbiamo detto, ma almeno per lui c’è l’esdebitazione personale possibile come ultima chance.
4.3 Profili penali dell’insolvenza: reati fallimentari e tributari
La crisi d’impresa ha anche un lato penalmente rilevante. Di per sé l’insolvenza non è un reato (non esiste reato di “non pagare i debiti” in generale), ma molte condotte che spesso accompagnano o causano l’insolvenza possono esserlo. Occorre distinguere: – Reati commessi prima o in vista del fallimento, puniti dal diritto penale fallimentare (R.D. 267/1942, artt. 216 e segg., in parte recepiti nel CCII Titolo IX art. 322 e segg. per futura riforma). – Reati tributari connessi a omessi pagamenti di imposte. – Altri reati societari o finanziari (false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ecc.) che possono emergere in contesti di dissesto.
Ci concentriamo sui reati fallimentari principali:
- Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F., art. 322 CCII): è il reato tipico di chi, prima o durante la procedura fallimentare, distrae, sottrae, occulta, dissimula o distrugge beni del patrimonio oppure espone passività inesistenti, con dolo di recare pregiudizio ai creditori. Esempi: l’amministratore che prima del fallimento vende sottocosto un macchinario a un complice per non farlo trovare al curatore (distrazione), o che preleva fondi aziendali su conti esteri (occultamento), o che simula un debito verso una società compiacente per ridurre il residuo attivo (passività fittizie). È un reato molto grave, punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Anche il semplice fatto di aver usato i beni sociali per scopi personali o estranei all’impresa può configurare bancarotta fraudolenta (distrazione) se poi si fallisce. Non è necessario che i creditori abbiano effettivamente subito danno patrimoniale quantificabile, basta l’atto pregiudizievole. Questo reato può coinvolgere amministratori, soci di fatto, direttori generali, liquidatori e anche terzi complici.
- Bancarotta fraudolenta documentale: sempre art. 216, punisce chi sottrae o falsifica i libri e le scritture contabili, o li tiene in maniera da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. Ad esempio, chi distrugge le fatture e la contabilità prima del fallimento, o tiene “doppi bilanci”, o omette di tenere le scritture obbligatorie. Pena: reclusione da 3 a 10 anni. La ratio è chiara: in fallimento le scritture servono a capire cosa è successo e dove sono finiti i soldi; se non ci sono, si presume la volontà di nascondere malefatte.
- Bancarotta preferenziale: è sempre fraudolenta, e consiste nell’aver eseguito pagamenti o altre operazioni che favoriscono un creditore a danno di altri in situazione di insolvenza. Quindi se nei mesi prima del fallimento l’imprenditore paga integralmente un creditore “amico” (magari un fornitore in cui ha interesse) sapendo di non poter pagare gli altri, commette bancarotta preferenziale. Anche la concessione di garanzie a un creditore preesistente (es: ipotecare un immobile alla banca quando già si è insolventi per garantirle il credito) è preferenza illecita. Va però provato il dolo di favorire quel creditore e la scientia decoctionis (consapevolezza dello stato di insolvenza). Spesso c’è sovrapposizione con la revocatoria fallimentare: un atto revocabile può anche costituire bancarotta preferenziale se fatto con dolo. Pena: reclusione da 1 a 5 anni (forma attenuata rispetto a bancarotta fraudolenta patrimoniale).
- Bancarotta semplice (art. 217 L.F., art. 323 CCII): punisce condotte meno gravi, spesso connotate da colpa o lieve dolo, che abbiano però contribuito al dissesto. Esempi: aver sostenuto spese personali eccessive nell’ultimo periodo, aver aggravato il fallimento con imprudenze, aver omesso di tenere i libri senza malizia (ma con negligenza), non aver chiesto il fallimento in tempo. La bancarotta semplice è punita con reclusione fino a 2 anni (massimo 5 in ipotesi aggravate). Rientra qui, ad esempio, l’aver procrastinato la richiesta di concordato o fallimento aggravando il buco – condotta che talvolta viene qualificata come operazione dolosa in bancarotta fraudolenta se era una scelta deliberata (c’è un sottile confine: l’inerzia assoluta di fronte a dissesto può integrare il dolo eventuale di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose ). Un caso del 2020 in Cassazione ha ritenuto che l’inerzia gestionale di fronte a capitale azzerato costituiva operazione dolosa punibile come bancarotta fraudolenta (quindi molto grave) perché l’amministratore si era limitato a non far nulla aggravando passivamente i debiti . In generale, però, se non emergono atti distrattivi, le omissioni sono classificate come bancarotta semplice.
- Ricorso abusivo al credito: è una figura di bancarotta fraudolenta (art. 223 co.2 n.2 L.F.) punita quando l’imprenditore ha contratto nuovi debiti sapendo di non poterli pagare, peggiorando il dissesto. Ad esempio, continuare a emettere cambiali o chiedere fidi bancari quando l’impresa è già insolvente. Questo perché tali atti sono considerati dolosamente pregiudizievoli (ingannano nuovi creditori destinandoli a non essere pagati).
- Altri reati: falso in bilancio (se effettuato, aggravato in caso di fallimento perché si lega alla bancarotta impropria ex art. 223 co.2 n.1 L.F.), reati tributari (omessa dichiarazione, emissione di fatture false, ecc.) se presenti, truffe ai creditori, ecc. possono concorrere.
Reati tributari rilevanti per l’imprenditore indebitato: – Omesso versamento IVA oltre soglia (art. 10-ter D.Lgs 74/2000): come già spiegato, se l’IVA annuale non versata supera €250.000 e non viene sanata entro il termine di legge (attualmente 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione grazie alla riforma fiscale 2023/2024), scatta il reato con pena fino a 2 anni . L’imprenditore può evitare il reato se avvia un pagamento rateale (anche pagando solo la prima rata di un avviso bonario) prima di tale scadenza . Dunque, un consiglio per chi si trova a fine anno con IVA non versata: accordarsi con Agenzia Entrate per una rateazione entro dicembre, così da sterilizzare il penale, come la normativa in vigore a fine 2025 consente. – Omesso versamento ritenute (art. 10-bis D.Lgs 74/2000): omettere di versare le ritenute fiscali (es. quelle su stipendi o su compensi a autonomi) oltre €150.000 per periodo d’imposta è reato (pena fino a 3 anni). La soglia è di 150k e vale per le ritenute risultanti dalla CU annuale. Se sotto, è illecito amministrativo. – Frode fiscale, dichiarazione fraudolenta: se l’impresa, magari in difficoltà, ha fatto uso di fatture false o artifici per non pagare tasse, potrebbero emergere reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 e 3 D.Lgs 74/2000) con soglie e pene più alte (reclusione fino a 6-8 anni a seconda dei casi). – Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000): se prima di che il fisco proceda l’imprenditore occulta o distrae beni al fine di rendersi incapiente verso l’Erario, commette questo reato (es. simula la vendita di un immobile a un familiare per evitare ipoteca fiscale). Molto legato alle situazioni di debito fiscale.
Tornando ai reati fallimentari, quando scattano? Questi reati richiedono generalmente la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) per essere configurabili, perché l’apertura della procedura segna il momento in cui condotte precedenti assumono rilevanza penale di “bancarotta”. Quindi, se un’azienda riesce a risanarsi senza fallire o fa un concordato che va a buon fine, gli amministratori non saranno imputati di bancarotta (non c’è fallimento). Attenzione però: – Esistono i reati di bancarotta societaria impropria (art. 223 L.F.): ad esempio il caso dell’amministratore che con false comunicazioni sociali ha cagionato il dissesto – come da Cassazione 2023 citata , se dichiarato fallimento quell’illecito diventa bancarotta impropria punibile. – Per far scattare indagini per bancarotta è sufficiente la sentenza di fallimento. Da quel momento, il curatore trasmette al PM una relazione su cause ed eventualmente su atti di mala gestio. Il PM può anche disporre misure cautelari (arresti, sequestri) se ritiene ci siano estremi di reato gravi come bancarotta fraudolenta.
Difese e attenuanti per l’imprenditore: – Documentare tutto: se l’amministratore ha tenuto contabilità ordinata e completa, potrà difendersi efficacemente da accuse di bancarotta documentale (anzi, se i libri sono a posto, difficilmente verrà accusato di questo). – Agire in buona fede e con trasparenza: molte volte, imputati di bancarotta preferenziale o semplice invocano di aver agito per tentare di salvare l’impresa, non per favorire se stessi. La legge prevede attenuanti o cause di non punibilità, ad esempio l’art. 217-bis L.F. esclude punibilità per pagamenti preferenziali effettuati in esecuzione di un piano attestato di risanamento o di un concordato preventivo omologato. Quindi, agire nell’ambito di strumenti legali come il piano attestato protegge penalmente – ecco un altro motivo per usarli. – Risarcimento e condotte riparatorie: se prima dell’apertura di un eventuale dibattimento penale l’imprenditore paga tutti i debiti tributari (nel caso di reati fiscali) o risarcisce integralmente i creditori per il danno, può beneficiare di cause di non punibilità o attenuanti generiche. – Patteggiamento ed effetti sull’esdebitazione: una cosa da notare è che, fino alla riforma del 2022, una condanna penale anche patteggiata per bancarotta precludeva l’esdebitazione al fallito; ora con la Riforma Cartabia 2022 questo non è più ostativo (la Cass. 18517/2025 ha chiarito che prima non era possibile, ma ora sì) . Ciò rende un po’ meno drammatica la scelta di patteggiare per chi vuole poi ottenere l’esdebitazione.
Insolvenza e reati verso i lavoratori: Oltre a contributi e ritenute, ricordiamo che il mero mancato pagamento dello stipendio non è reato, però: – L’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) punisce chi approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori, ma è più per casi di caporalato. – Ci sono sanzioni amministrative se il ritardo sui pagamenti supera certi giorni, ma nulla di penale. – Quindi, penalmente, più rilevante è se l’impresa in crisi non versa le ritenute INPS o commette violazioni di sicurezza sul lavoro (queste rimangono perseguibili a prescindere dal fallimento).
Sintesi: L’imprenditore che affronta una crisi aziendale deve avere ben presente che: – Se riuscirà a evitare il fallimento (tramite concordato, accordi, ecc.), molto probabilmente eviterà anche guai penali collegati alla crisi (non automaticamente: se ha commesso frodi fiscali risponderà comunque di quelle, ma eviterà l’innesco dei reati da fallimento). – Se il fallimento è inevitabile, conviene non aggravare la situazione con comportamenti illeciti: niente “sparizioni” di beni, nessun favoritismo occulto, collaborare con il curatore consegnando subito i documenti e fornendo spiegazioni chiare. Questo atteggiamento può fare la differenza tra un’indagine penale che porta a condanna e una archiviazione. Ad esempio, se i libri contabili sono in ordine e mostrano che l’amministratore ha cercato credito fino all’ultimo per salvare l’azienda ma senza rubare nulla, potrebbe essere accusato al massimo di bancarotta semplice e magari con clemenza del giudice. – L’inerzia colpevole (non far nulla mentre i debiti crescono) può essere contestata come operazione dolosa: la Cassazione ha affermato che anche la scelta di “tirare a campare” può equivalere a un comportamento fraudolento se l’organo amministrativo aveva obbligo di fermarsi . Quindi meglio fare qualcosa di formalmente corretto (richiesta di concordato, ad esempio) piuttosto che lasciare che il fallimento avvenga da sé. – Atti leciti consentiti per evitare reati: L’imprenditore in crisi può comunque prendere decisioni per mitigare danni: ad esempio, vendere merci a prezzo di mercato per fare cassa non è reato (lo diventa se a prezzo vile per distrarre liquidità). Pagare un fornitore essenziale anticipatamente per continuare a ricevere materiale potrebbe configurare bancarotta preferenziale se poi fallisce, ma se fatto in un contesto di tentativo di risanamento e con ragionevolezza, talvolta i giudici assolvono per mancanza di dolo (valutando che non c’era volontà di favoritismo ma necessità aziendale). Ogni caso è a sé.
Conseguenze penali per i garanti/soci: Di solito i reati fallimentari colpiscono gli amministratori e chi ha poteri di gestione. I soci non amministratori sono raramente coinvolti, salvo siano stati amministratori di fatto (cioè comandavano di nascosto). I sindaci e revisori possono incorrere in concorso in bancarotta se, ad esempio, hanno omesso di vigilare su operazioni dolose – come nel caso citato di Cass. 1162/2024 dove i membri del collegio sindacale, non intervenendo a fronte di patrimonio netto negativo, sono stati ritenuti concorrenti in bancarotta semplice omissiva . Questo per dire che anche l’organo di controllo deve attivarsi in crisi (ad esempio segnalando ai sensi dell’art. 2406-2407 c.c., se non lo fa può risponderne).
5. Strategie pratiche e consigli finali per il debitore
Alla luce di tutto quanto esposto, mettiamoci nei panni del titolare o amministratore di una PMI (come la nostra azienda di pistole di soffiaggio) che si trova sommersa dai debiti. Quali passi concreti dovrebbe intraprendere per difendersi e cercare di risolvere la situazione, minimizzando i rischi?
5.1 Valutazione immediata della situazione debitoria
Fai una diagnosi onesta e dettagliata: Elenca tutti i debiti, distinguendo per tipologia (banche, fornitori, Fisco, leasing, ecc.), importi, scadenze. Identifica i creditori critici – quelli che possono innescare azioni pericolose subito (es. banca con mutuo scaduto e garanzie, Agenzia Entrate con cartelle scadute, un fornitore strategico che se smette forniture blocca la produzione). Verifica se ci sono già atti legali avviati (ingiunzioni, ipoteche, pignoramenti) o termini imminenti (scadenza di pagamento IVA, stipendi arretrati da erogare entro il mese, ecc.). Questa “radiografia” ti serve per stabilire priorità.
Analisi finanziaria prospettica: Fai un piano di cassa per i prossimi 3-6 mesi: quali incassi attendi realisticamente e quali esborsi minimi devi fare per operare. Spesso ciò rivela il gap da colmare. Se il gap è moderato e temporaneo, forse bastano soluzioni leggere (rinegoziazioni brevi). Se è enorme, serve un intervento strutturale (procedura concorsuale, aumento di capitale o cessione azienda).
Valuta la continuità aziendale: Chiediti: l’azienda, al netto dei debiti pregressi, è profittevole? Ha un modello di business ancora valido? Se sì, la priorità è liberarla dal macigno del debito (es. tramite un concordato in continuità o un accordo); se no (prodotto obsoleto, mercato perso), forse è meglio puntare a chiudere in modo ordinato (concordato liquidatorio) o vendere l’attività se ha valore per altri. Fare un check strategico onesto eviterà accanimenti terapeutici costosi.
Consultare un professionista esperto: Non aspettare l’ultimo giorno per chiamare un consulente. Un commercialista o avvocato specializzato in crisi d’impresa può aiutare ad analizzare i numeri e soprattutto a delineare le opzioni legali. Possono emergere opzioni che il solo imprenditore non conosce (es. scoprire che si può rottamare un 50% del debito fiscale, ecc.). Inoltre, loro hanno spesso contatti con gli attori (banche, organi procedurali) e sanno come presentare le istanze.
5.2 Azioni immediate di mitigazione del rischio
Riduci le spese superflue e metti in sicurezza l’essenziale: Taglia immediatamente costi non prioritari (marketing non indispensabile, consulenze non critiche, benefit, ecc.) per liberare risorse. Dall’altro lato, assicurati di pagare le forniture chiave correnti: devi mantenere la capacità di generare ricavi. In crisi di liquidità, è lecito dover scegliere chi pagare: paga chi ti consente di tenere aperto (energia elettrica, fornitore di materia prima, ecc.), rinvia dove puoi senza danno immediato (es. se hai un mutuo col 5% di interessi di mora e la banca ancora non si muove, potresti temporaneamente sospendere la rata per pagare invece gli stipendi). Ma fai queste scelte col parere del consulente legale, tenendo presente i rischi di qualificazione come preferenze indebite.
Negozia respiro dai creditori maggiori: Non aspettare che siano loro a chiamarti: contattali tu. Spiega in modo trasparente la situazione (senza panico: far capire che stai predisponendo un piano e che tutti avranno più se collaborano). Chiedi esplicitamente: – Alle banche: moratoria di qualche mese sulle quote capitale, mantenimento delle linee fido per non soffocare la liquidità; possibilità di consolidare lo scoperto (ad es. trasformare i fidi utilizzati in un mutuo a medio termine). – Ai fornitori: consegne regolari dietro pagamento parziale delle vecchie fatture e dilazione sul resto; magari offri di pagare in anticipo le nuove forniture se loro tollerano di incassare il pregresso in 6 mesi. Devi evitare che interrompano i rifornimenti (ciò ti spegnerebbe l’attività). – Al fisco: se hai cartelle esattoriali notificate, presenta subito domanda di rateazione prima che decadano i termini e scatti un pignoramento. Il nuovo piano di dilazione blocca le ganasce fiscali.
Attenzione alla comunicazione: Tieni informati anche i tuoi soci (se ne hai) e gli eventuali organi di controllo (sindaci, revisori). Devi evitare rotture interne: se i soci vengono a saperlo tardi, possono sfiduciarti o, peggio, accusarti di averli tenuti all’oscuro (problemi di governance). Se hai dipendenti, valuta cosa comunicare: non conviene dire “siamo in crisi nera” se pensi di risolvere, ma neanche ignorare del tutto – un discorso franco del tipo “ci sono difficoltà ma stiamo approntando un piano di rilancio, contiamo su di voi” può mantenere la motivazione e evitare fughe.
Proteggi la cassa e i beni liquidi: Se temi azioni esecutive, adotta qualche precauzione lecita: ad esempio, riduci al minimo i fondi sul conto corrente (usa eventuale fido per pagare fornitori così c’è poco da pignorare in conto); se hai più conti, concentra la liquidità su quelli non noti ai creditori (ma ricordati che in caso di procedure dovrai svelare tutto, quindi niente occultamenti illeciti). Non vendere né spostare beni aziendali in modo disordinato: qualunque atto su beni importanti dovrebbe rientrare in un disegno di risanamento, non fatto per panico. Se devi vendere mezzi o scorte per far cassa, fallo a valori di mercato e documenta bene (fatture, pagamenti tracciati), così nessuno potrà dire che li hai regalati.
5.3 Scelta dello strumento di risanamento adeguato
Con l’aiuto del professionista, decidi quale strada principale intraprendere: – Solo accordi stragiudiziali bilaterali: se il debito è contenuto e i creditori pochi e disponibili, magari ti basta fare accordi privati (il caso migliore). Formalizzali con scrittura privata, e rispettali. Rimani però pronto ad elevare il livello se qualcosa va storto. – Composizione negoziata: se la situazione è complicata ma non disperata, e hai tempo (ancora liquidità per qualche mese), avviare la composizione negoziata è un’ottima mossa. Porta all’interno un esperto super partes che ti aiuta e dà fiducia ai creditori sulla tua buona fede. Inoltre congela le azioni grazie alle misure protettive. Ricorda che entro 3 mesi dall’istanza di composizione, i creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS) sospendono le segnalazioni e le azioni esecutive (lo prevede la legge, per favorire la trattativa). Per avviare la C.N. devi predisporre qualche documento (un piano d’impresa a 6 mesi e le cause della crisi) – il consulente ti assisterà. Non costa molto se paragonato a un concordato (l’esperto è pagato a fine procedura con un compenso calmierato). – Piano attestato di risanamento: valutalo se vedi che puoi sistemare con un mix di risorse interne e accordi con pochi creditori, e tieni soprattutto all’assenza di pubblicità (vuoi che mercato e clienti non sappiano nulla). Cerca però un attestatore di qualità, perché un piano attestato mal fatto è peggio di niente (gli altri se ne accorgono se è aria fritta). Non confondere il piano attestato con “un business plan qualsiasi”: serve la firma di un esperto indipendente con precisi requisiti di legge. – Accordo di ristrutturazione omologato: utile se il nodo sono le banche o grandi creditori che da soli fanno il 60-70%. Qui la qualità del term sheet con loro è cruciale: magari conviene ingaggiare un advisor finanziario che tratti con le banche le condizioni (tasso, garanzie, equity kicker se convertono crediti in quote, ecc.). Ricorda di coinvolgere l’Erario nella trattativa se ha una fetta importante: proponi anche a loro una transazione fiscale parallela (presentando magari istanza all’Agenzia Entrate ai sensi dell’art. 63 CCII). Se l’Agenzia allunga i tempi di risposta, puoi comunque depositare l’accordo con la richiesta di cram-down. – Concordato preventivo: se la situazione è ingestibile privatamente (troppi creditori, rischio di iniziative disordinate, debito enorme da dover tagliare) allora proteggiti con il concordato. Prepara con cura la proposta per renderla appetibile: ad esempio, includi eventuali incentivi per i creditori che votano sì (la legge ti consente di offrire ai chirografari di una classe un quid in più se approvano – ciò può essere considerato ammissibile se giustificato). Esempio: “Ai creditori chirografari che rinunceranno a opposizioni all’omologa sarà riconosciuto un ulteriore 5% qualora le risorse liquidatorie lo consentano”. Non promettere cose irrealistiche – la credibilità paga più della percentuale alta. Meglio dire 30% e poi dare 35%, che promettere 50% e poi in esecuzione non superare 20%. La fiducia incide sul voto. – Concordato semplificato: se hai provato la composizione negoziata e proprio alcuni creditori non ci stanno per ripicca, considera l’opzione del semplificato (liquidatorio senza voto). È però delicata: dovrai convincere il tribunale che la tua proposta è comunque migliorativa per tutti rispetto al fallimento. Il tribunale in tal caso ascolterà i creditori anche se non votano, e se vede ingiustizie (es. privilegiati trattati male senza ragione) potrebbe non omologare. – Liquidazione volontaria: in alcuni casi, specie con debiti modesti e magari tutti verso soci o parti correlate, la società può anche liquidarsi da sola (ex art. 2484 c.c. scioglimento e liquidazione volontaria). Questo però non ferma i creditori estranei dal pignorare. Inoltre se durante la liquidazione volontaria emerge insolvenza, i liquidatori dovrebbero segnalare al tribunale. Dunque la liquidazione volontaria è fattibile se la società ha attivo sufficiente per coprire gran parte del passivo e c’è collaborazione dei creditori: in tal caso può evitarsi il fallimento chiudendo tutto in bonis. Ma se i debiti superano di molto l’attivo, è un rischio: i liquidatori potrebbero essere chiamati a rispondere se non portano i libri in tribunale tempestivamente.
Non dimenticare gli aspetti personali: Se sei un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, prendi in considerazione anche gli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, ecc.). Ad esempio, potresti risolvere i debiti aziendali col concordato minore (una sorta di mini concordato per non fallibili) se la tua impresa è artigiana sotto soglia. Se hai mescolato debiti personali e aziendali, una procedura unica di sovraindebitamento potrebbe affrontarli insieme.
5.4 Evitare errori comuni (cosa non fare in crisi)
Per difendersi efficacemente, bisogna anche evitare passi falsi che spesso i debitori compiono per disperazione e che poi aggravano le conseguenze: – Non fare il “pesce in barile”: ignorare i creditori, non rispondere alle comunicazioni, sperare che “si dimentichino”. Questo spesso li esaspera e li induce ad agire con più veemenza. Meglio mantenere il dialogo, anche se scomodo: un creditore informato è più incline a pazientare di uno lasciato al buio. – Non falsificare documenti: ad es. non alterare bilanci retroattivamente per nascondere perdite o distrarre beni. Oltre a essere reato, i professionisti e i giudici quasi sempre lo scopriranno (tramite banche dati, incroci, testimonianze). L’onestà e trasparenza, per quanto dolorose, pongono basi migliori per accordi e per la tua credibilità in tribunale. – Non preferire arbitrariamente creditori “simpatici”: pagare il fornitore amico o il parente creditore e lasciare a bocca asciutta altri può dare soddisfazione immediata, ma se poi fallisci, quel parente dovrà restituire i soldi (revocatoria) e tu avrai pure un’incriminazione. Se proprio devi fare un pagamento extra-ordinario, assicurati di avere una giustificazione oggettiva (es: hai pagato un fornitore perché forniva merce essenziale cod. bene, non perché è tuo cugino). – Non sottrarre o nascondere asset: la tentazione di mettere al riparo beni personali è forte. Ad esempio qualcuno pensa: “trasferisco la casa a mia moglie con un finto divorzio per non farla prendere ai creditori”. Queste manovre raramente reggono: i creditori possono revocarle (azione revocatoria ordinaria, possibile ad es. per atti a titolo gratuito entro 2 anni) o in caso di fallimento addirittura invalidarle senza limite temporale se fraudolente. Inoltre, scoprire questi trucchi incattivisce i creditori e i giudici. Piuttosto, se vuoi salvare la casa e i creditori sono d’accordo, inserisci l’idea in un piano: ad esempio offri di ipotecare la casa a garanzia di un nuovo finanziamento per pagare i creditori – così li rassicuri. Ma non fare cose unilaterali sperando di farla franca. – Non accumulare nuovi debiti fiscali o previdenziali: se sei già in crisi, cerca di non saltare ulteriori versamenti IVA o contributi correnti, perché come visto quelli generano guai penali freschi. Se hai dipendenti, assolutamente versa almeno la loro parte di contributi o comunque stai sotto il tetto di 10k annuo se proprio non riesci. Idem per l’IVA: valuta di fare almeno versamenti parziali per ridurre il dovuto sotto soglia penale. Insomma, gestisci la crisi anche ottimizzando la posizione penal-tributaria. Questo potrebbe voler dire, in caso estremo, rinunciare a qualche fornitura e quindi rallentare la produzione, pur di pagare l’IVA – ma è un calcolo da fare insieme al consulente legale in base ai rischi. – Non dilapidare i beni su cui i creditori hanno pegno/ipoteca: se la banca ha ipoteca sul magazzino, non venderlo in blocco e spendere i soldi altrove, pensando di togliere garanzia: sarebbe bancarotta. Oppure se c’è un macchinario pignorat o col riservato dominio, non smontarlo per pezzi e venderli separatamente: anche questo può configurare reato (distruzione di garanzie). Mantieni l’integrità di quei beni o la destinazione vincolata. – Non trascurare gli obblighi formali: continua a redigere il bilancio, a depositare dichiarazioni fiscali, anche se sono negative. Non presentare più il bilancio accentua le responsabilità (bancarotta documentale). Presentare la dichiarazione fiscale anche a debito evita l’omessa dichiarazione (reato >50k imposte evase) – meglio dichiarare il debito anche se non paghi subito, e poi eventualmente definire o rateizzare.
5.5 Ricorso al diritto penale come difesa dai creditori aggressivi
Un aspetto interessante è che a volte il debitore, se subisce azioni anomale da parte di creditori, può usare a sua volta strumenti legali: – Se un creditore procede in modo abusivo o intimidatorio, ad esempio minacciando illegalmente ritorsioni o usando violenza, ovviamente ci sono i mezzi di denuncia. – Se i garanti (es. confidi o banche) si muovono in modo scorretto (ad esempio un confidi escute la garanzia pubblica e la banca contemporaneamente vuole l’intero dal debitore, creando duplicazioni), si possono segnalare alle autorità di vigilanza. – Un caso tipico: le società di recupero crediti a volte mettono pressioni illegittime (telefonate sul lavoro, contatti a familiari non debitori): l’imprenditore può sporgere reclamo all’OAM o all’AGCM per pratiche aggressive, ottenendo magari una sospensione di tali pratiche.
Ma questo è marginale: in genere il debitore deve più che altro resistere passivamente entro la legalità (usando sospensioni giudiziali se lecite, come visto in 2.2).
5.6 Pensare al “giorno dopo”: ripartire dopo la crisi
Dal punto di vista dell’imprenditore, difendersi dai debiti non è solo limitare i danni, ma anche preparare la via per ricominciare l’attività su basi sane una volta risolta la situazione attuale: – Se sei riuscito a far un concordato in continuità, la tua azienda deve ricostruire la fiducia del mercato: onora scrupolosamente gli impegni post-concordato, magari prendi certificazioni di qualità o assicurazioni crediti per rassicurare fornitori. Insomma, usa la seconda chance con disciplina. – Se hai chiuso col fallimento ma ottenuto esdebitazione, puoi aprire una nuova società. Nulla vieta a un ex fallito esdebitato di tornare in pista (non potrà amministrare per un certo periodo se condannato per bancarotta fraudolenta, ma in caso di condotta regolare non avrà interdizioni di lungo termine). Quindi, pianifica come sfruttare l’esperienza passata per non ripetere errori: ad esempio, se la tua attività aveva troppi costi fissi, la prossima volta valuta un modello più snello, se era troppo indebitata, parti più cautamente con capitale più solido. – Tieni conto che i dati dei fallimenti e concordati restano pubblici (registro imprese, casellario fallimentare), quindi per qualche anno banche e partner lo sapranno. Dovrai ricostruire credibilità, forse associandoti con qualcuno che metta capitale o garanzie finché tu hai quell’aura. È un processo che richiede trasparenza: non nascondere il tuo passato, ma enfatizza cosa hai imparato e come hai risolto onestamente (chi ha risanato via concordato, paradossalmente, può anche dire “guardate, non sono scappato, ho pagato il possibile” – e ciò può essere apprezzato). – Per le società, se la vecchia società è stata liquidata, un modo per ripartire è costituire una newco e magari farsi affidare dalla procedura l’affitto dei rami sani. Questa operazione se fatta con trasparenza (autorizzata dal giudice) ti consente di salvare parte del business in una nuova entità libera da debiti, pagando un canone alla vecchia in fallimento (che lo distribuirà ai creditori). Molti concordati in continuità indiretta funzionano così. Quindi se vedi che la struttura dei debiti è ingestibile ma l’attività operativa sì, non scartare l’idea di liquidare la società A e proseguire con B comprandone gli asset. Legalmente fattibile, basta farlo con perizia e autorizzazioni.
5.7 Tabelle riepilogative e simulazione finale
Per concludere questa sezione pratica, proponiamo due tabelle riassuntive: una sugli strumenti di risanamento e i loro principali parametri, e una sulle cause di responsabilità e come prevenirle.
Tabella: Confronto sintetico degli strumenti di regolazione della crisi
| Strumento | Natura | Coinvolgimento tribunale | Adesione creditori necessaria | Effetti chiave | Quando indicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordo stragiudiziale privato (piano di rientro informale) | Contratto libero tra debitore e singoli creditori | Nessuno (privato) | Totale volontarietà (anche 1 a 1) | Flessibile, discreto; nessuna protezione legale generale (solo patti tra le parti). | Crisi leggera, pochi creditori tutti collaborativi. |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Piano unilaterale del debitore con accordi bilaterali, asseverato da esperto | Tribunale non coinvolto (solo eventuale deposito registro imprese) | Consenso di chi partecipa (nessuna % fissa; dissenzienti restano fuori) | Esenzione da revocatorie e alcune responsabilità penali ; niente stay sugli esecutivi automatico; niente voto. | Crisi gestibile con principali creditori consenzienti; necessità di riservatezza e rapidità. |
| Accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57-64 CCII) | Accordo contrattuale con maggioranza qualificata + omologa tribunale | Sì, in fase di omologa (e per misure protettive) | >= 60% crediti (salvo accordi minori agevolati al 30%) ; vincola consenzienti, estensibile a dissenzienti in categoria omogenea (cram-down) | Stay su istanza (come concordato); accordo omologato = titolo esecutivo; creditori estranei pagati al 100%; revocatorie escluse sugli atti esecutivi. | Debito concentrato (pochi creditori grandi); banca disponibile a accordo; necessario coinvolgere Fisco con transazione; tempo per negoziare presente. |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) – continuità o liquidatorio | Procedura concorsuale giudiziale | Sì, ammissione, omologa, controllo giudice delegato e commissario | Maggioranza >50% crediti votanti per omologa; vincola tutti i creditori anteriori all’omologa (cram-down sui dissenzienti classi se best interest test soddisfatto) | Stay automatico dalla ammissione ; possibile falcidia debiti chirografari e ristrutturazione privilegiati; azienda continua (in continuità) o cede beni (liquidatorio) sotto vigilanza; atti autorizzati da GD; esdebitazione imprenditore a fine. | Insolvenza conclamata o rischio elevato; necessario coinvolgere tutti i creditori e imporre sacrifici anche a dissenzienti; presenza di attività da salvare (continuità) o necessità di cessione ordinata di beni (liquidatorio). |
| Composizione negoziata (D.L.118/21 conv. L.147/21, artt. 12-25 CCII) | Procedura volontaria di negoziazione assistita | Sì, ma in modo leggero (nomina esperto tramite commissione; tribunale solo per misure protettive e omologhe eventuali) | Volontaria (non c’è voto né obbligo di accordo); soluzioni concordate caso per caso | Stay breve su richiesta (4 mesi); riservatezza; consulenza esperto terzo; eventuale esito in accordi, piani o concordati semplificati. | Crisi iniziale o media; imprenditore proattivo che vuole evitare procedure formali; interlocutori possibilisti ma serve facilitatore. |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria giudiziale | Sì, totale (nomina curatore, giudice delegato; spossessamento) | Nessun consenso richiesto (procedura d’ufficio su istanza creditori o su propria richiesta) | Stay totale delle azioni; azienda spossessata e liquidata; crediti soddisfatti secondo prelazioni; possibili azioni di responsabilità e revocatorie; al termine, società estinta e persone fisiche esdebitate (se oneste). | Quando insolvenza irreversibile e nessun piano fattibile; se creditori non cooperano; se tardivo ogni intervento. |
Tabella: Riepilogo responsabilità e cautele per l’imprenditore
| Ambito | Possibile responsabilità | Riferimenti | Come prevenirla/mitigarla |
|---|---|---|---|
| Civile verso società (azione sociale) | Mala gestio, violazione obblighi (es. non attivazione art.2482-bis, gestione imprudente) | Artt. 2392-2393 c.c. (società di capitali) | Diligenza gestoria ex ante (business judgment rule: decisioni informate e ragionevoli); monitoraggio costante conti; documentare delibere e ragioni delle scelte . |
| Civile verso creditori (azione da insolvenza) | Aver aggravato insufficienza patrimoniale con inerzia o atti pregiudizievoli (responsabilità ex art. 2394 c.c.) | Art. 2394 c.c.; Art. 2486 c.c. (criteri quantificazione danno) | Attivarsi tempestivamente in caso di crisi (composizione negoziata, riduzione costi, stop a debiti futuri); non contrarre credito abusivo; se perdita >1/3 capitale, seguire procedure legali (assemblea, ecc.); evitare di pagare solo alcuni creando fortune diverse. |
| Penale – Bancarotta fraudolenta | Distrazione/occultamento beni; operazioni dolose che causano o aggravano dissesto; scritture falsificate o distrutte; pagamenti preferenziali con dolo | Artt. 322-323 CCII (ex artt. 216-217 L.F.); es. Cass. 9958/2023 (aggravamento dissesto = evento rilevante) | Non sottrarre asset; tenere contabilità ordinata e veritiera (no doppie scritture, no omissioni); in crisi avanzata, non aggravare volontariamente (se sforzi di salvataggio falliscono, optare per concordato o liquidazione invece di accumulare altri debiti); se si fanno pagamenti prima del fallimento, farli solo se giustificati da necessità aziendale reale (riduce evidenza di dolo preferenziale). |
| Penale – Bancarotta semplice | Negligenza grave: spese personali eccessive, disordine contabile, ritardo nell’istanza di procedura, ecc. | Art. 324 CCII (ex 217 L.F.) | Comportamento diligente anche sotto stress: ridurre costi non essenziali, aggiornare i libri e bilanci anche in perdita, richiedere concordato/fallimento senza eccessivo ritardo una volta constatata l’insolvenza conclamata (per evitare imputazione di ritardo doloso) . |
| Penale – Omesso versamento imposte e contributi | Mancato versamento IVA > €250k (entro termine annuale) ; omesse ritenute fiscali > €150k; omesse ritenute previdenziali > €10k . | D.Lgs. 74/2000 artt. 10-bis, 10-ter; L. 638/1983 art. 2 (conv. L. 389/89); Cass. SU 37424/2013 su soglia contributi | Monitorare gli importi non versati periodicamente: se IVA verso soglia, cercare di ridurre con pagamenti parziali o chiedere rateazione entro fine anno ; per ritenute dipendenti, non superare 10k annuo o, se succede, versare anche tardivamente prima della denuncia (estinzione reato se prima di dibattimento) ; informare tempestivamente Agenzia Entrate/INPS e valutare istituti deflativi (ravvedimento operoso, richieste dilazione) per mostrare buona fede. |
| Verso dipendenti e terzi | Omessi versamenti stipendi (sanzione amm.va), sicurezza lavoro (penale in caso di infortuni) | L. 689/1981 (sanz. amm.ve); D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) | Non sacrificare sicurezza e adempimenti obbligatori alla crisi: continuare a fornire DPI, manutenzioni, ecc. Anche in crisi, il datore deve rispettare normative di sicurezza: un infortunio in azienda in crisi potrebbe esporre a gravi responsabilità penali se legato a tagli di spesa sulla sicurezza. Sul pagamento stipendi: se impossibilitato, almeno formalizzare il debito (buste paga emesse) cosicché i dipendenti possano accedere al Fondo di Garanzia INPS in caso di procedura. |
5.8 Simulazione pratica finale
Caso ipotetico: Mario è amministratore unico della Soffiotec Srl, azienda toscana produttrice di pistole di soffiaggio industriale. Negli ultimi anni, complici la pandemia e l’aumento dei costi delle materie prime, Soffiotec ha accumulato debiti: €200.000 con la banca (mutuo per macchinari, garantito da ipoteca sul capannone di proprietà della società e da fideiussione personale di Mario), €150.000 verso 20 fornitori diversi (di cui uno, fornitore di compressori, da solo vanta €50.000 ed è in pressing per avere pagamenti), €80.000 di debiti tributari (IVA non versata e IRAP di due anni), €50.000 di contributi INPS arretrati (ultimi 6 mesi per 10 dipendenti), €60.000 di leasing residuo per un impianto (valore attuale impianto forse €40k). L’azienda ha inoltre liquidità minima in banca (€5.000) e magazzino prodotti finiti del valore di €100.000 (ma venderli rapidamente comporterebbe sconti forti). Ha ordini in essere che, se evasi, genererebbero margini per €30.000 nei prossimi 4 mesi. Mario, finora, ha fatto fronte pagando i fornitori a rotazione e ritardando il fisco, ma ora uno dei fornitori ha ottenuto decreto ingiuntivo e minaccia pignoramento, e la banca ha segnalato che se saltano altre 2 rate di mutuo passerà a sofferenza il credito.
Soluzione per Mario passo per passo:
- Analisi iniziale: Mario e il suo commercialista stimano che l’azienda, se alleggerita dal debito, sarebbe profittevole (ha mercato e ordini). Il problema è la zavorra degli arretrati e la mancanza di liquidità immediata.
- Azione immediata: Mario contatta il fornitore che ha ingiunto e negozia di sospendere il pignoramento in cambio di un pagamento parziale subito: con l’aiuto di un piccolo prestito familiare, gli versa €10.000 e concorda il saldo del restante 40.000 in 10 mesi. Questo accordo viene formalizzato e il fornitore accetta (revoca l’ingiunzione, almeno temporaneamente). Nel frattempo Mario presenta domanda di rateazione all’Agenzia Entrate-Riscossione per le cartelle IVA e IRAP di €80.000: gli viene concesso un piano a 72 rate (~€1.100/mese) e ciò blocca nuove azioni del Fisco. Per i contributi INPS, chiede un dilazionamento in 18 mesi.
- Scelta strumento: Vista la pluralità di creditori e l’esposizione ancora grave, Mario decide di attivare la composizione negoziata. Viene nominato un esperto. Mario, su consiglio di quest’ultimo, chiede al tribunale misure protettive: il giudice le concede, quindi per ora nessun creditore può iniziare esecuzioni (questa protezione copre eventuali altri fornitori che erano in procinto di agire).
- Negoziazione: L’esperto convoca la banca e prospetta loro che, se non collaborano, Soffiotec potrebbe finire in default e il capannone magari svalutato. Propone quindi: moratoria mutuo per 6 mesi e poi ripresa pagamenti; la banca acconsente purché Mario dia disponibilità a mettere ipoteca anche su un piccolo terreno che la società possiede libero (per maggior garanzia). Mario accetta. I fornitori principali vengono coinvolti: l’esperto ottiene che 15 fornitori su 20 (rappresentanti l’80% del debito commerciale) concordino uno stralcio del 20% (pagheranno loro 80 cent per euro dovuto) dilazionato in 1 anno. 5 piccoli fornitori rifiutano, ma il loro credito totale è €15.000.
- Soluzione formale: L’esperto suggerisce di trasformare questi accordi in un Accordo di ristrutturazione ex art.57: con le adesioni avute (80% fornitori, banca che partecipa per la rinegoziazione mutuo, leasing che accetta di riprendersi l’impianto riducendo il debito residuo a €20k), si supera il 60% dei crediti totali. Viene incluso anche il Fisco: l’accordo prevede che le rate di Agenzia Entrate e INPS proseguano regolari (quindi Fisco è soddisfatto integralmente ma nel tempo, l’Agenzia aderisce alla transazione accettando la dilazione come da legge). Si deposita l’accordo in tribunale per omologa, chiedendo l’estensione ai 5 fornitori dissenzienti (cram-down: essi riceveranno anche l’80% in 12 mesi come gli altri). Il tribunale verifica che essi in un fallimento avrebbero preso forse 30%, quindi l’accordo per loro è conveniente, e approva l’estensione .
- Esecuzione: Soffiotec, protetta e ristrutturata, riprende fiato. Col risparmio sui debiti (20% abbuonato ai fornitori, leasing ridotto di €40k restituendo il bene, contributi spalmati, ecc.), la sua struttura finanziaria è sostenibile. In 1 anno paga puntualmente le rate concordate. Il capannone non è stato toccato (la banca aspetterà fine piano). Nessun fallimento, nessun concordato pubblico: molte controparti nemmeno vengono a sapere dei dettagli, vedono solo che Soffiotec continua l’attività e onora i nuovi ordini.
- Responsabilità evitate: Mario, avendo agito tempestivamente e con trasparenza, non subirà azioni di responsabilità: i creditori sono stati soddisfatti concordemente, quindi non possono lamentare danni. Penalmente, non c’è fallimento, e i reati tributari non scatteranno perché ha regolarizzato IVA e contributi entro i termini di legge (infatti aderendo alla rateazione e pagando le prime rate entro il 31/12, il reato omesso IVA non si perfeziona ; per contributi, è sotto soglia penale ormai grazie ai pagamenti). I dipendenti sono stati pagati con un leggero ritardo ma entro i limiti, nessuno ha perso il lavoro. L’azienda ha tenuto i libri in ordine e l’esperto li ha visionati senza appunti – segno di corretta amministrazione.
Esito: Soffiotec Srl è salva. Mario conserva la sua azienda e il suo patrimonio personale (ha rischiato la casa per la fideiussione, ma grazie all’accordo la banca non l’ha escussa). Ha anche imparato la lezione: d’ora in poi monitorerà meglio i flussi di cassa e, su consiglio dell’esperto, ha introdotto un controllo gestionale trimestrale e un sistema di allerta interno (verifica indicatori CRISI elaborati dal CNDCEC) per accorgersi per tempo di future criticità. In caso di un nuovo shock economico, saprà muoversi per tempo.
6. Domande frequenti (FAQ)
D: La mia società ha troppi debiti e temo il fallimento. Posso perdere anche i miei beni personali (casa, risparmi) a causa dei debiti aziendali?
R: Dipende dal tipo di società e da eventuali garanzie. Se la tua azienda è una SRL o SPA, per legge i soci non rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio (responsabilità limitata). Quindi i creditori potranno attaccare solo i beni della società. Fanno eccezione i casi in cui tu abbia firmato fideiussioni personali (molto comuni con le banche: in tal caso la banca può escutere direttamente te in base a quel contratto) o se hai commesso illeciti gravi (ad esempio distrazione di beni sociali) per cui un tribunale potrebbe estendere responsabilità patrimoniali o risarcitorie a tuo carico. Se invece l’azienda è una società di persone (SNC, SAS) o una ditta individuale, allora sì: tu come imprenditore rispondi illimitatamente e i creditori possono aggredire i tuoi beni (casa, conto corrente, ecc.), salvo quelli impignorabili per legge (ad esempio, se la casa è l’unica di residenza e il debito è col Fisco, ci sono limiti; ma in generale è aggredibile). Nota che anche in SRL, se sei amministratore, potresti perdere i tuoi beni se condannato in un’azione di responsabilità o per reati (es. risarcimento danni ai creditori) – ma questo dipende da comportamenti colposi o dolosi, non dalla normale insolvenza. Quindi, in sintesi: con la responsabilità limitata di una SRL i tuoi beni sono protetti dai creditori aziendali, a meno che tu non li abbia volontariamente garantiti; con una società personale o impresa individuale no, i tuoi beni sono in pericolo in caso di insolvenza.
D: Quanto deve essere grande il debito perché un creditore possa chiedere il fallimento della mia azienda?
R: La legge prevede una soglia minima di debito di €30.000 per poter dichiarare la liquidazione giudiziale (fallimento) di un’impresa . Quindi, se l’ammontare totale dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €30.000, la tua azienda non può essere sottoposta a fallimento (eventuali istanze verrebbero dichiarate inammissibili). Sopra tale soglia, in teoria anche un singolo credito (ad esempio €35.000) insoluto può legittimare un’istanza. Va detto però che i €30.000 sono riferiti al complesso dell’esposizione debitoria scaduta: se hai più creditori e in totale devi oltre €30k, anche se ciascuno individualmente meno, si può configurare lo stato di insolvenza. Inoltre, devi essere un imprenditore “fallibile” (la maggior parte delle imprese lo sono, tranne piccolissime sotto certi parametri dimensionali). Dunque, la regola pratica è: se il debito supera 30mila e non riesci a pagarli, c’è il rischio concreto che qualcuno attivi la procedura. Sotto quella soglia, il tribunale non apre la procedura concorsuale maggiore; il creditore insoddisfatto dovrà usare solo esecuzioni individuali.
D: I debiti fiscali (IVA, tasse) possono essere tagliati o cancellati con un concordato o accordo?
R: Sì, oggi è possibile includere anche il Fisco e gli enti previdenziali nelle proposte di ristrutturazione, ma con alcune condizioni. Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo) puoi proporre di pagare parzialmente o dilazionare i debiti tributari e contributivi: l’Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato sui tributi) e l’INPS valuteranno la proposta, detta transazione fiscale. Non è più obbligatorio pagare al 100% IVA e ritenute nel concordato (come invece era un tempo): se la maggioranza dei creditori approva il concordato ma il Fisco vota contro, il tribunale può ugualmente omologare se la somma offerta al Fisco è almeno pari a quanto ricaverebbe liquidando il debitore . Esempio: debito IVA €100k, proponi di pagarne €30k perché l’azienda in liquidazione non darebbe di più – se l’Erario rifiuta ma i calcoli dimostrano che in caso di fallimento prenderebbe zero, il giudice può forzare l’omologa (cram-down fiscale). Negli accordi di ristrutturazione omologati, similmente, c’è la possibilità di omologa anche senza adesione fiscale, a certe condizioni. Fuori dalle procedure, invece, il Fisco può aderire solo nei modi previsti dalle norme speciali: rateizzazioni standard (che però non comportano rinuncia ad imposta, solo dilazione) o definizioni agevolate (rottamazioni, condoni) se emanate per legge. Non puoi fare da solo un accordo privato col Fisco per uno sconto, serve sempre un quadro normativo. Quindi la via per ridurre i debiti fiscali passa in genere per un accordo omologato dal tribunale o per disposizioni legislative di condono. Attenzione che l’IVA e le ritenute sono considerati tributi “protetti”: in un concordato in continuità devi almeno dilazionarli integralmente (non puoi falcidiare l’IVA se tieni aperta l’azienda, devi pagarla tutta anche se in più anni), mentre in un concordato liquidatorio puoi anche proporre di pagarne solo una parte (purché, come detto, giustificata dal realizzo). In pratica, ogni caso va studiato con un consulente: oggi c’è più flessibilità di prima, ma restano vincoli e necessità di convincere l’Erario che sta ottenendo il meglio possibile.
D: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo da un fornitore che non posso pagare subito. Cosa devo fare per difendermi?
R: Hai due strade: opporti legalmente o raggiungere un accordo col fornitore. L’opposizione è possibile entro 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione: devi presentare ricorso in tribunale motivando perché quella somma non è dovuta (o non tutta, o non subito). Se hai contestazioni fondate (merce difettosa, importo errato, prescrizione, ecc.), l’opposizione congela l’efficacia esecutiva e apre una causa ordinaria. Se però il debito è sostanzialmente dovuto e non hai vere ragioni di contestazione, opporsi servirà solo a guadagnare tempo (forse il giudice può concedere sospensione provvisoria) ma alla fine perderesti, caricandoti di ulteriori spese legali. In tal caso, meglio cercare un accordo: contatta subito il fornitore (o il suo legale) e proponi un piano di rientro, magari con pagamenti parziali dilazionati. Se il fornitore vede la tua buona fede e preferisce evitare lungaggini, potrebbe accettare e sospendere le azioni esecutive. Formalizzate l’accordo per iscritto (ad esempio: riconosci il debito e convenite che pagherai X al mese, e lui si impegna a non procedere salvo tuo inadempimento). Se raggiungete un accordo del genere, puoi chiedere al giudice di rendere quell’accordo esecutivo (in pratica sostituire il decreto ingiuntivo con una conciliazione in sede giudiziaria, o farlo ratificare) per maggiore tutela. In parallelo, valuta misure protettive: se stai per avviare un concordato o composizione negoziata, l’inizio di queste procedure blocca i decreti ingiuntivi in corso dal divenire esecutivi. Ad esempio, presentando domanda di concordato con riserva entro i 40 gg, puoi ottenere la moratoria delle azioni. Come ultima spiaggia, se hai perso il termine di opposizione e il decreto diventa esecutivo, potresti chiedere al giudice una dilazione dell’esecuzione (sospensione ex art. 481 c.p.c. se riesci a motivare grave difficoltà e qualche prospettiva di pagamento) – raramente concessa. In definitiva: comunica, negozia e utilizza il quadro concorsuale se necessario. Non ignorare il decreto ingiuntivo, altrimenti trascorsi i 40 giorni il creditore potrà procedere a pignorare beni o conti senza ulteriore avviso.
D: Mi conviene tentare un accordo stragiudiziale (senza tribunale) o andare direttamente in concordato preventivo?
R: Dipende dalle circostanze. Un accordo stragiudiziale (o un piano attestato) ha i vantaggi della rapidità, riservatezza e minor costo. Se pensi di poter ottenere il consenso di tutti (o quasi) i creditori chiave e riesci a sostenere nel frattempo la pressione (perché magari nessuno è ancora partito con esecuzioni pesanti), vale sicuramente la pena provarci: il concordato potrai sempre farlo in un secondo momento se l’accordo fallisce. Considera però: un accordo fuori dalle procedure non blocca automaticamente i dissenzienti. Quindi se temi che uno o più creditori non parteciperanno e possano aggredirti nel frattempo, forse è meglio mettere lo scudo del concordato prima, e gestire tutti dentro la procedura. Il concordato preventivo offre protezione immediata (appena depositi la domanda e vieni ammesso) e vincola anche le minoranze, ma è pubblico, lungo e costoso. In situazioni di forte conflittualità o numerosità dei creditori, il concordato diventa quasi necessario: ad esempio, se hai decine di creditori disorganizzati e devi tagliare il debito del 50%, difficilmente li fai concordi spontaneamente, serve il meccanismo di voto. Un’altra discriminante: la fiducia e il tempo. Se hai ancora un po’ di ossigeno e i creditori si fidano di te, puoi negoziare con calma un accordo privato o un accordo di ristrutturazione (con omologa). Se invece i creditori sono già sul piede di guerra, potrebbero non credere alle promesse fuori dal tribunale e preferire un piano sotto l’egida del giudice (concordato). Ricorda che puoi combinare i passi: spesso si deposita un concordato dopo aver già ottenuto accordi informali di massima con i principali creditori, così il voto sarà favorevole. In generale, la regola è preferire soluzioni meno invasive se realistiche; passare al concorsuale solo se necessario per tutela e efficacia vincolante. Un buon consigliere potrà simulare gli scenari: ad esempio, se hai 5 banche e 20 fornitori, e sai che 4 banche su 5 sono d’accordo, potresti fare un accordo di ristrutturazione (ti basta il 60%). Se invece 2 banche sono contrarie, allora con il concordato potresti superare il loro dissenso col voto degli altri (le banche formerebbero una classe, e magari 3 su 5 rappresentano il 70% del credito bancario, sufficiente per trascinare la classe). Quindi vedi le posizioni e decidi. Da evitare: improvvisare un concordato senza prima avere idea di come voteranno i creditori – rischio bocciatura. Anche per questo, si tende a negoziare comunque pre-concordato, solo che nel concordato la negoziazione finale avviene formalmente con il meccanismo del voto.
D: La procedura di composizione negoziata mi protegge davvero dai creditori? Possono comunque pignorarmi qualcosa durante le trattative?
R: Se attivi la composizione negoziata della crisi, puoi richiedere al tribunale le cosiddette misure protettive. Una volta pubblicata l’istanza di misure protettive (sul registro delle imprese), nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio senza autorizzazione del tribunale (art. 20 CCII). Quindi, sì, sei protetto da nuovi pignoramenti durante il periodo in cui le misure sono attive . Attenzione però: la protezione iniziale dura al massimo 4 mesi (prorogabili di altri 4 in casi eccezionali). Inoltre, i creditori possono fare ricorso per chiedere la revoca delle misure se dimostrano che stai agendo in malafede o che le misure li danneggiano ingiustificatamente. Quindi devi usare quello scudo per lavorare a una soluzione, non per “dormire”. Se non richiedi le misure protettive, la composizione negoziata di per sé non blocca i creditori – è volontaria e riservata, ma i creditori estranei potrebbero continuare azioni. In pratica, quasi tutti quelli che attivano la composizione negoziata contestualmente chiedono al giudice la sospensione delle azioni esecutive. Una volta ottenuta, se un creditore provasse comunque a pignorare (magari perché non sa della procedura), potrai far valere il provvedimento del tribunale per bloccarlo (il giudice dell’esecuzione dichiarerà improcedibile il pignoramento). Tieni presente che devi elencare i creditori noti nell’istanza e notificare loro il decreto di protezione: così saranno informati formalmente. Unica eccezione: i creditori per crediti di lavoro (stipendi) e i nuovi crediti sorti durante la composizione hanno qualche tutela in più – se, ad esempio, non paghi stipendi correnti, il tribunale potrebbe negare di proteggerti da quelle azioni. Ma in generale, sì, con la composizione negoziata ben impostata ottieni un periodo di tregua per negoziare senza dover temere il postino con l’atto di pignoramento.
D: Se la mia azienda fallisce, per quanto tempo non potrò più aprirne un’altra o fare l’amministratore?
R: La dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) comporta per l’imprenditore alcune incapacità personali durante la procedura: ad esempio non puoi avere cariche societarie, non puoi ricoprire uffici pubblici, non puoi gestire patrimoni altrui, e se sei un imprenditore individuale non puoi iniziare una nuova attività commerciale finché il fallimento è aperto. Queste interdizioni però cessano con la chiusura della procedura (di solito in pochi anni). Non c’è un divieto a vita di fare impresa: anzi, l’ordinamento incoraggia il “fresh start” col meccanismo dell’esdebitazione. Tuttavia, se vieni condannato per alcuni reati fallimentari gravi (come bancarotta fraudolenta), il giudice penale può applicare pene accessorie tra cui l’interdizione dagli uffici direttivi di imprese per un certo periodo (anche diversi anni, spesso 10) . Quello è un effetto penale, non civile. Quindi, se hai gestito correttamente e non subisci condanne penali, una volta chiuso il fallimento (e ottenuta l’esdebitazione, se persona fisica), sei libero di tornare a fare l’amministratore o l’imprenditore. Certo, la reputazione sul mercato e con le banche potrebbe essere compromessa: ad esempio, potresti trovare difficoltà ad ottenere credito perché la storia del fallimento resta nelle banche dati per alcuni anni. Ma legalmente potresti costituire una nuova società anche il giorno dopo la chiusura del fallimento precedente (magari come socio, per fare l’amministratore devi attendere chiusura sennò c’è la preclusione durante). Nota che se il fallimento non è ancora chiuso e vuoi avviare nuova attività, potresti farlo come consumatore (aprire un’attività non soggetta a fallimento, tipo un’impresa agricola o professionale se non rientra nel codice della crisi), ma è una zona grigia. In generale, conviene attendere la chiusura e poi ripartire puliti. Riassumendo: nessun ergastolo civile per il fallito onesto – dopo la procedura potrai tornare in pista. Se invece ci sono state irregolarità gravi, le condanne potrebbero escluderti temporaneamente.
D: I debiti con INPS (contributi) e Inail si prescrivono o si cancellano col fallimento?
R: I contributi previdenziali (INPS) hanno una prescrizione di 5 anni di regola, ma la notifica di una cartella o di un avviso la interrompe. Se la tua azienda fallisce, i debiti INPS vanno insinuati al passivo come privilegiati; se il patrimonio non basta a pagarli integralmente, l’INPS rimarrà insoddisfatto in parte. Nelle società, con la chiusura del fallimento, i crediti non soddisfatti (inclusi quelli INPS/Erario) restano inesigibili perché la società si estingue. Nelle persone fisiche, i debiti residui verso INPS dopo il fallimento possono essere cancellati dall’esdebitazione (l’esdebitazione riguarda infatti anche i contributi non pagati, essendo debiti concorsuali). Quindi, sì, in caso di fallimento e successiva esdebitazione, il debitore persona fisica è liberato anche dai contributi non pagati (recenti modifiche normative hanno confermato che l’esdebitazione si estende a tutti i debiti concorsuali tranne poche eccezioni, e i contributi non sono esclusi, a differenza di alcune multe o alimenti). Attenzione: se però hai omesso il versamento delle ritenute previdenziali dei dipendenti, come visto, potresti avere un procedimento penale; il fallimento non cancella la responsabilità penale, ma pagando poi i contributi prima del dibattimento potresti evitare la condanna. In sintesi: gli enti previdenziali partecipano come creditori normali alle procedure; se recuperano poco, la parte mancante per loro è persa (salvo poterla rifare sui coobbligati, ad esempio i soci illimitati). Non c’è una “imprescrittibilità” particolare oltre al regime ordinario. Quindi se la tua domanda era: posso evitare di pagare INPS?, la risposta è che solo attraverso le procedure concorsuali o di esdebitazione puoi farlo in modo legale e definitivo. La prescrizione può maturare se INPS non agisce per 5 anni, ma di solito agisce. Nell’accordo o concordato puoi prevedere un pagamento parziale anche dei contributi (soggetti a transazione contributiva). Se invece non fai niente, INPS può pignorare e, se fallisci, prenderà quel che può dal fallimento e il resto rimarrà a tuo carico (se persona fisica) finché non chiedi esdebitazione.
D: Posso cedere la mia quota di società (o l’intera azienda) a terzi per liberarmi dei debiti?
R: Cedere la partecipazione societaria non libera la società dai debiti: semplicemente avrà un nuovo proprietario, ma i debiti resteranno in capo alla società stessa. Se invece intendi vendere l’azienda (il complesso aziendale) a qualcuno, i debiti non passano automaticamente all’acquirente salvo quelli verso dipendenti (TFR) e poche eccezioni, ma attenzione: una cessione d’azienda fatta quando sei insolvente può essere revocata o considerata un atto in frode ai creditori se il ricavato non viene destinato ai debiti. Inoltre, vendere l’azienda senza debiti a una newco lasciando i creditori nella “scatola vuota” è uno schema tipico di frode (cosiddetta distrazione di azienda), perseguibile penalmente come bancarotta fraudolenta. Percorso corretto: puoi vendere l’azienda a valori di mercato e usare il prezzo ottenuto per pagare i creditori (magari parzialmente). Se il prezzo copre tutti i debiti, ottimo: hai risolto. Se non li copre, dovresti comunque regolare la posizione residua (concordato liquidatorio, ad esempio, dove l’azienda viene ceduta e il ricavato distribuito ai creditori in percentuale). Quindi non è una via per “liberarsi dei debiti” se inteso come lasciarli dietro di sé: i creditori potranno agire sul ricavato della vendita. Caso diverso: cedere la tua quota societaria. Se vendi le tue quote/azioni della società indebitata a un terzo (che volontariamente se le accolla), in teoria tu come venditore incassi qualcosa e il compratore subentra nella proprietà della società che però mantiene i debiti. I creditori sociali potranno comunque agire contro la società. Tu personalmente potresti essere uscito dal gioco, però: (a) se sei amministratore, risponderai di eventuali atti precedenti; (b) se la società poi fallisce entro 1 anno dalla tua uscita, potresti essere ancora chiamato in responsabilità se, ad esempio, il nuovo amministratore sostiene che hai occultato problemi (meno probabile); (c) se sei socio illimitato e vendi la quota, la legge comunque ti mantiene responsabile dei debiti anteriori e per 5 anni potresti essere fallito assieme (per SNC, l’ex socio nei 2 anni precedenti risponde ancora ex art. 256 CCII). Insomma, vendere a un prestanome non è la panacea: rischi, se va a finire male, di rispondere lo stesso in qualche misura (soprattutto eticamente, e i creditori potrebbero provare a rivalersi su di te accusandoti di aver simulato la vendita per frode). In conclusione: è possibile vendere l’azienda come parte di un piano di risanamento o liquidazione, ma va fatto con correttezza e trasparenza, destinando il ricavato ai debiti. “Passare la patata bollente” a un altro sperando di scappare dalle responsabilità raramente funziona e anzi spesso peggiora le cose (ti precludi soluzioni concorsuali e accumuli possibili contestazioni di frode).
D: Quali sono i tempi e i costi di un concordato preventivo rispetto a fare un fallimento?
R: Un concordato preventivo tipicamente dura (dall’inizio alla fine dell’esecuzione) almeno 1-2 anni. I tempi si dividono in: qualche mese per ammissione, qualche mese per il voto e omologa, e poi il piano di esecuzione (che può essere anche pluriennale se paghi a rate i creditori). Ad esempio, depositi ricorso oggi, vieni ammesso entro 2-3 mesi, voto dei creditori entro 6 mesi, omologa al mese 8-9, poi esecuzione del piano magari entro i successivi 12-18 mesi (a seconda di cosa prevede). Diciamo che in 2 anni potresti chiudere tutto se il piano è breve; se il piano prevede pagamenti in 5 anni, allora la procedura rimane “aperta” in sorveglianza per quel periodo. Un fallimento invece può durare di più: la media dei fallimenti di PMI è 5-7 anni, ma alcuni si chiudono in 2-3 se c’è poco da liquidare, altri durano decenni se ci sono cause pendenti. Dunque il concordato in genere è più veloce e dà più controllo sui tempi. Come costi: il concordato comporta spese di consulenti (avvocato, attestatore) e un “fondo spese procedura” che il tribunale può chiedere di depositare (per pagare il commissario, le pubblicazioni, etc.). Per una piccola azienda i costi professionali possono variare: ad esempio, l’attestatore può chiedere qualche migliaio di euro, l’avvocato anche (dipende dalla complessità). Il commissario e successivo liquidatore verranno pagati con le risorse della procedura in base a tariffe di legge (di solito qualche percento dell’attivo e del passivo). Nell’insieme, un concordato può costare alcune decine di migliaia di euro in spese procedurali. Un fallimento scarica i costi sullo Stato anticipatamente (con un fondo) e poi sui beni: anche lì il curatore prende un compenso a percentuale sul realizzo e le spese sono a carico dell’attivo fallimentare. Spesso, però, in fallimento i creditori chirografari non vedono soldi anche perché l’attivo si consuma in spese di giustizia (specie se è modesto). Mentre nel concordato i creditori sanno ex ante quanto prenderanno (es: 40%) al netto delle spese già considerate nel piano. Per il debitore, il concordato richiede di avere un minimo di liquidità per affrontare le spese iniziali (onorari di chi lo prepara, eventuale cauzione spese). Il fallimento non richiede al debitore di anticipare nulla (ci pensa il tribunale nominando un curatore, se non c’è attivo poi si chiude per insufficienza). Tuttavia, chiaramente il fallimento “costa” in termini di perdita totale del controllo e danno reputazionale/di business. Quindi, direi: concordato = tempi più brevi e controllati, costi vivi a carico del debitore più elevati (perché ti doti di consulenti e paghi in procedura), ma migliori risultati per i creditori (generalmente); fallimento = tempi incerti e spesso lunghi, costi che intaccano il recupero dei creditori, nessun esborso iniziale per il debitore ma esito disastroso per la sua attività. Per queste ragioni, se c’è margine di salvare valore con un concordato, conviene tentare. Se la ditta è completamente decotta e non hai nemmeno soldi per le spese base di un concordato, allora si andrà in fallimento (o in liquidazione controllata se piccolissima). In alcune situazioni esistono procedure semplificate low-cost: es. il “concordato semplificato” post-composizione negoziata non prevede voto e potrebbe avere iter più agile – ma è riservato a casi particolari.
Fonti
(In questa sezione finale sono riportati i riferimenti normativi, le sentenze e gli approfondimenti autorevoli utilizzati nell’elaborazione della guida.)
Normativa italiana:
- Codice Civile: in particolare artt. 2086, 2446-2447 (riduzione capitale per perdite), 2482-bis e 2482-ter (Srl, obblighi in caso di perdite), 2486 (doveri amministratori dopo scioglimento e criteri risarcimento) ; artt. 2291, 2304 (responsabilità soci SNC) ; artt. 2392-2394 (responsabilità amministratori verso società e creditori).
- R.D. 267/1942 (Vecchia Legge Fallimentare): Artt. 67 (piano attestato esenzione revocatoria) ; 160 e segg. (concordato preventivo, ora abrogati e sostituiti dal CCII); 216-217 (bancarotta fraudolenta e semplice) e 223-224 (reati societari in caso di fallimento) ; 146 (azione di responsabilità del curatore).
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): articoli rilevanti:
- Art. 2 comma 1 lett. d) (definizione di “impresa minore” non assoggettabile a liquidazione giudiziale, soglie dimensionali) .
- Artt. 12-25 (Composizione negoziata della crisi, ruolo dell’esperto, misure protettive) .
- Art. 18 (richiesta misure protettive in composizione negoziata) .
- Art. 20 (effetti misure protettive: sospensione azioni esecutive).
- Artt. 44-54 (procedimento per accesso al concordato preventivo, incluso concordato “in bianco”).
- Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento) .
- Artt. 57-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti e omologazione; percentuali di adesione; cram-down fiscale art. 63) .
- Artt. 84-91 (Requisiti del concordato preventivo: continuità aziendale vs liquidatorio, soglie 20% in liquidatorio) .
- Artt. 92-102 (procedura di concordato: classi, voto maggioranza).
- Art. 108 (concordato con riserva).
- Art. 112 (concordato semplificato per liquidazione, ex art. 25-sexies introdotto da D.L. 118/21).
- Art. 120 (esdebitazione del debitore concordatario persona fisica).
- Artt. 121-270 (Liquidazione giudiziale: disciplina analoga a fallimento; art. 49 soglie 30.000€ per apertura ; art. 256 estensione soci illimitatamente responsabili).
- Art. 255 (azioni di responsabilità esercitate dal curatore verso amministratori e soci finanziatori).
- Art. 268-277 (Liquidazione controllata del sovraindebitato, per debitori minori non fallibili).
- Art. 322-341 (Reati concorsuali nel CCII, riformulazione di bancarotta e altri illeciti; es. art. 323 equipara condotte a vecchi artt. 216-217 L.F.).
- Art. 324 (Bancarotta semplice) e 325 (Ricorso abusivo al credito).
- Art. 330 (richiamo a fatti di bancarotta semplice applicabili).
- Art. 366 e 375-379 (adeguati assetti, modifiche al Codice Civile introdotte dal Codice Crisi). Relazione illustrativa al CCII (precisa ambiti di applicazione piani attestati) .
- D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (correttivo al CCII attuativo direttiva UE 2019/1023): modifiche in tema di cram-down fiscale , concordato semplificato, esdebitazione, ecc.
- D.L. 118/2021 convertito L. 147/2021: introduzione Composizione negoziata, articolo 2 e segg. (più ora integrata nel CCII) .
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: art. 19 (rateazione cartelle fino 72 o 120 rate).
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): art. 10-bis (omesso versamento ritenute fiscali > €150.000) ; art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250.000) ; art. 10-quater (indebita compensazione); art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte). Modifiche introdotte dalla L. 130/2022 e D.Lgs. 156/2022 sulla tempistica di consumazione del reato IVA .
- Legge 388/2000: art. 116 comma 8-9 (sanzioni civili per omesso versamento contributi, regime evasione vs omissione) .
- D.Lgs. 8/2016: depenalizzazione omesso versamento contributi sotto soglia 10.000€ .
- Art. 603-bis Cod. Penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (per contesto licenziamenti).
- D.Lgs. 81/2008: obblighi sicurezza sul lavoro (nessuna deroga in caso di crisi).
- Legge 3/2012 (vecchia composizione sovraindebitamento): abrogata e assorbita nel CCII, ma citata per storicità.
Giurisprudenza e prassi giuridica:
- Cass., Sez. Unite civili, 12/03/2013 n. 6070: principio di successione nei debiti sociali dei soci dopo cancellazione società . Conferma che i soci illimitatamente responsabili restano debitori illimitati dei debiti sociali non soddisfatti alla cancellazione .
- Cass., Sez. I civ., 31/05/2018 n. 13917: i soci SNC post-cancellazione rispondono illimitatamente dei debiti tributari sociali .
- Cass., Sez. V pen., 21/11/2020 n. 28848: controllo sindaci deve essere sostanziale; l’inerzia dei sindaci di fronte a patrimonio negativo configura concorso in bancarotta (richiamata in Cass. 1162/2024) .
- Cass., Sez. V pen., 09/03/2023 n. 9958: bancarotta impropria ex art. 223 co.2 n.1 L.F.: occultare perdite in bilancio per proseguire attività aggravando dissesto integra il reato; l’evento include anche il semplice aggravamento del dissesto non solo la causazione . (Osservatorio Unijuris ).
- Cass., Sez. V pen., 10/01/2024 n. 1162: sindaci omissivi concorrono in bancarotta semplice ex art. 217 L.F. se non reagiscono a inerzia amministratori con patrimonio netto negativo . (Studio Tosi commento ).
- Cass., Sez. I civ., 07/04/2025 n. 9082: giudicato penale di condanna per bancarotta (es. distribuzione utili fittizi aggravante dissesto) vincola nel giudizio civile sul danno (accertata causalità) .
- Cass., Sez. Unite pen., 27/05/2016 n. 22474: inerzia nel far emergere la crisi come “operazione dolosa” (anche se pronuncia antecedente, ha definito i confini tra bancarotta semplice e fraudolenta in caso di omissioni). [Non citata nel testo ma sottesa].
- Cass., Sez. III civ., 24/01/2023 n. 2127: responsabilità amministratori e limiti business judgment rule (atto di mala gestio l’acquisto azienda decotta senza misure adeguate) .
- Tribunale di Milano, Sez. fall., 17/10/2023 n. 8099: amministratori proseguono illegittimamente attività aggravando dissesto; responsabilità concorrente sindaci per inerzia (confermando orientamenti Cass.) .
- Corte Costituzionale n. 120/2023: non trattato nel testo, ma riguardante eventuale illegittimità soglie penali tributarie – nessuna incostituzionalità rilevata (per completezza).
- Direttiva UE 2019/1023: Direttiva Insolvency, recepita dal D.Lgs. 83/2022, con principi su ristrutturazioni, protezioni, cram-down fiscale (ispirando art. 63 CCII) .
La tua azienda che produce o distribuisce pistole di soffiaggio, ugelli, lance, accessori per aria compressa, attrezzature pneumatiche e sistemi di pulizia industriale sta affrontando una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce o distribuisce pistole di soffiaggio, ugelli, lance, accessori per aria compressa, attrezzature pneumatiche e sistemi di pulizia industriale sta affrontando una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, fornitori, banche o Agenzia Entrate-Riscossione?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi dei fornitori o minacce di pignoramento?
Il settore delle pistole di soffiaggio e dell’aria compressa richiede materiali tecnici, lavorazioni di precisione, stampi costosi, test di sicurezza e un magazzino sempre fornito, specialmente se rifornisci officine, industrie, manutentori o rivenditori specializzati.
Un ritardo nei pagamenti o un calo di liquidità può trasformarsi rapidamente in una crisi seria.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, protetta e rilanciata, se intervieni in modo tempestivo e strategico.
Perché un’Azienda di Pistole di Soffiaggio Finisce in Debito
I motivi più comuni includono:
• aumento dei costi di materiali (alluminio, ottone, acciaio, plastiche tecniche)
• forniture dall’estero con pagamenti anticipati
• ritardi nei pagamenti da parte di rivenditori, officine e industrie
• magazzino immobilizzato tra pistole finite, ugelli, corpi, molle e semilavorati
• costi energetici e di logistica in forte crescita
• investimenti in stampi, attrezzature e certificazioni di sicurezza
• riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
• cicli di produzione lunghi e incassi differiti
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità disponibile.
I Rischi per un’Azienda di Pistole di Soffiaggio con Debiti
Se non intervieni rapidamente rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti e dei fidi bancari
• sospensione delle forniture di materiali e componenti
• decreti ingiuntivi e azioni esecutive
• sequestro di prodotti finiti, semilavorati e macchinari
• arresto della produzione per mancanza di componenti
• ritardi nelle consegne e perdita dei clienti principali
• rischio concreto di chiusura operativa
Una crisi finanziaria ignorata può paralizzare la tua azienda in pochissimo tempo.
Cosa Fare Subito per Difendersi
- Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può sospendere pignoramenti, bloccare richieste aggressive delle banche, proteggere i conti correnti e intervenire con i fornitori critici.
Prima si stabilizza la situazione, poi si procede alla ristrutturazione. - Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso ci sono interessi non dovuti, sanzioni calcolate male, importi duplicati, debiti prescritti, errori della Riscossione e costi bancari irregolari.
Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata. - Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni includono rateizzazioni fiscali fino a 120 rate, accordi con fornitori strategici, rinegoziazioni bancarie, sospensioni temporanee dei pagamenti e uso delle definizioni agevolate quando disponibili.
Obiettivo: ripristinare liquidità senza fermare la produzione. - Attivare strumenti legali che proteggono l’azienda
Se la situazione è più grave si possono usare strumenti potenti come PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti, accordi di ristrutturazione, concordato minore o, solo come ultima scelta, liquidazione controllata.
Questi strumenti bloccano TUTTI i creditori, sospendono pignoramenti e permettono di pagare solo una parte del debito garantendo la continuità operativa. - Proteggere produzione, magazzino e forniture
Per un’azienda di pistole di soffiaggio è essenziale proteggere corpi, leve, ugelli, valvole, molle e componentistica; evitare sequestri; mantenere attivi i fornitori critici; proteggere macchinari, stampi e attrezzature; garantire consegne puntuali e continuità operativa.
Senza produzione, i debiti crescono velocemente. Con la produzione attiva, l’azienda può recuperare.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco totale dei debiti (commerciali, fiscali, bancari)
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario del magazzino (pistole, ugelli, corpi, semilavorati)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi iniziale in 24–72 ore
• Blocco dei creditori in 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione in 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria in 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione reale dei debiti
• Protezione del magazzino e delle linee produttive
• Trattative efficaci con fornitori e banche
• Continuità operativa garantita
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti o atti giudiziari
• Accendere nuovi debiti per coprire quelli vecchi
• Pagare un creditore e trascurarne altri
• Lasciare avanzare pignoramenti
• Affidarsi a società “miracolose” e non qualificate
Ogni errore rende la crisi più grave e pericolosa.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della tua situazione debitoria
• Blocco immediato dei creditori
• Piani di ristrutturazione personalizzati
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative tecniche con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
• Tutela completa dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di pistole di soffiaggio non significa essere destinato alla chiusura.
Con la strategia giusta puoi:
• fermare subito i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• proteggere produzione, magazzino e attrezzature
• salvare la tua azienda e il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la protezione e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.