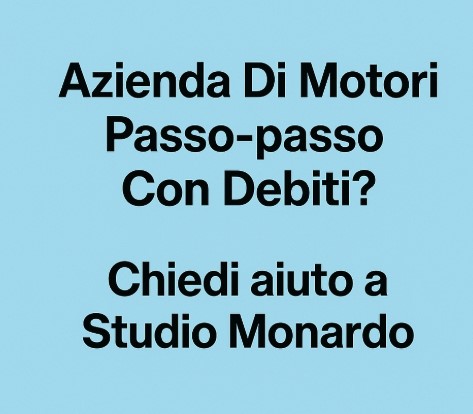Se gestisci un’azienda che produce, importa o distribuisce motori passo-passo, motori stepper ibridi, driver per motori passo-passo, motori NEMA, azionamenti, controlli elettronici e soluzioni per automazione CNC e industriale, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la continuità della tua attività è seriamente a rischio.
Il settore dei motori passo-passo richiede componenti elettronici costosi, forniture costanti, alta affidabilità e tempi di consegna puntuali. Un blocco dovuto ai debiti può fermare consegne, interrompere forniture a integratori e costruttori di macchine, creare ritardi nei progetti e farti perdere clienti strategici nel mondo dell’automazione.
La buona notizia è che puoi ancora difenderti, ridurre i debiti e salvare la tua azienda, se intervieni subito con la strategia giusta.
Perché le aziende di motori passo-passo accumulano debiti
Le cause più frequenti sono:
- costi elevati di motori, driver, encoder, schede di controllo e componentistica elettronica
- rincari dei semiconduttori e dei materiali importati
- pagamenti lenti da parte di clienti industriali, integratori e costruttori di macchine
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi con molte taglie, versioni e codici diversi
- investimenti continui in ricerca, test, firmware, certificazioni e strumenti di misura
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
- fornitori strategici che richiedono pagamenti rapidi o anticipati
Questi fattori possono trasformarsi in crisi di liquidità e indebitamento crescente, se non gestiti per tempo.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
La cosa più importante è non restare fermo. Ecco le prime azioni concrete:
- fai analizzare l’intera situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verifica quali debiti sono corretti e quali invece sono irregolari, gonfiati o prescritti
- evita di firmare piani di rientro frettolosi o rateizzazioni che non puoi sostenere
- richiedi la sospensione di eventuali pignoramenti e procedure esecutive in corso
- valuta rateizzazioni realmente sostenibili con Agenzia delle Entrate e INPS
- proteggi subito i rapporti con fornitori critici e componenti fondamentali
- previeni il blocco del conto corrente e il taglio dei fidi bancari
- utilizza gli strumenti legali disponibili per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Solo una diagnosi professionale ti permette di capire quali debiti ridurre, sospendere o contestare davvero.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni rapidamente, i rischi sono seri e concreti:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di strumenti, banchi di test, apparecchiature e mezzi
- blocco delle forniture di motori, driver, schede e componenti essenziali
- impossibilità di completare commesse, forniture o assistenze tecniche
- perdita di clienti industriali, integratori e partner strategici
- danni seri alla reputazione tecnica e commerciale
- crisi di liquidità e mancato pagamento di dipendenti e fornitori
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore dei motori passo-passo anche un ritardo minimo può bloccare interi impianti dei clienti o fermare linee produttive, con costi e penali a catena.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e altre azioni esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative mirate con Fisco, INPS e creditori privati
- ottenere rateizzazioni davvero sostenibili, basate sui flussi di cassa reali
- far annullare debiti prescritti, notificati male o calcolati in modo errato
- negoziare con banche e fornitori per evitare sospensioni delle consegne e del credito
- proteggere magazzino, attrezzature, know-how e continuità operativa
- stabilizzare la situazione mentre l’azienda ristruttura il proprio debito
- evitare l’apertura di procedure concorsuali e l’insolvenza
In altre parole, una strategia legale ben costruita può fare la differenza tra chiusura e rilancio.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere la tua azienda operativa e credibile sul mercato devi:
- intervenire subito, non quando è troppo tardi
- evitare di negoziare da solo con i creditori, senza un piano
- proteggere fornitori e componenti fondamentali per le consegne e il post-vendita
- ristrutturare i debiti prima che scattino pignoramenti o blocchi del conto
- individuare e contestare debiti irregolari o non più esigibili
- presidiare la liquidità, concentrandola sulle attività che generano valore (produzione, assistenza, consegne)
Così puoi evitare fermi, penali contrattuali e la perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo subito se:
- hai ricevuto cartelle, solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS, banche o fornitori stanno diventando ingestibili
- temi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità sta scendendo rapidamente e non riesci più a far fronte a tutte le scadenze
- i fornitori ti minacciano di sospendere le consegne
- temi che la situazione, se non fermata, possa portare alla chiusura dell’azienda
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e rimettere in sicurezza la tua attività.
Attenzione: molte imprese tecnologiche e di automazione non falliscono per i debiti in sé, ma perché intervengono troppo tardi. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, proteggendo davvero il futuro della tua azienda.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese elettroniche e industriali – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di motori passo-passo.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Affrontare una situazione di crisi d’impresa dovuta a debiti elevati è una sfida complessa, soprattutto alla luce delle recenti riforme normative in Italia. Una società (es. una S.r.l. produttrice di motori passo-passo) con debiti verso Fisco, banche, fornitori, INPS ed ex dipendenti deve conoscere gli strumenti di difesa e ristrutturazione a sua disposizione, nonché i propri obblighi legali. Nel 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), più volte modificato fino al 2024, che ha innovato profondamente le procedure concorsuali e introdotto misure preventive di gestione della crisi. In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo in dettaglio cosa fare per difendersi dalle iniziative dei creditori e come procedere passo-passo per risanare l’azienda, privilegiando il punto di vista del debitore.
Il taglio sarà avanzato e tecnico (adatto a legali, consulenti e imprenditori), ma con intento divulgativo, fornendo spiegazioni chiare dei concetti giuridici. Utilizzeremo domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti, proporremo tabelle riepilogative per confrontare le opzioni disponibili e descriveremo casi pratici tipici in ambito italiano, il tutto fondato su normativa vigente e giurisprudenza aggiornata (comprese le più recenti sentenze rilevanti). L’obiettivo è offrire una guida passo-passo per il debitore che si trovi a fronteggiare debiti insostenibili, illustrando come difendersi dalle azioni dei creditori e quali strategie attuare per salvare l’azienda o, nel peggiore dei casi, ridurre i danni di una liquidazione inevitabile.
Tipologie di debiti e rischi per l’azienda debitrice
Una azienda indebitata può avere esposizioni di diversa natura. Ciascun tipo di debito presenta criticità specifiche sia in termini legali che strategici. Prima di scegliere la strategia difensiva, occorre mappare i debiti e comprenderne le conseguenze potenziali:
- Debiti fiscali (verso l’Erario) – Comprendono imposte non pagate (IVA, IRES, IRAP), ritenute non versate, cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione, ecc. Questi debiti godono spesso di privilegi (cioè diritto di essere pagati con precedenza su altri crediti) e, se non gestiti, possono sfociare in procedure esecutive rapide (fermo amministrativo di beni, ipoteche, pignoramenti) o misure cautelari. Inoltre, alcuni inadempimenti fiscali comportano sanzioni amministrative e perfino responsabilità penali per gli amministratori (ad es. omesso versamento IVA > €250.000 o omesse ritenute > €150.000 sono reati) . Ignorare i debiti tributari è dunque molto pericoloso: il Fisco ha poteri di riscossione diretta e, in caso di crisi, sarà un creditore chiave in qualunque piano di ristrutturazione (anche tramite la cosiddetta transazione fiscale, v. oltre).
- Debiti contributivi/previdenziali (INPS, INAIL) – Simili ai debiti fiscali, riguardano contributi obbligatori non versati per i dipendenti o il titolare. L’INPS può emettere avvisi di addebito immediatamente esecutivi, portando a pignoramenti in tempi brevi. Anche qui, superati certi importi, scattano sanzioni e possibili reati (ad es. omesso versamento di contributi previdenziali sopra soglie di legge). In un eventuale concordato o accordo di ristrutturazione, i crediti contributivi possono essere oggetto di transazione contributiva insieme a quelli fiscali . Va segnalato che i contributi non versati ai dipendenti (trattenuti in busta paga ma non girati a INPS) comportano responsabilità personali molto gravi per l’amministratore.
- Debiti bancari e finanziari – Mutui, affidamenti di conto, leasing, finanziamenti vari. Le banche in genere dispongono di garanzie reali (ipoteche su immobili, pegni su macchinari o crediti) o personali (fideiussioni degli imprenditori/soci). Un’impresa “schiacciata dai mutui e scoperti bancari” deve aspettarsi che, in caso di insolvenza conclamata, le banche possono revocare gli affidamenti e avviare l’escussione delle garanzie (es. pignoramento di immobili ipotecati). Inoltre la banca potrebbe segnalare a sofferenza la posizione in Centrale Rischi, aggravando la reputazione creditizia dell’azienda. Tuttavia, le banche spesso preferiscono trovare un accordo (es. moratoria, piano di rientro o rinegoziazione) se intravedono prospettive di recupero: ciò rende possibile, per l’azienda debitrice, attivare trattative complesse ma fruttuose. In un accordo di ristrutturazione o concordato, le banche saranno generalmente raggruppate in classi specifiche e il loro voto/consenso è spesso determinante.
- Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali – Si tratta di fatture non pagate per forniture di merci, servizi, utenze, etc. Questi creditori sono in genere chirografari (senza garanzie né privilegi, dunque ultimi in ordine di soddisfazione), ma ciò non significa che siano inoffensivi: un fornitore strategico potrebbe interrompere le forniture mettendo in ginocchio l’attività, mentre altri fornitori potrebbero agire legalmente (richiedere un decreto ingiuntivo e successivamente pignorare conti o beni aziendali). Il rischio principale è la perdita di fiducia nella filiera: se la voce si diffonde, i fornitori potrebbero chiedere pagamenti anticipati o revocare dilazioni. Dal lato difensivo, l’azienda dovrebbe classificare i fornitori per importanza, cercando di negoziare con quelli essenziali (magari offrendo piani di pagamento sostenibili) e valutando di includerli in eventuali accordi formali di ristrutturazione. In procedura concorsuale, i debiti commerciali non privilegiati subiscono spesso falcidie (riduzioni): ad esempio, un concordato preventivo liquidatorio deve garantire ai chirografari almeno il 20% di soddisfazione (salvo apporti esterni) per legge.
- Debiti verso dipendenti ed ex dipendenti – Comprendono stipendi arretrati, ferie maturate non pagate, Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dovuto a chi ha cessato il servizio, e altre indennità. Questi crediti godono di un privilegio generale mobiliare molto forte (art. 2751-bis c.c.), che li rende preferiti su gran parte degli altri debiti . In pratica, in caso di fallimento o concordato, i lavoratori vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari. Inoltre, i dipendenti hanno strumenti rapidi per tutelarsi: ad esempio possono ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per le retribuzioni non pagate e pignorare i conti aziendali in tempi brevi . Esiste anche un Fondo di Garanzia INPS che interviene, in caso di insolvenza conclamata dell’azienda, per pagare ai dipendenti il TFR e ultime mensilità non saldate (il Fondo poi subentra come creditore privilegiato nella procedura concorsuale). Dal punto di vista del debitore, è cruciale cercare di compensare i lavoratori almeno in parte e tempestivamente: non solo per ragioni etiche e di clima aziendale, ma anche perché pagare i dipendenti può evitare cause di lavoro e fermare emorragie di personale chiave. Attenzione però a non preferire arbitrariamente alcuni creditori a discapito di altri in fase di crisi: pagare solo i dipendenti lasciando insoluti tutti gli altri potrebbe essere visto come pagamento preferenziale contestabile in caso di fallimento, a meno che ciò avvenga nell’ambito di un piano di risanamento legalmente ammesso (v. esenzione da revocatoria infra).
Riassumendo, non tutti i debiti sono uguali: alcuni (Fisco, INPS, dipendenti) hanno uno status legale forte e spesso tutele speciali nell’insolvenza; altri (banche, fornitori) possono esercitare pressioni contrattuali immediate o vantare garanzie reali. Una strategia di difesa efficace deve tenere conto di queste differenze: ad es., ignorare i debiti fiscali o contributivi è estremamente pericoloso (per via di privilegi, sanzioni e reati) mentre per i debiti bancari può essere fondamentale negoziare una moratoria prima che scattino le revoche dei fidi. Nei paragrafi successivi vedremo quali strumenti offre la legge per gestire e ristrutturare queste diverse categorie di debito, ma prima è opportuno chiarire la posizione di amministratori e soci rispetto ai debiti sociali.
Responsabilità degli amministratori e tutela del patrimonio personale
Uno dei principi cardine del diritto societario è la separazione patrimoniale: nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.) i debiti della società non ricadono, di regola, sui soci oltre il limite del capitale sottoscritto. Ciò significa che, in assenza di garanzie personali, il patrimonio personale di soci e amministratori è protetto dai debiti aziendali. Tuttavia, esistono importanti eccezioni e responsabilità da considerare, specialmente dal punto di vista dell’amministratore-debitore che voglia “difendersi” da conseguenze patrimoniali o penali:
- Responsabilità civile degli amministratori verso i creditori sociali: gli amministratori hanno l’obbligo di gestire la società con diligenza e nell’interesse non solo dei soci, ma anche dei creditori in caso di erosione del capitale. In base all’art. 2086 c.c. (come modificato dal Codice della crisi) essi devono istituire assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e adottare senza indugio le iniziative per farvi fronte. Se amministratori e organi di controllo omettono di reagire a una crisi incipiente e ciò causa un aggravamento del dissesto, possono essere chiamati a rispondere dei danni verso i creditori (azione di responsabilità per deficit patrimoniale). Ad esempio, protrarre attività imprenditoriale insolvente accumulando ulteriori debiti può costare agli amministratori una condanna a risarcire il maggior passivo, oltre alla possibile bancarotta in sede penale. Recenti interventi normativi e giurisprudenziali hanno rafforzato questi concetti: oggi è chiaramente richiesto all’imprenditore di attivarsi tempestivamente per la composizione della crisi, pena conseguenze personali.
- Violazione della legge o dell’atto costitutivo: al di là della crisi, se i debiti derivano da cattiva gestione (es. evasione fiscale deliberata, distrazione di beni, indebiti finanziamenti ai soci), l’amministratore ne risponde personalmente. In caso di fallimento, il curatore può promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori per recuperare somme a beneficio dei creditori. I soci di S.r.l. potrebbero anche perdere la protezione della “scatola societaria” in ipotesi di abuso di personalità giuridica (ad es. se la società è usata per frodare creditori): in tal caso i creditori possono tentare azioni per estinzione della personalità giuridica o operatività di fatto, onde aggredire i beni dei soci (sono situazioni estreme e non codificate chiaramente, ma la giurisprudenza talvolta “punisce” condotte di sottocapitalizzazione dolosa o confusione patrimoni).
- Garanzie personali e coobbligazioni: molto spesso, al di là delle norme di legge, sono gli stessi imprenditori a vincolarsi personalmente per ottenere credito. Fideiussioni bancarie, avalli su cambiali, polizze a garanzia di fornitori, ipoteche su beni personali per debiti aziendali – tutte queste situazioni espongono direttamente il patrimonio privato. Se la società non paga, il creditore potrà aggredire il socio o amministratore garante senza particolari formalità, secondo il contratto di garanzia sottoscritto. Difendersi in questi casi è più difficile: l’eventuale concordato preventivo della società non estingue le garanzie personali (il garante rimane obbligato per l’intero debito residuo). Vi sono solo parziali eccezioni: ad es. nei concordati in continuità, è previsto il beneficio di non escussione temporaneo per i garanti fino all’omologazione, e se il concordato viene adempiuto i creditori sociali devono liberare le garanzie personali (art. 94 CCII). Ma in caso di stralcio dei crediti chirografari, i creditori potranno comunque rivalersi sui fideiussori per la parte decurtata, a meno che anch’essi non ottengano una parallela esdebitazione personale. Pertanto, se sei amministratore-socio e hai firmato garanzie, considera strategie anche sul fronte personale (ad es. un piano del consumatore se sei sovraindebitato come privato).
- Responsabilità penale degli amministratori: un’azienda in crisi può spingere i suoi gestori ad adottare condotte illecite nel tentativo di tamponare la situazione, ma ciò ovviamente aggrava enormemente i rischi. Alcune fattispecie tipiche:
- Reati tributari: come già accennato, non pagare IVA o ritenute oltre soglie di punibilità configura reati (art. 10-bis, 10-ter D.Lgs. 74/2000). Inoltre, presentare dichiarazioni IVA o dei redditi omettendo di indicare passività (per ottenere credito) può integrare dichiarazione fraudolenta. In situazioni disperate, taluni omettono del tutto le dichiarazioni: anche l’omessa dichiarazione IVA o redditi è reato se l’imposta evasa supera €50.000 (art. 5 D.Lgs. 74/2000) .
- Reati fallimentari: se poi l’azienda finisce in fallimento (oggi liquidazione giudiziale), l’amministratore può essere accusato di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni, bancarotta preferenziale se ha pagato alcuni creditori (favorendoli) a detrimento di altri in fase di insolvenza, o bancarotta semplice se la crisi è stata aggravata da inerzia o altre colpe (artt. 322-323 CCII). Nota bene: il nuovo Codice della crisi esonera da responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale gli atti compiuti in esecuzione di un piano di risanamento concordato (piano attestato, accordo omologato o concordato preventivo). Ciò significa che se l’amministratore, nell’ambito di un regolare tentativo di risanamento, effettua pagamenti preferenziali o assume nuovi rischi per salvare l’impresa, tali atti non saranno puniti in caso di successivo fallimento. L’art. 324 CCII è pensato proprio per incoraggiare il risanamento onesto: se segui le regole e agisci in buona fede per ristrutturare, non verrai incriminato per aver favorito un creditore o aggravato il dissesto tentando la salvezza. Restano ovviamente puniti gli abusi: ad esempio, usare un “piano” fittizio solo per guadagnare tempo e nascondere beni è bancarotta fraudolenta a tutti gli effetti.
- Falso in bilancio e false comunicazioni: manipolare i dati di bilancio o occultare la reale situazione debitoria per ottenere credito aggiuntivo costituisce reato (artt. 2621-2622 c.c.). In contesti di crisi, truccare i numeri per “tenere in piedi la baracca” può sembrare una tentazione, ma è altamente rischioso: oltre alle pene, un bilancio falso compromette la fiducia del tribunale o dell’esperto in sede di procedura di risanamento. Il nuovo art. 342 CCII punisce specificamente l’attestatore che renda false attestazioni, ma è un monito anche per l’imprenditore: fornire dati falsi all’attestatore o omettere informazioni rilevanti è equiparato al falso e può portare a conseguenze penali.
In sintesi, dal punto di vista del debitore-amministratore, difendersi dai debiti significa anche difendersi da possibili responsabilità personali. È fondamentale: – Agire in modo trasparente e tempestivo di fronte alla crisi (ciò può attenuare accuse di mala gestio). – Non aggravare il buco con operazioni avventate o preferenze indebite, se non in contesto di un piano autorizzato. – Tenere una contabilità regolare e bilanci veritieri nonostante le difficoltà (evitando ulteriori problemi legali). – Se le perdite erodono il capitale sociale oltre i limiti di legge, rispettare gli obblighi di ricapitalizzazione o liquidazione (art. 2482-bis c.c. per S.r.l.): ignorarli può costituire grave negligenza verso i creditori. – Consultare professionisti (commercialisti, legali) non appena la tensione finanziaria diventa seria: questo non solo aiuta a trovare soluzioni, ma è anche una prova di condotta diligente.
Nel prossimo capitolo passeremo in rassegna gli strumenti di regolazione della crisi previsti dall’ordinamento italiano, ossia le varie procedure – formali o informali – che l’imprenditore indebitato può attivare per tentare il risanamento o quantomeno gestire in modo ordinato la propria insolvenza.
Strumenti di composizione della crisi e di ristrutturazione del debito
La normativa italiana (specie dopo l’entrata in vigore del CCII nel 2022) offre un ventaglio di strumenti per affrontare la crisi d’impresa. Tali strumenti vanno da soluzioni stragiudiziali (private, basate su accordi volontari) a vere e proprie procedure concorsuali giudiziali (sotto controllo del tribunale). La scelta dello strumento adeguato dipende dalla gravità dell’insolvenza, dal livello di consenso dei creditori e dagli obiettivi dell’imprenditore (continuare l’attività vs. liquidare). Di seguito analizziamo i principali istituti difensivi a disposizione del debitore:
Composizione negoziata della crisi d’impresa
La Composizione Negoziata è una procedura introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021, ora confluita nel CCII art. 17 e ss.) come strumento pre-concorsuale e volontario. Si tratta, in pratica, di un percorso di negoziazione assistita: l’imprenditore in difficoltà, prima di essere insolvente in modo irreversibile, può richiedere la nomina di un esperto indipendente tramite la Camera di Commercio . L’esperto ha il compito di facilitare trattative tra l’imprenditore e i creditori per raggiungere un accordo che eviti procedure concorsuali. Punti chiave: – È confidenziale: l’avvio della procedura non è pubblico di per sé (viene iscritta in una piattaforma telematica accessibile solo alle parti). Ciò tutela la reputazione dell’impresa mentre si cerca una soluzione. – L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria dell’azienda durante la negoziazione (non c’è spossessamento dei beni) . L’esperto assiste e vigila, ma non amministra l’impresa. – Si possono chiedere al tribunale misure protettive temporanee: ad es. il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori per la durata delle trattative (di norma fino a 4 mesi, prorogabili di 4) . Questo “scudo” permette di negoziare senza l’assillo immediato dei pignoramenti. – Durante la composizione negoziata, l’impresa può ottenere dal tribunale autorizzazione a compiere atti straordinari o finanziamenti prededucibili (per avere liquidità di urgenza), se l’esperto attesta che servono a migliorare le prospettive di risanamento.
Obiettivo finale: raggiungere un accordo con i creditori. Tale accordo può assumere diverse forme: un semplice accordo stragiudiziale (es. moratoria dei debiti, nuove scadenze), oppure la predisposizione di uno degli strumenti formali (piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato). La composizione negoziata è quindi un contenitore flessibile: può sfociare in una soluzione privatistica oppure fare da trampolino a una procedura concorsuale semplificata.
Le novità 2024-2025 hanno potenziato la composizione negoziata, visto che inizialmente era poco utilizzata. Ad esempio, il Terzo Correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha chiarito che la pendenza di una istanza di fallimento da parte di un creditore non impedisce l’accesso alla composizione negoziata (prima alcuni tribunali la negavano se c’era già una richiesta di liquidazione giudiziale, per paura di abusi dilatori). Ora l’imprenditore può avviare la composizione negoziata anche se un creditore o PM ha chiesto il fallimento, cercando un accordo in extremis; sarà poi compito del tribunale valutare la serietà del tentativo e nel frattempo tenere sospesa la decisione sull’istanza di fallimento. Inoltre, il correttivo 2024 ha introdotto incentivi per stimolare l’uso di questo strumento: – Estensione della segnalazione d’allerta interna anche ai revisori contabili: ciò significa che, nelle società senza organo di controllo obbligatorio, il revisore (se c’è) deve avvisare l’organo amministrativo di eventuali segnali di crisi. Questo favorisce l’attivazione tempestiva di misure come la composizione negoziata. – Chiarimenti sulle misure protettive: è ora esplicito che anche se l’azienda è già insolvente, può tentare la composizione negoziata purché l’insolvenza sia reversibile, ossia suscettibile di rimedio. Prima c’era incertezza se si potesse accedere essendo già tecnicamente insolventi; ora la legge lo consente se c’è ragionevole prospettiva di risanamento (questo in linea con la Direttiva UE 2019/1023 che mira al recupero precoce). – È stata prevista la transazione fiscale anche in composizione negoziata: dal 2024, l’imprenditore in composizione negoziata può proporre al Fisco e agli enti previdenziali la falcidia o dilazione dei loro crediti, e se ciò confluisce in un successivo piano attestato o accordo, si applicano le stesse regole di cram down fiscale . In sostanza, si cerca di integrare la posizione del Fisco anche nell’accordo che dovesse derivare dalla composizione negoziata.
La composizione negoziata, per quanto volontaria, prevede comunque vari adempimenti formali (istanza iniziale motivata, caricamento di dati contabili sulla piattaforma, redazione di un piano di risanamento ipotizzato, ecc.) e coinvolge un esperto nominato da una commissione. Se il tentativo fallisce (cioè non si raggiunge accordo), l’imprenditore può decidere di accedere a un concordato semplificato per la liquidazione (strumento particolare introdotto nel 2021): si tratta di chiedere al tribunale l’omologazione di un piano di liquidazione dei beni senza voto dei creditori, riservato al caso in cui la composizione negoziata non abbia prodotto soluzioni (è un’opportunità di liquidare l’impresa evitando il fallimento, ma è fuori dal nostro focus “difensivo” perché implica la fine dell’azienda).
Quando è adatta la composizione negoziata? Quando la crisi è ancora gestibile con la collaborazione dei creditori, e si vuole mantenere riservatezza e controllo. È ideale per PMI che intravedono una via di uscita (es. nuovi investitori, o la ripresa di commesse) ma hanno bisogno di tempo e sollievo dalle azioni dei creditori. Dal punto di vista del debitore, offre il vantaggio di sospendere temporaneamente le pressioni (con lo stay autorizzato) e cercare un accordo senza lo stigma di una procedura concorsuale pubblica. Di contro, non impone sacrifici ai creditori dissenzienti: se uno o più creditori non vogliono cooperare, la composizione negoziata rischia di non concludersi utilmente. In tal caso, come vedremo, si dovrà passare a strumenti più incisivi (concordato preventivo, etc.).
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento (spesso abbreviato PAR) è uno strumento di origine privatistica e flessibile, con radici nella Legge Fallimentare del 2005 e oggi disciplinato dall’art. 56 CCII. Esso consiste in un piano industriale e finanziario predisposto dall’imprenditore in crisi o insolvenza, finalizzato a riequilibrare la situazione debitoria e a garantire la continuità dell’impresa, accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In sostanza: – Il debitore elabora un dettagliato progetto di risanamento (ristrutturazione dei debiti, eventuali dismissioni di asset, taglio di costi, iniezioni di finanza fresca, ecc.). – Un attestatore (dottore commercialista o esperto ex art. 2 CCII, indipendente e iscritto in apposito elenco) verifica il piano e certifica che i numeri sono attendibili e che, secondo le ipotesi formulate, il piano ha possibilità concrete di successo. – Sulla base di questo piano attestato, l’impresa negozia privatamente con i creditori le modifiche delle proprie obbligazioni (allungamento scadenze, riduzioni parziali – “stralci” – di crediti, conversione di debiti in capitale, ecc.). Non c’è un voto collettivo: ogni creditore è libero di aderire oppure no. Si formalizzano una serie di accordi bilaterali con i creditori che accettano il piano (tipicamente contratti di rinegoziazione del debito, quietanze a saldo e stralcio, nuovi patti di pagamento). – Il piano attestato non richiede omologazione del tribunale né alcuna dichiarazione di apertura di procedura concorsuale. Può però – facoltativamente – essere pubblicato al Registro delle Imprese per dare data certa e opponibilità ai terzi.
Vantaggi:
– Stragiudiziale e riservato: non c’è l’iter formale di tribunale, commissari o votazioni pubbliche. Ciò evita il rischio di allarme sul mercato (clienti e fornitori potrebbero neanche venire a conoscenza della crisi). La pubblicazione del piano è opzionale proprio per preservare la riservatezza. Molte imprese preferiscono il piano attestato per non “mettere in piazza” i loro problemi, cosa che un concordato preventivo invece farebbe (essendo pubblico e notoriamente percepito come anticamera del fallimento).
– Flessibilità: l’art. 56 CCII delinea solo requisiti minimi (piano scritto con data certa, contenuto idoneo al risanamento, attestazione indipendente), ma lascia totale autonomia sulle soluzioni da adottare e sugli accordi da prendere. Non ci sono rigidi quorum o classi: si adatta caso per caso.
– Esenzioni legali per favorire il risanamento: se il piano attestato rispetta le condizioni di legge, gli atti compiuti in sua esecuzione godono di esenzione da azioni revocatorie fallimentari e ordinarie. Ciò significa che, se poi la società fallisse, il curatore non potrà revocare i pagamenti, le garanzie o le vendite di beni effettuate secondo il piano (purché il piano fosse serio e fattibile). Questo scudo è fondamentale: consente ai creditori coinvolti di accettare pagamenti e garanzie senza temere che un domani gli vengano tolti indietro. Ad esempio, se nel piano la banca A viene pagata e poi l’azienda fallisce, quel pagamento non sarà revocato se era previsto da un piano attestato valido. Nota: la Cassazione ha chiarito che l’esenzione non è automatica – occorre che il piano avesse concrete chance di successo ex ante, altrimenti il giudice del fallimento può comunque revocare gli atti compiuti sotto un piano fasullo. In altre parole: il debitore non può abusare di un “piano di comodo” solo per blindare atti pre-fallimentari. Giurisprudenza costante (Cass. 13719/2016, Cass. 9743/2022) ribadisce che il piano deve essere ragionevolmente attuabile per meritare la protezione.
– Protezione penale: come accennato sopra, gli atti compiuti durante l’esecuzione di un piano attestato sono esentati dal costituire reato di bancarotta semplice/preferenziale (art. 324 CCII). L’imprenditore che paga un creditore piuttosto che altri, o che contrae nuovi debiti nel tentativo genuino di risanare, non sarà punibile se poi l’azienda fallisce, a condizione che tali atti fossero funzionali al piano. Questo incentiva ad agire senza la paura “della beffa oltre il danno” in caso di insuccesso.
Svantaggi e limiti:
– Consenso unanime richiesto de facto: a differenza del concordato, il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti. Ogni creditore importante che non sia d’accordo può far saltare il piano agendo per conto proprio (pignorando, istando per il fallimento, ecc.). Non esiste un meccanismo di cram-down o voto a maggioranza: il successo dipende dalla volontaria adesione di tutti o almeno dei principali creditori. Nella prassi, l’imprenditore cerca di ottenere il consenso delle banche e di altri creditori chiave in via riservata; spesso i piccoli creditori vengono pagati per intero per evitare ostacoli, concentrando le ristrutturazioni sui grandi. Se c’è anche un solo creditore cruciale che resta fuori e minaccia azioni, l’azienda potrebbe dover “ripiegare” su una procedura concorsuale formale per bloccarlo.
– Mancanza di una moratoria legale automatica: durante la negoziazione di un piano attestato, non c’è tutela legale contro iniziative esecutive individuali. Diversi creditori potrebbero firmare accordi di standstill (impegno a non agire), ma un estraneo o un dissenziente potrebbe comunque aggredire il debitore. Per questo a volte, parallelamente al piano attestato, l’impresa deposita una istanza di concordato “in bianco” per ottenere dal tribunale il blocco delle azioni (come “ombrello” temporaneo), salvo poi rinunciare alla procedura concordataria se il piano va in porto. È un equilibrismo: il piano attestato punta a evitare formalità e pubblicità, ma paradossalmente in certi casi deve appoggiarsi a un concordato preventivo prenotativo per garantire stabilità nelle trattative.
– Nessuna forzatura su crediti pubblici o del lavoro: Fisco e INPS, pur potendo aderire a transazioni nel piano, non sono obbligati a farlo. Se l’Agenzia Entrate rifiuta la proposta di stralcio nel piano attestato, il debitore non può imporgliela (diversamente dal concordato dove oggi esiste il cram-down fiscale, v. oltre). Lo stesso vale per crediti di lavoratori: non si possono ridurre se non accettano. In pratica, il piano attestato funziona meglio quando il numero di creditori è limitato e relativamente omogeneo (es. un pool di banche sindacate, alcuni fornitori principali). In presenza di troppi stakeholders eterogenei, può diventare ingestibile.
– Rischio postumo di revocatoria se il piano era inadeguato: come visto, l’esenzione da revocatoria vale solo se il piano aveva serietà. Se l’impresa fallisce dopo aver fatto un piano attestato manifestamente inidoneo a salvarla, il curatore potrà attaccare gli atti fatti sotto quel piano, sostenendo che non meritavano protezione. Già Cassazione 2016 e 2020 (Sirti) hanno concesso revocatorie in casi di piani “di comodo”. Quindi, l’imprenditore deve essere conscio che un piano attestato arrangiato solo per prendere tempo potrebbe non reggere al vaglio ex post del giudice.
Ruolo cruciale dell’attestatore: il professionista indipendente che attesta il piano deve rispondere a requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei commissari giudiziali . La sua relazione è il fulcro della credibilità del piano. Egli verifica i dati aziendali, le cause della crisi, e valida (oppure no) le assunzioni del piano (es. previsioni di vendita, taglio costi, apporto di nuovi fondi). Una attestazione positiva è condizione legale per le protezioni del piano. Va sottolineato che l’attestatore può incorrere in gravi responsabilità se sbaglia: civilmente, verso i creditori che abbiano fatto affidamento sulla sua relazione; penalmente, per il reato di falso in attestazioni (art. 342 CCII) se agisce con dolo o colpa grave. La Cassazione (Sez. Unite 1521/2013) ha stabilito che l’attestatore risponde di omessa vigilanza su dati non veritieri o per valutazioni grossolanamente errate. In una sentenza penale recente (Cass. pen. 36401/2023) si è ribadito che omettere informazioni rilevanti nella relazione equivale a falsità. Questo sprona gli attestatori ad essere scrupolosi e, di riflesso, spinge l’azienda a non occultare nulla e a presentare un piano realistico. Infatti, attestatori poco rigorosi sono stati perseguiti (es. caso Sirti, Trib. Milano 2020, in cui l’attestatore fu inizialmente imputato per non aver rilevato passività fiscali occulte; assolto per mancanza di dolo, ma con grande spavento).
In quali situazioni conviene tentare un piano attestato? Quando l’azienda è ancora vitale e la crisi circoscritta: ad esempio, se un nuovo investitore è disposto a entrare a condizione di ristrutturare il debito bancario, oppure se c’è una sola banca esposta e qualche fornitore principale, e tutti sono disposti a negoziare. È un ottimo strumento per PMI con pochi creditori concentrati (si citano casi di successo in società immobiliari che hanno rinegoziato con un gruppo di 5-10 banche sindacate evitando il fallimento). Se invece i creditori sono centinaia (es. obbligazionisti diffusi, tanti piccoli fornitori), è poco praticabile richiedere l’assenso individuale di ognuno. In tali casi, bisogna optare per soluzioni collettive dove la maggioranza vincola la minoranza (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o concordato preventivo).
Prima di passare agli accordi di ristrutturazione, ecco una tabella riepilogativa dei principali strumenti analizzati sinora, confrontati su alcuni aspetti chiave:
Tabella 1: Confronto strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata vs piano attestato vs concordato)
| Caratteristica | Composizione Negoziata | Piano Attestato di Risanamento | Concordato Preventivo (procedura concorsuale) |
|---|---|---|---|
| Normativa | Art. 17-25 quater CCII | Art. 56 CCII | Art. 84 e ss. CCII (ex art. 160 e ss. L.Fall.) |
| Natura | Stragiudiziale assistita da esperto (fase pre-crisi) | Stragiudiziale negoziale (accordi privati) | Giudiziale (procedura concorsuale pubblica) |
| Gestione dell’impresa | Rimane all’imprenditore (con esperto che vigila) | Rimane all’imprenditore (accordi privati) | Amm. straordinaria: l’imprenditore propone il piano ma opera sotto controllo di organi nominati (commissario, tribunale). |
| Protezione da creditori | Sì, su richiesta: misure protettive (stay) concesse dal tribunale fino 4+4 mesi | No automatica. Possibile standstill pattizio o ricorso provvisorio al concordato “in bianco”. | Sì, automatico dopo l’ammissione: divieto di azioni esecutive e cautelari (stay legale) per tutta la procedura. |
| Consenso richiesto | Volontario: nessun vincolo collettivo, si punta ad accordi con quanti più creditori possibili. | Volontario e individuale: serve accordo con ogni creditore rilevante (nessuna maggioranza vincolante). | Collettivo: voto a maggioranza dei crediti in ciascuna classe; minoranza dissenziente vincolata se piano omologato. |
| Percentuale/Quorum | – (nessun quorum legale, dipende dagli accordi che si riescono a siglare) | – (nessun quorum, ma se un creditore essenziale rifiuta può far fallire il piano) | Maggioranza per omologa: >50% dei crediti votanti (o maggioranza delle classi, con poss. cram-down trasversale) . |
| Tribunale coinvolto | Limitato: nomina esperto; concede misure protettive; omologa eventuali accordi minori. | No (solo eventuale deposito piano al Registro Imprese). | Sì, intensamente: dal decreto di ammissione, alla nomina commissario, fino alla sentenza di omologazione finale. |
| Effetti sugli atti e pagamenti | Atti autorizzati dal tribunale (es. finanziamenti interinali) sono prededucibili. Se composizione fallisce, procedura conseguente può inglobarli. | Atti in esecuzione del piano non revocabili ex post (se piano valido); pagamenti esenti da bancarotta preferenziale. | Atti compiuti dopo l’apertura sono soggetti ad autorizzazione; pagamenti non previsti dal piano possono essere revocati dal curatore; esenzione da revocatoria per quelli a norma di piano omologato. |
| Falcidi dei crediti | Possibili su base volontaria (il creditore accetta riduzione). Nessuna imposizione a dissenzienti. | Possibili se creditori aderiscono volontariamente (dissenzienti devono essere pagati per intero se vogliono ottenere lo scudo revocatoria). | Sì, possibili riduzioni forzate: il piano può prevedere pagamento parziale ai chirografari e anche ai privilegiati se li soddisfa almeno per valore di liquidazione. Dissentienti subiscono la falcidia se la maggioranza approva e il tribunale omologa. |
| Transazione Fiscale/Contributiva | Introdotta dal 2024: l’esperto può agevolare un accordo con Fisco/INPS, ma serve adesione Agenzia o successiva omologa in accordo formale . | Sì, possibile includere Fisco/INPS: tuttavia se non aderiscono volontariamente non si può imporre (nessun cram-down fiscale in piano attestato). | Sì, disciplinata da art. 88 CCII: possibile stralciare IVA, imposte e contributi con voto Agenzia; dal 2024 il tribunale può omologare il concordato anche senza adesione del Fisco se soddisfatto ≥ alternativo . |
| Esito se fallisce il tentativo | Può passare a concordato semplificato liquidatorio (senza voto) o a ordinaria procedura concorsuale. | Spesso preludio a concordato preventivo se un creditore rilevante resta fuori. Se impresa risana, nessuna procedura. Se fallisce dopo, atti esenti restano esenti; altri possibili azioni del curatore. | Se concordato non omologato → si apre la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Se omologato ma non eseguito → fallimento su istanza dei creditori. Se eseguito con successo → l’azienda prosegue (in continuità) o viene liquidata ma senza fallimento. |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. “Stay” = sospensione delle azioni esecutive. “Falcidia” = pagamento parziale di un credito, percentuale decisa nel piano. “Prededucibile” = debito che sarà pagato con precedenza nella eventuale procedura successiva.)
Come si nota dalla tabella, il concordato preventivo è lo strumento più strutturato e potente per imporre una soluzione ai creditori dissenzienti, mentre il piano attestato e la composizione negoziata si basano sul consenso volontario ma offrono maggiore discrezione e flessibilità.
Passiamo ora ad approfondire l’accordo di ristrutturazione dei debiti, che rappresenta un via di mezzo tra il piano attestato e il concordato: è un accordo privato, ma assistito dall’autorità giudiziaria mediante omologazione, e che può avere effetti vincolanti anche sui non aderenti in talune circostanze.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono stati introdotti nel 2005 (art. 182-bis L.Fall.) e oggi trovano disciplina negli artt. 57-64 CCII. Si tratta di accordi contrattuali tra l’impresa debitrice e una parte significativa dei creditori, aventi l’obiettivo di risanare l’esposizione debitoria ed evitare la liquidazione giudiziale. La peculiarità rispetto al piano attestato è che l’accordo viene sottoposto al Tribunale per l’omologazione (approvazione), e ciò conferisce efficacia anche verso terzi estranei in certi limiti. In sintesi, ecco come funziona: – Il debitore elabora un piano di ristrutturazione (spesso con l’ausilio di un attestatore, perché la legge richiede comunque una attestazione sulla veridicità dei dati e fattibilità dell’accordo, similmente al piano attestato). – Individua quali creditori aderiscono formalmente all’accordo, raccogliendo la loro adesione scritta. – Se il quorum di legge è raggiunto, il debitore può depositare in Tribunale l’accordo, il piano e la documentazione, chiedendone l’omologazione. Dal 2022, la soglia standard di adesione richiesta è il 60% del totale dei crediti (questa percentuale è stata confermata nel CCII per l’“accordo ordinario”). – Il Tribunale, dopo aver verificato la regolarità e sentito eventualmente i creditori (che possono fare opposizione), emette un decreto di omologazione che rende l’accordo efficace tra le parti e conferisce alcuni vantaggi legali (es. esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi dell’accordo, similmente al piano attestato).
Esistono diverse tipologie di accordi di ristrutturazione, introdotte dalle riforme recenti per maggiore flessibilità: 1. Accordo “ordinario” (art. 57 CCII) – Richiede adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. I creditori estranei (quelli che non aderiscono) non sono vincolati a riduzioni: vanno pagati integralmente alle scadenze originarie, sebbene la legge consenta di dilazionarli fino 120 giorni dall’omologazione (massimo) o 120 giorni dal loro termine, se successivo (art. 58 CCII). In pratica, con il 60% di consensi il debitore può chiudere un accordo con i principali creditori e gestire i restanti pagandoli regolarmente o con un piccolo ritardo ammesso. 2. Accordo “agevolato” (art. 60 CCII) – Introdotto di recente, consente di abbassare il quorum di adesione al 30%, a fronte di condizioni stringenti: il debitore rinuncia a chiedere misure protettive (niente stay), e non può avvalersi della moratoria di 120 giorni per i creditori estranei (deve prevedere pagamento tempestivo degli estranei). In pratica, l’accordo agevolato è pensato per chi non ha bisogno di protezione urgente dai creditori (perché la situazione è sotto controllo o i creditori sono collaborativi): in cambio di questa rinuncia allo “scudo”, la legge accetta un consenso molto più basso (30%). È utile se pochi creditori – magari banche – rappresentano gran parte del debito e si trovano d’accordo, mentre i restanti sono tanti piccoli creditori che verranno semplicemente pagati per intero a tempo debito (quindi non serve coinvolgerli nell’accordo). Da notare: se scegli l’accordo agevolato non puoi chiedere misure protettive, nemmeno per impedire azioni cautelari mentre l’accordo è in omologazione. 3. Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII, ex art. 182-septies L.Fall.) – È un meccanismo che permette di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori della stessa categoria che non hanno aderito. In particolare, è stato concepito per le banche e gli intermediari finanziari: se il debitore ottiene l’adesione di almeno il 75% dei crediti di una categoria omogenea (es. tutti gli istituti finanziatori), può chiedere al tribunale di estendere l’accordo ai finanziatori dissenzienti rimasti (purché abbiano possibilità di soddisfazione non inferiore a quella che avrebbero in alternativa). Questo è un semi-cramdown settoriale: consente di superare l’opposizione di poche banche “holdout” quando la stragrande maggioranza è d’accordo. Il CCII ha generalizzato un po’ l’istituto: originariamente riguardava solo banche, ora si parla di “categorie omogenee” di creditori – ad esempio potrebbe applicarsi anche a obbligazionisti o fornitori se raggruppati in classe e se ne hanno i numeri. L’accordo ad efficacia estesa richiede comunque il rispetto di condizioni di trattamento equo dei dissenzienti e l’attestazione che l’accordo è conveniente per loro rispetto alle alternative (criterio di miglior soddisfacimento). 4. Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e/o fornitori strategici – Nel vecchio impianto c’erano norme speciali (art. 182-septies e 182-novies L.Fall.) per accordi con soli istituti finanziari o con fornitori essenziali. Il nuovo Codice sembra aver integrato queste ipotesi nell’accordo ad efficacia estesa e in previsioni come la moratoria sui fornitori strategici. In pratica, è possibile concentrare l’accordo su certe tipologie di creditori e prevedere che altri vengano pagati normalmente.
Effetti dell’omologazione: una volta omologato, l’accordo produce diversi effetti legali: – I creditori aderenti sono vincolati ai nuovi termini concordati (piani di rientro, riduzioni, ecc.) e non possono agire esecutivamente a patto che il debitore rispetti l’accordo. – I creditori non aderenti rimangono liberi di agire per i loro diritti. Tuttavia, come detto, il debitore può avere previsto nel piano di pagarli comunque integralmente (altrimenti avrebbero opposto l’omologa) e la legge consente un breve slittamento di quei pagamenti (max 120 giorni) nei soli accordi non agevolati. Se il debitore non paga gli estranei alle scadenze, costoro possono chiedere la risoluzione dell’accordo o attivare procedure (quindi il piano deve essere calibrato per soddisfarli). – Stop alle esecuzioni durante le trattative: il debitore, quando deposita il ricorso per omologa, può chiedere le misure protettive (simili a quelle del concordato) per bloccare le azioni dei creditori fino all’omologazione. Questo è importante: diversamente dal piano attestato, qui c’è la protezione legale in itinere. Nota: se però il debitore opta per l’accordo agevolato, non chiederà misure protettive (per coerenza con l’art. 60). – L’omologazione dell’accordo viene pubblicata nel Registro delle Imprese; da lì decorre eventualmente il termine per opposizioni dei creditori estranei (che però, se sono stati pagati o garantiti integralmente, difficilmente avranno interesse a opporsi). – Esenzioni da revocatoria: analogamente al piano attestato, atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria fallimentare. Un’ulteriore spinta ai creditori per aderire senza timori. – Transazione fiscale: l’accordo può includere la ristrutturazione di debiti fiscali e contributivi (transazione fiscale ex art. 63 CCII). In tal caso, se Agenzia Entrate/INPS aderiscono, bene; se rifiutano, è ora previsto che il debitore possa chiedere comunque l’omologazione col cram-down fiscale, a condizione di aver soddisfatto anche tutti gli altri creditori non erariali per la percentuale richiesta . La Cassazione ha chiarito che per applicare il cram-down fiscale negli accordi occorre che il debitore abbia l’accordo con tutti i creditori diversi dal fisco (non puoi bypassare il voto del Fisco se anche altri creditori mancano) . In pratica: l’accordo con transazione fiscale va omologato forzatamente solo se il Fisco è l’unico a dire no, mentre gli altri ci stanno (principio confermato da Cass. 32954/2024).
Accordi e piccole imprese/non fallibili: il CCII consente l’accesso agli accordi di ristrutturazione anche a imprenditori minori (quelli che sarebbero soggetti al “concordato minore” invece del preventivo). Però, in tali casi, serve comunque il 60% dei creditori: spesso per micro-imprese c’è un numero ridotto di creditori, quindi raggiungere il 60% di crediti può significare convincerne pochi di rilevanti. Se l’imprenditore è non commerciale (es. un professionista), può comunque proporre accordi ex art. 57 CCII perché la norma non richiede la qualità di imprenditore commerciale (a differenza del vecchio fallimento). Quindi anche associazioni, fondazioni o professionisti indebitati potrebbero usare lo strumento, salvo poi incorrere nella disciplina del sovraindebitamento se non fallibili.
Vantaggi degli accordi di ristrutturazione: – Rapidità e minor onerosità rispetto al concordato: non c’è tutta la procedura di voto e adunanza, non serve nominare un commissario giudiziale (anche se spesso il tribunale nomina un ausiliario/esperto per esaminare l’accordo). L’omologa di un accordo può arrivare in pochi mesi, mentre un concordato dura più a lungo e ha costi procedurali maggiori. – Mantenimento di controllo: l’imprenditore negozia direttamente con i creditori; il tribunale interviene solo a valle per conferire efficacia. Non vi è spossessamento o gestione esterna dell’impresa. – Possibilità di includere solo alcuni creditori: a differenza del concordato, l’accordo può anche riguardare solo alcuni creditori (di solito però devi regolare il 100% delle passività per assicurare sostenibilità). In teoria, potresti lasciar fuori debiti marginali pagandoli a scadenza e focalizzarti in accordo su banche e fisco. Questa flessibilità è utile se alcuni debiti sono contestati o se ci sono creditori indifferenti alla ristrutturazione (es. una banca già garantita che preferisci pagare interamente e non includere nell’accordo). – Moratoria per finanziatori: spesso gli accordi contengono clausole di standstill e nuove linee di credito da banche consenzienti, realizzando nei fatti un refinancing dell’impresa sotto l’egida del tribunale (che dà conforto a tutti che l’accordo è “blindato”). – Nessun minimo di legge ai chirografari estranei: nel concordato liquidatorio c’è soglia 20% per chirografari. Negli accordi, se un creditore chirografo non aderente è pagato al 100%, va bene; se lo vuoi falcidiare devi convincerlo ad aderire, altrimenti niente. Quindi, non c’è un concetto di “percentuale minima” ma di fatto se resta estraneo lo paghi full.
Svantaggi e limiti degli accordi: – Richiede comunque notevole consenso: pur più basso dell’unanimità del piano attestato, arrivare al 60% (o anche 30% nell’agevolato) di crediti aderenti non è banale. Bisogna negoziare con molti creditori, magari di classi diverse. Finché non si ha il quorum, si è esposti. – I creditori estranei devono essere soddisfatti integralmente: questo spesso implica trovare finanza o risorse per pagarli cash. Se l’azienda non ha liquidità per pagarli (né asset non strategici da liquidare per fare cassa), un accordo potrebbe non reggere. Nel concordato, invece, i creditori estranei (che poi non esistono, perché tutti partecipano) possono subire decurtazioni forzose. – Periodo di opposizioni: dopo la pubblicazione in Reg. Imprese, i creditori estranei o dissenzienti che ritengono lesi i loro diritti (magari sostenendo che non saranno pagati integrali) possono fare opposizione e rallentare o impedire l’omologa. Serve preparare bene l’accordo per prevenire contestazioni. – Nessun effetto esdebitatorio per l’imprenditore individuale: se l’accordo fallisce dopo omologa e si va in fallimento, l’imprenditore persona fisica non beneficia di protezioni particolari (a differenza del concordato che, se adempiuto, comporta esdebitazione per l’imprenditore individuale).
Riassumendo, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento difensivo efficace quando l’impresa ha già costruito un consenso elevato con i propri creditori principali. È quasi il risultato di una buona negoziazione avvenuta magari in composizione negoziata o autonomamente. Per esempio, se Motori Srl convince 7 banche su 8 a sottoscrivere un accordo sul 90% dei debiti finanziari, potrà usare l’accordo ex art. 61 CCII per forzare anche l’ottava banca riluttante a rispettare le stesse condizioni concordate con le altre. Invece, se non c’è accordo diffuso, questa strada non è percorribile e bisognerà ricorrere al concordato preventivo, dove sarà il voto a decidere.
Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII)
Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale di ristrutturazione, erede della procedura prevista dalla Legge Fallimentare del 1942. È un procedimento giudiziario in cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori un piano di regolazione dei debiti, soggetto a votazione da parte loro e a omologazione (approvazione) da parte del tribunale. Rappresenta la soluzione da utilizzare quando non è possibile ottenere il consenso individuale dei creditori in via stragiudiziale, oppure quando si vuole assicurare un effetto vincolante universale (tutti i creditori inclusi nel piano ne saranno vincolati, anche se dissenzienti, se la maggioranza approva). Di contro, è una procedura pubblica e formale, con maggiore complessità.
Tipologie di concordato: il CCII distingue principalmente: – Concordato in continuità aziendale (art. 84, co. 2): il piano prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente da parte del debitore o tramite cessione/affitto d’azienda a terzi, in modo da generare valore per pagare i creditori. La continuità può essere diretta (l’azienda resta al debitore) o indiretta (l’azienda viene trasferita, ma l’attività prosegue con altro soggetto). Questo concordato è orientato a salvare la parte sana dell’impresa (i posti di lavoro, l’avviamento) mentre si ristruttura il debito. Spesso comporta dilazioni di pagamento lunghe e l’apporto di nuova finanza. – Concordato liquidatorio (art. 84, co. 3): il piano consiste prevalentemente nel liquidare il patrimonio del debitore e distribuire il ricavato ai creditori. È simile a un fallimento pilotato dal debitore, con la differenza che evita la dichiarazione di fallimento e può essere più rapido/ordinato. La legge – per scoraggiare i concordati liquidatori “opportunistici” – prevede che se si liquidano beni dell’impresa, il piano deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, salvo che vengano introdotte risorse esterne (finanza esterna) che innalzino il soddisfacimento almeno al 10% (nel qual caso si può omologare eccezionalmente anche sotto il 20%). Inoltre nel concordato liquidatorio puro, dal 2024 anche il cram-down fiscale è ammesso (prima era dubbio): significa che pure se il Fisco vota no, il giudice può omologare se quell’offerta è il massimo realizzabile (lo ha chiarito il correttivo 2024) . – Concordato misto o con continuità parziale: frequente nella prassi, è un piano dove una parte di beni viene liquidata e un’altra parte dell’azienda continua. Esempio: si vendono asset non strategici immobiliari per fare cassa, mentre il core business prosegue con un piano industriale di rilancio. – Concordato preventivo “minore”: riservato a debitori sotto soglie dimensionali (imprenditori minori), disciplinato ma con procedure semplificate. Non approfondiamo qui, focalizzandoci su S.r.l./S.p.A. che superano i limiti. – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: introdotto nel 2021, è un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, attivabile solo dal debitore e solo se è fallita la composizione negoziata. Qui il tribunale può omologare un piano di liquidazione che ritenga equo, senza passare per la votazione dei creditori (che comunque possono essere ascoltati). È un escamotage per scoraggiare creditori dall’atteggiamento ostruzionistico dopo una negoziazione onesta; tuttavia, è circoscritto a quell’ipotesi particolare.
Fasi e caratteristiche salienti del concordato preventivo: 1. Domanda di concordato – L’imprenditore può presentare il ricorso con un piano già completo (concordato “pieno”) oppure, se ha necessità di tempo per completarlo, un ricorso “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco). La domanda prenotativa blocca subito le azioni dei creditori e concede tempo (di norma fino a 120-180 giorni) per depositare il piano definitivo. Il correttivo 2024 ha reso questa fase più flessibile, ad es. facilitando la possibilità di presentare piani concorrenti dei creditori in certi casi, ecc.. 2. Ammissione e apertura della procedura – Il tribunale valuta prima facie che vi siano i requisiti (stato di crisi o insolvenza non irreversibile, proposta non manifestamente infeattibile, documentazione regolare) e, se tutto ok, dichiara aperta la procedura di concordato. Viene nominato un Commissario Giudiziale, figura terza che supervisiona l’impresa durante la procedura e redige una relazione per i creditori. Da questo momento scatta il blocco dei pagamenti dei crediti anteriori e delle azioni esecutive/cautelari (salvo eccezioni per crediti lavoratori per alcune mensilità). 3. Classi di creditori e proposte – Il debitore deve aver classificato i creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici (es. classe banche chirografarie, classe fornitori chirografari, classe dipendenti privilegiati, ecc.). Per legge i crediti privilegiati non possono essere alterati se non rinunciano al privilegio o se viene loro offerto almeno il valore di realizzo dei beni su cui hanno prelazione (principio del best interest test). Il piano può prevedere che alcuni beni vadano ai creditori (in pagamento o a garanzia). Se è in continuità, occorre allegare un piano industriale dettagliato. 4. Votazione – I creditori vengono convocati all’adunanza e/o possono votare per via telematica/epistolare. Serve il voto favorevole, calcolato per teste e per importi, di una maggioranza qualificata: di base, più del 50% dei crediti ammessi al voto. Se ci sono classi, occorre il 50% in ogni classe; in caso qualche classe voti no, il tribunale può applicare il cram-down interclassi (novità 2022/2024) omologando il concordato se almeno una classe di creditori non inferiore ha detto sì e il piano è equo verso le classi dissenzienti. Questo è il cross-class cram down, allineato alla Direttiva UE, che consente di superare il veto di una classe dissenziente purché certe condizioni siano rispettate (classe dissenziente soddisfatta almeno quanto soddisferebbe in liquidazione e non discriminata ingiustamente). Ad esempio, se i chirografari approvano ma una classe di subordinati no, il giudice può comunque omologare forzatamente. 5. Omologazione – Se la maggioranza (o le condizioni per cram-down) c’è, il tribunale omologa il concordato con decreto, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori. Se il Fisco o altri creditori pubblici hanno votato no ma il piano offre loro almeno il 100% del ricavabile in caso di fallimento, il tribunale può omologare lo stesso (cram-down fiscale e contributivo, ora esplicitamente ammesso anche senza il voto del Fisco) . Ad esempio, Cass. 27782/2024 ha confermato che l’omologa può avvenire anche con voto negativo dell’erario, se gli altri presupposti sono rispettati . L’omologazione chiude la procedura e apre la fase di esecuzione. 6. Esecuzione del piano – Il debitore, sotto il controllo di un Commissario (che diviene Liquidatore giudiziale nel caso di cessione beni), attua quanto promesso: paga i creditori secondo le percentuali e tempistiche concordate, eventualmente cede beni, prosegue l’attività se in continuità, ecc. Una volta completato l’execution, il debitore uscirá dalla procedura e – se è un imprenditore individuale – otterrà l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). Se è una società, i debiti residui chirografari restano inesigibili (la società riparte pulita se continua, oppure viene cancellata se era liquidatoria). 7. Vigilanza e risoluzione: se il debitore non rispetta gli obblighi del concordato, i creditori o il commissario possono chiederne la risoluzione e il tribunale dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale). Idem se emergono atti di frode ai danni dei creditori durante la procedura (in tal caso il concordato può essere annullato su istanza).
Vantaggi dal punto di vista del debitore: – Vincolatività universale: è il principale vantaggio. Anche chi non è d’accordo subisce il concordato se viene approvato dalle maggioranze. Questo consente di includere tutti i debiti e di effettuare ristrutturazioni profonde (ad esempio, falcidiare al 40% tutti i chirografari, compresi fornitori che non avrebbero mai accettato spontaneamente). – Moratoria legale immediata: la protezione dalle azioni dei creditori scatta già al momento del deposito del ricorso (in bianco o completo). Ciò dà respiro all’impresa: non può essere pignorata, i fornitori non possono risolvere contratti per crediti pregressi, eventuali istanze di fallimento sono sospese. In caso di urgenze, il tribunale può autorizzare pagamenti di creditori strategici o nuova finanza in prededuzione per evitare danni irreparabili. – Possibilità di sciogliersi dai contratti onerosi: il CCII (come la vecchia legge) consente al debitore in concordato di chiedere l’autorizzazione a sciogliersi da alcuni contratti in corso, se ciò è funzionale al piano (art. 94 CCII). Questo permette, ad esempio, di interrompere contratti di locazione troppo costosi, o forniture non più utili, pagando un indennizzo al contraente (che diventa credito concorrente). – Gestione accentrata del contenzioso: eventuali cause in corso vengono riunificate nella procedura e decise dal giudice del concordato (evitando una giungla di cause in tribunali diversi). – Transitabilità verso soluzioni migliori: fino all’omologa, se arriva un’opzione di risanamento migliore (es. un investitore propone un accordo ex art. 57, o si raggiunge un piano attestato che soddisfi tutti), c’è la possibilità di “convertire” il concordato in altro strumento o di ritirarlo (con il consenso del tribunale/creditori). Il CCII incoraggia soluzioni concordate anche dopo l’apertura del concordato, tanto che la domanda di concordato può essere trasformata in domanda di omologa di accordo di ristrutturazione e viceversa. – Effetti sull’azienda in continuità: se il concordato è in continuità, la legge permette alcune agevolazioni: i contratti pubblici non sono sciolti automaticamente (possono proseguire), i crediti verso la PA non vengono decurtati (devono essere pagati integralmente, salvo diversi accordi), e i nuovi crediti sorti per la continuità hanno prededuzione. Inoltre, le eventuali perdite fiscali pregresse non si azzerano con l’omologazione (come invece accadeva col fallimento): un’azienda che esce da un concordato in continuità può ancora utilizzare i suoi tax assets secondo certe regole.
Svantaggi / oneri del concordato: – Costi e formalità: c’è da pagare le spese di procedura, il compenso del commissario, eventualmente del liquidatore, gli atti vanno in Gazzetta Ufficiale, ecc. È una procedura onerosa e complessa, che richiede il supporto di consulenti legali e finanziari competenti sin dalla redazione del piano. – Tempistiche: mediamente più lunghe degli strumenti stragiudiziali, perché occorre attendere i termini di voto, le udienze di omologa, gestire eventuali opposizioni o reclami in Corte d’Appello. Ciò può comportare un periodo di incertezza in cui l’impresa è “in concordato” e potrebbe subire lo stigma sul mercato (clienti diffidenti, difficoltà a ottenere credito, etc.), benché sia protetta legalmente dai creditori. – Perdita di autonomia: l’impresa rimane in mano all’imprenditore (non c’è curatore come nel fallimento), però ogni atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice delegato. Inoltre, il commissario vigila e riferisce: se l’imprenditore devia dal piano o compie atti lesivi, ne risponde. In sostanza c’è un regime di controllo giudiziale continuo. – Rischio di esito negativo: se i creditori bocciano la proposta o il tribunale non la omologa (perché non congrua), si finisce quasi certamente in liquidazione giudiziale (fallimento). La presentazione di un concordato è quindi un passo serio: in gergo, “è l’ultima cartuccia”. Non a caso molte imprese tentano prima piani e accordi minori; il concordato è usato quando necessario (anche perché, una volta depositata la domanda, se poi la ritiri senza successo di un’alternativa, il tribunale dichiara il fallimento d’ufficio se sei insolvente: non c’è via di fuga). – Impatto reputazionale: un concordato, specie se liquidatorio, è percepito come un default di fatto. Fornitori e clienti lo vengono a sapere (è pubblicato), gli istituti bancari classificheranno la posizione come “credito deteriorato ristrutturato”, etc. Pur evitando la parola “fallimento”, rimane un’onta per l’azienda. Va però detto che con la cultura odierna e l’aumento dei concordati in continuità, c’è anche chi esce bene da un concordato e riprende a operare.
Alla luce di tutto ciò, quando utilizzare il concordato? Quando l’indebitamento è talmente diffuso o il disaccordo tra creditori è tale che nessun accordo stragiudiziale sarebbe possibile, oppure quando serve anche liberarsi di passività e contratti in modo netto. Se l’azienda ha prospettive di salvataggio (concordato in continuità), allora val la pena perché è uno strumento potente per rinegoziare l’intero debito; se invece l’azienda è decotta, il concordato liquidatorio può essere un mezzo per chiudere dignitosamente evitando le incognite di un fallimento (ad esempio scegliendo personalmente un liquidatore, vendendo i beni a valori più alti di una svendita in fallimento, e magari salvaguardando alcuni asset).
Altri strumenti e soluzioni
Oltre ai principali strumenti già visti, il panorama include anche: – Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO): introdotti in attuazione della Direttiva UE 2019/1023, questi piani (disciplinati dal CCII art. 64-bis, presumibilmente) permettono di sottoporre al giudice un piano di ristrutturazione anche senza il formale accordo di una maggioranza qualificata, se alcune condizioni sono soddisfatte. In pratica è un concordato preventivo “semplificato” in cui il debitore, se ottiene certe adesioni e rispetta il test di miglior soddisfazione, può chiedere l’omologazione di un piano di ristrutturazione senza passare da un vero voto. Questo istituto, per quanto poco applicato finora, mira a casi in cui c’è urgenza e si vuole evitare la trafila del concordato completo. Si può considerare come uno strumento intermedio (da qui il nome PRO), ma in sostanza i suoi effetti sono analoghi a un concordato omologato (vincola tutti). – Accordi di ristrutturazione “ibridi” con piani attestati in esecuzione (art. 56 CCII): il CCII colloca il piano attestato tra gli “strumenti di regolazione della crisi” e ne consente la pubblicazione. C’è un interessante meccanismo per cui un accordo esecutivo di piano attestato può essere pubblicato e, se sottoscritto da creditori oltre 30% e depositato, produce effetti protettivi provvisori (specie sui crediti fiscali, secondo alcune interpretazioni) . Tuttavia, ciò esula da un livello introduttivo ed è materia da specialisti. – Strumenti per il sovraindebitamento (Crisi da sovraindebitamento): se l’azienda debitrice fosse sotto le soglie di fallibilità (es. piccolissima impresa artigiana) o fosse un consumatore/professionista, non potrebbe accedere a concordato o accordi sopra descritti, ma esistono le procedure di composizione della crisi per sovraindebitati: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Non le trattiamo qui in dettaglio perché la domanda è focalizzata su S.r.l./S.p.A. e quindi su procedure maggiori. – Liquidazione giudiziale (ex fallimento): se l’azienda non riesce a risanarsi e i creditori (o il debitore stesso) attivano la procedura di fallimento, si entra nella liquidazione giudiziale disciplinata dal CCII. In questa fase, ormai non difensiva, un curatore nominato dal tribunale liquiderà tutti i beni, distribuirà il ricavato secondo le prelazioni (dipendenti e Fisco avranno la priorità sul ricavato, i chirografari piglieranno l’eventuale resto), e la società verrà cancellata. Dal punto di vista del debitore-imprenditore, l’unica nota “positiva” è l’esdebitazione del fallito: l’imprenditore persona fisica, a fine liquidazione, può chiedere di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti (se ha collaborato lealmente). Ma per una società, l’esdebitazione non è rilevante perché la società cessa di esistere (non c’è persona fisica da liberare dai debiti, salvo poi riflessi su soci garanti). – Stralcio stragiudiziale e rinunce dei creditori: non va dimenticato che molte crisi si risolvono al di fuori di questi strumenti formalizzati. Un debitore può sempre trattare con ciascun creditore per farsi rilasciare una transazione tombale sul debito (es: il fornitore accetta il 50% a saldo e stralcio, la banca allunga il mutuo di 5 anni, ecc.) senza passare per procedure legali. Se tutti i creditori accettano, di fatto hai risolto come in un piano attestato ma senza neanche attestazione. Queste soluzioni “low profile” funzionano quando il numero di creditori è molto basso e c’è fiducia nel debitore. Ovviamente non offrono protezioni: se uno cambia idea può attaccare. Ma sono sempre opzioni da tentare come prima mossa in situazioni circoscritte.
Abbiamo dunque un arsenale completo: dalla prevenzione negoziata (composizione), passando per soluzioni private protette (piano attestato, accordi) fino alle procedure concorsuali giudiziali (concordato e, come ultima risorsa, fallimento/liquidazione). Nel prossimo capitolo vedremo concretamente come un debitore dovrebbe muoversi passo dopo passo, ossia quali strategie e azioni intraprendere di fronte a una situazione di sovraindebitamento.
Cosa fare concretamente: strategie difensive e percorso passo-passo
Dal punto di vista pratico, un imprenditore che si trovi con la “acqua alla gola” deve agire con lucidità e metodo. Ecco un percorso in fasi per difendersi dai debiti aziendali e cercare una via d’uscita sostenibile:
1. Analizzare la situazione finanziaria e giuridica – Il primo passo è fare un check-up dei debiti: quanti sono, verso chi, quali scaduti e da quanto, quali garantiti o privilegiati. Parallelamente, occorre valutare l’andamento aziendale: c’è prospettiva di ripresa (nuovi ordini, taglio costi) o la crisi è irreversibile? Bisogna anche controllare se ci sono procedure in corso: decreti ingiuntivi notificati, atti di pignoramento, istanze di fallimento depositate (magari il socio non lo sa ma un creditore l’ha già chiesto). Questa due diligence consente di classificare i debiti per urgenza e importanza. Ad esempio: debito verso un fornitore critico che minaccia di fermare le forniture è urgentissimo; debito bancario con rata scaduta da 1 mese richiede attenzione ma forse la banca aspetta 90 giorni prima di revocare. Cruciale è verificare se l’azienda è solvibile nel breve: se non riesce a pagare stipendi e fornitori essenziali il prossimo mese, è già insolvente di fatto e servono misure immediate (es. richiedere misure protettive con composizione negoziata o pre-concordato). Valutare anche le garanzie personali: se la situazione precipita, quali beni personali sono esposti? Questo influirà sulle scelte (ad es. se l’imprenditore ha dato ipoteca sulla casa per il debito bancario, avrà interesse a un accordo che salvi anche quell’asset). In questa fase è bene consultare anche un legale per capire eventuali profili di responsabilità già in atto (es: omessi versamenti rilevanti penalmente?).
2. Coinvolgere consulenti esperti – “Non fare da te” è un mantra in queste situazioni. Occorre affidarsi a professionisti specializzati in crisi d’impresa: un dottore commercialista esperto di piani di risanamento, un avvocato societario/fallimentare. Questi soggetti aiuteranno a stimare realisticamente se l’azienda è risanabile o no e a predisporre il piano finanziario. Inoltre, la legge impone che sia nominato un attestatore indipendente per molte soluzioni: conviene coinvolgerlo fin dall’inizio nella predisposizione del piano, così da evitare di scrivere cose irrealistiche (l’attestatore, se chiamato all’ultimo, potrebbe bocciare il piano; se invece è consultato durante, guida la redazione su binari credibili). Molte aziende in crisi sprecano tempo prezioso pensando di poter rimediare internamente: meglio attivare subito un team di crisi (advisor finanziario, legale e magari manager temporaneo per la ristrutturazione). Questo team elaborerà anche la strategia di negoziazione con i creditori.
3. Stabilire un dialogo con i creditori chiave (ma con cautela) – È opportuno appena possibile contattare informalmente i principali creditori per sondare la loro disponibilità a rinegoziare. Spiegare la situazione e prospettare che si sta lavorando a un piano di risanamento serio. Questo può rassicurare e prendere tempo, magari ottenendo accordi a breve termine (es. il fornitore accetta di aspettare 30 giorni in più, la banca concede standstill di 2 mesi). Attenzione: bisogna evitare di fare promesse vuote o ingannare (dire “pagherò tra 10 giorni” senza basi): ciò distrugge la credibilità . Meglio essere trasparenti (“Non posso pagarvi ora, sto cercando soluzione, vi pago intanto una parte se possibile e vi presento un piano entro X”). Alcuni creditori apprezzeranno l’onestà e preferiranno collaborare piuttosto che spingere al fallimento e rischiare di recuperare meno. Va anche valutato di non pagare certi debiti minori per preservare liquidità per quelli essenziali (principio di cassa): es. se ho 10k euro in cassa e devo scegliere tra pagare l’F24 dell’IVA o i salari, probabilmente pago i salari (anche se l’IVA è importante, i dipendenti lo sono di più nell’immediato). Naturalmente ogni scelta di pagamento preferenziale deve poi essere giustificata e protetta (meglio se in un contesto di piano attestato che esenta da revocatoria quell’atto, altrimenti il rischio è di incorrere in revocatoria o bancarotta preferenziale se si finisce in insolvenza).
4. Valutare e attivare strumenti protettivi temporanei – Se la situazione è critica e qualche creditore aggressivo può compromettere tutto (pignorando le merci o bloccando i conti), non esitare a usare la legge come scudo. Ci sono due canali principali: – Composizione negoziata con misure protettive: in pochi giorni si può depositare istanza e ottenere dal tribunale il decreto di protezione. Ci vuole un abbozzo di piano e indicare l’esperto (che sarà nominato). Questo dà all’azienda fino a 4 mesi di tregua per negoziare . – Concordato “in bianco”: se la negoziazione privata appare futile o la crisi è molto avanzata, si può depositare una domanda di concordato con riserva. Anche ciò blocca subito i creditori e dà tempo (in genere 60-120 gg prorogabili) per presentare un piano definitivo. Queste due opzioni non sono esclusive: a volte si sceglie la composizione negoziata come preludio; se fallisce, si passa al concordato. L’importante è non abusarne per mero rinvio: i tribunali oggi sono vigili, se capiscono che un’istanza è fatta solo per prendere tempo senza reale volontà di risanamento, revocano le misure. Però, usate correttamente, sono strumenti salva-azienda: congelano la situazione e permettono di lavorare al piano senza l’incubo del fallimento immediato.
5. Sviluppare un piano di risanamento credibile – Questo è il cuore della difesa: il piano industriale e finanziario. Deve rispondere a due domande: (a) come intendo ristrutturare i debiti? (dilazioni, tagli, conversioni) e (b) come rilancio l’azienda o realizzo valore? (nuovi capitali, cessioni di asset, aumento fatturato, ecc.). Un piano solo finanziario (ad es. “pago il 60% dei debiti in 5 anni”) non è sufficiente: bisogna mostrare da dove vengono i soldi per pagare quel 60%. Potrebbe includere la vendita di un ramo d’azienda, l’ingresso di un socio finanziatore, il recupero crediti verso clienti, l’attivazione di casse integrazioni per abbassare il costo del lavoro, etc. Il piano deve essere accompagnato da proiezioni economico-finanziarie su base almeno triennale, con vari scenari (ottimistico, pessimistico). Qui il contributo dell’advisor aziendale e dell’attestatore è essenziale per tarare ipotesi realistiche. Ad esempio, se l’azienda ha perso il 30% di ricavi negli ultimi 2 anni, prevedere una crescita del +50% l’anno prossimo sembra fantasioso e l’attestatore lo boccerebbe. Meglio ipotizzare vendite stabili o lieve ripresa e basare il risanamento più su taglio costi/nuove finanze. Un capitolo fondamentale del piano deve riguardare il trattamento dei creditori: chi paga e quanto. Occorre rispettare i privilegi (non si può offrire meno ai privilegiati di quanto otterrebbero liquidando le garanzie, se no quelli voteranno contro e il giudice non omologherà neppure) e trattare con particolare riguardo i lavoratori e il Fisco (spesso conviene offrire a dipendenti e Fisco condizioni milgiori degli altri, per ragioni sia etiche che pratiche: i dipendenti perché protetti dal privilegio e fondamentali per la continuità, il Fisco perché oggi con il cram-down può essere superato ma resta un interlocutore istituzionale importante la cui adesione dà peso all’accordo). Nota bene: se si prevede una riduzione di crediti fiscali, contributivi o di grandi enti, è opportuno impostare la proposta secondo le regole della transazione fiscale (offrire almeno il credito privilegiato per intero o motivare perché viene falcidiato, e comunque offrire non meno di quanto ricaverebbe in caso di fallimento) . In parallelo al piano di risanamento, l’azienda dovrebbe implementare subito azioni correttive interne: ad esempio migliorare la contabilità, ridurre sprechi, vendere scorte obsolete per fare cassa. Questi segnali tangibili aiutano anche a convincere attestatore e creditori che l’imprenditore sta facendo sul serio.
6. Scegliere il percorso legale adatto per attuare il piano – Una volta definito cosa fare, occorre definire come formalizzarlo: – Se il piano è fattibile e tutti i principali creditori sono sostanzialmente d’accordo, si può optare per un piano attestato di risanamento: basta far redigere la relazione attestatrice e poi formalizzare accordi bilaterali con ciascuno. Questa via minimizza pubblicità e costi. – Se il piano richiede l’adesione della maggioranza, ma non di tutti, conviene l’accordo di ristrutturazione: raggiungere almeno il 60% (o 30%) di consensi e depositare per omologa. Ad esempio, se 8 creditori su 10 per importo hanno detto sì, è l’ideale. – Se il piano tocca moltissimi creditori o prevede sacrifici che alcuni non accetteranno mai volontariamente (es: pagare i fornitori al 30%), allora serve il concordato preventivo. Idem se serve “pulire” la società da troppi debiti residuali. – Spesso la scelta è obbligata: se la cassa è quasi zero e serve lo stay, si è probabilmente già in concordato (si sarà depositata la domanda e quindi seguita la via concorsuale). Se invece la situazione lo permette, preferire soluzioni meno invasive: ad es. provare accordo di ristrutturazione, tenendo il concordato come back-up. – Non trascurare la combinazione di strumenti: es. si può iniziare in composizione negoziata, e parallelamente predisporre un accordo 182-bis, e depositarlo per omologa se va in porto. Oppure depositare un concordato con riserva e poi convertirlo in accordo omologato se raccogli adesioni nel frattempo. L’ordinamento è abbastanza flessibile su queste conversioni (il fine supremo è evitare il fallimento favorendo qualunque soluzione negoziata, anche in corsa).
7. Esecuzione e monitoraggio del piano – “Paper doesn’t blush” dicono gli inglesi: scrivere un piano è un conto, eseguirlo è ben altro. Una volta ottenuta l’omologazione dell’accordo o del concordato (o semplicemente conclusi tutti gli accordi privati in caso di piano attestato), inizia la fase delicata di implementazione. Dal punto di vista del debitore: – Bisogna rispettare rigorosamente le nuove scadenze di pagamento. Ad esempio, se il piano prevedeva di pagare i fornitori stralciati in 4 rate semestrali, quei pagamenti vanno onorati anche a costo di fare sacrifici, perché un default del piano potrebbe far precipitare di nuovo la situazione ma con meno fiducia dei creditori di prima. – Occorre adempiere agli obblighi informativi: nei concordati in continuità, per legge l’azienda deve presentare report periodici sull’andamento a commissario e tribunale. Anche negli accordi è bene mantenere aggiornati i creditori sull’avanzamento, soprattutto se dipende da eventi futuri (es. vendita di un immobile: tenere informate le banche su come va il processo di vendita). – Se il piano prevede l’ingresso di un nuovo investitore o soci, curare questi passaggi societari (approvazione aumenti di capitale, ecc.) con assistenza notarile/legale tempestiva. – Monitorare il flusso di cassa reale vs quello pianificato. Se noti scostamenti significativi (ad es. vendite più basse del previsto nei primi mesi del concordato), non nascondere la testa sotto la sabbia: attivati subito per misure correttive o per informare il tribunale se necessario. In alcuni casi si può chiedere una modifica del concordato in corso di esecuzione, ma è difficile e serve comunque l’accordo dei creditori. Meglio prevenire aggiungendo magari un cuscinetto di sicurezza nel piano iniziale (un “fondo rischi”). – Mantenere buoni rapporti con i creditori durante l’esecuzione: un creditore soddisfatto al 50% potrà tornare a fare affari con te se vede correttezza; se lo tratti male, anche dopo il concordato potresti perderlo come fornitore.
8. Pianificare scenari alternativi (“piano B”) – Un imprenditore prudente tiene conto che il primo tentativo potrebbe fallire. Ad esempio, se stai puntando tutto su un accordo al 60% e temi che due creditori grossi non aderiranno, preparati all’idea di dover ripiegare su un concordato preventivo. Analogamente, se avvii un concordato in continuità ma l’esercizio peggiora, considera se devi convertirlo in liquidatorio (magari vendendo l’azienda a terzi) prima che sia tardi. Avere un piano B ti fa trovare pronto a difenderti anche nella sventura: ad esempio predisponendo già la documentazione per un eventuale fallimento (per facilitare l’esdebitazione) se vedi che proprio non c’è verso di salvarla. Questo suona pessimista, ma fa parte di una strategia completa.
9. Tutelare il patrimonio residuo e personale – Non ultimo, pensa anche a proteggere i tuoi beni personali legalmente. Se la società ha i giorni contati, valuta con un legale le opzioni lecite: ad esempio, se hai una casa di proprietà su cui la banca vanta ipoteca come garante, potresti trattare con la banca (nel contesto del piano) per limitare l’escussione (magari dandola in pagamento o vendendola tu stesso per chiudere il debito garantito – meglio che subire un’esecuzione forzata). Oppure, se temi una causa di responsabilità, stipula un’assicurazione D&O (responsabilità amministratori) se non l’avevi già: non coprirà dolo, ma magari colpa grave sì. Evita assolutamente di fare atti di sottrazione di beni (tipo intestarli a parenti) in corso di crisi: sarebbero revocabili e potenzialmente fraudolenti. Piuttosto, se la situazione è compromessa anche sul fronte personale, informati sulle procedure di esdebitazione personale (per i debiti non coperti da garanzie reali), come il piano del consumatore o la liquidazione del sovraindebitato, per avere un paracadute finale a livello individuale. Sono discorsi difficili, ma un imprenditore lungimirante li affronta.
Riassumendo, difendersi dai debiti aziendali richiede un mix di azioni tempestive, competenze specialistiche e buona fede negoziale. La legge oggi offre strumenti efficaci, ma vanno usati con preparazione. Nel prossimo capitolo illustreremo un caso pratico di come una società indebitata può evolvere attraverso queste fasi, e successivamente risponderemo alle domande frequenti che molti debitori si pongono in tali frangenti.
Esempio pratico: il caso di Motori Passo-Passo S.r.l.
Per rendere concreti i concetti trattati, immaginiamo un caso ipotetico (ma realistico) ispirato al titolo: Motori Passo-Passo S.r.l. è un’azienda italiana (S.r.l.) che produce piccoli motori elettrici per macchinari industriali. Negli ultimi anni ha subito un calo di ordini e alcuni investimenti sbagliati. Oggi si trova con i seguenti debiti principali: – Banca Alpha: esposizione di €500.000 su un mutuo ipotecario (garanzia su il capannone industriale) e €100.000 su un fido di cassa scoperto. – Banca Beta: €200.000 di mutuo chirografario (senza garanzie reali, ma con fideiussione personale del socio unico Sig. Rossi). – Agenzia delle Entrate-Riscossione: €150.000 in cartelle esattoriali (IVA non versata e ritenute dipendenti di due anni, più sanzioni ed interessi). – INPS: €50.000 di contributi non versati (parte a credito privilegiato). – Fornitori vari: circa €300.000, di cui €50k verso un fornitore di componenti elettronici essenziale (che ha minacciato sospensione consegne), e il resto diluito tra 30 fornitori vari (importi medio-piccoli). – Dipendenti: ha 20 dipendenti, con due mensilità arretrate più TFR maturato (complessivamente €80.000 dovuti). – Altri debiti: un leasing su un macchinario (€30.000 residuo), bollette arretrate €10.000.
L’azienda ha attivi per lo più immobilizzati (capannone valutato ~€600.000, macchinari per €200.000, magazzino merci €100.000) ma scarsa liquidità (in cassa €20.000). Il socio Rossi possiede anche un appartamento a titolo personale (su cui incombe la fideiussione Banca Beta) e vorrebbe salvarlo se possibile.
La situazione è critica: alcuni fornitori hanno già ottenuto decreti ingiuntivi (uno ha pignorato il conto, anche se c’era poco sopra). Banca Beta ha revocato il fido e minaccia di escutere la fideiussione. I dipendenti iniziano a agitarsi perché gli stipendi ritardano. L’azienda però ha ancora ordini e un possibile nuovo contratto con un grosso cliente che potrebbe, tra 6 mesi, risollevarne il fatturato. Inoltre c’è un investitore interessato ad entrare in società rilevando il 50%, a patto che i debiti bancari siano ristrutturati.
Fase 1: Check-up e consulenti. Il Sig. Rossi (socio e amministratore) prende atto che da solo non ce la fa. Ingaggia un commercialista esperto di crisi e un avvocato. Si rendono conto che Motori S.r.l. è tecnicamente insolvente (incapace di pagare regolarmente i debiti). C’è però uno spiraglio di risanamento se si ottiene finanza fresca (dall’investitore) e se i creditori fanno sconti. Decidono di tentare un salvataggio in continuità.
Fase 2: Misure protettive. Dato che i fornitori e Banca Beta sono sul piede di guerra, optano per una Composizione Negoziata. Presentano istanza alla CCIAA: viene nominato un esperto a metà marzo. Contestualmente, il tribunale emette un decreto di sospensione di tutte le azioni esecutive per 4 mesi. Ciò blocca i pignoramenti dei fornitori e impedisce a Banca Beta di avviare l’esecuzione ipotecaria o sul patrimonio di Rossi (temporaneamente). Gli stipendi arretrati però vanno comunque pagati entro 30 giorni o i dipendenti potrebbero chiedere di rompere il blocco per incassarli (il tribunale infatti di solito esclude dalla protezione i crediti per retribuzioni). L’azienda grazie ad un piccolo prestito soci riesce a pagarne almeno una mensilità.
Fase 3: Approccio ai creditori. Con l’aiuto dell’esperto della composizione, Motori S.r.l. convoca un incontro con le due Banche e con il fornitore principale. Si prospetta loro la situazione e la volontà di presentare un piano entro poche settimane. Già sondano le disponibilità: – Banca Alpha, garantita da ipoteca, è disposta a allungare il mutuo magari aggiungendo un anno di preammortamento, ma non ad alcun taglio sul capitale (sa che se si vendesse l’immobile, potrebbe recuperare gran parte dei €500k). Su €100k di fido chirografario, potrebbe accettare uno stralcio ad esempio del 30% (è credito chirografario, la banca rischia di meno in fallimento). – Banca Beta, chirografaria con garanzia personale, si mostra più dura: vorrebbe escutere la fideiussione subito. Tuttavia, di fronte alla prospettiva di un concordato dove prenderebbe il 20%, inizia a trattare: forse accetterebbe l’ingresso dell’investitore in cambio di un pagamento parziale attorno al 50% e la liberazione graduale della fideiussione. – Il fornitore essenziale, vedendo la buona fede e il blocco legale (che gli impedisce di interrompere il contratto, pena risarcimento), concorda di continuare a fornire se l’azienda almeno paga a pronto il nuovo materiale e garantisce un piano di rientro per i €50k arretrati in 6 rate. Si può fare. – Gli altri creditori non vengono interpellati uno per uno ancora, ma tramite una comunicazione generale l’azienda informa di essere in composizione negoziata e chiede pazienza assicurando che riceveranno un piano.
Fase 4: Piano e attestazione. Il team prepara il piano di risanamento. Principali punti: – L’investitore XY entrerà con €300.000 in aumento di capitale, ottenendo il 50% della S.r.l. Questi soldi freschi andranno in parte a pagare debiti, in parte a investimenti per evadere i nuovi ordini. – Il capannone industriale non sarà venduto (serve per continuità), ma la società offre a Banca Alpha di continuare a pagare il mutuo allungandolo di 5 anni (riducendo rata). Per convincerla, il piano prevede che per 2 anni l’investitore conceda un covenant: se Motori non paga le rate, l’investitore le subentra, così la banca è tranquilla. – Banca Beta accetta nel piano di ricevere il 50% (€100k) a saldo del suo credito da mutuo chirografario: €50k li paga subito l’investitore appena entra, gli altri €50k in 24 mesi grazie ai flussi di cassa migliorati. In cambio, libererà la fideiussione di Rossi progressivamente. – I fornitori chirografari vengono divisi in due gruppi: quelli strategici (circa €100k di debiti) saranno pagati al 80% in 12 mesi (per mantenerne la fiducia); gli altri (€150k) sono destinati a ricevere il 40%, dilazionato in 2 anni (questa è la parte più “dura” del piano, ma sono fornitori secondari e in genere in un fallimento prenderebbero forse 10-20%, quindi speriamo accettino). – Il debito fiscale di €150k: qui entra la transazione fiscale. L’azienda propone di pagare integralmente l’IVA e ritenute (che sono crediti privilegiati per ~€100k) ma di stralciare sanzioni e interessi e anche una parte dell’IVA non privilegiata (se c’è, ma di solito IVA è tutto privilegiato come creditore dello Stato). Offrono quindi circa il 70% del totale, in 5 anni, chiedendo alla Agenzia adesione. Con l’attestazione di convenienza (che mostra che in fallimento probabilmente l’erario recupererebbe solo 50% perché casa e beni coprono prima le banche, etc.), confidano che il Fisco possa aderire o comunque il tribunale omologhi lo stesso. – INPS €50k contributi: anche qui, essendo in parte privilegio, si propone pagamento 100% quote lavoratori e 80% su resto, sempre dilazionato. – Dipendenti: il piano prevede di pagare integralmente gli €80k di arretrati (salari e TFR) utilizzando parte dei €300k dell’investitore subito all’omologazione. Inoltre, l’investitore si impegna a mantenere i 20 posti di lavoro. – Si calcola che, con questo taglio e con i nuovi fondi, la società potrà sostenere il debito residuo. L’attestatore verifica: con le nuove commesse attese, il fatturato salirebbe del 20% l’anno prossimo, margine operativo 10%. Emette relazione positiva, evidenziando però che la riuscita dipende dall’adesione del Fisco e dal rispetto dell’aumento di capitale.
Fase 5: Definizione strumento legale. Mentre erano in composizione negoziata, l’azienda inizialmente puntava a fare un accordo di ristrutturazione omologato: hanno infatti ottenuto accordi di massima con Banca Alpha, Beta e col 60% di fornitori per valore (grazie alla distinzione chiave/secondari) – ciò sarebbe sufficiente per l’omologa. Tuttavia, c’è un ostacolo: l’Agenzia delle Entrate non ha ancora risposto positivamente (il tempo è poco) e alcuni fornitori minori, se sapessero di prendere 40%, potrebbero opporsi. Inoltre Banca Beta preferisce la cornice del concordato per avere certezza giuridica della liberazione garanzia. Dopo aver consultato l’esperto e i legali, Motori S.r.l. decide di procedere con un concordato preventivo in continuità sulla base del piano. In tal modo potrà: – Vincolare anche i fornitori che non hanno esplicitamente aderito (tanto raggiungerà la maggioranza per classe: i fornitori strategici votano sì perché prendono 80%, i secondari anche molti di loro voteranno sì perché 40% è meglio che niente). – Ottenere l’omologa anche se il Fisco vota no, grazie al cram-down (il piano offre al Fisco non meno del 70% che è superiore al presumibile realizzo in fallimento, quindi i presupposti di legge ci sono ). – Dare all’investitore maggiore tranquillità: investire in un’azienda che esce pulita da un concordato omologato con tutte le transazioni cristallizzate è più sicuro. – Uscire con i debiti residui azzerati (i creditori chirografari che prendono 40% non potranno più pretendere il resto).
Fase 6: Procedura di concordato. A fine giugno, Motori S.r.l. deposita la domanda di concordato con tutto il piano, avendo già in mano molte lettere di supporto dei creditori. Il tribunale ammette la procedura, nomina un commissario. Nel frattempo la composizione negoziata viene chiusa (l’esperto redige relazione finale segnalando che si è passati a procedura concorsuale). Al voto, a settembre, il concordato riceve: – Classe banche (Alpha e Beta): voto favorevole (Alpha prosegue il mutuo, Beta riscuote la metà subito, conviene). – Classe fornitori strategici: favorevole (80% in 1 anno li soddisfa). – Classe fornitori chirografari comuni: su 30, almeno 20 votano sì perché l’azienda li ha contattati spiegando che se fallisce loro prenderebbero molto meno. Alcuni contrari restano, ma la maggioranza in valore è 65% quindi classe approvata. – Classe Erario/INPS: formalmente hanno voto, Agenzia Entrate vota contrario (politica interna), INPS si astiene. Ma questa classe dissente. – Classe dipendenti (privilegiati): erano interamente soddisfatti nel piano, quindi non avevano diritto di voto (credito privilegiato non modificato se non pagato integralmente non vota). Comunque sono contenti.
Si pone il problema del cram-down fiscale: essendo la classe erario dissenziente, il tribunale valuta i criteri. Dall’attestazione risulta che in liquidazione il Fisco avrebbe preso forse 40%. Qui prende 70%. Inoltre, escludendo il loro voto, c’è comunque una maggioranza trasversale (banche e fornitori) di classi favorevoli. Quindi il tribunale omologa forzosamente il concordato nonostante l’opposizione dell’Agenzia . Emana il decreto di omologa a ottobre.
Fase 7: Esecuzione post-omologa. Come da piano: – L’investitore versa i €300k nel capitale sociale immediatamente. – Con quei fondi, la società paga entro 60 giorni dall’omologa: €80k dipendenti (ora totalmente quietati), €50k a Banca Beta (prima tranche), €30k ai fornitori strategici (una parte subito), €50k ad alcuni fornitori piccoli per raggiungere il 40% di alcuni già in coda, e €20k all’Agenzia Entrate (prima rata). – Nei mesi successivi, con i flussi generati dai nuovi ordini (che grazie all’investitore sono arrivati), la società continua a pagare: altre rate trimestrali ai fornitori, le rate semestrali al Fisco/INPS, e Banca Beta finisce di incassare entro due anni. – Il commissario giudiziale, rimasto come commissario vigilante, riceve report semestrali e verifica i pagamenti. Dopo 2 anni certifica che il piano è adempiuto: i creditori hanno ricevuto quanto dovevano e l’azienda è risanata, con ancora Banca Alpha come unico debito a lungo termine ma sostenibile. – La società è salva: ha mantenuto i dipendenti, i fornitori strategici hanno continuato con lei, e ora opera con il nuovo socio investitore. Il socio originario Rossi ha perso il controllo totalitario (ora 50%), ma ha evitato il fallimento e soprattutto ha salvato il suo appartamento: infatti con Banca Beta aveva concordato che a fronte del pagamento del 50% del debito, la fideiussione sarebbe stata liberata; così la banca ha rinunciato a escutere la garanzia e Rossi mantiene la casa.
Questo esempio mostra come un debitore può “difendersi” efficacemente sfruttando tutti gli strumenti: prima congelando le aggressioni (stay della composizione negoziata), poi negoziando il più possibile (ottenere consensi fondamentali), infine utilizzando la procedura concorsuale per vincolare il resto e dare certezza legale al piano. Naturalmente non sempre la storia finisce così bene: poteva accadere, ad esempio, che l’investitore si tirasse indietro o che i creditori votassero contro. In quel caso l’epilogo sarebbe stato la liquidazione giudiziale, con conseguenze peggiori per tutti (banche avrebbero fatto valere ipoteche, fornitori chirografari quasi zero, dipendenti al Fondo di garanzia INPS, ecc.). Proprio questo scenario negativo è ciò che si cerca di evidenziare per convincere i creditori a sostenere il piano: il confronto con l’alternativa fallimentare è la leva principale in ogni trattativa di ristrutturazione (in gergo, il “best interest test”: dimostrare che la proposta concordataria dà loro almeno quanto – se non di più – di un fallimento) .
Domande frequenti (FAQ)
Infine, rispondiamo ad alcune domande comuni che un imprenditore-debitore potrebbe porsi affrontando queste situazioni:
D: La mia società è piena di debiti e non riesce a pagarli: posso semplicemente chiuderla e aprirne un’altra, lasciando i debiti al vecchio shell?
R: Chiudere una S.r.l. indebitata senza pagare i creditori è molto rischioso e spesso impossibile legalmente. Se tenti di sciogliere e cancellare la società dal Registro Imprese con debiti pendenti, i creditori possono opporsi alla cancellazione e/o chiedere il fallimento entro un anno dalla cancellazione. Inoltre, se trasferisci l’attività (macchinari, clienti) a una nuova società (newco) a prezzo irrisorio per svuotare la vecchia, commetti illecito: tali atti sarebbero revocabili e potenzialmente configurare reati di bancarotta fraudolenta per distrazione. Anche i soci/amministratori potrebbero risponderne personalmente. Insomma, non esiste scappatoia facile: meglio usare gli strumenti di legge per risolvere i debiti. Solo una volta sistemati (o liquidati in procedure concorsuali) potrai ripartire con una nuova azienda senza strascichi.
D: I creditori possono aggredire i beni personali dei soci o amministratori per i debiti sociali?
R: In linea di massima no, se parliamo di società di capitali (S.r.l., S.p.A.), i debiti della società restano a carico solo della società. Fanno eccezione: – Garanzie personali: se hai firmato fideiussioni, certamente il creditore garantirà può attaccare i tuoi beni personali in base a quel contratto, indipendentemente dalla S.r.l. – Debiti tributari con responsabilità solidale: ad esempio, l’IVA incassata e non versata, o le ritenute d’acconto non versate: in alcuni casi l’Erario può ritenere responsabile personalmente l’amministratore (specie se ha commesso violazioni tributarie). Oppure in ambito lavoro, i soci accomandanti oltre soglia diventano illimitatamente responsabili. Ma per S.r.l. pure questo di regola non accade (salvo reati penali, dove però la sanzione è penale e non l’obbligo civile diretto). – Azione dei creditori sociali verso amministratori: se l’amministratore ha aggravato dolosamente il dissesto, dopo fallimento i creditori possono esercitare l’azione di responsabilità (art. 2394 c.c.). Se vinta, l’amministratore deve risarcire danni con il suo patrimonio. Quindi, un socio non garante di solito non rischia i propri beni (perde al massimo il capitale sociale investito). Un amministratore può rischiare in caso di condotte di mala gestione o violazioni di legge.
D: Che succede se non pago gli stipendi o il TFR ai dipendenti?
R: I dipendenti hanno tutele forti. In breve: – Possono dimettersi per giusta causa se non paghi gli stipendi, chiedendo anche l’indennità sostitutiva del preavviso (ulteriore costo per l’azienda). – Possono ottenere un decreto ingiuntivo in pochi giorni e far pignorare i conti aziendali. Hanno privilegio generale sui mobili, quindi se ci sono soldi in cassa, li prendono prima di altri chirografari . – In caso di fallimento dell’azienda, potranno chiedere al Fondo di Garanzia INPS di anticipare loro il TFR e ultime 3 mensilità . L’INPS poi si insinua al posto loro nel fallimento. – Dal punto di vista penale, il mancato pagamento sistematico delle retribuzioni potrebbe, in casi estremi, configurare violazione dell’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) se combinato con altre condotte di sfruttamento. Ma nella normalità, non è un reato specifico (lo è l’omesso versamento contributi > soglia, ma quello colpisce INPS, non il lavoratore). In sintesi, meglio pagare i dipendenti per primi. Se proprio l’azienda non ha risorse, informarli con trasparenza, magari offrendo pagamenti parziali e coinvolgendoli nel piano di risanamento. In un concordato, i crediti per stipendi e TFR devono essere comunque soddisfatti in ampia misura (spesso integralmente o quasi, grazie al privilegio), altrimenti il tribunale non approva.
D: Posso prevedere nel piano di non pagare le cartelle esattoriali o i debiti fiscali?
R: Non pagare nulla al Fisco è generalmente impossibile se vuoi che il piano passi. Le cartelle esattoriali contengono varie voci: imposte, interessi, sanzioni. Le sanzioni tributarie sono chirografarie e spesso nei piani si azzerano (lo Stato accetta di incassare l’imposta e rinunciare alle sanzioni). L’IVA e ritenute invece sono debiti privilegiati per legge: vanno trattati almeno come i privilegiati (di solito pagati al 100% in caso di continuità, o almeno al valore di realizzo in caso di liquidazione). Dal 2020 però si può anche falcidiare l’IVA e i contributi, se dimostri che stai offrendo il massimo sostenibile e comunque non inferiore al ricavabile in caso di fallimento . Questo è il cuore della transazione fiscale. In pratica devi: – Presentare una proposta dettagliata ad Agenzia Entrate e INPS in cui dici: “vi pago questa percentuale in tot anni, perché se fallisco avreste forse meno”. – Se loro aderiscono, bene (diventa come un accordo contrattuale). – Se non aderiscono, in concordato il tribunale può fregarsene del loro no e omologare lo stesso (cram-down) . Negli accordi di ristrutturazione invece se il Fisco dice no devi avere almeno il 30-40% di pagamento assicurato e l’accordo con tutti gli altri creditori per forzare comunque l’omologa . – In un piano attestato puro, se il Fisco non sta ai patti, non puoi fare molto: dovresti allora passare a un accordo 182-bis o concordato. Quindi, risposta: puoi certamente proporre un forte sconto/stralcio sulle cartelle, ma devi seguire la procedura di transazione fiscale e convincere il giudice che il Fisco non ci rimette rispetto ad altri scenari. Non pagare affatto il Fisco raramente è fattibile, a meno che in fallimento non avrebbe zero (ma se hai beni, qualcosa avrebbe). Quindi prepara a dare comunque una fetta al creditore erariale.
D: Quanto dura un concordato preventivo? Durante questo periodo posso continuare a gestire l’azienda?
R: La durata varia molto a seconda della complessità: può durare pochi mesi (6-9 mesi) se è un concordato semplice e c’è accordo dei creditori, o trascinarsi 1-2 anni se ci sono opposizioni o vendite di beni complesse. In media, diciamo che dall’ammissione all’omologa passano 6-12 mesi. L’esecuzione del piano poi può durare anni (alcuni pagamenti ai creditori si protraggono per 5 anni, ma quella è fase di adempimento). Durante la procedura, resti alla guida dell’azienda come debitor in possession, però sotto osservazione. Puoi compiere atti di ordinaria amministrazione liberamente (continuare la produzione, vendere i prodotti correnti, acquistare scorte normali), mentre per atti straordinari (vendere un immobile, accendere un nuovo mutuo, cedere quote) devi chiedere l’autorizzazione al giudice delegato. Il commissario giudiziale deve vigilare su eventuali abusi. Ma se la domanda è: posso continuare l’attività durante il concordato? – la risposta è sì, specialmente nel concordato in continuità è proprio previsto che l’impresa prosegua (anzi, se smetti di operare, verrebbe meno la base del piano). Certo, dovrai magari affrontare la diffidenza di clienti/fornitori sapendo che sei “in concordato”, ma legalmente puoi operare, stipulare contratti (salvo doverli eventualmente validare dal GD). Inoltre, i debiti che sorgono durante il concordato per forniture, consulenze, ecc. sono prededucibili: ciò significa che, se poi fallissi, questi verranno pagati prima di altri debiti concorsuali, quindi i fornitori potrebbero ancora fornirti merce dietro garanzia di prededuzione (anche se molti lo faranno solo dietro pagamento anticipato per prudenza). Insomma, si va avanti, magari a regime ridotto, ma si va avanti.
D: Che differenza c’è tra fallimento (liquidazione giudiziale) e liquidazione volontaria della società?
R: La liquidazione volontaria (ex art. 2484 c.c. per S.r.l.) è quando i soci decidono di sciogliere la società e nominano un liquidatore che paga i debiti con il patrimonio e poi distribuisce l’eventuale attivo residuo. Funziona se la società è solvibile (attivo ≥ passivo): in tal caso il liquidatore può pagare tutti i creditori e chiudere. Ma se la società è insolvente (passivo > attivo, o comunque non ha liquidità per pagare tutti), allora quella liquidazione ordinaria non può completarsi regolarmente: il liquidatore deve valutare di chiedere il fallimento. La liquidazione giudiziale (fallimento) invece è forzosa: la chiede un creditore o l’azienda stessa quando c’è insolvenza conclamata. Un curatore prende in mano l’azienda, la spossessa dei beni e li vende per distribuire il ricavato secondo i gradi di privilegio. A differenza della volontaria, quella giudiziale comporta conseguenze afflittive: ad esempio, gli amministratori possono subire inabilitazioni, i crediti verso la società vengono accertati in un procedimento formale (stato passivo), e come detto eventuali atti precedenti sospetti possono essere revocati (es. pagamenti preferenziali fatti negli ultimi 6 mesi). Quindi, liquidare volontariamente una S.r.l. con debiti funziona solo se quei debiti vengono saldati integralmente; se non è così, in genere la volontaria si interrompe e subentra il fallimento. In pratica per un debitore, la differenza sostanziale è che col fallimento perde il controllo totale e subisce possibili azioni di responsabilità, mentre con la liquidazione volontaria se riuscisse a pagare tutti i debiti, sarebbe una chiusura ordinata senza stigma (ma ripetiamo, se poteva pagare tutti i debiti non era veramente insolvente e non staremmo parlando di “difendersi”…).
D: La mia azienda è piccola, posso evitare di passare dal tribunale anche se ho debiti?
R: Se l’azienda è minore (ricavi < €200k, debiti < €500k, attivo < €300k, come parametri ex L.Fall.), allora non è soggetta a fallimento né a concordato preventivo ordinario: rientra nel sovraindebitamento. In tal caso esistono procedure semplificate presso il Tribunale: il concordato minore (simile al preventivo, ma più snello e con percentuali ridotte) o il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore/professionista o la liquidazione controllata (ex liquidazione del sovraindebitato). Anche queste però passano dal giudice, tranne l’accordo stragiudiziale semplice che però, di nuovo, se i creditori non sono tutti d’accordo non risolve definitivamente. Quindi, davvero, fuori dal tribunale si può stare solo se si trovano soluzioni amichevoli con tutti. Non c’è una soglia minima di debito sotto la quale i creditori non possono fare nulla: anche per 50k € di debiti un creditore può chieder il fallimento di una S.r.l. se vede comportamenti irregolari. La composizione negoziata si applica anche a piccole imprese (persino sotto soglia). Quindi la dimensione ridotta non dà immunità; semmai dà accesso a procedure dedicate (pensate per evitare eccessivi costi alle micro imprese).
D: Quali sono i costi di queste procedure? Mi conviene pagarli o aspetto che qualcuno mi porti i libri in tribunale?
R: Certamente attivare una procedura concorsuale o un accordo ha dei costi: compensi per l’attestatore, per i professionisti che redigono il piano, contributo unificato per il tribunale, e poi l’eventuale commissario/curatore da pagare. Nel concordato, il debitore paga queste spese in prededuzione (cioè le incorpora nel piano). Potremmo quantificare grossolanamente: per una piccola-media impresa, l’attestatore prende magari €10-20k, il legale e consulente altra cifra analoga, il commissario giudiziale qualche migliaio a decina a seconda della massa attiva. Complessivamente un concordato può costare decine di migliaia di euro. Un accordo 182-bis un po’ meno forse (niente commissario, ma attestatore comunque sì). Tuttavia, aspettare il fallimento passivamente è peggio: nel fallimento il curatore liquiderà e anche lì si pagano spese (sottratte ai creditori), e in più perdi il controllo e subisci possibili guai (revocatorie, azioni di responsabilità, interdizioni). Insomma, se c’è qualche chance di salvare o comporre, investire nei costi di una procedura guidata conviene. È come una operazione chirurgica: costa e fa male, ma può guarirti, mentre non operarsi porta alla morte certa dell’azienda. Inoltre, in molte procedure i professionisti accettano parte del compenso a success fee (ad esempio l’attestatore magari prende un anticipo e il resto lo esige solo a omologa avvenuta, in prededuzione). Ci sono anche esenzioni fiscali: l’omologa di concordati e accordi è esente da imposta di registro e bollo, quindi qualche risparmio c’è. Vale la pena ricordare che il nuovo codice ha predisposto anche incentivi (ad esempio, priorità nei crediti d’imposta per chi finanzia concordati in continuità, ecc.), come segnale che queste procedure sono da privilegiare rispetto al default disordinato.
D: Cosa rischio dal punto di vista penale se la mia azienda fallisce?
R: Se la tua azienda finisce in liquidazione giudiziale (fallimento), l’autorità controllerà la tua condotta precedente. I reati tipici sono: – Bancarotta fraudolenta: se hai distratto beni, sottratto merci, pagato preferenzialmente qualche creditore prima del fallimento (favorendolo in danno degli altri), o falsificato le scritture contabili per coprire buchi, potresti essere perseguito. È un reato grave (pena anche > 5 anni nei casi peggiori). – Bancarotta semplice: se sei stato solo molto imprudente (es. hai aggravato i debiti con spese personali, o non hai tenuto la contabilità), potresti avere una condanna minore (reato contravvenzionale). – Reati fiscali: il fallimento spesso porta alla luce omissioni fiscali; se rientrano nelle soglie di punibilità, la curatela le segnala alla Procura (quindi occhio a IVA e ritenute non versate degli ultimi anni). – Altri: false comunicazioni sociali se bilanci erano mendaci, ecc. Ora, se tu hai seguito procedure di risanamento (concordato, accordo, piano attestato), hai una grande esimente: come spiegato, l’art. 324 CCII non punisce gli atti compiuti in esecuzione di quei piani, anche se sarebbero bancarottieri. Cioè pagare un fornitore strategico prima di altri, se l’hai fatto sotto un piano attestato o accordo omologato, non è bancarotta preferenziale. Continuare l’attività benché insolvente, se era nel tentativo di attuare un concordato poi omologato, non è bancarotta semplice. Questa è una protezione notevole per chi agisce in buona fede per risanare. Ovviamente, se usi il concordato come paravento per fregare i creditori, quello scudo salta e vieni perseguito per bancarotta fraudolenta aggravata dal concordato. Dunque il miglior consiglio per ridurre il rischio penale è seguire le regole concorsuali: niente giochetti di occultare attivo o creare creditori fittizi; presentare informazioni veritiere; e se vedi che il concordato non regge, non cercare espedienti illegali, ma semmai converti in liquidazione (dove magari la bancarotta sarebbe solo semplice e pure esdebitabile). In sintesi: la legge non criminalizza chi prova a salvare l’azienda onestamente; anzi, lo tutela. Ma sanziona severamente chi, in crisi, fa il furbo distruggendo garanzie ai creditori.
Tabelle riepilogative
Per concludere questa guida, proponiamo due tabelle di riepilogo: una sul trattamento dei diversi tipi di debito nelle procedure concorsuali; l’altra sui pro e contro dal punto di vista del debitore dei vari strumenti difensivi.
Tabella 2: Destino delle principali categorie di debito nelle procedure (prospettiva del debitore)
| Categoria di debito | Azioni difensive possibili | Trattamento in procedura concorsuale | Note |
|---|---|---|---|
| Debiti fiscali (Erario) | – Rateizzazione amministrativa (se importi contenuti e condizioni regolari)<br>– Transazione fiscale in accordo o concordato, con proposta di stralcio parziale <br>– Pagamento integrale di IVA/ritenute privilegiate per evitare opposizioni<br>– Richiesta di cram-down (omologazione forzata) se Fisco dissente ma offerta ≥ scenario liquidatorio | – Concordato: Crediti con privilegio fiscale vanno soddisfatti almeno quanto il valore di realizzo dei beni (spesso 100% se continuità); crediti chirografari (es. sanzioni) equiparati agli altri chirografari.<br>– Accordo ristrutt.: occorre adesione Agenzia Entrate salvo soddisfo ≥ 30-40% e accordo con altri creditori ; omologabile nonostante dissenso se tutti gli altri ok.<br>– Liquidazione fall.: Crediti privilegiati partecipano al riparto preferenziale (dopo i lavoratori); crediti chirografari ricevono poco o nulla. | * Attenzione: Omessi versamenti IVA/ritenute possono comportare reati penali se > soglie. L’inclusione in un piano concordatario non cancella il reato già commesso, ma l’adempimento può evitare condanne (es. pagamento integrale IVA entro termini definibili causa di non punibilità ex art. 13 DLgs 74/2000, se ancora applicabile). |
| Debiti contributivi (INPS) | – Simile ai fiscali: possibile transazione contributiva con falcidia interessi/sanzioni.<br>– Rateazioni dirette con INPS se ammesse.<br>– Focus su evitare incriminazioni per omesso versamento contributi (sopra €10k annui è reato contravvenzionale): consigliato versare almeno quota dipendenti. | – Concordato: Crediti previdenziali trattati come fiscali: possibile falcidia ma non inferiore a quota di realizzo. INPS in genere segue esito Agenzia Entrate.<br>– Accordo: inclusi nella transazione fiscale art. 63 CCII, stesse regole (adesione necessaria o cram-down se altre adesioni e ≥ soglia).<br>– Fallimento: Credito privilegiato (contributi lavoratori) anticipato dal Fondo di garanzia INPS poi surrogato; contributi ordinari privilegio generale. | * INPS può essere rigido su contributi: storicamente meno incline a stralci consistenti. Importante dimostrare convenienza piano rispetto a liquidazione. |
| Debiti verso banche | – Moratorie/standstill: negoziare sospensioni temporanee dei pagamenti.<br>– Rinegoziazione: piani di rientro, allungamento scadenze, riduzione tassi.<br>– Conversione debito in capitale (debt-equity swap) se banca disponibile a diventare socia (raro in Italia).<br>– In caso di garanzie personali: includere clausole liberatorie nel piano a fronte di pagamento parziale. | – Concordato: Banche finanziarie spesso in classe separata; se garantite da ipoteca/pegno sono creditori privilegiati e da soddisfare almeno quanto valore garanzia (possono scegliere di escutere garanzia fuori concordato se non soddisfatti completamente). Se chirografarie, subiscono falcidia come altri chirografari.<br>– Accordo: se maggioranza di banche aderisce (75%), accordo esteso a tutte ex art. 61 CCII. Possibile trattamento differenziato (spesso banche ottengono percentuali migliori dei fornitori in virtù di garanzie o negoziazione).<br>– Fallimento: Banche ipotecarie: soddisfazione privilegiata sul ricavato beni ipotecati (di solito integrale se valore sufficiente). Banche chirografarie: code e scarsi recuperi. | * Segnalazioni Centrale Rischi: in accordo o concordato, la posizione viene segnalata come “ristrutturata”, salvando parzialmente rating rispetto a un sofferto o incaglio pesante. * Leasing: in concordato, debitore può decidere se sciogliersi dal leasing (lasciando bene al leasing e pagando eventuale differenza come chirografario) o proseguirlo (pagando canoni come costi prededucibili). |
| Debiti verso fornitori (trade) | – Negoziazione individuale: saldo e stralcio (es. pagare 30% entro breve, a saldo del dovuto).<br>– Conferma forniture future: offerta di pagamento parziale del vecchio debito in cambio di continuazione rapporti (spesso fornitori strategici accettano meglio se mantengono il cliente).<br>– Garanzie: eventualmente offrire garanzie (pegni su crediti futuri, ecc.) su nuovi termini per rassicurare.<br>– Consolidamento debiti di fornitori minori con finanziamento bancario (es. fido per pagare piccoli creditori in toto, poi fido ristrutturato a lungo termine). | – Concordato: Fornitori chirografari saranno in genere la classe più numerosa e subiscono la % di soddisfo prevista dal piano (minimo 20% se liquidatorio). Fornitori essenziali potrebbero essere pagati in prededuzione (con autorizzazione) se funzionali a continuità, oppure possono avere classi separate con trattamento migliorativo.<br>– Accordo: Solitamente, per evitare opposizioni, i fornitori estranei devono essere pagati integralmente o comunque nei termini contrattuali (nell’accordo agevolato non puoi posticiparli oltre 120 gg). Fornitori chiave spesso aderiscono in cambio di parziale soddisfo + mantenimento commessa.<br>– Fallimento: Fornitori chirografari incassano pro-quota coi restanti chirografari (spesso molto bassa). Fornitori con riserva di proprietà su beni forniti possono rivendicarli (diritto di separazione) se rispettati i requisiti. | * Considerare l’effetto di fornitura interrotta: Legge vieta ai fornitori energetici/telecom di sospendere forniture per morosità pregressa se l’azienda è in concordato e ne chiede la continuazione (art. 95 CCII), salvo garanzia pagamenti correnti. Per altri fornitori non c’è obbligo di continuare, ma in composizione negoziata l’esperto può convincerli mostrando prospettive. |
| Debiti verso dipendenti | – Tentare di pagarli prima o contestualmente all’apertura di procedure (magari con finanziamento dedicato) per evitare contenziosi.<br>– Includere nel piano l’integrale pagamento di retribuzioni arretrate e TFR o comunque la % massima possibile (spesso richiesta 100% a meno di dissenso lavoratori non opposti).<br>– Usare ammortizzatori sociali (es. CIGS per crisi) per ridurre costi futuri e ottenere liquidità (Fondo di Tesoreria INPS rimborsa TFR maturando se in CIGS lunga). | – Concordato: Crediti da lavoro per retribuzioni maturate negli ultimi 2 anni e TFR vantano privilegio generale superprivilegiato (2751-bis c.c.) e devono essere pagati integralmente salvo incapienza grave. Si può chiedere di dilazionarli (max 6 mesi dal decreto di omologa per legge ). Crediti oltre privilegio (es. parte eccedente tetti) trattati come chirografari ma spesso conviene comunque soddisfarli in alta percentuale.<br>– Accordo: in pratica, difficilmente un accordo passa se non prevede pagamento integrale o quasi dei lavoratori estranei. Spesso li si paga a parte e non li si include nell’accordo (così da non doverne dilazionare il pagamento).<br>– Fallimento: Ultime 3 mensilità e TFR pagate dal Fondo di Garanzia INPS (entro massimali); altri crediti di lavoro privilegiati soddisfatti in prededuzione sui riparti (di solito integrali o alta % perché vengono subito dopo spese di giustizia e crediti ipotecari). | * In concordato in continuità, i debiti per stipendio maturati durante la procedura sono prededucibili e vanno pagati regolarmente; se il piano li differisce > un certo limite rischia di non essere omologato. * Mantenere un buon clima col personale è cruciale per la riuscita del risanamento: coinvolgerli con trasparenza può evitare scioperi o fughe di talenti in un momento critico. |
Tabella 3: Vantaggi e svantaggi dal punto di vista del debitore dei diversi strumenti
| Strumento | Vantaggi per il debitore | Svantaggi / Rischi |
|---|---|---|
| Composizione negoziata | – Riservatezza iniziale (no stigma pubblico immediato).<br>– Possibilità di ottenere uno standstill legale delle azioni esecutive senza dichiararsi fallito .<br>– Mantiene il controllo dell’azienda in mano all’imprenditore (con affiancamento esperto, non spossessamento).<br>– Può sfociare in qualunque soluzione (piano, accordo, concordato) dandoti flessibilità.<br>– Supporto di un esperto terzo che aiuta la negoziazione. | – Non vincola i creditori dissenzienti: se uno importante non vuole trattare, può sabotare il processo (a meno di misure protettive temporanee).<br>– Durata limitata (massimo 6-8 mesi): se non risolvi entro, rischi aggravamento.<br>– Comunque onerosa: devi predisporre informazioni dettagliate, e le trattative richiedono impegno intenso.<br>– In caso di insuccesso, può emergere la situazione di crisi ai creditori peggiorando la fiducia. (Tuttavia, le comunicazioni sono riservate salvo necessità di misure protettive che implicano pubblicazione). |
| Piano attestato di risanamento | – Strumento veloce e flessibile: nessun passaggio in tribunale, contenuti plasmabili su misura del caso.<br>– Riservato (nessuna pubblicità obbligatoria): gestisci crisi fuori dai riflettori.<br>– Consente di immunizzare atti essenziali (pagamenti, garanzie) da revocatoria se piano serio.<br>– Protegge penalmente da reati di bancarotta semplice/preferenziale per gli atti esecutivi del piano.<br>– Mantenimento integrale del controllo in mano al debitore. | – Nessuna forzatura: serve l’accordo pressoché totale dei creditori rilevanti, altrimenti un solo dissenziente può far fallire il piano.<br>– Nessun automatic stay: i creditori possono comunque agire (salvo accordi di moratoria).<br>– Attestatore necessario: va trovato un professionista di qualità; un’attestazione negativa affossa il piano.<br>– Se il piano poi non funziona e l’azienda fallisce, c’è il rischio che atti compiuti siano revocati se il giudice li giudica parte di un piano manifestamente inidoneo (danno reputazionale e giuridico).<br>– Alcuni creditori (specie pubblici) sono diffidenti verso piani non omologati, quindi potrebbero non aderire preferendo la formalità del tribunale. |
| Accordo di ristrutturazione (60%-30% crediti) | – Maggiore efficacia legale: con l’omologazione, l’accordo acquista stabilità e resistenza ad impugnazioni (salvo opposizioni limitate).<br>– Coinvolgimento parziale: non serve convincere il 100% dei creditori, basta la maggioranza qualificata (60% o 30% agevolato), e gli altri se non li puoi falcidiare li paghi.<br>– Procedura relativamente rapida e discreta: atti depositati in tribunale ma non c’è fase di voto estesa; il decreto di omologa arriva di solito prima di un concordato.<br>– Meno costoso di un concordato: niente commissario, meno formalità (ma attestazione e legali sì).<br>– Personalizzabile: puoi modulare trattamenti diversi a creditori diversi purché aderenti (in concordato devi rispettare parità all’interno classi).<br>– Se ben costruito, permette di rifinanziare l’impresa con nuovi crediti (che vedranno l’azienda ripulita dopo omologa). | – Se non raggiungi il quorum di adesione l’accordo salta: richiede comunque notevoli capacità negoziali.<br>– Creditori estranei: devi disporre della liquidità per soddisfarli regolarmente (specie in accordo agevolato senza 120gg di moratoria), altrimenti faranno opposizione o attiveranno azioni subito dopo omologa.<br>– Pubblicità: la presentazione dell’accordo viene iscritta al Registro Imprese, quindi i mercati lo sapranno (anche se meno eclatante di un concordato, comunque la notizia circola).<br>– I creditori possono fare opposizione in omologa (entro 30 giorni): se accolta, rischi di perdere tempo e dover convertire in concordato o fallimento.<br>– Non blocca automaticamente azioni esecutive prima del deposito: puoi chiedere misure protettive, ma se un creditore aggressivo ti pignora prima che il tribunale le conceda, quell’azione potrebbe complicare le cose. |
| Accordo ad efficacia estesa (75% categoria) | – Permette di superare resistenze di minoranza in categorie omogenee (es. banche) e quindi evitare il concordato se tutto ruota intorno a quel gruppo creditori.<br>– Vantaggi simili all’accordo ordinario in termini di rapidità e flessibilità, con in più il fatto che vincola tutti di quella categoria. | – Limitato a categorie specifiche e condizioni rigorose (non si applica a creditori lavoratori o erario).<br>– Richiede soglia alta (75%): bisogna comunque persuadere gran parte dei creditori finanziari.<br>– I creditori “forzati” potrebbero impugnare per contestare la loro omogeneità di categoria o la convenienza per loro (contentious). |
| Concordato preventivo | – Coinvolgimento universale: tutti i creditori (tranne esclusi ex lege come fiscali per sanzioni) sono dentro, quindi una volta omologato sei “pulito” dai debiti residui (società li vede estinti per novazione/adempimento del piano).<br>– Imposizione a dissenzienti: con adeguate maggioranze e garanzie di legge, vincoli anche chi non vuole (coazione legale).<br>– Stay e respiro immediato: appena ammesso, blocca le esecuzioni e ingiunzioni, permettendo all’azienda di evitare il collasso da aggressioni individuali.<br>– Strumenti aggiuntivi: possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili autorizzati, di sciogliersi da contratti sfavorevoli, di cedere beni liberi da pesi con autorizzazione, ecc., tutte opportunità che aiutano il risanamento.<br>– Cram-down fiscale e interclassi: oggi il debitore può persino vincere l’opposizione del Fisco o di classi minoritarie se tratta equamente e offre almeno il “netto fallimentare” .<br>– Se in continuità, salvi l’azienda e i posti di lavoro; se liquidatorio, chiudi la vicenda più ordinatamente che in fallimento (creditori accettano il piano, niente istanze di fallimento in giro). | – Procedura lunga, costosa e complessa: richiede notevole impegno documentale, un piano dettagliato, spese legali e amministrative, e tempi giudiziari (durante i quali l’impresa è sotto vigilanza e reputationalmente esposta).<br>– Perdita di controllo parziale: decisioni importanti soggette ad autorizzazione, presenza di commissario che riferisce ai giudici, assemblee dei creditori da gestire, ecc.<br>– Esito incerto fino all’ultimo: se la votazione va male o un’opposizione viene accolta, rischi il fallimento d’ufficio (ex art. 121 CCII).<br>– Pubblicità negativa: la notizia del concordato è pubblica e può creare sfiducia in clienti, fornitori, banche (anche se c’è da dire che oramai molti lo vedono come tentativo di salvataggio più dignitoso del fallimento).<br>– Vincoli di legge stringenti: es. soglia 20% chirografari se liquidatorio, divieto di alterare ordine privilegi (salvo consenso), obbligo di non discriminazione ingiustificata tra creditori di pari grado, ecc., il che toglie un po’ di libertà rispetto a un accordo privato.<br>– Impone spesso sacrifici imprenditoriali: ad esempio ingresso di nuovi soci, perdita di parte del controllo, cessione di beni di famiglia per apporti, ecc., come contropartita per convincere creditori su un piano di rientro credibile. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | – (Nessun vantaggio strategico, è il “non scegliere” e subire). Se proprio un “vantaggio” c’è: solleva l’imprenditore dalla gestione, pensa a tutto il curatore; e a fine procedura la persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti non pagati, avendo così un fresh start personale. | – L’imprenditore perde l’azienda, i soci perdono il capitale, i dipendenti il lavoro (salvo esercizio provvisorio rado).<br>– Conseguenze negative: interdizioni legali per l’imprenditore, possibile segnalazione alla Centrale Rischi come soggetto fallito (affidabilità creditizia azzerata).<br>– Spesso i creditori ottengono meno rispetto a un concordato ben congegnato (a causa di costi di procedura più alti, tempi lunghi, forzata vendita a prezzi ribassati).<br>– Possibili azioni di responsabilità o penali verso amministratori e soci, come spiegato. In pratica, è l’ultima spiaggia da evitare se esistono alternative praticabili. |
Nota: Ogni situazione è unica. Le tabelle sopra semplificano casistiche generali; in pratica, la scelta dello strumento e il suo esito dipendono da numerosi fattori specifici (settore di attività, composizione del debito, presenza di asset finanziabili, atteggiamento dei creditori, ecc.). L’approccio difensivo del debitore deve quindi essere personalizzato con l’assistenza di professionisti qualificati e aggiornati.
Fonti (normativa, giurisprudenza e dottrina)
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, e successive modifiche (D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 – primo correttivo; D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 – adeguamento direttiva UE 1023/2019; D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 – “correttivo ter”). Testo normativo principale che disciplina piani attestati (art. 56), accordi di ristrutturazione (artt. 57-64), concordato preventivo (artt. 84-120), composizione negoziata (artt. 17-25 quinquies) e liquidazione giudiziale (artt. 121-270), oltre alle esenzioni da reati fallimentari (art. 324) e falso in attestazioni (art. 342). Entrato in vigore il 15 luglio 2022, con successive integrazioni nel 2024.
- Monardo G., Piano Attestato di Risanamento: Come Funziona – La Guida, Studio Monardo (avvocaticartellesattoriali.com), aggiornata ad aprile 2025. Guida approfondita allo strumento del piano attestato ex art. 56 CCII, con spiegazione di finalità, requisiti, effetti protettivi (esenzione da revocatoria, esoneri penali) e confronto con altri istituti. Include riferimenti giurisprudenziali di Cassazione: ad es. Cass. 5 luglio 2016 n. 13719 che nega esenzione automatica se piano inidoneo; Cass. 25 marzo 2022 n. 9743 che conferma il principio; Cass. 30 gennaio 2020 n. 3018 (principio analogo). Illustra inoltre Cass. pen. 17 nov 2023 n. 36401 sull’obbligo di veridicità dell’attestatore e Trib. Milano 6 marzo 2020 (caso Sirti) sulle responsabilità penali dell’attestatore. Utile per comprendere il ruolo chiave dell’attestatore e i limiti dell’istituto.
- Monardo G., Accordo di Ristrutturazione del Debito con le Banche: Cosa Sapere, Studio Monardo, maggio 2025. Analisi completa sugli accordi ex artt. 57 ss. CCII con focus sui crediti bancari. Spiega i diversi tipi di accordo (ordinario 60%, agevolato 30%, efficacia estesa 75%), gli effetti dell’omologazione e i rapporti con le altre procedure. Aggiornata alle novità CCII e allineata alla direttiva UE, con cenni alla transazione fiscale in tali accordi. Include simulazioni pratiche e FAQ, con indicazioni su come trattare con più banche e gli effetti su garanzie e segnalazioni. Fonte preziosa per strategie difensive verso banche e intermediari.
- Monardo G., Composizione Negoziata Crisi d’Impresa: La Guida (novità 2024–2025), Studio Monardo, maggio 2025 . Rassegna delle modifiche normative e giurisprudenziali riguardanti la composizione negoziata introdotta nel 2021. Descrive il funzionamento dello strumento (volontario, con esperto nominato, misure protettive) e segnala le innovazioni del correttivo 2024: eliminazione condizioni ostative come istanza di fallimento pendente, potenziamento utilizzo (allerta interna estesa ai revisori), possibilità di transazione fiscale anche nel contesto negoziato . Utile per capire come gestire la fase precoce della crisi e il raccordo con le procedure formali.
- Monardo G., Debiti verso personale dipendente e TFR: come gestirli, Studio Monardo, luglio 2025 . Approfondimento specialistico sulla tutela del lavoro in situazioni di crisi. Cita l’art. 2751-bis c.c. che attribuisce privilegio generale a retribuzioni e TFR , spiegando che in procedure concorsuali i dipendenti sono soddisfatti prima degli altri chirografari. Illustra obblighi del datore (tracciabilità pagamenti stipendi, versamento contributi) e strumenti come il Fondo di Garanzia INPS . Fornisce consigli pratici (agire subito, non promettere invano) . Rileva pronunce come Corte d’Appello Milano 2021 sull’obbligo del Fondo di pagare integralmente il TFR anche se in concordato . Fonte per il debitore per comprendere perché privilegiare i lavoratori e le conseguenze di inadempimenti retributivi.
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 22 luglio 2024 n. 20036, in Unijuris – Osservatorio Giurisprudenza Fallimentare . Sentenza delle Sezioni Unite che affronta il tema della giurisdizione sulle azioni di risarcimento danni contro l’Agenzia delle Entrate per mancata adesione a transazione fiscale nel concordato. Ha stabilito che tali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (non tributario) . Rilevante indirettamente per noi come conferma del quadro normativo sul cram-down fiscale: il fatto stesso che si ponga la questione indica come sia possibile omologare nonostante il voto negativo del Fisco, e come eventuali comportamenti pregiudizievoli del Fisco verso il debitore rientrino nell’alveo civilistico ordinario.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2024 n. 27782, in Unijuris . Pronuncia che conferma la possibilità per il tribunale di omologare un concordato preventivo anche in caso di voto negativo dell’Amministrazione finanziaria, ove ne ricorrano i presupposti (convenienza del piano per l’Erario e maggioranze trasversali). Si sottolinea che non è necessaria l’astensione del Fisco, potendosi procedere all’omologa forzata pure dopo un voto contrario . Questo avalla la disciplina del cram-down fiscale introdotta prima dal DL 137/2020 Ristori e confermata nel CCII (art. 88 e 112) . Un riferimento giurisprudenziale recente e autorevole a sostegno di quanto esposto in materia di transazione fiscale.
- Cass. penale, Sez. V, 17 novembre 2023 n. 36401, richiamata in Monardo, Piano attestato – Profili penali. Sentenza penale che ribadisce l’obbligo dell’attestatore di svolgere la prestazione con professionalità e completezza, equiparando l’omissione informativa al falso ideologico. Anche se riferita a un caso di concordato, il principio è esteso ai piani attestati come “monito”. Ciò evidenzia le responsabilità penali dell’attestatore ai sensi dell’art. 342 CCII e funge da garanzia indiretta per i creditori sulla veridicità dei piani.
- Unioncamere, Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali, ed. dicembre 2023, pubblicata su unioncamere.gov.it . Documento istituzionale che riepiloga in ottica pratica gli adempimenti al Registro Imprese nelle varie procedure (compresa la composizione negoziata). Utile per aspetti formali (es. iscrizione del provvedimento di omologa di concordato/accordo nel Registro, effetti pubblicitari). Indirettamente rilevante per capire i passi burocratici e i tempi (ad es. decorrenza termini opposizione da iscrizione decreto omologa).
La tua azienda che progetta, produce o distribuisce motori passo-passo, motori stepper 2–3 fasi, motori ibridi, motori con elettronica integrata, driver per motori passo-passo, sistemi di posizionamento e soluzioni per automazione si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che progetta, produce o distribuisce motori passo-passo, motori stepper 2–3 fasi, motori ibridi, motori con elettronica integrata, driver per motori passo-passo, sistemi di posizionamento e soluzioni per automazione si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori, leasing o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, sospensioni delle forniture o minacce di pignoramento?
Il settore dei motori passo-passo è altamente tecnico: richiede avvolgimenti precisi, magneti, lamierini, elettronica di controllo, driver, collaudi, firmware, approvvigionamenti dall’estero e magazzino strutturato.
È sufficiente un rallentamento nei pagamenti dei clienti o un taglio delle linee di credito per trasformare una normale tensione di cassa in una vera emergenza.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata, protetta e rilanciata, se intervieni subito con una strategia mirata.
Perché un’Azienda di Motori Passo-Passo Finisce in Debito
Le cause più frequenti includono:
- aumento dei costi di rame, lamierini, magneti, componenti elettronici e driver
- importazioni di componenti from Asia/Europa con pagamenti anticipati
- ritardi nei pagamenti da parte di integratori, costruttori di macchine, OEM e system integrator
- magazzino immobilizzato tra motori finiti, driver, schede e semilavorati
- investimenti in R&D, prototipazione, test, certificazioni e strumenti di misura
- costi energetici e logistici crescenti
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- progetti custom con tempi lunghi di sviluppo e incasso posticipato
In pratica, non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata a generare il debito.
I Rischi per un’Azienda di Motori Stepper con Debiti
Se non intervieni rapidamente puoi subire:
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco di affidamenti e fidi bancari
- sospensione delle forniture di componenti critici (magneti, elettronica, lamierini, driver)
- decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
- sequestro di magazzino, semilavorati e macchinari
- fermo della produzione e impossibilità di rispettare le consegne
- perdita dei clienti più importanti e dei contratti ricorrenti
- rischio reale di fermo totale dell’attività
Una crisi di debito non gestita può bloccare reparti produttivi e logistica in pochissimo tempo.
Cosa Fare Subito per Difendersi
- Bloccare immediatamente i creditori
Con l’aiuto di un avvocato specializzato è possibile:
- sospendere pignoramenti già avviati
- bloccare richieste di rientro immediate da parte di banche e finanziarie
- proteggere i conti correnti aziendali
- intervenire con i fornitori più aggressivi
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si lavora sulla ristrutturazione.
- Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso nelle posizioni debitorie si trovano:
- interessi non dovuti o usurari
- sanzioni e more calcolate in modo errato
- importi duplicati
- debiti ormai prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari irregolari
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.
- Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti concreti:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (elettronica, motori, meccanica)
- rinegoziazione di fidi e finanziamenti bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti più pesanti
- utilizzo delle definizioni agevolate, quando disponibili
Obiettivo: recuperare liquidità senza fermare la produzione.
- Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
In situazioni più gravi si possono usare strumenti come:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- concordato minore
- liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Queste procedure:
- bloccano tutti i creditori
- sospendono pignoramenti e azioni esecutive
- permettono di pagare solo una parte dei debiti
- mantengono l’azienda operativa
- proteggono l’imprenditore a livello personale
- Proteggere produzione, magazzino e catena fornitori
Per una azienda di motori passo-passo è essenziale:
- tutelare motori finiti, driver, schede elettroniche, magneti, lamierini
- evitare sequestri che bloccherebbero l’intera linea produttiva
- mantenere attivi i fornitori critici (elettronica, meccanica, avvolgimenti)
- proteggere macchinari, banchi prova, strumenti di test e collaudo
- garantire la continuità delle consegne verso clienti industriali e integratori
Se la produzione si ferma, i debiti esplodono. Se la produzione continua, l’azienda ha possibilità concrete di ripresa.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- Elenco completo dei debiti (fiscali, bancari, commerciali)
- Estratti conto bancari aggiornati
- Estratto di ruolo (se presente)
- Bilanci e dichiarazioni fiscali degli ultimi anni
- Lista fornitori strategici e insoluti
- Inventario di magazzino (motori, driver, elettronica, semilavorati)
- Copia di eventuali atti giudiziari ricevuti
- Elenco degli ordini aperti e pianificazione della produzione/consegne
Tempistiche di Intervento
- Analisi preliminare: 24–72 ore
- Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
- Definizione di un piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
- Eventuale procedura giudiziaria: 3–12 mesi
Le misure protettive possono essere operative già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
- Stop immediato a pignoramenti, pressioni e telefonate minacciose
- Riduzione reale e significativa del debito complessivo
- Protezione del magazzino, dei macchinari e delle linee produttive
- Trattative professionali con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Continuità produttiva e commerciale garantita
- Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
- Ignorare solleciti o decreti ingiuntivi
- Fare nuovi debiti per coprire i debiti vecchi
- Pagare un solo creditore e trascurare tutti gli altri
- Lasciare avanzare pignoramenti e precetti senza reagire
- Affidarsi a società “miracolose” prive di competenza legale e tecnica
Ogni errore rende la crisi più difficile da gestire e aumenta il rischio di chiusura.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- Analisi completa della tua situazione debitoria
- Blocco immediato delle azioni dei creditori
- Proposta di piani di ristrutturazione su misura
- Attivazione degli strumenti giudiziari di tutela più adeguati
- Trattative dirette con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore, anche sul piano personale
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di motori passo-passo non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia tempestiva e mirata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre drasticamente i debiti
- proteggere produzione, magazzino e clienti
- salvare la tua azienda e il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.