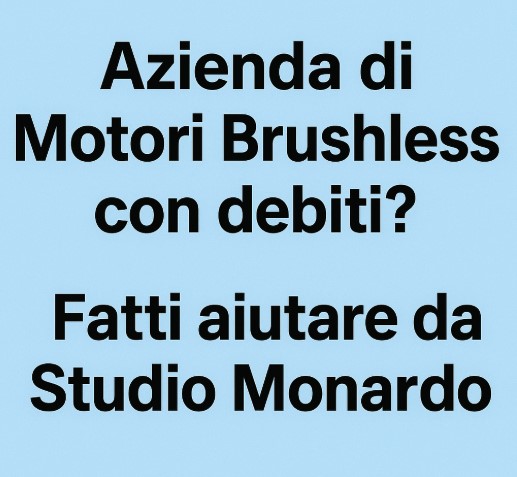Se gestisci un’azienda che produce o distribuisce motori brushless, motori BLDC, servoazionamenti, driver, encoder, controlli elettronici, componenti meccatronici e soluzioni per automazione industriale, CNC, robotica e macchine speciali, e oggi ti trovi con debiti fiscali, cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, arretrati INPS, esposizioni bancarie o debiti verso fornitori, la continuità della tua attività è seriamente minacciata.
Il settore dei motori brushless richiede approvvigionamenti costosi, elettronica di precisione, materiali rari e tempi di consegna puntuali. Un blocco dovuto ai debiti può fermare produzioni, ritardare progetti e far perdere clienti chiave.
La buona notizia è che puoi ancora salvare l’azienda, ma devi intervenire tempestivamente.
Perché le aziende di motori brushless accumulano debiti
Le cause più comuni sono l’aumento del costo dei magneti al neodimio e dei semiconduttori, forniture costose di elettronica e PCB, pagamenti lenti da parte di integratori e costruttori di macchine, ritardi nei versamenti IVA e INPS, magazzini complessi con molte taglie e versioni di motori, investimenti continui in firmware, test, prototipazione e certificazioni, difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati e fornitori strategici che richiedono pagamenti anticipati.
Tutto questo può trasformarsi rapidamente in una crisi di liquidità.
Cosa fare subito
Non lasciare che la situazione peggiori.
Inizia facendo analizzare la situazione debitoria da un avvocato esperto; verifica quali debiti sono corretti e quali invece irregolari, gonfiati o prescritti; non accettare piani di rientro o rateizzazioni impossibili da sostenere; richiedi la sospensione di eventuali pignoramenti; valuta soluzioni sostenibili con AE Riscossione e INPS; tutela i rapporti con i fornitori critici di elettronica, magneti, PCB e controlli; proteggi il conto corrente aziendale e sfrutta gli strumenti legali disponibili per ridurre, ristrutturare o rinegoziare il debito.
Rischi concreti se non intervieni subito
I rischi sono pesanti: pignoramento del conto corrente, blocco delle forniture di motori, driver, encoder e componenti elettronici, impossibilità di rispettare commesse e contratti industriali, perdita di clienti strategici, danni alla reputazione tecnica e commerciale, difficoltà a pagare dipendenti e fornitori e rischio reale di chiusura dell’azienda.
Nel settore dei brushless anche un ritardo minimo può generare fermi impianto per i clienti e costi a cascata.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive, ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative mirate, ottenere piani di pagamento realmente sostenibili, far annullare debiti prescritti o notificati male, negoziare con banche e fornitori per evitare sospensioni delle consegne, proteggere magazzino, componenti e know-how, stabilizzare l’azienda mentre ristruttura i debiti ed evitare l’apertura di procedure concorsuali.
Una strategia professionale può salvare l’azienda prima che la situazione diventi irreversibile.
Come evitare che l’attività si blocchi
Per garantire continuità operativa devi intervenire subito, evitare negoziazioni improvvisate con i creditori, tutelare i fornitori di elettronica e componentistica critica, ristrutturare i debiti prima che arrivi un pignoramento, contestare i debiti irregolari e concentrare la liquidità sulle attività strategiche: produzione, assistenza tecnica, consegne e sviluppo.
Solo così puoi evitare fermi, penali e la perdita di clienti importanti.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti farlo immediatamente se hai ricevuto cartelle, solleciti o preavvisi di pignoramento, se i debiti stanno crescendo troppo rapidamente, se temi il blocco del conto corrente, se la liquidità si sta esaurendo, se i fornitori minacciano di sospendere consegne o se temi che la crisi possa portare alla chiusura dell’azienda.
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ridurre i debiti e mettere in sicurezza l’attività.
Attenzione
Molte aziende nel settore brushless non falliscono per i debiti, ma perché intervengono quando ormai è troppo tardi. Con una strategia legale mirata è possibile ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e proteggere davvero il futuro dell’impresa.
La tua azienda è indebitata? Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Un’azienda che produce motori brushless e si trova gravata da debiti significativi deve affrontare una situazione delicata, ma non senza strumenti di tutela. In Italia, la gestione della crisi d’impresa è stata profondamente riformata con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) nel 2022 . Questo nuovo quadro normativo privilegia interventi tempestivi per risanare l’impresa in difficoltà, preservandone la continuità aziendale, e ricorre alla liquidazione solo come ultima risorsa . In altre parole, la legge incoraggia le aziende indebitate – incluse le S.r.l. e le S.p.A. manifatturiere come quelle del settore dei motori elettrici – a difendersi attivamente dal default attuando piani di ristrutturazione o accordi con i creditori, anziché subire passivamente le azioni esecutive o il fallimento.
Dal punto di vista del debitore, è fondamentale conoscere i propri diritti e doveri. Gli amministratori di società indebitate hanno l’obbligo legale di monitorare la situazione finanziaria e di attivarsi senza indugio per trovare soluzioni . Oltre agli strumenti civilistici per ristrutturare il debito (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi, ecc.), esistono precisi profili penali che entrano in gioco in caso di insolvenza e condotte illecite: ad esempio, omettere il pagamento di IVA o contributi oltre soglie di legge può costituire reato, così come distrarre beni sociali a danno dei creditori (bancarotta). Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, esamina in dettaglio le strategie di difesa per un’azienda italiana indebitata – con taglio tecnico-giuridico ma divulgativo – fornendo riferimenti normativi recenti, sentenze aggiornate, esempi pratici e risposte alle domande più frequenti di imprenditori, professionisti e privati coinvolti.
Scenario tipico: consideriamo una società di capitali (es. S.r.l.) produttrice di motori brushless che accumula debiti verso banche, Fisco, fornitori e enti previdenziali. Cosa può fare l’imprenditore per evitare il tracollo? Come può difendersi dalle azioni dei creditori e, al contempo, cercare di salvare l’azienda o quanto meno ridurre i danni? Nei paragrafi seguenti affronteremo: (a) le diverse categorie di debiti e le relative conseguenze legali; (b) gli strumenti di risanamento e ristrutturazione del debito offerti dall’ordinamento (dal piano attestato di risanamento agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, inclusi gli istituti più recenti introdotti dal Codice della Crisi, come la composizione negoziata e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione); (c) gli obblighi e responsabilità degli amministratori di un’azienda indebitata, per evitare che i debiti sociali si traducano in responsabilità personali; (d) i possibili risvolti penali, come la responsabilità per reati fallimentari o tributari in caso di insolvenza; (e) alcune FAQ – domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni; (f) tabelle riepilogative e casi pratici simulati riguardanti imprese in crisi (con particolare attenzione all’ordinamento italiano). Il tutto corredato dalle fonti normative e giurisprudenziali aggiornate citate, poste in una sezione finale dedicata.
Crisi d’impresa: definizioni chiave e quadro normativo
Per prima cosa, è essenziale capire di cosa parliamo quando usiamo termini come “crisi” e “insolvenza”. Il CCII definisce lo stato di crisi come la probabilità di futura insolvenza – una situazione di difficoltà economico-finanziaria che, se non affrontata, può evolvere in insolvenza conclamata. L’insolvenza, invece, è lo stato di incapienza patrimoniale attuale, in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (ad esempio, non riesce a pagare debiti esigibili in modo sistematico). Questa distinzione è fondamentale: molti strumenti di allerta e di composizione negoziale nascono per intervenire prima che l’insolvenza si manifesti ufficialmente, ossia in fase di crisi o “pre-crisi”.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (decreto legislativo 14/2019, come modificato dai correttivi del 2020, 2022 e 2024) è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e ha sostituito la vecchia legge fallimentare. Tra gli obiettivi dichiarati c’è quello di incoraggiare una gestione proattiva e ordinata delle difficoltà finanziarie dell’impresa, introducendo nuove procedure e rafforzando i doveri degli amministratori. Ad esempio, il secondo comma dell’art. 2086 c.c. (introdotto proprio dalla riforma) obbliga ogni imprenditore che operi in forma societaria a dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi senza indugio per adottare strumenti idonei a superarla . In pratica, la legge impone di non aspettare passivamente il precipitare degli eventi: al comparire dei primi segnali di squilibrio (perdite rilevanti, tensioni di liquidità, ritardi nei pagamenti, ecc.), l’organo amministrativo deve valutare le opzioni di risanamento (ricapitalizzazione, rinegoziazione dei debiti, ricerca di nuovi finanziamenti) e se necessario attivare una delle procedure previste dal CCII per regolare la crisi.
Il CCII ha abbandonato la terminologia tradizionale di fallimento: oggi la procedura liquidatoria giudiziale si chiama liquidazione giudiziale, per sottolineare un approccio meno stigmatizzante. Contestualmente, sono state introdotte procedure volte alla continuità aziendale: l’idea è che salvare l’attività (o parti di essa) quando possibile conviene sia ai creditori sia al sistema economico in generale (preservando valore e posti di lavoro) . Non a caso, la struttura del Codice riflette questa gerarchia di preferenze: i primi Titoli disciplinano strumenti di allerta e composizione negoziata prima che vi sia una crisi conclamata; seguono gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, ecc.), finalizzati al recupero dell’equilibrio aziendale o a una soluzione concordata con i creditori; infine viene trattata la liquidazione giudiziale, come extrema ratio .
Va segnalato che il Codice della Crisi è stato oggetto di successive modifiche integrative e correttive. Un primo correttivo nel 2020 (D.Lgs. 147/2020) e un secondo nel 2022 (D.Lgs. 83/2022) hanno adeguato la normativa italiana alla direttiva UE 2019/1023 e introdotto nuovi istituti, come la composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato post-fallimento, nonché eliminato (almeno per ora) le procedure di “allerta interna” inizialmente previste . Di recente, un terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024, cosiddetto “Correttivo-ter”) è entrato in vigore il 28 settembre 2024 . Quest’ultimo intervento ha affinato ulteriormente il sistema, correggendo difetti di coordinamento emersi nella pratica e chiarendo questioni applicative nei primi anni di utilizzo del Codice . In particolare, il correttivo 2024 ha apportato modifiche significative a: composizione negoziata e obblighi di segnalazione (per facilitare l’emersione precoce della crisi), disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e alcuni aspetti del concordato preventivo . Ciò significa che la normativa è in costante evoluzione per migliorare l’efficacia degli strumenti di crisi e rispondere anche alle sfide economiche (si pensi alla pandemia o agli incrementi dei costi energetici, che hanno messo sotto pressione molte PMI come quelle del settore meccanico/elettronico).
Riassumendo, nel contesto italiano attuale un’azienda indebitata ha a disposizione un ventaglio di soluzioni regolato da norme aggiornate: percorsi stragiudiziali (privati) e giudiziali (con l’ausilio o il controllo del tribunale) per ristrutturare il debito, oltre alla procedura liquidatoria finale. Prima di analizzarli nel dettaglio, esaminiamo le tipologie di debito che un’azienda manifatturiera come la nostra ipotetica azienda di motori brushless potrebbe avere, perché ciascuna categoria di credito ha caratteristiche e implicazioni legali proprie.
Tipologie di debiti aziendali e rischi connessi
Un’azienda in difficoltà spesso presenta un mix di debiti verso diversi soggetti. Comprendere la natura dei vari debiti è importante per predisporre le difese e le soluzioni più appropriate. Ecco le principali categorie di debito che una società può avere, con i relativi rischi e peculiarità:
- Debiti bancari e finanziari: includono mutui, finanziamenti, scoperti di conto, leasing e altri crediti concessi da banche o società finanziarie. Questi debiti sono spesso assistiti da garanzie (reali, come ipoteche o pegni, oppure personali, come fideiussioni dei soci). In caso di insolvenza, le banche creditrici hanno facoltà di revocare affidamenti e chiedere il rientro immediato, eventualmente escutendo le garanzie. I rischi per l’azienda debitrice includono azioni esecutive (pignoramenti di beni, escussione di ipoteche su immobili, ecc.) e, se i crediti sono rilevanti, anche l’istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) promossa dal creditore finanziario. È prassi che le banche, prima di attivare misure drastiche, tentino una rinegoziazione o concedano moratorie sui pagamenti se intravedono la possibilità di recuperare il credito su basi ristrutturate. Tuttavia, quando la situazione degenera, il sistema bancario tende ad agire con tempestività per tutelare i propri crediti. Un aspetto cruciale da tenere presente: se i soci o amministratori hanno firmato garanzie personali (es. fideiussioni) a favore della banca, il default della società comporterà conseguenze dirette anche sul patrimonio personale di costoro, a meno che non si riesca a trovare un accordo anche su tali garanzie.
- Debiti verso fornitori commerciali: sono somme dovute a fornitori di materie prime, componenti, servizi, ecc. Nel settore dei motori elettrici, ad esempio, potrebbero esservi debiti verso fornitori di componentistica elettronica, acciaio, aziende di lavorazione meccanica, e così via. I fornitori, diversamente dalle banche, di solito non dispongono di garanzie reali, ma possono far valere azioni legali ordinarie per il recupero (decreto ingiuntivo, esecuzione forzata su beni aziendali). Il rischio maggiore, oltre alle cause legali, è la perdita di fiducia: fornitori chiave potrebbero sospendere le forniture (applicando la regola “stop supply” per chi non paga), mettendo ulteriormente in crisi la continuità produttiva dell’azienda debitrice. Spesso le imprese in difficoltà cercano di negoziare piani di rientro con i fornitori (dilazioni di pagamento, magari garantite da effetti cambiari o altri impegni) per evitare il tracollo della supply chain. In ambito concorsuale, i fornitori non pagati rientrano tra i creditori chirografari (senza privilegio) e sarebbero soddisfatti pro quota in caso di concordato o fallimento.
- Debiti tributari verso il Fisco: comprendono imposte non versate (IVA, imposte sui redditi, IRAP, ritenute fiscali sui dipendenti o collaboratori, ecc.). In Italia, se un’impresa non paga spontaneamente queste somme, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) avvia la riscossione coattiva: viene iscritto a ruolo il debito e notificate cartelle esattoriali. Se il debito rimane insoluto, si possono avere fermi amministrativi di beni mobili (es. veicoli), ipoteche legali su immobili dell’azienda, pignoramenti di conti correnti o altri attivi. Inoltre, l’Agente della Riscossione può insinuarsi in procedure concorsuali e, in certi casi, promuovere istanza di liquidazione giudiziale se il debito fiscale è elevato e manifesta insolvenza (tipicamente ciò avviene se vi sono imposte non pagate per importi considerevoli e reiterati). Dal punto di vista penale, alcuni debiti fiscali assumono rilievo: l’omesso versamento dell’IVA oltre una certa soglia (oggi €250.000 per periodo d’imposta) costituisce reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni . Analogamente, l’omesso versamento di ritenute certificate (le imposte trattenute ai dipendenti o collaboratori, ad esempio le ritenute IRPEF) è reato se supera €150.000 annui . Va segnalato che nel 2024 la normativa penale tributaria è stata modificata prevedendo che, se il contribuente aderisce a un piano di rateizzazione “bonario” e lo rispetta, il fatto non è più punibile . Ciò significa che un imprenditore in crisi deve assolutamente valutare strumenti come la rateizzazione fiscale (ex art. 3-bis D.Lgs. 462/97) per evitare di incorrere in sanzioni penali mentre cerca di rimettersi in pari: ottenere un piano di dilazione con il Fisco, infatti, non solo consente di graduare il debito nel tempo, ma blocca temporaneamente le azioni esecutive e, come detto, oggi scongiura anche la punibilità per omesso versamento di IVA/ritenute (purché il piano sia in corso e regolare) . In ogni caso, i debiti tributari possono essere trattati nell’ambito di procedure concorsuali mediante la transazione fiscale (di cui diremo oltre), strumento che consente di proporre il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte e contributi, con l’adesione (o il “cram-down” giudiziale) dell’ente pubblico .
- Debiti verso enti previdenziali (INPS, INAIL) e debiti per contributi/dipendenti: questa categoria include i contributi previdenziali obbligatori dovuti per i lavoratori dipendenti e le altre somme dovute agli enti (ad esempio i premi assicurativi INAIL). Il mancato versamento dei contributi ha riflessi sia civili che penali. Sul piano civile, l’INPS (che gestisce anche il Fondo di Garanzia per TFR e ultime tre mensilità dei dipendenti in caso di insolvenza del datore) può iscrivere a ruolo i contributi non pagati, portando anche qui a cartelle esattoriali e azioni di recupero analoghe a quelle fiscali (ipoteche, pignoramenti, ecc.). Inoltre, un’impresa non in regola con i contributi non ottiene il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), necessario per partecipare ad appalti pubblici o ottenere certi benefici, aggravando dunque la crisi d’azienda. Sul piano penale, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti (ossia la quota contributiva a carico del lavoratore, che il datore trattiene in busta paga per versarla all’INPS) è reato se l’importo supera €10.000 annui . Tale reato (previsto dall’art. 2, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983) si perfeziona allo scadere del termine di legge per il versamento e riguarda specificamente le ritenute sulle retribuzioni: è quindi un’ipotesi di appropriazione indebita dei contributi dei lavoratori, punita con sanzione penale (nel tempo il legislatore ha introdotto soglie e cause di non punibilità per tenuità del fatto sotto certi limiti, ma oltre €10.000 la sanzione è applicabile) . È importante notare che non costituisce reato il mancato versamento della quota di contributi a carico dell’azienda (c.d. contributi “datoriale”) se non accompagnato dalla omissione della parte trattenuta al dipendente; tuttavia, restano le sanzioni civili (sanzioni amministrative, aggi e interessi di mora, ecc.). Come per il Fisco, anche l’INPS può essere coinvolto in un accordo di ristrutturazione o concordato: la normativa sulla transazione fiscale si estende infatti anche ai crediti contributivi, consentendo di includerli in un piano con falcidia (riduzione parziale) e dilazione, purché l’ente non subisca un trattamento peggiore di quello che avrebbe in caso di liquidazione . Un ulteriore rischio in quest’area riguarda i dipendenti: se l’azienda ha debiti verso i lavoratori (stipendi arretrati, TFR non versato), costoro hanno privilegi sul patrimonio dell’impresa. I dipendenti possono ricorrere anch’essi legalmente per ottenere decreti ingiuntivi e se l’impresa non paga, un insieme di lavoratori creditori può istigare la procedura concorsuale. I crediti di lavoro infatti godono di privilegio generale mobiliare e di privilegio speciale su determinati beni, il che significa che in un concordato o fallimento vengono soddisfatti prima dei crediti chirografari. Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori possono segnalare situazioni di insolvenza alle autorità. Non pagare i dipendenti, oltre ad avere implicazioni etico-sociali, è segnale di crisi conclamata che spinge spesso l’impresa ad attivare immediatamente ammortizzatori (es. cassa integrazione) o procedure concorsuali.
- Altri debiti finanziari o verso terzi: la categoria “varie” può includere debiti verso soci finanziatori (prestiti infruttiferi dei soci), debiti verso enti locali (tasse comunali o regionali), debiti per sanzioni, ecc. In generale, questi debiti seguono le regole generali: i soci finanziatori in caso di insolvenza sono postergati (spesso i loro crediti sono subordinati al soddisfacimento degli altri creditori, ex art. 2467 c.c. per i finanziamenti soci in S.r.l.), mentre gli enti locali possono anch’essi utilizzare la riscossione coattiva per tributi locali.
Come si nota, ogni tipologia di debito ha rimedi e margini di manovra differenti. Ad esempio, un debito bancario può essere rinegoziato privatamente (ad es. allungando le scadenze, riducendo il tasso, ottenendo nuova finanza garantita dallo Stato – si pensi ai fondi di garanzia per PMI – in cambio di un piano di rientro); un debito fiscale invece richiede l’adesione formale dell’ente a un piano di rateizzo o a un accordo ex art. 63 CCII; un debito verso fornitori può spesso essere oggetto di saldo e stralcio individuale (pagamento parziale immediato a chiusura del debito) se c’è trattativa.
Nei prossimi capitoli, vedremo come i vari strumenti di regolazione della crisi permettono di gestire congiuntamente queste diverse passività. L’obiettivo è difendersi dai creditori sfruttando le protezioni che la legge offre al debitore onesto e trasparente: ad esempio, evitare pignoramenti e azioni esecutive mentre si negozia una soluzione, impedire che un singolo creditore “aggressivo” faccia fallire l’azienda quando c’è la possibilità di salvarla, e così via. Una costante che vale per tutti: agire per tempo è fondamentale. Prima che il castello del debito crolli, l’imprenditore accorto deve fare un check-up della crisi e scegliere la terapia migliore, eventualmente con l’assistenza di professionisti (avvocati, commercialisti) esperti in diritto della crisi.
Strumenti per ristrutturare i debiti e risanare l’impresa
Passiamo ora in rassegna gli strumenti concreti che l’ordinamento italiano mette a disposizione di un’azienda indebitata per riequilibrare la propria situazione finanziaria. Questi strumenti – che vanno dalle soluzioni stragiudiziali e volontarie, agli accordi omologati dal tribunale, fino alle vere e proprie procedure concorsuali – rappresentano le “armi” che il debitore può utilizzare per difendersi dai creditori e, se possibile, salvare l’azienda. Li analizzeremo dal meno invasivo al più invasivo, mantenendo il focus sul punto di vista del debitore: quindi come e quando ciascun istituto può essere vantaggioso per chi si trova sovra-indebitato.
Soluzioni stragiudiziali e negoziazione privata del debito
Trattative private: Il punto di partenza per ogni imprenditore in difficoltà dovrebbe essere il dialogo con i propri creditori. Negoziare privatamente nuovi termini di pagamento o accordi transattivi è spesso la via più rapida e riservata per evitare azioni legali. Ad esempio, si può cercare un accordo a saldo e stralcio con taluni creditori (pagando una percentuale del dovuto in via transattiva, con liberatoria sul resto) oppure concordare una moratoria temporanea (una sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo o leasing per alcuni mesi). Nel passato recente, grazie anche a protocolli promossi da associazioni di categoria, si sono avuti strumenti come le moratorie ABI per i finanziamenti alle PMI, che congelavano le rate per periodi determinati. Tali misure, se disponibili, possono dare ossigeno immediato. Tuttavia, si tratta comunque di accordi volontari: ogni creditore resta libero di aderire o meno. Il debitore privo di liquidità deve quindi convincere i creditori che collaborare è nel loro stesso interesse (perché ad esempio l’alternativa – far fallire l’azienda – porterebbe a un incasso minore). La negoziazione privata funziona meglio quando i creditori sono pochi e ragionevoli, ad esempio due o tre banche esposte e qualche fornitore importante: in questi casi spesso si riesce ad evitare la formalizzazione giudiziaria, ad esempio siglando un accordo di standstill con le banche (le quali concordano di congelare le azioni di recupero e mantenere le linee aperte per un certo tempo mentre l’azienda elabora un piano di rilancio) e parallelamente accordi individuali con fornitori strategici. È sempre consigliabile mettere per iscritto questi accordi, per dare certezza e vincolatività alle nuove scadenze o alle riduzioni concordate.
Piano finanziario di risanamento informale: Nell’ambito delle trattative private, l’imprenditore dovrebbe predisporre un piano che illustri come intende superare la crisi. Anche se questo piano non è inizialmente “attestato” da nessuno, serve come base di discussione: include proiezioni di flussi di cassa, risorse aggiuntive che si intendono apportare (ad esempio nuovi capitali dai soci, cessione di asset non strategici per fare cassa, riduzione di costi), e la proposta di ristrutturazione dei debiti (ad esempio: “Banca X, proroga del mutuo di 5 anni con interessi ridotti; Fornitore Y, pagamento 50% del dovuto in 12 mesi e saldo del restante 50% rinunciato”, etc.). Spesso i consulenti invitano l’azienda a predisporre un vero e proprio piano di risanamento interno, perché avere uno schema chiaro rafforza la credibilità dell’impresa di fronte ai creditori.
C’è però un limite importante delle soluzioni puramente stragiudiziali: la vincolatività. Un accordo privato obbliga solo le parti che lo sottoscrivono. Un creditore dissenziente o esterno non è toccato dall’accordo e può proseguire con le sue azioni. Inoltre, manca la protezione dagli atti di aggressione individuale: se, mentre tratto con i più collaborativi, un altro creditore mi pignora il conto, l’azienda rischia il collasso di liquidità. Per questo, quando l’indebitamento è diffuso e coinvolge molti soggetti, spesso si rende necessario “salire di livello” e utilizzare strumenti tipizzati dalla legge, che offrono maggiori garanzie al debitore virtuoso (come la sospensione delle azioni esecutive, la maggioranza che vincola la minoranza, ecc.). Vediamo allora quali sono questi strumenti previsti dal Codice della Crisi.
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)
Il Piano Attestato di Risanamento è uno strumento di origine negoziale ma dotato di riconoscimento normativo. In breve, consiste in un piano di risanamento aziendale redatto dall’imprenditore in crisi, con il supporto eventualmente dei suoi consulenti, che viene asseverato (attestato) da un professionista indipendente riguardo alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano stesso . Non è una procedura concorsuale giudiziaria: tutto avviene al di fuori del tribunale (il piano può essere semplicemente conservato in azienda o, preferibilmente, depositato presso il registro delle imprese per “data certa”). L’utilità del piano attestato risiede principalmente in due effetti premiali che la legge gli riconosce:
- Protezione dalle azioni revocatorie: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato sono esenti dall’azione revocatoria fallimentare . Ciò significa che, se malauguratamente l’azienda dovesse comunque fallire (andare in liquidazione giudiziale) dopo aver eseguito un piano di risanamento, il curatore non potrà far annullare quei pagamenti o garanzie dati ai creditori durante il piano, purché il piano fosse regolarmente attestato ex art. 56 CCII. Questo beneficio è cruciale per incentivare i creditori a partecipare: ad esempio, una banca che aderisce al piano e ottiene un pagamento parziale del suo credito può tenerlo “al sicuro”, mentre altrimenti in caso di fallimento quell’incasso sarebbe a rischio restituzione.
- Esonero da taluni reati fallimentari: la legge fallimentare prevedeva (art. 217-bis L.F.) – e il CCII ha confermato nelle nuove norme penali – che se il debitore ha eseguito un piano attestato idoneo a risanarlo, non si applicano alcune fattispecie di reato di bancarotta semplice o preferenziale relative ai pagamenti e alle operazioni compiute in attuazione di quel piano. In sostanza, l’imprenditore non sarà punibile per aver, ad esempio, pagato un fornitore invece di un altro (bancarotta preferenziale) se ciò rientrava in un piano di risanamento attestato; né gli verrà imputato di aver aggravato il dissesto (bancarotta semplice) se ha seguito un progetto attestato ritenuto ragionevole. Questo naturalmente non copre eventuali condotte fraudolente, ma tutela l’imprenditore onesto che ha tentato la via del risanamento poi fallito.
Oltre a questi effetti legali, il piano attestato ha il vantaggio di essere flessibile e confidenziale. Non richiede percentuali di adesione prestabilite: l’imprenditore può costruire il piano coinvolgendo tutti o solo alcuni creditori, a seconda di ciò che è necessario. Ad esempio, potrebbe accordarsi privatamente con le banche (che magari rappresentano il 70% del debito totale) e lasciare fuori dal piano altri piccoli creditori che comunque conta di pagare normalmente; oppure potrebbe includere solo i fornitori strategici. Non vi è un numero minimo di creditori richiesto: anche un accordo bilaterale con la banca principale può formare oggetto di piano attestato, se quell’accordo risana l’esposizione debitoria e riequilibra la situazione finanziaria . L’importante è che il piano appaia “idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario dell’impresa” (così recita la norma) e che un esperto indipendente ne attesti la fattibilità.
Procedura di formazione: Nella pratica, l’azienda incarica un professionista (di solito un commercialista o revisore esperto in piani di ristrutturazione) come attestatore. Questo professionista, terzo e indipendente, analizza il piano predisposto dall’azienda e la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, verificando che i dati di partenza siano veritieri e che le proiezioni siano realistiche. Se tutto è in ordine, rilascia una relazione di attestazione positiva. A quel punto il piano, firmato e datato, è considerato “attestato” e l’azienda può darvi esecuzione. Non occorre omologazione o approvazione da parte di un giudice; tuttavia, se lo si desidera, si può pubblicare un estratto del piano nel registro imprese (non è obbligatorio ma è possibile, e viene fatto per dare pubblicità e data certa). Durante l’esecuzione, l’azienda continua ad operare normalmente – non c’è commissario né perdita di poteri da parte degli amministratori.
Limiti del piano attestato: Il rovescio della medaglia è che il piano attestato non impone sacrifici ai creditori dissenzienti. Chi non ha accettato l’accordo resta libero di agire: non c’è nessun “stay” automatico delle azioni esecutive verso chi sta fuori dal piano . Inoltre, il piano non prevede interventi del tribunale: se un creditore “estraneo” ritiene di essere pregiudicato dal piano (ad esempio perché l’azienda paga altri e non lui), può comunque chiedere un fallimento o un decreto ingiuntivo. Dunque, il piano attestato funziona bene quando c’è un consenso ampio e pressoché unanime dei creditori rilevanti, tale che nessuno abbia convenienza ad agire autonomamente fuori dagli accordi. In contesti con pochi creditori principali e relazioni di fiducia, il piano attestato è lo strumento ideale: evita i costi e i tempi delle procedure giudiziarie, dà massima agilità (il piano entra in azione appena firmato l’ultimo accordo e depositata l’attestazione, senza attendere omologhe) , ed evita pubblicità negativa (si può mantenere riservato il tutto, se non si iscrive il piano). Per contro, se l’azienda ha decine di creditori e qualche “franco tiratore” in agguato, il piano attestato rischia di non reggere – in questi casi, bisogna valutare strumenti più cogenti come l’accordo di ristrutturazione o il concordato.
Aggiornamenti 2022-2025: Nel CCII, il piano attestato è disciplinato dall’art. 56 ed è figlio diretto della normativa previgente (art. 67, co.3, lett. d) L.F.). Le modifiche più recenti hanno in parte ampliato la portata dello strumento. Ad esempio, il decreto correttivo 2020 ha previsto l’onere di pubblicazione nel registro imprese degli “atti esecutivi” del piano su richiesta del debitore, al fine di estendere pienamente l’esenzione da revocatoria anche a pagamenti non contestuali al piano stesso (norma tecnica per chiarire dubbi interpretativi). Inoltre, si è rafforzata la figura dell’attestatore, richiedendo standard più stringenti per la relazione (sono stati emanati Principi di attestazione aggiornati nel 2022 in seguito al CCII ). Da ultimo, è stato chiarito che il piano attestato può coesistere o innestarsi nella composizione negoziata: quest’ultima, come vedremo, è una procedura di ausilio, all’interno della quale l’imprenditore può benissimo decidere di concludere un piano attestato. In sintesi, il piano attestato è uno strumento “contrattuale puro” – flessibile, rapido, ma che richiede collaborazione pressoché totale dei creditori chiave. Se questa condizione c’è, consente di risolvere molte crisi senza passare dal tribunale. Se manca, spesso il piano attestato da solo non basta e deve evolvere in un accordo più vincolante.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) – art. 57 e ss. CCII
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) rappresentano un gradino successivo in termini di formalità e coinvolgimento dell’autorità giudiziaria. Introdotti originariamente nel 2005 (art. 182-bis Legge Fallimentare) e ora disciplinati dagli artt. 57-64 CCII, gli ARD prevedono che il debitore possa chiedere al tribunale l’omologazione di un accordo con i creditori, a condizione di aver raggiunto l’adesione di una percentuale qualificata di essi. Oggi, con il CCII, esistono diverse varianti di accordo, ma il modello base (accordo “ordinario”) richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti totali . Vediamo come funziona e quali vantaggi offre:
- Natura mista, privata e giudiziale: L’ARD nasce come un accordo contrattuale tra debitore e una maggioranza (in valore) dei suoi creditori . Ci si può arrivare dopo trattative (spontanee o facilitate, ad esempio, da una composizione negoziata). Tuttavia, per avere efficacia legale piena, questo accordo è sottoposto all’esame del tribunale: viene depositato un ricorso chiedendo l’omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, la presenza dell’attestazione di un professionista indipendente e soprattutto che i creditori non aderenti non subiscano un pregiudizio eccessivo dall’accordo . Se tutto è a posto, il giudice omologa l’accordo e questo decreto lo rende vincolante per i creditori aderenti (quelli che hanno firmato) e attiva alcuni effetti protettivi verso i creditori estranei.
- Effetti verso i non aderenti: Uno dei principali incentivi a utilizzare l’ARD invece di un piano puramente privato è la possibilità di ottenere una sorta di “moratoria” legale verso i creditori estranei. In particolare, se l’accordo omologato prevede che i creditori non aderenti vengano comunque pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (se chirografari) o entro 180 giorni (se privilegiati) – dunque se a questi estranei non viene chiesto alcun sacrificio oltre un po’ di attesa – il tribunale può disporre che, dall’omologazione fino a quei termini, costoro non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquisire titoli di prelazione . In pratica, è come dire: “Caro creditore estraneo, l’accordo non ti tocca perché verrai pagato per intero entro pochi mesi; in cambio, però, devi pazientare e non puoi rompere le uova nel paniere durante questo breve lasso di tempo.” Questo stay temporaneo tutela il debitore dal rischio che qualche estraneo faccia saltare l’equilibrio mentre l’accordo si esegue. Attenzione: se il debitore non rispetta poi i termini di pagamento di quei creditori estranei, costoro riacquistano i pieni diritti e l’accordo può anche essere risolto per inadempimento.
- Soglia di adesioni e vincolo per la minoranza: Come detto, serve almeno il 60% dei crediti (in valore) che accettino. Non occorre invece il consenso di tutti i creditori (a differenza di un piano attestato, che di fatto per funzionare richiede di convincere tutti quelli importanti). Questo significa che l’ARD è utile quando non si riesce a ottenere l’unanimità, ma si può contare su una larga maggioranza. La legge consente dunque di forzare una minoranza dissenziente a rispettare l’accordo, a patto che si abbia quell’adesione qualificata e che l’accordo sia equo. I creditori dissenzienti (che non hanno firmato) non sono obbligati a subire tagli nel senso che, a loro, l’accordo deve garantire almeno l’integrale pagamento (nei termini di legge come sopra), ma se ad esempio vogliono essere pagati subito e non tra 4 mesi non hanno scelta: devono aspettare, perché l’omologazione impedisce loro di agire immediatamente. Inoltre, per alcune categorie di creditori finanziari, la legge prevede persino il cram-down: nelle varianti di ADR ad efficacia estesa (art. 61 CCII), se il 75% degli istituti di credito aderisce, l’accordo può essere esteso anche alle banche dissenzienti minoritarie, imponendo loro le stesse condizioni . Così, ad esempio, se su 4 banche 3 sono d’accordo e solo una no, con l’accordo ad efficacia estesa si può includere anche la quarta banca a certe condizioni. Questa è una innovazione introdotta già dal 2016 e confermata nel CCII per evitare che un singolo istituto possa bloccare ristrutturazioni di debito sensate.
- Attestazione indipendente: Analogamente al piano attestato, anche per l’accordo di ristrutturazione è richiesta una relazione di attestazione da parte di un professionista esperto (iscritto all’albo dei gestori crisi). L’attestatore verifica soprattutto che l’accordo sia fattibile e che i creditori estranei possano essere soddisfatti nei termini previsti. Nel caso dell’ARD, il focus è sulla capacità del debitore di onorare l’accordo e pagare i terzi estranei come promesso (nel limite 120/180 giorni) . Senza attestazione favorevole il tribunale non omologa.
- Ruolo del tribunale: L’iter prevede il deposito presso il tribunale competente dell’accordo (con le firme raccolte) e del piano ad esso sottostante, insieme all’attestazione e alla documentazione contabile aggiornata. Il tribunale, in camera di consiglio, valuta eventuali opposizioni dei creditori non aderenti (che possono lamentare che l’accordo li pregiudica ingiustamente, ad esempio perché non offre loro davvero il 100% a breve) e può rifiutare l’omologa se ritiene che l’accordo sia in frode o che i dissenzienti sarebbero trattati peggio che in caso di fallimento. In assenza di opposizioni o se queste vengono respinte, il tribunale emette il decreto di omologazione che rende efficace l’accordo. Durante la pendenza del procedimento di omologazione, su richiesta del debitore, il tribunale può anche concedere misure protettive provvisorie (uno stay cautelare delle azioni esecutive) per evitare che qualcuno rovini la trattativa in corso.
- Varianti “agevolate” degli accordi: Il CCII, recependo la direttiva europea, ha introdotto una sottocategoria di accordi di ristrutturazione detti “agevolati” (art. 60 CCII) . Gli accordi di ristrutturazione agevolati consentono di attivare la procedura con una soglia di adesione iniziale più bassa (30% dei crediti) per ottenere protezione provvisoria, pur necessitando poi del 60% per l’omologazione . L’idea è di facilitare l’avvio del percorso: se il debitore riesce a portare in tribunale un accordo già sottoscritto dal 30% dei creditori, può accedere immediatamente alle misure protettive (sospensione dei pagamenti, blocco delle azioni esecutive) per negoziare col resto, confidando di arrivare al 60%. Inoltre, negli accordi agevolati è ammessa la falcidia (riduzione) dei crediti tributari e contributivi anche senza il voto favorevole del Fisco, tramite un particolare meccanismo di cram-down fiscale disciplinato dall’art. 63 CCII. Questo aspetto è stato oggetto di recenti aggiustamenti normativi: nel 2023, per evitare infrazioni UE, è stato stabilito un regime transitorio in cui il cram-down fiscale è possibile ma con garanzie di non discriminazione per l’Erario . In pratica, se il Fisco non aderisce, il tribunale può comunque omologare l’accordo se ritiene che al Fisco venga offerto almeno quanto otterrebbe in fallimento e che vi sia convenienza. Una recente legge del 2023 (L. 103/2023) ha rafforzato la tutela dei crediti pubblici in questi casi, richiedendo una sorta di parere dell’Avvocatura dello Stato e limitando temporaneamente la falcidia di IVA e contributi per recepire la normativa UE .
In definitiva, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento intermedio: più strutturato del piano attestato (perché coinvolge il tribunale e vincola anche la minoranza dissenziente almeno in parte), ma più snello e flessibile del concordato preventivo (non richiede il voto di tutti i creditori né la creazione di classi, ed è solitamente più rapido). La scelta tra piano attestato e ARD dipende spesso dalla necessità di efficacia erga omnes: se il debitore riesce a farsi seguire da tutti i creditori principali, può preferire il piano per semplicità; se invece alcuni importanti restano fuori ma c’è comunque un ampio consenso, conviene “blindare” il risultato con un accordo omologato .
Vantaggi specifici per il debitore: Oltre a quelli menzionati (stay sulle azioni esecutive, riduzione quorum rispetto all’unanimità), c’è da notare che durante la trattativa di un ARD il debitore può chiedere misure protettive urgenti, e se l’omologa arriva, l’accordo viene pubblicato nel registro imprese dando pubblicità all’avvenuta ristrutturazione (cosa che può aiutare a ristabilire fiducia sul mercato). Inoltre, l’ARD non comporta normalmente la nomina di organi commissariali: l’imprenditore resta in sella, non c’è spossessamento, e a differenza del concordato preventivo non si nomina un commissario giudiziale per gestire l’impresa (c’è solo, semmai, un ausiliario del giudice per le verifiche in sede di omologa, ma non è invasivo). Ciò significa continuità gestionale. Anche in termini reputazionali, un ARD può essere percepito meglio di un concordato (che è più assimilato all’idea di “pre-fallimento”). Infine, va evidenziato che se il debitore non rispetta l’accordo e questo viene risolto, potrà comunque accedere successivamente ad un concordato o altra procedura: l’ARD può dunque essere un tentativo, con un piano B disponibile in caso di fallimento del tentativo.
Svantaggi o limiti: L’ARD, benché più rapido del concordato, richiede comunque qualche mese per l’omologa, soprattutto se ci sono opposizioni . Durante questo tempo, se non sono state chieste misure protettive, i creditori estranei potrebbero agitarsi. Inoltre, l’accordo vincola solo i firmatari e i dissenzienti nei limiti detti: non consente di imporre una riduzione del credito ai non aderenti (salvo l’ipotesi particolarissima di cram-down fiscale per il Fisco). Quindi, se serve un effetto erga omnes più forte (ad esempio si vuole proprio tagliare i debiti anche a chi non fosse d’accordo, cosa che in ARD non si può fare se non aderisce), si deve ricorrere al concordato preventivo o al piano di ristrutturazione omologato (strumento di recentissima introduzione di cui subito diremo). Infine, l’accordo presuppone che l’impresa sia almeno in uno stato di crisi o insolvenza incipiente (non puramente sana) e che comunque sia in grado di predisporre un piano attendibile: se l’azienda è già “clinicamente morta”, i creditori non aderiranno e il tribunale non omologherebbe mai un accordo non credibile.
Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO)
Tra le novità arrivate con l’attuazione della direttiva UE, il CCII ha previsto anche i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (in gergo abbreviati come PRO). Si tratta di uno strumento introdotto dal correttivo 2022 (D.Lgs. 83/2022) e disciplinato negli articoli 64-bis e seguenti CCII . L’idea del PRO è quella di fornire un ulteriore mezzo di composizione negoziata della crisi, a metà strada tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo. In parole semplici, è un piano proposto dal debitore che può essere omologato dal tribunale anche senza l’accordo di tutte le classi di creditori, purché siano rispettate certe condizioni di legge . È uno strumento concepito per casi in cui l’imprenditore ha già una propria soluzione e vuole imporsi sui dissenzienti senza passare per l’intero iter del concordato con votazione. In pratica:
- Il debitore elabora un piano di ristrutturazione suddividendo i creditori in classi (come avverrebbe in un concordato) e propone trattamenti differenziati.
- Non è necessario ottenere preventivamente una percentuale di adesione (come l’ARD), perché si può chiedere al tribunale di omologare il piano anche se alcuni creditori o classi non aderiscono, evitando la votazione. Ciò è possibile solo se si soddisfano rigidi requisiti: in sostanza, bisogna dimostrare che il piano è più conveniente per tutti i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione e che i dissenzienti non vengono trattati in modo deteriore rispetto agli aderenti (principio di assoluta priorità o comunque di trattamento equo).
- Il tribunale, verificando queste condizioni e sentito un commissario giudiziale eventualmente nominato, può omologare il piano imponendolo anche ai creditori non consenzienti (cram-down di classi dissenzienti). Si tratta di un meccanismo ispirato al Chapter 11 statunitense o alle procedure di restructuring plan di altri ordinamenti: l’azienda si ristruttura dall’alto, con intervento del giudice, senza passare da un voto assembleare classico, se dimostra la meritevolezza e fattibilità.
In sostanza, il PRO è simile a un concordato ma più flessibile, perché consente di evitare il voto se il debitore soddisfa quei requisiti di tutela dei creditori dissenzienti . Il rovescio della medaglia è che comunque c’è un controllo giudiziale intenso: il debitore deve convincere il tribunale (con l’ausilio dell’attestazione) che il piano è equo. Al 2025, i PRO non risultano ancora molto applicati nella prassi – sono uno strumento nuovo e usato raramente, forse perché in molti casi si preferisce ancora l’accordo di ristrutturazione se c’è maggioranza o il concordato se serve un taglio forzoso. Potenzialmente, però, il PRO offre al debitore un percorso per aggirare la necessità di consenso qualificato: qualora un’azienda abbia un piano ottimo ma uno zoccolo di creditori irriducibili che lo rifiutano irragionevolmente, può tentare la via del PRO e chiedere al giudice di approvarlo comunque. Va detto che i criteri di omologa in questo caso sono stringenti: il giudice omologa solo se tutti i creditori (anche quelli che hanno detto no) ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale e se il piano non li discrimina ingiustamente. In pratica, il debitore deve proporre di destinare ai dissenzienti il massimo possibile compatibile con la tenuta del piano.
Confronto col concordato preventivo: Il PRO è concettualmente vicino al concordato con continuità ma senza voto. In effetti, una delle ipotesi in cui potrebbe essere usato è quando l’azienda ha poche classi e vuole evitare l’incognita del voto (che nel concordato può affossare la proposta se le maggioranze non si raggiungono). Se il debitore è confidente che il suo piano sarebbe comunque imposto dal tribunale per convenienza, potrebbe saltare la votazione e presentarlo direttamente come PRO. Tuttavia, se c’è incertezza, di solito si preferisce il concordato tradizionale dove almeno se i creditori votano sì l’omologa è assicurata. Diciamo che il PRO nel 2022 è stato introdotto come compliance alla direttiva UE che chiedeva una procedura di ristrutturazione più efficiente; ma la sua concreta utilità deve trovare conferme pratiche.
Nota: Dal punto di vista dell’azienda in crisi, il PRO è un’opzione di nicchia. La stragrande maggioranza dei casi di risanamento avviene tuttora con piani attestati, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi. Tuttavia, è bene sapere che esiste questa possibilità aggiuntiva. Ad esempio, se la nostra azienda di motori brushless avesse necessità di cramdown su una classe di creditori (mettiamo gli obbligazionisti o un certo gruppo di fornitori) e non volesse rischiare il voto, il suo legale potrebbe valutare un PRO invece di un concordato.
Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il Concordato Preventivo è la più nota e “classica” procedura concorsuale di ristrutturazione. Rappresenta il percorso giudiziale completo in cui tutti i creditori vengono coinvolti e vincolati, e che consente al debitore di ottenere un esdebitamento parziale (cioè di pagare i creditori solo in parte) oppure una riorganizzazione dei debiti a lungo termine, sotto il controllo del tribunale. Nel concordato preventivo:
- Proponente e ammissibilità: può proporre concordato ogni imprenditore commerciale che si trovi in stato di crisi o insolvenza, esclusi quelli piccolissimi non fallibili (i quali hanno semmai il “concordato minore”, simile ma regolato a parte per i soggetti minori). La proposta di concordato va presentata al tribunale con un ricorso, corredato da un piano e da una proposta dettagliata ai creditori, oltre che da documentazione contabile e da un’attestazione di fattibilità redatta da un professionista indipendente. È possibile anche presentare una domanda di concordato “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco) annunciando l’intenzione e depositando la documentazione completa in un secondo momento: questo serve a ottenere subito le protezioni (il “automatic stay”) e poi guadagnare tempo (fino a 120 giorni prorogabili) per completare il piano.
- Tipologie di concordato: esistono varie forme. Il concordato in continuità aziendale è quello in cui l’impresa prosegue l’attività (direttamente o indirettamente, ad es. tramite cessione a un terzo che la continua) e i creditori vengono soddisfatti col ricavato della gestione corrente o di operazioni straordinarie (aumento di capitale, investimenti di terzi) mantenendo appunto la continuità. Il concordato liquidatorio, invece, prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio aziendale, però in modo ordinato e sotto l’egida del tribunale, con distribuzione del ricavato ai creditori secondo certi criteri di favore (ad esempio attualmente la legge richiede che nel liquidatorio puro sia garantito un pagamento minimo del 20% ai chirografari, salvo eccezioni). Nel concordato in continuità è ammessa una maggior flessibilità (anche pagamenti percentuali più bassi agli chirografari, giustificati dal valore che si salva mantenendo l’impresa viva, come posti di lavoro, indotto, ecc.). Esiste poi il concordato misto (parte continuità e parte liquidazione di asset non strategici), frequente nella pratica. Infine, il CCII ha previsto un concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies), riservato ai casi in cui la composizione negoziata non abbia avuto esito e l’imprenditore non abbia altre vie: questo concordato semplificato non richiede il voto dei creditori (è il tribunale a omologarlo direttamente), ma è solo liquidatorio e prevede la nomina di un liquidatore giudiziale. Diciamo che è un’extrema ratio per micro-imprese che non trovano accordi, per evitare la liquidazione giudiziale tout court. Il suo ambito è circoscritto e non è applicabile se non nei casi espressi di composizione negoziata fallita .
- Procedimento e voto dei creditori: Dopo la presentazione della domanda di concordato (completa o con riserva), il tribunale effettua un esame di ammissibilità e nomina un commissario giudiziale, figura terza che sorveglia la gestione nel frattempo e redige una relazione per i creditori. Se tutto è regolare, si apre la procedura: i creditori vengono suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica e interessi (ad esempio: banche chirografarie in una classe, fornitori in un’altra, Fisco e INPS spesso ciascuno in classe separata se si prevede trattamento differenziato, ecc.; i creditori privilegiati possono essere in classi se si chiede loro qualche falcidia sul privilegio, altrimenti se sono soddisfatti integralmente non votano). Viene indetta un’adunanza dei creditori in cui essi esprimono il proprio voto sulla proposta. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza in valore, e anche di teste se il tribunale ha disposto il doppio quorum – la disciplina è un po’ complessa, ma semplificando: serve più del 50% dei crediti, calcolando il peso dei voti favorevoli, esclusi gli astenuti). Se ci sono più classi, occorre il voto favorevole della maggioranza delle classi o comunque si applicano regole di cram-down interclasse (ad es., il tribunale può omologare anche con il dissenso di una classe, se ritiene la proposta conveniente per quella classe rispetto all’alternativa liquidatoria – questo è un cram-down giudiziale interno al concordato, previsto dall’art. 112 CCII e succ. in attuazione della direttiva). In caso di esito negativo della votazione, il concordato è respinto (e spesso si apre il fallimento); in caso di esito positivo, si passa all’omologazione.
- Omologazione e esecuzione: Se i creditori approvano, il tribunale (sentite eventuali opposizioni di creditori dissenzienti che però sono minoranza) emette decreto di omologazione. Da quel momento il concordato è efficace e vincolante verso tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato. L’impresa quindi esegue il piano sotto la sorveglianza degli organi nominati (il commissario può diventare liquidatore se c’è liquidazione di beni, oppure c’è un attestatore che verifica i pagamenti, dipende). Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione: viene liberato dai debiti residui secondo quanto previsto nel piano. Ad esempio, se il piano prevedeva di pagare il 40% ai chirografari, una volta pagato quel 40% nei tempi previsti, il restante 60% si considera legalmente cancellato e i creditori non possono più pretenderlo.
- Protezione del debitore durante il concordato: Uno dei principali vantaggi del concordato per il debitore è la protezione immediata dalle azioni esecutive e cautelari individuali. Dal momento in cui si deposita una domanda di concordato completa, e anche durante un concordato con riserva (se accolto), i creditori per legge non possono iniziare o proseguire pignoramenti né acquisire privilegi sul patrimonio del debitore. Eventuali pignoramenti in corso rimangono congelati. Questo “ombrello” consente all’impresa di tirare il fiato e preservare l’integrità patrimoniale mentre cerca la soluzione concordata . Inoltre, il debitore in concordato può, previa autorizzazione del giudice, contrarre finanziamenti prededucibili, sciogliersi da contratti in corso particolarmente onerosi, e in generale operare (sotto controllo) per massimizzare le chance di riuscita del piano.
- Ruolo degli organi e perdita di gestione: Nel concordato l’imprenditore non è spossessato come nel fallimento (mantiene l’amministrazione dei beni), ma è comunque sotto osservazione del commissario giudiziale e del tribunale. Ogni atto di straordinaria amministrazione necessita di autorizzazione. Quindi c’è una ingerenza esterna maggiore che in ARD o piani attestati. Questo è un costo (anche economico, per via delle spese di procedura e dei compensi agli organi) e un sacrificio in termini di privacy, ma è il prezzo da pagare per ottenere il vincolo legale su tutti i creditori e soprattutto per poter imporre sacrifici anche ai dissenzienti (cosa che, come visto, né piano attestato né ARD consentono se non pagandoli integralmente).
- Quando ricorrere al concordato: Di solito il concordato è indicato quando la crisi è troppo estesa e non si può risolvere solo con accordi parziali. Se serve falciare in modo significativo i debiti chirografari, ad esempio offrendo loro 20% o 30%, il concordato è l’unica via perché negli accordi serve convincere ciascun creditore a accettare la riduzione (cosa improbabile per molti). Nel concordato invece i creditori subiscono la riduzione a maggioranza: se la maggioranza approva, i contrari si adeguano. Anche quando la struttura dei creditori è molto frammentata (centinaia di fornitori, erario, banche, leasing, ecc.), il concordato è lo strumento più efficiente per gestire tutti assieme i debiti. In pratica, se l’azienda di motori brushless fosse in uno stato di insolvenza grave, ma con un nucleo sano di attività che potrebbe sopravvivere ristrutturando i debiti (ad esempio tagliando quelli chirografari e dilazionando quelli privilegiati), il concordato in continuità potrebbe essere la scelta giusta: consente di abbattere il debito a un livello sostenibile, magari coinvolgendo un investitore o i soci con nuova finanza a supporto, e di ripartire. Se invece l’azienda non è più salvabile come attività (nessuna prospettiva di rilancio), ma ha ancora asset da liquidare, il concordato liquidatorio può essere usato per vendere gli asset in modo organizzato, evitare l’asta fallimentare e distribuire qualcosa ai creditori (spesso preferiscono un concordato liquidatorio che dà un 20-30% subito, piuttosto che un fallimento dove l’attesa è lunga e l’esito incerto).
Riassumendo i pro e contro dal lato debitore: Il concordato pro: offre la massima protezione (stay immediato), la possibilità di ridurre sensibilmente i debiti (anche senza consenso di tutti, grazie al voto a maggioranza), e una volta omologato libera definitivamente l’impresa dai debiti pregressi residui, permettendole un “fresh start” se in continuità, oppure una chiusura dignitosa se liquidatoria. Contro: è lento e costoso (può durare diversi mesi per arrivare a omologa, comporta costi di giustizia e spese legali notevoli), pubblico (l’apertura del concordato è iscritta a registro imprese, tutti i partner e il mercato lo sanno), e comporta una perdita di controllo parziale da parte degli amministratori. Inoltre l’esito è incerto: serve persuadere i creditori e il giudice, e se la proposta non è valida rischi di finire peggio (in fallimento) se bocciata. Infine, le banche e fornitori a volte reagiscono negativamente a un concordato, tagliando forniture o linee di credito per timore – questo va gestito con molta attenzione e comunicazione appropriata.
Nel contesto della nostra guida, basta ricordare che il concordato preventivo è lo strumento più potente per il debitore, ma va usato quando necessario. Se esistono soluzioni più snelle (piano attestato, accordo) è meglio tentare prima quelle, ricorrendo al concordato solo se non vi sono alternative consensuali praticabili o se la gravità della crisi impone un intervento autoritativo.
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 e artt. 12-25 CCII)
Un capitolo a parte merita la Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021) e poi integrata nel Codice della Crisi (artt. 12-25 CCII). La composizione negoziata (che chiameremo brevemente “CN”) non è una “soluzione” di per sé, ma un procedimento volontario e confidenziale finalizzato a facilitare le trattative tra l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori, con l’aiuto di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio . In pratica, è uno strumento di ausilio che può condurre poi a uno degli esiti visti sopra (piano attestato, accordo, concordato, ecc.) o, se fallisce, può preludere alla liquidazione semplificata.
Come funziona: L’imprenditore percepisce segnali di crisi (o è in crisi conclamata ma spera di risanare). Può presentare istanza di composizione negoziata tramite una piattaforma telematica nazionale . Deve allegare informazioni sull’azienda, sulle cause della crisi, sulle prospettive di risanamento, e bilanci/proiezioni. Un’apposita commissione nomina un esperto terzo, tipicamente un professionista con competenze aziendali, il quale studia la situazione e si affianca all’imprenditore per cercare un accordo con i creditori. Le trattative sono riservate: l’apertura della composizione negoziata non viene pubblicata (a meno che l’imprenditore non chieda misure protettive, caso in cui un minimo di pubblicità nel registro imprese è prevista). L’esperto convoca le parti, propone soluzioni mediatrici, suggerisce eventuali correttivi al piano dell’imprenditore. Il suo ruolo è di facilitare il dialogo e fare da garante di buona fede.
Misure protettive: Durante la CN, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure cautelari e protettive, in particolare la sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori. Questo consente, simile a un pre-concordato, di bloccare i pignoramenti nel frattempo che si tratta. A differenza del concordato, qui la protezione non è automatica con la domanda: va richiesta e il tribunale la concede se ritiene che vi siano concrete possibilità di negoziazione e che la continuazione dell’impresa non danneggi ulteriormente i creditori. Se accordata, la protezione può durare inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili di altri 4, per un totale di 8 mesi di trattative protette.
Esiti possibili: La composizione negoziata può concludersi in vari modi: – Se le trattative riescono, l’imprenditore e i creditori possono sottoscrivere uno o più accordi stragiudiziali (ad esempio singoli accordi di ristrutturazione bilaterali, o un accordo plurilaterale senza necessità di omologa se tutti firmano). In alternativa, può emergere dalla negoziazione un progetto di piano attestato di risanamento, che l’imprenditore formalizza con attestazione e poi esegue. Oppure, se si raggiunge l’adesione del 60% dei creditori, si può optare per depositare un accordo di ristrutturazione in tribunale. Insomma, la CN può sfociare in uno degli strumenti di soluzione della crisi di cui abbiamo parlato. Spesso, un caso pratico è: l’impresa attiva la composizione negoziata per congelare le azioni dei creditori e avere un esperto che certifica la serietà del tentativo, poi durante i 4-8 mesi arriva a definire un piano attestato accettato dalle banche e fornitori principali, e dunque esce dalla procedura con quel piano in tasca da eseguire . In tal senso, CN e piano attestato sono complementari: la CN è il processo, il piano attestato è il prodotto finale . – Se le trattative non approdano a nulla, l’esperto chiude la procedura dichiarando che non si è trovata soluzione. A quel punto, l’imprenditore può decidere di presentare comunque una domanda di concordato preventivo (tradizionale) oppure, nei casi previsti, ricorrere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (quest’ultimo è riservato proprio all’esito infruttuoso di una CN: il debitore rinuncia a salvare l’impresa, ma chiede al tribunale di approvare una liquidazione concorsuale senza voto, nominando un liquidatore, in modo più rapido del fallimento) . In mancanza di iniziative, ovviamente resta la possibilità che i creditori chiedano la liquidazione giudiziale e tutto sfoci in fallimento.
Vantaggi dal punto di vista del debitore: La composizione negoziata è volontaria e non stigmatizzante. Si svolge per lo più lontano dai riflettori, permettendo all’imprenditore di evitare il panico fra clienti e fornitori. L’esperto nominato è lì per aiutare, non per comandare: l’imprenditore resta in possesso e guida le trattative, beneficiando però dei consigli di un professionista super partes. Questo può anche aumentare la fiducia dei creditori, sapendo che c’è un arbitro imparziale al tavolo. In caso di necessità, la possibilità di ottenere uno stay delle azioni esecutive è preziosa: simile a un pre-concordato ma senza gli stessi formalismi, consente di guadagnare tempo. Inoltre, durante la CN l’imprenditore può richiedere al giudice autorizzazioni per contrarre finanziamenti prededucibili o per ottenere la sospensione/riattivazione di contratti essenziali, in modo da tenere in vita l’azienda (ad esempio, potrebbe farsi autorizzare un finanziamento bancario emergenziale da restituire poi con priorità, oppure chiedere di sospendere temporaneamente un contratto di fornitura troppo oneroso). Tutte queste misure rendono la CN una sorta di cassetta degli attrezzi flessibile per gestire la crisi in modo ordinato prima di dover ricorrere a soluzioni più drastiche .
Limiti: Va detto che la CN non garantisce il successo – dipende sempre dalla sostanza economica. Se l’azienda è decotta, l’esperto al massimo potrà certificare il decesso e consigliare di liquidare. Inoltre, c’è il rischio che alcuni creditori partecipino solo per capire le intenzioni e poi si sfilino. Per evitare abusi, alcuni tribunali hanno chiarito che la CN non deve essere usata solo per prendere tempo senza un serio intento di negoziare: ad esempio, sentenze del 2023 hanno revocato misure protettive quando hanno percepito che l’imprenditore la usava in malafede, solo per procrastinare pignoramenti senza una proposta concreta (”Usare la composizione negoziata come dilazione non funziona”, hanno titolato alcuni commentatori) . Quindi il debitore deve impegnarsi attivamente e dimostrare la propria buona fede e trasparenza, altrimenti il beneficio decade.
In sintesi, la composizione negoziata è un importante strumento di difesa preventiva: permette all’imprenditore in debito di prendere in mano la situazione, coinvolgere i creditori in un dialogo costruttivo con la “regia” di un esperto neutrale, e scegliere la soluzione migliore per tutti (che sia un accordo extragiudiziale, un piano attestato, un concordato o altro). Ha già mostrato risultati incoraggianti: in diversi casi, PMI che sarebbero probabilmente fallite sono riuscite a concludere accordi attraverso la CN, evitando il default e salvando la continuità (Unioncamere ha riportato un uso crescente di questo strumento, segno che sta entrando nella cultura delle imprese) . Per la nostra ipotetica azienda di motori brushless, ad esempio, se i segnali di crisi vengono colti con sufficiente anticipo, la composizione negoziata potrebbe essere il contesto ideale per rinegoziare debiti bancari e fornitori con l’aiuto di un esperto settoriale, magari arrivando a un piano attestato protetto. Se invece la situazione è già degenerata, la CN può preludere a un concordato semplificato per chiudere dignitosamente.
Altri strumenti: convenzioni di moratoria e accordi su crediti pubblici
Per completezza, citiamo brevemente altri strumenti previsti dal CCII, sebbene di utilizzo più specialistico:
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): è un accordo stipulato tra l’imprenditore e creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una certa categoria, avente a oggetto la moratoria temporanea dei pagamenti o la proroga delle scadenze. Questo strumento serve tipicamente per accordi settoriali, ad esempio con le banche: se le banche che detengono 3/4 dell’esposizione finanziaria accettano di congelare i crediti per un periodo, l’accordo può essere esteso anche alle eventuali banche dissenzienti minori della stessa categoria. È uno strumento affine agli accordi interbancari di ristrutturazione. La convenzione di moratoria, per avere efficacia, va pubblicata nel registro imprese. Non risolve di per sé la crisi, ma dà tempo (è infatti spesso propedeutica a un successivo accordo di ristrutturazione o concordato).
- Accordi sui crediti tributari o contributivi (transazione fiscale): all’interno di un concordato o accordo di ristrutturazione, l’art. 63 CCII consente di inserire una transazione fiscale e previdenziale, cioè un trattamento concordato dei debiti verso Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione e INPS/INAIL. Questo non è uno strumento a sé stante ma una parte fondamentale delle procedure, quando ci sono debiti fiscali. Consiste nel proporre all’Erario e agli enti una certa percentuale e/o dilazione, motivando che è il meglio possibile nell’interesse di tutti i creditori. Se l’ente aderisce, bene; se non aderisce, come detto, oggi c’è la possibilità di cram-down con l’omologa a certe condizioni (transazione fiscale “bloccata” d’ufficio). La normativa su questo tema è stata in fieri per anni e ora col CCII dovrebbe essere stabilizzata, con l’accortezza della legge 2023 che vincola maggiormente la falcidia IVA (nessun concordato può prevedere il pagamento di meno del 20% dell’IVA, salvo liquidazione del tutto incapiente, per via di vincoli euro-unitari). Ad ogni modo, l’imprenditore deve sapere che anche i debiti fiscali e contributivi possono essere trattati, non sono più intoccabili come un tempo: l’importante è seguire le procedure formali (non si possono fare “piani fai da te” col Fisco, ma attraverso accordi omologati si può ottenere sconto di interessi, sanzioni e anche parte dell’imposta in certi casi).
Abbiamo ora completato la panoramica dei possibili strumenti di difesa e gestione del debito. Nella tabella seguente riassumeremo le caratteristiche salienti di ciascuno, prima di passare ai doveri degli amministratori e ai profili di responsabilità.
Tabella riepilogativa degli strumenti di regolazione della crisi
| Strumento | Normativa | Natura | Requisiti | Vantaggi per il debitore | Svantaggi/Limiti | Quando usarlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trattativa stragiudiziale privata | – (libera autonomia) | Privata, volontaria | Consenso individuale di ciascun creditore coinvolto | – Riservata (nessuna pubblicità)<br>– Flessibile (si adatta ai singoli creditori)<br>– Nessun costo procedurale aggiuntivo | – Non vincola i dissenzienti (basta uno che si oppone per agire)<br>– Nessuna protezione legale dalle esecuzioni<br>– Successo dipende dalla buona volontà di tutti | Crisi iniziale con pochi creditori, rapporto fiduciario con essi, e capacità di trovare accordi bilaterali. |
| Piano attestato di risanamento | Art. 56 CCII | Stragiudiziale con attestazione | Piano idoneo a risanare<br>Attestazione da esperto indipendente<br>Data certa | – Nessun intervento del tribunale (rapido, discreto) <br>– Esenzione da revocatorie su atti esecutivi del piano <br>– Esonero da alcuni reati di bancarotta (se poi fallisce) <br>– Strutturato ma contrattuale: può coinvolgere solo i creditori necessari (non serve il 60% come ARD) | – Non blocca le azioni dei creditori non aderenti (assenza di stay) <br>– Necessario consenso effettivo di (quasi) tutti i principali creditori per funzionare<br>– Se un creditore rilevante resta fuori e agisce, può far saltare il piano<br>– Richiede costi di attestazione e completa trasparenza finanziaria verso l’attestatore | Crisi gestibile con accordo quasi unanime dei creditori chiave. Tipico per PMI con poche banche e fornitori disposti a collaborare. Utile se si vuole evitare pubblicità e si hanno soluzioni private già all’orizzonte. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Art. 57-64 CCII | Misto (privato + omologa) | Adesione ≥ 60% crediti <br>Attestazione indipendente<br>Ricorso in tribunale per omologa | – Vincola i creditori aderenti con forza di legge (dopo omologa)<br>– Permette misure protettive verso non aderenti (sospensione azioni, se pagati entro 120-180 gg) <br>– Non coinvolge tutti i creditori in votazione, solo i firmatari<br>– Meno lungo/costoso di un concordato (niente voto assembleare, procedura semplificata) | – Richiede comunque ampio consenso iniziale (60%)<br>– I non aderenti devono essere pagati integralmente (nessun taglio imposto a estranei, salvo forse interessi)<br>– Se troppe categorie diverse, difficile da applicare<br>– Necessita controllo giudiziale (tempi di omologa variabili)<br>– Pubblicità su Registro Imprese dell’accordo e decreto | Quando c’è larga maggioranza di creditori disposta a un accordo, ma non l’unanimità. Utile se il 60% accetta riduzioni e serve blindare quell’accordo imponendo una moratoria agli altri. Tipico per ristrutturazioni bancarie (75% banche possono vincolare resto) . |
| Accordo di ristrutturazione “agevolato” | Art. 60 CCII | Variante ARD | Adesione iniziale ≥ 30% per misure protettive <br>Adesione finale ≥ 60% per omologa<br>+ condizioni: nessuna precedente moratoria o misura protettiva attivata in 5 anni | – Soglia ridotta per iniziare (basta 30% per chiedere tutela) <br>– Stesse protezioni dell’ARD ordinario (stay azioni, ecc.)<br>– Incentivo all’emersione precoce: facilita avvio anche se consenso non ancora al 60% | – Comunque serve arrivare al 60% entro omologa<br>– Vincoli normativi stringenti (non deve aver già usato misure protettive recentemente, ecc.)<br>– Transazione fiscale possibile anche con Fisco non aderente ma secondo disciplina transitoria complessa | Quando il debitore ha un primo nucleo di creditori disponibili (≥30%) e vuole protezione subito per negoziare con gli altri. |
| PRO – Piano di ristrutturazione omologato | Artt. 64-bis e ss. CCII | Giudiziale innovativo | Classi di creditori formulate<br>Nessuna maggioranza richiesta ex ante (può essere omologato con cram-down classi dissenzienti)<br>Condizioni di legge: equità, convenienza per dissenzienti, rispetto ordine cause di prelazione | – Può essere omologato anche senza consenso di intere classi (cram-down) <br>– Evita la fase di voto creditore per creditore: decisione demandata al giudice<br>– Utile per superare blocchi irrazionali di minoranze dissenzienti | – Procedura comunque concorsuale e pubblica (simile al concordato come oneri)<br>– Criteri rigorosi: di fatto serve che il piano sia molto meritevole e vantaggioso rispetto al fallimento<br>– Poco sperimentato, incertezza applicativa | Raramente: casi ove il debitore ha un piano valido ma sa di non poter ottenere le maggioranze perché alcuni creditori (magari una classe) si oppongono per convenienza loro. Allora tenta l’omologa forzata dal tribunale. |
| Concordato preventivo (continuità o liquidatorio) | Artt. 84-120 CCII (più art. 25-sexies per semplificato) | Giudiziale concorsuale | Stato di crisi o insolvenza conclamata<br>Domanda con piano + proposta<br>Voto favorevole di >50% crediti votanti (salvo cram-down interclassi in certe circostanze)<br>Omologazione del tribunale | – Stay automatico: blocco immediato di pignoramenti e azioni appena presentata domanda <br>– Possibilità di abbattere il debito in percentuale (chirografari prendono quota stabilita, residuo esdebitato) <br>– Vincola tutti i creditori anteriori all’omologa (anche dissenzienti) una volta approvato<br>– Strumenti vari per favorire continuità: autorizzazione finanziamenti prededucibili, affitto d’azienda in continuità, ecc. | – Lungo e costoso: iter complesso (commissario, adunanza, voto, eventuali cause di opposizione), spese legali e per organi concorsuali<br>– Perdita di controllo: attività sotto vigilanza commissario e autorizzazioni del giudice<br>– Reputazione: procedura pubblica, rischio danni commerciali durante l’attesa<br>– Esito incerto: se il piano non convince i creditori o il giudice, si rischia il fallimento | Quando la situazione è grave e frammentata: serve ridurre drasticamente il debito o coinvolgere numerosi creditori che non troverebbero accordo spontaneo. È la “cura da cavallo” per evitare la liquidazione giudiziale, o per liquidare in modo ordinato se proprio non c’è altra via (salvaguardando un minimo i creditori). |
| Composizione negoziata (procedura di ausilio) | Artt. 12-25 CCII (da D.L. 118/2021) | Procedura volontaria, riservata (non concorsuale) | Impresa in squilibrio o crisi<br>Istanza alla Camera di Commercio<br>Nomina esperto indipendente<br>(Facoltativo: richiesta misure protettive al tribunale) | – Riservata (nessun annuncio pubblico, trattative confidenziali) <br>– Esperto facilitatore aiuta a trovare soluzione<br>– Possibile ottenere moratoria temporanea dal tribunale sulle azioni dei creditori (simile a pre-concordato) <br>– Imprenditore resta alla guida, nessuno spossessamento<br>– Può condurre a qualsiasi esito positivo (piano, accordo o concordato) senza vincoli predefiniti | – Non è di per sé risolutiva: se i creditori non collaborano, la CN sfuma<br>– Misure protettive non automatiche e di durata limitata<br>– In caso di esito negativo, bisogna comunque attivare altra procedura o si torna al punto di partenza<br>– Rischio di abuso da parte del debitore se non serio (ma giudici vigilano, possibili revoche) | Quando si vuole tentare un approccio concordato e mediato alla crisi, specialmente in fase iniziale o pre-insolvenza. Ideale se c’è margine per convincere i creditori sulla bontà di un piano, ma serve un contesto protetto e assistito per farlo. |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; “prededucibile” = con privilegio di pagamento prioritario in caso di concorsuale; stay = sospensione delle azioni esecutive dei creditori; cram-down = imposizione coattiva di un accordo anche ai creditori dissenzienti da parte del tribunale.)
Obblighi e responsabilità degli amministratori (difendersi dai debiti senza incorrere in guai personali)
Dal punto di vista del debitore societario, “difendersi” dai debiti non significa soltanto scegliere lo strumento giuridico adatto, ma anche comportarsi diligentemente per evitare che la situazione di crisi sfoci in responsabilità personali per chi amministra l’azienda. In un’azienda di capitali (S.r.l., S.p.A.) normalmente vige la regola della separazione patrimoniale: i debiti sociali si pagano con il patrimonio della società e i soci o amministratori non ne rispondono con il proprio, salvo eccezioni. Tuttavia, ci sono varie eccezioni e situazioni in cui gli amministratori possono dover rispondere di tasca propria per i debiti insoddisfatti, specialmente se la crisi è stata gestita male o tardivamente. Vediamo i principali doveri legali a carico degli amministratori e i correlati profili di responsabilità:
Dovere di conservazione del patrimonio sociale e gestione prudente: Il Codice Civile (art. 2394 per le S.p.A. e applicabile anche alle S.r.l.) impone agli amministratori di non pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale che è a garanzia dei creditori . In altre parole, se la società accumula debiti insostenibili e il patrimonio aziendale diventa insufficiente per pagarli, i creditori sociali possono sostenere che ciò è avvenuto a causa di atti od omissioni colpose degli amministratori e chiedere loro i danni. Questa è la cosiddetta azione di responsabilità per deficit patrimoniale (ex art. 2394 c.c.), che tipicamente viene esercitata dal curatore fallimentare nell’interesse di tutti i creditori (azione concorsuale) se la società fallisce, oppure direttamente dai creditori se la società non è fallita ma semplicemente insolvente. La giurisprudenza (Cass. Sez. Unite 24725/2021) ha chiarito che l’azione ex 2394 c.c. è concorsuale, nel senso che spetta in primis al curatore dopo il fallimento, e l’eventuale risarcimento va ripartito tra tutti i creditori chirografari . Ciò significa che, se la società viene dichiarata in liquidazione giudiziale, gli amministratori potrebbero essere citati dal curatore per rispondere dell’aggravamento del dissesto.
Dovere di istituire assetti adeguati e attivarsi tempestivamente (art. 2086 c.c. co.2): Come già accennato, dal 2019 esiste un preciso obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di strumenti organizzativi, contabili e di controllo idonei a cogliere segnali di crisi e di intervenire senza indugio per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi . Questo è un punto focale: significa che la legge impone di non restare inerti di fronte ai sintomi del dissesto. L’amministratore che, pur vedendo perdite e insoluti crescere, non convoca i soci, non consulta esperti, non cerca soluzioni e lascia che i debiti aumentino, viola questo dovere e può esserne chiamato a rispondere. In particolare, l’art. 2486 c.c. stabilisce che dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento (ad esempio la perdita del capitale sociale oltre certi limiti) o lo scioglimento della società, gli amministratori devono agire solo per la conservazione dell’integrità del patrimonio e non aggravare ulteriormente la situazione . Se continuano l’attività oltre quel limite, rischiano di dover risarcire i danni. Il Codice della Crisi, con l’art. 378, ha inserito un nuovo comma 3 all’art. 2486 c.c. che introduce criteri presuntivi di quantificazione del danno a carico degli amministratori inadempienti: in parole semplici, se si accerta che gli amministratori hanno proseguito la gestione in modo imprudente in presenza di cause di scioglimento, il danno risarcibile viene presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbero dovuto attivarsi e quello alla data dell’apertura della procedura concorsuale (oppure alla differenza tra entità dei debiti in quelle due date) . Ciò rende più agevole per i creditori o il curatore ottenere condanne degli amministratori, perché non serve provare nel dettaglio ogni singola operazione dannosa: basta mostrare che non hanno agito quando dovevano e che il buco si è ampliato in quell’arco di tempo.
Obblighi in caso di perdite rilevanti (artt. 2446-2447 c.c. per S.p.A. e 2482-bis/ter c.c. per S.r.l.): Collegato al dovere di cui sopra è la disciplina sul capitale sociale: se le perdite superano 1/3 del capitale e ricadono sotto il minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per provvedere, altrimenti la società dev’essere sciolta. Anche con la riforma, queste norme permangono. Quindi, se l’impresa accumula perdite gravi, gli amministratori devono formalizzare la situazione e o trovare nuovi apporti di capitale o mettere in liquidazione la società. Non farlo e continuare ad accumulare debiti è foriero di responsabilità.
Divieto di aggravare il dissesto e di favorire taluni creditori a scapito di altri: In vista di una possibile insolvenza, gli amministratori devono evitare atti che peggiorino la posizione dei creditori nel complesso. Ad esempio, contrarre nuovi debiti quando si è già in insolvenza conclamata potrebbe configurare un abuso di credito e costituire un elemento di “bancarotta preferenziale” o “ricorso abusivo al credito” se poi si fallisce. Anche pagare alcuni creditori escludendone altri* in prossimità dell’insolvenza può essere visto come atto di mala gestio (oltre che potenzialmente un reato di bancarotta preferenziale se c’è fallimento).
Responsabilità civile vs penale: Sul piano civilistico, le conseguenze sono quelle economiche: l’amministratore negligente può essere condannato a risarcire i creditori per aver tardato ad attivarsi. Un esempio recente è la Cass. Civ. 23659/2023, che ha stabilito che la prescrizione dell’azione di responsabilità verso amministratori (ex art. 146 L.F., corrispondente all’azione dei creditori ex 2394 c.c. esercitata dal curatore) decorre dal momento del fallimento salvo prova contraria . Questo per dire che i creditori (rappresentati dal curatore) hanno tempo dal fallimento per riflettere e agire contro gli ex amministratori, senza perder tempo prima – il che “responsabilizza ulteriormente gli amministratori durante la gestione nella crisi” . Tradotto: chi guida l’azienda in crisi sa che la spada di Damocle di una causa per responsabilità rimane pendente per anni dopo l’eventuale default, quindi è meglio che faccia le cose per bene.
Sul piano penale, invece, entrano in gioco i reati fallimentari: se la società finisce in liquidazione giudiziale, le autorità e il curatore esamineranno la condotta degli amministratori negli anni precedenti. Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice sono le due grandi categorie. La bancarotta fraudolenta (artt. 322-323 CCII, ex artt. 216-223 L.F.) punisce gli amministratori (e eventuali complici, anche soci) che abbiano distratto o occultato beni della società, esposto passività inesistenti, sottratto o falsificato le scritture contabili, o comunque compiuto atti dolosi di depauperamento prima del fallimento. Le pene sono gravi: reclusione da 3 a 10 anni nelle ipotesi più serie (patrimoniale fraudolenta) . La bancarotta semplice (ex art. 324 CCII, già art. 217 L.F.) invece sanziona condotte meno dolose ma comunque colpose come l’aver aggravato il dissesto con spese personali eccessive, operazioni imprudenti, o non aver tenuto la contabilità in modo regolare, con pene fino a 2 anni. Inoltre c’è la bancarotta preferenziale (parte della fraudolenta) per chi, in stato di insolvenza, paga o garantisce un creditore pregiudicando gli altri volontariamente: punita anch’essa con pena detentiva. Tutto questo per dire: se un amministratore, ad esempio, sottrae liquidità dalla società per metterla al sicuro altrove, oppure vende sottocosto beni aziendali a un amico, o ancora registra ad arte false perdite, e poi la società fallisce, molto probabilmente sarà imputato per bancarotta fraudolenta, rischiando la galera . Se invece la sua condotta è stata solo negligente – ha tirato avanti troppo a lungo, non ha tenuto i conti – potrà essere accusato di bancarotta semplice, che è meno infamante ma sempre un reato. Da sottolineare: la riforma del 2022 non ha depenalizzato affatto questi reati, li ha in gran parte trasportati nel nuovo Codice mantenendone la sostanza . Dunque la difesa del debitore passa anche per l’onestà e la trasparenza: un imprenditore che affronta la crisi con correttezza, documentando tutto e scegliendo per tempo uno strumento di composizione della crisi, ha molte più probabilità di evitare conseguenze penali. Ad esempio, se attiva una composizione negoziata e poi un concordato, è difficile che gli si imputi bancarotta semplice: sta facendo ciò che la legge chiede (attivarsi senza indugio) . Non solo: se pure il concordato dovesse poi convertirsi in fallimento, il fatto di aver tentato la via legale e di aver coinvolto un tribunale può costituire un elemento a suo favore in sede di valutazione penale.
Un caso riportato è quello deciso dal Tribunale di Milano nel 2024: un amministratore entrato in carica poco prima del fallimento, che però aveva fatto “tutto il possibile” – compreso presentare una domanda di concordato preventivo, poi sfumata per cause esterne – è stato esonerato da responsabilità; il giudice ha riconosciuto che aveva agito correttamente e tempestivamente, dunque non gli si poteva imputare il dissesto causato da fattori già in essere . Questo conferma che chi agisce in buona fede e segue le procedure consigliate si mette al riparo sia da cause civili, sia da accuse penali.
Responsabilità dei soci e di altri soggetti: In genere i soci non rispondono dei debiti sociali (salvo società di persone o società di capitali con garanzie prestate). Tuttavia, i soci di controllo che abbiano di fatto diretto la società possono essere considerati amministratori di fatto e subire le stesse azioni di responsabilità o imputazioni per bancarotta (se ad esempio hanno imposto scelte disastrose). Anche i membri del collegio sindacale o revisore possono incorrere in guai (specie se non vigilano e omettono di rilevare irregolarità – es. Cass. Pen. 1162/2024 ha condannato un presidente del collegio sindacale per concorso in bancarotta per omesso controllo) . Quindi c’è un intero ecosistema di responsabilità attorno alla crisi d’impresa.
In conclusione, dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, “difendersi dai debiti” significa anche difendersi dalle possibili azioni contro di lui: per farlo, la via maestra è la tempestività e trasparenza. Appena la situazione degenera, coinvolgere i professionisti giusti (legali, consulenti della crisi) è segno di diligenza . Attivare gli strumenti offerti dal Codice della Crisi (come la composizione negoziata) testimonia la volontà di fare il possibile per salvare baracca e creditori. Se poi, nonostante gli sforzi, l’impresa non si salva, almeno l’amministratore avrà costruito una difesa solida per sé: “ho fatto tutto il possibile, in modo ordinato e leale” . E la legge, oggi, tende a non punire chi si comporta in tal modo, riservando le sanzioni a chi ignora i segnali o peggio trucca le carte.
Profili penali in caso di insolvenza e condotte illecite
Abbiamo anticipato alcuni temi penali, ma giova ricapitolarli in maniera più sistematica, poiché ogni imprenditore-debitore deve aver ben presente cosa non fare assolutamente durante la crisi, per non trasformare un problema economico in un problema giudiziario personale. I principali reati che possono emergere nel contesto di un’impresa indebitata sono:
- Reati fallimentari (bancarotta fraudolenta e semplice): scattano solo se si apre una procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento). La bancarotta fraudolenta patrimoniale punisce l’imprenditore (amministratore) che prima o durante il fallimento distrugge, occulta, disperde, distrae o sottrae beni dell’impresa allo scopo di frodare i creditori. Ad esempio, portare via macchinari dal magazzino e venderli “in nero” all’estero poco prima di fallire, oppure prelevare ingenti somme dalla cassa societaria senza giustificazione, integra questa fattispecie. Pene: reclusione da 3 a 10 anni (nel nuovo Codice, art. 322 CCII, allineato al vecchio art. 216 L.F.) . La bancarotta fraudolenta documentale punisce chi sottrae o falsifica i libri contabili per ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: quindi tenere contabilità “in nero”, distruggere fatture, manipolare bilanci può portare a questa accusa (stesse pene). La bancarotta preferenziale è un’altra forma di bancarotta fraudolenta: si ha quando, in stato di insolvenza già manifestatasi, l’imprenditore paga o garantisce intenzionalmente un creditore pregiudicando gli altri. Esempio: sapendo di essere spacciato, paga integralmente un fornitore amico e lascia tutti gli altri a bocca asciutta; oppure costituisce un’ipoteca a favore della banca X su un bene sociale quando gli affari vanno male, cosciente di fare un “favoritismo” (in tal caso X riceve garanzia che altri non hanno). Questa condotta, se fatta con dolo di favorire quel creditore, è reato (punita fino a 2-6 anni di reclusione di solito). Notare: la legge esenta però i pagamenti eseguiti in buonafede nell’ambito di un piano attestato omologato, proprio per non punire chi segue un piano di risanamento attestato anche se poi fallisce (art. 324 comma 4 CCII, ex art. 217-bis L.F.). La bancarotta semplice (art. 324 CCII, ex 217 L.F.) invece si applica a imprenditore fallito per colpa grave, ad esempio per avere speso somme eccessive per fini personali, o per aver ritardato la richiesta di fallimento aggravando il buco, o ancora per non aver tenuto i libri o inventario. È punita con reclusione fino a 2 anni, quindi assai meno severa, ma sempre una condanna penale. In sintesi: se l’impresa arriva al fallimento, tutto ciò che gli amministratori hanno fatto negli ultimi anni verrà passato al setaccio; se emergono ammanchi, trasferimenti di denaro ingiustificati, favoritismi o lacune contabili, è probabile un’accusa di bancarotta. Miglior difesa: non fare nulla di questo, anzi – come ribadito – documentare ogni scelta e possibilmente farle approvare in procedure trasparenti (es. concordato) così da fugare sospetti di frode.
- Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): è un reato tributario (non legato al fallimento; sussiste di per sé) che si configura quando la società non versa l’IVA dovuta annualmente, in misura superiore a €250.000 per periodo d’imposta . La soglia di punibilità è stata confermata anche nel 2024. La condotta si perfeziona alla data di scadenza del versamento dell’acconto IVA dell’anno successivo (in base alla riforma 2024): in pratica, se la società nel 2024 non versa l’IVA dovuta per il 2023 oltre €250k, e al 31 dicembre 2024 ancora non ha rimediato o preso un piano di rateizzo, scatta il penale. Pena: reclusione 6 mesi – 2 anni . Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000): simile al precedente, riguarda le ritenute fiscali sui redditi di terzi (es. ritenute su stipendi o pagamenti autonomi). Soglia penale: €150.000 annui non versati . Pena: 6 mesi – 2 anni. Per entrambi questi reati, come visto, dal 2024 c’è una causa di non punibilità se il debito è in corso di rateazione “bonaria” con AdE e non decaduta . Questo significa che l’amministratore può evitare il penale attivandosi per tempo in un piano di dilazione (non quello concorsuale, ma quello amministrativo), e onorandolo. Consiglio pratico: mai ignorare i debiti IVA e ritenute, perché su quelli la Procura è obbligata a intervenire se segnalati. Se l’azienda non può pagarli subito, almeno formalizzare una rateizzazione – ciò dà respiro e protegge penalmente . Rientra in queste fattispecie il classico caso della società in crisi che decide “Pago gli stipendi netti ai dipendenti ma non verso le ritenute/IVA perché non ho soldi”: umanamente comprensibile, ma penalmente rilevante. La Cassazione ha più volte detto che la crisi di liquidità non esclude il dolo in questi reati, a meno che non sia assolutamente inevitabile (e va provato) .
- Omesso versamento di contributi previdenziali (art. 2, co.1-bis, D.L. 463/1983 conv. L.638/83): come già spiegato, se il datore di lavoro non versa all’INPS le ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per un importo complessivo annuo sopra €10.000, commette reato . Non importa che abbia pagato gli stipendi netti: la trattenuta che non arriva all’INPS configura un’appropriazione indebita ai danni dello Stato. È un reato contravvenzionale punito con ammenda fino a 4 volte il non versato o con arresto fino a 3 anni nei casi più gravi, anche se negli ultimi anni sotto i €10k è stata depenalizzata (diventa solo sanzione amministrativa). La particolarità è che l’INPS prima di denunciare deve inviare una diffida ad adempiere: se entro 3 mesi dalla notifica il datore versa i contributi dovuti, il reato è estinto e non si procede. Dunque, c’è un’ultima opportunità di ravvedimento, che chiunque dovrebbe cogliere. In caso contrario, la giurisprudenza è severa: hanno condannato amministratori anche in situazioni di crisi, affermando che la scelta di pagare altri debiti e non i contributi configura comunque il dolo generico del reato, perché si privilegiano altri pagamenti rispetto ai doveri contributivi . Solo un’assoluta impossibilità di pagare potrebbe essere scusante (ad esempio, cassa vuota per cause di forza maggiore), ma è difficile da dimostrare in concreto .
- Altri reati tributari: se la società, per reperire liquidità, entra in meccanismi illeciti – ad esempio emette fatture false per ottenere crediti o gonfiare costi – può incorrere in reati di frode fiscale (D.Lgs. 74/2000). Oppure, se nasconde beni per evitare il pignoramento delle imposte, c’è il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Esempio: trasferire la proprietà di un immobile a un’altra società/socio per evitare che il Fisco vi iscriva ipoteca – se fatto con dolo, è reato. In generale, qualsiasi artifizio per sfuggire ai creditori (specie erariali) rischia di avere un rilievo penale.
- Falso in bilancio (artt. 2621 e segg. c.c.): un imprenditore potrebbe essere tentato di falsificare i bilanci per nascondere la crisi (magari per ottenere nuovo credito). Ma ciò costituisce reato societario. Per le non quotate, il falso in bilancio semplice è punibile con multa o reclusione fino a 2-4 anni a seconda della gravità (non è più depenalizzato come in passato). Se il falso in bilancio è finalizzato a ingannare banche o investitori ottenendo finanziamenti, può configurarsi anche una truffa. Dunque, sconsigliatissimo manipolare le scritture per guadagnare tempo: non solo viola i doveri societari, ma può peggiorare la posizione penale dell’amministratore quando emergerà (e di solito emerge, specie in un fallimento, quando il curatore confronta i numeri).
- Ricorso abusivo al credito: nell’ombra del panorama penale c’è un concetto (che era nell’art. 218 vecchia L.F., ora eliminato come reato autonomo, ma può rientrare nella bancarotta semplice): ossia continuare a indebitarsi quando si sa di non poter ripagare, facendo abuso del credito altrui. Se portato all’estremo, potrebbe portare a conseguenze penali. In pratica, l’imprenditore disperato che prende nuovi fornitori a credito o finanziamenti nascondendo la reale insolvenza sta compiendo atti che, se poi fallisce, saranno valutati con sospetto e potrebbero far parte di un’accusa di bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto contrendo nuovi debiti ingiustificati).
In positivo: la miglior condotta per non incappare nel penale è: tenere una contabilità corretta e aggiornata; non “sparire” con asset aziendali; non privilegiare nessuno arbitrariamente (se serve, farlo in un contesto negoziato, es. piano attestato); pagare nei limiti del possibile contributi e IVA, o se non possibile, almeno aderire a piani di rateizzo o includerli in un concordato con la transazione fiscale; coinvolgere i creditori e il tribunale in modo limpido attraverso le procedure formali (questo toglie ogni ipotesi di dolo). E soprattutto, non aspettare l’ultimo secondo: molte condotte da bancarotta nascono quando, arrivati al collasso, si compiono gesti disperati (tipo svuotare la cassa la notte prima di chiudere). Se invece si gioca d’anticipo, si può evitare di trovarsi con l’acqua alla gola che spinge a illeciti.
In sintesi, l’imprenditore onesto e prudente raramente finirà sotto processo penale: le norme esistono per punire chi froda il Fisco, i lavoratori, i creditori o chi dissipa il patrimonio aziendale. Al contrario, il quadro normativo attuale, come evidenziato, dà strumenti per agire correttamente: chi li usa, oltre a fare il bene dell’impresa e dei creditori, mette una barra di protezione attorno a sé. Vale la pena ricordare un detto citato spesso: “nemo tenetur ad impossibilia” – a nessuno è richiesto l’impossibile. La legge non pretende che l’imprenditore salvi l’azienda a ogni costo, ma pretende che faccia tutto il possibile per gestire la crisi con trasparenza e senso di responsabilità . Se lo fa, anche un eventuale fallimento sarà visto come frutto di sfortuna o contingenze, non come colpa: e in quel caso né i giudici civili né quelli penali avranno motivo di punirlo.
Domande Frequenti (FAQ)
D1: La mia S.r.l. può essere dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) se non riesce a pagare i debiti?
R: Sì, se la tua società è insolvente (incapace di soddisfare regolarmente le obbligazioni) e non rientra nelle categorie “non fallibili” (in generale, tutte le S.r.l. e S.p.A. sono soggette a fallimento salvo che siano sotto soglie dimensionali davvero basse, come definito dal vecchio art. 1 L.F.), allora potenzialmente i creditori o anche la società stessa possono chiederne la liquidazione giudiziale al tribunale. Quindi una S.r.l. di medie dimensioni produttrice di motori brushless certamente può essere assoggettata a fallimento secondo la legge. Ciò che è cambiato con il nuovo Codice è più terminologico che sostanziale: oggi si parla di liquidazione giudiziale, ma la procedura è l’erede del fallimento tradizionale. Tieni presente però che la liquidazione giudiziale non è inevitabile: se riesci ad attivare per tempo uno strumento di regolazione della crisi (concordato, accordo, ecc.), puoi evitare o quanto meno posticipare l’apertura del fallimento. Ad esempio, presentare un ricorso per concordato preventivo in bianco prima che il tribunale decida su un’istanza di fallimento blocca quest’ultima (il tribunale sospenderà per valutare il concordato). In sostanza, la fallibilità c’è, ma hai modo di giocare d’anticipo con le procedure di composizione, se la situazione lo consente.
D2: Qual è la differenza tra “stato di crisi” e “insolvenza” ai fini legali?
R: Crisi è uno stato di difficoltà economico-finanziaria reversibile o ancora non conclamata, in cui l’impresa ha squilibri (ad es. prevede di non far fronte ai propri obblighi nei prossimi 6-12 mesi) ma non è ancora nel pallone totale. Insolvenza è invece l’incapacità attuale e non temporanea di adempiere alle obbligazioni: si manifesta con inadempimenti, protesti, mancanza di liquidità cronica. La crisi è uno stadio iniziale, l’insolvenza è lo stadio finale patologico. Dal punto di vista legale, lo stato di insolvenza è il presupposto per la liquidazione giudiziale (fallimento) e per il concordato preventivo; invece lo stato di crisi (anche solo probabile insolvenza futura) è sufficiente per attivare la composizione negoziata e gli altri strumenti di allerta e ristrutturazione (accordi e piani, pure il concordato può essere richiesto in stato di crisi, non serve essere già insolventi conclamati). Questo significa che dovresti agire già in fase di “crisi”, senza aspettare l’insolvenza conclamata, perché la legge te lo consente e anzi incoraggia a farlo.
D3: Come posso evitare che i creditori mi portino in tribunale e facciano fallire la società?
R: La miglior difesa è l’offesa proattiva: se vedi che alcuni creditori stanno perdendo la pazienza (ad esempio banche che minacciano di escutere garanzie, fornitori che minacciano decreti ingiuntivi), prendi tu l’iniziativa e proponi un piano di rientro oppure avvia formalmente una procedura come l’accordo di ristrutturazione o il concordato. In particolare, se temi un’istanza di fallimento imminente, presentare un concordato preventivo con riserva (in bianco) mette uno stop immediato: il tribunale, aperto il concordato, non dichiarerà il fallimento e i creditori dovranno attendere l’esito del concordato. Anche la composizione negoziata può aiutare: se comunichi ai creditori che hai avviato la procedura con un esperto, molti saranno più inclini ad attendere l’esito invece di precipitarsi in azioni individuali (sanno che c’è un negoziato in corso e magari misure protettive ordinate dal giudice). In pratica, devi negoziare o legalmente congelare. Mai restare immobile: se non paghi e basta, il creditore può (e spesso deve, per obblighi interni) agire. Ma se tu gli offri un percorso alternativo credibile (es. “aderisci al mio accordo e in 6 mesi recuperi il 50% anziché rischiare lunghe cause”), magari preferirà trattare. Ricorda: la legge ti consente di chiedere al giudice di sospendere le azioni esecutive (nel concordato e nella composizione negoziata). Quindi hai strumenti per proteggerti temporaneamente mentre organizzi una soluzione.
D4: I debiti fiscali (Erario) e contributivi (INPS) si possono includere in un piano di ristrutturazione? Posso non pagarli per intero legalmente?
R: Sì, oggi è possibile gestire anche i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali in modo concordato. Ci sono due modalità: – Stragiudiziale amministrativa: fuori dalle procedure concorsuali, puoi chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione (per cartelle esattoriali) fino a 72 rate standard, o fino a 120 rate in casi di comprovata e grave difficoltà. La legge di bilancio 2023 ha introdotto ad esempio una definizione agevolata (“rottamazione-quater”) per le cartelle fino al 2017 condonando sanzioni e interessi. Queste misure vanno e vengono, ma periodicamente ci sono. Rateizzando, eviti ganasce e diluisci il pagamento. Non ottieni un taglio dell’imposta di base, salvo normative speciali, ma almeno prendi tempo. Inoltre, come detto, se sei in regola col piano di rate, non incappi nel penale per IVA/ritenute. – Procedurale concorsuale: all’interno di un accordo di ristrutturazione o concordato, puoi proporre la cosiddetta transazione fiscale (art. 63 CCII). In sostanza, presenti a Agenzia Entrate/Agenzia Riscossione/INPS una proposta di pagamento ad es. del X% del debito con dilazione in Y anni. Se l’ente aderisce, il piano andrà avanti con quei termini e la parte eccedente verrà stralciata (condonata) una volta eseguiti i pagamenti concordati. Se l’ente non aderisce, il tribunale può ugualmente omologare il concordato o l’accordo se ritiene che la proposta verso l’ente pubblico è equa (non inferiore a quanto l’ente otterrebbe in un fallimento) . Questo è il famoso “cram-down fiscale” introdotto per superare i veti del Fisco, con alcuni aggiustamenti nel 2023 per rispettare la normativa UE (ad esempio, almeno l’IVA devi pagarla in misura significativa, non zero, salvo catastrofi). Quindi, sì, puoi ridurre legalmente anche il carico fiscale e contributivo, ma devi farlo in sede di accordo/concordato, seguendo regole precise. Non puoi invece decidere autonomamente di pagare metà IVA e pretendere che vada bene: al di fuori di queste procedure, l’unica è pagare integralmente (o sperare in condoni legislativi). – Nota: i debiti IVA storicamente erano intoccabili, ora sono trattabili nei limiti in cui ottengono almeno il trattamento del “miglior interesse” (ovvero non meno di quanto l’Erario incasserebbe liquidando l’azienda). Questo spesso significa che se l’azienda è proprio insolvente e fallendo l’Erario incasserebbe zero, anche nel concordato può prendere zero di IVA ed è accettabile. Ma se qualche soldo c’è, una parte di IVA va destinata lì.
In pratica, includere Fisco e INPS nel perimetro del risanamento è non solo possibile ma necessario se hai debiti ingenti verso di loro. Ignorarli significherebbe fallire comunque, perché lo Stato ha poteri esattivi forti. Meglio coinvolgerli proponendo il massimo fattibile. E ora la legge ti dà strumenti per far approvare il tutto anche contro la loro volontà in alcuni casi.
D5: Cosa rischio penalmente se non pago tasse o contributi per salvare liquidità?
R: Rischi parecchio. Se non versi l’IVA oltre €250k annui o le ritenute oltre €150k, commetti reato tributario (punibile con la reclusione) . Se non versi i contributi INPS trattenuti ai dipendenti oltre €10k, commetti altro reato . Inoltre, se arrivi al fallimento, qualunque utilizzo di risorse per fini diversi dal pagamento dei debiti fiscali/contributivi potrebbe essere visto come dolo generico nei reati suddetti (la Cassazione dice che pagare altri debiti al posto di IVA/INPS non scusa l’omissione, anzi conferma la volontarietà) . Quindi, rischi denunce da parte dell’Agenzia Entrate (per IVA/ritenute) e dell’INPS (per contributi) e condanne penali, oltre a dover comunque pagare poi quelle somme con interessi e sanzioni. Nel caso tu abbia deliberatamente destinato le risorse altrove (es. hai preferito pagare fornitori per continuare l’attività e non hai versato IVA), penalmente non è una giustificazione sufficiente. L’unica ancora di salvezza è: se sei ancora in tempo, metti in regola almeno parzialmente queste posizioni – ad esempio chiedi un piano di rate all’AdE-Riscossione prima che scattino le soglie penali o comunque prima che la Procura proceda. Dal 2024, se hai un piano di rateazione in corso e paghi regolarmente, non sei punibile per omesso versamento (il reato “non si perfeziona” se è in corso estinzione rateale) . Quindi consigliabilissimo: appena vedi che non riesci a pagare IVA o contributi, attivati con l’ente per trovare un accordo di pagamento. Se la situazione è tanto grave da dover includere quelle somme in un concordato, allora segui la strada concorsuale (transazione fiscale) di cui sopra. In sintesi: se semplicemente non paghi e basta, rischi denunce penali; se invece formalizzi un percorso (rate o concordato), mitighi o annulli il rischio penale.
D6: I debiti della società possono ricadere sugli amministratori o sui soci personalmente?
R: In linea generale, no per i soci, in casi specifici sì per gli amministratori. Mi spiego: la S.r.l. e la S.p.A. hanno per definizione autonomia patrimoniale perfetta, quindi i soci perdono al massimo il capitale investito e non rispondono con il loro patrimonio dei debiti sociali (salvo abbiano firmato garanzie personali a qualche creditore, il che però è un impegno contrattuale a parte, non effetto legale della partecipazione). Gli amministratori, come persone fisiche, neppure rispondono automaticamente dei debiti sociali: se la società non paga un fornitore, il fornitore non può chiedere i soldi a te amministratore solo per il fatto che sei amministratore. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l’amministratore diventa responsabile verso i creditori: – Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.: se per colpa o dolo dell’amministratore il patrimonio sociale è diventato insufficiente a pagare i creditori (ad esempio ha compiuto atti di mala gestione, ha ritardato il fallimento aggravando le perdite), i creditori (o il curatore in caso di fallimento) possono citare l’amministratore in giudizio per danni. In caso di condanna, l’amministratore deve versare di tasca propria una somma che va a beneficio dei creditori insoddisfatti . Esempio: la società fallisce e c’è un buco da €1 milione; si dimostra che se l’AD avesse fermato l’attività un anno prima il buco sarebbe stato di 300k; quell’AD può essere condannato a pagare la differenza (700k) a titolo di danno. – Debiti verso il Fisco per cui l’amministratore è obbligato in solido per legge: alcuni tributi, come ritenute d’acconto operate e non versate, possono vedere l’amministratore chiamato a rispondere come obbligato d’imposta (soprattutto in casi di omesso versamento doloso, l’Agenzia può a volte iscrivere a ruolo anche il rappresentante). Ma in generale non succede per IVA o imposte dirette (lì colpiscono la società, a meno di reati penali con confisca). – Garanzie personali: come detto, se hai firmato fideiussioni, quel è un obbligo tuo: quindi la banca potrà attaccare direttamente la tua casa se la società non paga, sulla base della fideiussione. – Debiti verso dipendenti per retribuzioni e TFR: qui c’è il Fondo di Garanzia INPS che interviene, però l’INPS poi si insinua verso la società. Non coinvolge l’amministratore direttamente, a meno che non vi siano stati illeciti. – Responsabilità penale: se l’amministratore commette reati come bancarotta, una condanna penale può prevedere anche il risarcimento dei danni ai creditori (oltre a carcere). Ad esempio, l’amministratore bancarottiere può essere obbligato a risarcire il buco, e quello diventa un debito civile suo.
In sintesi, la forma societaria protegge i soci (che non abbiano dato garanzie) e in prima battuta anche gli amministratori. Ma se questi ultimi hanno violato i loro doveri, la protezione cade e il loro patrimonio personale può essere aggredito per soddisfare i creditori insoddisfatti . Un amministratore accorto deve quindi sia operare nel rispetto delle regole (così nessuno potrà imputargli danni), sia magari dotarsi di una polizza D&O (Directors and Officers Liability) che copre eventuali richieste risarcitorie (tranne i casi di dolo) . Molti amministratori infatti stipulano assicurazioni ad hoc, che in caso di condanna per colpa grave pagano in loro vece (entro massimali). Ma attenzione: se c’è dolo o reato, l’assicurazione non paga e si resta esposti . Quindi la miglior protezione è la condotta diligente.
D7: Posso continuare ad operare con l’azienda durante la procedura di crisi (concordato, accordo ecc.) o dovrò fermare la produzione?
R: Dipende dallo strumento e dalla gravità della situazione. In generale, tutti gli strumenti puntano a salvaguardare la continuità aziendale se possibile. Nel concordato in continuità, ad esempio, l’azienda continua a produrre e vendere durante la procedura, sotto supervisione del commissario ma con i medesimi amministratori in carica. Certo, dovrai essere virtuoso: non puoi fare nuove esposizioni senza autorizzazione, ma l’attività ordinaria prosegue per generare cassa con cui pagare i creditori secondo piano. In un accordo di ristrutturazione, non c’è nemmeno commissario: tu continui a gestire come sempre, solo stai attento a rispettare l’accordo con i creditori (es. pagare le rate concordate ecc.). Nella composizione negoziata, assolutamente sì: l’idea è proprio di permetterti di proseguire l’attività mentre tratti la ristrutturazione, evitando la perdita di valore. Addirittura, la legge prevede che in CN, con autorizzazione, puoi fare atti urgenti di ordinaria e straordinaria amministrazione per evitare di interrompere l’attività (es. contrarre un piccolo finanziamento prededucibile per comprare materie prime e completare una commessa). Quindi, finché sei in una prospettiva di risanamento, l’obiettivo è mantenere l’azienda operativa. Soltanto se si va verso un concordato liquidatorio allora, una volta venduti i beni, di fatto l’attività cessa. E ovviamente in liquidazione giudiziale (fallimento) l’attività viene in genere sospesa o liquidata, salvo l’esercizio provvisorio autorizzato in casi particolari. Ma nelle procedure “preventive” lo scopo è di evitare quel punto di non ritorno, quindi sì, puoi e dovresti continuare la produzione se genera margine. Considera però: dovrai forse affrontare qualche difficoltà pratica, tipo fornitori diffidenti (magari chiedono pagamento anticipato una volta che sanno del concordato) o clienti preoccupati. Sta a te e ai tuoi consulenti gestire la comunicazione e rassicurarli che l’azienda, pur in procedura, sta andando avanti. Molte aziende sono passate attraverso un concordato in continuità e hanno proseguito la loro attività (un esempio noto fu quello di Air Italy (ex Meridiana) o molte società nel settore edile). Quindi è fattibile, anche se richiede un grande sforzo di coordinamento.
D8: Che differenza c’è tra concordato preventivo e liquidazione giudiziale (fallimento)?
R: In breve: – Il concordato preventivo è una procedura che precede l’eventuale fallimento e mira a evitare la dispersione dei valori. È proposta dal debitore, gestita in modo da includere i creditori e ottenere il loro consenso a un piano che di solito prevede il pagamento parziale dei debiti o la riorganizzazione. Il debitore rimane in carica (sia pure controllato), e se tutto va bene l’impresa può uscirne risanata (o comunque chiudere pagando una percentuale ai creditori). Al termine del concordato omologato e eseguito, i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione concordataria implicita nell’omologa: la liberazione da ciò che non è stato soddisfatto come da piano). – La liquidazione giudiziale (fallimento) è la procedura concorsuale liquidativa avviata d’ufficio o su istanza di terzi, in cui il debitore viene espropriato dell’azienda e delle sue attività, che passano sotto il controllo di un curatore nominato dal tribunale. L’obiettivo qui non è salvare l’impresa, ma liquidare i beni e distribuire il ricavato secondo la graduatoria dei crediti. L’impresa cessa generalmente la sua attività (salvo appunto brevi esercizi provvisori se vendere come azienda intera rende di più). I creditori non hanno voce in capitolo in un voto, subiscono la procedura e attendono il riparto finale. Spesso nel fallimento i creditori chirografari ricevono poco o nulla, e ci vogliono anni per chiudere la procedura. Inoltre, per l’imprenditore fallito (persona fisica) c’è lo stigma, sebbene oggi alleggerito, e possibili restrizioni (inabilitazioni temporanee).
Insomma, il concordato è una sorta di “accordo controllato” per evitare il fallimento, mentre la liquidazione giudiziale è la resa finale. Dal punto di vista del debitore, il concordato è preferibile perché ti dà un ruolo (sei tu a proporre come sistemare i debiti), protegge meglio la continuità aziendale e, se riesce, ti libera dai debiti residui. Il fallimento è subíto e comporta la fine dell’impresa come entità. Idealmente, il fallimento dovrebbe capitare solo quando ogni tentativo di concordato o accordo è impraticabile o fallito. Infatti la filosofia del Codice della Crisi è proprio “risolvere la crisi prima che degeneri; la liquidazione giudiziale solo in extremis” .
D9: Cos’è il “concordato semplificato” di cui ho sentito parlare?
R: Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una particolare procedura prevista dall’art. 25-sexies CCII, introdotta dal D.L. 118/2021, la quale consente all’imprenditore di chiedere al tribunale un concordato senza il voto dei creditori, esclusivamente liquidatorio (cioè vendi i beni e distribuisci il ricavato). È definito “semplificato” perché salta la fase della votazione e perché presuppone che prima sia stata tentata una composizione negoziata senza successo. In pratica, se tu attivi la composizione negoziata e l’esperto, alla fine, certifica che non è stato possibile trovare un accordo, ma c’è la possibilità di liquidare i beni in modo soddisfacente per i creditori più di quanto farebbe un fallimento, allora puoi proporre al tribunale questo concordato semplificato. Il tribunale nomina un liquidatore, i creditori possono fare osservazioni ma non votano, e si procede a liquidare. È una via di mezzo tra concordato e fallimento, introdotta per incentivare comunque a passare dalla composizione negoziata: anche se non salvi l’azienda, almeno chiudi in maniera ordinata (ad esempio vendendo l’azienda in blocco invece che frammentare in asta fallimentare). Nella pratica è stato usato pochissimo sinora (casi di microimprese). Per un’azienda manifatturiera strutturata come la tua ipotetica, conta il giusto: speriamo mai di dovervi ricorrere, perché vorrebbe dire che la CN è fallita e non ci sono margini di ristrutturazione. Comunque, sappi che esiste questa opportunità residuale. Non richiede la maggioranza dei creditori, ma richiede la loro informazione e serve convincere il giudice che è la soluzione migliore residua.
D10: Se la mia azienda è molto piccola (sotto le soglie di fallibilità), quali procedure posso usare?
R: Per le imprese “minori” (es. piccoli imprenditori commerciali sotto soglie di attivo, ricavi, debiti – ora mi pare nel CCII soglia 300k attivo, 200k ricavi, 500k debiti, simili alle vecchie), e per gli imprenditori agricoli o professionisti, il fallimento non si applica. Però esiste la sezione del Codice dedicata al sovraindebitamento (che ha sostituito la legge 3/2012). Lì dentro ci sono procedure come: – il concordato minore, che è analogo al concordato preventivo ma su scala ridotta e senza alcune complessità (destinato ai debitori “non fallibili”); – il piano di ristrutturazione del consumatore o dell’imprenditore minore, che è un piano simile al concordato ma calibrato per persone fisiche o ditte individuali; – la liquidazione controllata del patrimonio, che è l’equivalente del fallimento per il soggetto non fallibile (es. un piccolo imprenditore artigiano può essere messo in liquidazione controllata anziché fallimento, ma la sostanza è simile).
Nel tuo caso, una S.r.l. anche se piccola è soggetta a fallimento di solito (le soglie legali non escludono le società di capitali, a differenza di prima il CCII ammette al concordato anche imprenditori minori di default, quindi la distinzione è più sfumata). Comunque, per rispondere: se un’azienda è micro e non “fallibile”, può comunque fare concordato minore o piano di ristrutturazione, e accedere all’esdebitazione finale (la liberazione dai debiti residui, che per le società di persone spetta ai soci e per le persone fisiche ai debitori stessi). L’esdebitazione, a proposito, oggi spetta anche all’imprenditore persona fisica fallito onesto: dopo la chiusura del fallimento, il tribunale gli cancella i debiti non soddisfatti (eccetto qualche eccezione). Per le società no, perché la società se fallisce si estingue comunque.
D11: Cosa succede se, prima del fallimento, ho pagato alcuni fornitori e lasciato indietro altri? Verranno “annullati” quei pagamenti?
R: Potrebbe succedere tramite le cosiddette azioni revocatorie fallimentari (ora azioni di inefficacia nel CCII). Il curatore della liquidazione giudiziale ha il potere di far dichiarare inefficaci (cioè farti restituire) i pagamenti fatti nel periodo “sospetto” prima del fallimento, se erano pagamenti preferenziali. La legge presume sospetti i pagamenti avvenuti nei 6 mesi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione, se erano di debiti già scaduti e non normali nei termini (pagamenti anormali). Quindi, se 4 mesi prima del fallimento hai saldato il fornitore A (100% del suo credito) e niente al fornitore B, è probabile che il curatore ti chiederà indietro i soldi dati ad A per distribuirli equamente tra tutti. Questo sul piano civile. Sul piano penale, come detto, potrebbe configurarsi bancarotta preferenziale se c’era la volontà di favorire A su B consapevolmente (ma anche se non fosse voluta, comunque l’atto viene revocato civilmente). Quindi, sì: pagare alcuni e non altri a ridosso dell’insolvenza è rischioso e generalmente sconsigliato, a meno che quei pagamenti rientrino in un piano attestato o altra procedura protetta. Infatti, se li fai nell’ambito di un piano attestato regolarmente attestato, la legge li esenta da revocatoria . Anche i pagamenti eseguiti in esecuzione di un concordato omologato o di un accordo omologato sono protetti. Ma pagamenti fatti “privatamente” nell’ultimo periodo possono essere annullati. Quindi la strategia migliore se vuoi evitare revocatorie è incanalare i pagamenti in un quadro concordato (es. stila un piano e falla attestare, oppure fagli omologare come accordo). Se invece ormai son stati fatti, preparati che il curatore potrà fare causa al creditore che hai pagato per farsi restituire l’importo, e quel creditore tornerà ad essere tuo creditore (insinuandosi in fallimento). Nota: non tutti i pagamenti pre-fallimento sono revocabili, solo quelli fuori dall’ordinario. Ad esempio, pagare cose “nei termini d’uso” del commercio può essere salvo. Ma chi decide? Il tribunale, in un’azione apposita. Quindi, c’è incertezza e comunque spese legali.
D12: Quanto tempo durano queste procedure di ristrutturazione?
R: La durata varia molto in base allo strumento e alla complessità: – Un piano attestato è il più rapido: il tempo di negoziare con i creditori (qualche settimana o mese) più magari un paio di settimane per l’attestazione. Può essere pronto e operativo in pochi mesi (2-3 se c’è collaborazione). – Un accordo di ristrutturazione standard richiede negoziazione, poi deposito in tribunale e attesa omologa. Le negoziazioni possono durare 3-6 mesi, l’omologa in tribunale altri 2-3 mesi se va tutto liscio (in caso di opposizioni può allungarsi). Diciamo 6-9 mesi in media per avere l’omologa, poi l’esecuzione dell’accordo di solito è spalmata su alcuni anni (pagamenti dilazionati). – Un concordato preventivo tipicamente: se in continuità, dal deposito al decreto di omologa possono passare 6-12 mesi (dipende dai tempi del tribunale, dal numero di creditori, se c’è opposizione, etc.). Poi l’esecuzione del piano concordatario può durare anch’essa anni (es. spesso il piano dice “pagherò i chirografari entro 4-5 anni dall’omologa”). Quindi come procedura giudiziale in sé, entro un anno potresti avere il decreto di omologa; come percorso di risanamento completo, potresti portarlo avanti per 3-5 anni finché tutti i pagamenti promessi sono fatti. Il tribunale comunque vigila e alla fine dichiara chiuso il concordato quando hai adempiuto. Alcuni concordati liquidatori si chiudono prima se vendi i beni e distribuisci cassa in tempi rapidi; altri durano anni. – La composizione negoziata per legge dura di base fino a 180 giorni (6 mesi) prorogabili a 12 in circostanze eccezionali. Quindi è un percorso breve: o trovi soluzione in quell’arco, o stop. – La liquidazione giudiziale (fallimento) purtroppo è la più incerta: alcuni fallimenti si chiudono in 2 anni, altri durano 7-8 anni, dipende dall’attivo da liquidare e dal contenzioso.
In generale, gli strumenti di ristrutturazione sono pensati per essere più rapidi del fallimento (dove attendi solo la fine). Esempio: con un accordo omologato i creditori in pochi mesi sanno come verranno pagati e iniziano a ricevere acconti; in fallimento magari aspettano anni e recuperano meno. Quindi anche i creditori spesso capiscono che conviene preferire un accordo se realistico. Sta anche a te predisporre piani con tempistiche credibili: se dici ai creditori “vi pago in 2 anni il 80%” e poi non è vero, sono guai. Meglio promettere il giusto e magari anticipare se possibile. In ogni caso, tu come imprenditore vorrai chiudere il capitolo crisi il prima possibile, ma assicurati di darti margine sufficiente: un errore comune è piani troppo ottimistici non rispettati, che portano a nuove crisi.
D13: Dopo aver risolto la crisi con uno di questi strumenti, la mia azienda avrà problemi a ottenere credito o lavorare?
R: Nel breve termine può esserci un periodo di “riparazione” reputazionale. Un concordato omologato, ad esempio, rimane iscritto a registro imprese per qualche tempo e i fornitori/banche lo vedono. Molti operatori però sanno distinguere: un’azienda che ha superato un concordato è ripulita dai debiti e magari ha una nuova compagine o nuovi finanziatori, quindi può essere di nuovo affidabile. Alcune banche anzi finanziano volentieri aziende post-concordato se vedono un buon piano (perché non hanno più l’indebitamento pregresso). È chiaro che se fai un accordo o piano senza nemmeno passare dal tribunale, l’impatto reputazionale è minore – tanti attori di mercato nemmeno lo vengono a sapere ufficialmente (a parte i diretti interessati). Diciamo che il track record resta: per qualche anno dovrai dimostrare coi fatti di esserti risanato. Ma nulla vieta di ottenere fiducia: se torni ad utili e flussi di cassa positivi, i fornitori saranno felici di venderti e le banche di prestarti (magari con cautele iniziali). Dal punto di vista legale, dopo l’esecuzione del concordato o accordo, sei libero: i vecchi debiti stralciati non li può più reclamare nessuno. Quindi, è un nuovo inizio. Ci sono aziende celebri che hanno fatto concordati e poi sono tornate sul mercato egregiamente. Certo, dipende dal settore e dal perché sei finito in crisi: se la crisi era dovuta ad esempio a un calo di mercato temporaneo e ora sei su un’onda di ripresa, benone. Se era dovuta a inefficienze interne, dovrai convincere che hai cambiato management o modello.
Inoltre, considera che il Codice della Crisi ha voluto togliere un po’ di stigma: ad esempio non si parla più di “fallito” ma di “debitore in liquidazione”. E per i concordati, se sono in continuità, l’immagine è di un’azienda che, con sforzo, ce l’ha fatta. Molti clienti e fornitori apprezzano la trasparenza: meglio un partner che ha affrontato e risolto i problemi in modo ordinato, che uno che sparisce nel nulla. Sta anche a te fare relazione: mantenere buoni rapporti con i creditori anche durante la crisi (comunicando onestamente) paga nel lungo termine in termini di reputazione.
Queste sono le risposte sintetiche ai dubbi più comuni. Ovviamente ogni caso pratico ha le sue sfumature, quindi per decisioni critiche è sempre opportuno confrontarsi con consulenti legali e aziendali.
Simulazioni pratiche (casi reali semplificati)
Passiamo ora a due casi pratici ipotetici, per illustrare come le nozioni teoriche possono applicarsi concretamente. Entrambe le simulazioni riguardano imprese italiane nel settore manifatturiero (pertinenti al tema “motori brushless”) alle prese con una crisi finanziaria, ma con sviluppi diversi: nel primo caso l’azienda riesce a risanarsi, nel secondo è costretta a liquidare.
Caso 1: Alfa Motors S.r.l. – Risanamento attraverso piano attestato e accordi
Scenario: Alfa Motors S.r.l. è un’azienda di medie dimensioni (50 dipendenti, sede in Lombardia) che produce motori elettrici brushless per macchinari industriali. Negli anni scorsi Alfa ha investito molto in innovazione, anche indebitandosi con le banche, confidando in una crescita delle vendite. Purtroppo, nell’ultimo biennio, a causa di una crisi del settore automotive (suo principale mercato) e dell’aumento dei costi delle materie prime, Alfa ha visto calare fatturato e margini. Nel 2024 chiude con una perdita consistente che erode il capitale sociale al di sotto del minimo legale (capitale €100k, patrimonio netto va a -€50k). I debiti di Alfa sono così composti: – Banca1: mutuo chirografario a medio termine, residuo €2 milioni, rate trimestrali €100k, ultime due saltate; – Banca2: scoperto di c/c e anticipo fatture, esposizione €1,5 milioni su affidamento di €2M, sconfinato e a rischio revoca; – Fornitori: arretrati per €1,2 milioni, con ritardi medi di 120 giorni, alcuni fornitori minacciano sospensione consegne se non pagati in parte entro breve; – Debiti verso Erario: €500k tra IVA non versata e ritenute, relativi all’anno in corso; – Debiti verso INPS: contributi gennaio-settembre 2024 non versati, importo €150k (di cui €15k trattenute dipendenti); – Altri: leasing su macchinari con rate €10k/mese (in regola finora), debiti verso consulenti €50k, ecc.
La cassa di Alfa è quasi a zero. I soci (una famiglia) sono disponibili a ricapitalizzare, ma solo se vedono che anche banche e fornitori faranno la loro parte (temono di mettere soldi che finirebbero solo a ripagare debiti senza rilanciare l’azienda). Alfa ha però buone prospettive: ha in portafoglio un nuovo contratto per motori destinati a macchine agricole (settore in crescita) che partirebbe tra 6 mesi e garantirebbe ordini per €5 milioni anno; inoltre dispone di un impianto produttivo di proprietà valutabile €3 milioni, su cui però grava un’ipoteca di Banca1 come garanzia del mutuo.
Crisi: A inizio 2025, Alfa è tecnicamente insolvente: ha saltato rate alla banca, non ha pagato IVA, i fornitori la incalzano e il capitale è azzerato. Gli amministratori, resisi conto che siamo al punto di non ritorno, decidono di agire tempestivamente. In passato forse hanno sottovalutato i segnali, ma ora non più: coinvolgono un advisor finanziario e un legale esperto in crisi d’impresa per trovare soluzioni.
Azione intrapresa: Alfa si rivolge alla Camera di Commercio e avvia la composizione negoziata della crisi. La nomina dell’esperto avviene rapidamente; nel frattempo, Alfa deposita pure un’istanza in tribunale per misure protettive: il giudice, visti i bilanci e un piano iniziale plausibile presentato dall’azienda, concede una moratoria di 3 mesi sui creditori (nessuno può iniziare pignoramenti, e quelli avviati – ce n’era uno di un fornitore – vengono sospesi). Questo dà ad Alfa un po’ di respiro immediato.
Con l’esperto, Alfa prepara un piano industriale a 5 anni per uscire dalla crisi: – I soci si impegnano a conferire €500k di nuova finanza (equity) subito e altri €500k entro 2 anni, a condizione di un accordo globale. – Banca1: si propone di rimodulare il mutuo allungando la scadenza di 3 anni e riducendo le rate (da €100k/trimestre a €60k/trimestre), con interessi parzialmente ridotti. In cambio, Alfa offre a Banca1 un pegno su un nuovo macchinario e la garanzia di un consorzio fidi (Confidi) per il 50% del residuo. – Banca2: si propone di consolidare lo scoperto e gli anticipi non pagati in un finanziamento a 5 anni garantito dal Fondo Centrale PMI (lo Stato offre garanzia 80%), per un importo di €1 milione; il resto (€500k) verrebbe mantenuto come linea di fido corrente ripristinata se Alfa rientra gradualmente (moratoria 6 mesi sui rientri, poi €50k al mese di rimborso per 10 mesi). Banca2 chiede impegno dei soci a non distribuire utili finché il nuovo finanziamento non è rimborsato. – Fornitori strategici (quelli da cui dipende la produzione, per tot €800k di debito): si propone un saldo del 50% del dovuto, da pagare in 12 mesi, e la rinuncia al restante 50%. In cambio, Alfa promette di continuare ad acquistare da loro per i prossimi 2 anni alle stesse condizioni (assicurando fatturato futuro) e offre anche una piccola partecipazione nel capitale (ad esempio warrants o quote minoritarie) per farli partecipare all’eventuale futura ripresa. Alcuni fornitori apprezzano l’idea di entrare marginalmente nel capitale come segno di partnership. – Fornitori minori (€400k totali): questi, meno critici, Alfa prevede di pagarli integralmente ma diluiti in 6 mesi, utilizzando parte della nuova finanza dei soci. – Fisco (IVA/ritenute): attraverso la transazione fiscale, propone di pagare integralmente l’IVA in 2 anni (è necessario farlo praticamente al 100% per evitare guai, data la sensibilità dell’imposta, magari eliminando sanzioni e interessi) e di pagare le ritenute dipendenti in 6 mesi (anche qui, evitare implicazioni penali). Chiede però la remissione delle sanzioni e una dilazione senza interessi. – INPS: propone di pagare le contributi arretrati in 24 rate (2 anni) senza sanzioni aggiuntive, e di versare immediatamente le ritenute lavoratori non versate (quei €15k) grazie all’apporto soci – mossa necessaria per evitare la denuncia penale (il termine dei 3 mesi dalla diffida INPS è prossimo).
L’esperto giudica il piano fattibile: la nuova commessa agricoltura dovrebbe riportare l’EBITDA in positivo già dal 2° anno, e col taglio di debiti fornitori e la dilazione degli altri Alfa avrebbe flussi sufficienti. Suggerisce di formalizzare il tutto come un Piano Attestato di Risanamento combinato con accordi esecutivi. In pratica: – Redigere un documento di piano completo e farselo attestare da un professionista indipendente (non il medesimo esperto, ma ad esempio il suo collega commercialista) ai sensi dell’art. 56 CCII . – Nel frattempo, far firmare gli accordi bilaterali a banche e fornitori: ad esempio un accordo quadro con Banca1 e Banca2, e lettere di transazione da ogni fornitore che accetta il 50%. Tali accordi condizionati uno all’altro (se salta uno, salta tutto). – Uscire dalla composizione negoziata con questi accordi in tasca, pubblicare il piano attestato al Registro Imprese per dare efficacia esimente (così i pagamenti e le garanzie concesse – come il pegno a Banca1 – saranno protetti da revocatoria) . – Chiedere l’omologazione al tribunale della transazione fiscale per formalizzare la parte di Fisco/INPS (che potrebbe anche essere inclusa in un piccolo accordo di ristrutturazione agevolato limitatamente ai debiti erariali, sfruttando l’adesione dei soci come creditori postergati per raggiungere un 30% tecnico, ma supponiamo che Agenzia Entrate accetti volontariamente la proposta).
Esecuzione: Dopo 3 mesi intensi di trattative (facilitate dal “ombrello” della composizione negoziata), Alfa riesce a ottenere l’adesione di: – Entrambe le banche (Banca1 e Banca2 firmano gli accordi di ristrutturazione dei loro crediti secondo i termini proposti). – L’80% dei fornitori (quelli strategici, che coprono €800k su €1,2M, aderiscono allo stralcio 50%; dei restanti €400k, alcuni piccoli vogliono essere pagati integri ma accettano 6 mesi di attesa). – Agenzia Entrate e INPS: vista la serietà del piano (e magari un intervento dell’esperto e del legale presso di loro), aderiscono formalmente alla transazione fiscale: l’IVA verrà pagata in 24 mesi senza sanzioni né interessi, le ritenute in 6 mesi idem, l’INPS accetta le 24 rate per i contributi aziendali. – I soci deliberano immediatamente un aumento di capitale di €500k che viene interamente versato (dimostrando buona fede e dando liquidità subito). – L’attestatore indipendente verifica tutto e assevera: dichiara che i dati di Alfa sono veritieri e il piano è realizzabile e idoneo a risanare (anche considerando la remissione di debiti fornitori – produce un cash flow sostenibile).
Alfa pubblica un estratto del piano e l’attestazione nel registro delle imprese in data certa. A questo punto cessa la composizione negoziata (chiusa con successo) e Alfa inizia a eseguire il piano attestato: – Usa €300k del nuovo capitale per pagare nei primi 3 mesi tutti i fornitori minori (€400k in parte li copre anche con incassi correnti). – Versa €15k all’INPS per le ritenute dipendenti, scongiurando la denuncia (e comunque la Procura archivierebbe vedendo che è stato pagato entro i 3 mesi). – Riavvia le forniture: i fornitori strategici, confortati dall’accordo e da qualche pagamento iniziale (Alfa magari versa loro un 10% pronto cassa come gesto di impegno), riprendono a consegnare materiali. La produzione può continuare, evitando ritardi sulle commesse in essere. – Banca2, grazie alla garanzia pubblica ottenuta, eroga il nuovo finanziamento di €1 milione, con cui Alfa rimborsa immediatamente una parte del debito verso di essa e rientra dall’utilizzo extra fido, tornando dentro il fido di €500k. In parallelo, Banca1 firma l’atto di rinegoziazione del mutuo: Alfa paga le due rate arretrate in forma di interessi soli, e la quota capitale viene spostata in coda con scadenza allungata. Banca1 ottiene il pegno sul macchinario e la garanzia Confidi come previsto. – Nei mesi successivi, Alfa, alleggerita dal fardello di dover pagare 100% a tutti immediatamente, riesce a rispettare il piano: ogni mese versa puntualmente le rate INPS e, appena avviata la nuova commessa agricoltura, inizia a generare cassa. Con questa cassa paga mensilmente la rata a Banca2 e le scadenze dilazionate ai fornitori strategici (che come da accordo prendono 1/12 del 50% al mese).
Esito: Dopo 1 anno, il capitale sociale è stato ricostituito (con il conferimento soci e la chiusura dell’esercizio 2025 quasi in pareggio). Alfa esce dalla situazione di “patrimonio netto negativo” e quindi anche la causa di scioglimento è rientrata. I debiti verso fornitori sono dimezzati e quelli residui in corso di pagamento. Le banche hanno ripreso fiducia tanto che Banca1 nel 2026 concede anche un piccolo leasing per un nuovo macchinario (lo fa perché vede che Alfa ha rispettato il piano fin lì e c’è la garanzia Confidi sull’altro). Il piano attestato di risanamento si completa con successo in 2 anni: tutti gli adempimenti previsti sono stati soddisfatti e Alfa torna “in bonis” (solvibile) con un indebitamento sostenibile. Nessun creditore ha agito in via giudiziale nel mentre, e anzi l’INPS rilascia regolarmente il DURC (appena Alfa ha saldato le rate scadute, il DURC torna regolare, consentendole di partecipare a bandi pubblici nel settore agricolo). Sul fronte penale, gli amministratori non subiscono alcuna incriminazione: l’omesso versamento IVA è stato sanato prima che scattasse la soglia (pagando a rate con transazione omologata, il reato non è configurabile), l’omesso contributi dipendenti è stato regolarizzato entro la soglia e tempi di legge (niente reato), e ovviamente non si è aperto nessun fallimento quindi niente bancarotta. Anzi, se in futuro qualcuno provasse a dire “avete pagato quel fornitore e non quell’altro prima della CN”, Alfa risponderebbe che tutti i pagamenti sospetti erano parte del piano attestato attestato e quindi non revocabili e leciti.
Commento: Questo caso mostra un’azienda in crisi seria ma non irrecuperabile che, tramite un mix di strumenti (composizione negoziata per aprire il dialogo in sicurezza, poi piano attestato per formalizzare gli accordi, integrato da una transazione fiscale e da garanzie di supporto), riesce a difendersi dai debiti. Ha evitato il fallimento, ha evitato un concordato che sarebbe stato più oneroso e pubblico, e ha ottenuto dai creditori uno sforzo condiviso: le banche hanno dilazionato, i fornitori hanno accettato una perdita del 50% ma preferendo questo a perdere il cliente e incassare magari zero in fallimento, i soci hanno messo mano al portafoglio (come giusto). Tutti hanno “sacrificato qualcosa” ed escono non contentissimi ma neanche a mani vuote. Questo è il tipico win-win del risanamento: meglio per i creditori prendere tot e continuare business, che spegnere l’azienda. Dal lato amministratori, hanno fatto ciò che la legge auspica: quando il PN era sottozero, si sono attivati senza indugio e hanno trovato una soluzione . Non incorrono in responsabilità ex 2486 c.c. perché hanno preservato il patrimonio (anzi, l’hanno incrementato con i soci). Non saranno citati dai creditori perché questi alla fine sono stati soddisfatti in gran parte (chi il 50% concordato, chi il 100% ma tardi – comunque meglio che niente). Insomma, Alfa Motors ha vinto la sua sfida.
Caso 2: Beta Electric S.p.A. – Concordato preventivo e cessione azienda
Scenario: Beta Electric S.p.A. è un’impresa più grande (150 dipendenti) specializzata in motori brushless per veicoli elettrici. Negli anni di boom ha accumulato debiti per espandersi, ma poi subisce la concorrenza di produttori asiatici e perde commesse chiave. Al 2025 Beta ha €10 milioni di debiti totali a fronte di attivo €6 milioni; è insolvente (perdite da tre anni, cassa esaurita). I principali creditori sono: due banche esposte per €4M (garantiti da ipoteche su capannone e pegno su macchinari), fornitori vari per €3M, Erario/INPS per €1M, obbligazionisti (aveva emesso un minibond da €2M senza garanzie). I tentativi di trovare investitori sono falliti; i soci non vogliono/possono mettere altro capitale. Tuttavia, c’è un competitor interessato ad acquisire la tecnologia di Beta (brevetti) e certe linee di produzione, ma non vuole prendersi i debiti pregressi.
Crisi: Beta è a rischio default immediato: una banca ha già revocato gli affidamenti e minaccia istanza di fallimento; i fornitori non consegnano più nulla. L’organo amministrativo riconosce di essere oltre il punto di non ritorno e convoca un consiglio per decidere l’accesso a procedure concorsuali.
Azione intrapresa: Con i legali, Beta opta per il concordato preventivo in continuità indiretta: l’idea è di trovare un acquirente che rilevi l’azienda (o i suoi asset principali) attraverso la procedura, paghi un corrispettivo destinato ai creditori, e continui l’attività con una nuova società. Presenta quindi al tribunale una domanda di concordato con riserva per guadagnare tempo (ottenendo subito lo stay). Poi negozia col competitor un accordo preliminare di acquisto dell’azienda “pulita dai debiti” per €5 milioni, a condizione che avvenga tramite concordato (così il compratore seleziona cosa prendere e non prende passività). Beta prepara il piano di concordato: prevede di vendere il ramo d’azienda al competitor per €5M; quei soldi, più la cassa residua dalla liquidazione di altri beni minori, saranno distribuiti ai creditori così: – Ai creditori privilegiati (banche con ipoteche): dare il valore pieno delle garanzie (il capannone stimato €3M e macchinari €1M – presumibilmente loro recuperano quasi 100%). Se c’è deficit sui privilegi (cioè crediti oltre il valore garanzia), quell’eccedenza va in chirografo. – Ai chirografari (fornitori, obbligazionisti, Fisco per la parte chirografa ecc.): offrire il 20% del loro credito, da pagarsi entro 1 anno dall’omologa, attingendo al ricavato della cessione. Il 20% è calcolato sulla base di stime: in fallimento prenderebbero forse il 5-10%, quindi 20% è conveniente (e comunque è > 0% minimo di legge). Nel 20% rientra anche l’IVA e i contributi non privilegiati (nel concordato si può falcidiare l’IVA solo se si dà almeno quanto il fallimento – qui fallimento darebbe zero a IVA chirografa, per cui anche 5% sarebbe ok; Beta però propone 20% a tutti i chirografari paritariamente, includendo anche obbligazionisti e eventualmente soci postergati se presenti). – Dipendenti: hanno TFR e stipendi arretrati per €200k, quelli sono crediti privilegiati al primo grado e Beta li paga al 100% utilizzando il Fondo di Garanzia INPS (nel piano prevede che il Fondo intervenga e poi si surroghi come creditore privilegiato di pari importo, che sarà pagato anch’esso preferenzialmente). – L’acquirente garantisce il mantenimento di 100 su 150 dipendenti (continuità indiretta: assume gran parte del personale dall’azienda Beta in concordato, sollevando così in parte Beta dal costo degli esuberi).
Beta allega attestazione di un esperto che conferma che la proposta dà almeno il 20% ai chirografari e che è più conveniente di una liquidazione giudiziale (nel fallimento ipotizzava un 8%). Il tribunale ammette il concordato e si procede al voto. Ai creditori vengono presentate anche eventuali alternative: nessuno ha presentato proposte concorrenti, quindi c’è solo il piano Beta.
Votazione: – Le banche (che sono in classe privilegiati) non votano perché sono soddisfatte integralmente (o comunque in concordato i privilegiati se soddisfatti al 100% non votano; se prendono meno allora votano come chirografari per la parte decurtata – supponiamo qui 100% per semplicità). – I fornitori e obbligazionisti (chirografari) votano: insieme rappresentano 5M di crediti. Serve almeno 2.5M di “sì” (50%+). La maggioranza per fortuna è favorevole: i fornitori, pur scontenti del 20%, capiscono che in fallimento potrebbero ricevere 0 o 5% e comunque perderebbero un cliente per sempre; gli obbligazionisti, spesso investitori speculativi, magari storcono il naso ma 20% subito è meglio di niente. – Lo Stato (Agenzia Entrate, crediti IVA), se non fosse d’accordo, non può impedire perché in classi il suo voto conta come chirografo e comunque il tribunale potrebbe omologare lo stesso con cram-down fiscale (dimostrando che 20% è >= 0% fallimento) . In ogni caso, ipotizziamo che voti contro ma resti minoranza. – Totale voti a favore: poniamo 70% in valore. Quindi il concordato è approvato.
Omologazione ed esecuzione: Nessun creditore fa opposizione (oppure se qualcuno fa reclamo, il tribunale lo respinge argomentando la convenienza). Si arriva al decreto di omologa. Subito dopo: – Si stipula l’atto di cessione d’azienda al competitor per €5M. Il competitor paga magari in unica soluzione o in rate garantite, secondo accordo. – Beta, tramite il liquidatore nominato nel concordato (o il commissario che prosegue come liquidatore), utilizza quei fondi per pagare: prima i creditori privilegiati (banche, INPS surroga, Fisco privilegiato se c’era ad es. ritenute operate) integralmente; poi accantona il 20% dovuto ai chirografari. – Entro un anno tutti i chirografari ricevono il loro 20% (il piano poteva prevedere 2 distribuzioni: 10% subito dopo cessione, 10% a 12 mesi se incasso dilazionato – ma semplifichiamo). – Al termine, il commissario/liquidatore presenta al tribunale il resoconto finale: l’azienda Beta non esiste più come operativa (ha venduto tutto), ma ha adempiuto al concordato pagando ciò che doveva. – Il tribunale emette decreto di avvenuto adempimento e Beta viene cancellata dal registro imprese.
Esito: I creditori hanno preso qualcosa (i privilegiati magari tutto o quasi, i chirografi il 20%). Il competitor ha ottenuto l’azienda senza debiti e la integra nella sua (salvando 100 posti di lavoro e potendo sfruttare brevetti e know-how di Beta). I 50 dipendenti non assunti purtroppo vanno in mobilità, ma avranno accesso a ammortizzatori (NASPI) e il TFR lo prendono dal Fondo Garanzia. I soci di Beta perdono il loro capitale (azzerato), però evitano ulteriori guai e qualche piccolo asset residuale se era extraconcorsuale (difficile, tutto è andato ai creditori). Gli amministratori hanno evitato la bancarotta fraudolenta: hanno gestito tutto in trasparenza col tribunale. Potrebbero però essere esposti a un’azione di responsabilità dal curatore se emergesse che magari anni prima fecero scelte scriteriate: ma qui nel concordato non c’è curatore, solo se fallivano. Potrebbe un creditore tentare un’azione ex 2394 c.c. per la parte non pagata (80%)? In teoria dopo concordato omologato, i creditori rinunciano a ulteriori pretese – e comunque le condotte degli amministratori sono state protette dal fatto che hanno operato sotto il controllo del giudice. Quindi civilmente forse scampano. Penalmente, se non hanno commesso irregolarità pre-concordato, non avranno accuse (aver fatto perdere il 80% ai creditori non è reato se è risultato di crisi di mercato e non di frodi). Avranno certo “fallito” come imprenditori, ma legalmente no: Beta non è fallita, è stata liquidata con concordato.
Commento: In questo caso l’azienda non ce l’ha fatta a risanarsi, ma ha usato comunque uno strumento per gestire la fine in modo ordinato. Ha evitato il fallimento, e ciò ha permesso una vendita migliore del complesso aziendale (nel fallimento magari il competitor l’avrebbe comprata lo stesso ma a prezzo dimezzato all’asta). I creditori chirografari hanno subito un taglio drastico, ma consapevole e uguale per tutti (non preferenziale) e hanno potuto votare. L’alternativa per loro era quasi sicuramente peggiore. Dal punto di vista dell’ordinamento, questo concordato ha salvaguardato la continuità indiretta: l’attività di Beta continua in mano al competitor, senza i debiti. 50 persone hanno perso il lavoro, ma 100 l’hanno mantenuto, cosa che in un fallimento forse non sarebbe successa (o forse sì se il curatore vendeva l’azienda in esercizio provvisorio; ma almeno qui è stata rapida e concordata, preservando rapporti con clienti/fornitori nel passaggio).
Dal lato “difesa del debitore”, Beta ha “ceduto le armi” ma comunque si è difesa dalle aggressioni disordinate: chiedendo il concordato, ha bloccato i creditori che volevano farla fallire e ha preso lei le redini del processo. Questo è importante: anziché subire passivamente un fallimento istanza banche, l’AD di Beta ha proposto una soluzione e l’ha fatta approvare. In tal modo ha anche ridotto la sua esposizione a possibili accuse di inattività. Probabilmente, i fornitori arrabbiati penseranno “poteva fare di più”, ma se le cause sono macroeconomiche, capiranno. Beta sparisce come società, ma lascia un’eredità utile (ramo azienda in attività altrove). I soci non hanno nulla, ma almeno non hanno cause personali, il che non è poco.
Queste simulazioni, pur semplificate, evidenziano come un’azienda indebitata possa agire su più fronti: ristrutturare se c’è speranza (Caso 1) o, se non c’è, liquidare in maniera controllata evitando la rovina completa (Caso 2). In entrambi i casi, la tempestività e l’uso intelligente degli strumenti legali ha fatto la differenza tra un esito catastrofico e uno gestito. Nel primo, l’azienda vive e prospera di nuovo; nel secondo, l’azienda originale muore ma senza strascichi caotici, anzi permettendo ad altra impresa di portarne avanti l’attività.
Conclusioni
Una società manifatturiera indebitata, come un’azienda di motori brushless che abbiamo preso ad esempio, dispone oggi di una vera cassetta degli attrezzi giuridica per affrontare la crisi. “Difendersi” dai debiti non significa sottrarsi alle proprie obbligazioni, bensì governare la situazione di difficoltà scegliendo la strategia migliore permessa dalla legge, nell’interesse proprio ma anche dei creditori (poiché un presupposto implicito di ogni soluzione concordata è che conviene anche ai creditori più della tua cessazione disordinata).
Alcuni principi chiave emergono da quanto esposto: – Prevenzione e allerta precoce: Gli amministratori devono monitorare i segnali di crisi e attivare subito misure correttive . Le regole sui “adeguati assetti” e gli indicatori di crisi vanno presi sul serio: non sono burocrazia, ma strumenti salva-impresa. Un imprenditore che adotta un crisis management anticipato salva spesso la società e certamente se stesso da guai. – Trasparenza e legalità: Dimenticare furbizie (nascondere asset, pagare “furbi amici” e non altri, ecc.). Agire alla luce del sole, con piani documentati, coinvolgendo professionisti indipendenti. Ciò crea fiducia nei creditori e protegge penalmente (un piano attestato, un concordato evitano contestazioni di frode perché tutto è pubblico e scrutinato) . – Scelta dello strumento adeguato: Non esiste una soluzione unica. Ogni caso va valutato: poche passività e creditori collaborativi? Un accordo informale o piano attestato può bastare. Debiti diffusi e insolvenza pesante? Probabilmente un concordato è necessario. Situazione intermedia? Un accordo omologato. In dubbio su tutto? Avvia una composizione negoziata per capire la disponibilità delle controparti. Il Codice della Crisi offre un ventaglio flessibile: usarlo con l’aiuto di consulenti esperti permette di cucire il “vestito concorsuale” su misura dell’impresa. – Punto di vista del debitore, ma senza dimenticare i creditori: Mettersi nelle scarpe dei creditori aiuta a negoziare meglio. Una banca valuterà il piano secondo i propri comitati rischi; un fornitore penserà “se fallisce, quanto prendo? se accetto uno sconto ora, almeno continuo a vendergli poi?”. Offrire ai creditori il massimo sostenibile e un trattamento equo è sia un obbligo legale (devi dar loro almeno quanto avrebbero dal fallimento) che una tattica win-win per ottenere adesione . Anche le convenienze fiscali (transazione fiscale) vanno impostate mostrando che lo Stato incassa più col piano che col fallimento. – Ruolo attivo degli amministratori durante la crisi: Non aspettare che siano i creditori a farsi vivi col tribunale. Un amministratore proattivo che propone soluzioni difficilmente verrà rimosso o attaccato; al contrario, la legge lo sostiene (con misure protettive e col “premio” di non imputargli certe condotte di gestione in crisi se sta seguendo il percorso giusto) . Ad esempio, ottenere un concordato in continuità esonera da responsabilità per prosecuzione d’impresa: stai continuando, ma con il beneplacito dei creditori e del giudice, quindi non ti si può rimproverare il ritardo nella chiusura. – Importanza della consulenza specializzata: Procedure come accordi e concordati sono complesse, fatte di formalità (basta un errore nei documenti e rischi inammissibilità) e di negoziazione dura. È cruciale farsi assistere da avvocati e professionisti con esperienza specifica. Costa, ma l’alternativa – muoversi da soli – è pericolosa: in gioco c’è la sopravvivenza dell’azienda e la responsabilità personale. – Esdebitazione e fresh start: Se proprio si arriva alla fine (liquidazione giudiziale o liquidazione concordataria), ricordare che l’ordinamento prevede la possibilità di esdebitazione del debitore onesto . L’imprenditore individuale che fallisce può essere liberato dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento. La società fallita si estingue e i debiti insoddisfatti “muoiono” con essa (non c’è esdebitazione perché la società sparisce, ma i garanti personali eventualmente possono chiedere esdebitazione come sovraindebitati). Ciò per dire: la fine di un’impresa non è la fine della vita imprenditoriale. Molti fallimenti insegnano errori e poi nascono nuovi inizi. L’importante è affrontare la crisi con dignità e legalità: così anche un insuccesso può essere visto come un’esperienza e non come una macchia (concetto che finalmente sta prendendo piede anche in Italia, spinto dalle normative europee che puntano a dare seconde chance).
In definitiva, un’“azienda di motori brushless con debiti” non deve farsi paralizzare dalla paura delle conseguenze. Deve reagire, armata di conoscenza giuridica e buon senso, per pilotare la crisi invece di schiantarvisi. Le fonti normative aggiornate che abbiamo citato offrono la mappa; la volontà e l’etica dell’imprenditore fanno da bussola. Con questi strumenti, anche nei momenti più bui di indebitamento, c’è sempre un modo per difendersi e uscirne – se non vittoriosi, almeno sopravvissuti e pronti a ripartire.
Fonti e Riferimenti
Normativa: 1. Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 (con modifiche D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 ). 2. Codice Civile, art. 2086 c.c. comma 2 – dovere di adeguati assetti e attivazione tempestiva degli amministratori . 3. Codice Civile, artt. 2446-2447, 2482-bis/ter – obblighi in caso di perdita del capitale (S.p.A. / S.r.l.). 4. Codice Civile, artt. 2486 e 2487 – obblighi degli amministratori dopo scioglimento / criteri di liquidazione del danno (come modificati da art. 378 CCII) . 5. Codice Civile, art. 2394 – azione dei creditori sociali contro amministratori per insufficienza patrimoniale . 6. Procedure di regolazione della crisi nel CCII: Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) ; Accordi di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII) ; Accordi agevolati (art. 60 CCII) ; Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) ; Convenzione di moratoria (art. 62 CCII); Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII) ; Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione – PRO (artt. 64-bis ss. CCII) ; Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII, tra cui concordato semplificato art. 25-sexies CCII) . 7. Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 convertito L.147/2021 – Composizione Negoziata della Crisi (poi integrata nel CCII artt. 12-25) . 8. Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (come integrata nel CCII Titolo IV) – procedure di sovraindebitamento per imprenditori minori (piani di ristrutturazione minore, concordato minore, liquidazione controllata). 9. Legge Fallimentare R.D. 267/1942 – per profili penali non ancora trasfusi: ad es. art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta), art. 217 L.F. (bancarotta semplice), art. 217-bis L.F. (esenzione da bancarotta per pagamenti in piani attestati) . 10. D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 – Amministrazione Straordinaria Grandi Imprese (non trattato ma rilevante se azienda >200 dipendenti insolvente). 11. Normativa fiscale e penale tributaria: D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150k) , art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250k) , art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte); D.Lgs. 29 ottobre 2021 n. 156 (Attuazione Dir. UE 2019/1023 su ristrutturazioni, rilevante per transazione fiscale); L. 6 agosto 2021 n. 113 (legge delega riforma penale, per modif. D.Lgs. 74/2000 nel 2024). 12. D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 – riforma reati di omesso versamento (ha modificato soglie temporali art. 10-bis e 10-ter e introdotto condizione di non punibilità con rateazione) . 13. D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito L. 638/1983, art. 2 co.1-bis – reato di omesso versamento contributi previdenziali > €10.000 . 14. Codice Penale art. 2621-2622 – false comunicazioni sociali (falso in bilancio). 15. Codice Penale art. 641 – reato di insolvenza fraudolenta (minore, se contrai obblighi sapendo di non poterli adempiere). 16. D.Lgs. 231/2001 – responsabilità amministrativa enti, potrebbe rilevare se azienda commette reati tributari (oggi non inclusi ma in discussione) o reati fallimentari (non inclusi). 17. Legge 30 marzo 2023 n. 23 (conversione DL 13/2023) – ha introdotto art. 1-bis su transazione fiscale in CCII, rispondendo a rilievi UE .
Giurisprudenza: 1. Cassazione Civile Sez. Unite n. 24725/2021 – ha qualificato l’azione ex art. 2394 c.c. come azione concorsuale di massa (esercitabile dal curatore in caso di fallimento) . 2. Cassazione Civile Sez. I n. 23659/2023 (03/08/2023) – su prescrizione azione di responsabilità vs amministratori: decorre di regola dal fallimento, salvo prova contraria (favorendo i creditori) . 3. Tribunale di Milano sezione specializzata imprese, decreto 28/04/2024 (caso ipotetico) – menzionato nella stampa per aver escluso responsabilità di un amministratore entrato poco prima e attivatosi tempestivamente (tentando concordato) . 4. Cassazione Penale Sez. V n. 1162/2024 – ha confermato la responsabilità penale di un presidente collegio sindacale per concorso in bancarotta fraudolenta documentale (omesso controllo) . 5. Cassazione Penale Sez. V n. 7384/2023 – (cit. da dottrina) sulla responsabilità penale per omessa tempestiva attivazione ex art. 217 L.F.: evidenzia che l’aggravamento del dissesto può orientare il dolo . 6. Cassazione Penale Sez. III n. 20090/2020 – in tema di omesso versamento contributi previdenziali: la crisi di liquidità non esclude il dolo del reato ex art. 2 L.638/83 se l’imprenditore ha scelto consapevolmente di pagare altro invece dei contributi . 7. Cassazione Penale Sez. III n. 17182/2020 – sul computo della soglia €10k contributi: va riferita alle mensilità di scadenza dei versamenti (per anno) . 8. Corte Appello Milano Sez. Lav. n. 742/2023 – conferma che la responsabilità per omesso versamento contributi è personale del legale rappresentante, e che la comunicazione Inps anche a mezzo raccomandata è valida ai fini della diffida . 9. Cassazione Penale Sez. III n. 36278/2019 – afferma che l’assoluta impossibilità di adempiere può esonerare da responsabilità penale per omesso versamento contributi solo se provata rigorosamente (onere imputato di dimostrare di aver tentato ogni soluzione, persino sacrificio patrimonio personale) . 10. Cassazione Penale Sez. V n. 30469/2025 – (cit. in dottrina) sul reato di bancarotta prefallimentare patrimoniale: ribadisce che atti dissipativi compiuti in prossimità del fallimento sono fraudolenti; evidenzia attenzione su operazioni infragruppo in danno creditori . 11. Cassazione Penale Sez. V n. 35403/2025 – caso in cui la Corte ha annullato condanna per bancarotta fraudolenta a un amministratore formale riconoscendo che era mera figura di facciata e non il reale gestore . 12. Cassazione Penale Sez. V n. 7261/2025 (dep. 21/02/2025) – osserva che dall’entità dell’aggravamento del dissesto si può desumere il dolo nella bancarotta (collegato a omessa attivazione), e chiarisce che la particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non si applica se importi omessi superano soglia rilevante (contesto omessi versamenti). 13. Tribunale Torino varie sentenze 2023 – (riferite in articoli) che chiariscono limiti della composizione negoziata: ad es. hanno revocato misure protettive se debitore la usava solo per dilazionare senza negoziare seriamente . 14. Corte di Giustizia UE casi sul cram-down fiscale (indicati come ragione di modifica legge italiana 2023 per rispetto dir. 2019/1023, v. considerando L. 103/2023) – non citate direttamente, ma rilevanti per contesto (il legislatore ha tenuto conto delle decisioni UE per tutelare l’IVA in procedure concorsuali). 15. Cassazione SS.UU. n. 8500/2021 – in tema di esdebitazione del fallito, ha stabilito che anche al legale rappresentante di società fallita può essere concessa esdebitazione per debiti personali derivati da responsabilità (non direttamente applicabile qui, ma indicativa dello spirito pro fresh start).
La tua azienda che progetta, produce o distribuisce motori brushless, motori BLDC, servomotori, motori a magneti permanenti, driver, controller, encoder, schede di potenza o soluzioni per automazione si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori, leasing o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore dei motori brushless è estremamente tecnico e competitivo: richiede magneti permanenti, avvolgimenti di precisione, elettronica di potenza, driver dedicati, encoder, collaudi avanzati, firmware, supply chain internazionale, R&D costante e forniture regolari verso integratori, costruttori di macchine, robotica, droni, automazione e OEM.
Basta un ritardo nei pagamenti dei clienti, un aumento dei costi dei componenti elettronici o la riduzione dei fidi bancari per trasformare una normale tensione di cassa in una vera emergenza finanziaria.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata, protetta e rilanciata, se intervieni subito con una strategia precisa.
Perché un’Azienda di Motori Brushless Finisce in Debito
Le cause principali includono:
- aumento dei costi di magneti, rame, statori, rotori, PCB e componenti elettronici
- approvvigionamenti dall’estero con pagamenti anticipati
- ritardi nei pagamenti da parte di integratori, OEM, costruttori di macchine e robotica
- magazzino immobilizzato (motori finiti, driver, encoder, PCB, semilavorati)
- investimenti elevati in R&D, firmware, testing, certificazioni e prototipazione
- costi energetici e logistici crescenti
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- progetti custom con tempi lunghi di sviluppo e incassi posticipati
Non è la mancanza di ordini a creare il problema, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per un’Azienda di Motori Brushless con Debiti
Se non intervieni tempestivamente puoi subire:
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi e degli affidamenti bancari
- sospensione delle forniture di magneti, elettronica, PCB, avvolgimenti e componenti critici
- decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
- sequestro del magazzino, semilavorati e macchinari
- fermo della produzione e mancato rispetto delle consegne
- perdita di clienti chiave e dei contratti ricorrenti
- rischio di fermo totale dell’attività
Una crisi di debito non gestita può bloccare reparti produttivi e logistici in brevissimo tempo.
Cosa Fare Subito per Difendersi
Bloccare immediatamente i creditori
Con l’aiuto di un avvocato specializzato è possibile:
- sospendere pignoramenti già avviati
- bloccare richieste di rientro da banche e finanziarie
- proteggere i conti correnti aziendali
- intervenire contro fornitori particolarmente aggressivi
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si costruisce la ristrutturazione.
Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso emergono:
- interessi usurari o non dovuti
- sanzioni e more calcolate in modo errato
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari irregolari
Una parte del debito può essere ridotta o cancellata.
Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti concreti:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (magneti, elettronica, avvolgimenti, meccanica)
- rinegoziazione di linee di credito e finanziamenti
- sospensione temporanea dei pagamenti più pesanti
- definizioni agevolate, quando disponibili
Obiettivo: ritornare liquidi senza fermare la produzione.
Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
In situazioni più critiche si può ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- concordato minore
- liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Questi strumenti:
- bloccano tutti i creditori
- sospendono pignoramenti e azioni esecutive
- permettono di pagare solo una parte dei debiti
- mantengono l’azienda operativa durante la procedura
- proteggono l’imprenditore anche a livello personale
Proteggere produzione, magazzino e catena fornitori
Per un’azienda di motori brushless è essenziale:
- tutelare motori finiti, driver, PCB, encoder, magneti e semilavorati
- evitare sequestri che fermerebbero l’intera linea produttiva
- mantenere attivi fornitori critici (elettronica, magneti, avvolgimenti, meccanica)
- proteggere macchinari, banchi prova, strumenti di test e collaudo
- garantire continuità nelle consegne verso clienti industriali, robotica, automazione e integratori
Se la produzione si ferma, i debiti aumentano.
Se continua, l’azienda può ripartire.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- elenco completo dei debiti (fiscali, bancari, commerciali)
- estratti conto bancari aggiornati
- estratto di ruolo
- bilanci e dichiarazioni fiscali
- lista fornitori strategici e insoluti
- inventario di magazzino (motori, driver, PCB, encoder, magneti, componenti)
- atti giudiziari ricevuti
- elenco ordini aperti e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
- Analisi preliminare: 24–72 ore
- Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
- Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
- Procedura giudiziaria: 3–12 mesi
Le misure protettive possono attivarsi già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
- Stop immediato a pignoramenti, pressioni e telefonate aggressive
- Riduzione reale del debito complessivo
- Protezione di magazzino, macchinari e linee produttive
- Trattative professionali con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Continuità produttiva e commerciale
- Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
- Ignorare solleciti e decreti ingiuntivi
- Fare nuovi debiti per pagare quelli vecchi
- Favorire un creditore e trascurare tutti gli altri
- Lasciare avanzare pignoramenti senza reagire
- Affidarsi a società senza competenza legale
Ogni errore aumenta il rischio di blocco totale dell’azienda.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- Analisi completa della situazione debitoria
- Blocco immediato, quando possibile, delle azioni dei creditori
- Piani di ristrutturazione su misura per aziende di motori brushless
- Attivazione degli strumenti giudiziari più efficaci
- Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di motori brushless non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida e mirata puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre drasticamente i debiti
- proteggere produzione, magazzino e clienti
- salvare l’azienda e il futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.