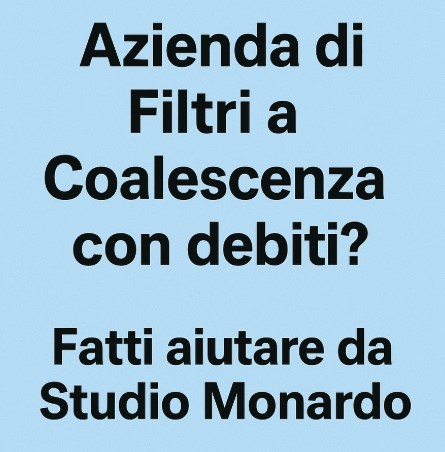Se gestisci un’azienda che produce o distribuisce filtri a coalescenza, separatori d’olio, cartucce filtranti, filtri per aria compressa, sistemi di depurazione, filtri industriali per impianti pneumatici e applicazioni ad alta efficienza, e oggi ti ritrovi con debiti fiscali, cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, arretrati INPS, esposizioni bancarie o debiti verso fornitori, la continuità della tua attività è concretamente a rischio.
Il settore della filtrazione richiede materiali costosi, membrane speciali, standard di purezza elevati e forniture puntuali. Un blocco dovuto ai debiti può fermare la produzione, creare ritardi nella consegna dei filtri a integratori, OEM e industrie e mettere in pericolo relazioni commerciali strategiche.
La buona notizia è che puoi ancora tutelare la tua azienda, ma devi intervenire rapidamente.
Perché le aziende di filtri a coalescenza accumulano debiti
Le cause principali includono aumento dei costi di fibre, membrane e materiali filtranti ad alta efficienza, rincari nell’acciaio e nelle lavorazioni meccaniche, costi elevati di test e certificazioni, pagamenti lenti da parte dei clienti industriali, ritardi nei versamenti IVA e contributi, magazzini complessi con molte varianti di filtri, investimenti continui in ricerca e sviluppo di materiali avanzati, difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati e fornitori strategici che richiedono pagamenti anticipati.
Questi fattori possono generare una crisi di liquidità crescente se non affrontati tempestivamente.
Cosa fare subito
Non lasciare che la situazione peggiori.
Fai analizzare la situazione debitoria da un avvocato esperto, verifica quali debiti sono effettivamente dovuti e quali contestabili o prescritti, evita piani di rientro non sostenibili proposti in fretta, richiedi la sospensione di eventuali pignoramenti, valuta piani di pagamento realmente sostenibili con AE Riscossione e INPS, proteggi i rapporti con i fornitori critici di membrane filtranti, materiali e cartucce, previeni il blocco del conto corrente e utilizza gli strumenti legali disponibili per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti.
Rischi concreti se non intervieni subito
I rischi includono pignoramento del conto corrente aziendale, blocco delle forniture di materiali filtranti e componenti essenziali, impossibilità di produrre filtri o rispettare contratti industriali, perdita di clienti strategici, danni alla reputazione commerciale e tecnica, ritardi nei pagamenti a dipendenti e fornitori e rischio reale di chiusura dell’azienda.
Nel settore dei filtri a coalescenza anche un piccolo ritardo può fermare linee produttive basate su aria compressa pulita, generando costi elevati e penali.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive, ridurre l’importo dei debiti tramite trattative mirate, ottenere rateizzazioni realmente sostenibili, far annullare debiti prescritti o notificati in modo irregolare, negoziare con banche e fornitori per evitare sospensioni delle consegne, proteggere magazzino, materiali e continuità operativa, stabilizzare la situazione mentre l’azienda ristruttura i debiti ed evitare l’avvio di procedure concorsuali.
Una strategia legale efficace può salvare l’azienda prima che i problemi diventino irreversibili.
Come evitare che l’attività si blocchi
Per mantenere operativa l’azienda devi intervenire subito, evitare trattative isolate con i creditori senza un piano, proteggere i fornitori critici di materiali filtranti e componenti, ristrutturare i debiti prima dell’arrivo di pignoramenti, contestare i debiti irregolari o non esigibili e concentrare la liquidità sulle attività fondamentali: produzione, assemblaggio, test e consegne.
In questo modo puoi evitare fermi, penali e perdita di clienti chiave.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti farlo immediatamente se hai ricevuto cartelle, solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento, se i debiti con AE Riscossione, INPS, banche o fornitori stanno aumentando, se la liquidità si sta riducendo in modo pericoloso, se i fornitori minacciano di sospendere le consegne o se temi che la situazione possa portare alla chiusura dell’azienda.
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ridurre i debiti e mettere davvero in sicurezza l’attività.
Attenzione
Molte aziende della filtrazione industriale non falliscono per i debiti in sé, ma perché intervengono troppo tardi. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e stabilizzare il futuro dell’impresa.
La tua azienda è indebitata? Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Un’azienda manifatturiera di filtri a coalescenza – tipicamente costituita come S.r.l. o S.p.A. – può trovarsi in una situazione di forte indebitamento a causa di difficoltà di mercato, investimenti errati o crisi di liquidità. In tale scenario, dal punto di vista del debitore (ossia della società indebitata e dei suoi amministratori), è fondamentale conoscere gli strumenti legali disponibili nell’ordinamento italiano (aggiornati a Ottobre 2025) per difendersi dai creditori e gestire la crisi debitoria in modo efficace e conforme alla legge. Questa guida avanzata – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati interessati – illustra in linguaggio giuridico divulgativo come affrontare una crisi d’impresa causata dai debiti, secondo la normativa italiana vigente, includendo riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati.
Di seguito esamineremo anzitutto le diverse tipologie di debiti aziendali (fiscali, contributivi, bancari, verso fornitori, ecc.) e i rischi specifici associati. Successivamente analizzeremo gli obblighi legali degli amministratori di società in crisi e le loro potenziali responsabilità civili e penali. Passeremo quindi in rassegna i principali strumenti di gestione della crisi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 , integrato da correttivi fino al 2024), distinguendo tra soluzioni stragiudiziali (accordi volontari, procedure negoziate) e procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento, ecc.). Verranno fornite strategie pratiche per il debitore su come agire tempestivamente, come negoziare con i creditori e quali procedure attivare a seconda della situazione.
Per chiarire l’applicazione concreta di tali strumenti, proporremo casi pratici simulati riguardanti aziende indebitate (tra cui un caso ispirato proprio a un’azienda produttrice di filtri a coalescenza) con diverse combinazioni di debiti e soluzioni adottate. Troverete inoltre una sezione di Domande Frequenti (FAQ) che risponde ai quesiti più comuni (ad es. “Un socio di S.r.l. risponde dei debiti sociali?”, “È possibile ridurre i debiti fiscali in un concordato preventivo?”, “Quando conviene la composizione negoziata rispetto al fallimento?”, ecc.), fornendo riferimenti a norme e sentenze recenti. Infine, alcune tabelle riepilogative aiuteranno a confrontare in sintesi le caratteristiche dei vari strumenti di risanamento del debito e il diverso trattamento delle categorie di debiti.
Nota sul quadro normativo: la guida tiene conto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) vigente , che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) a decorrere da luglio 2022 , integrando anche la disciplina del sovraindebitamento (che fu introdotta dalla L. 3/2012, cd. “legge salva suicidi”, ora abrogata ). Tale Codice, emanato in attuazione delle deleghe della L. 155/2017 e della Direttiva UE 2019/1023, è stato aggiornato da successivi decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024, ecc.) per affinare gli strumenti di allerta precoce e ristrutturazione. Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali forniti sono aggiornati a ottobre 2025 e sono riportati integralmente nella sezione Fonti e Riferimenti in fondo alla guida.
In sintesi: se la vostra azienda di filtri a coalescenza è schiacciata dai debiti, esistono soluzioni legali per “difendersi” dalle azioni dei creditori e provare a risanare o, quantomeno, gestire ordinatamente la crisi. Agire tempestivamente e con la giusta strategia può fare la differenza tra la salvezza dell’impresa (tramite un accordo o un concordato che riduce i debiti e permette la continuità) e il suo tracollo in una liquidazione fallimentare disordinata. Vediamo dunque in dettaglio come procedere.
Tipologie di Debiti Aziendali e Rischi Connessi
Una società può accumulare diversi tipi di debiti, ognuno con implicazioni giuridiche specifiche e poteri differenti in mano ai creditori. Prima di scegliere la strategia di difesa, è fondamentale mappare la natura dei debiti e comprenderne i relativi rischi . I principali debiti che un’azienda manifatturiera in difficoltà (come la nostra azienda di filtri a coalescenza) potrebbe aver accumulato sono:
- Debiti fiscali verso l’Erario (Agenzia delle Entrate): IVA non versata, imposte sui redditi (IRES, addizionali) o ritenute non pagate, IRAP, ecc.
- Debiti previdenziali e assicurativi verso enti come INPS e INAIL: contributi pensionistici dei dipendenti o dei soci lavoratori non versati, premi assicurativi obbligatori non pagati.
- Debiti bancari e finanziari: esposizioni verso banche o altri finanziatori (mutui, leasing, scoperti di conto corrente, finanziamenti e fidi, obbligazioni).
- Debiti verso fornitori commerciali di beni e servizi: fatture scadute non pagate a fornitori di materie prime, componenti, utilities, consulenze, ecc.
- Debiti verso i dipendenti: retribuzioni arretrate, tredicesime non corrisposte, trattamento di fine rapporto (TFR) non accantonato o liquidato.
Analizziamo separatamente queste categorie, poiché ciascuna presenta gradi di priorità diversi e differenti strumenti di riscossione da parte dei creditori, influenzando la strategia del debitore.
Debiti fiscali (Erario)
I debiti tributari verso l’erario (Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione) sono spesso i più pericolosi per un’azienda in crisi. Includono IVA non versata, imposte sui redditi non pagate, ritenute IRPEF operate sulle buste paga dei dipendenti ma non versate, imposte locali, ecc. Questi debiti presentano le seguenti caratteristiche e rischi:
- Privilegi e poteri speciali: Lo Stato gode di privilegi su molti crediti tributari (ad esempio, IVA e ritenute sono crediti privilegiati ex lege). Inoltre l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) può attivare rapidamente misure esecutive senza bisogno di passare dal tribunale: iscrizione di ipoteche sui beni immobili dell’azienda, fermi amministrativi sui veicoli, pignoramenti dei conti correnti e dei crediti verso terzi, fino alla possibilità di richiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) se il debito è ingente . Queste azioni possono paralizzare l’azienda (conti bloccati, impossibilità di incassare crediti) e aggravare la crisi.
- Sanzioni e interessi elevati: Il mancato pagamento di imposte comporta sanzioni amministrative tributarie molto onerose, oltre agli interessi di mora che maturano sul debito . Ad esempio, l’omesso versamento IVA è sanzionato al 30% dell’importo non versato, salvo definizioni agevolate. Le sanzioni e gli interessi possono far lievitare notevolmente l’ammontare dovuto, rendendo ancora più difficile il saldo.
- Conseguenze penali oltre certe soglie: Il legislatore ha previsto reati tributari per omessi versamenti oltre determinate soglie annuali. In particolare, l’omesso versamento IVA per importi superiori a €250.000 annui e l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate sopra €150.000 annui costituiscono reato punibile con la reclusione (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000) . Anche il mancato versamento di imposte dichiarate oltre soglie (es. €150.000) è penalmente rilevante. Ciò significa che gli amministratori possono subire procedimenti penali se non provvedono al pagamento di IVA e ritenute oltre tali limiti (a meno che non vi pongano rimedio entro la scadenza della presentazione della dichiarazione annuale seguente, evitando così la consumazione del reato). In caso di crisi di liquidità, dunque, tasse e contributi non pagati espongono anche a rischi penali per l’imprenditore .
- Ostacoli operativi (DURC e appalti): Un’azienda con debiti fiscali o contributivi non in regola non riesce ad ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Senza DURC l’azienda non può partecipare ad appalti pubblici e rischia la sospensione dei pagamenti nelle commesse in essere, con gravi ripercussioni sul business . Inoltre, una pesante esposizione verso il Fisco spesso compromette la reputazione creditizia dell’impresa.
In sintesi, i debiti fiscali sono debiti altamente prioritari: l’Erario ha sia strumenti coercitivi veloci sia una bassa tolleranza verso ritardi (basti pensare che la legge impone agli stessi enti pubblici di attivare segnalazioni di allerta o istanze di fallimento se l’esposizione supera certe soglie). Come affrontarli? Fuori dalle procedure concorsuali, le uniche vie sono chiedere rateizzazioni amministrative (piani di dilazione fino a 6 anni ex art. 19 DPR 602/1973, se l’ente le concede) o attendere ed aderire a eventuali definizioni agevolate varate per legge (es. condoni o “rottamazioni” delle cartelle esattoriali) . Ad esempio, nel 2023 la “rottamazione-quater” ha permesso a molte imprese di stralciare sanzioni e interessi pagando solo l’imposta . Tuttavia, queste misure straordinarie sono aleatorie (dipendono da decisioni politiche).
Nei procedimenti concorsuali o assimilati, invece, è possibile ricorrere alla transazione fiscale, uno strumento che consente di trattare con il Fisco una riduzione e dilazione dei debiti tributari all’interno di un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo . Grazie alle riforme introdotte dal 2020 in poi, oggi anche IVA e ritenute (prima “intoccabili”) possono essere falcidiate in concordato: il debitore può proporre di pagarle parzialmente (ad es. 20-30%) e a rate, a condizione di offrire almeno quanto l’Erario otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Se la proposta è conveniente, il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate – è il cosiddetto “cram-down” fiscale introdotto dal DL 125/2020 conv. L. 159/2020 . In altre parole, la volontà del Fisco può essere superata dal giudice nell’omologare un piano di concordato/accordo purché il trattamento offerto al Fisco rispetti quella soglia minima di soddisfacimento. La Cassazione ha confermato tale meccanismo: ad esempio, con sentenza n. 27782/2024 ha statuito che il tribunale può applicare la transazione fiscale d’ufficio anche se l’Erario ha espresso voto negativo, purché ne ricorrano i presupposti di legge . Anche i tribunali di merito hanno rimarcato che l’omologazione forzosa serve a perseguire l’interesse concorsuale superando le resistenze ingiustificate del Fisco . Inoltre, il correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha chiarito espressamente nel Codice che la transazione fiscale è ammessa sia nei concordati in continuità che liquidatori, eliminando dubbi applicativi . Questo potenziamento delle soluzioni concordate con il Fisco rende più concreta la possibilità di ridurre il carico fiscale dentro una procedura di risanamento.
Va ricordato infine che se l’azienda riesce a inserire i debiti fiscali in un concordato o accordo omologato, pagando la quota concordata, si ottiene anche la regolarizzazione fiscale: l’omologa vale come “attestato” di regolarità e consente il rilascio del DURC (perché i debiti sono dilazionati secondo legge). Inoltre, la soddisfazione – anche parziale – del debito IVA nell’ambito di una transazione fiscale esonera da responsabilità penale gli amministratori per il reato di omesso versamento IVA: la legge infatti prevede una causa di non punibilità se il debito IVA viene estinto prima del giudizio . Ebbene, la giurisprudenza ha riconosciuto che il pagamento integrale della percentuale concordataria (es. pagamento del 30-40% dell’IVA dovuta, secondo il piano omologato) equivale, ai fini penali, al pagamento integrale del debito tributario secondo le condizioni della transazione, comportando l’estinzione del reato . Si tratta di un ulteriore incentivo per l’imprenditore a utilizzare lo strumento concordatario per risolvere il debito fiscale, poiché così facendo evita anche guai penali.
In sintesi, i debiti fiscali vanno gestiti con priorità assoluta. Una regola pratica: è spesso preferibile impiegare le scarse risorse disponibili per pagare prima i debiti verso lo Stato (imposte correnti) e solo dopo – se necessario – ritardare altri pagamenti, previo accordo, verso i fornitori . Questo perché il costo del debito fiscale (sanzioni, interessi, azioni aggressive) è molto più elevato e rapido rispetto ad altri debiti . Naturalmente, una strategia completa di risanamento dovrà poi includere tutti i creditori, ma il messaggio è chiaro: mai ignorare o posticipare troppo a lungo IVA, tasse e contributi, altrimenti l’azienda rischia conseguenze irreversibili (blocco operatività, denunce, perdita di affidabilità).
Debiti previdenziali (INPS e altri Enti)
I debiti verso enti previdenziali (principalmente INPS per contributi pensionistici obbligatori, ma anche Casse professionali se rilevanti, e INAIL per premi assicurativi) presentano molte analogie con i debiti fiscali, pur avendo alcune peculiarità:
- Contributi non versati e privilegio: I contributi previdenziali dovuti (ad es. contributi INPS a carico del datore e del lavoratore) se non versati vengono iscritti a ruolo e sono anch’essi assistiti da privilegio generale sui beni mobili dell’azienda, similmente ai tributi. L’INPS per recuperare utilizza spesso l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) emettendo avvisi di addebito immediatamente esecutivi. Ciò significa che per l’azienda il mancato pagamento dei contributi può portare rapidamente a cartelle esattoriali, ipoteche e pignoramenti analoghi a quelli fiscali.
- Sanzioni civili elevate: Sui contributi omessi maturano sanzioni civili (more e somme aggiuntive) di importo rilevante, che l’INPS applica in automatico. Sebbene formalmente non siano “sanzioni amministrative” come quelle tributarie, di fatto aggravano il debito da pagare.
- Profili penali: Anche sul fronte previdenziale esistono reati. L’omesso versamento di ritenute previdenziali (ossia la quota contributi a carico dei lavoratori trattenuta in busta paga ma non versata dal datore) è reato se l’ammontare supera circa €10.000 annui (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983) . La pena è la reclusione fino a 3 anni o multa, con possibilità di estinzione se si paga integralmente entro termini fissati. Anche l’omesso versamento di contributi propri del datore, sebbene depenalizzato sotto una soglia, comporta sanzioni amministrative e nei casi gravi può portare all’arresto. Insomma, chi non paga i contributi dei dipendenti rischia sanzioni penali (oltre che un danno per i lavoratori che si vedono mancanti i contributi pensionistici).
- INPS come “creditore pubblico qualificato”: L’INPS rientra tra i creditori pubblici tenuti (dal Codice della Crisi) a inviare una segnalazione d’allerta all’impresa se i debiti contributivi superano determinate soglie (ad esempio, ritardi oltre 90 giorni nel versamento di contributi per un importo > €5.000 per PMI, o >€50.000 per grandi imprese – soglie previste dall’art. 25 novies CCII). In tal caso scatta una comunicazione formale che invita l’azienda a attivarsi (si vedano le FAQ sull’allerta più avanti). Trascorsi 90 giorni senza azioni, l’INPS può chiedere la liquidazione giudiziale (fallimento) . Ciò accentua la pressione sulle imprese debitrici.
Dal punto di vista delle soluzioni, i debiti contributivi possono essere inclusi in una transazione contributiva analoga a quella fiscale (art. 63 CCII) all’interno di un concordato preventivo o accordo . Le condizioni sono simili: l’INPS può accettare un pagamento parziale dei contributi, purché non inferiore a quanto otterrebbe in caso di fallimento del debitore. Anche qui vale il principio del cram-down: se la proposta è conveniente e l’INPS non aderisce, il tribunale può ugualmente omologare (sottoponendo l’ente a quel trattamento) . Fuori dalle procedure concorsuali, si può chiedere all’INPS una rateazione amministrativa (spesso fino a 24 mesi, talvolta estendibile a 60 mesi in casi eccezionali), oppure attendere eventuali condoni contributivi (meno frequenti di quelli fiscali, ma a volte concessi per interessi e sanzioni). Da notare che, al pari del Fisco, anche l’INPS nega il DURC se risultano morosità significative. Dunque, per imprese che lavorano con la P.A. o in edilizia, i debiti contributivi sono un collo di bottiglia da risolvere prioritariamente.
In definitiva, Fisco e INPS vanno considerati insieme come creditori pubblici molto potenti: l’azienda deve difendersi attivamente negoziando transazioni nei piani di ristrutturazione o cercando dilazioni, perché ignorare questi debiti porta quasi sempre a conseguenze dirette (pignoramenti, preclusioni DURC, denunce) che possono fare più male di una causa avviata da un fornitore privato.
Debiti bancari e finanziari
Le imprese industriali come i produttori di filtri spesso ricorrono a finanziamenti bancari o leasing per macchinari. Quando sopravviene la crisi, possono accumularsi insoluti verso le banche. I debiti bancari includono tipicamente: mutui ipotecari (su capannoni o terreni aziendali), finanziamenti a medio termine, aperture di credito in conto corrente (fidi) utilizzate e non rientrate, anticipi su fatture o ricevute bancarie non saldati, contratti di leasing finanziario su impianti e veicoli con canoni arretrati, ecc. . Questi debiti hanno caratteristiche peculiari:
- Garanzie reali o personali: Spesso i crediti bancari sono assistiti da garanzie. Ad esempio, i mutui ipotecari hanno ipoteca sugli immobili aziendali; i leasing sono garantiti dal diritto della società di leasing di riprendere il bene; molte volte inoltre i soci o una società controllante rilasciano fideiussioni personali a garanzia dei debiti bancari. In caso di inadempimento, la banca può escutere le garanzie: può iscrivere ipoteca giudiziale ulteriore e avviare l’esecuzione immobiliare sull’immobile ipotecato, oppure chiedere ai garanti (soci) il pagamento integrale sfruttando la fideiussione. Il patrimonio personale dei garanti, quindi, è a rischio. Nel contesto di una procedura concorsuale, i crediti garantiti da pegno o ipoteca sono considerati crediti privilegiati (previa spalmatura del privilegio sul presumibile valore del bene dato in garanzia): ciò significa che la banca, in sede concorsuale, ha diritto a essere soddisfatta con preferenza sul ricavato del bene fino a concorrenza del suo credito .
- Reazione delle banche in crisi d’impresa: Appena la banca percepisce che l’azienda è in difficoltà (ad es. sconfinamenti non rientrati, covenant di bilancio non rispettati, rating deteriorato, o persino notizie di ritardi verso altri creditori), tende a revocare i fidi e a ridurre l’esposizione. Questo può avvenire in modo repentino: la banca può comunicare la revoca dell’affidamento di conto corrente, chiedendo il rientro immediato di tutte le somme, oppure recedere da contratti di anticipazione. Tali azioni, se simultanee tra più banche, possono togliere all’azienda la liquidità residua e precipitare la crisi (classico credit crunch). Inoltre la banca segnala l’azienda come “sofferente” in Centrale Rischi, pregiudicandone ulteriormente l’accesso al credito. È quello che spesso si verifica prima che l’azienda decida di ricorrere a una procedura: i rubinetti del credito vengono chiusi.
- Procedimenti esecutivi: La banca con ipoteca può avviare il pignoramento immobiliare sul capannone o terreno ipotecato. Se ci sono leasing non pagati, la società di leasing può risolvere il contratto e riprendere i beni in leasing, o agire per i canoni scaduti e danni. Se un mutuo è garantito da fondo di garanzia statale (MCC ex L.662/96), la banca escuterà il fondo, che poi si surroga e diventa creditore. Insomma, i creditori finanziari non restano passivi: attivano procedure esecutive appena vedono insolvenza conclamata.
Come può difendersi il debitore con esposizioni bancarie? Le strade sono principalmente negoziali o concorsuali:
- Ristrutturazione del debito bancario in accordo (out-of-court): L’impresa può provare a negoziare con le banche una moratoria o un piano di rientro volontario. Talvolta tutte le banche si siedono attorno a un tavolo (c.d. accordo “monitored” o convenzione di moratoria ABI) e si concorda di congelare i pagamenti per un certo periodo. Queste intese, se pur possibili, richiedono trasparenza e credibilità del piano industriale presentato dall’azienda. In alcuni casi l’azienda propone un piano attestato di risanamento (PAR) coinvolgendo le banche: ad esempio, si impegna a vendere attivi non strategici e con il ricavato rimborsare parzialmente i crediti, e sul resto chiede una dilazione. Se il piano è attestato da un esperto indipendente e pubblicato, i pagamenti fatti in attuazione del piano godranno di protezione anti-revocatoria (vedi oltre). Ma fuori da procedure giudiziali non esiste un meccanismo per imporre alle banche una riduzione del credito: serve il consenso di ogni banca, spesso difficile da ottenere se il taglio è significativo. Un singolo istituto dissenziente può rompere il fronte e agire in via esecutiva.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) omologati: Se i creditori finanziari rappresentano almeno il 60% dei debiti, l’azienda può tentare un accordo ex art.57 CCII (già art. 182-bis L.F.) da omologare in tribunale . Con l’omologazione, l’accordo vincola tutti i creditori aderenti; i creditori non aderenti restano estranei, ma la legge permette comunque di estendere alcuni effetti: ad esempio, dal 2022 si può ottenere l’estensione forzata (cram-down) degli accordi di ristrutturazione anche ai creditori finanziari dissenzienti, se aderisce una maggioranza qualificata del 75% di tali crediti . Ciò consente di superare eventualmente l’opposizione di una minoranza di banche. Durante la pendenza dell’omologazione, l’azienda beneficia di una moratoria legale: il tribunale, appena è depositata la domanda di omologa, può sospendere per fino a 12 mesi le azioni esecutive individuali dei creditori . Questo “scudo” tutela l’azienda mentre finalizza l’accordo.
- Concordato preventivo in continuità aziendale: Se la situazione è troppo complessa (molte banche, anche fornitori, insolvenza già conclamata) e serve imporre sacrifici erga omnes, la strada è attivare un concordato preventivo. Nel concordato, i debiti verso le banche verranno suddivisi in classi e trattati secondo la priorità delle garanzie. Ad esempio, in un piano di concordato in continuità, l’azienda può proporre: pagare integralmente i crediti ipotecari (almeno fino al valore di stima dell’immobile) magari vendendo il bene o con nuovi finanziatori, e falcidiare invece la parte chirografaria (scoperta) del credito bancario, offrendo ad esempio una percentuale (es. 20%) pagata in alcuni anni . I crediti bancari unsecured possono essere messi in classe separata o insieme ad altri chirografari (fornitori). L’azienda può anche offrire alle banche una conversione del debito in strumenti partecipativi (equity): alcune banche, pur di non svendere in fallimento, accettano di diventare socie o di ottenere strumenti finanziari partecipativi, confidando in un futuro recupero di valore . Tutto questo però richiede la costruzione di un piano industriale credibile, che dimostri come – liberata da parte del debito e con nuova finanza eventualmente iniettata – l’impresa possa tornare redditizia e generare i flussi necessari per pagare le percentuali proposte ai creditori . La presenza di ordini o commesse potenzialmente lucrative (come nel caso di una società di filtri che abbia nuovi contratti in vista) è un elemento chiave: spesso è l’argomento con cui convincere banche e fornitori a supportare il piano invece di spingere per la liquidazione .
- Moratorie e accordi durante la procedura: Durante il concordato preventivo, l’azienda (assistita dal commissario giudiziale) può negoziare con le banche delle soluzioni integrative: ad esempio, la banca ipotecaria può accettare di rinegoziare il mutuo o attendere la vendita del bene a condizioni concordate; le banche chirografarie spesso votano a favore se la percentuale offerta è comunque superiore a quanto otterrebbero in caso di fallimento (spesso zero). Va ricordato infatti che in un fallimento, un creditore chirografario delle dimensioni di una banca recupererebbe forse pochi centesimi per euro e dopo molti anni, mentre un concordato che offre, poniamo, il 20% in pochi anni, può essere una soluzione più conveniente. Far comprendere questo ai creditori è cruciale: la convenienza comparativa del concordato rispetto alla liquidazione è il perno su cui si fonda l’omologazione (nonché uno strumento retorico efficace nelle trattative) .
In definitiva, i debiti bancari richiedono strategie diversificate: se l’indebitamento è gestibile e le banche sono collaborative, si può tentare un accordo stragiudiziale (magari certificato da un piano attestato); se invece la mole di debito bancario è insostenibile e serve imporre tagli, il concordato preventivo è la via maestra per ottenere falcidie e dilazioni forzose. Un consiglio pratico: mantenere la comunicazione aperta con le banche sin dai primi segnali di crisi. Spesso ignorare le banche o farle allarmare con notizie negative le porta a irrigidirsi; al contrario, presentare subito un piano di ristrutturazione può indurle a concedere tempo (standstill) anziché agire immediatamente. Nel Capitolo sulle strategie pratiche vedremo i passi da compiere con i finanziatori.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
Quasi ogni crisi aziendale comporta anche debiti commerciali verso fornitori di materie prime, merci, servizi, utenze, ecc. Quando un’azienda attraversa difficoltà di liquidità, spesso tende – comprensibilmente – a ritardare i pagamenti ai fornitori, privilegiando l’uso della cassa per spese immediate. Nel breve termine, alcuni fornitori tollerano ritardi; ma col protrarsi della crisi, si accumulano fatture scadute e i fornitori iniziano a perdere la pazienza.
Caratteristiche e rischi dei debiti verso fornitori:
- Nessuna garanzia speciale (chirografari): Di regola i fornitori sono creditori chirografari, cioè senza garanzie reali né cause di prelazione (salvo rari casi di privilegio per alcune forniture essenziali, ad es. spese di giustizia, o diritto di ritenzione se hanno beni del debitore in lavorazione). Ciò significa che, in caso di insolvenza, i fornitori saranno gli ultimi ad essere pagati ed è probabile che subiscano forti decurtazioni (nelle procedure concorsuali spesso prendono percentuali basse, se resta qualcosa dopo aver soddisfatto privilegiati).
- Azioni legali individuali: Un singolo fornitore insoluto può decidere di agire per vie legali. Tipicamente, dopo solleciti e diffide, può ottenere un decreto ingiuntivo (specie se la fattura è documentalmente provata) e poi procedere con un pignoramento (su conti correnti, beni mobili, crediti verso clienti, ecc.). Spesso i fornitori conoscono bene l’azienda e sanno dove colpire (es. pignorare i crediti presso un cliente importante). L’attivazione di azioni esecutive isolate può mettere in difficoltà la società, anche se un solo creditore agisce. Tuttavia, quando i debiti sono diffusi fra decine di fornitori, non tutti agiranno immediatamente: alcuni rimarranno inerti sperando in un pagamento spontaneo o in un accordo.
- Interruzione delle forniture e danno commerciale: Il rischio maggiore è che i fornitori, non venendo pagati, sospendano le forniture future. Un’azienda manifatturiera ha bisogno di materie prime e componenti continuamente: se i fornitori chiave bloccano le consegne (magari perché hanno perso fiducia o perché sono essi stessi esposti finanziariamente), la produzione si ferma. Si innesca così un circolo vizioso: l’azienda, già in crisi, non può più evadere gli ordini per mancanza di materiali, perde ricavi ulteriori e precipita. Dunque, i debiti verso fornitori hanno un impatto immediato sulla operatività: mantenere buoni rapporti con i fornitori critici è vitale per l’eventuale rilancio.
- Segnalazioni e reputazione: Un fornitore insoluto può anche segnalare l’azienda a altre imprese (passaparola nel settore) o revocare dilazioni concesse. La reputazione dell’azienda ne soffre, complicando la stipula di nuovi contratti commerciali.
Dal punto di vista delle soluzioni, i fornitori sono tipicamente i creditori che subiranno i maggiori sacrifici in una ristrutturazione, proprio perché chirografari. Le opzioni sono:
- Accordi bonari individuali: nulla vieta di negoziare con ciascun fornitore un accordo transattivo – ad esempio un saldo e stralcio (pagare subito il 50% a fronte dell’abbandono del restante) oppure una dilazione (pagare tutto ma in 12-24 mesi). Molto dipende dalla leva contrattuale: un fornitore piccolo e non strategico potrebbe accettare uno stralcio parziale pur di incassare qualcosa; un fornitore indispensabile per la produzione potrebbe invece pretendere pagamento integrale almeno per riprendere le consegne. Queste trattative informali spesso avvengono già nelle prime fasi della crisi. Il debitore deve stare attento però a non pagare arbitrariamente alcuni fornitori e lasciarne indietro altri: pagamenti preferenziali potrebbero essere soggetti a revocatoria fallimentare successivamente (se fatti nel periodo sospetto ante fallimento). Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione (come il piano attestato) di solito includono intese bilaterali con i fornitori principali, lasciando fuori quelli minori che saranno pagati regolarmente.
- Composizione negoziata della crisi: in sede di composizione assistita da un esperto (si veda oltre), l’azienda può coinvolgere i fornitori chiave nelle trattative. Spesso si propone loro: o un piccolo stralcio del credito, oppure il pagamento integrale però dilazionato nel tempo, chiedendo di continuare a fornire il materiale durante la crisi. I fornitori, se credono nel piano di rilancio, possono accettare di essere pazienti, consci che l’alternativa (azienda che chiude) li porterebbe a incassare molto meno (in fallimento magari nulla) . Il ruolo dell’esperto terzo aiuta a convincere i creditori della bontà delle misure prospettate.
- Concordato preventivo: all’interno di un concordato, i fornitori (creditori chirografari) vengono raggruppati in una o più classi e sottoposti a una proposta di pagamento parziale (falcidia) e differito. Ad esempio, un concordato può prevedere di soddisfare i creditori chirografari al 20% in 4–5 anni dall’omologazione . Se vi sono fornitori “strategici” – cioè indispensabili perché l’azienda possa continuare l’attività (ad es. il fornitore esclusivo di membrane filtranti per i filtri a coalescenza) – si può riservare loro un trattamento leggermente migliore, ponendoli in una classe separata con percentuale più alta (es. 30%) così da incentivarli a supportare la continuità aziendale . Questa differenza di trattamento è ammessa se giustificata da un “apprezzabile interesse comune” dei creditori in classe (nel caso, l’interesse a mantenere in vita un rapporto commerciale futuro). I fornitori meno importanti saranno in altra classe con trattamento inferiore. La maggioranza dei creditori per classe (per teste e per ammontare del credito) deve accettare la proposta affinché il concordato sia approvato – ma come detto, la convenienza rispetto al fallimento fa sì che spesso anche se la percentuale offerta è bassa, i chirografari votino a favore (poiché l’alternativa è zero) . Una volta omologato il concordato, tutti i fornitori sono vincolati e incasseranno solo quella percentuale, perdendo la quota eccedente (che verrà “stralciata”, non più esigibile).
In generale, i fornitori sono i creditori “deboli” in sede concorsuale, quindi subiranno i tagli maggiori; tuttavia, per il successo del risanamento, alcuni fornitori cruciali devono essere coinvolti e motivati. L’imprenditore dovrà individuare chi tra i creditori commerciali è indispensabile per proseguire l’attività e assicurarsi di trattare adeguatamente tale fornitore (pagamenti almeno parziali subito, o condizioni di favore nel piano) . In aggiunta, l’azienda in crisi dovrebbe cercare fornitori alternativi per le forniture non esclusive, così da ridurre il potere di ricatto di eventuali creditori ostili.
Una notazione: se l’impresa poi dovesse fallire, i fornitori che durante la crisi hanno continuato a fornire beni con pagamento anticipato o contestuale non rischiano revocatorie (poiché non si tratta di pagamenti a creditori antecedenti, ma di prestazioni corrispettive a termine). Diverso è il caso di fornitori che abbiano ricevuto pagamenti di arretrati durante la crisi: se ricevuti entro 6 mesi dalla sentenza di fallimento, il curatore potrebbe agire in revocatoria per far restituire quelle somme (salvo fossero pagamenti “in bonis” normali o rientranti nelle esenzioni di legge). Tuttavia, se tali pagamenti sono stati effettuati in esecuzione di un piano attestato pubblicato o di un accordo omologato, allora non sono revocabili ex art. 166 CCII . Questo è un elemento importante che rende i fornitori più tranquilli nel partecipare a soluzioni concordate: se accettano un pagamento concordato nel piano, non dovranno restituirlo nemmeno se poi l’azienda dovesse fallire, a meno che il piano si rivelasse fraudolento .
Debiti verso dipendenti
I debiti verso i propri dipendenti (stipendi non pagati, ferie non liquidate, TFR maturato non versato a fine rapporto) rappresentano una categoria a sé, con rilevanza sia giuridica sia sociale/morale. Le retribuzioni dei lavoratori godono di un privilegio generale mobiliare di primo grado (art. 2751-bis c.c.) e i TFR di un privilegio anch’esso molto elevato, oltre a poter essere garantiti dall’intervento del Fondo di garanzia INPS. Ecco i punti salienti:
- Priorità legale e morale: In qualunque procedura concorsuale, i crediti di lavoro per le ultime mensilità impagate e per il trattamento di fine rapporto devono essere soddisfatti integralmente, nei limiti del privilegio che copre per intero le ultime 2-3 annualità di stipendio e TFR . In un concordato in continuità aziendale, la legge impone che i crediti dei lavoratori (se privilegiati) vengano pagati al 100% entro 12 mesi dall’omologazione . Anche in un concordato liquidatorio, gli stipendi e TFR privileggiati vanno pagati integralmente (salvo l’eventuale parte che eccede il privilegio per somme molto alte). Ciò riflette la tutela speciale accordata ai lavoratori. Inoltre, dal punto di vista della gestione d’impresa, mantenere soddisfatti (per quanto possibile) i dipendenti è cruciale per evitare esodi di personale e conflitti sindacali durante la crisi.
- Interventi degli enti di garanzia: Se l’azienda non è in grado di pagare i dipendenti e finisce in procedura concorsuale liquidatoria, interviene l’INPS – Fondo di Garanzia a coprire i crediti di lavoro: il Fondo anticipa ai lavoratori il TFR e fino a alcuni mesi di retribuzioni impagate (massimo 3 mensilità) in caso di insolvenza accertata, rivalendosi poi sul datore in sede di insinuazione al passivo. Nei concordati preventivi in continuità, però, l’obiettivo è evitare la cessazione del rapporto: dunque il Fondo di Garanzia entra in gioco solo se c’è risoluzione del rapporto di lavoro e insolvenza.
- Possibili azioni legali e sanzioni: I dipendenti possono presentare ingiunzioni per salari non pagati e chiedere il pignoramento dei conti aziendali; inoltre, il mancato pagamento degli stipendi, unito al mancato versamento contributi, può portare a ispezioni degli enti del lavoro e sanzioni amministrative. Esiste anche il reato contravvenzionale di omesso versamento di ritenute previdenziali (già citato) e la mancata corresponsione di retribuzioni può, se protratta, configurare violazioni (ad es. sfruttamento del lavoro se approfitta dello stato di bisogno, nei casi più gravi). In ogni caso, i dipendenti possono dimettersi per giusta causa se non pagati, con obbligo per l’azienda di versare comunque il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso, aggravando il debito. E se l’azienda entra in concordato o fallimento, i dipendenti hanno diritto a vedere riconosciuto il titolo di privilegio.
In una fase di ristrutturazione, come gestire i debiti verso il personale? Alcune mosse includono:
- Ricorso agli ammortizzatori sociali: Per evitare di accumulare ulteriori debiti salariali, l’azienda può richiedere la Cassa Integrazione Guadagni (CIGS per crisi aziendale) se ne ricorrono i presupposti, ottenendo un sostegno pubblico per retribuire (in parte) i dipendenti temporaneamente sospesi dal lavoro. Durante la crisi COVID, molte imprese hanno usato la CIG in deroga per non licenziare e alleggerire il costo del personale. Questo strumento aiuta a congelare il debito verso i lavoratori in attesa del piano di risanamento.
- Accordi sindacali e transazioni individuali: Si possono negoziare con i dipendenti (anche tramite i sindacati, se presenti) degli accordi di ristrutturazione del debito salariale: ad esempio, pagamento rateale degli arretrati su un certo periodo, o conversione di parte di essi in strumenti di welfare aziendale. Spesso i lavoratori sono disponibili a qualche sacrificio se vedono un serio piano di rilancio e se ciò serve a salvare i posti di lavoro.
- Riduzione dell’organico con tutele: Se la crisi richiede esuberi, l’azienda deve mettere in conto i costi di licenziamento collettivo (ticket Naspi, eventuali incentivi all’esodo). Un concordato in continuità può prevedere di ridurre il personale e includere tali costi come prededucibili nel piano. Tuttavia, licenziare durante la composizione negoziata o il concordato richiede spesso autorizzazione e comporta interazione sindacale (procedure di legge n. 223/1991 per riduzione di personale). Sono aspetti delicati ma necessari in alcuni casi per ridurre i costi.
In conclusione, i debiti verso i dipendenti vanno trattati con massima cura: non solo per le protezioni legali di cui godono, ma anche perché i lavoratori sono una risorsa chiave per far ripartire l’impresa. Un piano di risanamento credibile deve in genere prevedere il pagamento integrale degli arretrati ai dipendenti (magari dilazionato, ma certo) e il mantenimento per quanto possibile della forza lavoro residua. Se ciò non fosse possibile e l’impresa dovesse cessare, i dipendenti verranno soddisfatti in priorità con il patrimonio disponibile o dal Fondo di Garanzia – ma questa è l’extrema ratio. Dal punto di vista dell’amministratore, mostrare attenzione verso i dipendenti (pagando almeno in parte gli stipendi appena c’è liquidità, spiegando la situazione) è anche un elemento che viene valutato in caso di procedure: un atteggiamento imprenditoriale corretto considera la tutela dei lavoratori un dovere, e i tribunali guardano con maggior favore i piani dove i lavoratori non sono sacrificati oltre il necessario .
Dettaglio sulle procedure concorsuali: In concordato preventivo, i dipendenti votano anch’essi come creditori per la parte eventualmente non privilegiata dei loro crediti (ad es. se hanno TFR eccedente il limite di privilegio). Ma poiché di solito sono soddisfatti integralmente entro breve, raramente ostacolano il piano. Nei concordati in continuità, c’è l’obbligo di classare separatamente i crediti di lavoro e di pagarli integralmente entro un anno ; ciò implica che di fatto i lavoratori non subiscono decurtazioni nei concordati di risanamento. Nei concordati liquidatori, se i beni non bastano a pagarli, per la parte non coperta interviene il Fondo INPS a tutela.
Riassumendo quanto visto finora:
I diversi tipi di debito richiedono approcci differenti. Un elemento chiave è distinguere tra creditori privilegiati/garantiti (come Erario, INPS, banche con ipoteca, dipendenti) e creditori chirografari (fornitori, banche senza garanzie, ecc.): i primi hanno una posizione più forte e in ogni piano vanno trattati con priorità (spesso pagando tutto o quasi), mentre i secondi sono destinati ai sacrifici maggiori . Questa gerarchia di trattamenti è imposta sia dalle norme (il Codice della Crisi vincola a pagare certi privilegiati integralmente) sia dalla logica negoziale (bisogna “premiare” i creditori la cui collaborazione è essenziale per la sopravvivenza dell’impresa). Nel prossimo capitolo, esamineremo i doveri degli amministratori di una S.r.l. indebitata e come essi devono muoversi per tutelare l’impresa e sé stessi, prima di entrare nel dettaglio delle soluzioni offerte dalla legge.
Obblighi degli Amministratori in Crisi e Responsabilità
Quando una società entra in uno stato di crisi o insolvenza, gli amministratori (sia di S.r.l. che di S.p.A.) assumono una posizione delicatissima: da un lato devono tentare il risanamento dell’azienda, dall’altro hanno precisi obblighi legali volti a tutelare il patrimonio sociale a beneficio dei creditori. L’ordinamento impone agli amministratori di agire con diligenza per contenere la crisi e non aggravare il dissesto . Viceversa, comportamenti omissivi o imprudenti possono esporli a responsabilità personali di natura civile (verso i creditori e verso la società) e persino penale.
Esaminiamo i principali doveri e responsabilità degli amministratori di una società (in particolare S.r.l.) in crisi:
1. Dovere di monitoraggio e istituzione di assetti adeguati: L’art. 2086 c.c. (come modificato dalla riforma crisi d’impresa) impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità. Ciò significa che l’organo amministrativo deve monitorare continuamente la situazione finanziaria e patrimoniale. Ai primi segnali di tensione (ad es. cronici ritardi nei pagamenti, flussi di cassa negativi, indicatori come DSCR<1 su 6 mesi) gli amministratori devono analizzare a fondo le cause e l’entità del problema . In pratica, occorre predisporre subito un check-up finanziario: elenco completo dei debiti scaduti e in scadenza, previsione di cassa a breve, verifica di eventuali perdite di esercizio e impatto sul capitale sociale, stima degli asset liquidabili, etc. . Va distinto se la crisi è transitoria (es. dovuta a un credito importante incassato in ritardo) o strutturale (insolvenza conclamata). Questo monitoraggio fa parte dei doveri di diligenza professionale degli amministratori.
2. Obbligo di informare gli organi sociali e i soci: Se la S.r.l. ha un Consiglio di Amministrazione, tutti i suoi membri vanno informati tempestivamente dello stato di crisi . Se vi sono soci non amministratori, anche a loro devono essere fornite informazioni sulla gravità della situazione (ad es. convocando un’assemblea per spiegare la crisi), anche perché i soci potrebbero decidere interventi di supporto (ricapitalizzazione, finanziamenti soci). Inoltre, se la società ha un organo di controllo (sindaci o revisore unico), questo deve essere immediatamente avvertito: spesso anzi è il collegio sindacale a segnalare agli amministratori i primi segnali di crisi e a sollecitare provvedimenti (c.d. “allerta interna”). Mantenere all’oscuro soci o sindaci della crisi costituisce violazione dei doveri e può aggravare la posizione di responsabilità degli amministratori .
3. Divieto di aggravare il dissesto – gestione conservativa: Dal momento in cui la crisi diventa evidente, cambia radicalmente il “mindset” richiesto agli amministratori. Non è più tempo di perseguire l’utile per i soci, ma di salvaguardare il patrimonio aziendale a garanzia dei creditori . Questo principio, sebbene di matrice giurisprudenziale, è ora recepito anche dall’art. 2486 c.c.: al verificarsi di una causa di scioglimento (es. perdite rilevanti che azzerano il capitale) gli amministratori devono gestire la società ai soli fini conservativi, senza intraprendere nuove operazioni se non finalizzate a evitare pregiudizio ai creditori. In pratica, cosa NON devono fare gli amministratori in crisi :
- Non contrarre nuovi debiti sapendo di non poterli onorare (“trading while insolvent”), ad esempio continuare ad acquistare a credito beni che non si riuscirà a pagare.
- Non effettuare pagamenti preferenziali ad alcuni creditori a scapito di altri (es. pagare un fornitore “amico” e non pagare le tasse o gli stipendi): questo viola la par condicio creditorum e, se poi si fallisce, è potenzialmente bancarotta preferenziale.
- Non distrarre o occultare beni dal patrimonio sociale (vendite sottoprezzo, prelevamenti ingiustificati a favore di soci, cessioni di asset senza serio motivo). Questi atti potrebbero configurare bancarotta fraudolenta distrattiva in caso di fallimento, oltre a danneggiare i creditori.
- Evitare operazioni azzardate o di mera dilazione che aggravino il passivo: es. prendere un nuovo finanziamento a tassi usuranti solo per tirare avanti qualche mese, ipotecare beni liberi per ottenere liquidità effimera, postergare artificiosamente problemi strutturali.
Ogni atto che aumenti il dissesto o diminuisca la garanzia patrimoniale è potenzialmente fonte di responsabilità. Gli amministratori devono adottare una condotta improntata alla conservazione: riduzione dei costi, nessuna spesa non essenziale, stop a investimenti espansivi, attenzione a non erodere ulteriormente il patrimonio.
4. Rispetto delle norme sul capitale sociale (perdite rilevanti): La crisi spesso porta con sé perdite di esercizio. Se le perdite intaccano il capitale oltre certi limiti (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le S.r.l.), gli amministratori hanno l’obbligo di convocare immediatamente l’assemblea per gli opportuni provvedimenti . In particolare: se le perdite superano 1/3 del capitale sociale, va ridotto il capitale e eventualmente aumentato; se la perdita azzera il capitale sotto il minimo legale, la società deve essere sciolta o trasformata. L’omessa tempestiva convocazione dell’assemblea in tali casi è un classico indice di mala gestio. La Cassazione ha chiarito (sent. 17834/2023 e successive) che la nuova regola di quantificazione del danno introdotta nel 2019 all’art. 2486 c.c. (basata sulla differenza tra patrimonio netto alla data in cui si doveva cessare l’attività e patrimonio netto alla data di apertura della procedura) si applica solo alle condotte post-riforma ed è una presunzione relativa . In sostanza, se gli amministratori non rispettano l’obbligo di attivarsi davanti a perdite rilevanti e continuano l’attività aggravando il deficit, possono essere chiamati a risarcire ai creditori il maggior passivo accumulato nel periodo di ritardo. La Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, sent. 28 febbraio 2024 n. 5252) ha precisato che il criterio dei “netti patrimoniali” ex art. 2486 c.c. – differenza tra patrimonio netto quando si doveva intervenire e patrimonio netto finale – costituisce un metodo equitativo e sussidiario di liquidazione del danno: il giudice deve applicarlo salvo che emergano elementi per un criterio più preciso e aderente al caso concreto . Ciò significa che gli amministratori possono provare che il danno effettivo ai creditori è minore di quanto risulti dalla differenza di patrimonio netto, ma in mancanza di prova contraria quel delta di patrimonio è addebitato loro come danno. Il messaggio per l’amministratore è chiaro: ignorare le perdite e non adottare misure sul capitale espone a responsabilità diretta.
5. Dovere di attivarsi (strumenti di composizione della crisi): Il Codice della Crisi (art. 24 CCII) non impone agli amministratori un obbligo automatico di depositare un’istanza concorsuale al primo manifestarsi della crisi; tuttavia impone di valutare seriamente le opzioni offerte dalla legge e di non restare inerti . In altre parole, una volta accertato che l’azienda è in stato di crisi (probabilità di futura insolvenza) o già insolvente, gli amministratori devono considerare se attivare una procedura di allerta/composizione negoziata, oppure un accordo di ristrutturazione, oppure direttamente un concordato preventivo o – se non c’è altra via – una liquidazione. L’inerzia colpevole è vista molto negativamente. In caso di successivo fallimento, uno degli elementi che i creditori e il curatore possono contestare agli amministratori è proprio il ritardo nell’aver avviato la procedura concorsuale, che spesso provoca l’erosione ulteriore del patrimonio (la cosiddetta “responsabilità da tardiva richiesta di insolvenza”). Questa colpa può far scattare l’azione di responsabilità ex art. 2486 c.c. citata sopra, o anche configurare bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Al contrario, un amministratore che prontamente avvia una composizione negoziata o chiede il concordato preventivo mostra di aver agito in buona fede per gestire la crisi, il che può attenuare eventuali conseguenze negative personali. Il CCII ha introdotto anche “misure premiali” per chi si attiva tempestivamente: ad esempio, se il debitore presenta istanza di composizione negoziata entro 90 giorni dalla segnalazione di allerta del Fisco/INPS, può beneficiare di riduzione di sanzioni e interessi e, in caso di successiva procedura, di esenzioni da alcune pene accessorie . Dunque c’è un incentivo normativo all’azione rapida.
6. Responsabilità verso i creditori (azione di responsabilità): Se la società poi finisce in fallimento o altra procedura liquidatoria, gli amministratori rischiano un’azione di responsabilità per aggravamento del dissesto promossa dal curatore o dai creditori (ex art. 2486 c.c. e art. 2394 c.c. per S.p.A.). Tale azione mira a ottenere il risarcimento del deficit creatosi a causa della cattiva gestione durante la crisi. Come già accennato, la giurisprudenza ha elaborato il criterio del differenziale di patrimonio netto per quantificare il danno e la riforma l’ha recepito, seppur mitigandolo come presunzione relativa . In pratica, se emerge che l’amministratore ha continuato l’attività in perdita invece di prendere provvedimenti, gli verrà imputato il peggioramento del passivo come danno risarcibile verso i creditori insoddisfatti . Anche atti specifici di mala gestio (pagamenti preferenziali, distrazioni) possono costituire base per la responsabilità.
7. Responsabilità verso la società e i soci: Indipendentemente dall’insolvenza, gli amministratori rispondono sempre verso la società per violazione dei doveri (azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. per S.r.l. e art. 2393 c.c. per S.p.A.). In situazioni di crisi, i soci potrebbero agire se la gestione ha causato perdite evitabili. Inoltre, i sindaci e revisori hanno loro stessi obblighi di controllo e dovere di segnalazione: la mancata reazione dell’organo amministrativo a un richiamo del collegio sindacale può aggravare la posizione dei primi.
8. Responsabilità dei soci (cenni): Normalmente i soci di S.r.l./S.p.A. non rispondono dei debiti sociali (limitazione di responsabilità). Tuttavia, in casi di abuso della forma societaria (es. confusione patrimoniale, sottocapitalizzazione dolosa) può applicarsi un “piercing the corporate veil” e rendere i soci illimitatamente responsabili, sebbene sia raro in giurisprudenza e richiede frode . Più concretamente, la legge prevede che dopo la chiusura di una liquidazione fallimentare o concordataria, i soci possano essere chiamati a restituire eventuali somme ricevute in sede di liquidazione se i creditori non sono stati soddisfatti integralmente . Le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. 6070/2013, hanno affermato che i soci di società di capitali succedono nei rapporti attivi e passivi non definiti dopo la liquidazione, e possono rispondere dei debiti residui nei limiti di quanto riscosso (o anche se nulla hanno riscosso, in ipotesi di mala gestio e svuotamento della società) . In parole povere, se i soci hanno beneficiato di distribuzioni in sede di liquidazione (anche solo l’attivo residuo), i creditori insoddisfatti possono rivalersi su di loro fino a concorrenza di quelle somme. E la Cassazione ha esteso il principio pure ai casi in cui formalmente nulla fu distribuito, per evitare facili elusioni . Ciò ribadisce che i soci non sono sempre intoccabili: se hanno, ad esempio, svuotato la società prima di fallirla trasferendo asset a sé stessi, possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali post estinzione per condotte distrattive.
9. Profili penali (bancarotta e altri reati): In caso di fallimento (liquidazione giudiziale), eventuali condotte illecite degli amministratori possono sfociare nei reati di bancarotta previsti dal R.D. 267/1942 (ancora in vigore per la parte penale). Tra questi: bancarotta fraudolenta distrattiva (se hanno sottratto o dissipato beni societari), bancarotta preferenziale (se hanno pagato taluni creditori preferendoli ad altri in pregiudizio della par condicio) , bancarotta semplice (per imprudenza, spese personali eccessive, ritardo nella dichiarazione di fallimento). Anche i soci di fatto amministratori (o che abbiano concorso nelle condotte) possono rispondere penalmente . Le pene per la bancarotta fraudolenta sono pesanti (reclusione fino a 10 anni). Inoltre, reati tributari come l’omesso versamento IVA già menzionati non vengono meno con il fallimento, anzi sono frequentemente contestati all’esito del crack. Tuttavia, se l’imprenditore ha agito tempestivamente per comporre la crisi ed evitato condotte fraudolente, potrà evitare le ipotesi di bancarotta fraudolenta, e se ottiene un concordato può avvalersi di cause di non punibilità per alcuni reati tributari come visto (transazione fiscale). Dunque anche sul piano penale la tempestività e correttezza gestionale paga.
In conclusione, gli amministratori di un’azienda indebitata devono muoversi con estrema cautela e responsabilità. Le linee guida fondamentali sono: monitorare la crisi, informare correttamente gli organi sociali, non peggiorare la situazione con operazioni spregiudicate, rispettare gli obblighi civilistici (capitale), e attivare per tempo le procedure di composizione della crisi. Così facendo, oltre a servire al meglio l’interesse dei creditori (e quindi aumentare le chance di risanamento), gli amministratori si tutelano da accuse future. Un amministratore che dimostra di aver fatto tutto il possibile per salvare l’azienda o quantomeno per liquidarla ordinatamente difficilmente verrà colpevolizzato; viceversa chi resta inerte o aggrava dolosamente la situazione andrà incontro quasi certamente a conseguenze giuridiche sfavorevoli.
Vale la pena di sottolineare che il Codice della Crisi, nel suo intento, ha cercato di creare un ecosistema in cui l’imprenditore onesto e diligente che affronta subito la crisi ottenga degli “sconti” (meno sanzioni, niente azioni di responsabilità se non ci sono danni ulteriori, niente bancarotta preferenziale se i pagamenti erano funzionali a un piano di risanamento , ecc.), mentre l’imprenditore inesperto o disonesto che nasconde la testa sotto la sabbia o compie atti di frode venga punito più severamente. Le numerose norme sulle premialità e sull’esdebitazione (vedremo dopo cosa significa) vanno lette in questa chiave: incoraggiare la gestione attiva e trasparente della crisi, scoraggiare le furbizie e l’ostinazione colpevole.
Strumenti per Risanare i Debiti nel Codice della Crisi d’Impresa
Passiamo ora ad esaminare le soluzioni giuridiche che un’azienda indebitata ha a disposizione per gestire la crisi e, ove possibile, salvarsi. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) prevede un’articolata gamma di strumenti, dalle procedure stragiudiziali e volontarie fino a quelle concorsuali giudiziali, allo scopo di offrire all’imprenditore vari percorsi per ristrutturare il debito o liquidare in modo ordinato . La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi, dalla fattibilità di una continuazione aziendale, dal numero e tipo di creditori, e dalla volontà di questi ultimi di cooperare.
Possiamo classificare gli strumenti in due macro-categorie:
- Soluzioni stragiudiziali (volontarie o con minima interferenza del tribunale): qui rientrano la Composizione negoziata della crisi e il Piano attestato di risanamento. Si tratta di percorsi in cui l’accordo con i creditori è raggiunto su base volontaria, senza l’apertura formale di una procedura concorsuale pubblica. Il tribunale interviene solo marginalmente (per concedere misure protettive o omologare singoli aspetti se necessario), ma in sostanza l’azienda rimane “in bonis” (non dichiarata insolvente). Questi strumenti sono flessibili e confidenziali.
- Procedure concorsuali giudiziali: includono l’Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, il Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), il Concordato semplificato post-fallimento negoziato, e la Liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento). Queste sono procedure aperte dinanzi al tribunale, con nomina di organi ausiliari (commissario, liquidatore), pubblicità legale e coinvolgimento di tutti i creditori secondo regole di maggioranza e par condicio. Sono più strutturate e rigide, ma permettono di imporre soluzioni anche ai creditori dissenzienti.
In aggiunta, esistono procedure peculiari per le imprese minori non fallibili (concordato “minore” e liquidazione controllata), che riprendono la filosofia delle procedure di sovraindebitamento.
Analizziamo uno per uno questi strumenti principali, indicando per ciascuno chi vi può accedere, come funzionano in breve, quali vantaggi offrono e in quali casi convengono.
Composizione negoziata della crisi (CNC)
La Composizione negoziata della crisi è uno strumento innovativo e prevalentemente stragiudiziale, introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021) e ora disciplinato dagli artt. da 12 a 25-quinquies CCII . Ha sostituito le procedure di “allerta” obbligatorie che erano previste originariamente dalla riforma, introducendo invece un processo volontario e riservato di risanamento assistito.
Chi può accedervi: qualunque imprenditore (anche piccolo o agricolo) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far prevedere la crisi o l’insolvenza (in pratica, quando l’azienda è in difficoltà ma non ancora irreversibilmente compromessa). Si accede tramite una piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio, presentando istanza e allegando le informazioni sull’impresa (bilanci, debiti, ecc.). Non è necessario essere formalmente insolventi; anzi, lo scopo è anticipare la soluzione prima dell’insolvenza conclamata.
Come funziona: una volta accettata la domanda, viene nominato da un’apposita commissione un esperto indipendente (di norma un commercialista o avvocato esperto in crisi, iscritto in un elenco). L’esperto convoca l’imprenditore e analizza la situazione aziendale. Insieme, elaborano possibili strategie e conducono trattative con i creditori. L’obiettivo è raggiungere, entro un periodo breve (al massimo 6 mesi prorogabili di 3), un accordo con i creditori che consenta il risanamento dell’impresa. L’accordo può assumere varie forme: dalla semplice dilazione dei pagamenti a un vero e proprio accordo transattivo con stralci (ad esempio, riduzione di parte dei crediti) , oppure la ricerca di un investitore, la cessione di rami d’azienda, ecc. Il tutto avviene riservatamente: l’apertura della procedura di composizione negoziata non è pubblica (non viene iscritta al registro imprese, salvo si chiedano misure protettive). Questo consente all’azienda di lavorare al riparo da stigmi, cercando una soluzione senza allarmare ulteriormente il mercato.
Misure protettive: se necessario, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive durante la composizione negoziata: tipicamente un blocco o moratoria delle azioni esecutive da parte dei creditori per la durata delle trattative . Il tribunale, valutato che vi siano trattative serie in corso, emette un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti e sequestri fino a X giorni (prorogabile). Ciò crea un ambiente stabile in cui negoziare. Nel frattempo però l’impresa continua ad essere gestita dall’imprenditore, senza organi commissariali, sebbene sotto la vigilanza morale dell’esperto. Quest’ultimo non ha poteri gestori, ma può segnalare atti pregiudizievoli al tribunale (che potrebbe revocare le misure protettive se l’imprenditore non collabora).
Esito: se si raggiunge un accordo soddisfacente con una parte significativa o la totalità dei creditori, la composizione negoziata si conclude con la stipula degli accordi. Questi possono rimanere privati (accordi contrattuali bilaterali con i singoli creditori) oppure possono essere elevati a rango di accordo di ristrutturazione omologato (se si decide di omologarli in tribunale per maggiore efficacia). In ogni caso, l’esperto redige una relazione finale in cui attesta l’esito (positivo o negativo). Se l’accordo riesce, l’impresa esce dalla composizione negoziata “in bonis” e prosegue l’attività risanata . Se invece non si trovano soluzioni (o i creditori chiave non aderiscono), l’imprenditore potrà scegliere di: uscire dalla procedura e magari accedere ad un concordato semplificato per la liquidazione (se risulta impossibile la continuità), oppure presentare un ricorso per concordato preventivo ordinario o altre procedure. Durante tutto il periodo negoziato, l’imprenditore conserva la possibilità di “deviare” verso un concordato preventivo con riserva, se vede che le trattative falliscono.
Vantaggi della CNC: è confidenziale, flessibile (non richiede di rispettare rigide percentuali di legge per i creditori – si può accordarsi come si vuole con ciascuno), relativamente veloce (massimo 9-12 mesi) e poco costosa rispetto a un concordato (non ci sono spese di giustizia, solo il compenso dell’esperto secondo tariffa). Permette di ottenere uno stay temporaneo senza dichiarare insolvenza . Inoltre, se l’imprenditore vi accede per tempo, gode delle misure premiali citate (riduzioni di sanzioni fiscali, attenuanti per tardivo fallimento, ecc.) . Lo svantaggio è che richiede collaborazione volontaria dei creditori: non c’è un voto a maggioranza, ogni creditore può decidere di non aderire e, salvo alcune eccezioni, non può essergli imposto nulla. Quindi funziona bene se c’è un numero limitato di creditori rilevanti e se questi sono ragionevoli. Se invece i creditori sono tanti o litigiosi, o se serve tagliare pesantemente il debito di una parte non trascurabile di essi, la CNC può non bastare e bisogna passare a un concordato.
In pratica, la composizione negoziata conviene quando l’impresa ha prospettive di risanamento reali (esiste un core business sano se alleggerito dai debiti), la crisi è ancora gestibile, e c’è apertura al dialogo dai creditori principali . Ad esempio, se un’azienda ha 5 banche e 10 fornitori importanti e tutti (o la maggior parte) sono disponibili a trovare un’intesa fuori dal tribunale, la CNC è ideale: consente soluzioni su misura (magari accordi diversi con ciascuno) senza la rigidità di un concordato . Inoltre, evita il “marchio” di impresa insolvente: molti contratti contengono clausole di risoluzione in caso di fallimento o concordato, mentre la CNC non essendo procedura concorsuale non fa scattare queste clausole risolutive . Ciò aiuta a mantenere commesse e contratti.
Va detto che durante la CNC l’azienda è ancora formalmente attiva: quindi deve stare attenta a non peggiorare la posizione dei creditori estranei. Ad esempio, non può pagare solo alcuni creditori violando la par condicio (a meno di cose autorizzate dall’esperto come funzionali al risanamento), altrimenti rischia poi contestazioni in eventuale fase successiva. Tuttavia, i pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione di accordi raggiunti in CNC che vengono conclusi e depositati possono ottenere la stessa esenzione da revocatoria prevista per i piani attestati pubblicati (se l’accordo viene pubblicato nel registro imprese o omologato come ADR).
In sintesi: la Composizione negoziata è un ombrello temporaneo che l’imprenditore può aprire per cercare di risolvere la crisi consensualmente e rapidamente, mantenendo il controllo dell’azienda. Se piove troppo forte (creditori non collaborativi), allora questo ombrello potrebbe non bastare e servirà entrare in un rifugio più solido (concordato). Ma tentarne l’uso è spesso raccomandabile, data la sua economicità e la possibilità di evitare l’”ultimo stadio” concorsuale .
Piano attestato di risanamento (PAR)
Il Piano attestato di risanamento è uno strumento stragiudiziale puro, disciplinato dall’art. 56 CCII (già art. 67 L.F.). Si tratta di un piano di risanamento predisposto dall’imprenditore, asseverato da un professionista indipendente, e facoltativamente pubblicato nel registro delle imprese . Lo scopo è quello di permettere all’impresa di ristrutturare i debiti e riequilibrare la situazione finanziaria in via privata, beneficiando però di alcune tutele di legge (in particolare, l’esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti eseguiti in adempimento del piano: art. 166, comma 3, lett. d) CCII).
Come funziona in breve: l’azienda elabora, magari con l’aiuto di advisor finanziari, un piano industriale e finanziario pluriennale che mostra come potrà superare la crisi e tornare solvibile. Nel piano prevede specifiche azioni: ad esempio, accordi con determinati creditori (banche, fornitori) per dilazioni o stralci, cessione di asset non strategici per fare cassa, ricapitalizzazioni da parte dei soci, taglio costi, ecc. Questo piano viene sottoposto a un attestatore (un professionista terzo, iscritto a registro, tipicamente un commercialista esperto in crisi) che verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestatore rilascia una relazione di attestazione positiva se ritiene che il piano sia realistico e idoneo a risanare l’impresa.
Gli accordi con i creditori nel contesto di un PAR non richiedono un’adesione minima per legge: sono accordi bilaterali volontari. Spesso l’azienda negozia con le banche principali una moratoria o un refinancing, con i fornitori principali uno scaglionamento dei pagamenti, etc., e questi accordi vengono richiamati nel piano.
Una volta ottenuta l’attestazione, l’impresa può – ma non è obbligatorio – pubblicare la relazione e il piano nel registro delle imprese. La pubblicazione serve soprattutto a cristallizzare la data e consentire la protezione dagli effetti della revocatoria: la legge infatti prevede che i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato pubblicato non siano soggetti a revocatoria in caso di successivo fallimento (purché il piano non fosse un mero artificio doloso). Ciò dà fiducia ai creditori che partecipano al piano: sanno che, se accettano una dilazione o un pagamento parziale come da piano, quell’atto non verrà più messo in discussione anche se la società fallisse poi, salvo frode.
Ruolo del tribunale: nessuno, direttamente. Non c’è omologa, non c’è apertura di procedura. Il tribunale può entrare in gioco indirettamente se l’impresa, durante la negoziazione del piano, ha bisogno di protezione: in tal caso però deve attivare una composizione negoziata o presentare un’istanza di misure cautelari parallele (il CCII consente di richiedere misure protettive temporanee propedeutiche alla finalizzazione di un piano attestato, di fatto innestandosi nella composizione negoziata). Ma il piano attestato in sé non prevede automatic stay.
Quando conviene: il PAR è ideale se l’impresa ha relativamente pochi creditori chiave e ragionevolmente cooperativi, tali che si può trovare un accordo individuale con ciascuno di essi. Ad esempio: 3 banche principali e 5 fornitori strategici, che concordano un piano di rientro, mentre i creditori minori verranno comunque pagati integralmente a scadenza (per non complicare il piano). In questi casi non serve la macchinosità di un concordato – basta un accordo quadro privato. Il vantaggio per l’impresa è di evitare la procedura concorsuale, restando “pulita” sul mercato (il piano non comporta insolvenza dichiarata). Inoltre i professionisti attestatori lavorano per l’azienda, quindi c’è maggiore flessibilità nel tarare il piano.
I limiti del PAR sono: richiede unanimità di fatto con i creditori coinvolti (se una banca non sta all’accordo, non c’è strumento per forzarla); non dà protezione immediata se un creditore volesse agire esecutivamente (a meno di misure protettive richieste in altro contesto); e se la crisi è molto grave o i creditori sono troppi, è difficile da implementare.
In passato, molti piani attestati venivano usati anche per la sola finalità di proteggere pagamenti: l’imprenditore faceva un mini-piano “di comodo” per legittimare pagamenti preferenziali e sottrarli alla revocatoria. La giurisprudenza ha reagito dicendo che la protezione vale solo se il piano è serio e funzionale al risanamento, altrimenti quell’attestazione farlocca non salva i pagamenti preferenziali . Quindi oggi un PAR deve essere genuino e concretamente idoneo a migliorare la situazione dell’impresa per poter dispiegare le sue tutele.
In conclusione, il piano attestato di risanamento è uno strumento raffinato da usare in situazioni dove la crisi è affrontabile con pochi accordi mirati, magari confidando in nuova finanza dei soci e in piccole concessioni dai creditori. È il più economico e meno invasivo degli strumenti: nessun commissario, nessuna pubblicità tranne (eventuale) l’annotazione del piano. Ma in scenari complessi potrebbe rivelarsi insufficiente.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)
Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti a metà strada tra il piano attestato e il concordato: sono accordi privati con i creditori, ma con un intervento dell’autorità giudiziaria per renderli efficaci erga omnes in certe parti. Sono disciplinati dagli artt. 57-64 CCII (ex art. 182-bis e ss. L.F.) . L’idea di base è: se il debitore riesce ad ottenere l’adesione di una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% dell’ammontare dei debiti), allora quell’accordo può essere omologato dal tribunale e reso vincolante, con alcuni effetti protettivi anche verso i non aderenti.
Procedura in breve: il debitore negozia con quanti più creditori possibile un accordo (può essere un unico documento sottoscritto da molti creditori, o accordi separati che poi confluiscono in un unico piano). Deve raggiungere almeno il 60% dei crediti totali. Predispone una relazione di un esperto attestatore sulla fattibilità dell’accordo e sulla capacità di soddisfare integralmente i creditori estranei nei termini di legge. Deposita quindi in tribunale la domanda di omologazione dell’accordo, allegando l’accordo stesso e l’elenco dei creditori aderenti. Il tribunale, dopo aver verificato la regolarità e sentito eventualmente i creditori contrari, omologa l’accordo rendendolo efficace.
Effetti principali:
- I creditori aderenti sono vincolati a quanto sottoscritto: ad es. se hanno accettato il 70% a saldo, saranno obbligati a tale stralcio una volta omologato.
- I creditori non aderenti rimangono formalmente fuori dall’accordo: non subiscono la falcidia (devono essere pagati integralmente). Tuttavia, la legge consente alcune agevolazioni: il debitore può chiedere al tribunale di sospendere azioni esecutive dei non aderenti finché l’omologa non è completa, e fino a 60-120 giorni dopo (moratoria temporanea) . Inoltre, se l’accordo coinvolge banche o obbligazionisti finanziari, è possibile imporre il vincolo anche ai dissenzienti finanziari se si raggiunge il 75% di adesione di tale categoria (c.d. cram-down finanziario introdotto nel 2021). Ciò significa, ad esempio, che se 3 banche su 4 (aventi il 80% del credito finanziario) aderiscono, l’accordo omologato può essere esteso anche alla quarta banca dissenziente, purché le vengano offerte condizioni non deteriore di molto a quelle medie degli aderenti .
- L’omologazione comporta l’esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie compiuti in esecuzione dell’accordo (come per il piano attestato).
- Non c’è voto dei creditori come nel concordato, perché l’adesione è manifestata contrattualmente prima. I creditori contrari possono però fare opposizione in sede di omologa, lamentando eventualmente pregiudizio (ad es. un creditorino estraneo può temere di non venir pagato intero nonostante la previsione di legge).
Misure protettive: sin dal deposito della domanda di omologa, il tribunale può bloccare le azioni esecutive di tutti i creditori, aderenti e non, per massimo 6 mesi (prorogabili di altri 6) . Questo è un grande vantaggio rispetto al piano attestato: l’impresa ottiene un automatic stay come nel concordato, ma senza essere in procedura concorsuale. Ciò consente di finalizzare le ultime adesioni in tranquillità.
Transazione fiscale negli ADR: il debitore può includere anche il Fisco e gli enti previdenziali nell’accordo. Tuttavia, fino al 2020 la regola era che per falcidiare i tributi serviva comunque l’adesione formale dell’Agenzia Entrate. Dal 2020 in poi, grazie sempre al DL 125/2020, anche negli accordi di ristrutturazione è previsto il meccanismo del cram-down fiscale: se il Fisco (o l’INPS) non aderiscono ma l’accordo è stato approvato dalla percentuale di altri creditori richiesta (60%) e il trattamento proposto al Fisco è conveniente rispetto al fallimento, il tribunale può omologare comunque l’accordo nonostante il diniego del Fisco . Cassazione recente (sent. 34377/2024 e 32954/2024) ha chiarito i termini procedurali: il debitore deve notificare all’Erario la proposta e attendere 30 giorni per l’eventuale adesione; se l’Erario tace o dice no, può chiedere l’omologa col cram-down, purché abbia già l’accordo con gli altri creditori non erariali . Inoltre è condizione necessaria che almeno qualche creditore non fiscale abbia aderito (non si può fare un ADR cram-down solo col Fisco e nessun privato) . In pratica, la giurisprudenza ha posto paletti per impedire che si usi l’ADR solo per bypassare il voto fiscale senza un vero consenso degli altri creditori.
Tipologie speciali di ADR: il CCII ha introdotto alcune varianti: l’accordo ad efficacia estesa a creditori finanziari dissenzienti (già menzionato), l’accordo agevolato con soglia abbassata al 30% dei crediti (ma con pagamento integrale dei non aderenti entro 120 giorni), e il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) in cui non serve il 60% ma si propone un piano a classi con cram-down (una sorta di mini-concordato semplificato). Il PRO è una novità di derivazione europea, introdotta dal D.Lgs. 83/2022, da utilizzare quando non si raggiungono le maggioranze ADR ma c’è comunque consenso parziale: consente di chiedere l’omologa di un piano anche senza 60%, con misure protettive già in corso . È però uno strumento avanzato e ancora poco sperimentato in giurisprudenza.
Quando conviene un ADR: tipicamente quando l’impresa ha molti debiti finanziari e qualche fornitore grosso, e riesce ad ottenere l’ok della maggioranza di essi, ma vuole comunque tutelarsi dal free rider (il piccolo creditore esterno che potrebbe attaccare). L’ADR ha meno costi e formalità del concordato, e una durata più breve (l’omologa avviene in pochi mesi, senza voto assembleare). Ad esempio, se si hanno poche banche che coprono 70% del debito e sono d’accordo a ristrutturare, ma restano 30% di fornitori dispersi, l’ADR permette di siglare con le banche e poi pagare per intero i fornitori estranei ma in modo dilazionato (entro 120-180 giorni dall’omologa, come consente la legge). In tal modo i fornitori non possono fare nulla nel frattempo e si devono accontentare di aspettare quei mesi per essere pagati integralmente. È un compromesso vantaggioso spesso.
Rispetto al concordato, l’ADR non consente di imporre perdite ai non aderenti (salvo la categoria finanziaria col 75% di consensi). Quindi se c’è da falcidiare pesantemente anche i piccoli creditori, meglio il concordato. Inoltre nell’ADR non c’è commissario né voto, per cui se un creditore importante non firma, l’accordo non si perfeziona: questa fragilità va considerata.
Esempio d’uso: un’azienda con 10 milioni di debiti, di cui 7 verso 5 banche e 3 verso 50 fornitori. L’azienda riesce a convincere 4 banche su 5 (rappresentanti il 80% del totale crediti) a firmare un accordo in cui prendono il 50% in 5 anni, e magari i fornitori principali con 1 milione di crediti aderiscono per 30% in 2 anni. Il totale adesioni è 70% dei crediti: sopra il 60%. Si chiede omologa: l’unica banca dissenziente (20%) sarà soggetta a cram-down finanziario se soddisfatte le condizioni; i fornitori estranei (che non hanno firmato) vanno pagati integrali entro 120 giorni dall’omologa (o come stabilito), e intanto non possono agire. L’accordo si realizza e l’azienda evita il fallimento con una procedura più snella del concordato.
Da notare: se poi durante l’accordo omologato il debitore non rispetta gli impegni, i creditori tornano liberi di agire e l’ombrello dell’omologa cade. Non c’è liquidatore o simili: è un contratto vincolante ma pur sempre contratto, non procedura esecutiva. In caso di inadempimento, i creditori potrebbero poi chiedere un fallimento.
Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)
Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale, presente da decenni nell’ordinamento (anche la vecchia legge fallimentare lo prevedeva) ed ora rinnovata negli artt. 84 e ss. CCII . È la procedura mediante la quale un debitore in stato di crisi o insolvenza propone ai creditori un piano per la ristrutturazione dei debiti (sia tramite prosecuzione dell’attività, sia tramite liquidazione dei beni) che viene votato dai creditori stessi e, in caso di approvazione, omologato dal tribunale, diventando vincolante per tutti. Il concordato ha diverse varianti, ma principalmente distinguiamo:
- Concordato in continuità aziendale: il piano prevede la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività dell’impresa, utilizzandone i ricavi futuri per pagare i creditori. Esso può prevedere anche intervento di nuovi investitori, ristrutturazione aziendale, etc. La continuità può essere diretta (l’azienda stessa prosegue) o indiretta (ad esempio, si affitta l’azienda o la si vende in blocco a un terzo che continua l’attività, distribuendo il ricavato).
- Concordato liquidatorio: il piano prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio ai creditori. È ammesso solo se i creditori ricevono almeno il 20% di soddisfazione (regola del “quinto”), salvo che vengano apportate risorse esterne aggiuntive.
- (Esiste poi il concordato semplificato che vedremo a parte, perché peculiare e senza voto creditori, applicabile solo in casi post-composizione negoziata fallita).
Fasi e funzionamento: Il concordato si apre con la presentazione di un ricorso da parte del debitore al tribunale competente, accompagnato da una proposta, un piano dettagliato e una relazione di un attestatore indipendente che certifica veridicità dei dati e fattibilità del piano. In alternativa, l’impresa può presentare un ricorso “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco), chiedendo un termine (45-120 giorni) per depositare poi piano e proposta . Il tribunale, all’apertura, nomina un Commissario Giudiziale (supervisore) e dispone le misure protettive (divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 54 CCII, analogo al vecchio art. 168 L.F.), cioè blocco dei pignoramenti da parte dei creditori per tutta la durata della procedura .
Segue la fase di istruttoria: il commissario esamina l’azienda e raccoglie le dichiarazioni di credito dai creditori, formando l’elenco dei crediti ammessi al voto. Il debitore può svolgere l’attività ordinaria sotto vigilanza, mentre per gli atti straordinari deve chiedere autorizzazione al tribunale. Se è concordato in continuità, l’attività prosegue; se è liquidatorio, spesso viene autorizzato a vendere già alcuni beni con procedure competitive pre-omologa.
Si tiene quindi l’adunanza dei creditori: i creditori votano sulla proposta secondo classi (se il piano le prevede) o per categorie di legge. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (>50% in valore; non conta il numero di teste). Se ci sono classi, serve anche che la maggioranza delle classi approvi (o che il tribunale applichi il cram down interclassi se alcuni la bocciano ma altri approvano, purché i dissenzienti siano trattati equamente).
Una volta approvato dai creditori, il tribunale passa alla fase di omologazione: verifica legalità e merito (tra cui la convenienza della proposta per i creditori dissenzienti, cioè che prendano almeno quanto otterrebbero in liquidazione fallimentare). Se tutto ok, emette decreto di omologa. Da quel momento il piano concordatario diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche quelli che non hanno votato o hanno votato contro.
L’esecuzione del concordato viene poi attuata dal debitore sotto il controllo di un commissario/giudice delegato o, in caso liquidatorio, di un liquidatore nominato.
Trattamento dei creditori nel concordato: dipende dal piano, ma rispettando le regole di priorità. I creditori privilegiati (es. ipotecari, privilegi speciali) devono essere soddisfatti per intero salvo il caso in cui il bene su cui insiste la garanzia non copra l’intero credito: allora la parte eccedente diviene chirografa e può essere falcidiata. I creditori con privilegio generale (Erario, INPS, dipendenti) in un concordato liquidatorio devono essere anch’essi soddisfatti integralmente (almeno per la parte di privilegio) a meno che il valore di liquidazione non basti – ma in un concordato in continuità, grazie alla transazione fiscale e contributiva, si può proporre il pagamento parziale anche di IVA, ritenute e contributi, come già spiegato, a condizione di rispettare la regola di miglior soddisfazione rispetto al fallimento . I creditori chirografari vengono messi in classi omogenee e di solito ottengono percentuali ridotte. Come vincolo generale, in un concordato liquidatorio puro almeno il 20% ai chirografari deve essere garantito (art. 84 CCII) – se non c’è, non è ammissibile a meno di contributi esterni che aumentino il monte creditori. Nel concordato in continuità, non c’è soglia minima di legge per i chirografari, potenzialmente potrebbero ricevere anche meno del 20% se ciò è comunque più di quanto avrebbero in caso di liquidazione, e se accettano la proposta.
Cram-down fiscale: l’abbiamo già trattato – è applicabile pari pari nel concordato. Dunque il tribunale può omologare anche col voto contrario del Fisco, se l’offerta soddisfa il best interest test per l’Erario . La Cassazione (sent. 27782/2024 citata) ha confermato che non è nemmeno necessaria l’astensione del Fisco: può aver votato no, ma il giudice può comunque forzare l’omologa . Anche le sezioni unite sono intervenute su un aspetto peculiare: con sentenza 20036/2024 hanno stabilito che eventuali azioni di risarcimento contro l’Agenzia Entrate per aver rifiutato una transazione fiscale rientrano nella giurisdizione ordinaria (non tributaria) e che il danno eventualmente lamentato attiene alla lesione del principio di buona fede nelle trattative . Questo per dire che il contenzioso sul ruolo del Fisco nei concordati è stato vivace, ma la tendenza attuale è dare prevalenza all’interesse concorsuale sul particolare, come ben sintetizzato da un decreto del Tribunale di Roma del 2023: “la funzione dell’omologazione forzosa è perseguire il preminente interesse concorsuale superando le resistenze degli uffici [fiscali]” .
Concordato in continuità vs liquidatorio: nella continuità l’azienda prosegue e dunque il piano punta a generare valore dai ricavi futuri. Ci sono regole speciali: ad es. come detto i lavoratori vanno pagati entro 12 mesi ; se la continuità è indiretta (es. cessione d’azienda a terzi) il 10% del prezzo di cessione deve andare ai chirografari se i privilegiati non sono soddisfatti al 100% (regola per evitare concordati finti liquidatori mascherati da continuità). Nella liquidazione, si vendono i beni. Il vantaggio del concordato liquidatorio rispetto al fallimento è che si può pianificare la vendita in blocco, magari trovando un compratore dell’intera azienda che paghi più di quanto frutterebbe la liquidazione atomistica . Inoltre, i soci possono apportare risorse aggiuntive (denaro fresco) da destinare ai creditori: questo aumenta la “convenienza” per i creditori e rende ammissibile la proposta anche se di base offrirebbe meno del 20%. Il concordato liquidatorio quindi ha senso se si può offrire ai creditori qualcosa in più di un fallimento standard . Se non si hanno tali elementi migliorativi, il tribunale potrebbe non ammettere la proposta (in passato i concordati liquidatori puri con piccoli vantaggi sono stati ammessi, ma la riforma intende scoraggiarli, preferendo in tal caso andare direttamente a liquidazione giudiziale).
Durata e costi: il concordato è la procedura più lunga e costosa. Dall’ammissione all’omologa spesso passa 1 anno o più (tra tempi per presentare piano, voti e omologa). Prevede il pagamento delle spese di giustizia in prededuzione (compenso commissario, liquidatore, esperto attestatore, legali, ecc.). È dunque un percorso impegnativo. Il legislatore però lo ha reso più attraente rispetto al passato per i debitori, proprio introducendo cose come la transazione fiscale e regole più flessibili per la continuità. Oggi il concordato in continuità è visto come uno strumento di “rescue” in linea con la Direttiva UE, mentre prima era usato spesso come escamotage liquidatorio (con cordate di affittuari, ecc.).
Quando ricorrervi: il concordato preventivo si rivolge a situazioni dove serve un trattamento concorsuale di ampia portata: debiti insostenibili con moltissimi creditori, necessità di tagliare erga omnes il passivo e magari di reperire nuova finanza in prededuzione (che i nuovi investitori concedono solo se c’è la protezione concorsuale). Ad esempio, se la nostra azienda di filtri ha debiti multipli (banche, fisco, fornitori) e vuole salvarsi, il concordato in continuità consente di cristallizzare tutto il debito pregresso, bloccare i pignoramenti, e ripartire con un carico ridotto, pagando quanto promesso nel piano con i profitti futuri. Nessuna soluzione stragiudiziale darebbe quella definitiva “ripulita” al bilancio. D’altra parte, il concordato richiede di convincere i creditori (almeno la maggioranza) che il piano è credibile e conviene a loro. Spesso ciò comporta notevoli sforzi di comunicazione e trasparenza: incontri con banche e fornitori durante la procedura, illustrazione dettagliata del piano industriale, ecc. .
Un buon concordato può anche prevedere soluzioni creative: ad esempio, la conversione di crediti in quote societarie (debt-equity swap) per dare ai creditori un potenziale upside futuro ; oppure l’ingresso di un nuovo investitore in equity o con finanza esterna, che apporta soldi freschi (questi soldi possono essere destinati a pagare i creditori in prededuzione, incentivando l’adesione). Tutto ciò è permesso e incoraggiato.
In conclusione, il concordato è la procedura regina per risolvere le crisi d’impresa complesse. Richiede buone basi (un business almeno potenzialmente profittevole se rilanciato, o asset liquidabili a sufficienza) e buona fede. Dal punto di vista dell’imprenditore, presentare un concordato serio è considerato un comportamento virtuoso se l’alternativa sarebbe fallire senza tentare nulla . Non a caso, in caso di fallimento successivo, il tribunale valuta negativamente chi non abbia provato a percorrere strade come il concordato liquidatorio prima di arrendersi .
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il concordato semplificato è un istituto speciale introdotto in via sperimentale dal D.L. 118/2021 (art. 25-sexies CCII) . Esso consente, solo in caso di esito infruttuoso di una composizione negoziata, di accedere a un concordato liquidatorio senza voto dei creditori. In pratica, se l’imprenditore ha tentato la CNC ma non è riuscito a trovare un accordo e la crisi risulta non risolvibile se non liquidando, può presentare una proposta di concordato “semplificato” al tribunale, offrendo ai creditori tutto il ricavato liquidatorio (più eventuali extra) e ripartendolo secondo le priorità di legge. I creditori non votano, il tribunale valuta la fattibilità e la non manifesta pregiudizievolezza, e può omologarlo d’ufficio. Un liquidatore nominato venderà i beni e ripartirà il ricavato.
Questo strumento è concepito per evitare di dover passare dal fallimento quando comunque si è già persa un po’ di tempo con la negoziazione. Il vantaggio per il debitore è che velocizza la chiusura in maniera ordinata, e soprattutto può evitare alcune conseguenze afflittive del fallimento: ad esempio, l’imprenditore non viene dichiarato fallito, e ciò può aiutare a preservare la reputazione e ad evitare le interdizioni legali collegate (es. divieto di ricoprire cariche, etc.). In più, consente di nominare un liquidatore di fiducia e di evitare alcune lungaggini di un fallimento (bando di vendita, etc.), potendo magari vendere in blocco gli asset.
Tuttavia, il concordato semplificato liquida comunque l’impresa – non la salva – quindi è un rimedio di chiusura. I creditori potrebbero opporsi in sede di omologa se ritengono che in fallimento avrebbero di più, ma è difficile immaginare un caso in cui il fallimento generi più valore di una vendita ragionata (salvo situazioni particolari). Nel 2022-2023 ci sono state alcune applicazioni: per esempio, piccole imprese che, fallita la trattativa in CNC, hanno usato il semplificato per vendere rapidamente beni e pagare i creditori in pochi mesi invece di attendere anni di fallimento.
Importante: il concordato semplificato non è un diritto automatico: è in potere del tribunale ammettere e omologare. Se il tribunale percepisce malafede o mancanza di trasparenza nel precedente tentativo di CNC, potrebbe respingere la domanda di semplificato, e a quel punto si aprirebbe la liquidazione giudiziale tradizionale. Quindi è riservato a chi effettivamente ha collaborato e tentato seriamente di risolvere la crisi prima.
Per i creditori, il beneficio del concordato semplificato è di solito una distribuzione più rapida e costi minori rispetto al fallimento. Ecco perché il legislatore lo ha introdotto: per far sì che anche i casi disperati dopo la negoziazione abbiano uno sbocco efficiente, senza punire oltremisura il debitore cooperativo.
Liquidazione giudiziale (ex “fallimento”)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale di natura liquidatoria-coattiva che ha preso il posto del “fallimento” con il nuovo Codice (le sue norme ricalcano in gran parte la vecchia legge fallimentare, ma con vari aggiornamenti terminologici e procedurali). È la soluzione finale quando l’impresa è insolvente e non esistono prospettive di risanamento o soluzioni concordate. Vi si accede su richiesta di un creditore, del debitore stesso o d’ufficio dal tribunale in caso di altre procedure non andate a buon fine.
Una volta aperta, la liquidazione giudiziale comporta:
- Spossessamento dell’imprenditore, sostituito dal Curatore nominato dal tribunale che amministra i beni.
- Interruzione dell’attività salvo esercizio provvisorio autorizzato in casi eccezionali (se serve a conservare valore per una cessione migliore).
- Cristallizzazione dei debiti al momento dell’apertura: i creditori devono insinuarsi al passivo e verranno soddisfatti secondo le regole del concorso (privilegi prima, chirografi proporzionalmente se avanza).
- Possibili azioni di revocatoria fallimentare su pagamenti preferenziali o atti a titolo oneroso compiuti in tempi sospetti prima della procedura (6 mesi – 1 anno prima, a seconda dei casi, salvo esenzioni come viste).
- Investigazioni su eventuali responsabilità degli amministratori (il Curatore può promuovere l’azione di responsabilità di cui sopra).
- Al termine, chiusura della procedura e cancellazione della società dal registro. L’imprenditore persona fisica o socio illimitatamente responsabile, se ha agito onestamente, può ottenere l’esdebitazione (vedi FAQ su questo) liberandosi dai debiti residui .
La liquidazione giudiziale è ovviamente l’esito più indesiderato per il debitore: perde la gestione dell’azienda, che spesso viene smembrata. Per i creditori stessi non è ottimale, perché i recuperi in fallimento sono storicamente molto bassi (spese procedura elevate, tempi lunghi, beni venduti all’asta spesso a prezzi ribassati). Per questo la legge e la prassi preferiscono concordati e accordi, se praticabili .
Ci sono casi però in cui la liquidazione giudiziale è inevitabile: quando oggettivamente non c’è niente da fare per salvare l’impresa (“azienda decotta”), e magari il debitore stesso non propone soluzioni. In quelle situazioni, anziché protrarre una agonia, è meglio che un organo terzo prenda in mano il patrimonio residuo e lo distribuisca come giustizia comanda.
Esempio tipico: un’azienda che ha perso tutti i clienti, ha macchinari obsoleti, ha debiti enormi che superano gli attivi, e nessun investitore interessato: qui un concordato anche a pensarci sarebbe privo di contenuto utile; tanto vale portare i libri in tribunale. Oppure, i creditori stessi perdono fiducia e presentano istanza.
Da notare che il CCII stabilisce che le imprese minori sotto soglia non possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale, bensì solo a liquidazione controllata (procedura di sovraindebitamento) . In pratica, se un’impresa è non fallibile (parametri: attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k ), i creditori non possono chiederne il fallimento ma la liquidazione controllata ex L.3/2012. Tuttavia molte S.r.l. superano tali soglie minime con facilità , quindi la maggior parte delle società di capitali medie e grandi rimane soggetta a liquidazione giudiziale ordinaria.
Un cenno va fatto all’esdebitazione dell’imprenditore individuale onesto: dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, l’imprenditore persona fisica è automaticamente esdebitato dei debiti residui (art. 278 CCII) salvo eccezioni, a meno che non venga negato per frodi . Ciò consente all’ex fallito di ripartire pulito. Nel caso di una S.r.l., la società viene estinta con i debiti non soddisfatti che restano inesigibili (non c’è “fresh start” per la società perché cessa di esistere) . I soci di S.r.l., come detto, non rispondono dei debiti sociali residui se non avevano garanzie o colpe dirette, quindi per loro il fallimento della società è di solito la fine della vicenda (a meno di azioni di responsabilità o penali). Gli amministratori però, se colpevoli, non beneficiano certo di esdebitazione rispetto alle loro obbligazioni risarcitorie: anzi, come visto, curatore e creditori possono inseguirli per danni .
In sintesi, la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio: serve a chiudere i conti quando non c’è più trippa per gatti. Dal punto di vista dell’imprenditore, arrivare a questo punto senza aver tentato almeno un concordato può esporlo a critiche severe e ad azioni per aver aggravato il dissesto . E dal punto di vista dei creditori, come già detto, spesso conviene preferire concordati pilotati (anche liquidatori) perché danno qualche prospettiva in più di recupero e tempi minori . Non sempre però è possibile: se manca un acquirente e i soci non mettono un euro, il concordato liquidatorio rischia di essere bocciato per mancanza di convenienza, e la via del fallimento diventa obbligata.
A questo punto, avendo passato in rassegna tutti i principali strumenti di regolazione della crisi, può essere utile una visione d’insieme comparativa per fissare le idee. La tabella seguente confronta sinteticamente le caratteristiche dei vari strumenti (natura, ruolo del tribunale, consenso dei creditori richiesto, misure protettive disponibili, effetti sui debiti e destino finale dell’impresa):
Tabella 1: Confronto tra i principali strumenti di gestione della crisi d’impresa
| Strumento | Natura e ruolo del tribunale | Consenso dei creditori | Misure protettive | Effetti sui debiti | Esito per l’impresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Stragiudiziale assistita da esperto. Tribunale coinvolto solo su richiesta per misure protettive o atti urgenti; nessuna dichiarazione di insolvenza (azienda resta in bonis). | Volontario individuale: ogni creditore deve aderire ai singoli accordi di risanamento. Nessun meccanismo di voto a maggioranza (accordi bilaterali). | Sì, su richiesta: sospensione delle azioni esecutive (stay) concessa dal tribunale fino a 12 mesi totali . Possibili misure cautelari ad hoc (es. divieto di revoca fidi) . | Solo debiti dei creditori aderenti vengono ristrutturati secondo gli accordi (dilazioni, stralci). I creditori non aderenti restano estranei e mantengono intero il loro diritto (salvo la moratoria temporanea se c’è lo stay) . Nessun effetto erga omnes unilaterale. | Se si raggiungono accordi con la totalità (o la gran parte) dei creditori, l’impresa prosegue in bonis, “pulita” dai debiti ristrutturati. Se le trattative falliscono, l’impresa può accedere ad altre procedure (concordato, liquidazione) oppure precipitare in liquidazione coatta/fallimento. La CNC in sé non apre procedure concorsuali. |
| Piano attestato di risanamento (PAR) | Stragiudiziale privato. Tribunale non coinvolto (salvo eventuale ausilio per protezioni via CNC parallela). Richiede attestatore indipendente (controllo tecnico) ma non un giudice. | Adesione pressoché unanime dei principali creditori coinvolti: si concordano modifiche bilaterali del credito con ciascun soggetto rilevante. Nessun meccanismo per imporre l’accordo a dissenzienti; i creditori minori possono essere lasciati fuori pagando loro il 100%. | Nessuno stay legale automatico proprio del PAR. Tuttavia, il debitore può richiedere misure protettive attivando una CNC in parallelo se necessario, oppure confidare nel tacito assenso dei creditori durante le trattative. | Debiti ristrutturati solo verso chi aderisce (dilazioni, riduzioni secondo accordi). I creditori estranei devono essere pagati integralmente fuori piano. Protezione anti-revocatoria: se il piano è attestato e pubblicato, i pagamenti/garanzie effettuati in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria in un eventuale fallimento successivo . | L’impresa rimane “in bonis” e continua l’attività normalmente durante e dopo l’attuazione del piano. Non essendo procedura concorsuale, non c’è interruzione formale né stigma – l’azienda risana i propri conti e prosegue. Se il piano fallisce nei suoi obiettivi, l’impresa potrà comunque accedere a procedure concorsuali in un secondo momento (ma eventuali atti compiuti secondo il piano restano protetti se il piano era regolare). |
| Accordo di ristrutturazione (ADR) omologato | Ibrido: accordo privato + omologazione in tribunale. Procedura giudiziale breve per l’omologa. Nessun organo nominato (salvo ausiliari occasionali). Insolvenza non dichiarata, ma l’omologa è pubblica. | 60% del totale debiti minimo di adesioni richiesto dalla legge. I creditori aderenti (≥60%) vincolano l’accordo; i non aderenti restano estranei ma: c’è una moratoria legale per loro e possibili cram-down sui creditori finanziari dissenzienti con ≥75% di consensi finanziari . Non c’è voto assembleare, conta la % di firme raggiunta. | Sì, automatic stay disposto dal tribunale all’atto del deposito della domanda di omologa: sospensione di azioni esecutive e cautelari per max 6 mesi + eventuale proroga di altri 6 . Durante questo periodo i creditori non aderenti non possono agire, in attesa dell’omologa. | Debiti falcidiati/dilazionati per i creditori aderenti secondo quanto stabilito nell’accordo. I dissenzienti devono essere pagati integralmente fuori dall’accordo (entro 120 giorni dall’omologa se chirografari, 180 giorni se privilegiati) , ma subiscono la moratoria temporanea e – se creditori finanziari – possono essere forzosamente inclusi (stesse condizioni degli aderenti) se ricorrono i presupposti (≥75% adesione finanziaria). È ammessa la transazione fiscale integrata nell’accordo, con possibilità di omologa nonostante il voto negativo di Fisco/INPS (cram-down fiscale) . | Se l’accordo è omologato, l’impresa prosegue l’attività (non c’è liquidazione coatta). Non essendo procedura d’insolvenza, l’azienda tecnicamente resta in bonis, ma vincolata a rispettare l’accordo. L’esecuzione rimane in capo al debitore; se l’accordo riesce, l’azienda resta in piedi con il debito ristrutturato. Se l’accordo non viene eseguito (inadempimento), i creditori potranno agire (anche chiedere il fallimento) ma intanto eventuali atti compiuti restano validi. In sé l’ADR non comporta chiusura dell’impresa né nomina di liquidatori. |
| Concordato preventivo <br>(continuità aziendale) | Procedura concorsuale giudiziale completa. Tribunale competente dichiara aperta la procedura, nomina un Commissario giudiziale e sovrintende a tutte le fasi. Impresa ammessa come debitore in “stato di crisi/insolvenza”* ma con prospettiva di risanamento. | Voto dei creditori per classi su proposta del debitore. Serve >50% dei crediti votanti a favore (maggioranza in valore) e la maggioranza delle classi approvanti. I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridico-economica omogenea. I dissenzienti sono comunque vincolati dall’omologa se c’è maggioranza. <br>Casi particolari: possibile cram-down interclassi (se una classe dissenziente è trattata meglio di quelle inferiori); cram-down fiscale (omologa anche con voto contrario Fisco se proposta ≥ caso liquidazione) . | Sì, automatic stay per legge: dal momento di apertura (o dalla domanda con riserva) sono sospese tutte le azioni esecutive e cautelari individuali (art. 54 CCII) . Divieto ai creditori chirografari di iniziare o proseguire pignoramenti; i privilegiati non possono escutere fuori procedura. Lo stay dura per tutta la procedura sino all’omologa (salvo revoca concordato). Inoltre, il debitore sotto commissario deve astenersi da atti straordinari non autorizzati, a tutela del patrimonio. | Debiti ristrutturati per tutti i creditori anteriori secondo la proposta omologata. In continuità: i privilegiati (es. dipendenti, Fisco garantito) solitamente pagati integralmente salvo falcidia consentita per la parte chirografa; chirografari pagano la percentuale offerta (es. 20–30%) e la parte residua è cancellata (esdebitazione dell’ente per la società, che estingue i debiti insoddisfatti con la chiusura). <br>I crediti post-apertura (prededucibili) invece vanno pagati integralmente. La transazione fiscale consente di ridurre IVA, ritenute e contributi purché offerto ≥ valore di liquidazione . <br>Gli atti esecutivi del piano (pagamenti, garanzie, ecc.) godono di esenzione da revocatoria futura . | L’impresa prosegue l’attività durante e dopo il concordato (in continuità). La gestione rimane in mano al debitore (debtor in possession) ma vigilato dal commissario; se la continuità è diretta, l’azienda continua operare normalmente, salvo eventualmente cedere alcune partecipazioni o asset non strategici secondo piano. <br>All’esito, se il concordato viene eseguito correttamente, l’impresa risanata continua a vivere, alleggerita dal debito che è stato stralciato. Se il concordato invece non viene omologato o non viene eseguito, l’alternativa è la liquidazione giudiziale (fallimento). Durante il concordato, l’impresa non viene cancellata né perde la personalità; se l’esito fosse negativo potrebbe comunque subire fallimento successivo. |
| Concordato preventivo <br>(liquidatorio) | Procedura concorsuale come sopra, ma finalizzata alla cessazione attività e vendita beni. Nomina di liquidatore giudiziale (spesso dopo l’omologa). Insolvenza dichiarata superabile solo via liquidazione asset. | Voto dei creditori richiesto come nel concordato in continuità. Necessaria però una soglia minima di soddisfazione: il piano deve garantire almeno il 20% ai creditori chirografari (salvo apporto di risorse esterne che migliora recovery) per legge, altrimenti non è ammissibile. I privilegiati prendono in base ai beni liquidati. Creditori votano sapendo che l’alternativa è il fallimento immediato. | Stay automatico come per il concordato in continuità: divieto azioni esecutive dall’ammissione. Eventualmente già con la domanda con riserva si ottiene protezione temporanea . | I debiti vengono liquidati pagando i creditori con il ricavato delle vendite. Di solito: privilegiati pagati (integralmente o in misura pari a realizzo sui beni); chirografari pagati quel tot % ≥20% (se possibile). La parte di debito non soddisfatta è cancellata all’esito positivo (società estinta libera dai debiti). <br>Se è previsto l’intervento del Fondo di garanzia INPS per TFR e salari, il piano può tenerne conto (dunque quei debiti lavoro, pur pagati dal Fondo, restano chirografari per eventuale surroga INPS). | L’impresa viene sostanzialmente chiusa: tutti o parte dei beni sono venduti (spesso in blocco per massimizzare valore, es. cessione azienda funzionante a un terzo) . Dopo l’esecuzione del piano di liquidazione, la società viene cancellata. La differenza rispetto al fallimento è che qui la liquidazione avviene sotto il controllo e l’iniziativa del debitore (pur con supervisione giudiziale), spesso con più ordine e velocità. Per gli amministratori, aver scelto il concordato liquidatorio è visto positivamente (collaborazione), a differenza di un fallimento “subìto” . Se però il concordato liquidatorio non raggiunge l’omologa (perché magari ritenuto non conveniente), allora si aprirà la liquidazione giudiziale classica. |
| Concordato semplificato <br>(post-Composizione negoziata) | Procedura concorsuale speciale, liquidatoria, attivabile solo dal debitore e solo se è fallita la Composizione negoziata. Tribunale interviene per omologare senza voto creditori. Nomina un liquidatore giudiziale per l’esecuzione. | Nessun voto dei creditori. Il piano è proposto dal debitore e distribuisce il valore ai creditori secondo le regole di prelazione. I creditori possono al massimo presentare osservazioni o opposizione all’omologa se ritengono la proposta pregiudizievole rispetto al fallimento. Il tribunale valuta e decide se omologare comunque (se i creditori non riceverebbero di più in un fallimento). | Misure protettive: quelle già eventualmente attivate durante la precedente Composizione negoziata possono essere prorogate dal tribunale fino all’omologa del semplificato (massimo 4 mesi). | I debiti vengono liquidati come in un concordato liquidatorio: vendita beni e distribuzione ai creditori secondo gradi (privilegi prima, resto ai chirografari). Debiti non soddisfatti stralciati all’esito. Non c’è soglia minima del 20% qui, ma il tribunale verifica la convenienza (creditori devono prendere almeno quanto in fallimento). | L’impresa viene liquidata e cessata. Il vantaggio è che lo fa in modo più rapido rispetto al fallimento e con minori costi. La società poi sarà cancellata. Per il debitore persona fisica, dopo l’omologa potrà chiedere l’esdebitazione (essendo equiparata a liquidazione giudiziale). Questo concordato non mira a continuare l’attività ma solo a chiuderla ordinatamente. |
(Legenda: stay = sospensione azioni esecutive individuali; erga omnes = con effetti obbligatori verso tutti)
Come si evince dalla Tabella 1, ogni strumento ha una sua “filosofia”: quelli negoziali puntano sul consenso volontario ma soffrono i dissensi; quelli giudiziali garantiscono cram-down e maggioranze, ma sono più lenti e costosi. Dal punto di vista del debitore, la scelta dipenderà da quanta collaborazione si aspetta dai creditori e da quanto tempo ha a disposizione. Un’azienda che intravede possibilità di accordo rapido tenterà prima la CNC o un piano attestato; un’azienda già in default conclamato probabilmente dovrà rifugiarsi subito in un concordato con riserva per bloccare i creditori e poi negoziare dentro quella cornice.
Nel capitolo successivo vedremo come un imprenditore debitore deve impostare la propria strategia di difesa: quali passi concreti compiere non appena si rende conto che i debiti stanno soffocando l’azienda, come comunicare con i creditori, e come decidere quale degli strumenti sopra descritti attivare.
Come Difendersi dai Debiti: Strategie Pratiche per il Debitore
Mettiamoci ora nei panni dell’imprenditore debitore (ad esempio, l’amministratore della nostra azienda di filtri a coalescenza indebitata) e tracciamo un percorso pratico su cosa fare concretamente per affrontare la situazione debitoria. La parola d’ordine è tempestività: ogni giorno di ritardo può peggiorare la situazione e ridurre le opzioni disponibili . Ecco una lista di passi e strategie che il debitore dovrebbe seguire:
1. Mappatura immediata della situazione debitoria e finanziaria: Appena ci si accorge che l’azienda fatica a pagare debiti importanti (stipendi, fornitori chiave, rate fiscali/bancarie), si deve compiere un’analisi approfondita delle finanze. Bisogna redigere un elenco dettagliato di tutti i debiti scaduti e in scadenza (importi, creditori, eventuali garanzie e privilegi associati) . Contestualmente, predisporre un cash flow previsionale a 6-12 mesi: qual è la liquidità attesa? Quali incassi sicuramente arriveranno (crediti clienti, ordini in corso) e quali uscite non rimandabili (stipendi, forniture per tenere aperto, tasse correnti)? Da questo si capirà l’ammontare del buco e la tempistica della crisi. Ad esempio: “se non pago l’IVA di giugno entrerò in irregolarità col Fisco e rischio sanzioni, ma se la pago non avrò soldi per i fornitori di luglio”. Queste valutazioni quantitative servono a decidere le priorità.
In questa fase, serve anche capire se l’impresa è già tecnicamente insolvente (incapace di far fronte regolarmente alle obbligazioni) o se è “solo” in crisi (difficoltà prospettica). Indicatori utili sono: DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi sotto 1 significa probabile insolvenza in arrivo ; capitale netto negativo indica che il patrimonio è eroso; ritardi prolungati (oltre 90 giorni) su debiti verso dipendenti o Erario segnalano che siamo oltre la soglia di guardia. Se l’analisi rivela che tra 3 mesi non si potranno pagare debiti rilevanti, siamo in stato di crisi; se già oggi l’azienda non paga stipendi o fornitori da tempo, siamo in insolvenza conclamata . Queste valutazioni sono importanti perché determinano quali strumenti attivare (ad es. la CNC richiede che non si sia ancora irrimediabilmente insolventi; il concordato richiede di dichiarare l’insolvenza, quantomeno prospettica).
2. Coinvolgimento di soci, organi di controllo e advisor: Un amministratore accorto deve poi informare prontamente tutti i soggetti interni rilevanti . Se esiste un Consiglio di Amministrazione, tutti i consiglieri vanno messi al corrente e riuniti per deliberare eventuali azioni. I soci non amministratori devono essere informati della crisi: potrebbero essere disponibili a mettere risorse (ad esempio un finanziamento soci urgente per pagare stipendi o un aumento di capitale per ridurre i debiti). Il collegio sindacale, se presente, va informato subito – spesso è già a conoscenza via bilanci. Ignorare i soci o i sindaci aggraverebbe la propria posizione di responsabilità. In parallelo, quasi sempre conviene ingaggiare degli esperti esterni: un consulente finanziario specializzato in ristrutturazioni e un legale esperto di crisi d’impresa. Questi advisor aiuteranno a elaborare un piano di risanamento credibile e ad evitare errori procedurali. Ad esempio, il Chief Restructuring Officer (CRO) può supportare l’azienda nel dialogo con le banche. Anche l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), se l’azienda è piccola e orientata a sovraindebitamento, può essere contattato per valutare le opzioni.
3. Stabilire le priorità di pagamento (e i sacrifici immediati): In attesa di attivare le procedure formali, bisogna decidere chi pagare e chi mettere in mora perché con tutta probabilità non c’è liquidità per onorare tutto. Una regola generale, già detta, è privilegiare i debiti strategici e con maggiore impatto: ad esempio, pagare i fornitori essenziali per non bloccare la produzione (previo accordo di moratoria su altri pagamenti meno vitali), pagare almeno in parte i dipendenti per non perdere la forza lavoro, pagare le utenze per non farsi staccare luce e gas, pagare le forniture future prepagate di cui si ha bisogno. Al contrario, congelare i pagamenti su debiti meno immediati: ad es. se c’è una rata di mutuo che può slittare (tanto la banca dovrà venire a patti poi) o se c’è da scegliere tra pagare l’IVA corrente e pagare il fornitore, forse conviene – temporaneamente – pagare il fornitore per continuare a operare e poi includere l’IVA in una transazione fiscale (valutare rischio penale, chiaramente: se l’IVA supera la soglia, bisogna calcolare pro e contro con l’avvocato). L’importante è non fare favoritismi ingiustificati: ogni pagamento deve essere ponderato per la funzionalità alla continuità aziendale o per evitare guai peggiori. Documentare queste scelte è utile (per difendersi in futuro da accuse di preferenze). In pratica, si congelano i pagamenti dove possibile e si tengono le risorse per la gestione corrente e per trattare.
Parallelamente, bloccare uscite non essenziali: stop a investimenti espansivi, rinviare spese in conto capitale, ridurre all’osso costi variabili (marketing, consulenze non indispensabili). Se l’azienda ha filiali o reparti in perdita, valutare di chiuderli subito per limitare l’emorragia di cassa.
4. Approccio ai creditori chiave – comunicazione e moratorie informali: È fondamentale comunicare in modo proattivo con i principali creditori, soprattutto banche e fornitori strategici, prima che la situazione precipiti e questi perdano fiducia. Molto spesso, accordi temporanei possono essere presi anche in via informale: ad esempio, chiedere alle banche un periodo di standstill (astensione dal revocare fidi o dall’escutere garanzie) magari in attesa di presentare un piano di ristrutturazione . Le banche sono abituate a tavoli di moratoria (specie se ci sono più istituti coinvolti, può essere utile farli coordinare da una capofila). Similmente, coi fornitori più importanti si può concordare di allungare i termini di pagamento (es. da 60 a 120 giorni) assicurando però la continuità degli ordini futuri e magari un piano di rientro per gli arretrati. Questa fase è delicata: bisogna bilanciare la trasparenza con la cautela. Non si deve dichiarare “siamo alla frutta” in modo scomposto, altrimenti tutti corrono ai ripari (banche revocano, fornitori bloccano forniture). Occorre comunicare che l’azienda sta attraversando difficoltà, ma che sta approntando un piano di ristrutturazione e che chiede collaborazione per evitare soluzioni peggiori per tutti. Spesso aiuta mettere per iscritto un accordo di moratoria in cui i creditori concordano di non intraprendere azioni esecutive per X mesi: questo è di fatto l’anticamera di una CNC o accordo formale.
Se qualche creditore è già partito con ingiunzioni o pignoramenti, il legale potrebbe cercare di prendere tempo (chiedere rinvii, fare opposizioni tattiche) nell’attesa di attivare la protezione formale. Tuttavia, attenzione a non perdere il controllo: se ad es. un immobile vitale viene pignorato e va all’asta, forse conviene a quel punto presentare subito un ricorso di concordato in bianco per congelare la situazione . Dunque monitorare costantemente il timing delle azioni legali dei creditori.
5. Valutazione e scelta dello strumento legale da attivare: Contestualmente ai passi sopra, occorre – possibilmente con l’aiuto di consulenti – decidere quale procedura di composizione della crisi perseguire. Questo dipende dallo stato di cui sopra (crisi vs insolvenza), dalla fattibilità del risanamento e dal feedback ricevuto dai creditori nelle prime interlocuzioni. Le opzioni, semplificando, sono:
- Se l’azienda è ancora fondamentalmente sana ma oppressa da debiti ristrutturabili, e i creditori paiono ragionevoli: tentare una Composizione negoziata. Quindi preparare l’istanza su piattaforma e nominare l’esperto. Si otterrà rapidamente un professionista terzo che aiuta a trovare un accordo. Durante la CNC, chiedere subito misure protettive per bloccare eventuali creditori aggressivi (ad es. Agenzia Entrate Riscossione) . La CNC conviene se non è già scoppiato il pandemonio (cioè nessun creditore ha ancora fatto istanza di fallimento o pignoramenti irreversibili) e c’è tempo di qualche mese.
- Se la situazione è già precipitata (insolvenza manifesta, molti creditori in fibrillazione) e/o serve imporre sacrifici e tagli che difficilmente otterrebbero adesione unanime: optare per un Concordato preventivo. In molti casi si ricorre alla domanda di concordato con riserva (“in bianco”) per ottenere immediatamente lo stay e guadagnare tempo (fino a 4 mesi) per elaborare il piano . Questo è spesso il caso di aziende con insolvenza conclamata: depositare il ricorso con riserva, far nominare il commissario, e poi negoziare dentro il concordato con i creditori, piuttosto che fuori. Ad esempio, se l’Erario ha già notificato cartelle e minaccia pignoramenti, un ricorso in bianco blocca tutto e dà respiro, mentre la CNC richiederebbe qualche settimana almeno per le misure protettive e nel frattempo potrebbero aggredire i conti.
- Se l’insolvenza è conclamata ma si è ragionevolmente certi di ottenere l’accordo di almeno il 60% dei creditori (magari perché sono pochi grandi creditori e sono già orientati positivamente), si potrebbe scegliere l’Accordo di ristrutturazione invece del concordato: minor pubblicità, niente voto, più rapido. Ma attenzione: durante la raccolta firme non si ha protezione fino al deposito in tribunale – a meno di combinare ADR e CNC (prassi possibile: apri CNC, raccogli consensi, poi converti in ADR). Da valutare caso per caso.
- Se appare chiaro che l’impresa non è salvabile (nessuna prospettiva di rilancio, solo realizzo asset) e le trattative sono fallite, allora l’opzione è presentare direttamente istanza di liquidazione giudiziale oppure, se eravamo in CNC, un concordato semplificato. Quest’ultimo, come detto, può essere preferibile al fallimento tradizionale per chiudere con meno traumi. L’importante è non arrivarci costretti dai creditori: meglio che sia il debitore a proporre una soluzione liquidatoria (dimostra cooperazione, può influire su eventuali giudizi futuri) .
Spesso la scelta può essere graduale: ad esempio, si può iniziare con la Composizione negoziata, e tenere pronto il “piano B” del concordato se la CNC non porta a un accordo. In generale, le linee guida normative incoraggiano a tentare prima le soluzioni meno invasive (piani, accordi) e solo poi quelle concorsuali. Ma bisogna essere realistici: se un’azienda ha 200 creditori e zero cassa, la CNC rischia di essere una perdita di tempo prezioso.
6. Attivazione formale dello strumento scelto e condotta durante la procedura: Una volta deciso, bisogna agire prontamente: se concordato, depositare il ricorso immediatamente (preparando intanto il piano di massima); se CNC, caricare i dati sulla piattaforma e inviare l’istanza. Appena la procedura è avviata, il debitore deve seguire scrupolosamente le regole: nel concordato, non compiere atti senza autorizzazione, fornire al commissario tutte le informazioni, astenersi da pagamenti extra. Nella CNC, collaborare lealmente con l’esperto (è lì per aiutare, ma riferirà al giudice se l’imprenditore attua frodi o scorrettezze) . Questa condotta corretta verrà valutata positivamente da tribunale e creditori. Al contrario, comportamenti ostruzionistici (nascondere beni, favorire occultamente qualcuno, non rispettare obblighi informativi) possono far saltare la procedura e aggravare la posizione dell’imprenditore.
7. Negoziazione con i creditori all’interno dello strumento legale: Se siamo nel concordato, sfruttare il periodo di predisposizione del piano (o la fase ante-voto) per concordare informalmente con i creditori chiave i termini. Ad esempio, discutere con le banche la classe e percentuale da offrire (magari ottenendo che convertano parte del credito in partecipazione, come già ricordato) ; con i fornitori strategici capire quale percentuale accetterebbero per continuare a fornire . Il commissario è un prezioso mediatore in queste fasi. Nel concordato è anche possibile proporre modifiche migliorative della proposta in corso d’opera se servono a ottenere il voto di una classe. L’importante è mantenere i creditori informati e mostrarsi trasparenti nei numeri: presentare business plan attendibili, magari validati da esperti indipendenti, per persuadere i creditori che conviene accettare il piano.
Nella Composizione negoziata, l’imprenditore deve lavorare a stretto contatto con l’esperto per trovare punti d’incontro: può proporre ad esempio ai creditori pubblici un taglio del 40% con dilazione (e l’esperto lo convincerà che è già meglio di fallimento) , ai fornitori il pagamento integrale ma in 12 mesi (come nel Caso 1 vedremo) , ecc. Bisogna essere creativi ma anche realistici: offrire ciò che si può mantenere. Sempre meglio promettere meno e poi eventualmente pagare di più a sorpresa, che il contrario.
8. Esecuzione del piano e monitoraggio post-procedura: Se tutto va a buon fine – accordo raggiunto o concordato omologato – il lavoro del debitore non è finito: ora deve rispettare fedelmente gli impegni. Pagare le rate concordatarie ai creditori nei termini, versare i contributi correnti regolarmente (pena decadenze da benefici), attuare il piano industriale (tagli, investimenti promessi). Spesso il concordato prevede relazioni periodiche al giudice delegato sullo stato dei pagamenti. Qualora il debitore veda difficoltà nel rispettare il piano, è fondamentale non nasconderle: la legge consente, ad esempio, di chiedere modifiche alle condizioni del concordato (entro certi limiti) o ottenere proroghe nel pagamento se giustificate. Ma se il debitore tace e poi defaulta sul concordato, rischia la revoca dell’omologa e il fallimento immediato.
Se invece, malgrado gli sforzi, non si arriva a un accordo o a un concordato, allora prepararsi all’impatto: difendersi nel fallimento, cercare di salvare il salvabile (ad es. proporre al curatore vendite pre-concordate di asset per massimizzare il prezzo), e soprattutto collaborare col curatore. Un amministratore collaborativo può anche evitare accuse di bancarotta se dimostra di aver fatto di tutto e di non aver nulla da nascondere.
9. Tutela del patrimonio personale (per l’imprenditore/socio): Un aspetto collaterale ma importante: se l’imprenditore (persona fisica) ha beni personali o della famiglia a rischio (es. ha dato ipoteca su casa personale alla banca, o fideiussioni), deve considerare azioni di tutela come ricontrattare quelle garanzie nell’ambito del piano (magari la banca libera l’ipoteca se riceve tot pagamento). Oppure, se teme aggressioni, valutare istituti come il fondo patrimoniale o trust (attenzione però: il trasferimento di beni quando si è già insolventi può essere revocato o considerato addirittura bancarotta fraudolenta se fatto per frodare i creditori!). Quindi niente mosse opache dell’ultimo minuto: meglio negoziare la posizione privata direttamente con i creditori (es. accordarsi con la banca per una liberatoria parziale della fideiussione dietro un certo pagamento, piuttosto che far finta di vendere la villa al parente per sottrarla). In generale, i soci di S.r.l. non rischiano la casa per i debiti sociali salvo abbiano dato garanzie personali. Se l’hanno fatto, quell’obbligazione rimane anche dopo il concordato (il concordato non libera i garanti, a meno che la banca vi rinunci espressamente) – salvo il caso del concordato con assunzione da parte di terzi, soluzione complessa in cui un garante potrebbe assumere l’onere del concordato. Ad ogni modo, è bene che l’imprenditore pianifichi insieme al legale anche la propria exit strategy personale.
10. Documentare ogni passo e agire in buona fede: Infine, un consiglio trasversale: tenere traccia scritta di tutte le decisioni e motivazioni (verbali CdA, relazioni sulla crisi, comunicazioni ai creditori). Questo costituirà la “prova” che l’amministratore ha agito diligentemente e nell’interesse dei creditori una volta nota la crisi. La buona fede e la correttezza sono spesso l’ago della bilancia che distingue un imprenditore sfortunato ma onesto (che magari otterrà l’esdebitazione e non subirà condanne) da un imprenditore negligente o malintenzionato. Ad esempio, rispondere alle segnalazioni di allerta di INPS/Agenzia Entrate entro 90 giorni attivando una procedura eviterà che in futuro gli contestino inerzia grave . Al contrario, ignorare gli avvisi peggiora solo le cose e verrà usato contro di lui.
In definitiva, “difendersi dai debiti” per un’azienda significa in gran parte giocare d’anticipo: non aspettare che i creditori attacchino per reagire, ma prendere in mano la situazione, mettere tutti attorno a un tavolo – fisico o virtuale – e cercare una soluzione ordinata. Il quadro normativo italiano, specie dopo le riforme del 2020-2022, offre vari strumenti per farlo. Ma la legge da sola non basta: serve la volontà dell’imprenditore di affrontare la realtà, anche quando è difficile, e la consapevolezza che a volte salvare l’azienda comporta dei sacrifici (per i soci in primis, che magari perdono valore delle quote, e per i creditori che accettano tagli). Come recita un detto in ambito di crisi: “Il primo perdita è la migliore”, ossia prima si accetta di subire una perdita controllata (ad esempio un concordato al 40%), migliore sarà l’outcome, rispetto a trascinare la situazione e arrivare a perdite integrali (fallimento con 0%). Chi è debitore deve far capire ai creditori che anche loro hanno interesse a trovare un accordo: con questa mentalità, più che difendersi in senso conflittuale, si può collaborare per uscire dalla crisi con il minimo danno per tutti.
Nei prossimi paragrafi esemplificheremo queste strategie attraverso alcune simulazioni pratiche, per vedere come, in casi concreti, un’azienda indebitata può agire e quali risultati può ottenere. Successivamente affronteremo in modalità domanda/risposta (FAQ) i dubbi più comuni su questi temi, completando la guida.
Casi Pratici: Simulazioni di Gestione della Crisi
Per rendere più concreti i concetti esposti, presentiamo alcune simulazioni basate su scenari tipici di società in difficoltà. Ogni caso evidenzia una diversa combinazione di debiti e le possibili soluzioni ai sensi del Codice della Crisi, dal punto di vista del debitore (cioè della società indebitata e dei suoi amministratori) . I nomi delle società e i numeri sono di fantasia, ma rispecchiano situazioni verosimili.
Caso 1: Piccola S.r.l. commerciale con debiti fiscali e previdenziali prevalenti
Scenario: Alfa S.r.l. gestisce due negozi al dettaglio (3 dipendenti totali). Negli ultimi anni, complice il calo dei consumi e la pandemia, Alfa ha accumulato debiti con il Fisco (~€150.000 di IVA non versata e ritenute IRPEF) e con l’INPS (~€50.000 di contributi arretrati) . Per cercare di restare a galla, gli amministratori hanno continuato a pagare fornitori di abbigliamento utilizzando liquidità che avrebbero dovuto destinare a imposte e contributi – una scelta discutibile ma dettata dall’urgenza di avere merce per i saldi. Ora però l’Agenzia Entrate-Riscossione ha notificato cartelle esattoriali per l’IVA non pagata e minaccia pignoramenti su conti e merci; l’INPS ha inviato diffida per i contributi omessi. I debiti verso fornitori invece sono contenuti (circa €30.000 recenti, per merce acquistata negli ultimi mesi) . La liquidità in cassa e banca è quasi zero; la banca ha revocato il piccolo fido di c/c a causa di insoluti. Riassumendo: Alfa è al bivio – l’attività potrebbe anche essere potenzialmente redditizia (uno dei due negozi va bene, l’altro è in perdita), ma il macigno dei debiti fiscali/previdenziali e l’azione aggressiva degli enti rischiano di travolgerla .
Problema: Debiti concentrati verso creditori pubblici (Erario e INPS), che hanno poteri speciali e tolleranza bassa . La liquidità è scarsa. Siamo in presenza di uno stato di crisi serio ma forse non irreversibile: se si riuscisse a dilazionare il debito fiscale/previdenziale (magari sfruttando qualche definizione agevolata) l’azienda potrebbe tornare in bonis, dato che il fatturato dei negozi è in ripresa.
Azione intrapresa: Gli amministratori di Alfa, consultato il commercialista, decidono di attivarsi immediatamente prima che il Fisco blocchi i conti o ipotechi i locali. Optano per la Composizione Negoziata della crisi: presentano istanza tramite la piattaforma online della Camera di Commercio. In pochi giorni viene nominato un esperto indipendente . Contestualmente, Alfa richiede al tribunale misure protettive: il giudice concede un decreto che blocca temporaneamente le azioni esecutive da parte di Agenzia Entrate-Riscossione . Ciò sospende i pignoramenti già minacciati sui conti bancari. Protetta dallo stay, Alfa – con l’aiuto dell’esperto – avvia subito il dialogo con l’Agenzia Entrate e l’INPS proponendo una transazione fiscale e contributiva nell’ambito della composizione negoziata: in sostanza offre di pagare il 60% del dovuto, dilazionato in 5 anni a rate mensili, con stralcio totale di sanzioni e interessi (che rappresentano una buona fetta del debito) . Per rendere più credibile l’offerta, gli amministratori mettono immediatamente sul piatto un piccolo acconto di €20.000 (raccolto facendosi prestare soldi dai soci a titolo di finanziamento infruttifero), da versare subito al Fisco appena l’accordo sarà formalizzato, a dimostrazione di buona fede . L’esperto aiuta a stendere un piano finanziario prospettico: suggerisce di chiudere il punto vendita meno redditizio (tagliando costi di affitto e personale) e concentrare le risorse sull’altro negozio che ha vendite migliori; stima così che Alfa, liberata di quell’onere, potrà generare cassa per ~€40.000 all’anno con cui sostenere le rate concordate .
Esito delle trattative: Grazie anche alle novità normative (il D.Lgs. 83/2022 ha consentito la transazione fiscale anche in composizione negoziata, mentre prima era ammessa solo in concordato o ADR) , l’Agenzia delle Entrate accetta la proposta di stralcio e dilazione nell’ambito di questo accordo stragiudiziale . Anche l’INPS aderisce per la parte contributiva. Entrambi gli enti firmano un atto formale di transazione che verrà depositato. Rimangono i fornitori: su €30.000 di debiti commerciali, l’esperto li contatta uno ad uno e propone loro il pagamento integrale di quanto dovuto però dilazionato in 12 mesi, spiegando che l’azienda sta raggiungendo un accordo col Fisco e chiedendo pazienza . I fornitori, fiutando che l’alternativa è vedere Alfa fallire (nel qual caso prenderebbero briciole), accettano. In definitiva, l’esperto certifica che è stato raggiunto un accordo con la totalità dei creditori: il 100% dei creditori di Alfa ha sottoscritto intese di risanamento. Erario e INPS mediante un atto transattivo ufficiale, i fornitori mediante accordi privati di dilazione .
Chiusura: Dopo circa 4 mesi dall’avvio, la composizione negoziata si conclude con successo. L’esperto redige la relazione finale positiva e la procedura viene archiviata . Alfa S.r.l. esce dalla composizione e riprende la normale attività. Ha chiuso uno dei due negozi (quello in perdita), ma l’altro punto vendita continua a funzionare bene e, liberato dall’eccesso di debiti, torna gradualmente in utile. Negli anni successivi Alfa paga regolarmente le rate concordate con Fisco e INPS (che vigileranno ovviamente sui versamenti) e onora i piani con i fornitori . Grazie a ciò, evita sia la dichiarazione di fallimento sia qualsiasi procedura concorsuale giudiziale. Gli amministratori hanno anche evitato conseguenze penali: l’omesso versamento IVA da €150k sarebbe un reato, ma se la società rispetta la transazione e versa quel 60%, il reato viene estinto per effetto della speciale causa di non punibilità (il pagamento integrale del debito IVA, anche se ridotto per transazione, evita la punibilità) . La società è salva e i posti di lavoro (almeno di un negozio) preservati.
Considerazioni: Questo caso mostra come una crisi prevalentemente fiscale/previdenziale possa essere risolta senza ricorrere al fallimento né al concordato, sfruttando la flessibilità della composizione negoziata e le possibilità introdotte dalla transazione fiscale . La chiave è stata agire prima che le azioni esecutive distruggessero l’operatività, offrire ai creditori pubblici un piano ragionevole e dimostrare la sostenibilità futura (anche tramite sacrifici come la chiusura di un punto vendita). In assenza di uno strumento come la CNC, Alfa probabilmente sarebbe stata travolta da pignoramenti e avrebbe chiuso i battenti in fallimento, con scarsi recuperi per il Fisco (che invece ora incassa 60% in 5 anni anziché forse nulla) e con la perdita di tutti i posti di lavoro. Questo evidenzia il win-win possibile quando i debitori usano gli strumenti di composizione per collaborare con i creditori: l’Erario preferisce incassare 60% certo a rate che spendere soldi in fallimento per incassare magari il 10% dopo anni.
Caso 2: Media S.r.l. manifatturiera indebitata con banche e fornitori (continuità possibile)
Scenario: Beta S.r.l. è un’azienda manifatturiera di medie dimensioni (60 dipendenti) nel settore metalmeccanico. Ha accumulato debiti finanziari ingenti verso le banche (circa €4 milioni in totale: mutui ipotecari per €2M su il capannone, scoperti di c/c e anticipi fatture per €1M, leasing su macchinari per €1M) e debiti verso fornitori per circa €1,5 milioni già scaduti da mesi . Inoltre ha debiti fiscali per €200k (IVA e IRES non ancora iscritti a ruolo) e verso dipendenti €100k (straordinari e TFR arretrati). Dal lato attivo: possiede un capannone industriale (valore stimato €1,5M ma gravato da ipoteca residua €2M), macchinari in leasing (residuo €1M), magazzino e crediti verso clienti per circa €800k . L’azienda è di fatto insolvente: da 4 mesi non paga i fornitori, le banche hanno segnalato sconfinamenti e minacciano revoca dei fidi . Tuttavia Beta ha in mano ordini importanti per l’anno prossimo grazie a un nuovo contratto con un cliente estero; se riuscisse a finanziarsi per acquistare materie prime e lavorare, potrebbe generare utili e risanarsi nel medio termine .
Problema: Situazione complessa con molti creditori e insolvenza già manifesta. C’è una potenziale via di salvezza (il portafoglio ordini futuro), ma serve tempo e una ristrutturazione del debito significativa. I creditori attuali hanno interessi divergenti: le banche vogliono rientrare (alcune hanno garanzie, altre no), i fornitori sono allo stremo, il Fisco incalza per l’IVA. Beta da sola non può farcela: ha bisogno di ridurre drasticamente l’ammontare dei debiti e dilazionarli, oltre che di nuova finanza per continuare la produzione .
Azione intrapresa: Dopo valutazione con i consulenti, Beta conclude che un semplice piano attestato non basterebbe: convincere singolarmente ~50 fornitori sarebbe arduo, e le banche difficilmente acconsentirebbero senza un quadro vincolante . D’altra parte, Beta vuole evitare la liquidazione fallimentare, perché ciò annullerebbe gli ordini in corso e distruggerebbe la continuità (il maggiore valore dell’azienda). Opzione scelta: il concordato preventivo in continuità aziendale. Beta deposita presso il tribunale un ricorso di concordato “con riserva” (c.d. concordato in bianco), ottenendo immediatamente il blocco dei pignoramenti e delle azioni individuali (lo stay automatico) . Ciò le dà respiro: nessun creditore può aggredire i beni o i conti nel frattempo. Nei successivi 3 mesi, con l’aiuto di un advisor finanziario, Beta prepara un dettagliato piano di concordato:
- Prevede una riorganizzazione interna e riduzione dei costi (taglio di spese non strategiche, efficientamento produttivo).
- Vendita di alcuni macchinari inutilizzati (valore stimato €200k) per fare cassa subito .
- Ricerca di un investitore disposto a immettere €500k di nuova finanza, a titolo di prestito prededucibile o equity, per sostenere il capitale circolante . (I contatti con un fondo locale sono promettenti, in quanto intravedono che con i nuovi ordini l’azienda può risollevarsi).
- Strutturazione di una proposta ai creditori suddivisi in classi:
- Classe 1: Dipendenti (TFR e stipendi arretrati) – proposta pagamento 100% entro 6 mesi dall’omologa (priorità morale e legale).
- Classe 2: Erario (IVA/IRES) – sono crediti in parte privilegiati, proposta di pagamento 50% in 4 anni, sfruttando la transazione fiscale per azzerare sanzioni .
- Classe 3: Fornitori strategici (quelli senza cui l’azienda non potrebbe proseguire) – proposta 30% in 5 anni (li consideriamo vitali e li “premiamo” con un dividendo maggiore per assicurarci la loro continuità) .
- Classe 4: Banche chirografarie (la parte non garantita delle banche, ossia per la quota di credito non coperta da ipoteche o pegni) – proposta 20% in 4 anni.
- Classe 5: Fornitori generici (altri fornitori non strategici) – proposta 20% in 5 anni (allineati alle banche chirografe).
- (Nota: i crediti bancari garantiti da ipoteca o leasing su beni specifici saranno soddisfatti fuori dal concordato: Beta prevede di risolvere i leasing restituendo/vendendo i beni, e di trattare con la banca ipotecaria vendendo il capannone e riconoscendole il ricavato di ~€1,5M a saldo parziale – queste operazioni possono essere tecnicamente incorporate nel piano come stralcio extra-concordatario per quelle posizioni garantite) .
Parallelamente, Beta prepara un dettagliato piano industriale per convincere i creditori che l’azienda, liberata dal peso dei debiti, tornerà redditizia grazie ai nuovi ordini e potrà sostenere i pagamenti proposti . Il piano mostra proiezioni di ricavi in crescita e margini tali da coprire quelle percentuali e rimborsare il prestito prededucibile dell’investitore .
Trattative durante la procedura: Prima ancora del voto formale, Beta (supportata dal commissario nominato dal tribunale) incontra banche e fornitori principali per illustrare il piano . Le banche ipotecarie, vedendo che la proposta per la parte non garantita è solo 20%, inizialmente storcono il naso; Beta però fa loro notare che se l’azienda fallisce, con le procedure esecutive sul capannone rischiano di recuperarne forse il 50% (svendita in asta), e i chirografari zero – quindi prendere 20% come chirografari non è scandaloso in comparazione . Inoltre offre alle banche la possibilità di convertire parte del credito in partecipazione (quote) insieme al nuovo investitore, così da avere un eventuale upside se l’azienda risale – alcune banche apprezzano e accettano la conversione di quota di credito in equity, altre preferiscono incassare la percentuale cash . I fornitori strategici (ad es. fornitori di componenti speciali che Beta non può facilmente rimpiazzare) sono relativamente soddisfatti di vedersi offrire 30% invece di 20%, e soprattutto di mantenere Beta come cliente in futuro, quindi si dichiarano a favore . I fornitori piccoli, pur delusi dal 20% in 5 anni, capiscono anche loro che in caso di fallimento prenderebbero quasi zero, e che la continuità di Beta potrebbe portare loro futuri ordini; pragmaticamente, molti si orientano per votare sì. L’Erario (Agenzia Entrate), grazie alla transazione fiscale, è d’accordo sul 50% proposto (in parte perché metà del suo credito era chirografario, quindi in linea col 20% offerto agli altri chirografari – ma qui sale a 50% includendo la parte privilegiata) . Inoltre ha il beneficio legale del cram-down: anche se formalmente il Fisco votasse no, il tribunale potrebbe omologare perché Beta dimostra che con la liquidazione giudiziale il Fisco avrebbe preso forse 20-30%. Confortata da ciò, l’Agenzia Entrate tende ad approvare.
Arriva il momento del voto: in adunanza, il 75% dei crediti votanti è favorevole, con tutte le classi che approvano (tranne una classe di piccoli fornitori dove ha votato a favore “solo” il 60%, ma viene comunque considerata approvata perché la maggioranza di tutte le classi c’è e l’unica dissenziente è comunque soddisfatta in misura non inferiore a classi inferiori e oltre il 20%); eventuali contestazioni di creditori contrari vengono rigettate. Il tribunale verifica la convenienza per i dissenzienti (che risulta evidente: in fallimento i chirografari avrebbero preso stime 5-10%, qui ne avranno 20-30%) e quindi omologa il concordato.
Esito e implementazione: Beta ottiene così l’omologa del concordato in continuità. Subito dopo, viene erogato il finanziamento prededucibile dall’investitore di €500k, che Beta usa come circolante per riprendere produzione su larga scala per il nuovo cliente. I macchinari vendibili vengono venduti e incassati €200k (usati per iniziare a pagare i creditori privilegiati secondo piano). Il capannone viene messo in vendita tramite procedura competitiva supervisionata dal commissario: dopo 4 mesi si individua un acquirente che offre €1,5M, la banca ipotecaria acconsente a cancellare l’ipoteca ricevendo quel ricavato a parziale soddisfo (resto del suo credito è stato trattato nel concordato come chirografo, quindi al 20%). I leasing vengono risolti e i beni restituiti o riscattati e venduti: anche qui le società di leasing subiscono una perdita ma già contabilizzata nel piano. Nel frattempo Beta riprende a fatturare bene grazie al contratto estero e ai costi ottimizzati: genera utili, con cui inizia a pagare regolarmente le prime rate ai fornitori e alle banche secondo il piano concordatario. I lavoratori ricevono i loro arretrati appena dopo l’omologa come promesso (100%). Dopo un anno, Beta S.r.l. è ancora operativa, con ~50 dipendenti (qualcuno è uscito con incentivo) e bilanci in utile. Il rapporto debito/equity è tornato sotto controllo. Dopo 4 anni Beta completa tutti i pagamenti previsti dal concordato: i fornitori e le banche hanno incassato quel 20-30% (in gran parte grazie ai flussi di cassa generati e un po’ grazie all’apporto dell’investitore). A quel punto il tribunale dichiara eseguito il concordato e chiude la procedura. Beta è ufficialmente risanata e competitiva sul mercato. I soci originari mantengono una parte delle quote (alcune quote sono andate a banche convertite e all’investitore, ma la governance è condivisa). Gli amministratori hanno evitato il fallimento e anche azioni di responsabilità, avendo agito correttamente. Sul fronte penale, eventuali reati di bancarotta preferenziale per i pagamenti fatti pre-concordato non sono stati contestati perché ritenuti funzionali al tentativo di risanamento, e in ogni caso il concordato li ha “sanati” (i pagamenti ai fornitori essenziali sono considerati esenti da revocatoria e da censura, essendo stati poi inglobati nel piano) .
Considerazioni: Questo caso dimostra la potenza del concordato in continuità come strumento di salvataggio di un’impresa medio-grande con debiti ingenti. Nonostante l’insolvenza, l’azienda è stata in grado di riorganizzarsi e offrire ai creditori un piano migliore di quello che avrebbero ottenuto smembrando l’azienda. I creditori hanno accettato dei sacrifici (banche e fornitori han preso 20-30 centesimi per euro) perché convinti che l’alternativa fosse peggiore. L’azienda ha così potuto attuare una sorta di “haircut” del debito e attirare nuova finanza, preservando al contempo la capacità produttiva e i posti di lavoro. Il ruolo del tribunale e del commissario è stato fondamentale per dare fiducia ai creditori (terzietà) e per imporre la soluzione anche ai recalcitranti. Senza il concordato, Beta sarebbe quasi certamente finita in fallimento, con perdita totale per i chirografari e disoccupazione per 60 persone. Così invece c’è stata una continuità e i creditori hanno massimizzato il recupero possibile secondo il principio di migliore soddisfazione. Questo scenario evidenzia l’importanza di un buon piano industriale di rilancio: è stato il nuovo portafoglio ordini (e la credibilità di tornare in utile) a convincere i creditori a dare fiducia. Inoltre mostra come la classazione differenziata può aiutare: dare un po’ di più ai creditori critici (fornitori indispensabili) e un po’ meno agli altri, mantenendo equità di trattamento all’interno delle classi. Ciò è perfettamente lecito e consente di cucire il piano sulle esigenze di risanamento.
Caso 3: S.r.l. immobiliare senza prospettive (liquidazione inevitabile)
Scenario: Gamma S.r.l. è una società edile che, a seguito di una grave crisi del mercato, ha cessato i lavori e non ha più cantieri attivi. Ha un grosso debito con la banca e vari debiti verso fornitori, ma nessuna attività in corso e prospettive di ripresa nulle. I suoi attivi consistono in alcuni terreni e un immobile invenduto. I soci hanno già perso le speranze di continuare l’attività.
Gamma ha provato la composizione negoziata (nominando un esperto) ma è emerso che non c’è alcuna soluzione di continuità fattibile: nessun investitore è interessato e il patrimonio residuo copre a malapena il 30% dei debiti. I creditori principali (una banca e alcuni fornitori) l’hanno capito e puntano a far liquidare il patrimonio al più presto.
Problema: Siamo di fronte a un’azienda “decotta”, insolvente senza possibilità di risanamento. L’unico tema è come liquidare nel modo più efficiente il residuo patrimonio. Se la si lascia andare in fallimento, il rischio è di lungaggini e di valore disperso; se i soci propongono un concordato liquidatorio, bisogna vedere se possono offrire qualcosa in più rispetto al fallimento (ad es. un acquirente unico per i beni o un contributo esterno).
Azione intrapresa: Gamma, avendo tentato inutilmente la CNC, decide di utilizzare il nuovo strumento del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’esperto della CNC certifica l’esito negativo delle trattative. Entro 60 giorni Gamma deposita un ricorso in tribunale proponendo un piano semplificato: in pratica, propone di vendere in blocco l’immobile e i terreni a una società immobiliare terza che si è fatta avanti, per un importo di €X (pari a circa il 35% del totale debiti), e distribuire immediatamente quel ricavato ai creditori secondo i loro privilegi (in particolare, la banca ipotecaria prenderà gran parte per via dell’ipoteca sull’immobile, i fornitori chirografari residui prenderanno forse il 5-10%). Non potendo offrire il 20% ai chirografari, Gamma sottolinea che la proposta è comunque migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale, perché l’acquirente in blocco pagherà €X solo se può ottenere tutto in tempi rapidi senza aste; stima che in fallimento, vendendo spezzettato e dopo anni, si incasserebbe forse il 25% dei debiti (e i costi procedurali mangerebbero un altro 5%). I soci di Gamma si impegnano inoltre a versare un contributo extra di €50k (denaro loro) da destinare al soddisfacimento dei creditori chirografari, come segnale di buona volontà. Chiedono contestualmente che sia nominato lo stesso liquidatore che l’acquirente preferisce, per velocizzare la cessione.
Esito: Nel concordato semplificato non c’è voto dei creditori, ma la banca ipotecaria e i maggiori fornitori depositano osservazioni chiedendo garanzie che la vendita avvenga a prezzo equo. Il tribunale convoca le parti e analizza l’offerta: fa fare una perizia veloce sul valore dei beni, da cui risulta che €X è un prezzo di mercato onesto (forse leggermente basso, ma giustificato dalla celerità e dalla certezza dell’affare). Considerando che i creditori non hanno prospettive migliori (nessun altro compratore in vista, i soci aggiungono pure soldi), il tribunale decide di omologare il concordato semplificato ritenendo la proposta non manifestamente pregiudizievole per i creditori . Nomina un liquidatore giudiziale (indipendente rispetto al compratore, ma che collaborerà con quest’ultimo). In pochi mesi, il liquidatore formalizza la vendita all’acquirente e incassa il prezzo. Distribuisce poi le somme: la banca soddisfa il suo credito ipotecario (non interamente, ma esaurendo il ricavato dell’immobile), i fornitori privilegiati (pochissimi, tipo operai per stipendi) prendono il loro, i chirografari ricevono il riparto del contributo soci (qualche punto percentuale). In sei mesi la liquidazione è completata, il liquidatore deposita il rendiconto e Gamma S.r.l. viene cancellata dal registro imprese. I soci non hanno ricevuto nulla (ovviamente), anzi hanno perso i €50k aggiuntivi, ma evitano il marchio di un fallimento e possibili azioni per bancarotta (non c’è stato alcun comportamento fraudolento). I creditori, pur non interamente pagati, riconoscono che almeno si è chiuso tutto rapidamente e senza i costi di un lungo fallimento.
Considerazioni: Questo caso evidenzia la situazione in cui, se non c’è nulla da fare per salvare l’impresa, tanto vale “pilotare” la liquidazione attraverso una procedura concorsuale più snella che non subire passivamente il fallimento . Il concordato semplificato introdotto dal D.L. 118/2021 ha proprio questa logica: dare una via di uscita veloce alle crisi irreversibili, premiando comunque il debitore che ha tentato la CNC. I creditori in questo scenario hanno poco da guadagnare in più rispetto al fallimento – ma risparmiano tempo e costi, e soprattutto se c’è un compratore in blocco ottengono il vantaggio di evitare aste dall’esito incerto. Dal punto di vista degli amministratori, proporre il concordato (sia esso semplificato o ordinario liquidatorio) è visto di buon occhio: mostra collaborazione e porta a una soluzione più ordinata, e come detto mitiga le responsabilità (hanno almeno tentato qualcosa anziché far precipitare tutto) . I soci in questo caso hanno anche fatto un sacrificio economico per i creditori: non è obbligatorio, ma spesso è ciò che convince il tribunale ad omologare un concordato liquidatorio che altrimenti darebbe meno del 20% (il famoso apporto di risorse esterne). Questo può essere utile in altre situazioni analoghe: se i soci vogliono evitare conseguenze peggiori (es. azioni risarcitorie), mettere mano al portafoglio per “ungere” un po’ il meccanismo concordatario è una mossa intelligente.
Naturalmente, se non vi fosse stato l’istituto del concordato semplificato, Gamma avrebbe dovuto fallire, con tempi lunghi e incognite (magari i soci non avrebbero messo quei €50k se fosse finita in fallimento). Quindi anche qui, la riforma ha dato uno strumento in più a vantaggio di tutti.
(Potremmo aggiungere un Caso 4 con un esempio virtuoso di allerta precoce gestita bene, ma per brevità ci fermiamo qui.)
Nei tre casi visti, abbiamo coperto le tipologie principali: crisi gestita con accordo stragiudiziale (CNC), crisi gestita con procedura concordataria di risanamento, e crisi irrimediabile gestita con liquidazione concorsuale. Nella realtà, ovviamente, ogni situazione ha le sue particolarità, ma questi modelli aiutano a capire come applicare i concetti teorici esposti.
Passiamo ora alla sezione finale di Domande Frequenti (FAQ), in cui risponderemo in forma concisa ai dubbi più comuni che emergono quando si affronta una situazione di azienda indebitata in Italia.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Quando una S.r.l. può considerarsi in “stato di crisi” ai sensi del Codice?
R: Il Codice definisce lo stato di crisi come la probabilità di futura insolvenza, desumibile da uno squilibrio economico-finanziario . In pratica, un’impresa è in crisi se – pur essendo magari ancora adempiente oggi – le proiezioni indicano che non riuscirà a far fronte regolarmente ai debiti nei prossimi 12 mesi . Indici utili: flussi di cassa prospettici insufficienti (es. DSCR a 6 mesi < 1), capitale netto che tende al negativo, ritardi crescenti nei pagamenti, utilizzo completo e prolungato dei fidi bancari, debiti scaduti verso dipendenti/fornitori oltre certe soglie (es. salari non pagati per più di metà dell’importo dovuto, per oltre 30 giorni) . La crisi è dunque uno stadio precedente all’insolvenza conclamata (in cui invece l’impresa è già incapace di adempiere ai debiti esigibili in modo regolare). Il CCII incoraggia gli imprenditori a cogliere questi segnali di pre-crisi e intervenire subito, anziché attendere l’insolvenza conclamata .
D: Che differenza c’è tra crisi e insolvenza?
R: Crisi indica una difficoltà oggettiva che, se non risolta, può evolvere in insolvenza; insolvenza è invece l’incapacità attuale di pagare regolarmente i debiti ed ottenere ulteriore credito . Ad esempio: un’azienda con flussi di cassa molto tesi, ma che non ha ancora “saltato” pagamenti importanti, è in crisi; se invece ha già vari debiti scaduti da tempo e non paga stipendi o fornitori, è già insolvente . La distinzione è importante: la crisi consente accesso a misure di allerta e a strumenti di risanamento prima di dover ricorrere a procedure concorsuali, mentre l’insolvenza di regola richiede l’avvio di un concordato preventivo o della liquidazione giudiziale senza ulteriore indugio .
D: Quali sono i primi passi che gli amministratori devono compiere quando si accorgono che la società ha problemi di liquidità o solvibilità?
R: Attivarsi tempestivamente. In concreto: 1. Fare subito un’analisi approfondita della situazione finanziaria (cassa disponibile, elenco debiti scaduti, impegni futuri) e delle cause della crisi . Serve una fotografia chiara di quanti soldi mancano e di perché. 2. Informare il CdA e gli eventuali soci della gravità del quadro . Condividere i dati con tutti i decisori interni è fondamentale (anche per eventuali interventi di sostegno dai soci). 3. Evitare di aggravare il dissesto: niente spese non essenziali, bloccare investimenti non urgenti, non prendere nuovi debiti se non strettamente necessari . Stop a operazioni rischiose; preservare la cassa. 4. Valutare immediatamente le opzioni previste dal CCII: ad esempio contattare informalmente i creditori chiave per sondare una possibile moratoria volontaria, oppure presentare istanza di Composizione Negoziata se la situazione lo consiglia (così da ottenere un esperto e bloccare le esecuzioni) . In alcuni casi può essere opportuno depositare un ricorso per concordato “in bianco” per congelare le azioni dei creditori e guadagnare tempo. 5. Attivare eventuali procedure interne di allerta: se c’è un collegio sindacale, confrontarsi con esso; se c’è un organismo di allerta interno (nelle intenzioni originarie della riforma, poi non attuato, sostituito dall’esperto CNC), tenerlo informato . 6. Rivolgersi a consulenti specializzati (un advisor finanziario, un legale esperto di crisi d’impresa) per predisporre un piano di risanamento o comunque una strategia di gestione della crisi . Spesso l’imprenditore da solo fatica a vedere tutte le soluzioni: un esperto esterno può individuare interventi utili (ricapitalizzazione, vendite asset, ecc.) e guidare nelle procedure.
L’errore capitale è aspettare sperando in miracoli: ogni giorno di ritardo può peggiorare la situazione e, in caso di fallimento poi, i curatori guarderanno con sospetto l’inerzia degli amministratori (che può costituire colpa grave in vigilando) . Quindi l’approccio deve essere attivo e rapido.
D: Gli amministratori o i soci di una S.r.l. rispondono personalmente dei debiti sociali?
R: In linea generale no: il bello della S.r.l. è la responsabilità limitata. I soci sono al riparo, e anche gli amministratori non rispondono dei debiti sociali di regola . Tuttavia, ci sono importanti eccezioni: – I soci rispondono personalmente se hanno prestato garanzie personali (es. fideiussioni alla banca) o in casi di abuso della personalità giuridica (il cosiddetto piercing the veil, applicato raramente e solo in presenza di confusione patrimoniale fraudolenta) . – Inoltre, dopo la chiusura di una liquidazione (fallimentare o concordataria), i soci possono essere chiamati a restituire quanto incassato nel bilancio finale di liquidazione se i creditori sono rimasti insoddisfatti. La giurisprudenza recente (Cass. Sez. Un. 6070/2013) ha esteso questo principio persino al caso in cui la liquidazione non abbia distribuito nulla ai soci: in certe situazioni di mala gestio, i soci potrebbero dover rispondere dei debiti residui anche se formalmente non hanno ricevuto riparti . È una teoria complessa, ma segnala che i soci non sono sempre intoccabili se si dimostra che hanno svuotato la società a danno dei creditori. – Gli amministratori, invece, possono incorrere in responsabilità verso i creditori se, violando i loro doveri di gestione diligente, hanno provocato un danno al patrimonio sociale poi insufficiente a pagare i creditori . Questo si concretizza tipicamente con l’azione di responsabilità per aggravamento del dissesto promossa dal curatore fallimentare o dai creditori: se l’amministratore ha ritardato colpevolmente l’accesso alla procedura o ha gestito male nella crisi (pagamenti preferenziali, nessun assetto adeguato, ecc.), può essere condannato a risarcire il deficit . – Inoltre, gli amministratori rispondono sempre verso la società per mala gestio ex art. 2476 c.c., e i soci possono fare causa se la gestione ha causato perdite ingenti. – Sul piano penale, amministratori e anche soci (se amministratori di fatto) possono essere puniti per reati concorsuali: la bancarotta fraudolenta (distrazione di beni, documenti falsi), bancarotta preferenziale (pagamenti preferenziali in danno della par condicio), ecc., se la società fallisce e emergono quelle condotte . I soci non coinvolti nella gestione di solito non rispondono penalmente, salvo casi di concorso (es. se hanno beneficiato di distrazioni consapevolmente).
Quindi, in sintesi: i soci di norma rischiano poco di tasca propria (salvo impegni specifici o condotte fraudolente), gli amministratori rischiano in proprio se gestiscono male la crisi. Da ciò l’importanza, per amministratori e soci, di comportarsi diligentemente durante la crisi: questo li protegge in gran parte sia civilmente che penalmente.
D: Cosa succede se la società non paga i debiti fiscali e previdenziali?
R: I debiti verso Erario e INPS sono molto “sensibili”. Se una S.r.l. non paga l’IVA o le ritenute fiscali, oltre agli interessi maturano sanzioni amministrative elevate; superate certe soglie scatta la segnalazione di crisi dal Fisco (come creditore pubblico qualificato) e potenzialmente anche una denuncia penale . Ad esempio, l’omesso versamento IVA oltre €250k annui o di ritenute oltre €150k annui è reato . Sul fronte previdenziale, l’omissione di versamento contributi oltre circa €10k è reato (punito con multa e nei casi gravi anche arresto) . Inoltre, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) può attivare procedure esecutive rapide: fermi amministrativi di veicoli, pignoramenti dei conti correnti, blocchi dei crediti verso terzi, ipoteche sugli immobili della società . Un altro effetto paralizzante: se hai debiti fiscali/previdenziali, non ottieni il DURC (documento di regolarità contributiva), e senza DURC niente appalti pubblici e problemi con i cantieri . La reputazione crolla. Inoltre, i grandi enti come AE e INPS possono presentare istanza di fallimento se la situazione degenera .
In poche parole, i debiti fiscali/previdenziali non pagati possono paralizzare l’azienda: conti bloccati, impossibilità di lavorare con la PA, rischio penale, ecc. .
Cosa offre il CCII? Soluzioni concordate: attraverso un accordo di ristrutturazione o un concordato con transazione fiscale, è possibile pagare solo parzialmente e dilazionato questi debiti, ottenendo la regolarizzazione . Ad esempio, si può proporre di pagare l’IVA al 30% senza sanzioni in un concordato: se il tribunale omologa, l’Erario deve accettarlo (è il cram-down fiscale) . Fuori dalle procedure, invece, l’unica strada sono le rateizzazioni ordinarie concesse dagli enti o sperare in periodiche rottamazioni di cartelle decise dal legislatore (ad esempio la “Rottamazione-quater” del 2023) . Queste sanatorie straordinarie permettono di estinguere i debiti fiscali riducendo o azzerando sanzioni e interessi: se l’impresa ne ha diritto, dovrebbe sempre valutare di aderire, perché aiutano moltissimo .
In generale, i debiti verso lo Stato vanno gestiti con priorità assoluta: spesso conviene pagare prima quelli correnti e, se proprio, ritardare i fornitori (previo accordo con loro), perché il Fisco ha poteri molto più invasivi e il “costo” del debito fiscale (sanzioni, interessi, rischi) è ben più alto .
D: Quali scelte ha un’azienda troppo indebitata per salvarsi (priva di prospettive di risanamento)?
R: Se un’analisi onesta rivela che l’azienda non è più risanabile (ad esempio: non c’è mercato per i suoi prodotti, gli asset non generano flussi, i debiti superano di molto gli attivi, nessun investitore interessato), allora rimangono essenzialmente due vie: il concordato liquidatorio o la liquidazione giudiziale (fallimento) . Il concordato liquidatorio può essere utile se c’è la possibilità di offrire ai creditori qualcosa in più rispetto a un fallimento standard : ad esempio vendere l’intero complesso aziendale in blocco a un acquirente che continui l’attività (massimizzando il prezzo di cessione rispetto allo “spezzatino” fallimentare) , oppure far entrare i soci con un contributo aggiuntivo destinato ai creditori. Se non ci sono queste condizioni migliorative, probabilmente il tribunale non ammetterà nemmeno il concordato, perché non soddisferebbe i requisiti di convenienza per i creditori . In tal caso si andrà direttamente in liquidazione giudiziale.
In alcuni casi particolari, come visto nel Caso 3, se prima si era tentata la composizione negoziata senza successo, si può accedere al concordato semplificato: questo non salva l’impresa (la liquida), però evita le lungaggini del fallimento e magari consegna i beni più rapidamente ai creditori (o a chi di dovere) . Quindi, la scelta per un’azienda “decotta” è sul come liquidare, non sul se liquidare: concordato (ordinario o semplificato) oppure fallimento. Dal punto di vista degli amministratori, proporre un concordato liquidatorio è di solito visto di buon occhio: dimostra volontà collaborativa, porta a una soluzione più ordinata e può mitigare le responsabilità (hanno almeno tentato qualcosa) ; al contrario, lasciar precipitare in un fallimento senza aver fatto nulla li espone a critiche severe e possibili azioni di responsabilità per aggravamento del dissesto .
In breve: se non c’è nulla da fare per salvare l’impresa, conviene comunque pilotare la liquidazione attraverso una procedura concorsuale piuttosto che subire passivamente il fallimento .
D: Una piccola S.r.l. può evitare il fallimento? Esistono procedure “più leggere” per imprese minori?
R: Sì. Il Codice prevede che le cosiddette imprese minori (quelle sotto specifici parametri di attivo, ricavi e debiti) non siano soggette a liquidazione giudiziale, bensì alle procedure previste per il sovraindebitamento (ora chiamate “crisi da debiti” dei non fallibili) . In concreto, una piccola S.r.l. sotto soglia, se insolvente, non viene dichiarata fallita ma può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata . Il concordato minore è molto simile a un concordato preventivo ma semplificato: c’è comunque un piano, un commissario e l’omologa del tribunale, ma è calibrato su realtà più piccole e con maggior flessibilità (ad esempio quorum di voto più bassi). La liquidazione controllata è l’equivalente del fallimento per il piccolo imprenditore, svolta dal tribunale ma con formalità ridotte e possibilità di esdebitazione finale anche dell’ex imprenditore .
In sostanza, le micro-imprese hanno un “paracadute” per evitare la parola fallimento e le relative interdizioni. Tuttavia, molte S.r.l. superano le soglie di non fallibilità (basta spesso avere un attivo > €300k o debiti > €500k per essere fallibili) , e quindi non rientrano tra i minori. Per queste, le procedure sono quelle ordinarie: concordato preventivo o liquidazione giudiziale . Vale la pena notare che, se una S.r.l. è sotto soglia, in caso di insolvenza potranno essere i creditori a chiedere al tribunale che venga dichiarata non la liquidazione giudiziale, bensì la liquidazione controllata ex L.3/2012 (ora confluita nel CCII) . In pratica, per il creditore cambia poco (c’è comunque un liquidatore nominato che vende i beni), ma per l’imprenditore c’è il vantaggio di non essere formalmente “fallito” e di avere più chance di liberarsi dei debiti residui grazie all’esdebitazione personale .
D: Come si tutela l’imprenditore onesto in caso di fallimento? C’è l’esdebitazione?
R: Sì. Il CCII prevede che, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, la persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) sia liberata dai debiti residui automaticamente entro certi limiti (art. 278 CCII) . Nel caso di S.r.l., la società viene cancellata, quindi il problema dell’esdebitazione societaria non si pone (cessando il soggetto, i debiti rimasti sono inesigibili) . Ma per l’imprenditore inteso come persona fisica dietro la società, come funziona? I soci di S.r.l. di norma non rispondono dei debiti sociali, quindi non hanno bisogno di esdebitazione (a meno che abbiano dato garanzie personali; però, in tal caso, l’esdebitazione del socio-fideiussore non è automatica: dovrebbe eventualmente fare una procedura di sovraindebitamento a parte, se come persona fisica è insolvente). In sintesi: l’esdebitazione è un istituto che riguarda gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili una volta esaurito il fallimento, e consente loro di ripartire senza quei debiti . Per l’ex amministratore di S.r.l., invece, l’esdebitazione non cancella eventuali condanne risarcitorie se è stato ritenuto responsabile verso i creditori o la massa. Quindi attenzione: l’esdebitazione libera dai debiti concorsuali, ma non da obblighi risarcitori per mala gestione o da pene pecuniarie per reati . Un amministratore condannato a risarcire per bancarotta fraudolenta, ad esempio, dovrà comunque pagare quel danno, l’esdebitazione non glielo condona.
D: Cosa comporta la segnalazione di allerta inviata da INPS/Agenzia Entrate?
R: Quando l’INPS, l’Agenzia Entrate o l’Agente Riscossione inviano la comunicazione di allerta esterna (del tipo: “La informiamo che la sua impresa ha debiti scaduti per €XX superiori alle soglie…”), da quel momento scattano alcune cose: 1. L’organo amministrativo ha 90 giorni per reagire in modo adeguato, preferibilmente presentando un’istanza di composizione negoziata o attivando altra procedura (accordo di ristrutturazione, concordato) . 2. Se lo fa tempestivamente, potrà beneficiare delle misure premiali previste (riduzione di interessi e sanzioni fiscali, non punibilità per ritardata dichiarazione di fallimento, ecc., come da artt. 25-octies e seguenti CCII) . 3. Se non lo fa, l’inerzia viene registrata: la legge non prevede sanzioni immediate (non è che scatta automaticamente il fallimento), ma in caso di successivo fallimento il fatto che l’amministratore abbia ignorato l’allerta verrà valutato negativamente (potrebbe costituire colpa grave) e l’azienda perde i benefici premiali; . 4. Inoltre, trascorsi i 90 giorni, i creditori pubblici qualificati (AE/INPS) possono autonomamente presentare istanza di liquidazione giudiziale (anzi, dovrebbero valutarlo se il debitore non dà segnali) .
In pratica, la segnalazione d’allerta crea una forte pressione: o reagisci subito attivando strumenti, oppure sai che se poi fallisci, ti verrà contestato di non aver agito e perderai possibili “sconti” (e intanto l’INPS/AE potrebbe nel frattempo averti portato in tribunale) . L’obiettivo è far sì che l’imprenditore non ignori i debiti con lo Stato: se arriva la lettera, meglio muoversi, perché ignorarla peggiora solo le cose.
(Nota: Queste norme sulle segnalazioni esterne sono state introdotte nel 2022; nel frattempo, con la pandemia, l’obbligo delle segnalazioni è stato sospeso fino a fine 2023. Ma in prospettiva dal 2024 in poi dovrebbero essere operative).
D: In un concordato preventivo, si possono falcidiare i debiti verso il Fisco e l’INPS?
R: Sì, è possibile tramite la transazione fiscale e contributiva prevista dall’art. 63 CCII. In un concordato (o anche in un accordo di ristrutturazione omologato), il debitore può proporre di pagare parzialmente e/o dilazionato i debiti tributari e contributivi, incluse IVA e ritenute, che prima erano intoccabili . La condizione è che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione: deve offrire all’Erario/INPS almeno quanto otterrebbero in caso di fallimento del debitore . Se tale condizione è soddisfatta, il tribunale può omologare anche senza il voto favorevole del Fisco (è il cosiddetto cram-down fiscale introdotto dalla legge 159/2020) . Ad esempio, se la mia S.r.l. in concordato offre di pagare il 30% dell’IVA e dimostra che in fallimento l’Agenzia Entrate prenderebbe 5%, il tribunale può confermare il concordato anche se l’Agenzia ha votato no. Naturalmente, se invece la proposta fiscale offre meno del realizzo fallimentare, l’Agenzia può opporsi e avrebbe ragione.
Va anche detto che spesso l’Amministrazione finanziaria, se vede che la proposta è seria e conforme al test di convenienza, partecipa al voto e la approva (non è più un soggetto che mette veti preconcetti come in passato, grazie anche alle nuove norme) . Fuori dalle procedure, invece, non è ammesso stralciare imposte e contributi: al massimo si possono ottenere dilazioni o rottamazioni, ma non un taglio dell’importo se non pagando integralmente il capitale. Quindi la sede concordataria è l’unica in cui lo Stato accetta di perdonare una parte di tasse e contributi dovuti, pur di massimizzare la chance di incasso del resto.
D: Cos’è la Composizione Negoziata e quando conviene utilizzarla?
R: Ne abbiamo parlato molto nel testo: la Composizione Negoziata è un percorso volontario e riservato in cui l’impresa in difficoltà cerca un accordo con i creditori assistita da un esperto indipendente, senza procedure concorsuali formali . Conviene utilizzarla quando l’impresa non è ancora insolvente irrimediabilmente, ma si trova in uno squilibrio e ha bisogno di una ristrutturazione del debito consensuale. È spesso il primo step consigliato: si tenta di risolvere fuori dal tribunale, con l’ombrello temporaneo delle misure protettive. Se funziona, si evita il concordato; se non funziona, comunque si può uscire dalla negoziazione ed entrare in concordato (anche semplificato, se ricorrono i requisiti) .
In sintesi, conviene provare la Composizione Negoziata quando: la crisi è incipiente o gestibile con accordi, c’è apertura al dialogo da parte dei creditori, e l’azienda preferisce evitare la pubblicità e la rigidità di un concordato . Ad esempio, se ho 5 banche e 10 fornitori e tutti sono ragionevoli, con l’aiuto di un esperto potrei trovare una soluzione su misura senza dover portare i libri in tribunale. Inoltre, la CNC è utile per ottenere uno standstill immediato (blocco delle azioni) magari mentre cerco un investitore o definisco un piano . Viceversa, se i creditori sono troppi o litigiosi, o se serve imporre sacrifici a una parte consistente di essi, allora tanto vale andare in concordato preventivo direttamente .
D: Cosa significa che gli atti in esecuzione di un piano attestato o accordo omologato non sono soggetti a revocatoria?
R: La legge fallimentare e ora il CCII prevedono che in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) certi pagamenti o garanzie concessi prima del fallimento possano essere revocati dal curatore se fatti in periodo sospetto e lesivi della par condicio. Tuttavia, per favorire le soluzioni concordate, si è stabilito che se un pagamento o una garanzia è effettuato in esecuzione di: – un piano attestato di risanamento pubblicato, – oppure di un accordo di ristrutturazione omologato, – oppure di un concordato preventivo omologato,
allora quel pagamento/garanzia non potrà essere oggetto di revocatoria nel successivo eventuale fallimento . Esempio: se nel contesto di un piano attestato pago anticipatamente un fornitore strategico e poi un anno dopo la società fallisce, il curatore non potrà chiedere indietro quei soldi a quel fornitore, purché il piano era vero e pubblicato. Questo serve a dare sicurezza ai creditori che collaborano al risanamento: non rischiano di dover restituire in futuro . Attenzione però: la Cassazione ha chiarito che questa esenzione vale solo se l’atto era funzionale al piano e il piano era serio. Se il piano era farlocco e serviva solo a giustificare pagamenti preferenziali, allora la protezione potrebbe venire meno (perché quello non era un vero risanamento) . Ma nella normalità, è una garanzia: creditore, se accetti il nostro accordo e prendi il 50% ora, sappi che se poi le cose vanno male, quel 50% te lo tieni. Stesso discorso per chi riceve pagamenti in un accordo di ristrutturazione o in un concordato: sono definitivi .
D: Quali vantaggi pratici ha la procedura di Composizione Negoziata rispetto al concordato preventivo?
R: In breve:
– Riservatezza: la CNC è confidenziale, il suo avvio non viene pubblicato (solo le misure protettive eventualmente sì, ma sono generiche). Il concordato invece è pubblico e spesso notizia, con possibili danni di reputazione .
– Flessibilità: nella CNC non ci sono regole rigide su percentuali, classi, maggioranze. Si possono trovare soluzioni creative e su misura, coinvolgendo solo alcuni creditori e modulando accordi diversi con ciascuno . Nel concordato bisogna rispettare la par condicio all’interno delle classi e principi di uniformità (pur con flessibilità nelle classi, ma è più schema rigido).
– Costo e tempi ridotti: la CNC di norma dura pochi mesi e ha costi contenuti (solo compenso dell’esperto secondo tariffe, e i consulenti eventuali). Il concordato dura spesso oltre un anno, con spese di giustizia, commissari, legali, etc.
– Mantenimento pieno del controllo: in CNC l’imprenditore resta pienamente in sella (l’esperto non gestisce, solo consiglia). In concordato l’imprenditore è in possesso ma vigilato strettamente dal commissario e deve chiedere autorizzazioni per atti straordinari .
– Nessun stigma legale: la CNC non è procedura concorsuale, quindi l’impresa non è considerata in default legale. Ad esempio, contratti con clausole di risoluzione per fallimento non scattano; non si perde la possibilità di partecipare a gare (diverso dal concordato, che spesso comporta esclusioni) .
Di contro, la CNC non consente di imporre soluzioni ai dissenzienti: serve l’accordo di ciascun creditore rilevante, mentre il concordato sì (maggioranza e cram-down). Inoltre CNC non consente di falcidiare unilateralmente debiti pubblici come IVA se non con l’accordo dell’ente (mentre col concordato sì via giudice). Quindi è win su riservatezza e flessibilità, loss su potere impositivo. In definitiva, va valutata caso per caso la convenienza.
Fonti & Riferimenti
(Si riportano di seguito fonti normative e giurisprudenziali autorevoli citate nel testo):
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 (aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024). Testo disponibile su Normattiva .
- Legge 3/2012 (sovraindebitamento) – Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogata dal CCII a decorrere dal 15/07/2022 .
- DL 118/2021 conv. L. 147/2021 – Introduzione dell’istituto della Composizione negoziata e del concordato semplificato .
- Cass., Sez. Unite, 12/03/2013 n. 6070: i soci di società estinta possono succedere nei rapporti attivi/passivi non definiti e rispondere dei debiti entro i limiti dell’attivo distribuito (principio di “fenomeno successorio”) .
- Cass., Sez. I, 21/06/2023 n. 17834: criteri di liquidazione del danno ex art. 2486 c.c. in caso di tardiva attivazione – il criterio dei netti patrimoniali è presunzione relativa, applicabile alle condotte successive alla riforma 2019 . (Confermata da Cass. Sez. I, 28/02/2024 n. 5252 ).
- Cass., Sez. I, 28/10/2024 n. 27782: Concordato preventivo e transazione fiscale: confermata l’ammissibilità dell’omologazione forzata nonostante il voto contrario dell’erario, se la proposta garantisce il soddisfacimento minimo di legge .
- Cass., Sez. Un., 22/07/2024 n. 20036: Azione di risarcimento contro Agenzia Entrate per mancata adesione a transazione fiscale: appartiene al giudice ordinario; l’Ag.Entrate agisce quale creditore concorsuale e non pubblico potere .
- Cass., Sez. V, 12/02/2025 n. 3617: Riduzione delle sanzioni tributarie in concordato preventivo in corso: l’impresa in concordato (non omologato) può accedere al regime agevolato di pagamento sanzioni (concordato preventivo non esclude definizioni agevolate) .
- Corte di Giustizia UE, 08/05/2024 (causa C-20/23): uno Stato membro non può escludere interamente talune categorie di debiti (come i tributari) dall’esdebitazione post-liquidazione se ciò non è previsto dalla Direttiva UE 2019/1023 .
- Tribunale di Roma, 09/05/2023 (decr.): Transazione fiscale forzosa: l’omologazione forzata serve a perseguire l’interesse concorsuale superiore, superando le resistenze ingiustificate degli uffici fiscali .
- Tribunale di Piacenza, 26/11/2024 (decr.): Effetti della transazione fiscale: l’omologa del concordato con transazione fiscale “cristallizza” il debito tributario complessivo, impedendo ulteriori interessi e sanzioni oltre la misura concordata .
- Codice Civile: artt. 2482-bis, 2482-ter (obblighi per perdite rilevanti), art. 2486 (gestione dopo scioglimento e criteri danno) , art. 2476 (azione responsabilità soci verso amministratori) .
- Linee guida CNDCEC sulla crisi d’impresa (2022): indicatori di allerta e DSCR < 1 a 6 mesi .
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce filtri a coalescenza, filtri per aria compressa, separatori d’olio, filtri per gas, cartucce coalescenti, sistemi di filtrazione industriale e soluzioni per impianti pneumatici si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai debiti verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori, leasing o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, sospensioni delle forniture o minacce di pignoramento?
Il settore dei filtri a coalescenza è altamente tecnico: richiede materiali filtranti speciali, media microfibrosi, supporti metallici, test di efficienza, tolleranze strette, certificazioni, supply chain internazionale e continuità nelle forniture verso impianti pneumatici, compressori, OEM e industrie che dipendono dalla qualità dell’aria.
Basta un aumento dei costi, un ritardo nei pagamenti dei clienti o una riduzione delle linee di credito per trasformare una normale tensione finanziaria in una crisi aziendale.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata e rilanciata, se intervieni subito.
Perché un’Azienda di Filtri a Coalescenza Finisce in Debito
Le cause più frequenti includono:
- aumento dei costi dei media filtranti, resine, supporti metallici e materiali speciali
- ritardi nei pagamenti da parte di distributori, costruttori di compressori, integratori e clienti industriali
- importazioni di materiali e componenti con pagamenti anticipati
- magazzino immobilizzato tra cartucce finite, filtri, supporti e semilavorati
- costi elevati per test, certificazioni, controlli qualità e conformità tecnica
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- investimenti in nuove serie filtranti e aggiornamenti normativi
- progetti custom con lunghi tempi di sviluppo e incassi posticipati
Il problema non è l’assenza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per un’Azienda di Filtri a Coalescenza con Debiti
Se non agisci in tempo puoi subire:
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco di affidamenti e fidi bancari
- sospensione delle forniture di media filtrante, supporti metallici, guarnizioni e componenti critici
- decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
- sequestro del magazzino e delle linee di produzione
- fermo della produzione e impossibilità di evadere gli ordini
- perdita di clienti chiave e fornitori strategici
- rischio concreto di fermo totale dell’attività
Una crisi di debito non gestita può paralizzare l’azienda in pochi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
Bloccare immediatamente i creditori
Con l’aiuto di un avvocato specializzato è possibile:
- sospendere pignoramenti già avviati
- bloccare richieste di rientro da banche e finanziarie
- proteggere i conti correnti aziendali
- gestire i fornitori più aggressivi
Prima si mette al sicuro l’azienda, poi si procede alla ristrutturazione.
Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso si trovano:
- interessi non dovuti o usurari
- sanzioni e more calcolate in modo errato
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- irregolarità bancarie
Una parte considerevole del debito può essere ridotta o cancellata.
Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti concreti:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici (media filtrante, componenti metallici, guarnizioni)
- rinegoziazione di finanziamenti e fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti più pesanti
- utilizzo di definizioni agevolate e rottamazioni, quando disponibili
Obiettivo: liquidità immediata senza bloccare la produzione.
Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Nei casi più complessi è possibile ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- concordato minore
- liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Queste procedure:
- bloccano tutti i creditori
- sospendono pignoramenti e azioni esecutive
- permettono di pagare solo una parte dei debiti
- mantengono operativa l’azienda
- tutelano anche l’imprenditore a livello personale
Proteggere produzione, magazzino e catena fornitori
Per un produttore di filtri a coalescenza è essenziale:
- tutelare cartucce, filtri finiti, media filtranti, componenti metallici e semilavorati
- evitare sequestri che paralizzerebbero intere linee produttive
- mantenere attivi i fornitori critici (media filtrante, torneria, guarnizioni, resinatura, lavorazioni)
- proteggere macchinari, impianti di avvolgimento, impregnazione e collaudo
- garantire continuità nelle consegne verso integratori, impianti industriali, automotive e OEM
Se la produzione si ferma, i debiti aumentano.
Se continua, l’azienda può ripartire.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- elenco completo dei debiti (fiscali, bancari, commerciali)
- estratti conto bancari aggiornati
- estratto di ruolo
- bilanci e dichiarazioni fiscali
- lista fornitori strategici e insoluti
- inventario di magazzino (filtri, cartucce, media, supporti, componenti)
- copia degli atti giudiziari ricevuti
- elenco ordini aperti e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
- Analisi preliminare: 24–72 ore
- Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
- Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
- Procedura giudiziaria: 3–12 mesi
Le misure protettive possono essere operative nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
- Stop immediato a pignoramenti e pressioni
- Riduzione reale del debito complessivo
- Protezione di magazzino, macchinari e linee produttive
- Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Continuità produttiva garantita
- Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
- Ignorare solleciti e decreti ingiuntivi
- Fare nuovi debiti per pagare debiti vecchi
- Pagare un creditore e trascurare gli altri
- Lasciare avanzare pignoramenti senza reagire
- Affidarsi a società prive di competenza legale
Ogni errore aumenta il rischio di blocco totale dell’attività.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- Analisi completa della situazione debitoria
- Blocco immediato, quando possibile, delle azioni dei creditori
- Piani di ristrutturazione su misura per produttori di filtri
- Attivazione degli strumenti giudiziari più efficaci
- Trattative professionali con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di filtri a coalescenza non significa essere destinato alla chiusura.
Con la strategia giusta puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre drasticamente i debiti
- proteggere produzione, magazzino e commesse
- salvare l’azienda e il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare immediatamente.