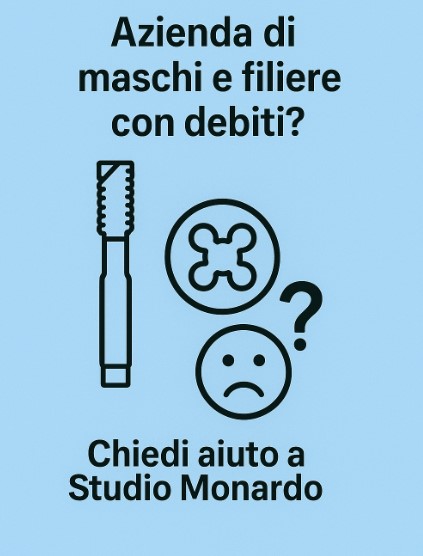Se gestisci un’azienda che produce, distribuisce o affila maschi, filiere, utensili filettatori, maschi speciali, filiere circolari, portamaschi, inserti per filettatura e utensili per macchine utensili, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la continuità della tua attività è a rischio.
Le aziende che lavorano nel settore della filettatura industriale operano con materiali costosi, lavorazioni di precisione, tolleranze strette, investimenti continui in macchine CNC e tempi di consegna rigorosi. Un blocco dovuto ai debiti può fermare commesse, causare ritardi non accettabili e far perdere clienti industriali strategici.
La buona notizia è che puoi ancora bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua azienda, se intervieni subito.
Perché le aziende di maschi e filiere accumulano debiti
Le cause principali includono:
- costi elevati di HSS, metallo duro, acciai speciali e trattamenti termici
- rincari delle materie prime e della componentistica importata
- pagamenti lenti da parte di officine, industrie e costruttori di macchine
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi con molte misure, profili e varianti
- investimenti continui in macchine CNC, affilatrici, strumenti di misura e rivestimenti
- difficoltà nell’ottenere credito bancario sufficiente
- fornitori strategici che richiedono pagamenti immediati
Tutti questi fattori possono generare crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
Agire subito è fondamentale per evitare un peggioramento della situazione. Ecco cosa devi fare:
- far analizzare da un avvocato l’intera posizione debitoria
- verificare quali debiti sono corretti, contestabili o già prescritti
- evitare piani di rientro affrettati o insostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
- proteggere fornitori critici e materiali indispensabili
- prevenire blocchi del conto corrente o riduzioni dei fidi bancari
- valutare strumenti legali che consentono di ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Una diagnosi professionale ti permette di capire quali debiti ridurre, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Trascurare i debiti può portare a conseguenze gravi:
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- fermo di macchine utensili, affilatrici e attrezzature
- blocco delle forniture di materiali, utensili grezzi e componenti critici
- impossibilità di completare commesse e rispettare le consegne
- perdita di clienti industriali e appalti consolidati
- danni pesanti alla reputazione professionale
- crisi di liquidità e mancato pagamento di fornitori e personale
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Nel settore della filettatura, anche un minimo ritardo può compromettere intere linee produttive dei clienti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato esperto in debiti aziendali può:
- bloccare subito pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre l’importo totale dei debiti tramite trattative professionali
- ottenere rateizzazioni davvero sostenibili
- annullare debiti irregolari, mal notificati o prescritti
- trattare con fornitori e banche per evitare sospensioni delle consegne
- proteggere macchinari, magazzini e continuità produttiva
- stabilizzare l’azienda mentre si ristruttura il debito
- impedire che la crisi sfoci in insolvenza
Una strategia professionale può salvare l’azienda anche in fase avanzata di difficoltà.
Come evitare il blocco dell’attività
Per evitare la paralisi produttiva devi:
- intervenire immediatamente
- evitare trattative improvvisate con i creditori
- tutelare fornitori fondamentali e materiali critici
- ristrutturare i debiti prima che arrivino pignoramenti
- identificare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare liquidità per garantire continuità e consegne
Così puoi evitare ritardi, penali e perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
D è necessario farlo se:
- hai ricevuto solleciti o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS o fornitori stanno aumentando
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità è in calo rapido
- fai fatica a rispettare scadenze e salari
- vuoi evitare la chiusura o la procedura concorsuale
Un avvocato specializzato può bloccare immediatamente le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
Attenzione: molte aziende non falliscono per i debiti, ma per aver ritardato a intervenire. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, proteggendo davvero l’impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese metalmeccaniche – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di maschi e filiere.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Un’impresa manifatturiera – immaginiamo la Maschi & Filiere S.r.l. (un’azienda metalmeccanica produttrice di utensili “maschi e filiere” per filettatura) – che si trova schiacciata dai debiti deve affrontare scelte difficili per difendersi dai creditori e tentare il risanamento. In Italia, l’ordinamento giuridico mette a disposizione una serie di strumenti, sia stragiudiziali (fuori dai tribunali) sia concorsuali (procedure giudiziali), concepiti per gestire la crisi d’impresa e l’insolvenza. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, offre un’analisi approfondita di tutte le possibili soluzioni e strategie difensive a disposizione di un imprenditore debitore. Adottiamo un punto di vista del debitore (amministratori e soci dell’azienda indebitata) e utilizziamo un linguaggio rigoroso ma divulgativo, adatto sia ai professionisti legali sia a imprenditori e privati interessati.
Affronteremo innanzitutto le varie tipologie di debito (fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi, ecc.) e le conseguenze legali del mancato pagamento. Analizzeremo quindi gli obblighi di legge introdotti dalle recenti riforme – in particolare dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) – che impongono una gestione oculata e tempestiva della crisi. Illustreremo gli strumenti “di allerta” e di composizione della crisi, come le segnalazioni precoci di Fisco e INPS e la composizione negoziata della crisi, evidenziando come un debitore diligente possa prevenire esiti distruttivi intervenendo per tempo.
Il cuore della guida sarà dedicato alle soluzioni pratiche: dai piani di risanamento stragiudiziali (trattative private, piani attestati di risanamento) agli accordi con i creditori formalizzati e omologati (accordi di ristrutturazione dei debiti), sino alle procedure concorsuali vere e proprie come il concordato preventivo – sia in continuità aziendale che liquidatorio – e, quale ultima ratio, la liquidazione giudiziale (il “fallimento” nella nuova terminologia). Esploreremo anche istituti introdotti di recente, come la composizione negoziata della crisi (procedura volontaria assistita da un esperto indipendente) e il concordato semplificato post-negotiation, nonché i meccanismi per ristrutturare i debiti pubblici (transazione fiscale e contributiva) con eventuale cram down (omologazione forzosa nonostante il dissenso del Fisco) .
Dal punto di vista pratico, forniremo tabelle riepilogative (ad es. soglie di debito che attivano obblighi di allerta, confronto tra diversi strumenti di regolazione della crisi, etc.) e simulazioni di casi concreti ambientati in Italia, per comprendere passo-passo le mosse migliori che un imprenditore-debitore può compiere. Un’ampia sezione finale presenterà Domande & Risposte frequenti, chiarendo dubbi tipici: ad esempio, cosa accade se è già partita un’esecuzione forzata, se i fornitori minacciano azioni legali, se la banca revoca gli affidamenti, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una cartella esattoriale, oppure quali sono i rischi penali per gli amministratori in caso di omissioni di versamenti fiscali o previdenziali, ecc.
Importante: Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo sono elencate nella sezione Fonti in fondo alla guida. Si tratta di riferimenti ad articoli di legge (Codice Civile, Codice della Crisi e leggi speciali) e a sentenze aggiornate (2024-2025) delle magistrature italiane più autorevoli (Corte di Cassazione, tribunali specializzati) o a documenti ufficiali, al fine di garantire l’autorevolezza delle informazioni. Ogni soluzione suggerita sarà quindi suffragata da fonti verificabili. L’obiettivo è offrire una guida avanzata ma comprensibile, che metta il debitore in condizione di valutare consapevolmente le opzioni disponibili per tutelare l’impresa indebitata, cercando ove possibile di salvarla, oppure di limitare i danni in caso di inevitabile liquidazione, proteggendo anche il patrimonio personale nei limiti consentiti dalla legge.
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio la situazione in cui si trova la nostra ipotetica azienda “Maschi & Filiere” indebitata, e vediamo cosa fare per difendersi e come farlo concretamente.
1. Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Una società come Maschi & Filiere S.r.l., attiva da anni nel settore metalmeccanico, può trovarsi esposta a diversi tipi di debiti. Ciascuna categoria di debito comporta dinamiche legali specifiche in caso di insolvenza o ritardo nei pagamenti:
- Debiti fiscali (Erario): comprendono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) e ritenute non pagate. Se l’azienda omette questi versamenti, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute e l’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) – il concessionario della riscossione – potrà emettere cartelle esattoriali. Il mancato pagamento delle cartelle può portare a misure esecutive come fermi amministrativi sui beni mobili registrati, ipoteche su immobili aziendali, pignoramenti di conti correnti o altre aggressioni al patrimonio. Inoltre, alcuni omessi versamenti configurano reati: ad esempio, il mancato versamento di IVA superiore a una certa soglia annua (attualmente €250.000) è reato penale tributario (omesso versamento IVA), così come l’omissione di ritenute certificate oltre soglie più basse (circa €150.000). Anche l’omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti oltre €10.000 annui è reato. Dunque, i debiti fiscali e contributivi presentano un duplice profilo: esattoriale (riscossione coattiva e sanzioni amministrative) e penale (in caso di superamento di determinate soglie di omissione). Dal punto di vista civilistico, lo Stato e gli enti previdenziali godono di privilegi sui beni del debitore, sicché nelle procedure concorsuali i loro crediti sono soddisfatti con priorità rispetto ai crediti chirografari comuni.
- Debiti verso fornitori: sono i classici debiti commerciali di fornitura di beni e servizi. In una fase di crisi di liquidità, l’azienda potrebbe accumulare fatture non pagate ai fornitori. Questi creditori generalmente non hanno garanzie specifiche (sono chirografari, ovvero non privilegiati), ma possono attivarsi rapidamente per il recupero del credito: spesso ottengono un decreto ingiuntivo e in mancanza di opposizione procedono con pignoramenti di beni aziendali (macchinari, merci) o crediti (es. pignoramento di crediti vs clienti, pignoramento conti correnti). Il rischio principale è la paralisi operativa: un pignoramento di conto corrente o di attrezzature può bloccare l’attività. Inoltre, un singolo fornitore non pagato – se il credito supera una certa soglia – potrebbe anche presentare istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) contro l’azienda debitrice, sostenendo lo stato di insolvenza. I debiti commerciali non soddisfatti tendono a generare reazioni a catena: forniture bloccate, perdita di fiducia dei partner e innesco di procedure esecutive individuali.
- Debiti bancari e finanziari: includono esposizioni per finanziamenti, mutui, scoperti di conto (affidamenti), anticipo fatture, leasing. Le banche sono spesso creditori garantiti (ad esempio da ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o su titoli, o da fideiussioni personali degli imprenditori/soci). In caso di crisi, la banca può revocare gli affidamenti (ad esempio chiedere rientro immediato dello scoperto di conto o dell’anticipo fatture), aggravando la stretta di liquidità. Se l’azienda non rientra, la banca può escutere le garanzie: escussione di fideiussioni (aggredendo il patrimonio personale dei garanti), esecuzione sull’immobile ipotecato (espropriazione e vendita all’asta) o sul bene oggetto di leasing (riappropriazione). I contratti bancari spesso prevedono clausole risolutive espresse: al verificarsi di determinate condizioni (insolvenza, ritardi nei pagamenti ad altri creditori, iscrizione di pregiudizievoli) la banca può risolvere il contratto e pretendere il rimborso integrale. Inoltre, le banche tendono a coordinarsi in caso di crisi aziendale tramite accordi interbancari (esiste un Protocollo ABI per ristrutturazione dei debiti bancari), ma ciò avviene solo se l’azienda avvia un dialogo attivo proponendo un piano di rientro credibile. In un fallimento o concordato, i crediti bancari ipotecari o pignoratizi sono soddisfatti con prelazione sui beni dati in garanzia; le eventuali eccedenze non garantite diventano chirografarie.
- Debiti verso i dipendenti: riguardano stipendi arretrati, TFR, ecc. I dipendenti godono di privilegio generale sui mobili e di privilegio speciale su alcuni beni per le ultime mensilità. In caso di insolvenza grave, il mancato pagamento continuativo degli stipendi può portare i dipendenti a dimettersi per giusta causa o ad agire anch’essi in via monitoria (ingiunzione) e esecutiva. Tuttavia, esiste il Fondo di Garanzia INPS che interviene (a seguito di fallimento o anche di concordato preventivo liquidatorio) per pagare ai lavoratori il TFR e le ultime mensilità entro certi limiti. Dal punto di vista penale, l’omesso pagamento di retribuzioni non è più reato in sé (lo era decenni fa), ma può rilevare come bancarotta semplice se l’imprenditore aggrava il dissesto omettendo di soddisfare obbligazioni nate dopo lo stato di insolvenza. Inoltre, il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni (come detto sopra) integra reato se supera €10.000 annui.
- Debiti verso l’INPS e altri enti previdenziali: includono i contributi non versati per i dipendenti (quota a carico azienda e quote trattenute al lavoratore) o i contributi dei lavoratori autonomi/soci. L’INPS ha poteri di riscossione analoghi al Fisco: iscrive a ruolo i contributi omessi e affida all’Agente della Riscossione la riscossione coattiva (cartella esattoriale). I crediti INPS sono privilegiati al pari di imposte. Come già menzionato, il mancato versamento delle ritenute previdenziali (la parte di contributi a carico del dipendente, trattenuta in busta paga) oltre €10.000 è penalmente sanzionato, a meno che il datore non vi ponga rimedio prima dell’apertura del dibattimento . L’omissione della sola quota datoriale non è reato ma comporta sanzioni civili (somme aggiuntive). Dunque, debiti INPS protratti espongono l’azienda sia ad azioni esecutive (AER può pignorare beni come per i debiti fiscali) sia ai suddetti rischi penali per gli amministratori.
In sintesi, i debiti aziendali possono portare a azioni esecutive individuali (pignoramenti, cause) e/o a iniziative concorsuali (richieste di fallimento) da parte dei creditori. Dal lato dell’imprenditore debitore, è fondamentale capire che l’ordinamento privilegia chi prende iniziativa per tempo. Inattività e inerzia aggravano la posizione: più il debito invecchia, più crescono interessi e sanzioni (specie sui debiti fiscali), e maggiori sono le probabilità che un creditore “stanco di aspettare” avvii procedure esecutive o richieda un intervento del tribunale. Nei prossimi capitoli vedremo come la legge italiana abbia introdotto meccanismi per spingere gli amministratori ad attivarsi prima che la situazione precipiti, e quali strumenti concreti possano utilizzare per gestire o risolvere l’indebitamento.
2. Obblighi di legge per gli amministratori: rilevare tempestivamente la crisi
Uno degli aspetti più innovativi del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è l’enfasi sulla prevenzione e sulla gestione tempestiva della crisi. Agli amministratori di società (S.r.l., S.p.A. ecc.) sono richiesti comportamenti proattivi per monitorare la salute finanziaria dell’impresa e intervenire ai primi segnali di difficoltà. Vediamo i punti chiave della normativa vigente:
a) Assetti organizzativi adeguati (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) – L’art. 2086 comma 2 del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. In pratica, gli amministratori devono dotare la società di sistemi di controllo interno capaci di monitorare costantemente lo stato di salute finanziaria (indici di liquidità, solvibilità, flussi di cassa prospettici, ecc.) e di cogliere i segnali di squilibrio . Questo significa che non è più ammessa una gestione “a vista” o approssimativa: la legge esige un approccio manageriale prudente e pianificato, secondo il principio che prevenire è meglio che curare.
In concreto, “assetti adeguati” implica ad esempio: contabilità aggiornata e veritiera, strumenti di budgeting e controllo di gestione, indicatori per segnalare tensioni di liquidità o erosione del patrimonio netto, e procedure interne per reagire (piani finanziari, ricerca di nuova finanza o capitali, taglio dei costi). Se l’azienda ha un organo di controllo (sindaco o revisore), questo deve poter vigilare efficacemente, il che presuppone che gli amministratori lo informino e predispongano reporting adeguati. Insomma, l’era dell’improvvisazione è finita: la legge impone agli amministratori di essere sentinelle della continuità aziendale.
b) Doveri degli organi di controllo interni – Parallelamente, il CCII e il Codice Civile rafforzano i compiti dei sindaci, del revisore legale e degli altri organi di controllo societari. Questi soggetti, nell’esercizio delle loro funzioni, se rilevano segnali di crisi ignorati dagli amministratori (es: perdite rilevanti, tensioni di cassa gravi, indicatori che prospettano insolvenza entro 6-12 mesi), devono spronare gli amministratori ad agire . In base all’originario art. 24 CCII (ora modificato), i sindaci avrebbero dovuto persino effettuare una segnalazione formale al board sollecitando interventi per evitare il dissesto. Questa parte “procedurale” dell’allerta interna è stata sospesa e posticipata, ma il principio di buona gestione resta: i sindaci fungono da sentinelle interne e non possono voltarsi dall’altra parte di fronte a evidenti segnali di crisi. Anzi, il “Correttivo ter” del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha espressamente equiparato i revisori legali ai sindaci negli obblighi di monitoraggio e segnalazione tempestiva della crisi . Ciò significa che, in una S.r.l. soggetta a revisione legale, il revisore ha il dovere di allertare gli amministratori sulle criticità, proprio come farebbe un collegio sindacale.
Se né gli amministratori né i controllori interni adottano misure adeguate di fronte a indicatori di crisi conclamata, potranno andare incontro a responsabilità personali per omessa tempestiva reazione. In altre parole, se l’azienda poi fallisce, l’inazione di amministratori e sindaci potrà essere valutata come colpa grave. Le Linee Guida 2025 sul governo dell’impresa in crisi (richiamate dagli operatori) evidenziano che l’amministratore sarà chiamato a rispondere per mancato intervento tempestivo, con rischio di azioni di responsabilità e sanzioni . Per i sindaci e revisori, omissioni gravi potrebbero integrare violazioni dei doveri con possibili revoche per giusta causa o coinvolgimento in responsabilità risarcitorie se dal loro mancato controllo è derivato un aggravamento del dissesto.
c) Allerta “esterna” dei creditori pubblici qualificati – Oltre alla vigilanza interna, la legge affida a determinati enti pubblici il compito di inviare segnali d’allarme esterni quando un’impresa accumula debiti significativi verso lo Stato. Questi enti, detti “creditori pubblici qualificati”, sono principalmente: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione (AER) . Dal 1° gennaio 2022 sono operative soglie specifiche oltre le quali scatta l’obbligo per tali enti di inviare una segnalazione formale all’impresa debitrice. La tabella seguente riepiloga le soglie attuali (introdotte dal D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021):
Soglie di debito per segnalazione d’allerta esterna
| Ente segnalante | Condizione che fa scattare l’allerta (debito scaduto non regolarizzato) |
|---|---|
| INPS – Contributi previdenziali dovuti ai lavoratori | Mancato versamento di contributi da oltre 90 giorni, per un importo > €15.000 (imprese con dipendenti, e tale importo rappresenta almeno il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente) oppure > €5.000 (imprese senza dipendenti) . |
| Agenzia delle Entrate – Imposte (IVA, ritenute) | Esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalle comunicazioni trimestrali IVA (LIPE), di importo > €5.000 . È sufficiente quindi omettere un versamento IVA periodico oltre tale soglia perché scatti l’allerta. (NB: per altre imposte dirette, il meccanismo è analogo e confluisce comunque nella soglia cartelle AER infra). |
| Agente Entrate-Riscossione (AER) – Ruoli esattoriali | Presenza di debiti iscritti a ruolo (affidati alla riscossione) scaduti da oltre 90 giorni, per importi superiori a €100.000 (imprenditori individuali), €200.000 (società di persone) o €500.000 (società di capitali) . In pratica, cartelle esattoriali non pagate per importi rilevanti determinano la segnalazione. |
Come si nota, alcune soglie non sono affatto elevate: ad esempio, un’omissione di versamento IVA di appena €5.000 o contributi arretrati per €15.000 possono capitare anche a piccole aziende, e fanno comunque scattare l’allerta . L’intento del legislatore è dichiaratamente preventivo: intercettare segnali di crisi nelle fasi iniziali, quando l’impresa può ancora salvarsi se interviene subito, anziché aspettare che i debiti diventino insostenibili .
Cosa accade alla segnalazione? Ciascun ente monitora automaticamente il verificarsi di queste condizioni. Una volta superata la soglia e decorso un breve periodo (in genere 60 giorni dal termine di pagamento previsto) senza che il debitore abbia rimediato, l’ente invia una PEC di segnalazione all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo della società . Nella PEC si segnala il superamento della soglia e si invita espressamente l’imprenditore ad attivare la procedura di composizione negoziata della crisi (o comunque a prendere provvedimenti per regolarizzare) . Attenzione: questo avviso non dichiara formalmente uno “stato di crisi” giuridico né avvia di per sé alcuna procedura concorsuale – è piuttosto un campanello d’allarme ufficiale: “Hai accumulato debiti rilevanti con Fisco/INPS; valuta di rivolgerti a un esperto indipendente per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi” . In sostanza è una moral suasion normata: il legislatore vuole “spingere” il debitore a conoscere e utilizzare gli strumenti di aiuto (come la composizione negoziata, di cui diremo) per affrontare la crisi .
Dal punto di vista strettamente legale, il ricevere questa segnalazione non obbliga l’imprenditore ad avviare una procedura (non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di una scelta imprenditoriale discrezionale). Tuttavia, ignorare l’allerta può avere conseguenze indirette molto serie . In primis, la PEC costituisce una formale “messa in mora informativa”: da quel momento gli amministratori non possono più invocare ignoranza della situazione di dissesto, e ogni eventuale inerzia successiva sarà valutata severamente . Se in seguito l’impresa fallisse senza aver preso misure, i creditori o il curatore fallimentare avranno gioco facile nel dimostrare che già a partire da quella PEC gli amministratori erano consapevoli della crisi e non sono intervenuti – configurando una grave colpa gestionale. Inoltre, la PEC viene inviata anche al collegio sindacale o al revisore: ciò mette in allerta pure i controllori, i quali non possono ignorare il segnale e, se gli amministratori restano inerti, dovranno attivarsi per tutelarsi (in casi estremi, dottrina suggerisce che potrebbero perfino segnalare la situazione al tribunale ex art. 2409 c.c., denunciando gravi irregolarità) . Infine, l’allerta esterna “fissa un confine temporale netto”: se dopo quell’avviso nulla viene fatto e la situazione degenera, sarà impossibile per il debitore sostenere di non essersi accorto della gravità; viceversa, se reagisce attivando ad esempio la composizione negoziata, tale condotta potrà essergli riconosciuta come diligente e di buona fede, con possibili benefici futuri (ad esempio ai fini dell’esdebitazione personale post-fallimento o per evitare contestazioni di bancarotta semplice per tardiva attivazione) .
Esempio: Gamma S.p.A., impresa edile, nel 2024 accumula debiti IVA per €200.000 e contributi INPS arretrati per €20.000 (4 mensilità). In ottobre 2024 riceve due PEC: una dall’Agenzia Entrate, che rileva IVA non versata ben sopra €5.000 invitando alla composizione negoziata, l’altra dall’INPS per i contributi non pagati >90 giorni. Il collegio sindacale di Gamma richiama subito l’amministratore alle sue responsabilità. Se l’amministratore ignora gli avvertimenti, i sindaci – per non incorrere in corresponsabilità – potrebbero anche informare il tribunale. Al contrario, se l’amministratore reagisce (ad es. depositando istanza di composizione negoziata o cercando un accordo coi creditori), potrà tentare di salvare l’azienda e al contempo dimostrare di aver agito con diligenza, il che tornerà a suo favore in caso di successivo giudizio (evitando imputazioni di imprudenza grave) .
d) Il tramonto degli “OCRI” e il nuovo approccio volontario – Va notato che il disegno originario del Codice Crisi prevedeva, dopo la segnalazione d’allerta, l’attivazione quasi automatica di una procedura di composizione assistita dinanzi a speciali Organismi (detti OCRI, istituiti presso le CCIAA). Questo meccanismo di allerta pubblica non è mai divenuto operativo: prima rinviato per Covid, poi di fatto superato dalla riforma del 2021 (D.L. 118/2021) che ha introdotto la composizione negoziata al posto degli OCRI . Oggi, dunque, la “segnalazione d’allerta esterna” si esaurisce con l’invio della PEC: non scatta alcuna procedura concorsuale d’ufficio, ma si tratta solo di un forte stimolo all’imprenditore affinché prenda iniziative.
Riassumendo questa sezione, l’ordinamento attuale combina obblighi organizzativi interni e segnalazioni esterne per fare in modo che i segnali di crisi non passino inosservati. Per un debitore, ciò si traduce in un consiglio preciso: se ricevi allarmi (interni o esterni), non ignorarli. Al contrario, attivarsi tempestivamente – ad esempio contattando un consulente, predisponendo un piano o avviando una procedura volontaria – potrà essere decisivo per difendere l’azienda**: sia perché aumenta le chance di superare la crisi, sia perché, in caso di esito negativo, dimostra la buona fede e diligenza degli amministratori, evitando loro guai ben peggiori (responsabilità personali, azioni di danni o persino accuse penali di mala gestio). Nei capitoli che seguono, vedremo quali strumenti concreti l’amministratore-debitore può attivare in risposta a questi segnali di allerta.
3. Soluzioni stragiudiziali per gestire i debiti (negoziazione privata e piani di risanamento)
Una volta emersi i problemi di insolvenza o grave crisi finanziaria, l’imprenditore ha davanti a sé due grandi famiglie di soluzioni: quelle stragiudiziali, che non richiedono inizialmente l’intervento del tribunale, e quelle concorsuali (giudiziali), che implicano l’accesso a procedure legalmente regolate e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Cominciamo dalle soluzioni extragiudiziali, spesso preferibili in quanto più snelle, riservate e potenzialmente rapide, anche se non sempre sufficienti a risolvere ogni crisi.
3.1. Trattative private e accordi “in bonis” con i creditori – La prima opzione per un’azienda indebitata, prima di ricorrere a strumenti formali, è tentare di negoziare spontaneamente con i creditori. Ad esempio, Maschi & Filiere S.r.l. potrebbe incontrare i principali fornitori a cui deve denaro e proporre un piano di rientro: pagamento dilazionato del dovuto, magari con uno stralcio parziale (una riduzione dell’importo totale) se accettano di attendere. Analogamente, con la banca si potrebbe ridiscutere il piano di ammortamento del mutuo, chiedere una moratoria temporanea delle rate, o consolidare lo scoperto di conto in un finanziamento a più lungo termine. Queste soluzioni negoziali volontarie hanno il vantaggio di evitare pubblicità e costi di procedura; spesso il creditore preferisce trovare un accordo ragionevole anziché avventurarsi in cause lunghe o nel rischio che l’azienda fallisca (nel qual caso il creditore chirografo prenderebbe forse molto poco).
Tuttavia, le trattative informali presentano anche rischi e limiti: (i) richiedono l’adesione di tutti (o almeno dei principali) creditori, altrimenti l’azione isolata di uno può vanificare tutto; (ii) eventuali accordi non omogenei potrebbero, in caso di successivo fallimento, essere soggetti a revocatoria fallimentare (es. se l’azienda paga un fornitore privilegiando lui su altri in fase di insolvenza, quel pagamento può poi essere revocato dal curatore – salvo si possa rientrare in qualche esenzione di legge); (iii) manca la “protezione” dalle azioni esecutive: un creditore che non partecipa all’accordo può comunque aggredire i beni; (iv) in assenza di omologazione giudiziale, gli accordi non vincolano i dissenzienti. Pertanto, la via puramente stragiudiziale funziona soprattutto se il numero dei creditori è contenuto e c’è fiducia reciproca. Esempio: se Maschi & Filiere ha 3 fornitori principali e 1 banca, e tutti sono disposti a collaborare, un accordo privato di ristrutturazione può bastare. Ma se i creditori sono decine, o se alcuni adottano linee dure, serviranno strumenti più strutturati.
Un consiglio pratico nella gestione privata: agire in buona fede e trasparenza con i creditori. Presentare loro un piccolo dossier con la situazione aziendale e le prospettive può aiutare la credibilità. Inoltre, se si promette un pagamento parziale o dilazionato, occorre poi rispettarlo rigorosamente: un mancato rispetto di un accordo privato fa perdere la residua fiducia e probabilmente conduce i creditori dritti dal legale.
3.2. Il Piano Attestato di Risanamento (PAR) – Il Piano attestato di risanamento è uno strumento intermedio tra il puramente informale e il concorsuale. Si tratta di un piano di risanamento aziendale, predisposto dall’imprenditore con l’ausilio dei suoi consulenti, che mira a rilanciare l’impresa e riequilibrare la sua posizione finanziaria, eventualmente tramite ristrutturazione dei debiti. La caratteristica chiave è che tale piano viene asseverato (attestato) da un professionista indipendente (un esperto, di norma un commercialista o revisore, con i requisiti di indipendenza previsti dalla legge) il quale dichiara, in una relazione, che – sulla base dei dati e delle ipotesi fornite – il piano appare veritiero e ragionevolmente fattibile per risanare l’esposizione debitoria dell’impresa .
Il piano attestato è disciplinato oggi dall’art. 56 CCII. È definito strumento di regolazione stragiudiziale della crisi, in quanto non prevede alcuna omologazione o intervento preventivo del Tribunale . In sostanza, dopo aver elaborato il piano e raccolto l’attestazione professionale, l’imprenditore può proporlo ai creditori; se costoro volontariamente lo accettano – spesso tramite accordi bilaterali (ad esempio una convenzione di moratoria con le banche, intese scritte con i fornitori per dilazioni o saldo e stralcio) – il piano viene eseguito in autonomia. Non c’è pubblicità legale obbligatoria (anche se, di fatto, spesso si comunica l’esistenza del piano per giustificare eventuali operazioni straordinarie annesse).
Quali vantaggi offre allora un piano attestato rispetto a un semplice accordo privato? Principalmente due, introdotti dal legislatore per incoraggiare questi risanamenti volontari:
- Esonero dall’azione revocatoria fallimentare: gli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo al risanamento sono esenti da revocatoria fallimentare (art. 166, co.3, CCII) . Ciò significa che se l’imprenditore, eseguendo il piano, paga parzialmente un fornitore o concede garanzie su nuovi finanziamenti, e poi nei due anni successivi comunque fallisse, il curatore non potrà chiedere la revoca di quei pagamenti o garanzie, purché fossero previsti dal piano. È una protezione importante: senza di essa, i creditori diffiderebbero ad aderire a un piano stragiudiziale sapendo che, se il debitore fallisce, potrebbero dover restituire quanto ricevuto. Con questa esenzione, invece, i creditori aderenti sono tutelati (devono però poter dimostrare che l’atto era funzionale al piano attestato, e il piano aveva i requisiti di idoneità).
- Esonero da responsabilità penale per bancarotta preferenziale: analogamente, l’art. 324 CCII prevede che i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato non siano punibili come bancarotta semplice o preferenziale . Ad esempio, pagare integralmente un fornitore prima degli altri, se rientra nel piano di risanamento attestato, non potrà essere contestato all’amministratore come atto di favore che ha danneggiato la par condicio. In assenza di piano, lo stesso pagamento eseguito in stato di insolvenza poteva configurare il reato di bancarotta preferenziale. Questa franchigia penale dà quindi serenità all’imprenditore nelle scelte esecutive del piano.
Va però sottolineato: per godere di queste esenzioni il piano attestato deve avere i requisiti di legge. In particolare, l’art. 56 CCII richiede che il piano sia idoneo a garantire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Deve avere forma scritta e data certa, contenere dettagli sull’impresa, sulle cause della crisi, sulle strategie di intervento (ristrutturazione del debito, ricapitalizzazione, dismissioni, rilancio commerciale, taglio costi, ecc.) e soprattutto le proiezioni economico-finanziarie che mostrano il ritorno all’equilibrio. Il professionista attestatore (figura normativamente definita ora come “professionista indipendente” ex art. 2, co.1 lett. o) CCII) deve verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Egli rilascia una relazione di attestazione nella quale assevera che le informazioni sono attendibili e le strategie proposte, con ragionevole probabilità, consentiranno all’impresa di superare la crisi (o comunque di migliorare la sua posizione in modo risolutivo). Non si chiede al professionista di garantire il risultato, ma di effettuare una diligente verifica e attestare che sì, questo piano ha concrete possibilità di riuscita.
Nel 2023-2024 sono stati aggiornati i Principi di attestazione a cura del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) , per adeguarli al CCII: l’attestatore deve seguire linee guida rigorose nell’analizzare il piano (verifica della continuità aziendale prospettica, test di ragionevolezza delle assunzioni di ricavi/costi, analisi della sostenibilità dei flussi di cassa, ecc.). Il Correttivo ter del 2024 ha ulteriormente arricchito l’art. 56 CCII, ampliando le informazioni minime obbligatorie che il piano deve contenere . Ciò per renderlo più trasparente e completo sia per i creditori sia per eventuali controlli ex post.
Esempio pratico di piano attestato: Maschi & Filiere S.r.l., con €2 milioni di debiti (banche, fornitori e fisco) e difficoltà di liquidità, elabora un piano su 5 anni per tornare solvibile. Il piano prevede che un investitore apporti nuovi fondi per €500.000, l’azienda dismetta un ramo d’azienda non strategico incassando €300.000, e le banche proroghino le linee per diluire i pagamenti. I fornitori strategici accettano uno stralcio del 20% delle esposizioni in cambio di pagamenti garantiti sul restante 80%. Il piano mostra che, con queste misure, l’EBITDA torna positivo e sufficiente a sostenere il debito residuo, mentre la liquidità iniziale e liberata dalle cessioni copre i pagamenti immediati. Un commercialista indipendente analizza i numeri, verifica che le assunzioni (crescita del fatturato del 5% annuo, margini in linea col passato, ecc.) siano plausibili e che l’apporto di terzi sia concreto (c’è lettera d’intenti). Attesta che il piano è fattibile e che, se attuato, l’azienda risanerà i debiti. Sulla base di ciò, la società firma accordi individuali: con banche (moratorie), con fornitori (accordi transattivi per riduzione del credito), formalizza la richiesta all’investitore (che verrà formalizzata in aumento di capitale) e così via. Il tutto resta riservato (non è una procedura pubblica). Se la società esegue il piano e si risolleva, la crisi è superata senza passare dal tribunale. Se malauguratamente, dopo aver eseguito parte del piano, la società dovesse comunque fallire, i pagamenti fatti e le garanzie concesse nell’ambito del piano non saranno revocabili né penalmente rilevanti come preferenze.
Limiti del piano attestato: È importantissimo capire che il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti. Se, ad esempio, 8 fornitori su 10 accettano lo stralcio, ma 2 rifiutano e fanno decreto ingiuntivo, quei due possono proseguire e pignorare beni, magari mandando all’aria il piano. Il piano attestato non offre alcuna protezione legale automatica: non c’è stay delle azioni esecutive e non c’è possibilità di imporre la riduzione del credito a chi non è d’accordo. Dunque, questo strumento funziona se c’è un consenso molto ampio e spontaneo dei creditori. Per ovviare a questo, a volte il piano attestato si usa in combinazione: ad es. si fa un piano attestato per rassicurare banche e fornitori, ma parallelamente si ottiene dal tribunale un provvedimento protettivo (con un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo “in bianco” di cui diremo). Il confine è labile: quando il consenso non è unanime, conviene forse passare allo strumento successivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.
3.3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex artt. 57-64 CCII) – Gli accordi di ristrutturazione sono il primo vero strumento legalmente formalizzato per regolare la crisi d’impresa senza passare da un concorso pieno come il concordato. Si tratta di accordi che l’imprenditore conclude con una parte consistente dei creditori e che vengono poi omologati dal Tribunale, acquistando efficacia vincolante. In sostanza, l’imprenditore propone ai creditori un certo trattamento (pagamento parziale, dilazionato, riorganizzazione del debito), raccoglie l’adesione di una maggioranza qualificata di crediti, e chiede al Tribunale di omologare l’accordo rendendolo efficace anche per eventuali creditori non aderenti.
Secondo il Codice attuale, esistono tipologie differenti di accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD), con diverse soglie di adesione :
- Accordi “ordinari”: richiedono l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti dell’impresa . I creditori che non aderiscono (il rimanente <40%) devono, per legge, essere pagati integralmente entro determinati termini (entro 120 giorni dalle scadenze originarie o dall’omologazione) . Ciò tutela i dissenzienti: l’accordo ordinario non può imporre a un non aderente una decurtazione o dilazione oltre i 120 giorni dal dovuto – deve prendervi tutto entro quel lasso di tempo . In pratica, l’accordo ordinario serve per ristrutturare la posizione con la maggioranza dei creditori, mentre i pochi estranei vengono comunque soddisfatti in breve termine (magari utilizzando le risorse liberate dall’accordo stesso).
- Accordi “agevolati”: introdotti dalle riforme recenti (D.L. 118/2021 e correttivi), prevedono una soglia di adesione inferiore, pari al 30% del passivo . Sono “agevolati” proprio perché all’imprenditore è sufficiente ottenere un consenso molto meno ampio. In compenso, però, hanno condizioni più stringenti verso i non aderenti: di fatto, si applicano solo in situazioni dove i creditori estranei non subiscono pregiudizio (ad esempio vengono comunque pagati per intero). La norma consente accordi al 30% soprattutto per facilitare piccole/medie imprese o situazioni in cui pochi creditori sono da gestire attivamente e gli altri verranno soddisfatti integralmente. Nota: L’accordo agevolato è uno strumento tecnico, la cui logica è: se l’impresa non chiede sacrifici ai creditori estranei (li paga integralmente), allora si può omologare l’accordo anche con solo il 30% di consensi degli altri – presumibilmente privilegiati o banche che accettano la ristrutturazione.
- Accordi ad efficacia estesa: se i creditori aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di una certa categoria omogenea (tipicamente, una categoria formata da banche o da obbligazionisti), l’imprenditore può chiedere che l’accordo sia esteso forzosamente anche ai creditori della stessa categoria che non hanno aderito . Questo meccanismo (già previsto dalla L. 40/2020 e ora nel CCII) è pensato ad esempio per evitare che una piccola minoranza di banche dissenzienti faccia saltare un accordo approvato dalla larga maggioranza del ceto bancario. Il tribunale, verificati i presupposti e che i dissenzienti siano trattati non peggio degli altri, può dunque estendere l’efficacia dell’accordo a questi ultimi.
Gli accordi di ristrutturazione possono includere tutti i tipi di crediti, anche i debiti fiscali e previdenziali, previa transazione fiscale (cioè una proposta specifica di pagamento parziale/rateale dei tributi e contributi, su cui si esprime l’Erario – v. infra) . L’obiettivo degli ARD può essere sia la continuazione dell’attività (risanamento in continuità) sia la dismissione di asset e liquidazione parziale. Non è richiesto come nel concordato di garantire una certa percentuale minima ai chirografari, ma ovviamente l’accordo deve essere conveniente per i creditori aderenti, altrimenti non lo firmerebbero, e non può peggiorare la condizione dei dissenzienti rispetto al fallimento (condizione di legge controllata dal giudice in sede di omologa).
Procedura: l’imprenditore (con i suoi legali e advisor) prima negozia con i principali creditori il contenuto dell’accordo. Raggiunto almeno il quorum (60%, 30% o 75% a seconda del tipo), deposita un ricorso in Tribunale chiedendo l’omologazione dell’accordo, allegando il testo sottoscritto e una serie di documenti (bilanci, elenco creditori, una relazione di un professionista attestatore). Infatti, anche negli accordi serve l’attestazione di un professionista indipendente, che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sottostante l’accordo . In più, se è un accordo “ordinario”, l’attestatore deve specificare che l’accordo assicura il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dal termine (come da legge) . Il tribunale, verificato che tutto sia regolare (quorum, corretta informazione ai creditori, parere positivo dell’attestatore, rispetto di eventuali obblighi verso estranei), omologa l’accordo con decreto. Da quel momento, l’accordo è efficace erga omnes secondo i termini pattuiti.
Vantaggi per il debitore: una volta depositato il ricorso per omologa, il debitore può chiedere al Tribunale misure protettive analoghe a quelle del concordato (sospensione o divieto di azioni esecutive individuali dei creditori) per il tempo necessario a perfezionare e omologare l’accordo. Il CCII infatti prevede il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore, su istanza dell’imprenditore connessa alla presentazione della domanda di omologa . Ciò consente di evitare che, durante le trattative o mentre si attende l’omologazione, qualche creditore “fuori dal coro” pignori beni compromettendo l’operazione. Inoltre, dalla pubblicazione del ricorso di omologa nel Registro delle Imprese, scattano analoghe protezioni (come l’inibitoria di acquisire prelazioni se non concordate).
Durante l’esecuzione dell’accordo, l’impresa rimane in mano all’imprenditore (non c’è spossessamento come nel fallimento). In alcuni casi però il tribunale nomina un Commissario Giudiziale per vigilare sull’esecuzione: ciò avviene se ci sono istanze di liquidazione giudiziale pendenti o se è necessario tutelare specifici interessi . Il commissario, se nominato, sorveglia il rispetto dei patti. Di solito comunque negli accordi semplici non è nominato nessuno, e l’imprenditore continua a dirigere l’azienda liberamente , salvo dover rispettare l’obbligo (introdotto dal CCII) di tenere informati i creditori sull’andamento del piano (ad es. relazioni periodiche ai firmatari dell’accordo).
Differenze rispetto al piano attestato: l’accordo di ristrutturazione formalizzato offre i benefici della sospensione delle azioni individuali (grazie alle misure protettive) e della vincolatività erga omnes (entro certi limiti) una volta omologato. Di contro, è meno riservato: la notizia dell’accordo viene iscritta nel Registro Imprese, e i creditori estranei possono opporsi all’omologa (il tribunale fissa un termine entro cui i non aderenti possono fare ricorso per contestare la convenienza o la regolarità). Inoltre, i costi aumentano (spese legali, eventuale commissario, contributo unificato etc.). In pratica, l’accordo è un ibrido: meno invasivo di un concordato, ma più strutturato di un accordo privato. Funziona bene se l’impresa è in crisi ma non ancora del tutto insolvente e riesce a trovare un’intesa con almeno una maggioranza qualificata di creditori, ad esempio con le banche e alcuni fornitori chiave, sopportando di dover comunque pagare per intero altri piccoli creditori.
Transazione fiscale e cram-down del Fisco: un aspetto cruciale negli accordi è il trattamento di Erario e INPS. Spesso l’impresa in crisi non può pagare integralmente imposte e contributi arretrati. Con il decreto correttivo D.Lgs. 83/2022 e il D.L. 69/2023, l’ordinamento consente ora di omologare accordi di ristrutturazione anche senza adesione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, a certe condizioni, introducendo di fatto un cram down fiscale. In particolare, l’art. 63 CCII come modificato e l’art. 1-bis del D.Lgs. 69/2023 (conv. L. 103/2023) stabiliscono che il tribunale può omologare l’accordo anche se Fisco e/o enti previdenziali non hanno aderito, purché: (i) l’accordo non sia meramente liquidatorio; (ii) il voto (o adesione) di tali enti sarebbe stato determinante per raggiungere le percentuali di legge (60% o 30%); (iii) gli altri creditori aderenti rappresentino almeno il 25% dei crediti totali (al netto di quelli erariali/previdenziali) oppure, se rappresentano meno, che ai crediti erariali/previdenziali venga riconosciuto almeno il 40% del loro importo (comprensivo di sanzioni e interessi) e comunque la dilazione proposta non ecceda 10 anni ; (iv) la proposta verso il Fisco/enti sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria , come asseverato dal professionista. Se queste condizioni sono soddisfatte, il giudice può omologare l’accordo nonostante il voto contrario del Fisco/INPS (il cosiddetto cram-down fiscale). Ad esempio, una recente sentenza del Tribunale di Vasto (11 dicembre 2024) ha applicato queste regole omologando un accordo nonostante il diniego dell’AdE, ritenendo che il piano fosse più vantaggioso della liquidazione e verificando che oltre il 25% di altri crediti aderenti c’era . Si tratta di una svolta notevole: in passato il Fisco aveva di fatto potere di veto, ora se la proposta è serio e il rifiuto appare irragionevole, si può procedere ugualmente. Ciò incoraggia i debitori a includere anche il Fisco nelle ristrutturazioni (presentando l’istanza di transazione fiscale, ossia la proposta di pagamento parziale/rateale ex art. 63 CCII) e a dimostrare, con l’attestazione, che stanno offrendo almeno quanto il Fisco otterrebbe in caso di fallimento. In caso di omologazione forzata, comunque, la legge tutela l’Erario prevedendo clausole risolutive automatiche: ad esempio, se il debitore non paga regolarmente le rate promesse al Fisco/INPS entro 60 giorni dalle scadenze, l’accordo si risolve di diritto . Questo incentiva il debitore a non venir meno agli impegni verso l’Erario, pena il crollo dell’accordo.
Riassumendo, l’accordo di ristrutturazione è indicato quando l’impresa ha prospettive di risanamento e vuole evitare il peso di un concordato (che prevede voti di tutti i creditori) ma le serve comunque una cornice legale per gestire la moltitudine di creditori. Se il numero di creditori è ristretto, invece, spesso si preferisce restare sul piano attestato per semplicità.
3.4. La Composizione Negoziata della Crisi – Introdotta in via d’urgenza col D.L. 118/2021 e ora organicamente disciplinata nel CCII (artt. 12-25 D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022), la composizione negoziata è uno strumento nuovissimo e peculiare. Si tratta di un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore, trovandosi in condizioni di squilibrio o insolvenza reversibile, chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nel tentativo di raggiungere un accordo con i creditori per superare la crisi . A differenza delle soluzioni viste sinora, la composizione negoziata non è di per sé un accordo con i creditori, ma un procedimento di assistenza alla negoziazione. Vediamone gli elementi essenziali:
- Presupposti per accedere: può accedere alla composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione (non c’è distinzione tra sopra o sotto soglia fallimentare), che si trovi in stato di crisi o insolvenza, oppure anche solo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile l’insolvenza (definizioni ex art. 2 CCII) . È richiesto inoltre che vi siano prospettive di risanamento dell’impresa (cioè la crisi non dev’essere senza rimedio) . Questo strumento è quindi finalizzato principalmente alla prevenzione: può essere attivato anche prima che l’impresa sia formalmente insolvente, basta che ci siano segnali di difficoltà e il risanamento sia ancora realisticamente perseguibile.
- Nomina dell’esperto: l’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma informatica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio), allegando informazioni sulla propria impresa, sui debiti, sulle cause della crisi e possibilmente un abbozzo di piano di risanamento. È previsto anche un test pratico di autodiagnosi sulla piattaforma, dove inserendo alcuni dati contabili l’imprenditore ottiene indici che misurano la sostenibilità del debito con i flussi futuri . Questo test non è vincolante ma orienta sulla situazione. L’istanza deve includere una sorta di check-list sul piano di risanamento previsto , cioè una scaletta di misure. Una commissione (presso la CCIAA regionale) nomina entro breve un esperto indipendente scelto da elenchi di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con esperienza) . Per le imprese più piccole (“sotto soglia”, quelle non fallibili, anche se la distinzione è sfumata ora) la nomina può essere fatta direttamente dal segretario generale della Camera di Commercio . L’esperto nominato è tenuto a criteri di indipendenza e imparzialità, e accetta l’incarico dopo aver esaminato una prima documentazione.
- Ruolo e attività dell’esperto: l’esperto agevola le trattative tra imprenditore e creditori, con l’obiettivo di individuare una soluzione per superare la crisi, eventualmente mediante il trasferimento dell’azienda o rami di essa, e preservando per quanto possibile i posti di lavoro . L’esperto convoca l’imprenditore per valutare se il risanamento appare ragionevolmente perseguibile; in caso positivo, convoca i principali creditori e altri soggetti interessati proponendo soluzioni o facilitando il dialogo . Importante: l’esperto non ha poteri sostitutivi, né decisionale. La negoziazione resta nelle mani dell’imprenditore : l’esperto non firma accordi al posto suo né impone piani ai creditori. Egli però con la sua autorevolezza “certifica” la credibilità dell’impegno dell’impresa e garantisce un confronto ordinato. Può suggerire soluzioni creative e far comprendere ai creditori che collaborare può dare un risultato migliore del fallimento del debitore. Tutte le parti coinvolte nella composizione negoziata operano sotto un vincolo di riservatezza rigorosa: notizie sull’impresa apprese nelle trattative non possono essere divulgate. Questo è cruciale: la procedura di per sé è confidenziale, mirata a evitare allarmismi sul mercato.
- Esito della composizione negoziata: il percorso si può concludere in vari modi. Idealmente, con la sottoscrizione di uno o più accordi stragiudiziali di ristrutturazione (potrebbe sfociare in un piano attestato o in accordi ad hoc con ciascun creditore, o in un accordo collettivo se possibile). In alternativa, potrebbe portare alla decisione di accedere a una procedura concorsuale vera e propria (ad es. l’imprenditore, con i consigli dell’esperto, valuta che serve un concordato preventivo e lo presenta). Oppure, se non si trovano soluzioni, la procedura si chiude senza accordo. In ogni caso, l’esperto redige una relazione finale in cui dà conto dell’attività svolta e delle possibili soluzioni emerse (se ve ne sono) . Questa relazione viene depositata e la composizione negoziata si archivia. Se non ha avuto successo e l’impresa è insolvente, l’imprenditore dovrà valutare se c’è da portare i libri in tribunale (richiedere la liquidazione giudiziale) o se esistono ancora strade.
- Misure protettive e incentivi: punto fondamentale: durante la composizione negoziata l’imprenditore può ottenere protezione contro le azioni dei creditori. Inizialmente, la procedura è solo negoziale, non comporta pendenze automatiche col tribunale . Però, se necessario per il buon esito delle trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive (e anche cautelari) sul suo patrimonio . In pratica, si può ottenere un decreto che blocca temporaneamente i creditori: dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel Registro delle Imprese, i creditori non possono acquisire o far valere garanzie né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari contro il debitore . Questa protezione ha inizialmente durata breve (fino 4 mesi, prorogabile a 12 in casi complessi) e necessita della successiva conferma da parte del giudice, dopo aver sentito le parti . Dunque, appena l’imprenditore deposita l’istanza e ottiene la pubblicazione, scatta uno standstill legale – nessun nuovo pignoramento o sequestro può colpirlo nel frattempo. Questa è una differenza enorme rispetto al passato: consente di negoziare “sotto scudo”, simile a quanto avviene col pre-concordato. Naturalmente il giudice potrà revocare o non confermare le misure se dall’atteggiamento del debitore o dall’assenza di concrete trattative emerge che è solo un modo dilatorio. Ma se l’imprenditore e l’esperto dimostrano serietà, il beneficio del time-out viene concesso. Inoltre, sotto certe condizioni il debitore in composizione negoziata può ottenere autorizzazioni dal tribunale per atti urgenti come finanziamenti prededucibili o vendite di beni non strategici, funzionali a portare avanti l’attività durante le trattative (artt. 18-22 CCII). Ciò evita che nel frattempo la situazione peggiori irreversibilmente.
- Sospensione degli obblighi patrimoniali civilistici: durante la composizione negoziata, l’azienda è temporaneamente esentata da alcuni obblighi del Codice Civile che altrimenti scatterebbero in presenza di perdite. Ad esempio, se emerge una perdita oltre 1/3 del capitale nelle società di capitali, di regola bisognerebbe ridurre il capitale o sciogliere la società (artt. 2447, 2482-ter c.c.). Ebbene, l’art. 20 CCII sospende tali obblighi di ricapitalizzazione durante la composizione negoziata . Ciò per dare respiro: l’imprenditore non è costretto immediatamente a liquidare la società per legge, può tentare prima la rinegoziazione protetta.
- Conclusione del percorso: come detto, se porta frutto, la composizione negoziata può sfociare in: (i) un contratto con uno o più creditori (ad esempio un accordo di moratoria o ristrutturazione fuori dalle procedure concorsuali, magari assistito dall’attestazione dell’esperto come piano di risanamento); (ii) un accordo di ristrutturazione “agevolato” ex art. 61 CCII (si può combinare: l’esperto aiuta a raccogliere le firme per arrivare al 30% e poi si presenta accordo in tribunale); (iii) un concordato preventivo (tradizionale, se serve coinvolgere tutti i creditori con un piano più complesso); (iv) nei casi estremi, se non c’è via d’uscita, l’imprenditore potrà optare per la liquidazione giudiziale ordinaria – in tal caso aver tentato la composizione può essere visto come un attenuante di responsabilità; (v) infine, vi è uno strumento speciale: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che può essere proposto solo se la composizione negoziata non ha prodotto soluzioni. Questo concordato semplificato non prevede voto dei creditori, ma solo l’omologazione giudiziale, per liquidare rapidamente i beni con un piano predisposto dal debitore. Ne parleremo più avanti.
In pratica, la composizione negoziata è un ombrello procedurale che aiuta l’imprenditore onesto e lungimirato a trattare con i creditori in modo protetto e strutturato, senza il peso dello stigma del fallimento imminente. È uno strumento moderno, ancora in fase di rodaggio (il 2023-2024 hanno visto molte nomine di esperti e primi casi di successo, ma anche situazioni di difficoltà). Il suo grande pregio è la flessibilità: non impone uno schema rigido di risanamento, lascia le parti libere di trovare soluzioni tailor-made (dalla rinegoziazione del debito, alla ricerca di un investitore, alla cessione dell’azienda). Dal punto di vista del debitore, aderire per tempo alla composizione negoziata può anche valere come esimente o attenuante di possibili responsabilità (come già accennato: se poi l’impresa fallisce, potrà dire “ho tentato tutto il possibile in modo tempestivo”). Non a caso, le linee guida ministeriali incoraggiano l’uso di questo strumento prima che sia troppo tardi.
3.5. Confronto riepilogativo tra strumenti stragiudiziali – A questo punto, può essere utile una tabella comparativa dei principali strumenti fin qui trattati (piano attestato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata), evidenziandone la natura, i requisiti di adesione e gli effetti:
| Strumento | Tipo | Adesione creditori necessaria | Ruolo del Tribunale | Caratteristiche ed effetti |
|---|---|---|---|---|
| Trattativa privata (accordo informale) | Extragiudiziale puro | 100% dei creditori con cui si tratta (serve consenso di ciascuno coinvolto) | Nessuno (accordi privati) | Massima riservatezza; flessibilità totale nei termini. Svantaggi: Nessuna protezione verso creditori non aderenti; rischio di revocatoria se l’impresa fallisce (atti a favore di alcuni creditori). Adatto a crisi moderate con pochi creditori disposti a cooperare. |
| Piano Attestato di Risanamento (PAR) | Stragiudiziale con attestazione | Nessuna maggioranza legale prefissata, ma occorre ottenere adesioni sufficienti da garantire il risanamento (tipicamente banche e fornitori principali) | Tribunale non coinvolto nell’approvazione (solo eventuale controllo postumo se si contesta l’esenzione revocatorie) | Piano di risanamento asseverato da esperto indipendente ; forma libera ma scritta e con data certa. Vantaggi: esenzione da revocatoria e da bancarotta preferenziale per atti in esecuzione del piano ; nessuna pubblicità obbligatoria. Svantaggi: non vincola i dissenzienti; nessuno stay automatico delle azioni esecutive; necessaria la buona fede di (quasi) tutti i creditori rilevanti. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti – ordinario | Ibrido stragiud.-giudiziale (omologazione) | ≥ 60% del totale dei crediti (quorum di legge). I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni (nessuna falcidia per loro) . | Omologato dal Tribunale (decreto). Tribunale verifica regolarità, fattibilità, rispetto condizioni per estranei e eventuali opposizioni. | Benefici: omologa vincola tutti i creditori aderenti secondo i patti; possibile stay delle azioni esecutive su richiesta ; sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione durante l’accordo . Possibile nomina di Commissario in casi particolari . Limiti: pubblicità dell’accordo (Registro Imprese); opposizioni possibili dai creditori estranei; obbligo di soddisfare integralmente i dissenzienti (non consente di tagliare il 100% del debito di chi non firma, a differenza del concordato). |
| Accordo di ristrutturazione – agevolato | Giudiziale (omologa) | ≥ 30% dei crediti . Di fatto utilizzabile se i non aderenti non subiscono decurtazioni (sono pagati cash o esclusi perché irrilevanti). | Omologa tribunale necessaria (come sopra). | Simile all’ordinario ma con quorum ridotto. Uso pratico: imprese medio-piccole dove pochi creditori principali (es. banche) decidono per tutti e i restanti crediti vengono pagati completamente. |
| Accordo di ristrutturazione – ad efficacia estesa | Giudiziale (omologa) | ≥ 75% dei crediti di una medesima categoria omogenea (es. 75% delle banche). | Omologa tribunale necessaria (verifica che ai dissenzienti della categoria non sia riservato trattamento inferiore a quello degli aderenti). | Consente di vincolare anche i creditori finanziari dissenzienti se costituiscono minoranza in quella classe. Vantaggio: risolve problema hold-out tra banche. Si può combinare con accordo ordinario o agevolato (ad esempio, 80% banche aderisce, 20% no: si estende comunque l’accordo alle banche dissenzienti). Non applicabile ai creditori diversi (non finanziari) se non formano categoria a sé stante. |
| Composizione negoziata della crisi | Stragiudiziale assistito | Volontaria: non richiede adesioni predeterminate per avviarsi. Obiettivo è trovare un accordo con quanti più creditori possibile (idealmente tutti quelli principali). | Tribunale coinvolto solo se richieste misure protettive o autorizzativi. Non vi è omologa finale, salvo si sbocchi in accordo o concordato formale. | Procedura riservata e flessibile: nomina di un esperto indipendente facilitatore ; possibilità di ottenere stay delle azioni (misure protettive) su semplice istanza ; durata in genere 3-6 mesi estensibili. Esiti possibili: accordi stragiudiziali (piani, moratorie) oppure accesso a concordato preventivo o accordo di ristrutturazione se necessario; in caso di fallimento successivo, la tempestiva composizione negoziata è elemento a favore del debitore (buona fede). Nessun voto né percentuali di legge, perché non impone nulla: tutto è consensuale. |
Come si evince, più si sale di livello (da sinistra a destra della tabella) più cresce l’intervento dell’autorità giudiziaria e la “forza” legale dell’accordo, ma diminuiscono la riservatezza e la semplicità. La composizione negoziata è un unicum perché è volontaria ma beneficiata dalla legge con lo scudo protettivo e l’intervento di un esperto terzo. Vale la pena sottolineare che gli strumenti non si escludono a vicenda: anzi, possono essere combinati in sequenza. Ad esempio, l’imprenditore può iniziare con una composizione negoziata; se durante le trattative capisce che raggiunge il 60% di consensi, può convertire la procedura in un accordo di ristrutturazione da omologare. Oppure, può predisporre un piano attestato per il risanamento e, contemporaneamente, depositare in tribunale un ricorso per concordato “in bianco” solo per congelare i creditori, eseguire il piano e poi rinunciare al concordato se il piano riesce (prassi a volte vista in passato). La scelta va calibrata sul caso concreto, anche valutando i costi/benefici di ciascuna opzione.
Nei capitoli successivi entreremo nelle soluzioni concorsuali vere e proprie – concordato preventivo e liquidazione giudiziale – che rappresentano le vie da percorrere quando la situazione è troppo grave per risolversi privatamente o con strumenti soft, oppure quando già un creditore ha “alzato il cartellino rosso” avviando un’azione giudiziaria.
4. Procedure concorsuali per la crisi d’impresa: concordato preventivo e liquidazione
Quando l’indebitamento è tale che non si può gestire solo con accordi volontari, oppure quando è già partita una procedura esecutiva o concorsuale (ad esempio un’istanza di fallimento da parte di un creditore), l’imprenditore può (e in certi casi deve) ricorrere alle procedure concorsuali previste dalla legge. Le principali, nel nostro ordinamento, sono il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento). Esiste anche il citato concordato semplificato post-composizione negoziata, che toccheremo. Vediamo come funzionano e come difendersi in tali contesti, sempre dal lato del debitore.
4.1. Il Concordato Preventivo – Il concordato preventivo è la procedura concorsuale mediante la quale l’imprenditore in crisi (anche insolvente, ma desideroso di evitare il fallimento) propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione parziale, sotto il controllo del tribunale e con l’approvazione dei creditori stessi. È una procedura volontaria (la chiede l’imprenditore) e negoziale, perché implica il voto dei creditori. Il concordato può essere di due tipi principali:
- Concordato in continuità aziendale: quando l’impresa, pur ridimensionata o ristrutturata, continua la propria attività (in via diretta, mantenendo la gestione, oppure in via indiretta, cedendo l’azienda a un terzo che la prosegue). L’obiettivo è evitare la dissoluzione del business, preservando valore e posti di lavoro.
- Concordato liquidatorio: quando invece si prevede la cessazione dell’attività e la mera liquidazione del patrimonio per distribuire il ricavato ai creditori. In sostanza, è una alternativa al fallimento ma guidata dal debitore (o con una sua proposta), con eventuali benefici come un apporto esterno di risorse e condizioni meno draconiane.
Il CCII (artt. 84-120) disciplina ampiamente il concordato. Esaminiamo gli aspetti chiave utili al debitore:
Accesso al concordato (“filing”): L’imprenditore presenta un ricorso al Tribunale con cui domanda l’ammissione al concordato, allegando la proposta, il piano e la documentazione richiesta (bilanci ultimi 3 anni, elenco creditori, inventario beni, ecc., più la relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità del piano). In alternativa, può presentare un ricorso “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco): un’istanza iniziale breve in cui dichiara di voler accedere al concordato e chiede un termine (fino a 60-120 giorni prorogabili) per depositare poi piano e proposta definitiva. Questa seconda modalità è spesso usata per guadagnare tempo e bloccare subito le azioni esecutive (“ombrello protettivo” immediato), finalizzando il piano con calma. Nel caso di Maschi & Filiere S.r.l., se vediamo che da soli non riusciamo a mettere d’accordo tutti i creditori e c’è rischio di aggressioni, potremmo presentare un concordato “in bianco” per congelare la situazione e poi cercare un investitore o predisporre un piano di ristrutturazione da far votare.
Effetti della domanda di concordato: Dal momento in cui viene pubblicato il ricorso per concordato nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (art. 54 CCII, ex art. 168 L.F.) – è uno stay automatico. Inoltre, i creditori chirografari non possono acquistare cause di prelazione su beni del debitore (niente ipoteche dell’ultimo minuto). Questo protegge la par condicio. Se erano pendenti procedure esecutive individuali, vengono sospese (non si possono proseguire aste, ecc.). Attenzione però: i creditori privilegiati (garantiti) godono di qualche facoltà in più di proseguire, a seconda dei casi (ad es. il codice prevede che su istanza si possano autorizzare pagamenti di creditori strategici o continuare rapporti essenziali). In generale comunque il concordato blocca il dissesto in quell’istante, evitando corse dei creditori. Per il debitore questo è vitale: può continuare la gestione senza l’assillo di pignoramenti (sotto vigilanza del commissario).
Gestione dell’impresa durante il concordato: Diversamente dal fallimento, nel concordato l’imprenditore rimane alla guida dell’impresa (gestione “in proprio”), ma sotto la sorveglianza di un Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale. Questi è tipicamente un commercialista o figura con competenze concorsuali, che vigila sull’operato del debitore e riferisce ai creditori e al giudice. Il debitore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice delegato (per evitare che svenda beni o pregiudichi la massa). Ma la gestione ordinaria prosegue, e anzi, se è un concordato in continuità, l’azienda continua a lavorare, fatturare, pagare forniture correnti (le quali saranno in prededuzione, ossia pagate integralmente come spese di procedura).
Contenuto della proposta di concordato: Il debitore deve presentare un piano dettagliato su come intende soddisfare i creditori. Può prevedere classi di creditori (aggregazioni omogenee: ad esempio separare fornitori, banche chirografarie, obbligazionisti, etc.) e trattamenti differenziati tra le classi, ma all’interno di ciascuna classe i crediti di pari grado vanno trattati paritariamente. Può proporre percentuali di pagamento ridotte (falcidia del credito) e/o dilazioni nel tempo. Può anche prevedere soddisfazioni non monetarie (ad esempio, attribuzione ai creditori di azioni o di beni in conto pagamento). Nel concordato liquidatorio puro, la legge (art. 84 CCII) impone che vi sia un apporto di risorse esterne tale da aumentare almeno del 10% l’attivo liquidabile e che i creditori chirografari ottengano almeno il 20% del loro credito . In altre parole, se la proposta concordataria liquida solo i beni esistenti, dev’esserci qualcun altro (soci o terzi) che immette liquidità fresca pari ad almeno il 10% di quel valore, e comunque i creditori non garantiti non possono ricevere meno del 20% del dovuto . Queste soglie servono a evitare concordati liquidatori “troppo penalizzanti”. Nota: Nel concordato in continuità, invece, non c’è una percentuale minima di legge per i chirografari ; è ammesso anche pagare meno del 20% se è giustificato dal piano industriale, purché comunque nessun creditore riceva meno che in un fallimento (principio di convenienza). L’importante è che la proposta concordataria offra ai creditori almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione fallimentare (c.d. test di convenienza, di cui diremo a breve) .
Il piano deve essere corredato dalla relazione di un attestatore indipendente (anche qui un professionista qualificato, diverso da eventuali consulenti che hanno redatto il piano) che attesta sia la veridicità dei dati, sia la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Ad esempio, l’attestatore deve dichiarare che se in caso di fallimento i chirografari prenderebbero 10%, il concordato ne offre 30% e dunque è migliorativo. Oggi la legge, come modificata dal correttivo 2022, prevede che se nessun creditore contesta la convenienza, il tribunale omologa senza sindacare nel merito; se invece un creditore dissenziente fa opposizione sulla convenienza, il giudice dovrà valutare effettivamente il confronto col fallimento . In ogni caso, grava sul debitore l’onere di dimostrare analiticamente la preferibilità del piano rispetto alla liquidazione (calcolando l’attivo liquidabile e i riparti in ipotesi fallimentare, vs attivo/recupero in concordato).
Apertura e votazione: Una volta depositato il piano, se il tribunale lo ritiene ammissibile (controllo formale e di fattibilità sommaria), emette decreto di apertura del concordato preventivo. Da quel momento: nomina il Commissario; fissa una data per l’adunanza dei creditori (o le modalità di voto se avviene per via telematica o scritto) di solito entro 4-6 mesi; e impartisce eventuali provvedimenti (sospensione procedure, autorizzazioni per atti urgenti, ecc.). I creditori vengono informati del contenuto della proposta e del piano (ricevono una relazione del commissario e dell’attestatore). Hanno diritto di voto tutti i creditori ammessi al passivo (salvo i privilegiati se soddisfatti integralmente, che sono “irrituali”). La maggioranza richiesta è, per legge, la maggioranza dei crediti ammessi al voto (calcolata in percentuale sul valore). Se ci sono classi, serve anche la maggioranza delle classi (il meccanismo è complicato: ogni classe approva o respinge, serve che la maggioranza numerica delle classi approvi e in ogni caso almeno il 50% dei crediti totali). Ogni classe ha diritto di veto in continuità, il che significa che la mancata approvazione di una classe può bloccare tutto, salvo la possibilità di cram-down interclassi se almeno una classe approva (ma su questo la legge è restrittiva).
Supponendo che la maggioranza approvi la proposta, il tribunale passa all’omologa. Se nessuno oppone, di solito omologa rapidamente. Se ci sono opposizioni (es. creditori dissenzienti che lamentano violazioni di legge o convenienza insufficiente), il tribunale le esamina e decide se omologare comunque o rigettare. Al termine, con decreto di omologazione, il concordato diviene vincolante per tutti i creditori anteriori (anche per chi ha votato no). Se invece i creditori non approvano la proposta, il tribunale dichiara il fallimento (o archivia e i creditori potranno chiederlo subito).
Esecuzione del concordato: Dopo l’omologazione, il debitore deve dare attuazione al piano: pagare le percentuali promesse entro i tempi, eventualmente sotto la sorveglianza di un liquidatore giudiziale nominato per vendere i beni (se è un liquidatorio) o del commissario (se in continuità). Se il debitore non adempie, il concordato può essere risolto su istanza dei creditori e si aprirà la liquidazione giudiziale.
Vantaggi del concordato per il debitore: Il concordato, se ben concepito, evita la dichiarazione di fallimento e permette al debitore di conservare l’azienda operativa, se in continuità. Anche nel liquidatorio, offre la chance di coinvolgere investitori e di ottenere l’esdebitazione più rapidamente. Importante per gli amministratori: la legge considera l’apertura del concordato come circostanza che esclude la punibilità per il reato di bancarotta semplice relativo al ritardo dell’istanza di fallimento. In altre parole, l’amministratore che chiede il concordato non potrà poi essere accusato di aver aggravato il dissesto ritardando la procedura, a meno di condotte fraudolente. Inoltre, se il concordato va a buon fine, l’azienda può proseguire epurata da una parte dei debiti (nella continuità) oppure l’imprenditore, se è anche debitore personale (tipo socio illimitatamente responsabile), potrà beneficiare dell’esdebitazione residua. Da ultimo, nel concordato il debitore può ottenere la moratoria fino a un anno per pagare i creditori privilegiati (se il piano lo prevede e l’attestatore certifica che i loro beni in garanzia non si deprezzano nel frattempo), cosa utile per diluire esborsi.
Svantaggi/rischi: Il concordato è una procedura onerosa e complessa. Vi sono costi di commissario, attestatore, legali, e una rigidità formale notevole. Inoltre, l’esito è incerto perché dipende dal voto dei creditori. Se i creditori (o classi) lo bocciano, l’impresa quasi certamente finisce in liquidazione fallimentare. Bisogna saper negoziare anche nel concordato: spesso si cercano preventivamente lock-up agreements (impegni di voto) con i maggiori creditori per avere ragionevole certezza di approvazione. In passato, molti concordati sono stati usati in modo opportunistico da debitori per “tirare a campare” offrendo percentuali minime, cosa che ha reso i creditori diffidenti; oggi con la regola del confronto con il fallimento e con l’abolizione di soglie minime in continuità (ma comunque col controllo giudiziario) si mira a concordati di qualità, dove il vantaggio per i creditori sia chiaro.
Caso pratico: Maschi & Filiere S.r.l. potrebbe utilizzare il concordato se, ad esempio, trova un investitore disposto a rilevare l’attività a condizione di pulirla dai debiti pregressi. Poniamo che arrivi un compratore che offre €1 milione per acquisire l’azienda come going concern, somma che sarà distribuita ai creditori, i quali vantano €5 milioni di crediti. Si potrebbe proporre un concordato in continuità indiretta: la società cede l’azienda all’investitore (che ne continua l’attività, salvando i dipendenti), incassa €1 milione e lo destina a pagare i creditori in una certa percentuale (ad esempio 20%). I creditori votano su questa proposta. Se approvata e omologata, ogni creditore chirografo riceverà il 20% ed è soddisfatto per legge; i debiti residui sono inesigibili. La società rimane come scatola vuota ma ha evitato il fallimento; l’imprenditore magari resta socio minoritario della newco acquirente. Uno scenario del genere può essere win-win: creditori ottengono più che nella liquidazione spezzatino (per ipotesi, il perito stima che vendendo i macchinari e asset singolarmente si sarebbe ricavato solo €500k, quindi 10%), l’imprenditore salva l’avviamento dell’azienda tramite il passaggio di mano, e i posti di lavoro sono preservati (l’investitore assume i dipendenti). Questo è un tipico concordato con continuità indiretta.
4.2. Concordato semplificato (ex art. 25-sexies CCII) – Merita una breve menzione il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Introdotto inizialmente dal D.L. 118/2021 come misura transitoria, è ora previsto nel Codice come opzione solo all’esito infruttuoso di una composizione negoziata. In pratica, se l’imprenditore ha tentato la composizione negoziata ma non ha raggiunto un accordo con i creditori, egli può presentare direttamente (entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto) una proposta di concordato liquidatorio al tribunale, senza passare per il voto dei creditori. Il tribunale convoca comunque i creditori per eventuali osservazioni, ma non c’è una votazione: decide il giudice se omologare, valutando che la proposta sia migliore per i creditori della liquidazione giudiziale . È dunque un concordato senza voto, “semplificato” in questo senso (ma in realtà può essere anche più duro, perché i creditori non possono opporsi numericamente, possono solo fare contestazioni tecniche). Ovviamente, essendo senza voto, la legge pone criteri stringenti: deve essere liquidatorio puro, con distribuzione integrale dell’attivo secondo le cause di prelazione (a parte eventuali apporti esterni per i chirografari). Il tribunale omologa solo se ritiene soddisfatto il test di convenienza rispetto al fallimento. Nella pratica, questo strumento è pensato come exit strategy rapida: invece di nominare un curatore per la liquidazione giudiziale, si lascia al debitore di proporre lui la liquidazione con un piano (magari individuando già acquirenti per beni) e un liquidatore concordatario. Non essendoci voti, il rischio di ostruzionismi di creditori è eliminato, ma il tribunale sarà molto attento a evitare abusi (ad esempio, soci che cercano di riprendersi beni per poco etc.). Per il nostro focus, diciamo che il debitore dovrebbe vedere il concordato semplificato come un’ultima spiaggia per evitare le complessità del fallimento, solo dopo aver provato la negoziazione assistita.
4.3. La Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento) – Se nessuna delle soluzioni di cui sopra va in porto, o se la situazione è di conclamata insolvenza e i creditori (o il pubblico ministero) perdono la pazienza, si arriva alla liquidazione giudiziale, nuova forma di procedura concorsuale prevista dal CCII che ha preso il posto del vecchio fallimento (il termine “fallimento” è ora riservato alle sole persone fisiche insolventi in ambito civile, per le imprese si parla di liquidazione giudiziale). Per semplicità, nei discorsi useremo a volte “fallimento” essendo ancora di uso comune.
La liquidazione giudiziale è la procedura d’ufficio che porta allo spossessamento dell’imprenditore e alla liquidazione coattiva di tutto il patrimonio sotto il controllo del tribunale, nominando un curatore che amministra i beni e ripartisce il ricavato ai creditori secondo le regole legali. Dal punto di vista del debitore, subire una liquidazione giudiziale è evidentemente l’esito meno desiderabile, perché perde la gestione dell’azienda e vede la propria impresa avviarsi alla dissoluzione. Tuttavia, in certe situazioni può diventare inevitabile. È importante per l’imprenditore conoscere come comportarsi se riceve un’istanza di fallimento o se capisce che la sua insolvenza è irreversibile.
Quando si apre la liquidazione giudiziale? Su ricorso di un creditore, o su istanza dello stesso debitore (anche se raramente l’imprenditore chiede la propria liquidazione, può accadere per liberarsi da tormenti e accedere all’esdebitazione), oppure su iniziativa del Pubblico Ministero (in caso di insolvenze che toccano interesse pubblico, ad es. frodi). Il tribunale accerta lo stato di insolvenza (l’incapacità strutturale di adempiere regolarmente alle obbligazioni). Bastano inadempimenti gravi: ad esempio protesti, pignoramenti non soddisfatti, debiti scaduti rilevanti. Se l’imprenditore non ha alternative (tipo: non ha depositato un concordato o un accordo di ristrutturazione in tempo), il tribunale con sentenza dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Effetti per il debitore: La sentenza di apertura spoglia l’imprenditore (o gli amministratori, se società) della gestione del patrimonio: i beni dell’azienda e dell’imprenditore vengono affidati al Curatore nominato. Cessa ogni attività salvo il curatore decida di esercitarla provvisoriamente per valorizzare l’azienda. Gli amministratori perdono i poteri (pur dovendo collaborare col curatore nel fornire documenti, informazioni; hanno obblighi di consegna contabilità e beni). Si apre la procedura concorsuale in senso stretto: i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo, il giudice delegato (figura che sovrintende legalmente) esamina le domande e forma lo stato passivo, quindi il curatore procede a liquidare i beni (vendite all’asta o trattativa autorizzata) e dopo mesi/anni ripartisce i ricavi secondo l’ordine dei privilegi (pagando prima creditori prededotti, poi privilegiati, infine chirografari in percentuale se resta qualcosa). Al termine, il tribunale chiude la procedura. La società viene cancellata (se era soggetto collettivo).
Implicazioni pratiche per l’ex imprenditore: Con la liquidazione giudiziale, l’ex imprenditore perde il controllo ma non tutti i mali vengono per nuocere: paradossalmente, se egli era anche garante dei debiti aziendali o debitore per confusione di patrimoni, può trovarsi a beneficiare dell’esdebitazione. Infatti, il CCII prevede che il debitore persona fisica (ad esempio un socio illimitatamente responsabile o un imprenditore individuale fallito) possa ottenere l’esdebitazione di tutte le obbligazioni residue non soddisfatte, una volta chiusa la procedura, purché abbia cooperato lealmente e non vi siano ragioni ostative (reati gravi, atti in frode, ecc.). L’esdebitazione è concessa dal Tribunale come provvedimento che “libera” il fallito dai debiti residui, permettendogli il cosiddetto fresh start . Nel caso di società, la società si estingue e i crediti insoddisfatti muoiono con essa (i soci di S.r.l./S.p.A. non ne rispondono). Quindi, per quanto possa sembrare controintuitivo, a volte accettare la dichiarazione di fallimento e puntare a una rapida chiusura può essere preferibile a trascinarsi a lungo: il fallimento pulisce la situazione e consente di ripartire a chi se lo può permettere.
Detto ciò, la liquidazione giudiziale comporta gravi conseguenze: – Dal lato patrimoniale, l’imprenditore perde i beni aziendali, e se è impresa individuale o socio illimitato, anche i beni personali (casa, auto – salvo quelli impignorabili per legge). – Dal lato giuridico, si aprono possibili azioni di responsabilità: il curatore può esperire l’azione di responsabilità contro gli amministratori se hanno violato i doveri ed è derivato danno (ad es. continuando ad aggravare i debiti oltre la soglia di sostenibilità). Abbiamo visto in sezione 2 come la prosecuzione illegale dell’attività in perdita possa generare un danno quantificato con il criterio della differenza dei patrimoni netti . La Cassazione ha di recente confermato condanne personali di amministratori che continuarono l’attività nonostante la perdita integrale del capitale, aggravando il dissesto, e ha ribadito che anche gli amministratori non operativi rispondono per omessa vigilanza . Il curatore fallimentare (ora liquidatore giudiziale) è tenuto per legge a valutare se ci sono azioni risarcitorie contro gli ex amministratori, sindaci o anche soci (ad es. per pagamenti infragruppo indebiti). Quindi, un fallimento spesso trascina con sé anni di contenziosi postumi. – Sul piano penale, la sentenza di fallimento attiva la competenza del tribunale penale per eventuali reati di bancarotta. Se l’imprenditore o gli amministratori hanno commesso irregolarità (distrazione di beni, falsificazione di bilanci, pagamento preferenziale di taluni creditori a scapito di altri, mancata tenuta delle scritture, ecc.), il curatore le segnala e la Procura può procedere per bancarotta fraudolenta o semplice. Le pene sono gravi (per la fraudolenta patrimoniale si va da 3 a 10 anni di reclusione). Tuttavia, se l’amministratore ha agito diligentemente e la bancarotta è solo frutto di sfortuna o errore onesto, non avrà problemi penali: la bancarotta semplice punisce comportamenti come l’aver aggravato la crisi per negligenza, ma se uno può mostrare di aver tentato il risanamento per tempo (es. attivando per davvero la composizione negoziata, il concordato, etc.), difficilmente verrà accusato di questo reato. La Cassazione Penale, ad esempio, ha chiarito (sent. n. 36683/2025) che anche gli amministratori di fatto possono rispondere di reati tributari e che la società può essere coinvolta ex D.Lgs. 231/2001 per alcuni reati fiscali , segnalando l’importanza di una gestione trasparente. In generale, l’apertura di fallimento rende quasi automatiche indagini sui reati fallimentari: se sei stato corretto non hai nulla da temere, ma se hai fatto “magheggi” verrai molto probabilmente scoperto.
Cosa può fare il debitore durante la fase di istruttoria pre-fallimentare? Se viene notificata un’istanza di fallimento da un creditore, l’azienda ha la possibilità di opporsi e difendersi. Prima cosa: verificare se il debito è realmente dovuto, o se è contestabile. Un’opposizione sul merito del credito può prendere tempo. Seconda cosa: se l’insolvenza c’è, il debitore può cercare di convertire la procedura in qualcos’altro. Il CCII prevede che fino all’udienza pre-fallimentare, l’imprenditore possa depositare un ricorso per concordato preventivo o per omologazione di un accordo di ristrutturazione, e in tal caso la dichiarazione di fallimento è sospesa in attesa di vedere l’esito di quella soluzione (salvo istanze del PM per frodi). Quindi, un’ottima tattica difensiva è: presentare un concordato in bianco prima o all’udienza fallimentare. Ciò automaticamente blocca il fallimento e sposta la situazione sul binario concordatario. I creditori istanti potranno lamentarsi, ma la legge dà priorità alla soluzione concordata se c’è serietà. Dunque, mai lasciarsi fallire passivamente: se c’è anche solo una chance di predisporre un piano, va colta. Il tribunale ovviamente valuterà che il ricorso non sia abusivo (cioè presentato solo per dilazione senza prospettive): però anche un concordato con offerta modesta ma seria può essere preferito al fallimento.
Se invece la situazione è compromessa e non si ha alcuna proposta valida, a volte il male minore è persino aderire al fallimento. Collaborare col tribunale, magari negoziando col creditore istante il mancato opposizione in cambio di qualcosa (es. consegna immediata beni, ecc.). La “resa” coordinata può evitare aggravio di responsabilità. Ad esempio, se l’azienda è decotta, forzare un concordato fittizio per prendere tempo potrebbe esporre gli amministratori a rimproveri di aggravamento del dissesto.
4.4. Riepilogo delle procedure concorsuali – Proponiamo una tabella di raffronto conciso tra concordato preventivo (continuità e liquidatorio), concordato semplificato e liquidazione giudiziale:
| Procedura | Chi la attiva | Coinvolgimento creditori | Organi della procedura | Esito sull’impresa | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Concordato preventivo in continuità | Debitore (volontario) | Creditori votano per classi e percentuali (nessuna soglia minima di pagamento chirografi, ma test convenienza obbligatorio) | Commissario giudiziale (vigilanza); giudice delegato; attestatore (fuori organi) | L’impresa prosegue l’attività, direttamente o tramite cessione a terzi (continuità indiretta). Debiti pregressi ristrutturati come da piano; l’azienda può uscirne risanata se il piano riesce. | Richiede piano industriale credibile. Nessun minimo 20% se continuità, ma necessaria convenienza > liquidazione . Possibile falcidia anche dei privilegiati se classe approva (tranne lavoratori/IVA per legge). |
| Concordato preventivo liquidatorio | Debitore (volontario) | Creditori votano (maggioranza valore >50%). È previsto apporto esterno ≥10% attivo e soddisfacimento chirografi ≥20% . | Commissario giudiziale; giudice delegato; attestatore indipendente. | Cessazione attività e vendita dei beni. L’impresa di regola viene liquidata (anche se formalmente non viene cancellata finché non eseguito tutto). | Alternativa “ordinata” al fallimento: il debitore supervisiona la liquidazione tramite un piano. Deve offrire almeno 20% ai chirografari per legge , salvo concordato minore. Creditori privilegiati vanno pagati per intero salvo rinunce concordate. |
| Concordato semplificato (post-negoziazione) | Debitore (dopo composizione negoziata fallita) | Nessun voto dei creditori; creditori solo consultati/opposizioni. | Liquidatore nominato dal Tribunale per eseguire; giudice delegato. (Non c’è commissario prima, perché non c’è voto). | Liquidazione rapida dei beni sotto controllo giudice. L’azienda cessa o viene venduta intera se offerta. | Procedura speciale senza voto. Omologa solo se creditori ottengono ≥ quanto in fallimento . Usata per evitare fallimento quando accordo stragiudiziale non è stato possibile. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Creditore, PM o debitore stesso (in dissesto conclamato) | Nessun voto: creditori presentano insinuazioni e vengono soddisfatti secondo legge (ordine privilegi). Possono costituire comitato dei creditori consultivo. | Curatore (amministra e liquida); giudice delegato; tribunale fallimentare (decreti di vendita, ecc.); eventuale comitato creditori. | L’impresa cessa e viene spogliata dei beni. Se possibile, curatore può esercitare provvisoriamente l’azienda per venderla come un tutto (es. affitto d’azienda e cessione). Alla fine la società si estingue (o se impresa individuale, imprenditore viene liberato dai debiti residui se onesto). | Procedura concorsuale d’ufficio classica. Implica spesso azioni contro amministratori (responsabilità) e possibili sanzioni personali (bankruptcy crimes). Durata variabile (in medie imprese spesso 2-5 anni). Debitore persona fisica può chiedere esdebitazione a fine procedura per ricominciare pulito. |
Dal punto di vista del debitore/imprenditore, la preferenza è sempre per le soluzioni che preservano valore e controllo (concordato in continuità > concordato liquidatorio > fallimento). Tuttavia, occorre essere realistici: non sempre l’azienda è salvabile. Una scelta saggia, a volte, è optare subito per una liquidazione concordata (concordato liquidatorio con offerte di acquisto) anziché ostinarsi a proseguire un’attività decotta dissipando ulteriormente patrimonio – ciò eviterebbe anche responsabilità per tardiva richiesta di procedura.
Esempio conclusivo: se Maschi & Filiere S.r.l., nonostante tutti gli sforzi, non trova investitori e la crisi peggiora (macchinari fermi, dipendenti licenziati, magazzino obsoleto), l’amministratore dovrebbe evitare di accumulare altri debiti inutilmente e potrebbe, responsabilmente, depositare istanza di liquidazione giudiziale auto-dichiarativa. Questo porrebbe fine all’agonia: un curatore venderà gli asset rimasti e distribuirà quel che c’è. L’amministratore potrà così beneficiare del fatto di aver collaborato (evitando imputazioni per bancarotta preferenziale, perché non ha sprecato risorse negli ultimi mesi per pagare qualcuno a discapito di altri, e per bancarotta semplice, avendo subito attivato la procedura quando la continuità non era più ipotizzabile). I soci andranno incontro alla perdita del capitale investito, ma eviteranno rischi ulteriori. Soprattutto, se nessun accordo era possibile, aver insistito avrebbe peggiorato il passivo (ad es. interessi, more, sanzioni che continuano a maturare).
5. Focus: Strategie di difesa per il debitore nelle diverse situazioni
Ricapitoliamo ora, in forma di linee guida pratiche, cosa può fare un imprenditore-debitore per difendersi nelle varie situazioni in cui può trovarsi. Ci riferiremo sempre al caso “Maschi & Filiere S.r.l.” come esempio prototipico.
5.1 Se l’azienda è in difficoltà ma non insolvente (crisi iniziale)
Siamo in quella zona grigia in cui l’impresa fatica a pagare tutti puntualmente, magari ha qualche ritardo con il Fisco o con alcuni fornitori, ma sta ancora producendo ricavi e potrebbe risollevarsi con interventi correttivi. Qui la parola d’ordine è: giocare d’anticipo. Come difendersi?
- Analisi interna e piano di emergenza: Appena emergono i segnali (indici in peggioramento, tensione di cassa, fatture in scaduto oltre il normale), gli amministratori devono attivare un’analisi approfondita con l’aiuto di consulenti. Bisogna stimare l’ammontare reale del debito, distinguendo i creditori per tipologia e importanza (chi non si può far arrabbiare? quali pagamenti si possono magari differire?). Redigere un cash flow previsionale per i mesi successivi aiuta a capire se è crisi temporanea (poi entrano pagamenti clienti capienti) o se si avvita. In parallelo, predisporre un piano di emergenza: ad esempio taglio di spese voluttuarie, blocco straordinari, vendita di qualche cespite non essenziale per fare cassa, ecc. Questa reazione immediata spesso può evitare il peggio.
- Comunicare con le banche: Se ci sono linee di credito bancarie, è utile informare proattivamente la banca della temporanea difficoltà e magari chiedere una rimodulazione del debito prima di andare in default con una rata. Le banche apprezzano la trasparenza: potrebbero concedere una breve moratoria o consolidare l’esposizione. Attenzione a non bruciare credibilità: se si promette un rientro, lo si deve rispettare.
- Evitare violazioni gravi verso Fisco/INPS: Non pagare l’IVA o le ritenute è “pericoloso” per vari motivi (sanzioni, segnalazioni d’allerta, reati). Se proprio c’è da scegliere chi pagare e chi ritardare (cosa che teoricamente non si dovrebbe fare, ma nella prassi di crisi succede), conviene privilegiare gli adempimenti fiscali e contributivi minimi per evitare soglie di reato. Ad esempio, assicurarsi di versare l’IVA almeno fino alla soglia di €5.000 se possibile, o pagare una parte di contributi per restare sotto €15.000 di arretrato (se con dipendenti) . Ciò può prevenire guai peggiori. Inoltre, se ci sono cartelle esattoriali già emesse, valutare subito la rateizzazione: con un piano di rate AER attivo, l’agente non procede all’esecuzione. Dal 2025, come visto, è possibile ottenere piani fino a 120 rate anche per importi notevoli, presentando idonea documentazione di difficoltà . Ad esempio, ottenere un piano decennale per €200k di cartelle consente di pagare solo €1.667 al mese, un sollievo di cassa rispetto all’ansia di un pignoramento immediato.
- Attivare la Composizione Negoziata (se serve): Se dagli indici interni o addirittura da segnalazioni (es. arriva una lettera di allerta dall’INPS o Agenzia Entrate) appare che la crisi rischia di degenerare, il debitore può “giocare la carta” della composizione negoziata tempestivamente. Fare ciò prima che i creditori perdano la fiducia è fondamentale. Ad esempio, Maschi & Filiere, avendo visto calare liquidità, potrebbe già nominare un esperto via Camera di Commercio e mettersi sotto tutela negoziale, ottenendo subito misure protettive. Così i fornitori non potranno attaccare l’azienda per qualche mese mentre si studia un piano. Questa mossa, come spiegato, viene considerata segno di buona gestione e blocca le azioni individuali . Va preparata per bene (bisogna allegare i documenti richiesti ed essere onesti nel test).
In sintesi: agire prima che la crisi diventi conclamata è la migliore difesa. Ciò massimizza le opzioni disponibili (si può ancora salvare la continuità) e minimizza i rischi di responsabilità per gli amministratori (potranno sempre dire di aver fatto tutto il possibile per prevenire il dissesto).
5.2 Se l’azienda è in insolvenza e i creditori iniziano azioni esecutive
Poniamo che Maschi & Filiere ormai non paghi più molti debiti scaduti, i fornitori mettono in mora, qualcuno ha già ottenuto un decreto ingiuntivo. La situazione è di insolvenza di fatto. Come difendersi?
- Valutare una procedura concorsuale volontaria immediata: In questa fase, aspettare può solo peggiorare le cose (salvo un miracolo all’orizzonte, tipo un pagamento cliente straordinario). Quindi l’amministratore dovrebbe considerare seriamente di presentare un ricorso per concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione prima che i creditori ottengano pignoramenti o presentino istanza di fallimento. Ad esempio, un concordato in bianco depositato tempestivamente permette di congelare tutto. Ci vuole, però, quantomeno uno straccio di piano su cui basare la mossa: non è lecito depositare il ricorso solo per prendere tempo e poi farlo decadere senza motivo. Ma spesso un concordato in bianco è usato proprio per guadagnare qualche mese e definire un’offerta agli investitori o ai creditori.
- Opporsi legalmente alle esecuzioni quando possibile: Se un fornitore pignora un macchinario, l’azienda può verificare se ci sono estremi per un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (magari il decreto ingiuntivo è stato notificato male, o il bene pignorato è funzionale all’attività e si può chiedere la sostituzione). Questo però è un tatticismo temporaneo. Più efficacemente, se c’è un concordato depositato, tutti i pignoramenti sono sospesi per legge. Quindi la via concorsuale volontaria è più efficace di mille opposizioni formali.
- Negoziare “standstill” informali con i principali creditori: In parallelo alla preparazione di una procedura, l’imprenditore può riunire i creditori chiave e dire: “Sto per presentare un concordato o sto nominando un esperto per la composizione; vi chiedo nel frattempo di non agire individualmente, perché sto cercando una soluzione che massimizzi il rimborso per tutti”. A volte i creditori, sapendo che c’è un processo in corso, accettano di aspettare qualche settimana in più. Specie le banche: queste preferiscono un concordato ben fatto a un fallimento (perché magari in concordato incassano più in fretta). Formalizzare un accordo di moratoria breve (anche solo un documento in cui i creditori dichiarano di sospendere le azioni per X giorni) può essere utile.
- Richiedere al tribunale misure protettive mirate: Questo si riallaccia al concorso volontario. Ad esempio, nell’ambito di una composizione negoziata, il debitore può chiedere il blocco dei soli creditori che minacciano esecuzioni, mantenendo tranquilli gli altri. Le misure protettive infatti possono essere generali o limitate. Se solo uno o due creditori aggressivi creano problema, si può chiedere di inibire quelli. Anche nel concordato con riserva, si può contestualmente chiedere al giudice di sospendere specifici pignoramenti in corso (c’è base normativa per sospendere asta su istanza del debitore una volta presentato il concordato).
- Proteggere i beni fondamentali tramite atti leciti: Prima che la situazione degeneri troppo, l’imprenditore può pensare a mettere al riparo alcuni asset strategici attraverso strumenti legali ma attenti a non incorrere in revocatoria o bancarotta fraudolenta. Ad esempio, costituire una newco e trasferirvi contratti o beni essenziali può essere illecito se fatto a prezzo vile e per sottrarre ai creditori (sarebbe revocabile e pure bancarotta). Però concordare con un investitore la vendita (a valori di mercato) di un ramo d’azienda prima che venga disperso in fallimento può essere un’operazione sensata e anche non revocabile se contestuale a trattative di risanamento. La legge consente in composizione negoziata, con autorizzazione del tribunale, di cedere beni non strategici anche prima di un concordato, proprio per evitare perdita di valore. Quindi muoversi nel lecito: chiedere autorizzazioni quando servono e non fare atti occulti.
- Non aggravare ulteriormente il debito: Sembra ovvio, ma nella disperazione molti imprenditori fanno il contrario (continuano ad acquistare a credito sperando di recuperare). Se sai di essere insolvente, fermati dall’assumere nuove obbligazioni che sai di non poter onorare: ogni fornitura che prendi sapendo che finirai in fallimento poi potrà portare a accuse di frode ai creditori (contrarre debiti senza prospettiva di pagarli è una forma di malafede). Meglio ridurre l’attività al minimo, informare magari i fornitori critici che si è in ristrutturazione (evitando così che continuino a fornire inconsapevolmente). Questo rientra nel dovere di corretta gestione in pendenza di insolvenza.
5.3 Se è stata depositata un’istanza di fallimento (o liquidazione giudiziale)
Questo è uno scenario di “difesa” classico: un fornitore o la stessa Agenzia Entrate Riscossione (che può chiedere fallimento per debiti tributari ingenti) ha depositato il ricorso in tribunale per far dichiarare fallita Maschi & Filiere S.r.l. L’udienza è tra poche settimane. Cosa può fare il debitore per difendersi?
- Esaminare la legittimità dell’istanza: Prima cosa, affidarsi a un legale concorsualista e verificare se ci sono motivi formali per respingere l’istanza. Ad esempio: l’istante è realmente creditore per importo sopra soglia (€30k per imprese, di solito)? Il credito è certo, liquido ed esigibile? Esiste uno stato d’insolvenza oggettivo? Talvolta si può obiettare che l’insolvenza non sussiste (magari c’è illiquidità momentanea ma attivo > passivo, etc.). Se ci sono elementi, il legale preparerà una memoria difensiva e chiederà di rigettare il ricorso.
- Pagare o transare col creditore istante: Se l’istanza viene da un solo creditore (es. un fornitore da €100k), una via rapida di difesa è trovare un accordo con quell’istante prima dell’udienza. Magari pagandogli una parte del dovuto o dando garanzie, in cambio che rinunci alla richiesta di fallimento. Questo spegne il fuoco. Ovviamente serve liquidità o un mediatore. Spesso i creditori presentano istanza come leva per essere pagati: se li soddisfi (almeno in larga parte), poi non hanno più interesse a fallirti. Attenzione però: soddisfare integralmente un creditore e trascurarne altri, se poi l’azienda comunque fallisce, è un pagamento preferenziale revocabile (entro 6 mesi) e potenzialmente bancarotta preferenziale. Tuttavia, pagare l’istante per salvarne 100 altri può valere il rischio. Diciamo che è un trade-off: idealmente, se si paga l’istante e poi si riesce a risanare l’impresa, bene. Se invece era solo rinvio e si fallisce più tardi, quel pagamento potrà essere revocato e l’amministratore criticato per aver sottratto risorse alla massa. Una via migliore: proporre all’istante di aderire a un accordo di ristrutturazione o concordato, così il suo credito verrà pagato come parte di un piano collettivo e non è preferenza isolata.
- Presentare un concordato preventivo subito prima dell’udienza: Lo abbiamo detto ma lo ribadiamo: il CCII consente al debitore di depositare fino all’ultimo momento (anche il giorno prima dell’udienza prefallimentare) un ricorso di concordato preventivo o una domanda di omologa di accordo, e ciò sospende la procedura di fallimento. Il tribunale dovrà attendere l’esito del concordato. Questa è spesso la mossa risolutiva per difendersi dal fallimento. Naturalmente, se l’hai fatto solo per prendere tempo e poi lasci decadere il concordato, il tribunale e i creditori se ne ricorderanno – e potresti incorrere in bancarotta semplice per aggravamento. Quindi va utilizzata con l’intenzione genuina di portare avanti una soluzione. Comunque, statisticamente molti fallimenti sono evitati grazie al concordato in extremis che poi però si trasforma in fallimento un anno dopo; almeno quel lasso di tempo a volte consente vendite migliori di asset o arrivo di investitori.
- Chiedere il differimento dell’udienza per trattative: Se per qualche motivo non si riesce a preparare subito un concordato, il legale può chiedere al giudice un breve rinvio dell’udienza prefallimentare, adducendo che sono in corso trattative per una soluzione. Spesso i giudici concedono 30-60 giorni se intravedono spiragli (anche perché il CCII li incoraggia a favorire strumenti di composizione negoziale). Ad esempio, se l’imprenditore dimostra di aver avviato una composizione negoziata (istanza nominato esperto), il tribunale potrebbe attendere l’esito prima di fallire l’azienda.
- Se tutto fallisce, prepararsi alla dichiarazione di fallimento: Se appare inevitabile (creditori tanti e feroci, azienda finita, nessun piano fattibile), allora la “difesa” consiste nel mitigare i danni successivi. L’amministratore dovrà: mettere in sicurezza i libri e le scritture (nessuna sparizione o manomissione: reato grave! Al contrario, ordinare e consegnare tutto subito al curatore), redigere un elenco dei creditori e consegnarlo, custodire i beni ed evitare qualsiasi movimento (anche prelevare l’auto aziendale può essere contestato come distraente). In pratica, predisporre una collaborazione esemplare col curatore sin dal primo giorno. Ciò tornerà utile sia per evitare misure personali (tipo dichiarazioni di inibizione all’esercizio d’impresa, che i giudici possono emettere per 2-10 anni se ravvisano cattiva condotta), sia per chiedere poi l’esdebitazione a chiusura (che viene negata se il fallito non ha collaborato). Inoltre, se l’impresa ha beni e contratti in corso, l’amministratore può suggerire al curatore possibili acquirenti o soluzioni per massimizzare il valore – questo è apprezzato e può essere considerato come circostanza attenuante in eventuali giudizi di responsabilità.
5.4 Se l’azienda è sovraindebitata ma il titolare è un privato (no fallimento)
Un piccolo inciso: finora abbiamo considerato S.r.l. e S.p.A., soggette a fallimento. Ma se l’attività fosse individuale o una S.r.l. così piccola da non superare mai le soglie di fallibilità (ricavi < €200k, attivo < €300k, debiti < €500k), allora i creditori non possono chiederne il fallimento. Tuttavia, esiste il problema del sovraindebitamento. In tal caso, il titolare d’impresa non fallibile ha a disposizione le procedure ex Legge 3/2012 (ora integrate nel CCII come “composizione della crisi da sovraindebitamento”): il concordato minore, il piano di ristrutturazione del consumatore (se è persona fisica non imprenditore), e la liquidazione controllata. Questi strumenti sono analoghi ai concordati e fallimenti, ma calibrati su piccoli debitori. La difesa quindi passa per la presentazione di un concordato minore (che è un mini-concordato per chi non fallisce, con richieste più flessibili come minimo 10% ai chirografi ) oppure per la liquidazione controllata volontaria (che consente anche qui l’esdebitazione). Non entriamo nei dettagli, ma ricordiamo che un imprenditore persona fisica oberato da debiti personali (es. perché la banca gli escute la fideiussione) può ricorrere a queste procedure per ottenere la liberazione dai debiti e rifarsi una vita, piuttosto che restare perseguitato dai creditori a vita.
6. Domande frequenti (FAQ) e casi pratici
Di seguito proponiamo una serie di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni in tema di azienda indebitata e difesa del debitore, e alcuni scenari concreti con la relativa soluzione.
D1: La mia S.r.l. ha debiti fiscali molto alti e non riesco a pagarli. Posso ottenere una riduzione di queste tasse dovute?
R: Sì, ma non extra-giudizialmente su base individuale, a meno che il Governo introduca misure straordinarie (come le rottamazioni delle cartelle esattoriali). Nell’ordinario, l’Agenzia delle Entrate non può spontaneamente abbuonare imposte dovute per legge. Puoi però chiedere una rateizzazione (come detto, fino a 10 anni con prova di difficoltà). Se invece accedi a una procedura concorsuale (accordo di ristrutturazione o concordato), puoi proporre una transazione fiscale, cioè pagare parzialmente imposte e contributi. Grazie alle modifiche normative recenti, il tribunale può omologare la transazione fiscale anche se l’Agenzia delle Entrate vota contro, purché la proposta sia conveniente e rispetti certe soglie . Quindi in un concordato, ad esempio, potresti offrire di pagare – poniamo – il 50% del debito fiscale in 5 anni, se il piano dimostra che in fallimento il Fisco prenderebbe meno. Se il Fisco rifiuta ma la proposta rispetta i criteri di legge, il giudice può confermarla comunque . Fuori dalle procedure, l’unica speranza di riduzione è attendere definizioni agevolate varate per legge (negli ultimi anni ce ne sono state: “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà, “rottamazione-ter/quater” per scontare sanzioni e interessi su cartelle, ecc.). Tieniti aggiornato sulle norme fiscali annuali.
D2: Ho dato una fideiussione personale per i debiti bancari della mia azienda. Se l’azienda non paga e va in concordato o fallimento, la banca poi può rivalersi su di me?
R: Sì. Il concordato o fallimento della società non libera i garanti personali (fideiussori) dall’obbligo. La banca, se l’azienda non paga integralmente il suo credito, potrà chiedere a te come fideiussore la differenza. Questo vale anche se in concordato la banca accetta il 60%: per il restante 40% può escutere la garanzia personale. Ci sono però un paio di eccezioni/soluzioni: (i) talvolta nel concordato il garante persona fisica propone ai creditori di rinunciare ad agire contro di lui in cambio di un miglior trattamento nel concordato (si chiama accordo di esonero: non vincola i non aderenti, ma se la banca vota a favore, di solito accetta di limitarsi a quanto prende in procedura). (ii) Tu come fideiussore, se sei sovraindebitato personalmente a causa di ciò, potrai accedere al procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (introdotto dal CCII): in pratica, se non hai patrimonio né reddito per pagare, potresti chiedere al giudice di essere liberato dai debiti residui post-fallimento della società, senza pagare nulla, dimostrando la tua buona fede e che almeno parte del debito societario è stato soddisfatto . Questa è una novità per dare chance ai piccoli garanti di non restare indebitati a vita per colpa del fallimento altrui. Devi però essere persona fisica meritevole (non aver ricavato utilità dal debito, ecc.). In generale, come garante devi prepararti al peggio: se vedi che l’azienda è in crisi, cerca un dialogo con la banca per ristrutturare il debito anche lato tuo (es. trasformare la garanzia in un mutuo personale più lungo, se hai reddito).
D3: I soci di una S.r.l. rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti sociali?
R: Per definizione, no, la S.r.l. è a responsabilità limitata. Dunque i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio della società, non sulle case o conti dei soci. Fanno eccezione: (i) i casi in cui i soci abbiano prestato garanzie personali (allora rispondono come garanti, vedi sopra); (ii) i casi di illeciti gravi dei soci che portino a revocatoria o azione di responsabilità: ad esempio, se i soci hanno svuotato la società prima del fallimento, il curatore può agire contro di loro (c.d. “azione di responsabilità per direttori di fatto” se decidevano loro). (iii) In S.r.l., se un socio unico non ha adempiuto all’obbligo di versare i conferimenti o di ricapitalizzare a seguito di perdite quando avrebbe dovuto, potrebbe essere chiamato a rispondere nei limiti di ciò. Ma in generale, se tu sei socio di capitale non coinvolto nella gestione, il peggio che ti succede è perdere i soldi investiti nelle quote. Diverso è per i soci amministratori: quelli in quanto amministratori possono avere responsabilità (ma tecnicamente per la carica, non per essere soci). Attenzione: in casi eccezionali la giurisprudenza ammette la “responsabilità illimitata per abuso della personalità giuridica”, cioè i creditori possono chiedere di “schermare” la società e colpire i soci se questa era usata come schermo per frodare (ad es. società sottocapitalizzata che fa solo debiti e poi fallisce, con soci che l’hanno eterodiretta). È rarissimo, però, e molto difficile da dimostrare.
D4: La banca mi ha revocato il fido e chiesto rientro immediato di tutto lo scoperto. Così rischio di saltare. Posso oppormi?
R: Dipende dal contratto. Quasi sempre i contratti di conto corrente con affidamento prevedono che la banca possa revocare “ad nutum” (cioè a sua discrezione) dandoti un preavviso scritto (di solito 15 giorni). Se la banca ha rispettato i termini contrattuali, non c’è modo legale di impedirle di revocare. Tuttavia, puoi trattare: spesso la revoca arriva perché sei sconfinato o sei in ritardo nel rimborso rate di altri prestiti. Puoi presentare un piano di rientro graduale, chiedendo ad esempio: “Non posso rientrare 100k subito, ma vi rientro in 10k al mese per 10 mesi, nel frattempo non chiudete il conto”. La banca potrebbe accettare se convinta che così recupera più facilmente. Se invece la revoca è già effettiva, la somma diventa esigibile: se non la paghi, la banca potrà portare in tribunale un decreto ingiuntivo e pignorare (o se ipotecario, iniziare forecloser su ipoteca). Unico scudo legale è se entri in concordato o altro: in quel caso la banca resta bloccata come gli altri creditori chirografari. Tieni presente che la banca, in caso di insolvenza, di solito è uno dei creditori che spingono per soluzioni concordatarie: preferisce un concordato (dove magari prende 40% subito) a un fallimento incerto. Quindi, se la banca è il creditore principale, coinvolgila e formula una proposta di accordo o concordato riservato a loro (nel CCII c’è un istituto chiamato accordo di ristrutturazione ad hoc con intermediari finanziari dove basta il 75% delle banche per estendere a tutte ).
D5: Ho scoperto che uno dei fornitori ha già fatto un’istanza di fallimento contro la mia azienda senza nemmeno avvisarmi bene. Posso evitarlo all’ultimo minuto?
R: Sì, come detto, hai fino all’udienza per presentare un concordato preventivo o far risultare un accordo. Il tribunale deve privilegiare l’alternativa concordataria. Quindi se ti muovi subito e depositi un ricorso per concordato (anche senza piano dettagliato all’inizio), l’udienza fallimentare verrà sospesa. Dovrai poi sviluppare il concordato. In parallelo, come sopra, potresti cercare un accordo col fornitore istante: se ha fatto istanza vuol dire che è esasperato, ma se ora vede che lo pagherai (anche parzialmente) in concordato, potrebbe allentare. Attenzione anche a possibili vizi nella notifica dell’istanza: per legge, l’istanza di fallimento va notificata con un certo preavviso. Se non hai ricevuto nulla e lo scopri per vie traverse, informati presso la cancelleria: magari la notifica è viziata e puoi far valere questo (il giudice rimanderà l’udienza per rinotifica, guadagnando tempo prezioso).
D6: Che succede ai contratti (affitti, leasing, forniture) se attivo un concordato o fallisco?
R: Nel concordato, i contratti pendenti (non ancora completamente eseguiti da entrambe le parti) rimangono in vigore, salvo il debitore chieda l’autorizzazione a scioglierli o sospenderli. Ad esempio, se hai un contratto di leasing oneroso e nel piano non ti serve, puoi chiedere al tribunale di scioglierti dal leasing: la controparte avrà diritto a un indennizzo pari al danno (che sarà un credito concorsuale). Se invece il contratto è essenziale (es. un affitto di capannone), continui a eseguirlo regolarmente e i crediti maturati post-concordato (canoni correnti) saranno in prededuzione (pagati al 100%). In fallimento, invece, il curatore decide entro un certo termine se subentrare nei contratti o scioglierli. Tipicamente, i leasing li scioglie (restituisce il bene al concedente, che insinua il credito residuo); i contratti di affitto di azienda se fruttuosi li mantiene (magari per cedere l’azienda in esercizio provvisorio). Ogni contratto fa storia a sé, ma sappi che l’apertura di concordato non determina automatica risoluzione dei contratti in corso – clausole contrattuali che dicano “se vai in concordato, il contratto si risolve” sono nulle per legge. Invece, la clausola di risoluzione in caso di fallimento è valida e opera, perché l’art. 169-bis L.F. (ora CCII) tutela i contratti in corso solo nel concordato, non nel fallimento.
D7: Dopo il fallimento, potrò aprire un’altra attività o sarò segnato a vita?
R: Dipende. La legge non impedisce a un ex fallito di tornare a fare l’imprenditore (previa esdebitazione magari). Tuttavia, ci sono conseguenze: c’è l’interdizione legale temporanea (non puoi gestire altre imprese durante la procedura, e spesso per qualche anno, salvo autorizzazione del giudice). Inoltre, le banche e fornitori potrebbero diffidare di te se sanno del fallimento passato (ma qui entra in gioco l’esdebitazione: se ottieni dal tribunale la liberazione dai debiti e la chiusura “buona fede”, puoi cercare di ripulire la tua reputazione). L’Italia ha abolito il pubblico registro dei falliti, quindi non c’è più una “lista nera” permanente; però le informazioni creditizie private magari riportano eventi negativi per un tot di anni. Se il fallimento è chiuso senza colpa e tu riesci a ripartire, hai pieno diritto. Alcune professioni (es. amministratore di società quotate, ruoli fiduciari) richiedono di non aver subìto fallimenti, ma per la PMI comune non ci sono preclusioni di legge. In breve: no, non sei segnato a vita giuridicamente, ma devi ricostruire sul piano economico e di fiducia.
D8: La mia azienda è piccola, ho debiti 100k con fornitori e 50k con banca, nessuno con lo Stato; posso fare a meno di procedure costose e gestirmela da solo magari chiudendo la società?
R: Chiudere semplicemente la società (liquidazione volontaria) con debiti pendenti non li estingue: i creditori resterebbero insoddisfatti e potrebbero chiedere il fallimento entro un anno dalla cancellazione. Se davvero la dimensione è piccola (e magari non fallibile), puoi tentare un accordo stragiudiziale: offrire ai creditori un pagamento parziale (es. “vi do il 30% in 12 mesi, e chiudo la ditta”). Fatti assistere da un legale per formalizzare accordi di saldo e stralcio in cui i creditori dichiarano di rinunciare al resto a fronte del parziale pagamento. Se tutti firmano e rispetti i patti, avrai risolto senza tribunale. Il rischio è se uno non ci sta: quello può saltare l’accordo globale e trascinarti in tribunale. Valuta anche la procedura di composizione negoziata o di concordato minore (se sei sotto soglia): sono pensate proprio per piccole realtà. Il concordato minore è meno costoso di uno ordinario e non richiede percentuali minime (solo il 10% ai chirografi) . Spesso però, per 150k di debiti, andare in tribunale può costare troppo in relazione. In tali casi, la convenienza di un piano stragiudiziale è alta. L’importante è formalizzare bene e poi estinugere la società solo dopo aver definito i debiti, altrimenti rischi l’azione post-chiusura.
D9: Cos’è l’azione di responsabilità contro gli amministratori e quando viene esercitata?
R: È l’azione con cui la società (o, in caso di fallimento, il curatore a nome della massa dei creditori ) chiede il risarcimento dei danni causati dagli amministratori per violazione dei loro doveri. Nel contesto di crisi, la situazione tipica è questa: la società fallisce con un buco molto più grande di quello che aveva quando già si era manifestata la perdita di capitale sociale. I creditori, tramite il curatore, contestano agli amministratori di aver continuato ad operare oltre la soglia di sostenibilità, incrementando i debiti. L’art. 2486 c.c. impone all’amministratore, una volta sciolta la società (anche di fatto, per perdita totale capitale), di conservare il patrimonio e non aggravare la situazione. Se lo fa, è responsabile verso la società. La riforma del CCII ha introdotto un criterio semplificato di calcolo del danno: la differenza tra patrimonio netto alla data in cui avrebbero dovuto attivarsi e patrimonio netto alla data della liquidazione/fallimento (cd. criterio dei netti patrimoniali) . Le Sezioni Unite della Cassazione già nel 2015 avevano tracciato la linea . Quindi, se vieni accusato, il curatore dirà: “dovevi chiudere nel 2023 con patrimonio netto -100, hai chiuso nel 2025 con patrimonio netto -500, hai causato 400 di danno”. Tu potrai difenderti provando che quelle perdite in più non sono colpa tua (es. crisi di mercato imprevedibile, atti di terzi, etc.). In Italia negli ultimi anni molti amministratori sono stati condannati. Ad esempio, Cassazione novembre 2025 (ordinanza, rif. Avv. Tedesco) ha confermato la condanna di un intero CDA per mala gestio: contabilità inattendibile e prosecuzione illegale dopo perdita capitale, imponendo risarcimento di oltre 1,2 milioni . Anche i non esecutivi sono stati ritenuti colpevoli per non aver vigilato . Quindi, l’azione di responsabilità è un pericolo concreto se non gestisci bene la crisi. Difendersi ex ante = attivarsi tempestivamente (così diventa difficile dire che hai aggravato colpevolmente).
D10: Il fallimento della mia S.r.l. è stato chiuso da poco. Sono un po’ traumatizzato: c’è qualcosa che posso fare per ripartire pulito?
R: Se la procedura ha soddisfatto almeno parzialmente i creditori (non serve completamente, basta quel che è venuto fuori), puoi chiedere l’esdebitazione per la società (non serve, la società si estingue e i debiti residui restano insoddisfatti senza eredi) e per te come garante o coobbligato. Se tu non sei personalmente fallito (perché eri socio di S.r.l., quindi non fallibile), i creditori insoddisfatti tecnicamente potrebbero ora rivalersi su di te solo se avevi garanzie personali. Se non ne avevi, tu personalmente non hai debiti. Se li avevi (es. hai garantito il leasing e quello rimane in parte impagato), tu ora sei sovraindebitato: valuta di rivolgerti all’OCC (organismo composizione crisi) per una procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. È una specie di “perdono giudiziale” dei debiti per chi non ha niente da dare, con l’obbligo morale di versare qualcosa se nei 4 anni successivi la tua condizione migliora. In parallelo, cura la riabilitazione reputazionale: spiega ai futuri partners che hai fatto tutto il possibile (se è vero). Dal punto di vista legale, se non hai commesso reati, sei libero: l’importante è imparare dall’esperienza e dotare la nuova attività (se ne farai un’altra) di quegli strumenti di controllo che magari mancavano nella precedente.
7. Conclusione
La gestione di un’azienda indebitata in Italia richiede un difficile equilibrio tra tutela dei propri diritti e adempimento dei propri doveri. Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, “difendersi” non significa sfuggire furbescamente ai creditori, bensì proteggere il valore aziendale e il proprio patrimonio dagli effetti disordinati della crisi, utilizzando gli strumenti legali per arrivare a una soluzione equa e sostenibile. Come abbiamo visto, l’ordinamento offre molteplici vie: dalle trattative bonarie agli accordi attestati e omologati, dalle procedure negoziate in camera caritatis fino al concordato preventivo pubblico e, in ultimo, la liquidazione concorsuale.
Una costante che emerge dalle recenti riforme (specie quelle attuate entro il 2022-2024) è l’insistenza sulla tempestività e sulla trasparenza. Il debitore che agisce tempestivamente – dotandosi di assetti adeguati, cogliendo i segnali di allarme e imboccando per tempo la strada del risanamento o, se necessario, della liquidazione – viene in certo modo premiato: può evitare gli esiti più traumatici e anche vedere alleggerite le proprie responsabilità personali. Viceversa, l’imprenditore che persevera nell’inerzia o nell’occultamento della crisi viene oggi punito con meccanismi che spaziano dalle azioni di responsabilità civile alle sanzioni penali. Difendersi bene, dunque, significa anzitutto affrontare la realtà della crisi, pianificare e dialogare.
La nostra ipotetica Maschi & Filiere S.r.l. avrebbe opportunità di salvezza se i suoi amministratori seguissero passo passo le indicazioni qui esposte: monitoraggio costante, coinvolgimento di esperti, coinvolgimento responsabile dei creditori nelle soluzioni e utilizzo calibrato di ogni strumento disponibile (dal piano attestato per mettere in sicurezza atti di risanamento, fino al concordato per tagliare i debiti eccedenti). In ogni fase, deve prevalere l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale quando possibile (perché un’azienda “viva” paga comunque i creditori meglio di un’azienda morta), oppure – se il salvataggio non è praticabile – l’obiettivo di massimizzare il valore di realizzo in maniera ordinata e condivisa, anziché bruciarlo in una gara caotica tra creditori armati di decreti ingiuntivi.
Chiudiamo con un incoraggiamento pragmatico: le leggi da sole non fanno miracoli, ma mettono nelle mani dell’imprenditore gli strumenti per risolvere situazioni altrimenti disperate. Usarli con competenza (magari affiancati da un buon consulente legale e finanziario) può fare la differenza tra un’azienda che esce dal tunnel ristrutturata e competitiva, e una che scompare travolgendo con sé imprenditori, lavoratori e creditori. La difesa del debitore in fondo coincide con la gestione virtuosa della crisi: le due facce di una stessa medaglia.
Fonti
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 e successive modifiche) – artt. 12-25 (composizione negoziata), 56 (piani attestati di risanamento), 57-64 (accordi di ristrutturazione), 84-120 (concordato preventivo), 121-147 (liquidazione giudiziale). [Disponibile su Normattiva]
- Codice Civile – artt. 2086 c.c. (assetti adeguati e dovere di attivarsi per prevenire la crisi), 2446-2447 e 2482-bis/ter (riduzione capitale per perdite), 2486 c.c. (obblighi dell’amministratore dopo scioglimento della società e criteri di liquidazione del danno) , 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori verso società e creditori sociali).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – ora abrogata e sostituita dal Codice della Crisi dal 15/7/2022, ma rilevante per la giurisprudenza pregressa e transitoria.
- D.L. 118/2021 convertito in L.147/2021 – Introduzione della composizione negoziata e concordato semplificato .
- D.Lgs. 83/2022 – “Correttivo” al CCII per recepire Direttiva UE 2019/1023, ha introdotto accordi di ristrutturazione agevolati (30%), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, estensione forzata ai tributari in taluni casi, ecc. .
- D.Lgs. 136/2024 – “Correttivo ter” al CCII, in vigore dal 28/9/2024, ha integrato la disciplina dei piani attestati (art.56 CCII) ampliando le informazioni obbligatorie e equiparato i revisori ai sindaci per doveri di allerta .
- D.L. 69/2023 conv. L.103/2023 – Ha innovato la transazione fiscale, consentendo il cram-down del Fisco negli accordi e concordati (art.1-bis), con condizioni (almeno 25% altri creditori aderenti o 40% di pagamento al Fisco, proposta conveniente rispetto a fallimento) .
- D.Lgs. 110/2024 – Riforma delle dilazioni fiscali dal 2025, aumentato numero rate per piani di rateizzo AER .
- Cassazione Civile – Sez. Unite n.9100/2015: principi su responsabilità ex art.2486 c.c. e criteri di quantificazione del danno da continuazione attività .
- Cassazione Civile – ordinanza 8 novembre 2025 (in LexCED, a cura Avv. Tedesco) – conferma condanna amministratori S.r.l. per mala gestio: criteri differenza netti patrimoniali, responsabilità non esecutivi, inapplicabilità business judgment rule su omesso versamento IVA .
- Tribunale di Vasto, sentenza 11.12.2024 – Omologa accordo di ristrutturazione con cram down fiscale , applicando art.57 e 63 CCII e art.1-bis D.Lgs.69/2023: soddisfatto test convenienza, accordo omologato nonostante diniego AdE.
- Linee Guida CNDCEC 2024 sui Piani Attestati di Risanamento – Principi di attestazione aggiornati .
La tua azienda che produce, affila o commercializza maschi filettatori, filiere, strumenti per filettatura, maschi speciali, utensili per filettatura CNC, set filettatura e attrezzature di precisione sta affrontando una situazione grave di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, affila o commercializza maschi filettatori, filiere, strumenti per filettatura, maschi speciali, utensili per filettatura CNC, set filettatura e attrezzature di precisione sta affrontando una situazione grave di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, fornitori, banche, leasing o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai subendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore della filettatura industriale richiede materiali molto costosi, trattamenti termici complessi, rettifiche di precisione, affilature, rivestimenti PVD/CVD, qualità elevatissima e scorte importanti.
Una riduzione della liquidità o un ritardo nei pagamenti dei clienti può trasformarsi in una crisi immediata.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata, protetta e rimessa in equilibrio, se intervieni con decisione e strategia.
Perché un’Azienda di Maschi e Filiere Finisce in Debito
Le cause più frequenti includono:
• aumento dei costi di HSS, metallo duro, rivestimenti PVD/CVD e trattamenti termici
• lavorazioni esterne costose: rettifica, affilatura, brasatura, tempra
• ritardi nei pagamenti da parte di officine meccaniche, tornerie e integratori
• magazzino immobilizzato tra maschi finiti, semilavorati e barre grezze
• investimenti necessari in macchine CNC, rettificatrici, affilatrici e strumenti di misura
• costi energetici e logistici elevati
• taglio o revoca improvvisa dei fidi bancari
• commesse speciali che richiedono cicli lunghi e incassi tardivi
Il problema non è la mancanza di lavoro: è la mancanza di liquidità.
I Rischi per un’Azienda di Filettatura con Debiti
Se non intervieni subito, rischi:
• pignoramento dei conti correnti aziendali
• blocco totale delle linee di credito
• sospensione delle forniture di materiali fondamentali
• decreti ingiuntivi e azioni esecutive
• sequestro di utensili, macchinari, semilavorati e materiali
• fermo delle lavorazioni di affilatura, rettifica e tempra
• ritardi nelle consegne ai clienti più importanti
• rischio reale di fermo totale dell’attività
Una crisi finanziaria può paralizzare l’azienda nel giro di pochissimi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
- Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato puoi sospendere pignoramenti, fermare richieste aggressive delle banche, evitare blocchi dei conti correnti e gestire i fornitori più pressanti.
Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si pianifica la ripartenza. - Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso i debiti includono interessi illegittimi, sanzioni calcolate male, somme duplicate, errori della Riscossione, costi bancari irregolari e persino posizioni prescritte.
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata. - Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni più efficaci includono:
• rateizzazioni fino a 120 rate
• accordi di rientro con fornitori critici
• rinegoziazione dei fidi bancari
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• utilizzo delle definizioni agevolate se disponibili
L’obiettivo è recuperare liquidità e non interrompere la produzione. - Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
In casi più gravi si possono usare strumenti come PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti, accordi di ristrutturazione, concordato minore o, solo in casi estremi, la liquidazione controllata.
Queste procedure bloccano TUTTI i creditori, sospendono pignoramenti e permettono di pagare solo una parte dei debiti mantenendo viva l’azienda e tutelando l’imprenditore. - Proteggere produzione, scorte e macchinari
Per un’azienda di maschi e filiere è essenziale proteggere metallo duro, barre HSS, utensili finiti, rettificatrici, affilatrici e strumenti di precisione.
È fondamentale evitare sequestri, mantenere attivi i fornitori chiave e garantire puntualità nelle consegne.
Se la produzione si ferma, i debiti esplodono. Se rimane attiva, l’azienda può recuperare.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco completo dei debiti e dei creditori
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario del magazzino (maschi, filiere, barre, inserti, grezzi)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e programmazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare in 24–72 ore
• Blocco dei creditori in 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione in 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria in 3–12 mesi
Le misure protettive possono partire già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione significativa del debito
• Protezione di macchinari, scorte e utensili
• Trattative efficaci con banche e fornitori
• Continuità produttiva e commerciale assicurata
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti o atti giudiziari
• Accendere nuovi debiti per coprire quelli vecchi
• Pagare un creditore lasciando indietro gli altri
• Lasciare avanzare pignoramenti o precetti
• Affidarsi a società “miracolose” senza competenza reale
Ogni errore rende la crisi più difficile da risolvere.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa del debito aziendale
• Blocco immediato delle azioni dei creditori
• Piani di ristrutturazione personalizzati
• Attivazione degli strumenti giudiziari più efficaci
• Trattative mirate con fornitori, banche e Agenzia Riscossione
• Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di maschi e filiere non significa essere destinati alla chiusura.
Con la strategia giusta puoi:
• fermare immediatamente i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• proteggere produzione e magazzino
• salvare l’azienda e il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.