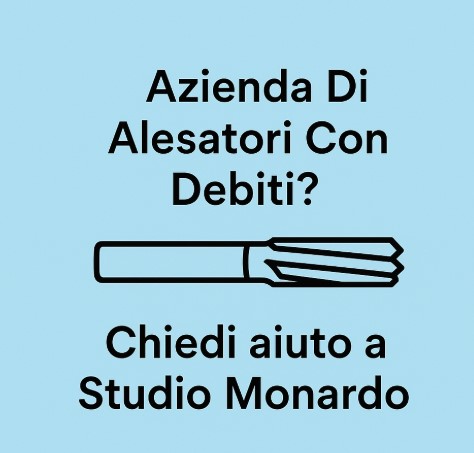Se gestisci un’azienda che produce, distribuisce o affila alesatori, alesatori di precisione, alesatori modulari, alesatori regolabili, utensili per alesatura CNC, alesatori in metallo duro, HSS o rivestiti, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la continuità della tua attività è seriamente a rischio.
Il settore delle lavorazioni di precisione richiede utensili altamente tecnici, materiali costosi, tolleranze micrometriche, macchinari CNC e consegne puntuali. Per questo un blocco causato dai debiti può fermare forniture, mandare in ritardo ordini critici e far perdere clienti industriali strategici.
La buona notizia è che puoi ancora bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua azienda, se intervieni rapidamente.
Perché le aziende di alesatori accumulano debiti
Le cause più frequenti sono:
- costi elevati di acciai speciali, metallo duro, rivestimenti tecnici e trattamenti termici
- rincari dei materiali e della componentistica per CNC
- pagamenti lenti da parte di officine, industrie e costruttori di macchine
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi con molte misure, tolleranze e varianti
- investimenti costanti in affilatrici, centri CNC e strumenti di misura avanzati
- difficoltà nell’ottenere linee di credito adeguate
- fornitori strategici che richiedono pagamenti rapidi
Questi fattori possono portare rapidamente a crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
La priorità è intervenire subito, prima che la situazione sfugga di mano. Ecco cosa devi fare:
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verificare quali debiti sono corretti, irregolari o prescritti
- evitare piani di rientro affrettati o non sostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso
- ottenere rateizzazioni realmente compatibili con i tuoi flussi di cassa
- proteggere i fornitori critici e i materiali indispensabili
- prevenire il blocco del conto corrente o dei fidi bancari
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Una diagnosi professionale permette di capire quali debiti ridurre, sospendere o contestare con efficacia.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni tempestivamente rischi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di macchinari CNC, affilatrici e attrezzature tecniche
- blocco delle forniture di utensili grezzi e materiali
- impossibilità di completare ordini e consegne
- perdita di clienti industriali e officine strategiche
- danni seri alla reputazione tecnica
- crisi di liquidità e mancato pagamento di dipendenti e fornitori
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore degli alesatori, anche un leggero ritardo può bloccare intere catene di produzione dei clienti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e misure esecutive
- ridurre significativamente l’importo dei debiti tramite trattative mirate
- ottenere rateizzazioni sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
- far annullare debiti prescritti, mal calcolati o notificati in modo scorretto
- mediare con fornitori e banche evitando sospensioni delle consegne
- proteggere macchinari, magazzino e continuità produttiva
- stabilizzare l’azienda mentre si ristrutturano i debiti
- evitare l’insolvenza e salvare l’impresa
Una strategia professionale può salvare l’azienda anche in condizioni molto critiche.
Come evitare il blocco dell’attività
Per garantire continuità operativa devi:
- intervenire immediatamente
- non trattare con i creditori senza una strategia definita
- tutelare i fornitori e i materiali essenziali
- ristrutturare i debiti prima dell’avvio di pignoramenti
- identificare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare liquidità per produzione, affilatura e consegne
Così puoi evitare ritardi, penali e la perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
È il momento di farlo se:
- hai ricevuto solleciti, intimazioni o avvisi di pignoramento
- hai debiti crescenti con AE Riscossione, INPS o fornitori
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità si sta riducendo in modo preoccupante
- fai fatica a rispettare scadenze e pagamenti
- vuoi evitare la chiusura della tua azienda
Un avvocato esperto può bloccare subito le procedure, ristrutturare i debiti e mettere in sicurezza la tua attività.
Attenzione: molte imprese non falliscono per i debiti, ma per aver aspettato troppo prima di intervenire. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, salvando davvero l’impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese metalmeccaniche – ti aiuta a proteggere la tua azienda di alesatori.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Le aziende di alesatura – officine specializzate nelle lavorazioni di precisione dei metalli mediante macchine alesatrici – costituiscono un settore di nicchia nell’industria manifatturiera meccanica. Si tratta tipicamente di PMI altamente specializzate che forniscono componenti o lavorazioni su commessa per l’industria automobilistica, aeronautica, energetica o per impiantistica pesante. Queste imprese affrontano costi fissi elevati (macchinari CNC di grandi dimensioni, utensili costosi, personale tecnico specializzato) e operano spesso con margini ridotti e capitali immobilizzati in macchinari. Inoltre, lavorando su commesse di elevato importo, gli alesatori sono esposti ai ritardi di pagamento dei committenti maggiori e ai cicli altalenanti della domanda industriale.
Una combinazione di fattori – investimenti iniziali ingenti, spese generali costanti, dilazioni di pagamento lunghe (90-180 giorni) e talvolta la dipendenza da pochi clienti principali – rende queste aziende particolarmente vulnerabili alle tensioni di liquidità. In tempi di crisi economica o di shock settoriali (si pensi alla contrazione dell’automotive o al blocco di cantieri infrastrutturali), è frequente che un’azienda di alesatura accumuli debiti significativi verso banche (per finanziamenti e leasing dei macchinari), verso il fisco (IVA o IRES non versati per mancanza di liquidità), verso gli enti previdenziali (contributi INPS arretrati) e verso i fornitori di materiali e utensili.
L’ordinamento italiano, specie dopo la riforma organica attuata tra il 2019 e il 2022, mette oggi a disposizione una serie di strumenti giuridici per affrontare situazioni di questo tipo. Questa guida – aggiornata alla normativa di ottobre 2025 – intende fornire a imprenditori, avvocati e consulenti un quadro avanzato e completo delle opzioni disponibili dal punto di vista del debitore. Verranno esaminate:
- le varie tipologie di debito e i relativi rischi (fiscali, contributivi, bancari, commerciali, verso i dipendenti ecc.),
- gli obblighi e le responsabilità degli amministratori nel prevenire e gestire la crisi (in particolare l’obbligo di adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e le norme del Codice Civile sulla responsabilità patrimoniale),
- gli strumenti stragiudiziali di ristrutturazione (piani di rientro concordati, piani attestati di risanamento, accordi con creditori),
- le procedure concorsuali e di allerta introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – dalla Composizione Negoziata al Concordato Preventivo, dagli Accordi di Ristrutturazione ai procedimenti di liquidazione (giudiziale o controllata) – con le ultime modifiche normative e giurisprudenziali,
- le implicazioni fiscali e previdenziali (transazione fiscale e contributiva, rapporti con Agenzia Entrate e INPS durante le procedure),
- nonché cenni ai profili penali connessi (reati fallimentari e tributari) al fine di indicare i comportamenti da evitare per non incorrere in responsabilità.
Il taglio della trattazione è giuridico-specialistico ma di taglio divulgativo, pensato per un pubblico sia di professionisti (avvocati, commercialisti) sia di imprenditori informati. Ogni sezione riporta riferimenti normativi aggiornati (in particolare al CCII come modificato dai correttivi del 2022-2024) e richiami a pronunce giurisprudenziali recenti (Cassazione e tribunali di merito) per esemplificare l’interpretazione delle nuove norme. In coda al documento sono incluse tabelle riepilogative, simulazioni pratiche di casi comuni per aziende di alesatura e una sezione di Domande e Risposte (FAQ) sui dubbi più frequenti. Tutte le fonti normative e le sentenze citate sono elencate in fondo per un rapido riferimento.
1. Inquadramento normativo: dal fallimento al Codice della crisi
1.1 Evoluzione legislativa: dalla Legge Fallimentare al nuovo Codice
Per molti decenni la disciplina italiana dell’insolvenza è stata regolata dalla Legge Fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942). A partire dal 2005, e soprattutto negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008, il legislatore è intervenuto più volte per introdurre strumenti di risanamento in un impianto però rimasto prevalentemente “liquidatorio”. Si pensi all’introduzione del concordato preventivo con continuità aziendale (L. 80/2005), agli accordi di ristrutturazione dei debiti (L. 166/2008) e ai piani attestati di risanamento (DL 78/2010), tutti innesti sulla vecchia legge fallimentare . Tuttavia, l’ossatura generale della normativa è rimasta quella di un’epoca industriale ormai superata, improntata alla tutela prioritaria dei creditori attraverso la liquidazione dei beni del debitore.
Nel 2019, dopo una lunga gestazione, è stato emanato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con il D.Lgs. 14/2019 . L’obiettivo dichiarato era duplice: riunificare in un testo unico tutte le procedure concorsuali e introdurre strumenti di allerta e prevenzione della crisi prima che sfociassero in insolvenza conclamata . L’entrata in vigore del Codice è stata più volte rinviata – anche a causa della pandemia COVID-19 – fino alla data del 15 luglio 2022, quando il CCII è divenuto operativo in sostituzione (in gran parte) della legge fallimentare . Da quel momento il termine “fallimento” è stato giuridicamente sostituito da “liquidazione giudiziale”, e nuove procedure hanno preso il posto (o affiancato) gli istituti previgenti.
Successivamente, il legislatore è intervenuto con vari correttivi per adeguare il Codice sia alle direttive UE sia per affinare alcuni meccanismi. In particolare: il D.Lgs. 83/2022 ha recepito la direttiva UE 2019/1023 sull’insolvenza, introducendo modifiche significative in tema di ristrutturazione preventiva (ad esempio, potenziando la tutela dei finanziamenti durante la crisi e armonizzando le norme sul cram-down fiscale) . Più di recente, il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “correttivo ter”, in vigore dal 28 settembre 2024) ha ulteriormente revisionato numerosi articoli del CCII . Le relazioni ministeriali al correttivo evidenziano la volontà di chiarire alcuni punti controversi e rafforzare l’approccio conservativo delle procedure . Ad esempio, il correttivo-ter ha esplicitato che la definizione di “consumatore” ai fini della normativa esclude le persone fisiche con debiti di natura imprenditoriale o professionale, limitandola a chi ha contratto debiti solo per scopi personali o familiari . Inoltre, si è sancito a livello di principi che le soluzioni che preservano la continuità aziendale vanno privilegiate rispetto a quelle liquidatorie . Ciò risponde all’esigenza di salvaguardare i posti di lavoro e il valore produttivo, evitando quando possibile la dispersione degli asset aziendali.
In parallelo, va ricordato che non tutta la vecchia legge fallimentare è stata abrogata: alcune sue parti restano in vigore per i procedimenti pendenti o speciali. Ad esempio, le disposizioni penali del R.D. 267/1942 (reati di bancarotta) sono state in buona parte mantenute e trasfuse nel nuovo sistema. Anche alcune procedure speciali (come l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza o la liquidazione coatta amministrativa di banche e assicurazioni) restano disciplinate da leggi speciali e fuori dal CCII .
1.2 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: struttura e principi generali
Il CCII si struttura in quattro parti principali :
- Parte Prima – Disposizioni generali e allerta interna (artt. 1–25): contiene definizioni di base (come le nozioni di crisi e insolvenza), i doveri degli imprenditori e degli organi sociali nell’organizzazione dell’impresa e nella rilevazione tempestiva degli indizi di crisi (spicca l’art. 3 CCII sul dovere dell’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare e affrontare la crisi), nonché il sistema di allerta interna tramite indicatori e check-up periodici. Vi è inoltre disciplinata in questa parte la nuova procedura volontaria di Composizione Negoziata della Crisi (artt. 12–25-octies CCII) , strumento di emersione assistita della crisi di cui diremo diffusamente.
- Parte Seconda – Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 26–102): disciplina tutte le procedure per la soluzione della crisi, sia di natura negoziale (accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, convenzioni di moratoria) sia concorsuale in senso stretto (concordato preventivo per imprenditori maggiori, concordato minore e liquidazione controllata per i debitori minori e i consumatori). Questa è la parte centrale del Codice, che dettaglia presupposti, fasi procedurali, effetti e conclusioni di ciascuno strumento.
- Parte Terza – Crisi di gruppi di imprese e insolvenze civili (artt. 103–115): contiene norme specifiche per la trattazione unitaria della crisi nei gruppi di imprese (artt. 284–292 CCII) e per le procedure familiari (regolando casi di condebitori, soci illimitatamente responsabili etc.).
- Parte Quarta – Disposizioni penali e finali (artt. 116–391): include i reati concorsuali (bancarotta fraudolenta, preferenziale, semplice, ricorso abusivo al credito, ecc., in gran parte ripresi dagli artt. 216 e ss. l.fall.), le sanzioni amministrative e le disposizioni di coordinamento e abrogazione.
In sintesi, il CCII ha preso l’eredità della legge fallimentare integrandola in un quadro più organico e moderno. I principi cardine che emergono dalla nuova normativa sono: la tempestività nell’affrontare la crisi (il legislatore impone agli amministratori di attivarsi senza indugio appena emergono segnali di difficoltà), la valorizzazione degli strumenti di composizione negoziale (si cerca di favorire accordi di ristrutturazione e concordati “in continuità” rispetto alla liquidazione), e la salvaguardia possibile della continuità aziendale come interesse meritevole di tutela pubblicistica (bilanciato però con la tutela dei creditori). Non a caso, il correttivo ter del 2024 ha ribadito il dovere di leale collaborazione tra debitore e creditori e l’importanza della buona fede nelle trattative .
Da ultimo, va segnalato che il CCII ha introdotto formalmente il concetto di “impresa minore” (art. 2 lett. d CCII) per definire le piccole imprese sotto soglia non assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie . Come approfondiremo più avanti (§5.3), un’impresa che rientra in determinati parametri dimensionali (attivo annuo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000 negli ultimi 3 esercizi ) è esclusa dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento) e dal concordato preventivo ordinario . Tali imprese minori, in caso di insolvenza, seguono percorsi semplificati: possono accedere al concordato minore (procedura concorsuale “minore” riservata ai soggetti non fallibili) o alla liquidazione controllata dei beni (equivalente semplificato del fallimento per i sovraindebitati) . Questo regime distingue nettamente le tutele e gli obblighi a seconda della dimensione dell’impresa, un aspetto cruciale per capire quale strategia adottare nel caso concreto.
Sintesi normativa aggiornata: Nel 2025 il panorama normativo della crisi d’impresa in Italia risulta quindi regolato principalmente dal CCII (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Rimangono inoltre rilevanti il Codice Civile (soprattutto per il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e per l’art. 2086 c.c. sugli assetti organizzativi ), nonché leggi speciali come il D.Lgs. 74/2000 in materia di reati tributari e le normative fiscali di favore varate di anno in anno (p.es. le disposizioni delle Leggi di Bilancio 2023 e 2024 sulle definizioni agevolate dei debiti tributari ). Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 222-230) ha previsto lo stralcio automatico dei debiti erariali residui fino a €1000 relativi al 2000-2015 , e il disegno di legge di Bilancio 2026, in discussione a ottobre 2025, prevede una nuova edizione della “rottamazione” per i carichi fino al 2023 . Queste misure fiscali straordinarie si affiancano stabilmente agli strumenti concorsuali del CCII, offrendo al debitore opportunità ulteriori di riduzione del carico debitorio.
2. Tipologie di debiti aziendali e conseguenze dell’inadempimento
Un’azienda in crisi come la nostra impresa di alesatura può presentare un ventaglio di debiti di natura diversa. Ciascun tipo di debito è soggetto a normative specifiche e comporta differenti rischi e priorità d’azione. Mappare i debiti per categoria è il primo passo per definire una strategia di risanamento. Di seguito esaminiamo le principali categorie di esposizioni debitorie tipiche:
- Debiti fiscali (Erario): imposte e tasse dovute allo Stato o agli enti locali (IVA, IRES, IRAP, ritenute, IMU, TARI, ecc.).
- Debiti contributivi e previdenziali: contributi obbligatori dovuti agli enti previdenziali (INPS per lavoratori dipendenti e autonomi, INAIL per assicurazione infortuni, eventuali Casse professionali).
- Debiti bancari e finanziari: esposizioni verso banche o società finanziarie (mutui, finanziamenti a breve termine come fidi di cassa o anticipi fatture, leasing di impianti o veicoli, garanzie escusse).
- Debiti verso fornitori: somme dovute a fornitori di materie prime, componenti, utensileria, servizi o consulenze; in generale tutti i creditori chirografari (senza garanzie reali) derivanti dal normale ciclo commerciale.
- Debiti verso dipendenti e collaboratori: retribuzioni non corrisposte, TFR maturato ma non versato, rimborsi spese dovuti, ecc. Queste sono passività privilegiate per legge (hanno un privilegio generale sui beni mobili del datore ex art. 2751-bis c.c.) e il loro mancato pagamento ha implicazioni sia civili sia potenzialmente penali (es. reato di omesso versamento di ritenute previdenziali se oltre soglie).
- Debiti verso enti pubblici o altri particolari creditori: ad esempio debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione derivanti da ingiunzioni fiscali locali, sanzioni amministrative, penali contrattuali in appalti pubblici, ecc. A seconda del caso possono comportare privilegi, ipoteche legali o altre tutele per il creditore pubblico.
Vediamo ora nel dettaglio ciascuna categoria, le conseguenze tipiche dell’inadempimento e gli strumenti di difesa e gestione disponibili al debitore.
2.1 Debiti fiscali (Erario e tributi)
I debiti verso l’Erario rappresentano spesso la componente più gravosa e urgente per un’azienda in crisi, poiché lo Stato dispone di potenti strumenti di riscossione coattiva. In Italia, se un’azienda omette il versamento di imposte dichiarate (come IVA, IRES, IRAP) o riceve un accertamento fiscale che contesta maggiori imposte, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che subentra nel recupero. Il procedimento tipicamente è questo: dopo un avviso di accertamento “esecutivo” o la liquidazione di un tributo, viene notificata una cartella di pagamento. La cartella concede 60 giorni per pagare; decorso tale termine senza adempimento né ricorso, la riscossione diviene esecutiva .
Strumenti di riscossione fiscale: L’AdER (ex Equitalia) può attivare rapidamente diverse misure esecutive senza bisogno di passare dal tribunale: ad esempio il fermo amministrativo dei veicoli aziendali (iscrizione del divieto di circolazione per mezzi intestati al debitore), l’ipoteca legale sugli immobili dell’azienda (concessa per legge per debiti sopra €20.000, ex art. 77 DPR 602/1973) , il pignoramento presso terzi dei crediti (inviando direttamente atti a banche e clienti per farsi versare importi dovuti all’azienda), nonché il pignoramento mobiliare o immobiliare dei beni aziendali, il tutto senza previa autorizzazione giudiziaria. Bastano la notifica della cartella e l’intimazione di pagamento scaduta perché l’agente della riscossione possa procedere.
Queste azioni possono paralizzare la vita d’impresa: ad esempio, il fermo di un autocarro impedisce consegne e può fermare un cantiere; il pignoramento del conto corrente blocca tutti i pagamenti (stipendi, fornitori) creando un effetto domino; l’ipoteca su capannoni o terreni aziendali impedisce di venderli o usarli come garanzia . Inoltre, l’esposizione fiscale rilevante compromette il rapporto con le banche: un’impresa con cartelle esattoriali non pagate viene spesso segnalata come cattivo pagatore nei sistemi creditizi, riducendo la possibilità di ottenere fidi .
Cosa fare di fronte a debiti fiscali? Ecco gli strumenti principali di gestione:
- Pagamento o rateazione ordinaria: In prima battuta, il debitore può chiedere all’AdER una dilazione del pagamento ex art. 19 DPR 602/1973. Attualmente è possibile ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni) se il debito supera €60.000 presentando prova di temporanea difficoltà finanziaria, e fino a 120 rate (10 anni) in casi di grave e comprovata difficoltà . Il decreto-legge 159/2019 ha innalzato a 100 mila euro la soglia sotto la quale la rateazione è concessa con semplice istanza, introducendo anche il piano “straordinario” da 120 rate per chi ha cali di fatturato rilevanti . Attenzione: se l’azienda aveva già un piano di rateazione e lo ha interrotto (saltando il pagamento di 5 rate), decade dal beneficio e difficilmente otterrà una nuova dilazione. Inoltre, gli interessi di dilazione applicati dall’AdER sono elevati (attualmente circa 3,5-4% annuo). La rateazione ordinaria sospende le azioni esecutive solo finché le rate sono pagate regolarmente . In caso di peggioramento della crisi, queste rateazioni possono essere inglobate in successivi piani di ristrutturazione o concordati, ma se ciò non avviene e la procedura concorsuale viene aperta, le rateazioni decadranno a meno che il piano omologato non le confermi .
- Definizioni agevolate (“rottamazioni”): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure straordinarie per alleggerire il peso delle cartelle esattoriali. La più nota è la rottamazione delle cartelle, giunta alla quarta edizione nel 2023. La Rottamazione-quater (art. 1 commi 231-252 L.197/2022) ha permesso di estinguere i debiti fiscali affidati all’AdER dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo l’imposta e una parte degli interessi, senza sanzioni né interessi di mora, con possibilità di dilazionare in 18 rate fino al 2027 . In parallelo, la stessa legge ha disposto lo stralcio automatico dei mini-debiti fino a €1000 relativi al periodo 2000-2015 . Guardando avanti, la Legge di Bilancio 2024 e la prossima del 2025 prevedono ulteriori sanatorie: è in cantiere una rottamazione-quinquies per i carichi affidati entro il 2023, con pagamento del solo capitale e dilazione estesa fino a 9 anni (54 rate bimestrali) e un interesse agevolato del 4% . Queste definizioni agevolate offrono un taglio drastico delle sanzioni (spesso oltre il 30% del debito) e vanno colte tempestivamente quando disponibili, rispettando i termini di adesione e pagamento: un ritardo o una rata saltata comporta la decadenza dalla definizione e la ripresa delle azioni di recupero per l’intero importo originario .
- Opposizioni e ricorsi in Commissione/CGT: Se il debito fiscale è contestabile, il debitore deve valutare il ricorso tributario. Esempi: una cartella potrebbe riguardare un avviso di accertamento mai notificato regolarmente; oppure potrebbe essere già stato versato tramite compensazione quanto richiesto. Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile (che può essere sia l’accertamento sia la cartella) . Con il ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione. Inoltre, è possibile fare opposizione al giudice ordinario contro eventuali ingiunzioni fiscali emesse dagli enti locali ex R.D. 639/1910 o contro i provvedimenti di fermo/ipoteca se ritenuti illegittimi. L’opposizione agli atti esecutivi va fatta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, mentre l’opposizione all’esecuzione (contestando il diritto di procedere) può avvenire anche successivamente, ma prima che la procedura sia conclusa. L’importante è non lasciare decorrere i termini: un conto corrente pignorato dall’AdER può essere sbloccato solo se si dimostra un vizio (ad es. mancata notifica della cartella) e si agisce in giudizio tempestivamente.
- Transazione fiscale e composizione con il fisco: Nell’ambito delle procedure concorsuali, la legge consente di includere i debiti fiscali in un piano e proporre allo Stato un pagamento parziale (falcidia) o dilazionato. Questo è chiamato transazione fiscale. Storicamente la transazione fiscale era ammessa solo nel concordato e negli accordi di ristrutturazione, con forti limiti (ad esempio non si poteva falcidiare l’IVA se non pagando almeno il 20%). Il Decreto correttivo 136/2024 ha riformato la materia (artt. 63–64 CCII) prevedendo che il debitore possa proporre ad Agenzia Entrate e agli enti previdenziali pagamenti parziali o a lunga dilazione, purché un esperto indipendente certifichi che la proposta offre al fisco un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe dalla liquidazione . Se l’Agenzia non risponde entro 90 giorni, la proposta si considera accettata tacitamente . Inoltre, se il piano proposto assicura ai creditori pubblici il pagamento di almeno il 50% del debito tributario principale (esclusi interessi e sanzioni) entro 10 anni, e contemporaneamente i creditori privati hanno aderito in misura significativa, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole dell’Erario (il cosiddetto cram-down fiscale) . La Cassazione ha chiarito che questo cram-down forzato sul fisco è ammissibile solo se il debitore ha raccolto un’adesione sufficiente dai creditori privati: senza un ampio consenso privato, non è lecito imporre il piano all’Erario . In pratica, lo Stato deve essere trattato equamente rispetto agli altri creditori e la forzatura del suo diniego è eccezionale. Per un’azienda di alesatura, ciò significa che è possibile ridurre i debiti tributari all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, ma serve una solida adesione degli altri creditori e una proposta seria (es. pagamento del 50% del dovuto in 5-10 anni) per convincere il giudice . Anche nella Composizione Negoziata è possibile inserire i debiti tributari nel piano di risanamento. Formalmente la transazione fiscale non è disciplinata per la CNC, ma in pratica l’imprenditore in crisi può, con l’aiuto dell’esperto, negoziare con Agenzia Entrate-Riscossione un piano di rientro agevolato, magari sfruttando gli strumenti appena detti (rate lunghe, stralcio di sanzioni) . Durante la CNC, chiedendo le misure protettive ex art. 18 CCII, si ottiene la sospensione di tutte le azioni esecutive dei creditori, compreso il fisco , il che offre una finestra di respiro per trattare senza l’assillo di nuove ipoteche o pignoramenti.
In conclusione, di fronte a debiti fiscali importanti è fondamentale agire con tempestività e strategia: ignorare le cartelle esattoriali è assolutamente sconsigliato . Occorre invece valutare immediatamente le possibilità di sanatoria (se il legislatore ne offre), presentare eventuali ricorsi per gli importi non dovuti e, soprattutto, considerare l’adesione a una procedura di ristrutturazione (composizione negoziata, accordo o concordato) che includa il fisco. Quest’ultima opzione consente infatti di bloccare le esecuzioni mentre si cerca un accordo e di proporre pagamenti sostenibili evitando la paralisi aziendale .
2.2 Debiti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL)
Accanto al fisco, un’azienda può accumulare debiti verso gli enti previdenziali, principalmente INPS (contributi pensionistici e assicurativi obbligatori per dipendenti e titolari artigiani/commercianti) e INAIL (premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro) oltre ad eventuali Casse professionali per specifici settori. Il mancato versamento dei contributi genera non solo un debito monetario ma anche conseguenze sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): un’impresa con contributi arretrati risulta irregolare e non può partecipare ad appalti pubblici né ottenere certi benefici pubblici fino a quando non sistema la sua posizione .
Azioni esecutive dell’INPS: L’INPS dispone, per i crediti contributivi, di poteri simili a quelli dell’Erario. In particolare, dal 2011 può emettere un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo, che equivale a una cartella esattoriale e viene affidato anch’esso all’Agenzia Entrate-Riscossione per il recupero forzoso. L’INPS può iscrivere ipoteca legale su immobili aziendali per crediti contributivi (sopra €5.000) e disporre fermi amministrativi su automezzi, analogamente al fisco . Inoltre, le sanzioni e interessi per omesso versamento di contributi sono molto onerosi: ogni rata mensile non pagata accumula interessi di mora e sanzioni civili che possono far lievitare il debito originale. Per fare un esempio, l’aliquota di sanzione per ritardato pagamento di contributi è in genere del 6% circa annuo (aumentata in caso di evasione conclamata) e si cumula sugli importi dovuti.
Strumenti di gestione dei debiti contributivi:
- Rateizzazione ordinaria INPS: l’INPS consente di dilazionare i debiti contributivi fino a 120 rate mensili (10 anni), condizione simile al fisco ma con procedure interne. La domanda si presenta per via telematica (servizio VERA – Verifica debiti e rateazione sul portale INPS) e, diversamente dal fisco, l’INPS tende a concedere la dilazione se il debitore dimostra la difficoltà, anche perché gli interessi applicati dall’INPS sulle rate sono generalmente inferiori a quelli delle cartelle esattoriali . È importante rispettare il piano: la decadenza da una rateazione INPS (ad esempio saltando due rate) rende molto più difficile ottenerne una nuova. Mentre è attiva la rateazione, l’INPS sospende le azioni esecutive (e rilascia un DURC provvisorio regolare), ma appena si decade, tutte le misure possono ripartire.
- Definizioni agevolate contributive: a differenza del fisco, non esiste una “rottamazione” generalizzata per i contributi INPS. Ogni tanto vi sono stati condoni mirati o sanatorie settoriali (ad es. condono Monti 2012 su sanzioni per aziende edili, o provvedimenti per sanare situazioni di lavoro sommerso con pagamento parziale dei contributi), ma nessuna norma di carattere generale paragonabile alle rottamazioni fiscali . Quindi, sebbene politicamente se ne parli, al 2025 il debitore contributivo deve pagare integralmente almeno il capitale e generalmente anche una parte delle sanzioni. L’ultima Legge di Bilancio (L. 197/2022 e L. 205/2023) non ha previsto condoni contributivi ma solo incentivi per nuove assunzioni e riduzioni di aliquote per specifiche categorie, nulla che incida sul debito pregresso .
- Opposizioni e conciliazioni in sede INPS: se l’azienda contesta la pretesa contributiva (ad es. l’INPS richiede contributi per lavoratori che l’azienda ritiene autonomi e non subordinati, o applica sanzioni per ritardi già giustificati), si può presentare ricorso amministrativo agli organi interni dell’INPS entro 90 giorni dall’avviso di addebito, oppure ricorso giudiziale al Tribunale (sez. Lavoro) entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso o cartella, chiedendo eventualmente la sospensione. In parallelo, l’INPS ha strumenti di conciliazione amministrativa: in caso di accertamenti ispettivi, per esempio, è possibile a volte definire transattivamente pagando solo una parte dei contributi accertati. Queste procedure però dipendono dalla disponibilità dell’ente e dalle circostanze. Va ricordato che taluni omessi versamenti contributivi oltre soglie rilevanti configurano reato (omesso versamento ritenute previdenziali, art. 2 L. 638/83, soglia circa €10.000 annui). In tali casi, sanare rapidamente il debito (prima dell’apertura del dibattimento) estingue il reato: quindi se ci sono pendenze di questo tipo è prioritario cercare di pagarle (magari con finanziamento esterno), per evitare guai penali.
- Composizione negoziata e transazione contributiva: analogamente al fisco, anche i debiti INPS possono essere inseriti in un piano di risanamento complessivo. Il legislatore con il D.Lgs. 83/2022 ha previsto espressamente la possibilità di transazione contributiva nei concordati e negli accordi : significa che l’INPS può accettare un pagamento parziale/dilazionato dei contributi nell’ambito di tali procedure, in linea con quanto detto per le imposte. Tuttavia, a differenza del fisco, non c’è ancora una disciplina dettagliata per la transazione INPS nella Composizione Negoziata . In pratica però, l’esperto nominato nella CNC potrà coinvolgere l’INPS nelle trattative e proporre un piano di pagamento graduale (tipicamente, il massimo 120 mesi già previsto per legge), ottenendo in cambio la sospensione delle azioni esecutive da parte dell’INPS durante la procedura . Anche nel concordato preventivo, oggi l’INPS può essere falcidiata come un qualsiasi creditore privilegiato se il piano lo prevede e se l’attestatore certifica che prende almeno quanto avrebbe in liquidazione. L’importante è che i contributi relativi ai lavoratori (trattenute sulle buste paga) siano equiparati a imposte per certi aspetti e abbiano trattamento prioritario nelle distribuzioni.
In definitiva, i debiti contributivi vanno affrontati insieme a quelli fiscali: spesso le aziende in crisi li accumulano congiuntamente, e una soluzione efficace deve tener conto di entrambi . Un approccio integrato (es. richiedere una composizione negoziata così da bloccare sia Equitalia sia INPS, mentre si elabora un piano per rateizzare gli arretrati contributivi) è la via migliore . È fondamentale inoltre non lasciare i dipendenti senza risposte: comunicare ai lavoratori la situazione e magari concordare la dilazione di alcune spettanze può evitare vertenze immediate. Nelle procedure concorsuali i dipendenti sono tutelati dal Fondo di Garanzia INPS (che paga TFR e ultime tre mensilità in caso di insolvenza) , ma è chiaro che un’imprenditore responsabile cercherà di salvaguardare il più possibile i propri dipendenti o almeno di metterli nelle condizioni di accedere a tali tutele.
2.3 Debiti bancari e finanziari
Le esposizioni verso le banche (o altri finanziatori) includono: mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili o macchinari; affidamenti in conto corrente (fidi) utilizzati per la liquidità; leasing finanziari su macchinari utensili o automezzi; anticipi su fatture o factoring; e altre forme di credito come scoperti su conto, finanziamenti a medio termine, derivati con margini da coprire, ecc. Per molte imprese la quota bancaria rappresenta una porzione rilevante del passivo. Nel caso di un’azienda di alesatura, ad esempio, può esserci un mutuo decennale sul capannone, contratti di leasing sulle alesatrici CNC, e linee di castelletto bancarie per anticipo ordini.
Caratteristiche del debito bancario: le banche sono creditori forti e organizzati. Spesso dispongono di garanzie: ipoteca su immobili dell’azienda o dei soci, fideiussioni personali firmate dagli amministratori o dai garanti, pegno su attrezzature (in caso di leasing, la macchina è di proprietà del lessor) o su crediti (factoring). Inoltre, i contratti bancari contengono clausole di salvaguardia: ad esempio, il mutuo può prevedere la decadenza dal beneficio del termine se l’azienda ritarda il pagamento di una rata oltre X giorni, oppure la banca può revocare con effetto immediato gli affidamenti in conto corrente se l’impresa viene “segnalata a sofferenza” o se risultano pregiudizievoli come ipoteche da parte di altri creditori . Esistono anche clausole di cross-default: se il debitore è in default verso un’altra banca, tutti i contratti finanziari possono diventare immediatamente esigibili.
Quando la situazione degenera, le banche non esitano a tutelarsi: ad esempio, se l’impresa non rispetta i covenant (indicatori finanziari concordati) o subisce protesti/pignoramenti, la banca può bloccare immediatamente le linee di credito, richiedere rientri forzosi e segnalare la posizione “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi di Bankitalia, marchiando l’azienda come insolvente. Questi eventi hanno effetto domino: tutte le altre banche vedranno la segnalazione e potrebbero a loro volta revocare affidamenti .
Soluzioni per gestire i debiti bancari:
- Rinegoziazione privata: Finché l’azienda non è in default grave, è spesso possibile rinegoziare con le banche. Le banche preferiscono evitare sofferenze (che impattano sui loro bilanci) se intravedono possibilità di recupero. Si può chiedere: un allungamento dei piani di ammortamento (es. trasformare un mutuo residuo di 5 anni in uno di 10 per abbassare la rata), una moratoria temporanea (sospensione di 6-12 mesi delle quote capitale, pagando solo interessi), una riduzione del tasso o ricalcolo dello spread, o la concessione di nuove linee di credito per liquidità di emergenza. Nel 2020-2021, ad esempio, per effetto dei decreti COVID, molte PMI hanno fruito di moratorie straordinarie e prestiti garantiti (come quelli con Garanzia Italia di SACE) . Oggi, in mancanza di misure di legge, serve trattare caso per caso: presentando alla banca un piano di ristrutturazione credibile che mostri come e quando potranno rientrare dei soldi. È bene farsi assistere da un advisor finanziario in queste negoziazioni e muoversi prima che la posizione sia segnalata come “incaglio” o “sofferenza” nei sistemi bancari.
- Accordi di ristrutturazione del debito (art. 57 CCII): Se la mole di debito bancario è elevata e coinvolge più banche, un’opzione formale è l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale (ex art. 182-bis l.f., ora art. 57 CCII). Richiede l’adesione di almeno il 60% dei creditori in valore . In pratica si elabora un piano di risanamento, si ottiene il consenso della maggioranza qualificata delle banche (e volendo anche di altri creditori), quindi si chiede l’omologazione al tribunale. L’accordo omologato vincola anche i creditori dissenzienti che appartenevano alle categorie aderenti (questo vincolo erga omnes è la ragione per cui serve il passaggio in tribunale) . Vantaggi: è più rapido e meno “invasivo” di un concordato, l’azienda non viene dichiarata insolvente pubblicamente (c’è pubblicità solo al registro imprese dell’accordo omologato), e permette soluzioni flessibili concordate caso per caso (dilazioni pluriennali, conversione debito in strumenti partecipativi, remissioni parziali di interesse o capitale). Svantaggi: serve un’adesione molto alta e non offre protezione automatica: durante la trattativa gli altri creditori potrebbero agire ugualmente (a meno di chiedere misure protettive ex art. 54 CCII se si rispetta almeno il 30% di adesioni iniziali, come nei cosiddetti accordi agevolati ). Inoltre, se poi l’azienda fallisce, l’accordo si risolve e i creditori possono vantare l’intero credito originario decurtato solo di quanto eventualmente incassato in esecuzione dell’accordo . La Cassazione ha infatti ribadito che in caso di successivo fallimento, l’accordo omologato non produce un effetto remissorio definitivo: il curatore può richiedere ai creditori bancari di restituire quanto non versato rispetto all’originario (a meno che non fosse prededotto) . Ciò rende i creditori spesso diffidenti nel concedere stralci importanti se non sono sicuri del completo risanamento.
- Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII): Questo strumento privatistico (ex art. 67 l.f.) permette all’imprenditore di predisporre un piano economico-finanziario di risanamento pluriennale asseverato da un professionista indipendente . Non richiede il consenso di tutti i creditori né omologazione giudiziale: è essenzialmente un accordo contrattuale con uno o più creditori, reso però “protetto” dal fatto di essere attestato e pubblicato. Il vantaggio maggiore è che gli atti e i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano attestato pubblicato non sono soggetti a revocatoria fallimentare . Questo dà serenità ai creditori che aderiscono: se poi la società fallisce, non verrà chiesto loro di restituire quanto incassato sotto il piano. Tuttavia, il piano attestato non vincola i creditori non aderenti : dunque funziona bene se i creditori sono pochi e disponibili. Ad esempio, potrebbe essere utile se la nostra azienda di alesatura ha 2 banche principali e 3 fornitori grossi: si elabora un piano di rientro con loro, attestando che è fattibile, e lo si pubblica. Se tutti aderiscono contrattualmente, il piano parte e i pagamenti secondo quel piano sono al sicuro. Se qualcuno non aderisce, quel creditore può comunque agire per conto suo (da qui il limite).
- Moratorie di settore o patti di fornitura solidale: in alcuni settori industriali, le associazioni di categoria promuovono accordi collettivi di moratoria. Ad esempio, nel settore edile in certe crisi sono stati concordati patti di dilazione tra produttori di cemento e imprese costruttrici mediati dall’associazione di categoria, per evitare il fallimento a catena dei clienti . Non sono strumenti previsti da legge ma nascono da accordi privati plurilaterali. Un’azienda debitrice può sondare, tramite la propria associazione (es. Confartigianato Metalmeccanica, Confindustria territoriale), se esistono tavoli di questo tipo. Spesso però tali patti operano su base volontaria e non sono giuridicamente vincolanti per chi non vi aderisce.
- Nuova finanza e risorse esterne: se l’imprenditore o terzi credono nella possibilità di ripresa, un’opzione è immettere liquidità fresca nell’azienda per pagare (o ridurre) i debiti bancari. I soci possono effettuare finanziamenti soci (magari postergati o convertibili in capitale) per ridurre l’esposizione. Oppure si può cercare un investitore esterno disposto a rilevare parte dell’azienda assumendosi i debiti. Da notare: i nuovi finanziamenti erogati in funzione di un piano di risanamento o di un concordato possono godere della qualifica di prededucibili (cioè verranno rimborsati con priorità assoluta in caso di procedura concorsuale successiva) . L’art. 22 CCII e prima ancora l’art. 182-quater l.f. incoraggiano tali finanziamenti per facilitare il salvataggio. Questo aiuta a convincere terzi a prestare denaro in situazioni difficili, avendo la tutela che se poi qualcosa va storto e c’è il fallimento, recupereranno prima degli altri creditori.
- Procedure concorsuali (fallimento): Se l’azienda non trova accordi, la soluzione forzata è la liquidazione giudiziale chiesta dai creditori (spesso le banche sono le prime a presentare istanza di fallimento quando vedono l’irrecuperabilità). In tal caso, il tribunale dichiara aperta la procedura e nomina un curatore che liquiderà i beni. Le banche, se garantite da ipoteca, verranno soddisfatte sul ricavato degli immobili; se chirografarie concorreranno al riparto finale spesso con esiti modesti. Va ricordato che esiste anche il concordato fallimentare (oggi concordato nella liquidazione giudiziale ex art. 240 CCII) in cui, dopo la dichiarazione di liquidazione, la stessa banca o i soci possono proporre un piano di concordato ai creditori dentro la procedura. Ma in generale, per il debitore, arrivare a questo punto significa aver perso il controllo.
Riassumendo: prima che le banche agiscano giudizialmente occorre un confronto franco con loro. Mostrare un piano e chiedere tempo è spesso preferibile e può evitare la segnalazione a sofferenza. Se la situazione è compromessa con varie banche, meglio formalizzare un accordo di ristrutturazione od optare per un concordato, piuttosto che subire una liquidazione giudiziale avviata da un creditore. Come esempio pratico, pensiamo a un’officina meccanica con leasing per €1 milione su una grossa alesatrice: se il fatturato cala e non riesce a pagare le rate, attendere passivamente significa vedersi revocato il leasing e pignorare la macchina (con interruzione immediata della produzione). Invece, contattando la società di leasing si potrebbe ottenere un allungamento del contratto o la sospensione di 6 mesi delle rate per superare la crisi. Oppure, integrando la trattativa in una composizione negoziata, si potrebbe includere il lessor nel piano garantendogli magari un acconto subito (ottenuto vendendo un altro macchinario inutilizzato) e il resto a rate, così da evitare la risoluzione del contratto. Ogni euro speso in consulenza finanziaria in questa fase può salvarne cento in beni aziendali preservati.
2.4 Debiti verso fornitori (commerciali) e altri creditori chirografari
I fornitori di beni e servizi all’azienda rappresentano i classici creditori chirografari, ossia privi di garanzie reali. In un’azienda industriale, i fornitori possono avere crediti molto elevati perché spesso forniscono materiali con pagamento a 30-60-90 giorni e l’azienda, se in crisi di liquidità, accumula diverse fatture non pagate. Talvolta i termini dilazionati arrivano a 120 o 180 giorni in certi settori, aggravando l’esposizione dei fornitori . Se l’azienda di alesatura smette di pagare i fornitori di acciaio, utensili, energia elettrica o servizi di manutenzione, i fornitori avranno inizialmente un approccio differente rispetto alle banche: tenderanno a negoziare. Questo perché sanno di non avere ipoteche o garanzie e un’azione legale lunga potrebbe far fallire il cliente, facendogli recuperare magari meno.
Tuttavia, i fornitori dispongono comunque di azioni legali: tipicamente possono ottenere un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo se il credito è fondato su fatture e DDT) entro poche settimane, e poi passare al pignoramento di beni aziendali o crediti (conto corrente, crediti verso clienti) . Se qualche fornitore ha una fideiussione assicurativa a garanzia (p.es. polizze assicurative creditizie che indennizzano se il cliente non paga), potrebbe essere meno incline a trattare perché ceduto il rischio all’assicuratore.
Come gestire i debiti verso fornitori:
- Negoziazione diretta e piani di rientro: La strategia generalmente consigliata è di comunicare apertamente con i fornitori principali, spiegando la natura temporanea delle difficoltà e presentando un piano per saldare il dovuto gradualmente . Spesso i fornitori, pur di mantenere il rapporto commerciale (soprattutto se l’azienda cliente è importante o storica), accettano dilazioni o pagamenti parziali. È utile formalizzare questi accordi per iscritto (piano di rientro rateale, eventuale riduzione concordata del debito in caso di pagamento immediato di una percentuale – il cosiddetto saldo e stralcio). Tali accordi extragiudiziali, se ben strutturati, sono legalmente vincolanti e, in caso di successivo fallimento, i pagamenti fatti ai fornitori secondo l’accordo potrebbero essere esenti da revocatoria se rientrano nell’ambito di un piano attestato o comunque se avvenuti in un contesto di trattativa trasparente.
- Coinvolgimento nella Composizione Negoziata: nella CNC l’esperto convoca anche i fornitori rilevanti: questo crea un tavolo plurilaterale. I fornitori vedranno che anche banche e fisco sono coinvolti e spesso si convinceranno a sostenere un piano comune, magari accettando di essere pagati pro-quota insieme agli altri. Il vantaggio per loro è che la CNC li tutela dal rischio che altri li sorpassino (grazie alle misure protettive, nessuno può incassare prima degli altri) . Quindi un fornitore preferirà una soluzione concordata in CNC piuttosto che dover rincorrere il cliente in tribunale in concorrenza con creditori più aggressivi.
- Fattorizzazione e cessione di crediti: un modo indiretto per pagare i fornitori senza esborso immediato è utilizzare i crediti attivi dell’azienda. Ad esempio, se l’azienda attende pagamenti consistenti da alcuni clienti (crediti verso committenti), può cederli pro soluto a una società di factoring e usare l’anticipazione ottenuta per pagare i fornitori cash a un livello scontato . Oppure può proporre ai fornitori stessi di accettare in pagamento i crediti verso un terzo (accordo trilaterale di cessione del credito). In pratica, se la nostra azienda ha da incassare €100.000 dal Cliente X tra 4 mesi, un fornitore potrebbe accettare la cessione di quella fattura per incassarla lui (magari scontata del 5-10%) al posto di attendere i suoi €100.000 da noi.
- Tutela legale in caso di cause: se un fornitore ha già avviato un decreto ingiuntivo, l’azienda può fare opposizione per guadagnare tempo o contestare l’importo (es. eccependo vizi nella fornitura). L’opposizione al decreto ingiuntivo, se vi sono motivi plausibili, può portare il giudice a sospendere l’esecutorietà, dilatando i tempi della causa di parecchi mesi o anni. In quell’arco, potrebbe realizzarsi una soluzione concordata globale (come un concordato) che ingloba anche quel fornitore. In sede di concordato preventivo, i fornitori chirografari di solito ricevono solo una percentuale del loro credito (diciamo 20-40%, a seconda del piano), e l’eventuale causa di opposizione al decreto ingiuntivo rimasta pendente viene definita secondo le regole concorsuali (spesso con l’ammissione del credito in percentuale). Perciò nessun fornitore razionale preferisce il fallimento del cliente: se l’azienda fallisce, il fornitore spesso recupera poco o nulla; se invece accetta un piano di rientro, può sperare di recuperare di più con l’azienda viva.
- Concordato preventivo con classi separate di chirografari: nei concordati, i fornitori chirografari possono essere suddivisi in classi e soddisfatti in misura parziale. La legge impone nel concordato liquidatorio un pagamento minimo del 20% ai chirografari (art. 84 CCII), mentre nel concordato in continuità non c’è soglia minima ma deve essere assicurata la convenienza rispetto alla liquidazione . Ciò significa che se un fornitore rifiuta un accordo stragiudiziale e costringe l’azienda al concordato, potrebbe finire per avere persino meno. Ad esempio, se l’azienda proponeva 50% a rate e il fornitore ha detto no, in concordato liquidatorio potrebbe trovarsi a prendere 20% in anni. Questo argomento spesso persuade i creditori chirografari a cooperare prima.
Consiglio generale: mantenere un dialogo aperto con i fornitori è cruciale . Non sparite: spiegate le difficoltà, coinvolgeteli nella soluzione (anche emotivamente, facendogli capire che sono partner importanti per ripartire). Alcuni fornitori, se credono nella continuità del vostro business, potrebbero perfino accettare di convertire il credito in partecipazione (diventando soci al posto di creditori) oppure subordinare il loro credito (mettendolo postergato rispetto ad altri, per agevolare finanziamenti). Ciò avviene raramente, ma in imprese familiari o di distretto industriale, l’indotto a volte supporta il salvataggio dell’azienda leader per non perdere commesse future.
2.5 Debiti verso dipendenti e TFR
Una menzione a parte meritano i debiti verso il personale. Questi comprendono: stipendi arretrati, tredicesime non pagate, Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato e non accantonato, ferie non monetizzate, ecc. Dal punto di vista legale, tali crediti godono di privilegio generale sui mobili (art. 2751-bis c.c.) fino a un certo importo (le ultime 12 mensilità e TFR per i 3 anni precedenti) e di privilegio speciale su eventuali beni oggetto del loro lavoro. Inoltre, esiste il Fondo di Garanzia INPS che in caso di insolvenza conclamata (fallimento o concordato liquidatorio omologato) interviene a pagare TFR e ultime 3 mensilità ai dipendenti.
Tuttavia, dal punto di vista aziendale, accumulare debiti verso i dipendenti è estremamente pericoloso per diversi motivi:
- Rischio contenzioso immediato: Il dipendente può agire rapidamente con decreto ingiuntivo per salari non pagati (che è immediatamente esecutivo per legge) e ottenere un pignoramento, eventualmente anche chiedendo il fallimento dell’azienda (il lavoratore è legittimato a presentare istanza di fallimento come qualsiasi creditore).
- Morale e operatività: se i dipendenti non vengono pagati, calano motivazione e produttività, molti potrebbero abbandonare l’azienda cercando altro impiego o proclamare scioperi, aggravando la crisi. Nel settore altamente specializzato come la alesatura, la perdita di operai qualificati (alesatori CNC, attrezzisti) può significare l’impossibilità di portare avanti le commesse rimaste.
- Profilo penale: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti oltre €10.000 annui è reato; inoltre, situazioni di grave sfruttamento (lavoro non pagato per mesi) potrebbero integrare ipotesi di illecito (anche se raramente perseguite se c’è trasparenza sulla crisi).
Strumenti: In caso di difficoltà, è meglio trovare un accordo con i dipendenti, magari pagando parzialmente i salari con bonus futuri se l’azienda si riprende, oppure chiedendo la cassa integrazione guadagni (CIGS per crisi aziendale) se applicabile, che consente ai dipendenti di percepire parte del reddito dall’INPS mentre l’azienda sospende temporaneamente le attività. Nei concordati preventivi, i crediti dei dipendenti devono essere soddisfatti in prededuzione o privilegio integrale affinché la proposta sia approvabile (non è consentito falcidiare i crediti da lavoro se non pagando almeno quanto avrebbero dal Fondo di Garanzia, in pratica il 100% delle ultime 3 mensilità e TFR).
In una strategia di risanamento, mettere in sicurezza i dipendenti è prioritario: significa assicurarsi che percepiscano almeno il corrente (magari saldando lo stipendio mese per mese e lasciando arretrato il pregresso da regolare con il piano). Nel corso di una composizione negoziata, è possibile chiedere al Tribunale l’autorizzazione a pagare in via d’urgenza i fornitori strategici e i dipendenti nonostante la moratoria generale, proprio per garantire la prosecuzione dell’attività . L’art. 21 CCII consente infatti all’imprenditore in CNC di compiere anche atti di straordinaria amministrazione se funzionali alla continuità, previa autorizzazione del tribunale. Quindi durante la CNC si potrebbe ottenere il via libera a pagare stipendi arretrati per trattenere il personale chiave.
2.6 Conseguenze generali dell’inadempimento: sintesi dei rischi
Riassumendo quanto visto per le varie categorie, il mancato pagamento dei debiti da parte di un’azienda innesca tipicamente:
- Decreti ingiuntivi e pignoramenti mobiliari/immobiliari: i creditori (fornitori, banche, dipendenti) ottengono un titolo esecutivo e procedono al pignoramento di macchinari, merci in magazzino, crediti verso clienti, conti correnti ecc. . Ciò può portare alla vendita forzata di beni essenziali (bloccando la produzione) o al congelamento dei flussi finanziari.
- Ipoteca legale su immobili: l’Agente di Riscossione e l’INPS, come visto, possono iscrivere ipoteche sugli immobili dell’impresa senza passare dal giudice per cautelarsi sui crediti . L’ipoteca crea una prelazione a favore del creditore pubblico e riduce la capacità dell’azienda di finanziarsi (nessuna banca concede mutui su un immobile già ipotecato da Equitalia) e di vendere l’immobile (nessun acquirente vuole un bene gravato).
- Revoca dei fidi bancari e stop delle linee di credito: appena le banche rilevano segnali di insolvenza (anche un insoluto verso un fornitore può essere segnalato in CRIF), possono revocare gli affidamenti in conto e richiedere il rientro immediato . Le linee di credito che sostenevano la liquidità vengono meno, aggravando la crisi di cassa. Inoltre scatta la Centralizzazione dei rischi in Banca d’Italia: tutte le banche vedono che l’azienda è in default da qualche parte e chiudono i rubinetti.
- Blocco dei lavori e contratti: se l’azienda opera in settori regolamentati (edilizia, forniture pubbliche, ecc.), la perdita del DURC regolare comporta l’immediato stop ai cantieri o la risoluzione di contratti pubblici in corso . Anche clienti privati, sapendo di un vostro pignoramento o di una situazione critica (magari trapelata in ambienti locali), possono interrompere gli ordini per timore di inadempienze.
- Azioni conservative dei creditori: a volte i creditori, fiutando il pericolo, chiedono sequestri conservativi sui beni aziendali o sui conti, per bloccarli in attesa di sentenza (si pensi a un contenzioso con un cliente su penali contrattuali: il cliente può chiedere un sequestro conservativo sui conti temendo l’insolvenza futura). Oppure presentano istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): l’effetto è che la notizia diventa pubblica e l’azienda perde la fiducia di fornitori e partner.
- Possibili implicazioni penali: se l’inadempimento è accompagnato da comportamenti distrattivi (nascondere beni ai creditori, svuotare i conti, emettere fatture false per fittizi crediti IVA ecc.), si rischiano imputazioni per reati fallimentari o tributari. Ad esempio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) se si alienano beni per evitare che il Fisco li pignori; oppure bancarotta semplice o fraudolenta se poi l’azienda viene dichiarata insolvente e si ravvisa che gli amministratori hanno aggravato il dissesto o distratto attivi. La Cassazione ha definito grave comportamento colposo continuare a emettere fatture e contabilizzare crediti palesemente inesigibili, accumulando debiti: ciò configura bancarotta semplice da aggravamento del dissesto . In sostanza, proseguire l’attività aggravando il buco rischia di far incorrere gli amministratori in responsabilità (anche penali, oltre che civili verso i creditori).
Quindi l’inadempimento protratto in assenza di iniziative porta a un effetto valanga: da pochi debiti iniziali si arriva al collasso operativo, e spesso a quel punto l’unica via è la liquidazione giudiziale (fallimento) su iniziativa altrui, con conseguenze molto peggiori per l’imprenditore (perdita totale del controllo, possibili istanze di bancarotta, ecc.). Ecco perché il CCII insiste tanto sulla diagnosi precoce e l’azione immediata.
2.7 Importanza della prevenzione e dell’autodiagnosi della crisi
Il Codice della crisi d’impresa ha introdotto in capo agli amministratori e imprenditori un vero e proprio dovere di organizzazione preventiva. L’art. 3 CCII richiama l’art. 2086 c.c., che impone agli imprenditori (societari o individuali) di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale . In pratica, anche la piccola S.r.l. di famiglia deve avere un minimo di controllo di gestione e pianificazione finanziaria, non è più ammesso navigare a vista e accorgersi dei problemi quando è troppo tardi.
Tra gli strumenti di allerta interna il CCII e le linee guida del CNDCEC (commercialisti) prevedono indici finanziari di riferimento: ad esempio, indice di liquidità, indice di indebitamento (rapporto mezzi propri/debiti), DSCR (Debt Service Coverage Ratio, rapporto tra flussi di cassa prospettici e debiti a breve) ecc. . Se questi indicatori segnalano tensione (ad es. DSCR < 1 o patrimonio netto negativo per oltre 4 mesi, o debiti per salari/IVA scaduti rilevanti), l’imprenditore deve attivarsi. La riforma del 2024 ha esteso l’obbligo di segnalazione anche ai controllori esterni: sindaci e revisori devono avvisare l’organo amministrativo se rilevano fondati indizi di crisi, e in caso di inerzia possono informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi) .
Cosa significa in concreto? Che l’imprenditore diligente:
- tiene la contabilità aggiornata e analizza periodicamente bilanci infra-annuali;
- monitora i flussi di cassa prospettici almeno a 6-12 mesi, predisponendo un budget di tesoreria;
- controlla indicatori chiave come il patrimonio netto (che se azzerato impone interventi sui conferimenti o riduzione capitale), il rapporto tra EBITDA e oneri finanziari (se l’EBITDA non copre gli interessi, c’è un problema), il trend degli incassi e dei pagamenti;
- verifica i covenant imposti dalle banche per prevenire violazioni.
Appena emergono segnali di difficoltà, bisogna agire prontamente : tagliare costi non essenziali, negoziare dilazioni con i creditori prima di scadere, cercare nuovi capitali o soci, e soprattutto consultare professionisti esperti (un consulente finanziario, un avvocato d’impresa) per valutare strumenti straordinari.
Il CCII incoraggia ad attivare subito gli strumenti di regolazione quando la crisi è ancora reversibile. Aspettare che arrivi l’insolvenza conclamata è la scelta peggiore. In ottica di prevenzione, già con modesti ritardi nei pagamenti (es. Iva non versata per due trimestri, dipendenti pagati con 15 giorni di ritardo, fido sconfinato) l’imprenditore dovrebbe interrogarsi seriamente e magari accedere alla Composizione Negoziata volontaria, che è stata pensata proprio come percorso confidenziale da intraprendere prima di accumulare troppi debiti.
Non solo: il dovere di attivarsi tempestivamente ha anche riflessi sulla responsabilità personale degli amministratori. La giurisprudenza ha sempre condannato la cosiddetta “inerzia nell’aggravamento del dissesto”: se un amministratore continua a fare debiti sapendo di non poterli onorare, ritardando colposamente l’istanza di fallimento o l’adozione di misure riparative, può essere chiamato a rispondere dei danni verso i creditori per mala gestio. E, come già accennato, in caso di fallimento quella condotta può integrare bancarotta semplice (aggravamento del dissesto, art. 217 l.f.) seppur a titolo di colpa grave . Una recente sentenza (Tribunale di Milano, marzo 2025) ha richiamato proprio la necessità di trasparenza e correttezza nella gestione anche del concordato minore, stigmatizzando un amministratore che aveva continuato a operare in perdita con crediti inesigibili: il tribunale ha sottolineato che la revoca di un concordato per atti di frode o mala gestio deve avvenire a prescindere dal pregiudizio concreto, a tutela della legalità della procedura .
Insomma, oggi più che mai “prevenire è meglio che curare” non è solo un motto: è un obbligo giuridico. E l’imprenditore che lo ignora rischia di pagarne le conseguenze di persona.
3. Strumenti stragiudiziali di composizione della crisi e risanamento
Quando un’azienda presenta squilibri finanziari ma non è ancora insolvente in modo irreversibile, la prima linea di intervento è costituita dagli strumenti stragiudiziali di risanamento. Si tratta di soluzioni che puntano a evitare le procedure concorsuali formali, attraverso accordi volontari con i creditori o interventi interni di riorganizzazione, spesso con l’assistenza di professionisti. Questi strumenti hanno il pregio di essere riservati (non comportano in linea generale pubblicità di tribunale, salvo alcune eccezioni come la pubblicazione di un piano attestato) e più flessibili rispetto ai vincoli procedurali imposti da un concordato preventivo. Vediamoli in dettaglio.
3.1 Composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC)
La Composizione Negoziata della Crisi è la più importante innovazione introdotta con la riforma recente (D.L. 118/2021, convertito con L. 147/2021, poi confluita nel CCII artt. 12-25-octies) . Si tratta di uno strumento volontario e di natura extragiudiziale, finalizzato a favorire il risanamento di imprese che versano in condizioni di difficoltà, ma che hanno prospettive di recupero. La relazione illustrativa al decreto istitutivo sottolineava che lo scopo della CNC è di aiutare l’imprenditore a trovare un accordo con i creditori con l’ausilio di un esperto terzo, evitando di giungere a insolvenza conclamata . Non si apre una procedura concorsuale in senso tecnico (il debitore non è dichiarato insolvente), né l’imprenditore perde la gestione della sua azienda: la composizione negoziata infatti mantiene l’impresa in bonis durante le trattative .
Accesso e requisiti: Possono accedere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, sia in forma individuale sia societaria, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma ancora reversibile . Dal 2024 è stato chiarito che anche le società agricole (prima escluse) possono aderire . Non è necessario essere tecnicamente insolventi; anzi, se l’insolvenza è già conclamata e irreversibile la CNC non è lo strumento idoneo (bisognerà ricorrere a procedure concorsuali come concordato o liquidazione). L’imprenditore, prima di presentare istanza, è tenuto a effettuare una sorta di autodiagnosi: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha predisposto un check-up test con indici (DSCR a 6 mesi, patrimonio netto negativo, ecc.) che devono essere calcolati . Se dai test emergono segnali di crisi gestibile, l’imprenditore può procedere. Condizione formale: non devono essere pendenti procedure concorsuali (fallimento, concordato, etc.) né il debitore deve aver già utilizzato strumenti di regolazione negli ultimi 5 anni . Quindi, ad esempio, un’azienda che ha già fatto un concordato preventivo negli anni scorsi non può ora attivare la CNC, e ovviamente se è già stata dichiarata fallita o ha in corso un concordato non può accedervi in parallelo.
Va detto che il correttivo ter 2024 ha specificato che anche un’impresa formalmente insolvente può accedere se vi sono concrete prospettive di risanamento . Questo chiarimento serve a non escludere casi limite: può darsi che l’azienda abbia già superato la linea dell’insolvenza tecnica (ad es. ha debiti scaduti ingenti), ma intravede una soluzione (un investitore, un nuovo contratto) che la renderebbe recuperabile – in tal caso la CNC può essere tentata.
Presentazione dell’istanza: La domanda si presenta tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio (ora accorpate nel sistema Unioncamere) . Occorre inserire dati anagrafici, una relazione sulle cause della difficoltà e dichiarare la volontà di avviare la procedura. In pratica, si compila un modulo dove si dichiara: “l’impresa si trova in condizione di difficoltà tale da poter essere reversibile e intende accedere alla composizione negoziata; si chiede la nomina di un esperto indipendente” . Vanno allegati numerosi documenti: gli ultimi 3 bilanci depositati, le ultime dichiarazioni fiscali, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (specie se l’ultimo bilancio ha più di 6 mesi), l’elenco dettagliato dei creditori con importi e natura dei crediti (privilegiati, chirografari), un certificato che attesti i debiti fiscali e contributivi (estratto delle pendenze con AdER e il DURC INPS), l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti e un attestato antimafia . In pratica serve una due diligence interna seria. Non ci si improvvisa: già preparare l’istanza richiede l’ausilio di un professionista per raccogliere tutto e spesso per predisporre un embryo di piano.
Nomina dell’esperto e svolgimento: Una volta presentata l’istanza, la palla passa alla Camera di Commercio competente (quella della provincia dove l’azienda ha sede). Il Segretario Generale, entro breve tempo (la norma dice entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza , ma in pratica l’Unione Camere ha indicato un termine fino a 30 giorni in casi complessi ), nomina un esperto indipendente scelto da un apposito Albo nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia . L’esperto è in genere un commercialista, avvocato o consulente con specifiche competenze in risanamenti, che deve agire con imparzialità tra le parti. Nominato l’esperto, si tiene un primo incontro con l’imprenditore entro pochi giorni (indicativamente entro 10 giorni) . L’esperto studia la documentazione fornita, valuta la situazione e convoca successivamente i principali creditori per avviare le trattative . La legge prevede che la durata della composizione negoziata sia di 180 giorni prorogabili di altri 180 su richiesta motivata . Quindi massimo 12 mesi in totale. Durante questo periodo, l’impresa continua ad operare normalmente, sotto la supervisione “morbida” dell’esperto (che può dare consigli ma non ha poteri di gestione) .
Strumenti in mano all’esperto/debitore durante la CNC: possono chiedere al Tribunale misure protettive e cautelari (art. 18-20 CCII). Le misure protettive sono essenzialmente la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa per la durata delle trattative . Significa bloccare pignoramenti, sospendere i termini di scadenza di istanze di fallimento, impedire iscrizioni di ipoteche o privilegi durante la CNC. La concessione di tali misure non è automatica: va richiesta con ricorso al tribunale allegando l’istanza di CNC e una dichiarazione sull’attendibilità dei dati aziendali. Il tribunale, valutato che la società merita tutela (cioè che sta trattando in buona fede e c’è possibilità di accordo), emette decreto di concessione della protezione. Le misure cautelari, invece, possono consistere in autorizzazioni specifiche: ad esempio, l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili, o a trasferire l’azienda senza incorrere in revocatoria, o – come già detto – a pagare fornitori essenziali o dipendenti nonostante la pendenza della procedura . In sintesi, l’imprenditore in CNC può chiedere al giudice di “poter fare cose” che normalmente in pre-insolvenza non si oserebbero fare per timore di azioni revocatorie, e di “proteggersi” dai creditori ostili nel frattempo.
Esito della CNC: La composizione negoziata si può concludere in diversi modi :
- Accordo stragiudiziale con taluni creditori: ad esempio l’imprenditore potrebbe trovare un accordo individuale con le banche (tipo un piano bilaterale di ristrutturazione del debito bancario) e magari con qualche fornitore chiave, risolvendo così la maggior parte dei problemi e decidendo di interrompere la CNC perché ha raggiunto lo scopo. Oppure potrebbe ottenere una moratoria dalle banche e quindi proseguire l’attività senza necessità di altro.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII: se riesce a farsi sottoscrivere l’accordo dal 60% dei crediti, può passare a richiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (ordinario, agevolato al 30% di soglia per le misure protettive, o ad efficacia estesa se riesce ad avere il 75% di una categoria come le banche) . In pratica la CNC diventa il trampolino per depositare un accordo formale in tribunale.
- Piano attestato di risanamento: se le trattative si chiudono con un’intesa contrattuale con tutti o quasi i creditori, l’imprenditore può formalizzare un piano attestato e pubblicarlo, uscendo dalla CNC e confidando nel risanamento privato .
- Concordato preventivo (o concordato minore): se emergono criticità tali da dover coinvolgere il tribunale e tutte le parti, l’esito può essere il deposito di una domanda di concordato (che sia “concordato preventivo” per imprese non piccole, o “concordato minore” se sotto soglia) . In caso di procedura concordataria, la CNC sostanzialmente si chiude e subentra la nuova procedura concorsuale.
- Concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII): ipotesi particolare prevista proprio dal DL 118/2021: se la CNC fallisce nel senso che non si trova alcuna soluzione di risanamento ma c’è ancora un patrimonio da liquidare, l’imprenditore entro 60 giorni dalla relazione finale negativa dell’esperto può proporre al tribunale un concordato semplificato di liquidazione, senza votazione dei creditori . È un modo per evitare il fallimento convertendo la CNC in un concordato liquidatorio rapido (lo vedremo meglio più avanti).
- Liquidazione controllata: se l’impresa è sotto soglia e non c’è prospettiva di risanamento, può accedere direttamente alla liquidazione controllata dei beni (ex procedura di sovraindebitamento) , che è anch’essa una procedura concorsuale ma semplificata.
Va sottolineato che circa il 40% delle CNC finora attivate (dati 2023) si concludono con un accordo stragiudiziale o un piano attestato, un altro 40% circa sfocia in procedure concorsuali (concordati, accordi omologati) e il resto in liquidazioni o archiviazioni. Quindi è uno strumento che, pur nuovo, sta producendo risultati pratici.
Vantaggi della composizione negoziata: – Riservatezza e reputazione: la CNC non è pubblica finché non si chiedono misure protettive (anche in quel caso la pubblicità è limitata). Niente è pubblicato sul Registro Imprese se non su istanza (a differenza del concordato che è subito pubblicato). Ciò riduce lo stigma e consente di lavorare “sottotraccia” al risanamento . – Continuità aziendale totale: l’imprenditore resta al timone, non c’è un commissario che autorizza gli atti. Questo permette rapidità nelle decisioni quotidiane e soprattutto non allarma clienti e fornitori con l’arrivo di un amministratore giudiziario. L’esperto è solo un facilitatore. – Sospensione delle azioni esecutive: con le misure protettive, l’imprenditore ottiene uno stay generale dei creditori simile a quello del concordato, ma in una cornice volontaria . Questo è fondamentale per lavorare al piano senza dover spegnere incendi ogni giorno. – Nuova finanza protetta: durante la CNC è possibile ottenere finanziamenti in prededuzione (art. 22 CCII) con il placet dell’esperto, il che può dare ossigeno senza il timore che quei prestiti finiscano in coda se poi la cosa va male . Anche gli atti autorizzati (come cessioni di ramo d’azienda) sono esentati da revocatoria. – Focus sulla conservazione dell’impresa: l’esperto ha il compito di cercare soluzioni che mantengano l’attività in vita. Non avendo poteri impositivi, cerca di convincere le parti su un punto di equilibrio. Questo clima negoziale può salvare valore (know-how, avviamento, posti di lavoro) che un fallimento spazzerebbe via.
Svantaggi e limiti della CNC: – Volontarietà dei creditori: la CNC non impone nulla ai creditori. Se alcuni creditori chiave non collaborano (ad es. un fondo speculativo che ha rilevato i debiti bancari e vuole liquidare tutto), la CNC può fallire per mancanza di adesioni . Non c’è voto a maggioranza: serve convincere tutti quelli indispensabili. – Richiede trasparenza e disciplina al debitore: l’imprenditore deve mettere le carte in tavola, fornire dati completi e veritieri (altrimenti l’esperto ne prende atto e può chiudere la procedura) . Alcuni imprenditori, poco abituati alla trasparenza, faticano con questo approccio. – Non adatta a insolvenze gravi: se l’azienda è ormai decotta (patrimonio nettamente negativo, perdite continue, niente prospettive di mercato), la CNC non serve: è solo un rinvio di un esito inevitabile . In quei casi il codice stesso indirizza verso la liquidazione giudiziale. – Costi comunque presenti: sebbene extragiudiziale, la CNC comporta costi professionali (l’esperto va pagato secondo tariffe ministeriali, e spesso ci si avvale di consulenti aziendali per predisporre i piani) e richiede impegno di risorse manageriali per le trattative.
In conclusione, la Composizione Negoziata è oggi lo strumento principe per affrontare le crisi in fase iniziale. Dal punto di vista del debitore, offre una chance di ristrutturazione “concordata” con i creditori, evitando l’impatto reputazionale di un fallimento o di un concordato tradizionale, e massimizzando le possibilità di restare in attività. Va attivata per tempo: se un’azienda di alesatura vede all’orizzonte 6 mesi difficili (pochi ordini, cassa che si svuota, fornitori da pagare), può iniziare una CNC e magari nel giro di 3-4 mesi uscirne con accordi che le permettono di superare la tempesta. Se invece aspetta di avere l’ufficiale giudiziario alla porta, sarà troppo tardi per negoziare alcunché.
3.2 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento di natura privatistica, già previsto dalla legge fallimentare (art. 67 co.3 lett. d, introdotto nel 2005) e ora disciplinato all’art. 56 CCII . In sostanza, l’imprenditore elabora, con l’ausilio di advisor, un piano economico-finanziario dettagliato che deve essere idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa. Un professionista indipendente (revisore o esperto ex art. 2 CCII) redige quindi una relazione di attestazione in cui certifica: 1) la veridicità dei dati aziendali di partenza e 2) la fattibilità del piano proposto . Il piano accompagnato da tale relazione viene pubblicato nel Registro delle Imprese affinché se ne dia contezza ai terzi.
Il beneficio legale principale è che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato e pubblicato non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . Ciò rassicura molto i creditori che collaborano al piano, i quali temono sempre che, se l’azienda poi fallisce, vengano revocati i pagamenti incassati o le ipoteche ricevute. Con il piano attestato pubblicato questa spada di Damocle viene rimossa (limitatamente a ciò che rientra nell’esecuzione del piano).
Contenuto di un piano attestato tipico: Secondo la prassi, un piano attestato ben fatto contiene almeno: 1. Analisi della crisi e cause: descrizione del settore, dei problemi insorti (es. calo commesse automotive, aumento costo materie prime, ecc.) . 2. Stato attuale economico-patrimoniale: bilancio riclassificato, posizione finanziaria netta, elenco esposizioni verso ciascun creditore . 3. Proiezioni economico-finanziarie: stime di fatturato futuro, scenario base e magari scenario pessimistico, flussi di cassa attesi per almeno 3-5 anni . 4. Manovra finanziaria: l’insieme delle operazioni proposte per risanare: ad es. aumenti di capitale, dismissione di un immobile non strategico, rinegoziazione mutui, conversione debiti fornitori in prestiti, nuova finanza da soci . 5. Timeline degli interventi: il piano deve scandire i tempi (es. entro 6 mesi vendiamo il capannone secondario, con ricavato X paghiamo i debiti tributari arretrati al 50% in accordo, ecc.). 6. Attestazione finale: il professionista assevera che i numeri iniziali sono corretti e che, sulla base delle ipotesi indicate, il piano è fattibile e permette il riequilibrio .
Spesso il piano includerà singoli accordi negoziati con i creditori. Ad esempio: “Banca Alfa proroga il mutuo di 5 anni, Fornitore Beta accetta un pagamento del 70% entro 12 mesi a saldo e stralcio, Fisco: si aderisce a rottamazione-quater per €50k, Socio: apporta €100k di equity nuovo”. Tutto questo integrato in una manovra unitaria.
Vantaggi del piano attestato: – Riservatezza e snellezza: non serve omologa del tribunale, si evita tutta la procedura giudiziale. Si tratta di un accordo privato e la pubblicità è limitata alla nota sul Registro Imprese e sul portale CCII. – Nessuna dichiarazione di crisi/insolvenza: l’azienda resta formalmente in bonis, non subisce lo “stigma” di una procedura concorsuale. – Protezione delle operazioni realizzate: come detto, chi partecipa al piano può stare relativamente tranquillo che se anche la società malauguratamente fallisse dopo 1 o 2 anni, i pagamenti ricevuti in adempimento del piano non verranno attaccati dal curatore .
Svantaggi: – Nessun effetto automatico verso i dissenzienti: se un creditore non aderisce, resta fuori e potrà agire a piacimento (da qui l’esigenza di coinvolgere almeno quelli principali). In caso di molti creditori non collaborativi, il piano attestato non regge: è preferibile un accordo di ristrutturazione omologato o un concordato. – Minor “tenuta” in caso di scenario avverso: non essendoci la forza del tribunale dietro, basta un creditore riottoso per far saltare il banco. Ad esempio, se un fornitore non firmatario ottiene un pignoramento su un conto, potrebbe far fallire l’accordo costringendo l’impresa a deviare risorse, ecc. – Costi dell’attestazione: l’attestatore indipendente va remunerato (anche qui, come per l’esperto CNC, solitamente si tratta di commercialisti), e il lavoro per predisporre un buon piano è consistente. Tuttavia, di norma, i costi di un piano attestato sono inferiori a quelli di una procedura concorsuale vera e propria (niente commissari, meno adempimenti formali).
Quando è indicato: Il piano attestato funziona bene quando pochi creditori rilevanti sono coinvolti e c’è fiducia reciproca. Ad esempio, classico caso: l’impresa ha principalmente debito con banche (magari 2 banche) e con il fisco. Si attesta un piano in cui le banche concordano la ristrutturazione e il fisco viene soddisfatto tramite rottamazione o transazione. Aderendo le banche e con il fisco che, se c’è rottamazione, non si oppone, l’impresa esegue e risana. Se invece ci sono centinaia di piccoli fornitori coinvolti, è difficile far firmare a tutti accordi bilaterali: meglio passare per un concordato.
3.3 Accordi stragiudiziali informali e moratorie settoriali
Oltre ai due strumenti codificati sopra (CNC e Piano attestato), esistono prassi di gestione stragiudiziale meno formalizzate:
- Moratorie ABI o convenzioni interbancarie: in certe crisi sistemiche, l’ABI (Associazione Bancaria) e il Governo hanno promosso accordi-quadro (es. moratoria PMI 2015, accordo per il credito 2019, misure COVID 2020) per sospendere o allungare prestiti su richiesta delle imprese, con adesione volontaria delle banche. Questi strumenti straordinari, quando attivi, vanno sfruttati perché offrono sollievo immediato (es. sospensione rate per 6 mesi) su base generalizzata.
- Accordi di standstill con pool di banche: se l’impresa ha debiti con più banche, può cercare di far firmare a tutte un accordo di standstill, in cui si impegnano a non prendere azioni individuali e a mantenere le linee fidi in essere per un periodo (es. 6 mesi) durante il quale l’azienda elabora un piano di ristrutturazione. È un impegno contrattuale privato, spesso il preludio a un accordo di ristrutturazione ex lege.
- Patti con fornitori e clienti: come accennato, coinvolgere la filiera può aiutare: i fornitori strategici potrebbero accettare di continuare le forniture in cambio di pagamenti immediati di una parte e dilazione del resto (per evitare di perdere il cliente), i clienti importanti potrebbero accettare di pagare anticipatamente una parte delle commesse in corso per sostenere il fornitore in difficoltà (specie se dal fornitore dipende la loro produzione). Tali accordi sono spesso informali e basati su relazioni di fiducia.
- Rinegoziazione del debito “a saldo e stralcio”: come trattato, proporre transazioni a ciascun creditore, se fattibile, porta l’azienda a ridurre il debito complessivo. Esempio: se la società dispone di una certa liquidità (o di un supporto dei soci), può offrirla pro-quota ai creditori chirografari, ottenendo quietanze liberatorie. Questo approccio necessita che ogni creditore accetti volontariamente la riduzione; se l’adesione è ampia, l’impresa può evitare la concorsuale.
Attenzione: questi accordi frammentati funzionano solo se la crisi non è troppo grave e se c’è unanimismo. Se anche solo un creditore “rompe le righe” e fa partire un pignoramento o un’istanza di fallimento, l’intero castello rischia di crollare. Quindi, si usano preferibilmente in fasi iniziali e con un numero limitato di controparti. Se invece l’impresa è in situazione multi-debito e qualcuno scalpita, conviene incanalarli in uno strumento giuridico ordinato (accordo omologato o concordato) che abbia efficacia anche sui dissenzienti.
Nei prossimi capitoli, analizzeremo gli strumenti giudiziali e concorsuali veri e propri (accordi di ristrutturazione omologati, concordati preventivi ordinari e minori, concordato semplificato, liquidazione giudiziale e controllata), che entrano in gioco quando la soluzione stragiudiziale pura non è sufficiente o non ha successo.
4. Accordi di ristrutturazione dei debiti omologati
Gli accordi di ristrutturazione sono procedure ibride: sono accordi negoziati con i creditori, ma ricevono un sigillo dall’autorità giudiziaria (omologa) che conferisce loro effetti protettivi anche verso terzi o creditori non aderenti. Introdotti per la prima volta nel 2005 (art. 182-bis legge fall.), sono oggi disciplinati dagli artt. 57–64 CCII .
Nozione generale (art. 57 CCII): Si tratta di convenzioni tra l’imprenditore debitore e una percentuale qualificata di creditori, volte a ristrutturare l’indebitamento e assicurare il riequilibrio finanziario. Se tali accordi vengono omologati dal tribunale, essi producono effetti anche verso i creditori estranei secondo quanto previsto dalla legge . Dunque, non serve l’unanimità: una maggioranza di creditori vincola la minoranza dissenziente. Nel contempo, l’impresa evita il “peso” di un concordato vero e proprio, essendo un procedimento più snello e rapido.
Tipologie di accordi di ristrutturazione: il CCII ha ampliato e articolato i tipi di accordi disponibili :
- Accordo ordinario (art. 57): richiede l’adesione di almeno il 60% dei creditori (in valore sul totale crediti). Era la versione originaria. Non prevede misure speciali per i restanti creditori se non la moratoria ex art. 58 per quelli estranei (che però possono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa se privilegiati, o entro 120 giorni dalla scadenza se futuri).
- Accordo agevolato (art. 60): introdotto dalla riforma del 2020/2022 per incentivare l’uso dello strumento. Prevede due soglie: è sufficiente il 30% di adesioni per poter chiedere le misure protettive al tribunale (in pratica, già col 30% di concordato si possono bloccare le azioni), e resta il 60% per l’omologa . Inoltre, consente di includere nel perimetro dell’accordo anche i crediti fiscali e contributivi con possibilità di falcidia e dilazione analoghe al concordato . Vantaggi: soglia ridotta per attivare subito la protezione, possibilità di standstill anticipato, e procedimento più semplificato.
- Accordo ad efficacia estesa (art. 61): serve per superare il tipico problema delle ristrutturazioni finanziarie, in cui magari il 75% delle banche è d’accordo ma una minoranza dissenziente rischia di far saltare tutto. Questa norma permette che, se in una determinata categoria omogenea di creditori (ad es. banche chirografarie, o obbligazionisti) aderisce almeno il 75% di quella categoria, l’accordo sia esteso anche ai creditori non aderenti di quella categoria . È una forma di cram-down settoriale. Naturalmente serve che i non aderenti siano informati e abbiano possibilità di opposizione in omologa, ma se il giudice ritiene che l’accordo non li peggiora rispetto a uno scenario di liquidazione, li vincola comunque. Utile soprattutto con istituti di credito o bondholder riottosi.
- Accordo con transazione fiscale (artt. 63–64): È la versione con inclusi i debiti fiscali e contributivi falcidiati. Come detto, il correttivo 2024 ha unificato la disciplina fiscale/contributiva del concordato e accordi: ora, col piano attestato che mostra convenienza per l’Erario, è possibile proporre pagamento parziale di imposte e contributi . In più, se l’Erario rifiuta ma il piano offre almeno il 50% in 10 anni e c’è accordo con gli altri creditori, il tribunale può omologare comunque (cram-down fiscale) . In pratica, l’accordo con transazione fiscale richiede l’attestazione di un esperto che ciò che si offre al fisco è ≥ di quanto prenderebbe dal fallimento . L’Agenzia Entrate ha 90 giorni per rispondere; il silenzio vale come assenso . Questo strumento è potentissimo perché consente di comporre anche i debiti erariali al pari di quelli privati, risolvendo uno dei talloni d’Achille delle ristrutturazioni passate (dove il fisco era rigidissimo).
Procedimento di omologazione: L’iter per concludere un accordo di ristrutturazione è schematicamente il seguente :
- Negoziazione privata: l’impresa, con i suoi consulenti, elabora un piano e lo propone ai creditori. Si raccolgono le adesioni formali (accordi firmati, spesso lettere di commitment condizionate all’omologa). È importante farsi firmare accordi che contengano clausole di standstill nel frattempo.
- Deposito del ricorso in tribunale: una volta raggiunta la soglia (≥60% di adesioni, o anche 30% se vuole misure protettive immediate), il debitore deposita un ricorso per omologa presso il tribunale competente . Deve allegare l’accordo con l’elenco dei creditori aderenti e non, la relazione del professionista attestatore e tutta la documentazione contabile. L’art. 48 CCII prevede che il ricorso sia pubblicato nel Registro delle Imprese il giorno stesso del deposito. Anzi, la giurisprudenza ha chiarito che l’omologa è inammissibile se non c’è stata questa pubblicità preventiva , perché serve a informare eventuali creditori non aderenti per permettere opposizioni.
- Richiesta misure protettive (facoltativa): se necessario, il debitore può chiedere al tribunale di sospendere azioni esecutive e cautelari in corso. Nel caso di accordo agevolato, come detto, basta dimostrare il 30% di adesioni per ottenere queste misure . Se è un accordo ordinario, servirebbe il 60% già raggiunto, ma nella pratica quando depositi ne hai comunque il 60%. Il tribunale decide con decreto sull’applicazione dello stay.
- Nomina eventuale del commissario e udienza: di norma per l’accordo non è obbligatorio un commissario, ma il tribunale può nominarne uno se lo ritiene necessario per vigilare sulla gestione fino all’omologa (specie se c’è misure protettive in corso). Fissa poi un’udienza, entro 4 mesi circa, in cui sentirà le parti e verificherà i requisiti.
- Omologazione: il giudice omologa l’accordo se: è rispettata la percentuale di legge; il piano appare sostenibile e conveniente per i creditori che restano vincolati; i creditori estranei sono stati o soddisfatti integralmente entro i termini o non subiscono pregiudizio dalla dilazione; i creditori pubblici ricevono almeno quanto la liquidazione (c’è ora la possibilità di una moratoria di 2 anni per i privilegiati nel giudizio di convenienza) . L’omologa rende l’accordo efficace verso tutti i creditori indicati. I creditori non aderenti, per legge, restano fuori dall’accordo ma se chirografari sono bloccati nelle azioni esecutive fino a 120 giorni dall’omologa, e se privilegiati vanno pagati entro 180 giorni dall’omologa (o 120 dalla scadenza naturale se successiva), pena l’inefficacia per loro.
- Esecuzione: una volta omologato, l’accordo viene eseguito: il debitore deve adempiere alle obbligazioni previste (pagare le percentuali stabilite, concedere garanzie, ecc.). Se poi il debitore non rispetta l’accordo, i creditori tornano liberi di agire individualmente; ma se lo rispetta, il debito si ridetermina come da accordo.
Accordi nei gruppi di imprese: Accenniamo che l’art. 64 CCII prevede accordi di ristrutturazione di gruppo , dove più società collegate presentano un unico piano coordinato e domanda congiunta di omologa. Questo serve per conglomerati dove magari la capogruppo e le controllate hanno situazioni intrecciate. In un settore come quello meccanico, può essere utile se c’è, ad esempio, una holding finanziaria e una società operativa, entrambe da ristrutturare insieme per efficacia.
Vantaggi per il debitore: L’accordo di ristrutturazione è una sorta di “concordato light”: – preserva la governance (nessuna decadenza degli amministratori, a meno che il tribunale non imponga un commissario), – è tendenzialmente più rapido e meno costoso (mancano tutte le fasi di voto, adunanza dei creditori, etc.), – consente di cristallizzare posizioni: una volta omologato, l’accordo è legge tra le parti e mette fine a contestazioni sul passato. – Consente una certa flessibilità: i creditori possono concordare anche operazioni complesse (swap debito-equity, ristrutturazioni di contratti) che nel concordato sarebbero più rigide.
Svantaggi/limiti: – Richiede comunque un’adesione molto elevata (60%). Non sempre facile da ottenere, specie con creditori numerosi e dispersi. – I creditori non aderenti, se rilevanti, possono fare opposizione e far saltare l’omologa se dimostrano un pregiudizio. – Finché non è omologato, l’accordo è fragile: se una parte importante si sfila, va da sé che bisogna rifare i conti, o se un estraneo ottiene una sentenza immediata può creare caos (ma per questo conviene chiedere subito protezione). – Dopo omologa, se l’impresa va comunque in default e finisce in liquidazione giudiziale, l’accordo viene travolto come visto (i crediti risorgono al lordo, salvo i pagamenti già eseguiti in prededuzione) . Dunque è “win or die”: se il risanamento fallisce, non c’è scarico di residui come può avvenire con l’esdebitazione post-fallimentare.
Nella pratica italiana, gli accordi di ristrutturazione sono stati molto usati da medio-grandi imprese con poche banche esposte (es. ristrutturazioni industriali con pool bancari). Con la riforma 2022-24, estendendoli anche ai piccoli (accordi minori, che vedremo) e rendendoli più flessibili, si cerca di aumentare il loro utilizzo.
5. Concordato preventivo (ordinario e “minore”): continuità e liquidazione
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza che consente al debitore di evitare la liquidazione fallimentare, offrendo un piano ai creditori sotto il controllo del tribunale. È una procedura giudiziale vera e propria, con nomina di organi (commissario giudiziale), voto dei creditori e omologazione da parte del tribunale. Il concordato può essere di due tipi fondamentali: in continuità aziendale (l’impresa prosegue l’attività, sia direttamente sia indirettamente tramite cessione o conferimento) oppure liquidatorio (cessazione dell’attività e liquidazione del patrimonio ai creditori).
Il CCII disciplina il concordato preventivo agli artt. 84–118. Ha recepito molte innovazioni introdotte già dalla prassi: ad esempio, formalizza la suddivisione dei creditori in classi, consente soluzioni più flessibili per il pagamento dei privilegiati, prevede tempi più rapidi per certe fasi, ecc. .
Prima di entrare nei dettagli, notiamo che esiste anche il “concordato minore” (artt. 74–83 CCII) riservato ai debitori non soggetti a liquidazione giudiziale (cioè le imprese sotto soglia e i debitori civili). Questo concordato minore è simile al concordato preventivo ma con alcune semplificazioni e senza obbligo di classi . Ne parleremo a parte al §5.3. Per ora, con “concordato preventivo” intendiamo quello per imprese maggiori.
5.1 Presupposti e apertura della procedura
Chi può proporre il concordato preventivo? L’imprenditore in stato di crisi o insolvenza che esercita un’attività commerciale (non piccolo, quindi fallibile) può domandare di essere ammesso al concordato . Nel CCII “stato di crisi” significa anche probabilità di futura insolvenza, quindi non serve essere proprio insolventi già, si può accedere anche in pre-insolvenza. Questo è in linea col principio di early access. Peraltro, il “correttivo ter” 2024 ha precisato che la presenza di un’istanza di fallimento pendente non preclude la proposizione di un concordato (prima c’erano dubbi, ora è chiaro che se il debitore propone un concordato, la dichiarazione di insolvenza viene sospesa in attesa dell’esito) .
Domanda di concordato e “concordato in bianco”: L’imprenditore deve depositare un ricorso al tribunale, corredato da una proposta di concordato, un piano e la documentazione obbligatoria (bilanci ultimi 3 anni, relazione sulla situazione patrimoniale, elenco creditori e relativi privilegi, elenco beni, elenco dei contratti pendenti, certificato debiti fiscali e contributivi, relazione di un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano) . Redigere tutto questo è oneroso; per evitare perdita di tempo in situazioni urgenti, la legge consente il ricorso “prenotativo” o concordato con riserva (art. 44 CCII, ex art. 161 co.6 l.f.), detto volgarmente “concordato in bianco”. Si presenta cioè una domanda incompleta, chiedendo al tribunale un termine (da 60 a 120 giorni, prorogabile max 60) per depositare la proposta e il piano definitivi. Con il deposito del ricorso in bianco e la pubblicazione al registro, l’impresa ottiene subito le misure protettive automatiche (stay delle azioni esecutive) per la durata concessa . Questo serve a “prendere tempo” ed evitare pignoramenti mentre si finalizza il piano. Ovviamente il tribunale valuta a grandi linee che la prospettiva di ammissione sia seria, per dare il termine.
Ammissione e voto: Una volta presentato il piano e proposta, il tribunale fa un controllo di ammissibilità: verifica la completezza formale, l’assenza di cause di inammissibilità (piani manifestamente irrealizzabili, atti di frode ai creditori, ecc.). Se tutto ok, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, nomina un Commissario Giudiziale (professionista terzo che sorveglia la gestione) e fissa l’adunanza dei creditori per la votazione, di solito entro 90-120 giorni . Nel frattempo i creditori devono depositare le loro prove di credito (domande di ammissione al voto). In realtà, con le nuove norme, spesso si fa la “votazione senza adunanza fisica”: i creditori possono esprimere il voto per iscritto prima dell’adunanza e se si raggiungono le maggioranze non serve neanche tenere la riunione.
I creditori vengono divisi in classi se opportuno (obbligatorio se ci sono creditori con interessi differenti). Ad esempio, separare banche, fornitori, Fisco, ecc. Il commissario predispone una relazione per i creditori dove analizza la proposta. I creditori quindi votano: serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (≥50% in valore). Se ci sono classi, la maggioranza è calcolata sul totale e in più serve l’approvazione di oltre la metà delle classi votanti (questo per evitare che una classe sola di grossi creditori schiacci tutti gli altri). Se il concordato ottiene la maggioranza richiesta, si passa all’omologazione da parte del tribunale; se non ottiene i voti, il tribunale dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale).
Omologazione: Il tribunale omologa il concordato se ci sono state le maggioranze e se non ci sono opposizioni fondate. Un creditore dissenziente può opporsi sostenendo che il piano lo danneggia rispetto a un’alternativa liquidatoria: il giudice valuta la convenienza (principio del “best interest of creditors” anche recepito dalla direttiva UE). Se ritiene che il concordato offra ai creditori dissenzienti non meno di quanto avrebbero dalla liquidazione giudiziale, omologa nonostante l’opposizione. Altrimenti, rigetta e si apre la via al fallimento. Nel concordato in continuità c’è minor rigidità su certe regole di pagamento dei privilegiati, ma il giudice deve essere convinto che la continuità non danneggia i creditori in termini di risultato finale.
Effetti del concordato: con l’omologa, la procedura di concordato vincola tutti i creditori anteriori (anche se non hanno votato o hanno votato contro). I debiti vengono soddisfatti come da piano (in parte immediatamente, in parte rate, in parte stralcio). L’azienda può proseguire l’attività se era un concordato in continuità; se era liquidatorio, i beni vengono venduti da un liquidatore nominato e poi la società sarà cancellata. In entrambi i casi, una volta eseguito il concordato, il debitore viene liberato dai debiti residui come effetto dell’adempimento. In pratica, il concordato omologato ed eseguito è una esdebitazione anticipata per la società (diversamente dall’esdebitazione post-fallimentare che riguarda l’imprenditore persona fisica, qui è la procedura stessa che lo “pulisce” dai debiti concordatari).
Revoca e risoluzione: se si scoprono atti di frode durante la procedura (il debitore ha nascosto beni, falsificato passivo, ecc.), il tribunale può revocare l’ammissione e mandarlo al fallimento . Oppure, se dopo omologato, il debitore non rispetta gli impegni (non paga le percentuali promesse), ogni creditore insoddisfatto può chiederne la risoluzione e allora si aprirà comunque la liquidazione giudiziale.
5.2 Concordato in continuità aziendale
Il concordato in continuità (art. 84 CCII) è quello in cui l’attività dell’impresa prosegue, assicurando almeno in parte la prosecuzione della produzione e dei contratti. La continuità può essere diretta (la stessa società prosegue la gestione, eventualmente ridimensionata) o indiretta (il piano prevede la cessione o conferimento dell’azienda a un altro soggetto che continua l’attività). Ad esempio, un concordato può prevedere che l’azienda di alesatura venga affittata a una NewCo di investitori che portano capitale e poi alla fine del concordato venga ceduta a loro definitivamente: questo è continuità indiretta.
Caratteristiche peculiari: – Obbligo di soddisfare i creditori in misura non inferiore al valore di liquidazione dei beni (principio generale, quindi se la continuità dà meno soldi di una vendita spezzatino, va bocciata). – Possibilità di derogare alla regola di pagamento integrale dei creditori privilegiati: nel concordato liquidatorio, i creditori con privilegio (garanzie reali, prelazioni) devono essere pagati integralmente salvo che rinuncino o che dimostrino che il bene sottostante non copre l’intero credito (cosiddetta falcidia se parzialmente scoperto). In continuità aziendale, invece, è ammessa la falcidia anche dei creditori privilegiati purché venga assicurato il pagamento integrale in caso di liquidazione entro la fine del piano se la continuità fallisce . Questo concetto era introdotto dalla giurisprudenza sul “concordato con continuità indiretta” e ora recepito: ad esempio, si può pagare un ipotecario al 70% in un concordato in continuità se dimostri che quell’ipoteca in caso di fallimento avrebbe preso zero perché l’azienda chiusa avrebbe svuotato il valore del cespite. Insomma c’è flessibilità in più. – Moratoria fino a 2 anni per i creditori privilegiati: se la continuità richiede investimenti o mantenimento di liquidità in azienda, la legge consente di posticipare fino a 24 mesi dall’omologa il pagamento delle classi di creditori privilegiati, anche senza corrispettivo in interessi . Questa è un’altra agevolazione introdotta (già prevista dal DL 83/2015 e ora nel CCII). – Mantenimento contratti e autorizzazioni: in continuità, contratti pendenti essenziali non si interrompono (es. contratti di fornitura energia, leasing di macchinari, appalti in corso), anzi il CCII prevede che non possano essere risolti dal contraente per il solo fatto della presentazione del concordato (clausole ipso facto nulle). Anche le autorizzazioni amministrative (licenze, concessioni) rimangono in capo all’azienda in concordato e possono essere trasferite se c’è cessione d’azienda. – Finanza esterna prededucibile: per far funzionare la continuità spesso servono soldi freschi – fornitori per merce corrente, prestiti ponte. La legge incoraggia ciò: ha introdotto la prededuzione per la nuova finanza erogata in esecuzione del concordato autorizzata dal giudice. Ad esempio, se un istituto anticipa liquidità per completare le commesse durante il concordato, verrà rimborsato prima di tutti come costo della procedura, anche se il concordato poi fallisse. Questo stimola l’ingresso di investitori. – Salvaguardia dei posti di lavoro: la ratio del concordato in continuità è anche sociale: mantenere l’impresa viva e i lavoratori occupati. Spesso i piani in continuità includono accordi sindacali, cassa integrazione, ecc., per gestire l’organico in maniera sostenibile. Va segnalato che la legge consente nel concordato di variare i contratti di lavoro in accordo coi sindacati (art. 90 CCII), per es. riduzione personale, trasferimenti, purché approvati dal Ministero del Lavoro.
In sintesi, il concordato in continuità è la soluzione più complessa ma quella che mira alla sopravvivenza dell’azienda. Dal punto di vista del debitore, può significare salvare l’impresa a prezzo di sacrifici (cedere parte dell’equity a nuovi investitori, rinunciare a beni non strategici, etc.) ma conservando il “core business”. Dal punto di vista dei creditori, accettano di solito percentuali di soddisfo inferiori a quelle di un concordato liquidatorio, confidando però di ricavare benefici indiretti (es. continuare ad avere l’azienda come cliente/fornitore, evitare impatti sociali sul territorio, etc.).
5.3 Concordato liquidatorio (e concordato semplificato di liquidazione)
Il concordato liquidatorio è invece quello in cui l’obiettivo è la dismissione di tutto il patrimonio e la cessazione dell’attività, però in modo concordato con i creditori (in alternativa al fallimento). Tradizionalmente, la legge lo rendeva poco conveniente per il debitore, richiedendo ad es. che offrisse almeno il 20% ai chirografari, e vietando di intaccare i diritti dei privilegiati. Il CCII ha confermato in gran parte questi vincoli, pur con qualche flessibilità:
- Soglia di soddisfacimento ai chirografari: l’art. 84 CCII prevede che se il concordato non prevede la continuità aziendale (quindi è liquidatorio puro), debba assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari . (Nota: in alcune bozze di riforma questa soglia si voleva innalzare al 30%, ma ad oggi è rimasta 20%). Se il debitore non è in grado di offrire almeno 20, il concordato liquidatorio non è ammissibile, preferendo il legislatore in tal caso la via del fallimento con possibile intervento del Fondo di garanzia per i crediti lavoro ecc.
- Divieto di falcidia dei privilegiati oltre valore del bene: in liquidatorio vale la regola classica: un creditore con privilegio su un bene (es ipoteca su immobile, pegno su cespite) deve ricevere almeno il valore di stima di quel bene. Se il piano prevede di vendere un capannone ipotecato, dovrà destinare all’ipotecario quell’importo stimato di realizzo (al netto costi). Solo la parte del credito eventualmente eccedente il valore stimato può diventare chirografaria e prendere la percentuale. Questo per rispettare le cause legittime di prelazione.
- Obbligo di liquidazione tramite organi terzi: il CCII ha introdotto che nel concordato liquidatorio deve esserci un liquidatore indipendente nominato dal tribunale (spesso coincide col commissario), che sovraintende o effettua proprio la vendita dei beni. In passato a volte i liquidatori concordatari erano scelti dall’azienda, ora si preferisce terzietà.
- Contributo “esterno” obbligatorio se sotto 20% (concordato con apporto): se la liquidazione dei beni aziendali non arriva a soddisfare il 20%, l’imprenditore può colmare il gap apportando risorse esterne (es. denaro fresco dei soci) per raggiungere la soglia. Solo così può essere ammissibile.
In sostanza, il concordato liquidatorio è meno vantaggioso per il debitore rispetto al concordato in continuità, perché i creditori devono avere un ritorno minimo. Perché allora farlo? Tipicamente, se l’imprenditore vuole evitare le implicazioni del fallimento (stigma, possibili azioni di responsabilità aggravate, tempi lunghi) e magari garantire una più ordinata vendita degli asset (es. vendere l’azienda intera a un competitor invece che farla smembrare all’asta, ottenendo forse miglior prezzo e salvando qualche posto di lavoro). Spesso si usa quando c’è un compratore interessato all’azienda nel suo complesso: si costruisce un concordato liquidatorio in cui quell’acquirente paga un certo prezzo per l’azienda che va a soddisfare i creditori (un po’ come un’asta concordataria). In tal caso i creditori possono prendere più del valore di realizzo atomistico.
Una variante introdotta dal D.L. 118/2021 è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) . Questo, come accennato, è riservato all’esito infruttuoso di una composizione negoziata: se l’esperto dichiara che non si è trovata soluzione, entro 60 giorni il debitore può proporre un concordato liquidatorio “speciale”. Le particolarità: – Non c’è voto dei creditori. I creditori non approvano, il piano viene presentato direttamente al tribunale . – Il piano deve comunque assicurare una soddisfazione non inferiore alla liquidazione giudiziale (lo attesta l’esperto) e impiegare forme di liquidazione controllate e rapide. – È molto rapido: il tribunale, sentiti i creditori eventualmente in audizione, omologa se ritiene adeguato, oppure rigetta (in tal caso di solito dichiara la liquidazione giudiziale). – Serve l’elemento della “urgenza di salvaguardare il valore”: ad esempio, se c’è un’offerta di acquisto per l’azienda che perderebbe valore in caso di fallimento, il semplificato permette di accettarla subito senza passare mesi in burocrazia concordataria ordinaria. – Il difetto è che non prevede esdebitazione completa: essendo pensato come ultima ratio per evitare il fallimento, se non soddisfa tutti i crediti come promesso, i creditori insoddisfatti possono ancora agire per la parte residua. In pratica è un modo di chiudere la crisi senza tecnicamente “fallire”, ma non garantisce il perdono totale dei debiti .
Il concordato semplificato è uno strumento nuovo e inedito, volto a dare uno sbocco alla CNC fallita. Finora ne sono stati applicati pochissimi casi (pochi tribunali lo hanno omologato, essendo molto “forte” come potere del tribunale di bypassare i creditori). Però rimane nel codice come opzione.
5.4 Concordato “minore” per imprenditori sotto soglia e persone fisiche
Abbiamo detto che le imprese minori (quelle che soddisfano i 3 requisiti di non fallibilità: attivo ≤€300k, ricavi ≤€200k, debiti ≤€500k) non possono accedere al concordato preventivo ordinario . Per loro è previsto il concordato minore (artt. 74–83 CCII), che di fatto ha preso il posto del vecchio “accordo di composizione” della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Il concordato minore: – Lo possono proporre i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, i professionisti, le start-up innovative e le persone fisiche garanti (queste categorie rientrano nel “debitore non fallibile”) . – Non richiede soglia minima di pagamento del 20% come l’ordinario (quella è nata per evitare abusi di grandi imprese). Quindi, teoricamente, anche un concordato minore che paga il 5% potrebbe passare se quello è il valore di liquidazione. – Nessuna suddivisione in classi obbligatoria: solitamente i debitori minori hanno pochi creditori, quindi spesso non si fanno classi. Tutti votano per massa. – Procedura semplificata: il tribunale può decidere di non nominare un commissario (a seconda dei casi, se la situazione è lineare potrebbe omettere la nomina), e di non tenere adunanza fisica. – Tutto il resto è simile al concordato: si deposita proposta, piano con attestazione, si apre la procedura, i creditori votano (maggioranza sempre 50%). – La novità: per i consumatori e soggetti non imprenditori, il concordato minore esiste? La legge sembra destinare il concordato minore solo a chi ha un’attività (imprenditore minore o professionista). Per il consumatore puro resta un altro strumento (piano del consumatore). Ma a volte i confini sfumano, ad esempio un socio che ha garantito debiti aziendali, è persona fisica e tecnicamente potrebbe usare concordato minore? Diciamo che il socio fideiussore di solito rientra comunque nel regime del sovraindebitamento come “consumatore con debiti di garanzia”, su cui Cassazione però ha avuto da ridire: ha stabilito che non può unire in un unico piano del consumatore debiti personali e debiti da garanzia imprenditoriale . Quindi se un socio persona fisica ha sia debiti suoi (mutuo, ecc.) che fideiussioni, deve spezzare: i debiti da garante vanno nel concordato minore dell’impresa (o in liquidazione controllata), quelli personali in un piano del consumatore distinto .
In ogni caso, il concordato minore consente anche alle piccole realtà di offrire ai creditori un accordo concorsuale con l’effetto esdebitativo dell’omologa. Ad esempio, un artigiano sotto soglia con troppi debiti potrebbe proporre un concordato minore offrendo ai creditori di pagare, poniamo, il 30% grazie alla liquidazione di un macchinario e a un contributo di un familiare, venendo esdebitato del restante 70%. Pre-CCII, ciò era il campo del “piano del consumatore” o accordo di composizione L. 3/2012. Ora è il concordato minore se quell’artigiano ha debiti anche professionali.
Va segnalato che, secondo i dati, pochissimi concordati minori sono stati finora omologati: i debitori minori spesso preferiscono la liquidazione controllata o i piani del consumatore, perché il concordato è comunque complesso e costoso (richiede una maggioranza di creditori, che spesso sono banche o fisco non interessati a votare). Per i piccoli, infatti, la via più comune resta la liquidazione controllata con successiva esdebitazione (di cui diremo a breve).
6. Liquidazione giudiziale (ex fallimento) e Liquidazione controllata
Nonostante tutti gli sforzi, può accadere che l’azienda debitrice non riesca a evitare la fine ingloriosa: la procedura concorsuale di liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento). La liquidazione giudiziale viene aperta su istanza di un creditore (o del debitore stesso o di un PM) quando l’imprenditore si trova in stato di insolvenza e non ci sono procedure alternative in corso. Per le imprese sopra soglia, il tribunale, accertata l’insolvenza, dichiara aperta la liquidazione giudiziale, nomina un Curatore che prende in mano l’azienda (l’imprenditore viene spossessato dei poteri di amministrazione e disposizione del patrimonio), e avvia la vendita di tutti i beni per distribuire il ricavato ai creditori secondo le priorità.
Dal punto di vista del debitore, il fallimento è ovviamente l’evento meno desiderabile: si perde l’azienda, la propria reputazione viene colpita (anche se va detto che lo stigma del fallito è molto attenuato nel tempo presente), e si possono subire conseguenze personali (dall’inabilitazione all’esercizio di impresa per qualche anno, all’eventuale azione di responsabilità se si è amministratore di società, fino a eventuali imputazioni penali per condotte pregresse). Tuttavia, il fallimento comporta anche alcuni possibili benefici per l’imprenditore onesto: in particolare, dopo la chiusura della procedura, l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui non soddisfatti) se ha collaborato lealmente . La riforma ha ampliato l’esdebitazione: ora quasi tutti i debiti sono esdebitabili, tranne alcuni come le sanzioni penali, i debiti per mantenimento familiare e i debiti “tributari qualificati” (IVA e ritenute non versate) . Per cui il fallito persona fisica che non ha commesso illeciti e non poteva pagare i creditori, può aspirare a un “fresh start” ottenendo dal tribunale la cancellaizone dei debiti residui. Le società invece, essendo persone giuridiche destinate a estinguersi, non hanno bisogno di esdebitazione (cessando di esistere dopo la liquidazione, i loro debiti insoddisfatti restano inesigibili naturalmente, salvo garanzie di terzi).
La liquidazione controllata dei beni (artt. 268–277 CCII) è l’equivalente del fallimento per i soggetti non fallibili (imprese sotto soglia, consumatori, professionisti). Deriva dalla vecchia “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012. Si accede su richiesta del debitore, dei creditori o anche d’ufficio se un concordato minore o piano falliscono . La procedura è simile al fallimento: c’è un liquidatore nominato, si formano le graduatorie dei crediti, si liquidano i beni. Però ha caratteristiche di maggior snellezza: ad esempio, il liquidatore può essere l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) locale, c’è minor formalità, e soprattutto l’obiettivo dichiarato è fornire al debitore meritevole una rapida esdebitazione. Già la legge prevede che la liquidazione controllata debba concludersi di regola entro 4 anni (prorogabili a 5-6 solo in circostanze eccezionali) , così da non tenere il debitore bloccato troppo a lungo. Alla fine, il debitore persona fisica meritevole è esdebitato automaticamente salvo i debiti esclusi (anche qui, tributari qualificati e pochi altri) . Dunque la liquidazione controllata è uno strumento di “chiusura” delle crisi dei piccoli con finalità di dare un fresh start abbastanza veloce . Per le imprese sotto soglia, la liquidazione controllata significa la cessazione dell’attività ovviamente, ma può anche condurre a esdebitazione dei soci se questi erano responsabili illimitatamente.
In pratica, se la nostra azienda di alesatura è piccola e non ce l’ha fatta con gli accordi, finirà in liquidazione controllata, i beni saranno venduti, e i titolari (se individuali o soci di SNC ad esempio) potranno ripartire da zero senza debiti (eccetto eventuali debiti fiscali IVA che restano a loro carico, ma a quel punto se non hanno patrimonio probabilmente non verranno riscossi).
Confronto finale tra procedure concorsuali (per imprese maggiori e minori):
Per avere una visione sintetica, si propone la seguente tabella riepilogativa dei principali strumenti concorsuali disponibili:
| Procedura | Soggetti ammessi | Presupposti | Voto dei creditori | Vantaggi principali | Limiti / svantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) | Imprese (anche sopra soglia) e creditori che rappresentino ≥60% del debito (30% per misure prot.) | Crisi o insolvenza reversibile; accordo con quota qualificata di creditori | Sì, adesione del 60% (o 30% iniziale per misure prot.) ; omologato dal tribunale senza voto degli estranei | Procedura riservata; blocco esecuzioni con soli 30% di adesioni ; vincola anche dissenzienti (erga omnes) ; consente transazione fiscale e cram-down erario | Necessita alta adesione; creditori estranei vanno soddisfatti integralmente salvo cram-down; rischio risoluzione se fallimento successivo |
| Concordato preventivo in continuità (artt. 84-94) | Imprese soggette a liqu. giudiziale (sopra soglia) in crisi o insolventi | Piano di risanamento con prosecuzione attività; attestazione di fattibilità | Sì, voto per classi di creditori (magg. >50% e >1/2 classi) | Impresa continua operatività; moratoria 2 anni per privilegiati ; falcidia poss. privilegiati se attivo < debito ; salvaguardia occupazione | Procedura complessa, pubblica; costi elevati (commissario, attestatore); rischi di revoca se atti di frode ; richiede gestione oculata per anni sotto vigilanza |
| Concordato preventivo liquidatorio (art. 84 co.4) | Imprese soggette a liqu. giudiz. in insolvenza | Liquidazione integrale patrimonio; apporto esterno se necessario a ≥20% chirografi | Sì, voto creditori (≥50%) come sopra | Liquidazione ordinata e rapida; possibile vendita unitaria azienda; debitore evita dichiarazione di fallimento | Minimo 20% ai chirografari richiesto ; attività cessata; no esdebitazione legale per soci salvo persona fisica post liq.; se omesso pagamento rate concordato -> risoluzione |
| Concordato minore (artt. 74-83) | Debitori sotto soglia, piccoli imprenditori, professionisti, startup, consumatori con debiti da impresa | Crisi o insolvenza; capacità di soddisfare creditori almeno parzialmente | Sì, voto dei creditori (magg. >50%) in eventuali classi semplici | Procedura semplificata, costi ridotti; soglia 20% non applicabile; tutela sovraindebitati con esdebitazione finale | Richiede attestazione e piano; se rifiutato -> liquidazione controllata; spesso creditori pubblici poco coinvolti portano a fallimento |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Imprese dopo esito negativo composizione negoziata | Insolvenza irreversibile; nessuna prospettiva di continuità; CNC fallita | No voto (proposta diretta al tribunale) | Liquidazione rapida di beni; chiusura crisi senza fallimento formale; niente voto quindi niente maggioranze da ottenere | Solo liquidatorio; non garantisce esdebitazione completa ; serve convincere tribunale su convenienza; creditori possono opporsi in omologa |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Imprese sopra soglia insolventi (o che non dimostrino di essere sotto soglia) | Insolvenza accertata da tribunale; patrimonio liquidabile | No (creditori non votano; curatore liquida e giudice ripartisce) | Procedura ordinata con pari trattamento (par condicio); curatore professionale gestisce vendite; possibile esdebitazione imprenditore onesto a fine procedura | Impresa spossessata e cessata; tempi lunghi (anni per chiudere); stigma e possibili azioni di responsabilità; pagamento creditori spesso parziale minimo |
| Liquidazione controllata (artt. 268-277) | Debitori non fallibili (sotto soglia, consumatori, enti non commerciali) insolventi | Insolvenza o sovraindebitamento; patrimonio liquidabile | No voto (liquidatore OCC liquida e giudice approva riparti) | Procedura semplificata; durata contenuta (max 4-6 anni) ; esdebitazione automatica per debitore meritevole a fine procedura | Perdita totale patrimonio; impossibilità di continuare attività (tranne consumatore che non ha attività); debiti fiscali “qualificati” non esdebitati ; comunque apertura procedura concorsuale pubblica |
(Legenda: CCII = Codice crisi; L.F. = Legge Fallimentare 1942; OCC = Organismo Composizione Crisi)
Nella tabella sopra, abbiamo incluso anche un riepilogo delle principali fattispecie di reato collegate all’insolvenza, come richiamo per l’imprenditore su cosa non fare. In particolare: la bancarotta fraudolenta (art. 216 l.f., ora D.Lgs. 14/2019 art. 322 e seguenti) punisce distrazioni, occultamenti o falsificazioni contabili connesse al fallimento ; la bancarotta preferenziale punisce i pagamenti preferenziali fatti dal debitore insolvente a favore di alcuni creditori a scapito di altri ; la bancarotta semplice (art. 217) punisce condotte di cattiva gestione (spese personali eccessive, ritardo nell’istanza, mancanza di libri) con colpa grave ; la bancarotta impropria (art. 223) colpisce amministratori e dirigenti per violazioni dei doveri che abbiano causato o aggravato il dissesto ; la bancarotta da concordato equipara le distrazioni commesse durante un concordato preventivo alle bancarotte fraudolente . Vi sono poi reati tributari collegabili (es. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e omesso versamento IVA, D.Lgs. 74/2000) che possono concorrere con la bancarotta impropria senza assorbirsi . Infine, l’appropriazione indebita di beni sociali da parte di amministratori di fatto è stata equiparata alla bancarotta patrimoniale , come confermato dalla Cassazione 19402/2025 .
Lo scopo qui non è spaventare, ma rendere chiaro che ignorare la crisi e agire in modo disordinato può condurre non solo alla perdita dell’impresa ma anche a sanzioni personali severe. Viceversa, chi affronta la crisi con correttezza, trasparenza e competenza potrà uscire dalla fase critica con la migliore soluzione possibile e, nella peggiore delle ipotesi, contare su strumenti di esdebitazione per ricominciare.
7. Responsabilità degli amministratori e tutela del debitore in crisi
Dal punto di vista del debitore (e in particolare degli amministratori nel caso di società), la gestione di un’azienda indebitata comporta delicate responsabilità legali. Alcuni punti chiave da tenere a mente:
- Responsabilità patrimoniale illimitata (art. 2740 c.c.): L’imprenditore individuale risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dei debiti dell’impresa . Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s.) i soci illimitatamente responsabili rispondono analogamente. Ciò significa che se l’azienda fallisce, i creditori possono rifarsi sui beni personali. L’uso di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) limita in teoria la responsabilità al patrimonio sociale; tuttavia, garanzie personali (fideiussioni bancarie, ipoteche personali) rilasciate dai soci o amministratori di PMI vanificano spesso la barriera, esponendo il patrimonio personale.
- Obbligo di conservazione del patrimonio sociale: Gli amministratori di società hanno il dovere di non aggravare inutilmente il dissesto. Se continuano l’attività in presenza di perdita totale del capitale sociale (art. 2482-ter c.c.) senza adottare provvedimenti, o incrementano l’indebitamento in modo irragionevole, possono essere chiamati a risponderne. Ad esempio, contrarre nuovi debiti sapendo di non poterli pagare può configurare mala gestio e portare a azioni di responsabilità promosse dal curatore fallimentare (art. 2486 c.c. e azione ex art. 146 L.F.). Una sentenza del 2025 ha confermato la condanna di un amministratore per aver aggravato il dissesto continuando attività con crediti inesigibili .
- Doveri nella crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII): Come già evidenziato, c’è un dovere legale di attivarsi tempestivamente. L’amministratore che tace e nasconde la situazione, procrastinando gli interventi, rischia di essere accusato di gestione imprudente o persino di frode se compie atti pregiudizievoli (es. paga un solo fornitore amico escludendo gli altri prima del fallimento = bancarotta preferenziale, art. 216 L.F.). La Cassazione ha più volte ribadito che la revoca del concordato per atti di frode è doverosa anche se il pregiudizio non si è concretizzato, per tutelare la par condicio .
- Responsabilità verso l’erario e gli enti: Ci sono casi in cui l’amministratore può essere responsabile personalmente di certe imposte non versate. Ad esempio, se non versa l’IVA o le ritenute previdenziali commette reato (oltre la soglia) e, pur trattandosi di debito sociale, la sua condotta illecita può comportare sequestro/confisca su beni personali. Inoltre, per le S.r.l., in caso di accertata indebita continuazione dell’attività aggravando il buco, i creditori sociali potrebbero tentare un’azione verso gli amministratori per violazione dei doveri (ex art. 2394 c.c. in analogia, se il patrimonio è insufficiente).
- Esenzioni e protezioni possibili: D’altra parte, chi gestisce correttamente la crisi può beneficiare di alcune protezioni: ad esempio, durante la composizione negoziata l’esperto può segnalare al tribunale di non applicare misure cautelari personali (tipo interdizione) se l’imprenditore collabora. E soprattutto, la successiva esdebitazione libererà l’imprenditore persona fisica dai debiti residui (non dalle sanzioni penali, ovvio). La recente riforma consente l’esdebitazione persino dell’imprenditore che è stato in concordato liquidatorio (prima non chiarito), a patto che sia “meritevole” – cioè non abbia fraudolentemente causato la decozione .
- Tutela del patrimonio personale: Finché non c’è una procedura, l’imprenditore può legittimamente compiere atti per proteggere i propri beni, purché leciti (e.g., costituire un fondo patrimoniale per la casa familiare prima di contrarre i debiti, vendere un immobile personale per fare liquidità). Ma attenti: quando i debiti sono già presenti, atti dispositivi possono essere revocati in fallimento se fatti negli ultimi 1-2 anni in danno ai creditori. E se fatti con l’intento specifico di frodarli, possono integrare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (per i debiti fiscali) o essere inefficaci.
- Consigli per evitare guai personali:
- Documentare sempre tutto. Tenere la contabilità in ordine, i verbali delle decisioni, conservare prove che certe scelte erano l’unica opzione (es. dimostrare che continuare l’attività per 6 mesi era per tentare una vendita di azienda che avrebbe soddisfatto i creditori in misura maggiore). La regolare tenuta dei libri e registri è scriminante contro l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale .
- Non “liberarsi” dei beni sottocosto o simularne la vendita: queste sono tipiche condotte che portano a bancarotta fraudolenta. Meglio liquidare attraverso procedure competitive o valutazioni indipendenti.
- Trattare tutti i creditori con equità nelle fasi a ridosso di una procedura: evitare di pagare solo amici o parenti lasciando a bocca asciutta gli altri (bancarotta preferenziale) , a meno che quei pagamenti non siano oggettivamente giustificati per la continuità (ad es. pagare fornitore essenziale per poter vendere scorte e rimborsare più creditori – comunque andrebbe autorizzato dal giudice nella CNC o in pre-concordato).
- Cooperare con eventuali organi della crisi: se entra un commissario o un curatore, collaborare, consegnare documenti, spiegare operazioni. L’omessa consegna di scritture o la resistenza viene punita penalmente e preclude la meritevolezza.
In definitiva, l’amministratore di un’azienda indebitata deve muoversi in modo proattivo ma prudente: cercare soluzioni, sì, ma senza cadere nella tentazione di scorciatoie illecite. In caso di dubbio, il consiglio è sempre di coinvolgere subito consulenti legali e finanziari: un parere tempestivo può salvare dall’imboccare una strada sbagliata. Come sintetizzato nelle “5 regole d’oro”: 1. Trasparenza: con consulenti, creditori e tribunale. Menzogne e occultamenti poi si pagano cari . 2. Tempestività: agire prima possibile (attivare strumenti, ridurre costi, liquidare asset non core). 3. Legalità formale: rispettare procedure e priorità di legge (es. non toccare stipendi e ritenute). 4. Documentazione: ogni scelta motivarla e annotarla (serve in sede di valutazione ex post). 5. Lealtà e correttezza: verso i creditori e i dipendenti; ciò viene spesso preso in considerazione dai giudici quando valutano l’esdebitazione o sanzioni.
8. Strumenti speciali per la crisi da sovraindebitamento del privato (Piano del consumatore)
Abbiamo finora coperto l’ambito aziendale. Tuttavia, è utile menzionare brevemente lo strumento dedicato alle persone fisiche consumatori, perché spesso l’imprenditore può trovarsi ad avere anche debiti personali estranei all’impresa (mutui, finanziamenti per scopi familiari). Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII, ex “piano del consumatore” L.3/2012) consente al debitore persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale di proporre un piano per ristrutturare quei debiti con l’omologazione del tribunale, senza voto dei creditori, ma soggetto a un rigoroso controllo di meritevolezza.
In pratica: – Chi può accedere: solo chi ha debiti da consumo (es. prestiti personali, carta di credito, debiti per canoni, ecc.) e non debiti professionali. La Cassazione ha escluso che possano mischiarsi debiti personali e di impresa: se c’è anche solo una parte di debito derivante da attività imprenditoriale, non si è “consumatore puro” e quindi non si può usare questo strumento per l’intero indebitamento . Bisogna dividere: la parte personale va in piano del consumatore, quella imprenditoriale in concordato minore o liquidazione. – Procedura: Il consumatore prepara (con l’ausilio di un OCC) un piano dove indica quanto e come può pagare (spesso falcidiando parecchio i debiti in base al reddito disponibile) e lo deposita in tribunale. I creditori vengono avvisati ma non votano. Il giudice omologa se ritiene: 1) che il consumatore sia meritevole, cioè non abbia colposamente causato la sua situazione con spese sproporzionate o frodi; 2) che il piano sia fattibile e offra ai creditori almeno quanto la liquidazione del suo patrimonio darebbe (spesso il patrimonio è la casa di abitazione, che per legge è esclusa dalla liquidazione se ipotecata e il debitore vuole tenerla pagando le rate, quindi spesso i creditori chirografari in un piano prendono di più che da una liquidazione in cui la casa non si tocca). – Effetti: l’omologa del piano vincola i creditori (che devono accontentarsi di quanto previsto) e, se il piano è eseguito, il debitore viene liberato dai debiti residui. Se non eseguito, i creditori riacquistano i diritti originari al netto di quanto eventualmente ricevuto. – Durata tipica: di solito 4-5 anni, per allinearsi con un orizzonte ragionevole di rientro per una famiglia.
Questo strumento è rilevante perché, ad esempio, se l’imprenditore di cui trattiamo è anche consumatore (magari ha un mutuo per la casa e un prestito auto oltre ai debiti aziendali), deve fare un percorso doppio: uno per i debiti d’impresa (concordato minore o liquidazione controllata) e uno per i personali (piano del consumatore). Come visto nel Caso Beta delle simulazioni, i soci di una S.n.c. hanno dovuto imboccare entrambe le strade: concordato minore per i debiti aziendali e piano del consumatore separato per i mutui personali sulla casa . La legge vuole evitare che chi ha mescolato posizioni consumatore/imprenditore approfitti di tagliare i debiti professionali col regime più favorevole del consumatore.
9. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come questi strumenti si applicano nella realtà, presentiamo alcuni casi tipici che un’azienda di alesatura potrebbe trovarsi ad affrontare. Sono scenari semplificati ma basati su situazioni riscontrate nella prassi, per evidenziare le scelte possibili e le conseguenze dal punto di vista del debitore.
9.1 Caso A: Crisi di liquidità temporanea con commessa bloccata
Scenario: Alfa S.r.l. è una piccola società di alesatura di precisione. Ha in corso un’importante commessa per un cliente pubblico (manutenzione di turbine) per un valore di €500.000, con consegna tra 3 mesi. Purtroppo, a causa di problemi burocratici, il cliente pubblico ha sospeso i pagamenti delle SAL (stato avanzamento lavori) già completati per €200.000. Ciò ha prosciugato la cassa di Alfa, che si ritrova con debiti urgenti verso fornitori (€150.000) e banche (€100.000 di fido utilizzato) e non riesce a pagarli. L’INPS e l’IVA corrente sono invece in regola (DURC regolare). L’azienda ha ordini futuri da clienti privati e sarebbe in buona salute se incassasse il dovuto, quindi la crisi è chiaramente di natura temporanea e legata a un evento esterno. Tuttavia, alcuni fornitori minacciano azioni se non vengono pagati entro 30 giorni; e la banca sta valutando di revocare il fido perché ha visto il bilancio semestrale in perdita.
Opzioni possibili:
- Composizione Negoziata della Crisi: Alfa può attivare subito la CNC, caricando la documentazione nella piattaforma. Nel giro di una settimana viene nominato un esperto. L’esperto convoca subito i fornitori principali e la banca per discutere. Alfa chiede e ottiene dal Tribunale misure protettive ex art. 18 CCII, bloccando ogni pignoramento per 4 mesi. Con l’aiuto dell’esperto, negozia una moratoria di 6 mesi con i fornitori: questi accettano di aspettare, vedendo che c’è un ordine pubblico in arrivo, e l’azienda si impegna a pagarli integralmene non appena incassa dal cliente pubblico. Con la banca, l’esperto negozia una conferma della linea di fido per altri 6 mesi e un piccolo nuovo finanziamento ponte (10.000 €) per pagare stipendi, autorizzato dal Tribunale come prededucibile. Nel frattempo Alfa cede un vecchio macchinario inutilizzato incassando €20.000 che usa per pagare quei fornitori più critici (con l’ok dell’esperto). Dopo 4 mesi, grazie anche all’intervento dell’esperto che sollecita il cliente pubblico, la commessa si sblocca: Alfa consegna, incassa €300.000 (i 200k sospesi + altra tranche) e immediatamente paga i fornitori arretrati e azzera il fido. La crisi rientra completamente e la CNC viene conclusa positivamente con un semplice accordo stragiudiziale e un piano attestato di avvenuta ristrutturazione . L’azienda conserva pienamente l’attività e la reputazione, avendo evitato azioni esecutive e procedure concorsuali formali.
- Accordo di ristrutturazione agevolato: In alternativa, se Alfa avesse temuto di non poter confidare solo sulla buona volontà, avrebbe potuto cercare un accordo omologato. Ad esempio, ottenere l’adesione iniziale del 35% dei creditori (la banca e qualche fornitore maggiore) per chiedere misure protettive, e poi salire al 65% coinvolgendo gli altri . Proporre un piano omologato magari con transazione fiscale (qui fiscale non c’è, ma ipotizziamo se ci fossero debiti IVA piccoli). L’AdER accetta una dilazione decennale simbolica se c’era qualcosa di fiscale, e in tribunale si omologa. Questo avrebbe permesso di proseguire l’attività con un taglio parziale dell’indebitamento (nel nostro scenario però taglio non serve, serve tempo – quindi la CNC è più adatta). La via dell’accordo omologato sarebbe stata più costosa e pubblica; in uno scenario di crisi temporanea è overkilling, ma l’abbiamo citata per completezza.
- Concordato preventivo in continuità: Se le trattative fossero fallite (fornitore testardo che pignora ad esempio), Alfa avrebbe potuto depositare un concordato con continuità. Proponendo di pagare integralmente fornitori e banca entro 6 mesi (moratoria) grazie agli incassi futuri, forse suddividendo in classi. I creditori avrebbero votato e verosimilmente approvato (essendo pagati 100%). L’esito però dipende dal voto: se anche un creditore chirografario avesse rifiutato e fosse stato di peso, poteva complicare. E il fallimento del concordato avrebbe portato al fallimento. Quindi, in un caso di crisi temporanea, la soluzione meno giudiziale (CNC) è la più appropriata .
Risultato consigliato: la Composizione Negoziata appare la scelta migliore in uno scenario come questo . La crisi è chiaramente temporanea e c’è un’alta probabilità di continuità: serve solo bloccare i creditori per guadagnare tempo. L’esperto CNC aiuta a tenere calmi i fornitori e evitare panico. Concordati o accordi sarebbero soluzioni eccessive per un problema transitorio. Grazie alla CNC, Alfa risolve la crisi in pochi mesi, preservando l’impresa.
9.2 Caso B: Sovraindebitamento misto di società e soci
Scenario: Beta S.n.c. è un’impresa artigiana (impianti elettrici) con due soci lavoratori. Negli anni ha accumulato debiti per €200.000 tra fornitori e fisco. I soci, per sostenere l’azienda, hanno anche contratto debiti personali: uno ha acceso un mutuo per ipotecare la casa e versare liquidità in azienda; entrambi hanno firmato fideiussioni personali verso la banca su uno scoperto di €50.000. Inoltre, ciascuno ha alcuni debiti propri (uno per la ristrutturazione della casa, l’altro per spese familiari). Ora Beta S.n.c. è in difficoltà: il fatturato è calato e non riesce a pagare fornitori e banca. I soci si trovano schiacciati dal doppio livello di debito: l’azienda rischia insolvenza e loro personalmente rischiano l’escussione delle garanzie e le rate dei mutui.
Opzioni possibili:
- Concordato minore per la società e liquidazione controllata per i soci: Essendo una S.n.c., se Beta non è fallibile (supponiamo sia sotto soglia dati i €200k debiti e piccola attività), non può fare concordato preventivo ordinario. Ma può proporre un concordato minore. Il piano potrebbe prevedere il pagamento, ad esempio, del 40% dei debiti aziendali in 3 anni, utilizzando il ricavato della vendita di un magazzino di proprietà + un contributo esterno dei soci per un totale di, poniamo, €80.000 . I creditori aziendali (fornitori e fisco) voterebbero su questo piano: se approvano, Beta viene esdebitata del restante 60%. Parallelamente, i soci si trovano con debiti personali: mutui e fideiussioni. Le fideiussioni per i debiti aziendali, essendo garanzie di debiti d’impresa, non rientrerebbero in un loro eventuale piano del consumatore . Quindi per quei debiti, i soci dovranno usare le procedure “imprenditoriali” personali: come coobbligati dell’impresa, potrebbero dover ricorrere a una liquidazione controllata personale o a un proprio concordato minore. In pratica, Beta S.n.c. si “salva” con un concordato minore, mentre i soci, che rimangono con i debiti fideiussori residui (quelli non pagati dal concordato), li affrontano con la liquidazione controllata dei loro beni personali o un accordo personale. Nel nostro scenario, supponiamo che i soci vendano le loro seconde auto, rinuncino a TFR futuri ecc., e con quel poco attivino la liquidazione controllata: i beni personali vengono liquidati ma mantengono la casa di abitazione (protetta), e dopo la procedura ottengono esdebitazione per i debiti rimasti . Avendo salvato l’azienda e i posti di lavoro, questo sacrificio è accettato.
- Piano del consumatore per i soci + eventuale concordato minore per società (varianti): Se i debiti personali dei soci fossero ben distinti e prevalenti su quelli d’impresa, avrebbero potuto tentare un piano del consumatore per le loro posizioni private (mutui casa, carte credito) integrandovi forse le fideiussioni? Ma come detto, Cassazione esclude le fideiussioni di debiti aziendali dal piano del consumatore , ergo i soci avrebbero dovuto comunque affrontare quelle a parte. Dunque la soluzione migliore è, come suggerito dalle linee guida, separare i debiti : la società Beta tratta i debiti aziendali col suo concordato, i soci trattano i debiti personali con i loro mezzi (liquidazione controllata o accordi con banche ad personam, se possibile, di solito no se c’è insolvenza).
Risultato consigliato: Separare i percorsi: concordato minore per l’azienda e strumenti di sovraindebitamento per i soci . In questo modo, la società può essere ristrutturata e continuare l’attività (magari ridimensionata) – salvando la fonte di reddito – mentre i soci, a titolo individuale, possono liberarsi dai debiti eccedenti senza rimanere indebitati a vita. Questa strategia combinata consente di salvare l’azienda e ridurre il peso sulle famiglie dei soci .
9.3 Caso C: Insolvenza irreversibile e patrimonio insufficiente
Scenario: Gamma Impianti S.p.A. (settore impiantistica industriale) possiede anche un reparto di alesatura. Negli ultimi anni ha accumulato perdite pesanti (pandemia, rincari materiali) e ha debiti totali enormi (€5 milioni) con banche, fornitori, fisco. Ha ormai perso i principali clienti e la produzione è quasi ferma. Il patrimonio attivo è ridotto: giusto un capannone ipotecato valutato €1 milione e pochi macchinari obsoleti valore €100k . Non c’è alcuna prospettiva credibile di risanamento o continuità: l’insolvenza è conclamata e irreversibile.
Opzioni possibili:
- Concordato semplificato liquidatorio: Avendo tentato magari una composizione negoziata senza soluzioni (nessuno vuole investire su Gamma), la società, per evitare la liquidazione giudiziale, potrebbe presentare un concordato semplificato per la liquidazione . Nel piano propone di vendere il capannone ipotecato a €1M (che andrà quasi interamente alla banca ipotecaria) e liquidare i macchinari e magazzino per, diciamo, €100k da dividere pro-rata ai chirografari. Non c’è soddisfacimento per il fisco (privilegiato in parte, ma forse non interamente coperto dal magazzino). L’offerta ai chirografari sarebbe pressoché zero (forse un 5%). In condizioni normali, un concordato così non passerebbe mai il voto (chi voterebbe per 5%?). Ma con il semplificato, non c’è voto. Il tribunale valuta: se quell’offerta è pari a quanto i creditori avrebbero da un fallimento (probabilmente sì, se non di più considerando la rapidità e risparmio di costi), può omologare . I creditori vengono liquidati in breve tempo. Gamma si estingue senza passare per la trafila fallimentare. Tuttavia, i creditori insoddisfatti conserveranno il diritto verso eventuali coobbligati o fideiussori (es. se c’erano garanti) e i soci amministratori dovranno comunque affrontare le eventuali conseguenze (ad es. il fisco potrebbe iscrivere ipoteca sui loro beni per i tributi non incassati, perché il concordato semplificato non glieli toglie formalmente).
Vantaggio: velocità (nel giro di pochi mesi la vicenda è chiusa) e niente curatore fallimentare che indaga per anni (anche se comunque il tribunale potrebbe segnalare eventuali reati al PM). Svantaggi: i creditori potrebbero opporsi, e se il giudice li ritiene pregiudicati potrebbe respingere e dichiarare comunque il fallimento. Inoltre, i debiti non soddisfatti non si estinguono automaticamente: la società essendo persona giuridica fallirà di fatto, ma i creditori potrebbero ancora agire contro eventuali garanti o soci illimitatamente responsabili se fosse una società di persone (in S.p.A. no perché soci limitatamente responsabili, ma in S.n.c. ad esempio sì).
- Liquidazione giudiziale (fallimento) tradizionale: Questo è in realtà lo scenario più probabile: i creditori (banca ipotecaria o fisco o un fornitore grosso) presentano istanza di fallimento. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e apre la liquidazione giudiziale. Un curatore vende il capannone ipotecato, soddisfa la banca ipotecaria (magari al 60% del credito), paga in privilegio parziale il fisco col residuo (per dire), e nulla va ai chirografari. Dopo un paio d’anni, chiude la procedura. Nessuna soddisfazione per chirografari, a differenza del concordato semplificato dove magari avevano un contentino minimo. L’unico vantaggio del fallimento è che i creditori, se vogliono, possono ancora avviare azioni di responsabilità o far valere eventuali vizi (ma in realtà anche in concordato semplificato un creditore potrebbe far causa agli amministratori se ravvisa dolo nella gestione).
Dal punto di vista di Gamma, preferirebbe forse il semplificato: niente stigma di fallimento, niente lungaggini. Ma deve convincere il tribunale che il semplificato è la soluzione equa. Non facile.
- Liquidazione controllata sotto soglia (se fosse piccola): Poniamo invece Gamma fosse “Gamma SAS” sotto soglia. In tal caso, niente concordato ordinario. Si porterebbe direttamente in liquidazione controllata (simile al fallimento, ma gestita dall’OCC locale e tempi stretti). I beni venduti, creditori privilegiati prendono il ricavato, chirografari zero. Dopo ~4 anni i soci (se persone fisiche) possono chiedere esdebitazione personale (ma la SAS ha soci accomandatari illimitati che possono esdebitarsi). Debiti IVA restano loro se non pagati.
Risultato consigliato: Purtroppo, in un’insolvenza irreversibile con patrimonio insufficiente, la via liquidatoria concorsuale è inevitabile. Se disponibile, il concordato semplificato può evitare il fallimento formale e concludere prima la vicenda, ma non migliora molto la sorte dei creditori rispetto al fallimento . Quindi, in molti casi, si finirà in liquidazione giudiziale comunque. Il debitore deve accettare la realtà, collaborare col curatore e puntare all’esdebitazione finale se ne ha diritto. Eventuali condotte irregolari pregresse (distrazioni, preferenze) non potranno essere sanate: come visto, i reati di bancarotta puniscono anche atti compiuti durante il concordato , dunque cercare il concordato semplificato non mette certo al riparo chi ha commesso illeciti.
In sostanza, questo caso evidenzia che, quando non c’è nulla da salvare, l’unica scelta sensata dal lato debitore è agevolare una liquidazione ordinata, magari preferendo strumenti come la CNC o il concordato semplificato per velocizzare e ridurre i costi, ma senza creare false speranze. L’imprenditore deve concentrarsi su mitigare i danni: proteggere, se può, i beni personali non coinvolti; onorare gli obblighi verso il personale (che infatti è garantito dal Fondo di garanzia); e prepararsi a ripartire se possibile, facendo tesoro degli errori.
10. Domande e Risposte Frequenti (FAQ)
Passiamo ora a una sezione di domande comuni che imprenditori e debitori in crisi spesso pongono, fornendo risposte sintetiche e basate su quanto esposto.
D. Qual è la differenza tra una situazione di crisi e lo stato di insolvenza?
R. La crisi è uno stadio iniziale di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile in prospettiva l’insolvenza, ma non è ancora un’incapacità definitiva . L’insolvenza invece è la dimostrata incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni: si manifesta con inadempimenti gravi, protesti, mancanza di liquidità cronica. In breve, la crisi è reversibile con azioni tempestive, l’insolvenza no (o difficilmente). Il CCII spinge le aziende a intervenire già in fase di crisi (allerta interna) per evitare di cadere in insolvenza .
D. Un’azienda di alesatura in crisi può evitare il fallimento?
R. Sì, oggi esistono vari strumenti per evitare la liquidazione giudiziale e preservare la continuità . Ad esempio: la Composizione Negoziata per trattare coi creditori e bloccare azioni esecutive; il concordato preventivo in continuità per ristrutturare l’azienda con il controllo del tribunale; gli accordi di ristrutturazione dei debiti per convenire falcidie e dilazioni con i creditori qualificati. La chiave è agire per tempo e presentare piani realistici e sostenibili, dimostrando ai creditori che il piano proposto conviene più della liquidazione .
D. È possibile includere i debiti fiscali e contributivi in un accordo di ristrutturazione o concordato?
R. Sì, è possibile tramite la cosiddetta transazione fiscale e contributiva . La legge (art. 63 CCII) consente di inserire nel piano il pagamento parziale (falcidia) di imposte e contributi e la dilazione fino a 10 anni, purché un esperto attesti che lo Stato ottiene almeno quanto avrebbe da una liquidazione forzata . Con le riforme recenti, se il Fisco non risponde entro 90 giorni alla proposta, vale il silenzio-assenso . Inoltre, se il piano prevede il pagamento di almeno il 50% del debito fiscale e gli altri creditori privati sono d’accordo, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il consenso formale dell’Agenzia Entrate (il cosiddetto cram down fiscale) .
D. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate (o l’INPS) non risponde alla proposta di transazione fiscale nel concordato o accordo?
R. Come accennato, il silenzio equivale ad accettazione . Se entro 90 giorni (termine per legge) l’ente non comunica il proprio diniego, si intende che aderisce alla proposta di transazione. Resta comunque necessario che la proposta fosse depositata in tribunale e l’attestatore abbia certificato la convenienza per l’Erario . Questo meccanismo evita che i ritardi burocratici blocchino i piani di risanamento.
D. I soci che hanno prestato fideiussioni personali per i debiti dell’azienda possono liberarsene con un piano del consumatore?
R. No, le fideiussioni per debiti aziendali sono considerate debiti di natura imprenditoriale (derivati dall’attività economica) e quindi non possono essere inseriti in un piano del consumatore . I soci garanti, per quei debiti, devono utilizzare gli strumenti “concorsuali” come il concordato minore o la liquidazione controllata. Il piano del consumatore è riservato ai debiti personali estranei all’impresa (es. debiti familiari, consumo).
D. Quanto dura una procedura di composizione negoziata della crisi?
R. La durata standard è 180 giorni (circa 6 mesi), prorogabili di altri 180 con decreto motivato se ci sono trattative in corso promettenti . In totale, quindi, al massimo un anno (salvo eccezioni particolari). In pratica molte CNC si chiudono prima, in 3-4 mesi, se trovano accordi, oppure vengono interrotte in anticipo se appare chiaro che non si raggiungerà un esito positivo.
D. Che differenza c’è tra la liquidazione giudiziale (fallimento) e la liquidazione controllata?
R. La liquidazione giudiziale è la procedura liquidatoria per le imprese commerciali sopra soglia (ex fallimento): la conduce un curatore nominato dal tribunale, ha tempi non predeterminati (spesso alcuni anni), e al termine l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti) con alcune eccezioni. La liquidazione controllata è invece la procedura per i debitori sotto soglia e i privati sovraindebitati: qui di solito opera un OCC o un liquidatore nominato ad hoc, la durata è fissata in un massimo di 4 anni (prorogabile in casi eccezionali a 5-6) , ed è più orientata a chiudere rapidamente e dare un fresh start al debitore meritevole (esdebitazione quasi automatica a fine procedura per i debiti residui, tranne quelli esclusi per legge) . In altre parole, la liquidazione controllata è un “fallimento semplificato” per piccoli debiti, pensato per dare una seconda chance al debitore persona fisica.
D. Se l’azienda viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale), gli amministratori o i soci rispondono con i propri beni?
R. Se l’azienda è una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), la regola base è che i soci non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale conferito. Quindi, in un fallimento, i creditori si soddisfano sul patrimonio della società. Tuttavia, ci sono eccezioni: ad esempio, se i soci o amministratori hanno firmato garanzie personali verso banche o fornitori, i creditori potranno agire su di esse (anche durante o dopo il fallimento, indipendentemente). Inoltre, se vi sono state irregolarità gravi nella gestione, il curatore può promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori per far risarcire ai creditori il danno (patrimoniale) derivato dalla mala gestio. Quindi, mentre di regola il patrimonio personale è distinto, fatti come fideiussioni, distrazioni di beni sociali a favore dei soci, continuazione abusiva dell’attività possono mettere a rischio i beni personali dei responsabili. Nei fallimenti di società di persone (S.n.c.), invece, i soci illimitatamente responsabili vengono automaticamente coinvolti (il fallimento si estende a loro) e il loro patrimonio personale è incluso nella procedura.
D. Dopo un fallimento o una liquidazione controllata, i debiti che non sono stati pagati si cancellano?
R. Non automaticamente. Però esiste l’esdebitazione: l’imprenditore persona fisica (o il consumatore) che abbia cooperato e non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta può chiedere al tribunale, a fine procedura, di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti . Se viene concessa (e oggi è concessa nella grande maggioranza dei casi per i debitori “meritevoli”), egli non li deve più pagare, e i creditori non possono pretendere nulla oltre a quanto ricevuto in procedura. Fanno eccezione solo alcuni debiti “non esdebitabili” per legge: le sanzioni penali o amministrative di natura punitiva, i debiti alimentari/familiari, e i debiti fiscali particolarmente qualificati (IVA dovuta e ritenute non versate, per volontà di tutela erariale) . Le società invece, cessando di esistere, non necessitano esdebitazione (vengono cancellate dal registro imprese una volta chiuso il fallimento). Nell’ambito di un concordato preventivo, se il concordato è eseguito, l’effetto pratico è simile all’esdebitazione: i creditori non possono chiedere oltre quanto previsto e la società prosegue liberata dai debiti ulteriori.
D. Cosa succede ai contratti in corso se attivo una procedura concorsuale (concordato o fallimento)?
R. Dipende dal tipo di procedura. Nel concordato in continuità, i contratti pendenti proseguono normalmente, salvo diversa previsione del piano, e le controparti non possono risolverli solo perché c’è il concordato (clausole risolutive automatiche sono invalide). Nel concordato liquidatorio, invece, di solito l’attività cessa e i contratti vengono sciolti o ceduti: la legge consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sciogliersi da contratti in corso se vantaggioso (pagando eventuale indennizzo) o di sospenderli per un certo periodo in attesa di decisione. Nel fallimento (liquidazione giudiziale), i contratti pendenti non si sciolgono automaticamente: il curatore, entro breve, decide se subentrare nel contratto (se utile per la massa) o sciogliersi. Ad esempio, un contratto di affitto di azienda: il curatore può scegliere di proseguirlo se conviene oppure scioglierlo (il contraente avrà danno emergente come credito). In generale, le forniture vengono stoppate (per mancanza di pagamento), i dipendenti vengono licenziati salvo esercizio provvisorio. Nella composizione negoziata, invece, l’azienda è in bonis, quindi i contratti restano in essere; se ha bisogno di sospendere o modificare qualche contratto, deve contrattare con la controparte o eventualmente, dopo la CNC, prevederlo in un successivo concordato.
D. Affrontare la crisi con un accordo o un concordato incide sulla mia capacità di ottenere credito in futuro?
R. Inizialmente sì. La segnalazione di “procedura concorsuale” (anche solo un concordato) appare nelle banche dati e nel registro imprese e rende difficile ottenere nuovo credito nell’immediato. Tuttavia, se l’azienda riesce a risanarsi e completare il piano, col tempo la reputazione finanziaria può migliorare di nuovo. In caso di procedure come il concordato con continuità, alcune banche potrebbero continuare a supportare se confidano nel piano (magari partecipano pure come creditori). Va detto che la Composizione Negoziata, essendo riservata (fino a misure protettive), incide meno sulla reputazione: se risolta positivamente, molti partner commerciali e banche potrebbero anche non venirne a conoscenza ufficialmente. In sintesi: durante la crisi e subito dopo, l’accesso al credito sarà difficoltoso, ma superata la fase e dimostrata la ritrovata solidità, l’azienda può riacquistare fiducia. Per l’imprenditore persona fisica, invece, una volta esdebitato, non vi sono preclusioni formali a iniziare nuove attività, ma alcune informazioni (es. il fallimento passato) restano storicizzate per qualche anno.
D. Quali comportamenti devo assolutamente evitare quando la mia azienda è in crisi, per non incorrere in reati?
R. In estrema sintesi: non sottrarre o occultare beni (niente vendite simulate a parenti, trasferimenti di denaro all’estero senza causa, ecc.) ; non falsificare i dati contabili (tenere la contabilità aggiornata e genuina, anche se brutta), non favorire arbitrariamente alcuni creditori a scapito di altri quando sei già insolvente (evita di pagare solo chi ti fa pressione personale se questo lede la par condicio in modo rilevante) , non aggravare deliberatamente il deficit (ad es. continuare a ordinare merce sapendo che non potrai pagarla, solo per prendere tempo, è un aggravamento doloso o gravemente imprudente) . Inoltre, non distrarre risorse dall’azienda per scopi personali senza titolo: prelievi di cassa giustificati fittiziamente sono tipico caso di appropriazione indebita/bancarotta fraudolenta . Infine, sul fronte fiscale, non attuare artifici per sottrarti al fisco (tipo vendere l’azienda a una società di comodo per non farla pignorare – reato di sottrazione fraudolenta). In positivo: comportati con massima trasparenza e rettitudine, chiedi autorizzazione al giudice nelle procedure per gli atti di gestione delicati, e segui i consigli dei professionisti. Così eviterai di incorrere in responsabilità penali anche in caso di insuccesso del risanamento .
11. Conclusioni
Affrontare una grave crisi debitoria in un’azienda di alesatura (o in qualunque PMI) è una sfida complessa, ma non insormontabile. Dal punto di vista del debitore, la legge oggi offre una gamma di strumenti – dal negoziato stragiudiziale assistito alla ristrutturazione giudiziale, fino a procedure liquidatorie “umanizzate” – che consentono di gestire la crisi in modo ordinato e spesso di uscirne senza perdere tutto. Il filo conduttore è la tempestività e la correttezza: chi agisce presto, con professionalità e buona fede, massimizza le chance di salvataggio dell’impresa o quantomeno di limitare i danni e ripartire pulito.
Riassumendo gli snodi principali: – In prima battuta, stabilizzare la situazione: bloccare le azioni esecutive (con accordi o misure protettive), ottenere respiro finanziario (rateazioni, moratorie) ed evitare il default conclamato. La Composizione Negoziata è lo strumento chiave in questa fase. – Quindi, valutare oggettivamente la fattibilità di un risanamento: se c’è un core business sano e recuperabile, puntare su continuità (accordi, concordato in continuità, nuova finanza); se invece l’impresa non ha più prospettive, meglio optare per una liquidazione guidata (concordato liquidatorio, cessione asset) piuttosto che farla implodere in maniera caotica. – Coinvolgere i creditori nella soluzione: la trasparenza paga, spesso i creditori preferiscono recuperare qualcosa in un piano concordato piuttosto che avventurarsi in lunghe esecuzioni individuali o in fallimenti dove anche loro rischiano di perdere quasi tutto. – Tenere sempre d’occhio le priorità legali: pagare il fisco e i dipendenti appena possibile (perché i loro crediti crescono e hanno tutele forti), preservare l’integrità del patrimonio (niente mosse azzardate per “mettere in salvo” beni, che poi si ritorcono contro). – E soprattutto, affidarsi a consulenti esperti in crisi d’impresa: le norme sono tecniche e in continua evoluzione (come visto con i correttivi 2022-24), e avere al fianco un avvocato specializzato e un commercialista esperto può fare la differenza tra un concordato approvato e uno respinto, tra un debito ridotto e uno pagato per intero erroneamente.
La prospettiva avanzata adottata in questa guida speriamo abbia fornito un quadro completo e aggiornato a ottobre 2025 delle possibilità e dei rischi. Dalle sentenze di Cassazione citate traspare come i giudici valutino con attenzione i comportamenti del debitore: premiano chi agisce correttamente (ad es. permettendo cram-down o esdebitazione) e puniscono chi abusa (revocando concordati per frode, condannando amministratori infedeli) .
In definitiva, un’azienda indebitata può difendersi efficacemente se combina tre elementi: conoscenza degli strumenti legali, pianificazione finanziaria realistica e condotta leale. Questa triade, insieme all’assistenza di professionisti e – perché no – a un pizzico di coraggio imprenditoriale, può trasformare quella che sembra una fine (il baratro dei debiti) in un nuovo inizio.
Fonti e Riferimenti Normativi/Giurisprudenziali
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Legge Fallimentare (in gran parte abrogata dal 15/7/2022 salvo disposizioni penali e altre residuali).
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) , entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 , come modificato da:
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (primo correttivo CCII),
- D.L. 24 agosto 2021, n. 118 conv. in L. 147/2021 (ha introdotto composizione negoziata e concordato semplificato) ,
- D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (attuazione Dir. UE 2019/1023, cd. “Insolvency Directive”) ,
- D.Lgs. 15 settembre 2023, n. 121 (correttivo bis, minori modifiche),
- D.Lgs. 28 settembre 2024, n. 136 (correttivo ter, in vigore dal 28/09/2024, ha chiarito definizioni e rafforzato composizione negoziata) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte (rateazione cartelle art. 19 , ipoteca e fermo amministrativo da AdER artt. 77-78).
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Reati tributari (art. 10-bis omesso versamento ritenute, 10-ter omesso versamento IVA, 11 sottrazione fraudolenta al pagamento imposte) .
- Codice Civile (art. 2086 co.2 obbligo adeguati assetti organizzativi ; art. 2476-2486 responsabilità amministratori S.r.l.; art. 2740 responsabilità patrimoniale illimitata ).
- Leggi di Bilancio 2023 e 2024: L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023: rottamazione-quater, stralcio mini-debiti ); L. 23 dicembre 2023, n. 205 (Bilancio 2024: ha previsto eventuale rottamazione-quinquies nel 2026 ).
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. 32996/2024 del 17-12-2024 – In tema di accordi di ristrutturazione, ha stabilito che la risoluzione del successivo fallimento travolge l’accordo e i creditori riacquistano diritto all’intero credito originario (salvo prededuzione pagamenti eseguiti) .
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. 1869/2022 – Ha escluso la fattibilità di un piano del consumatore che includa anche parzialmente debiti di natura imprenditoriale: il debitore “misto” deve scinderli (rif. in testo) .
- Tribunale di Milano, decreto 23 marzo 2025 – In materia di concordato minore: ha affermato che l’accertamento del passivo ai fini del voto non è definitivo sulle pretese (non pregiudica contenziosi futuri) ; inoltre ha ribadito che la revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F. (oggi 119 CCII) per atti di frode prescinde dal pregiudizio concreto ed è volta a garantire la legalità della procedura .
- Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sent. 10750/2025 – Ha chiarito la differenza tra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e la bancarotta impropria: possono concorrere perché tutelano beni giuridici diversi (Erario vs. massa creditoria) .
- Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sent. 19402/2025 – Ha confermato condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale di un amministratore di fatto che prelevava fondi sociali senza giustificazione, qualificando i prelievi come distrazioni punibili .
- Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sent. 12314/2021 – (riferimento implicito) Ha ritenuto bancarotta semplice l’aggravamento colposo del dissesto mediante prosecuzione dell’attività con fatture per operazioni inesistenti (falso attivo), condotta considerata grave negligenza .
- “Relazione Illustrativa al D.Lgs. 83/2022” – evidenzia ratio di innovazioni come transazione fiscale, ruoli di allerta interna (citata indirettamente) .
La tua azienda che progetta, produce o vende alesatori di precisione, alesatori regolabili, alesatori modulari, alesatori speciali, alesatori in HSS o metallo duro, utensili multi-taglienti e soluzioni personalizzate per fori di alta qualità sta affrontando un problema serio di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che progetta, produce o vende alesatori di precisione, alesatori regolabili, alesatori modulari, alesatori speciali, alesatori in HSS o metallo duro, utensili multi-taglienti e soluzioni personalizzate per fori di alta qualità sta affrontando un problema serio di debiti?
Hai esposizioni con Agenzia delle Entrate, INPS, banche, leasing, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi dei fornitori o minacce di pignoramento?
Il settore degli alesatori richiede precisione assoluta, materiali costosi, trattamenti termici, rivestimenti avanzati, CNC di alta qualità, tolleranze micrometriche.
Basta un ritardo nei pagamenti dei clienti per generare una crisi immediata di liquidità.
La buona notizia è che puoi salvare la tua azienda, bloccare i creditori e ristrutturare i debiti con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Alesatori Finisce in Debito
I motivi più frequenti sono:
• aumento dei costi di HSS, metallo duro, rivestimenti PVD/CVD
• lavorazioni esterne costose: rettifica, affilatura, lappatura, saldobrasatura
• macchine CNC e rettificatrici costose da mantenere
• ritardi nei pagamenti da parte di officine, tornerie, costruttori e OEM
• magazzino immobilizzato tra alesatori finiti e semilavorati
• costi energetici e logistici elevati
• riduzione improvvisa dei fidi bancari
• commesse complesse con tempi lunghi di produzione e incasso
Il problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per un’Azienda che Produce Alesatori con Debiti
Senza interventi rapidi possono verificarsi:
• pignoramento dei conti correnti aziendali
• blocco dei fidi e delle linee di credito
• sospensione delle forniture di materiali e trattamenti
• decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
• sequestro di utensili, macchinari e semilavorati
• fermo delle lavorazioni di rettifica e affilatura
• ritardi nelle consegne ai clienti strategici
• rischio concreto di fermo totale dell’azienda
Una crisi finanziaria trascurata può bloccare completamente la produzione in pochi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
- Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può sospendere pignoramenti, fermare richieste di rientro, proteggere i conti correnti e intervenire con i fornitori più aggressivi. Prima si stabilizza l’azienda, poi si procede con la strategia. - Analizzare i debiti ed eliminare quelli illegittimi
Nei debiti aziendali spesso troviamo interessi non dovuti, more calcolate male, somme duplicate, debiti prescritti, costi bancari irregolari ed errori della Riscossione.
Una parte rilevante del debito può essere ridotta o cancellata. - Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni disponibili: rateizzazioni fiscali fino a 120 rate, accordi con fornitori strategici, rinegoziazioni bancarie, sospensioni temporanee dei pagamenti, ricorso alle definizioni agevolate quando disponibili.
Obiettivo: ripristinare liquidità e non fermare la produzione. - Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Per crisi più profonde sono disponibili strumenti efficaci come PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti, accordi di ristrutturazione, concordato minore o, solo in extremis, liquidazione controllata.
Questi strumenti bloccano tutti i creditori, fermano pignoramenti e permettono di pagare solo una parte del debito, mantenendo attiva la produzione e proteggendo l’imprenditore. - Proteggere produzione, macchinari e materiale
Un’azienda di alesatori deve proteggere barre HSS, metallo duro, utensili finiti, semilavorati, rivestimenti, rettificatrici, affilatrici e strumenti di misura.
È fondamentale salvaguardare macchine e magazzino da sequestri, mantenere attivi fornitori chiave e garantire continuità nelle consegne.
La produzione deve continuare: senza, il debito cresce. Con continuità produttiva, puoi salvare l’azienda.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco dettagliato dei debiti
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario di utensili, barre, semilavorati
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi iniziale entro 24–72 ore
• Blocco dei creditori entro 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione entro 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria entro 3–12 mesi
Le protezioni legali possono attivarsi già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato alle pressioni dei creditori
• Riduzione concreta e significativa dei debiti
• Protezione di macchinari, utensili, materiali e semilavorati
• Trattative mirate con banche, fornitori e Riscossione
• Continuità produttiva e rispetto delle consegne
• Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti e decreti ingiuntivi
• Accendere nuovi debiti per coprire quelli vecchi
• Pagare un creditore trascurando gli altri
• Lasciare procedere pignoramenti
• Affidarsi a società “miracolose” prive di esperienza
Ogni errore complica la crisi e aumenta il rischio di fermo aziendale.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato di pignoramenti e richieste aggressive
• Piani di ristrutturazione su misura
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
• Protezione totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di alesatori non significa essere destinati alla chiusura. Con una strategia tempestiva puoi:
• bloccare i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• proteggere macchinari, magazzino e produzione
• mantenere viva l’azienda
• tutelare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento di agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare immediatamente.