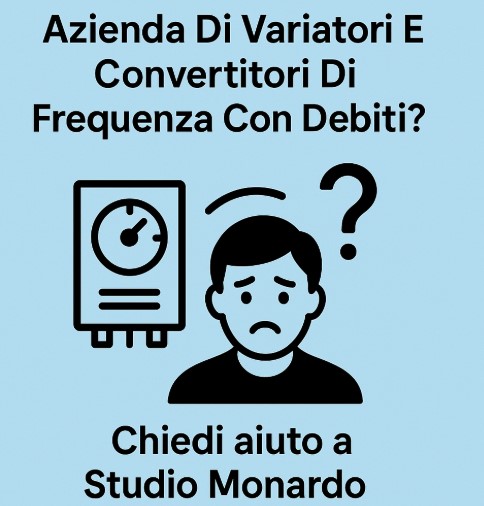e gestisci un’azienda che produce, importa o distribuisce variatori di velocità, convertitori di frequenza, inverter industriali, regolatori elettronici, drive per motori elettrici e sistemi di controllo, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente critica.
Il settore dei variatori e dei convertitori di frequenza richiede componenti elettronici costosi, forniture costanti, assistenza rapida e magazzini altamente tecnici. Per questo un blocco dovuto ai debiti può compromettere consegne, fermare installazioni e far perdere contratti con clienti industriali e integratori di sistemi.
La buona notizia è che, con un intervento tempestivo, puoi difendere la tua azienda, ridurre i debiti e bloccare le procedure, evitando conseguenze peggiori.
Perché le aziende di variatori e convertitori di frequenza accumulano debiti
Le cause principali includono:
- costi elevati di elettronica di potenza, componenti digitali e moduli IGBT
- rincari delle componenti importate e dei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di industrie e integratori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi con drive, moduli e schede costose
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
- investimenti necessari in test, collaudi, certificazioni e firmware
- fornitori strategici che richiedono pagamenti immediati
Questi fattori possono portare rapidamente a crisi di liquidità e indebitamento progressivo.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
In questi casi, la velocità è fondamentale. Ecco cosa devi fare subito:
- far analizzare la situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verificare quali debiti sono contestabili, irregolari o prescritti
- evitare accordi di rientro affrettati o non sostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti
- richiedere rateizzazioni realmente sostenibili con AE e INPS
- proteggere fornitori critici e componenti elettronici essenziali
- prevenire blocchi del conto corrente o riduzioni dei fidi
- valutare strumenti legali che consentano di ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Una diagnosi professionale permette di capire quali debiti ridurre, sospendere e contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni subito, i rischi diventano molto seri:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di mezzi, attrezzature o strumentazione tecnica
- blocco delle forniture di convertitori, drive e componenti critici
- impossibilità di completare installazioni o consegne
- perdita di clienti industriali e integratori di sistemi
- danni alla reputazione tecnica
- crisi di liquidità con mancato pagamento di personale e fornitori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Nel tuo settore, anche un breve ritardo può compromettere commesse e linee produttive dei clienti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative mirate
- ottenere rateizzazioni sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
- far annullare debiti prescritti o mal notificati
- negoziare con fornitori e banche per evitare sospensioni delle consegne
- proteggere magazzino, attrezzature e continuità produttiva
- stabilizzare l’azienda durante la ristrutturazione finanziaria
- evitare che la crisi sfoci in insolvenza o chiusura
Una strategia professionale può salvare l’azienda anche in situazioni complesse.
Come evitare il blocco dell’attività
Per garantire continuità operativa devi:
- intervenire immediatamente
- evitare trattative senza una strategia precisa
- proteggere fornitori e componenti elettronici essenziali
- ristrutturare i debiti prima di eventuali pignoramenti
- individuare debiti contestabili o calcolati male
- preservare liquidità per garantire produzione e consegne
Così puoi evitare ritardi, penali e perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo se:
- hai ricevuto solleciti, avvisi o preavvisi di pignoramento
- hai debiti crescenti con AE Riscossione, INPS o fornitori
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità sta calando rapidamente
- hai difficoltà a rispettare scadenze e impegni
- vuoi evitare che la crisi porti alla chiusura dell’azienda
Un avvocato esperto può bloccare subito le procedure, ristrutturare i debiti e salvare concretamente la tua impresa.
Attenzione: molte aziende non falliscono per i debiti, ma per la mancanza di una strategia tempestiva. Con il supporto giusto puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, evitando il collasso.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese elettroniche e industriali – ti aiuta a proteggere la tua azienda di variatori e convertitori di frequenza.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e mettere in sicurezza la tua attività.
Introduzione
Una società di capitali che produce o commercia variatori e convertitori di frequenza e che si trova gravata da debiti (fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi ecc.) deve affrontare complesse scelte strategiche e legali per tutelare la continuità aziendale e difendere sia il patrimonio societario sia quello personale di soci e amministratori. L’ordinamento italiano, specie dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), offre diversi strumenti di risanamento e procedure concorsuali per gestire la crisi, che vanno dalla ristrutturazione del debito in via negoziale a procedure giudiziali come il concordato preventivo (anche in continuità aziendale) o la liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento). Ogni categoria di debito – dai debiti fiscali verso l’Erario a quelli bancari garantiti, dai fornitori ai contributi previdenziali non versati – presenta particolarità nel trattamento e possibili soluzioni differenziate, in base alle tutele legali (privilegi, garanzie) e alle normative speciali applicabili.
Questa guida avanzata, aggiornata a ottobre 2025, esamina in dettaglio cosa può fare un’azienda indebitata nel settore dei variatori e convertitori di frequenza per difendersi dal sovraindebitamento, salvaguardare la continuità aziendale ove possibile e minimizzare i rischi di responsabilità personale per soci e amministratori. Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, con esempi pratici, tabelle riepilogative, una sezione di domande e risposte frequenti e riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati (incluse le più recenti sentenze rilevanti) per avvocati, imprenditori e privati interessati. L’ottica è quella del debitore, ossia delle strategie difensive che l’azienda e i suoi esponenti possono attivare di fronte ai creditori. In fondo alla guida è presente una sezione con tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate.
1. Valutazione iniziale: natura dei debiti e rischi connessi
Il primo passo per un’azienda indebitata è mappare la propria esposizione debitoria, distinguendo per tipologia di debito, e comprendere i relativi rischi legali. In particolare, occorre esaminare:
- Debiti fiscali: imposte non versate (IVA, IRES, IRAP, ritenute) e cartelle esattoriali. Questi debiti godono spesso di privilegi e il mancato pagamento può portare a misure esecutive dell’Erario (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) e, in taluni casi, a responsabilità personali di liquidatori o amministratori ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 . Inoltre, omessi versamenti di IVA o ritenute oltre soglie di legge integrano reati tributari. Va verificato se sono state notificate cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e se l’azienda ha rateizzazioni in corso o può accedere a definizioni agevolate (es. rottamazione).
- Debiti verso fornitori: derivanti da forniture non pagate (merci, servizi). Sono in genere chirografari (non garantiti), salvo eventuali riserve di proprietà o patti di ritenzione. I fornitori possono interrompere le forniture essenziali mettendo a rischio la produzione, oppure agire per decreto ingiuntivo e pignorare beni aziendali. Un accumulo di insoluti con i fornitori incide sull’affidabilità commerciale e può generare azioni legali multiple.
- Debiti bancari e finanziari: mutui, finanziamenti e linee di credito ottenuti da banche o società finanziarie. Spesso sono garantiti da ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o fideiussioni personali di soci/amministratori. Il mancato pagamento comporta rischio di escussione delle garanzie (es. espropriazione di immobili ipotecati) e segnalazioni negative in centrale rischi. Se vi sono garanzie personali, la banca potrà agire anche sul patrimonio privato del garante. Le esposizioni bancarie rilevano anche perché le banche, in qualità di creditori qualificati, possono essere tra i primi a presentare istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) in caso di insolvenza conclamata.
- Debiti verso i dipendenti e istituti previdenziali (INPS, Cassa edile ecc.): ad esempio, retribuzioni arretrate e contributi non versati. I debiti salariali hanno privilegio di rango molto elevato sui beni mobili e immobili dell’azienda; i contributi non versati all’INPS godono di privilegio generale e il loro mancato pagamento oltre determinati limiti configura reato di omissione contributiva (se > €10.000 annui) oppure illecito amministrativo (se ≤ €10.000 annui), punito con sanzioni pecuniarie elevate (ritenute dalla Corte Costituzionale proporzionate alla gravità ). L’omissione contributiva può implicare per l’amministratore anche responsabilità penale (art. 2 d.l. 463/1983) o quanto meno obblighi risarcitori verso la società: ad esempio, la Cassazione ha ritenuto l’amministratore civilmente responsabile per le sanzioni irrogate alla società a causa del mancato versamento di tributi e contributi, configurando tali importi come danno diretto causato dalla sua gestione negligente .
- Debiti verso l’Erario per sanzioni e interessi: oltre ai tributi in senso stretto, vanno considerati interessi moratori e sanzioni amministrative. Questi spesso vengono “cartolarizzati” nelle cartelle esattoriali. In sede di procedure concorsuali sono trattati come chirografari (le sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni tributarie non godono di privilegio) e possono essere falcidiati, ma in sede stragiudiziale di norma il Fisco non rinuncia spontaneamente a sanzioni se non tramite istituti di definizione agevolata previsti per legge.
La società di capitali gode del principio della autonomia patrimoniale perfetta: in linea generale, dei debiti sociali risponde solo la società col suo patrimonio (art. 2740 c.c.), e non i soci (al di là della perdita del capitale investito) né gli amministratori con il proprio. Tuttavia, attenzione: questa separatezza può venire meno in situazioni specifiche previste dalla legge, che costituiscono eccezioni importanti da valutare sin dall’inizio:
- Fideiussioni e garanzie personali: molto frequenti. Se i soci o gli amministratori hanno garantito personalmente obbligazioni sociali (es. fideiussione a una banca, avallo su cambiali, garanzia ipotecaria su un bene personale), il creditore potrà agire sul patrimonio personale del garante una volta che la società sia inadempiente. In pratica, il debito “sconfinato” dalla società al socio garante è un effetto contrattuale volontario, ma concretissimo: la banca o il fornitore garantito non devono far altro che escutere la garanzia una volta scaduto il credito, indipendentemente dalle vicende concorsuali. Ciò espone il privato a possibili pignoramenti di beni personali (es. casa di abitazione se non del tutto impignorabile) e impone di considerare parallelamente strumenti di difesa per il garante (come vedremo, ad esempio, un piano di sovraindebitamento per il socio escusso).
- Responsabilità per mala gestio e violazioni di legge: i creditori sociali possono agire contro gli amministratori qualora questi, violando i doveri verso la società, abbiano aggravato il dissesto (art. 2394 c.c. per S.p.A., art. 2476 c.c. per S.r.l.). Tipicamente, è il curatore fallimentare (ora curatore della liquidazione giudiziale) che esercita l’azione di responsabilità verso gli amministratori per conto di tutti i creditori, chiedendo il risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza dei doveri gestori. Un caso classico è la violazione dell’art. 2486 c.c.: non aver adottato una gestione conservativa dopo lo scioglimento della società per perdite rilevanti. La riforma introdotta dall’art. 378 CCII ha facilitato la prova del danno in queste azioni, prevedendo criteri presuntivi di quantificazione: salva prova contraria, il danno risarcibile è presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento della cessazione dell’amministratore (o dell’apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., al netto dei costi normalmente sostenuti in quel periodo. In mancanza di scritture contabili regolari per calcolare i netti, il danno è pari al deficit fallimentare (differenza tra attivo e passivo accertati) . Ciò significa che un amministratore che abbia ritardato indebitamente il fallimento rischia di dover risarcire l’intero aggravio del passivo maturato nel frattempo, a meno che non provi che il danno effettivo sia inferiore . Esempio: se al manifestarsi della crisi (capitale azzerato) il patrimonio netto era –100 e al fallimento due anni dopo è –500, il danno presunto è 400 (in migliaia di euro, ad es.), salvo che l’amministratore provi che parte di quell’aggravio non gli è imputabile. Questa normativa sprona gli amministratori a non protrarre l’attività in perdita senza prospettive, pena conseguenze pesanti sul piano risarcitorio.
- Responsabilità per gestione fiscale e contributiva scorretta: esistono norme che rendono personalmente responsabili amministratori, liquidatori o soci in determinate circostanze di inadempimento fiscale/previdenziale. Ad esempio, l’art. 36 del d.P.R. 602/1973 prevede che i liquidatori di società di capitali rispondono in proprio delle imposte dovute dalla società (per il periodo di liquidazione e quelli anteriori) se omettono di pagarle con l’attivo di liquidazione e invece soddisfano crediti di ordine inferiore o distribuiscono attivo ai soci senza aver pagato il Fisco . Inoltre, lo stesso articolo (nella formulazione aggiornata dal 2014) estende la responsabilità anche agli amministratori che, in presenza di cause di scioglimento, non adempiono all’obbligo di conservazione del patrimonio: se non mettono la società in liquidazione o compiono operazioni distrattive nei due anni precedenti la liquidazione, possono rispondere dei debiti tributari, così come ne rispondono i soci limitatamente a quanto ricevuto nei due anni anteriori . Questa responsabilità ha natura di obbligazione legale autonoma, che tuttavia è sussidiaria: scatta solo se i crediti tributari non sono soddisfatti con il patrimonio sociale. Peraltro, secondo giurisprudenza recente è necessario un accertamento specifico del Fisco sul comportamento illecito dell’amministratore; non basta il semplice ruolo debitorio per riversargli il debito . Una sentenza del 2025 (Corte Giust. Trib. Lombardia n. 752/2025) ha ribadito che i debiti fiscali di una S.r.l. non ricadono automaticamente sugli amministratori, in assenza di prove di condotte illecite personali . L’Agenzia delle Entrate deve dimostrare in modo specifico il coinvolgimento dell’amministratore in violazioni gravi prima di poter esigere il pagamento da lui . Questo è un importante punto di tutela: in altre parole, la carica sociale di per sé non implica che “i debiti fiscali seguono l’amministratore” – serve un fondamento giuridico concreto . Ciò non toglie però che, in presenza di comportamenti dolosi (es. mancato versamento di IVA fraudolento, distrazione di attivi), la responsabilità personale scatti ed è anzi rafforzata dalle norme penali e tributarie.
Rischio di insolvenza e procedure concorsuali: quando i debiti superano la capacità finanziaria dell’azienda e questa diviene incapace di soddisfarli regolarmente, si configura lo stato di insolvenza (art. 2 CCII) e diviene concreto il rischio di una procedura concorsuale avviata dai creditori o dall’azienda stessa. Già lo stato di crisi (squilibrio che non ha ancora raggiunto l’insolvenza conclamata) dovrebbe spingere l’imprenditore ad attivarsi, anche perché il nuovo Codice della crisi enfatizza la prevenzione e l’emersione tempestiva delle difficoltà. Dal 2022 sono previsti obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari (sindaci, revisori) e incentivi all’imprenditore per affrontare precocemente la crisi, ad esempio tramite la composizione negoziata (strumento di allerta “assistita” di cui diremo). Ignorare i segnali di crisi espone l’amministratore a quelle azioni di responsabilità di cui sopra, oltre che aggravare il rischio di default disordinato.
Una società insolvente, se non cerca soluzioni, può essere posta in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o dell’azienda stessa. Ciò comporta la perdita della disponibilità dei beni aziendali (che passano al curatore) e spesso la cessazione dell’attività con dispersione dell’avviamento. Anche un’eventuale procedura di concordato preventivo in extremis potrebbe essere vanificata se avviata troppo tardi e senza preparazione adeguata.
Sintesi dei rischi iniziali per l’azienda debitrice:
- Misure esecutive individuali: ogni creditore (banca, fornitore, fisco) può procedere con atti esecutivi (pignoramenti di conti, macchinari, immobili, crediti verso clienti) appena munito di un titolo esecutivo. Questo può paralizzare l’operatività (es. pignoramento del conto corrente aziendale). Per l’Erario e l’INPS, titoli come la cartella esattoriale o l’accertamento esecutivo consentono azioni rapide, inclusa l’iscrizione di ipoteca sugli immobili sociali o il fermo dei mezzi.
- Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): creditori insoddisfatti possono chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale) della società. Per le società di capitali “fallibili” (che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 2 LF/CCII: attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k circa, verificati negli ultimi esercizi), il tribunale accerterà lo stato di insolvenza. Se la società del nostro caso è un’azienda strutturata (è probabile, considerando che opera in un settore industriale di nicchia), difficilmente rientra tra i soggetti “minori” esentati: quindi il pericolo di liquidazione giudiziale su impulso dei creditori è reale.
- Perdita della continuità aziendale: l’esecuzione individuale e soprattutto il fallimento comportano tipicamente l’interruzione o la forte compressione dell’attività d’impresa. Ciò può far perdere il valore aziendale che risiede nell’avviamento, nel know-how, nella rete commerciale e nel personale specializzato. Esempio: se l’azienda di variatori ha contratti in corso o commesse future, un fallimento in tronco li farà decadere, mentre un’azione concordata (es. concordato con continuità) potrebbe preservare questi asset immateriali.
- Implicazioni reputazionali e contrattuali: la notizia dell’insolvenza (p.es. domanda di concordato o sentenza di fallimento) può far scattare clausole risolutive nei contratti con clienti o fornitori strategici e certamente compromette la fiducia del mercato. Anche l’accesso al credito viene azzerato.
Conclusione della valutazione iniziale: l’azienda deve agire con tempestività, scegliendo la strategia più adatta per il risanamento o, se questo non è possibile, per la liquidazione ordinata dei debiti. Nel fare ciò bisogna massimizzare la tutela del valore aziendale (macchinari, brevetti, relazioni commerciali) e minimizzare gli effetti pregiudizievoli sui soci e amministratori. Nei capitoli successivi esamineremo gli strumenti previsti dalla normativa italiana vigente per gestire la crisi, con particolare attenzione alle novità introdotte dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche, inclusi i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), e come essi possano essere utilizzati dal debitore in difficoltà. Si ricorda infatti che la riforma della crisi d’impresa ha l’obiettivo dichiarato di favorire la continuità aziendale delle imprese vitali e oneste in difficoltà, e di rendere più efficiente la liquidazione di quelle non risanabili, contemperando la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell’indotto .
2. Normativa di riferimento: il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
La disciplina applicabile alla crisi dell’azienda in esame è contenuta principalmente nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. Questo Codice ha sostituito, modernizzandola, la vecchia legge fallimentare (r.d. 267/1942) e le norme sul sovraindebitamento (l. 3/2012), attuando anche la Direttiva UE 2019/1023 in materia di ristrutturazioni preventive . Dopo vari rinvii, il CCII è entrato in vigore in modo completo a luglio 2022 e da allora è stato integrato e corretto da successivi provvedimenti (noti come correttivo): in particolare, il d.lgs. 83/2022 (attuazione della direttiva UE) e da ultimo il d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (“Correttivo-ter”), in vigore dal 28 settembre 2024 . Quest’ultimo intervento normativo ha affinato diverse disposizioni per migliorarne l’efficacia, specie sulla composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo e il nuovo piano di ristrutturazione omologato .
Riassumiamo i principi cardine e l’ambito di applicazione della normativa italiana attuale:
- Soglie di fallibilità: le società di capitali, come la nostra azienda, sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie se superano congiuntamente determinati limiti dimensionali (ricavi lordi annui oltre €200.000, attivo patrimoniale oltre €300.000 e debiti oltre €500.000, riferiti di norma ai bilanci degli ultimi esercizi – art. 2 CCII). Al di sotto di tali soglie, l’impresa è considerata “minore” e, pur non fallendo, può accedere alle procedure di sovraindebitamento speciali (concordato minore, liquidazione controllata). Nel nostro caso, un’azienda industriale di variatori di frequenza presumibilmente eccede tali parametri, salvo si tratti di una realtà micro-imprenditoriale, e dunque rientra nel campo “ordinario”.
- Stato di crisi e stato di insolvenza: il CCII distingue il concetto di crisi (squilibrio che rende probabile l’insolvenza futura) da quello di insolvenza (incapacità conclamata di far fronte regolarmente alle obbligazioni scadute). Questa distinzione è importante perché alcuni strumenti (es. la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione) possono essere attivati già in situazione di crisi incipiente, mentre altri (es. liquidazione giudiziale) richiedono l’insolvenza conclamata.
- Obblighi di emersione tempestiva: gli amministratori hanno il dovere (art. 3 CCII, art. 2086 c.c. novellato) di attivarsi per adottare strumenti idonei al superamento della crisi appena ne hanno sentore, instaurando adeguati assetti organizzativi per rilevare gli indizi di difficoltà. Gli organi di controllo societari devono segnalare tempestivamente le irregolarità gestionali e le perdite significative. Il sistema di allerta vero e proprio (segnalazioni esterne ad OCRI) è attualmente non operativo, ma rimane un generale obbligo di diligenza nella gestione della crisi.
- Strumenti di regolazione della crisi e insolvenza: il Codice prevede un ventaglio di strumenti, di natura negoziale o giudiziale, alcuni nuovi rispetto al passato:
- Composizione negoziata della crisi: procedura volontaria, confidenziale, di negoziazione assistita da un esperto indipendente, introdotta con d.l. 118/2021 (oggi nel CCII art. 17 ss.).
- Piano attestato di risanamento (PAR): accordo stragiudiziale basato su un piano di risanamento asseverato da un professionista (art. 56 CCII), evoluzione della procedura ex art. 67 l.fall.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: contratti tra debitore e una maggioranza qualificata di creditori, omologati dal tribunale (artt. 57-64 CCII, ex art. 182-bis l.fall.), inclusi accordi agevolati e ad efficacia estesa verso dissenzienti.
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): nuovo strumento (introdotto dal d.lgs. 83/2022, inserendo gli artt. 64-bis, 64-ter, 64-quater CCII) che consente un piano concordato all’unanimità tra le classi di creditori, con contenuto libero anche in deroga alle cause di prelazione . È un ibrido tra accordo privato e procedura concorsuale: richiede consenso unanime delle classi, ma ha effetto omologato dal tribunale. In pratica, il PRO permette di distribuire il valore generato dal piano anche non rispettando la graduazione legale dei crediti (ad es. pagando di più chirografari a scapito di privilegiati) purché tutti i creditori di ciascuna classe siano d’accordo . Se anche un solo creditore per classe dissente, il PRO non è approvabile (non essendo previsto cram-down in questa sede) .
- Concordato preventivo: procedura concorsuale giudiziale di soluzione della crisi, che può essere in continuità aziendale (prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta) o liquidatorio (cessione del patrimonio). Il concordato è sottoposto al voto dei creditori e all’omologazione del tribunale. Il CCII ha innovato la disciplina del concordato, in particolare introducendo la ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram down): il tribunale può omologare il concordato in continuità anche senza il voto favorevole di tutte le classi di creditori, a certe condizioni di equità e convenienza . In altre parole, se almeno una classe importante approva e le classi dissenzienti non sono pregiudicate rispetto a una liquidazione (fairness test), il concordato può essere imposto anche contro il voto contrario di talune classi (ossia un piano non consensuale ai sensi dell’art. 11 della Direttiva UE) . Questa novità (rafforzata dal correttivo 2024 che ha chiarito i criteri di cram-down nell’art. 112 CCII) amplia le possibilità di conferma del concordato anche in presenza di creditori dissenzienti, evitando che uno o pochi creditori in posizione strategica possano bloccare soluzioni favorevoli per la maggioranza .
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: introdotto nel 2021 e ora all’art. 25-sexies CCII, è uno strumento eccezionale utilizzabile solo all’esito infruttuoso di una composizione negoziata, che consente al debitore di chiedere l’omologazione di un piano liquidatorio senza votazione dei creditori (i quali però possono proporre opposizione in sede di omologa). Serve per evitare la liquidazione giudiziale quando la negoziazione non ha prodotto accordi, ma la proposta del debitore appare comunque più vantaggiosa per i creditori rispetto al fallimento.
- Liquidazione giudiziale: la procedura concorsuale liquidatoria equivalente al vecchio fallimento, in cui il patrimonio dell’impresa è destinato a essere venduto e distribuito ai creditori secondo le cause di prelazione. È avviata con sentenza del tribunale e comporta la spossessamento dell’imprenditore, la nomina di un curatore, lo scioglimento degli organi sociali e la fine dell’attività (salvo esercizio provvisorio temporaneo se utile per la conservazione dell’attivo). La liquidazione giudiziale può seguire al fallimento di un concordato (es. concordato non omologato, non eseguito o risolto), oppure essere la prima e unica soluzione se non vi sono prospettive di risanamento.
- Continuità aziendale vs. liquidazione: il CCII incoraggia, ove possibile, soluzioni che preservino la continuità dell’impresa (anche attraverso trasferimenti a terzi) perché più vantaggiose socialmente ed economicamente. Il legislatore bilancia tale obiettivo con la tutela dei creditori, imponendo nei concordati in continuità il rispetto di regole severe (pagamento integrale crediti privilegiati o assoluta priorità sul valore di liquidazione, etc.). Se la continuità non è sostenibile, il sistema assicura comunque procedure liquidatorie ordinate. Vi sono misure premiali per chi tenta la continuità: ad es. nel concordato in continuità aziendale sono ammessi pagamenti di crediti anteriori se funzionali al going concern (art. 95 CCII) e finanziamenti prededucibili per tenere in vita l’attività.
- Trattamento dei crediti pubblici (fisco, previdenza): un aspetto rilevante per la nostra azienda, viste le voci debitorie fiscali e contributive, è la cosiddetta transazione fiscale e contributiva. Il CCII ha integrato la possibilità di accordarsi con Fisco ed enti previdenziali all’interno di accordi di ristrutturazione e concordati. Le norme originarie (art. 182-ter l.fall.) sono ora trasfuse negli artt. 63 e 88 CCII. Il d.lgs. 83/2022 e il d.lgs. 136/2024 hanno reso questa materia più flessibile: oggi è espressamente consentito includere nel piano proposte di pagamento parziale o dilazionato di imposte e contributi, purché un esperto indipendente attesti che il trattamento offerto a tali crediti non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria . Di fatto, la riduzione dei debiti fiscali non è più un tabù, ma deve essere giustificata dalla convenienza per l’Erario in confronto a quanto otterrebbe in un fallimento. Inoltre, se il piano presentato è in continuità aziendale e soddisfa certe condizioni, il tribunale può omologare forzosamente l’accordo o il concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, qualora il suo dissenso sia determinante per le maggioranze ma il piano sia vantaggioso (c.d. cram down fiscale) . Vi sono però limiti: il correttivo 2024 ha escluso la possibilità di cram-down sui crediti erariali quando l’impresa abbia un indebitamento fiscale oltre una certa soglia o frutto di condotte fiscalmente scorrette (ad esempio, quando oltre 80% del debito totale è verso Erario, indice di evasione come “auto-finanziamento surrettizio”) . In tali casi di conclamata evasione, la proposta di transazione fiscale è comunque ammessa ma, se il Fisco nega l’adesione, non si potrà omologare il piano contro la sua volontà . Resta salva però la possibilità che l’Erario stesso valuti la proposta ed eventualmente vi aderisca se la ritiene conveniente, anche quando il debitore ha pregresse violazioni (il legislatore non ha precluso l’accesso alla procedura ma solo l’imposizione forzosa) .
- Procedure minori e casi speciali: per completezza, ricordiamo che il CCII disciplina anche il concordato minore (ex procedura da sovraindebitamento, per debitori non fallibili) e la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Tali procedure, tuttavia, riguardano tipicamente piccoli imprenditori o privati; una società di capitali di medie dimensioni utilizzerà invece gli istituti principali sopra detti. Esistono poi procedure speciali fuori dal CCII: ad es. amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 270/99 o legge Marzano) riservata a imprese con oltre 200 dipendenti, volta al risanamento o cessione dei complessi aziendali. Questa ipotesi appare remota per un’azienda del nostro settore a meno che non abbia dimensioni davvero rilevanti.
Norme penali e riflessi sulla crisi: parallelamente al CCII, persistono le norme penali della legge fallimentare (ancora applicabili in virtù del rinvio operato dal CCII) che sanzionano le condotte fraudolente o irregolari dell’imprenditore: bancarotta fraudolenta (distrazione di beni, false scritture), bancarotta preferenziale (pagamenti preferenziali a danno della par condicio) e altri reati concorsuali. Queste norme, ora coordinate con la liquidazione giudiziale, implicano che nella gestione della crisi bisogna evitare qualsiasi atto che possa configurarsi come reato fallimentare, pena responsabilità penale diretta degli amministratori. Va segnalato che, in caso di concordato preventivo, la bancarotta fraudolenta pre-fallimentare non viene in essere perché non vi è dichiarazione di fallimento; tuttavia esistono fattispecie di reati nelle procedure concorsuali (ad es. falso in attestazioni se l’attestatore indipendente collude col debitore, reato introdotto per scoraggiare abusi).
Sguardo d’insieme: il quadro normativo offre dunque all’imprenditore indebitato diverse vie d’uscita, ma ognuna con pre-condizioni e conseguenze differenti. Nei prossimi capitoli analizzeremo come questi strumenti possano essere concretamente utilizzati dall’azienda di variatori e convertitori di frequenza per ristrutturare il debito o, se necessario, liquidare in modo controllato, proteggendo per quanto possibile il business sano e i soggetti coinvolti. Partiremo dagli strumenti stragiudiziali e semi-stragiudiziali, per poi trattare le procedure concorsuali giudiziali, e infine focalizzeremo l’attenzione sulle tutele della continuità aziendale e sulle difese personali di soci e amministratori.
3. Strumenti di gestione della crisi: soluzioni stragiudiziali e giudiziali a confronto
Affrontare i debiti di un’azienda in crisi significa scegliere tra cercare un risanamento (ristrutturando il debito e proseguendo l’attività) oppure procedere a una liquidazione ordinata dell’impresa. La scelta dipende dalla valutazione prospettica: l’azienda ha una capacità di generare reddito e flussi finanziari positivi in futuro (magari dopo una riorganizzazione), oppure no? E ancora: vi sono soggetti interessati a investire o rilevare l’azienda? Se la risposta è sì, conviene tentare la strada del risanamento con continuità; se la risposta è negativa, bisogna puntare a minimizzare le perdite dei creditori tramite liquidazione.
In questa sezione distinguiamo gli strumenti stragiudiziali (o para-giudiziali) – che si basano su accordi volontari – dagli strumenti giudiziali (procedure concorsuali vere e proprie). Entrambe le categorie hanno pro e contro riassunti nella Tabella 1.
Tabella 1 – Confronto tra soluzioni stragiudiziali e procedure concorsuali giudiziali
| Caratteristica | Soluzioni Stragiudiziali (es. piano attestato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata) | Procedure Giudiziali (es. concordato preventivo, liquidazione giudiziale) |
|---|---|---|
| Formalità e tempi | Flessibili, meno formalità. Tempi dipendenti dalla negoziazione privata (possono essere rapidi se c’è intesa, o protrarsi se molti creditori). | Richiedono atti formali al tribunale (ricorso, omologa) e rispettano tempistiche di legge. Possono durare diversi mesi o anni. |
| Coinvolgimento autorità | Limitato o assente. Il tribunale interviene solo per omologare gli accordi ex art. 182-bis (ora 63 CCII) o per autorizzare misure protettive nella composizione negoziata. | Intenso. Il tribunale sorveglia la procedura, nomina ausiliari (commissario, curatore), omologa il concordato, dichiara la liquidazione, ecc. |
| Adesione dei creditori | Volontaria: occorre il consenso effettivo dei creditori chiave. Negli accordi di ristrutturazione serve il ≥60% dei crediti totali (dissenzienti fuori dall’accordo restano esigibili, salvo accordo esteso in certe condizioni) . Nel piano attestato serve l’adesione integrale di chi subisce modifiche (non ha effetti cogenti per i dissenzienti). | Può essere imposta a minoranze dissenzienti: nel concordato basta la maggioranza per classe e si può forzare il dissenso (cram down) se condizioni rispettate . Nella liquidazione giudiziale i creditori subiscono decisioni senza necessità di consenso. |
| Effetti protettivi (stay) | Composizione negoziata: su istanza del debitore, il tribunale può disporre misure protettive temporanee (blocco delle azioni esecutive) per facilitare le trattative (art. 20 CCII). Piano attestato: nessuna protezione formale, ma si può ricorrere ad accordi standstill volontari. Accordo di ristrutturazione: dalla pubblicazione dell’accordo o dalla domanda di omologa scatta l’automatica protezione dai sequestri e dalle azioni esecutive dei creditori aderenti e possibilità di richiederla anche verso non aderenti (art. 54 e 64 CCII). | Concordato preventivo: dalla data di ammissione (o dalla pubblicazione della domanda “in bianco”) vige il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori anteriori (stay automatico). Liquidazione giudiziale: dalla sentenza di apertura tutte le azioni individuali sono impedite e confluiscono nella procedura collettiva. |
| Pubblicità | Relativamente riservate. Composizione negoziata: non è pubblica salvo misure protettive (iscrizione al registro imprese). Piano attestato: documento tenuto riservato, eventuale annotazione solo se si vuole esenzione da revocatoria (registrazione). Accordo ristrutturazione: è pubblico perché depositato in tribunale per l’omologa (iscritto nel registro imprese). | Molto pubbliche: l’apertura di una procedura concorsuale viene iscritta nel registro imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e comunicata ai creditori. La reputazione dell’impresa ne risente (anche se oggi si parla di “soluzione concordataria” e non più di default totale). |
| Vincolatività e controllo | Meno vincolanti per il debitore prima della conclusione: il debitore può abbandonare la trattativa se non soddisfatto (ma occhio alla buona fede nelle trattative). Non c’è esame di merito di un giudice sul contenuto economico (salvo l’attestazione tecnica di un esperto per piani e accordi). Tuttavia, una volta firmato l’accordo, esso vincola le parti come un contratto. | Vincolanti e sotto controllo giudiziario: ad es. nel concordato il piano dev’essere fattibile e “meritevole” (no frode ai creditori), il giudice e il commissario vigilano. Una volta omologato, il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori (dissenzienti compresi). Nella liquidazione, le regole di riparto sono imposte dalla legge. |
| Costo | In genere inferiori: ridotti costi legali e consulenziali (sebbene un piano attestato richiede l’attestatore, e la composizione negoziata ha un esperto nominato). Non vi sono spese di procedura o compensi per organi concorsuali. | Più onerose: prevedono contributo unificato, spese di giustizia, e i compensi di curatore/commissario e ausiliari sono a carico dell’attivo. C’è però il controllo pubblico sull’equità delle spese. |
| Vantaggi principali | Flessibilità: si può adattare l’accordo alle esigenze delle parti. Rapidità: se c’è accordo, si evita la lunga trafila concorsuale. Minor stigma: mantenendo riservatezza, l’azienda salva la reputazione. Continuità meno perturbata: negoziare fuori dal tribunale evita gli effetti dirompenti di una procedura (clienti e fornitori magari non vengono nemmeno a saperlo, se gestito bene). | Forza legale erga omnes: il concordato o la liquidazione coinvolgono tutti i creditori, anche quelli non consenzienti, assicurando una soluzione globale. Stay automatico: tutela immediata dal’aggressione dei creditori. Possibilità di cram down: come detto, si possono superare dissensi isolati se il piano nel complesso è valido . Prededuzione nuovi finanziamenti: in procedure omologate, eventuali finanziamenti di emergenza possono essere privilegiati (prededucibili) per incoraggiare la finanza esterna. Esdebitazione (per imprenditore individuale): in liquidazione giudiziale, il debitore persona fisica può ottenere la liberazione dai debiti residui post-procedura. |
| Svantaggi principali | Rischio di fallimento dei negoziati: basta un creditore importante non aderente per far saltare lo schema, poiché non c’è coattività completa. Assenza di poteri coercitivi: non si possono imporre tagli del debito ai dissenzienti (tranne il caso limitato di accordi ad efficacia estesa per finanziatori). Mancanza di certezza definitiva: se restano creditori fuori dall’accordo, questi possono agire comunque (es. creditore non aderente può portare i libri in tribunale). Minor trasparenza: i creditori non coinvolti potrebbero lamentare discriminazioni. | Procedura lunga e complessa: richiede la gestione delle formalità, la votazione, possibili opposizioni e impugnazioni. Perdita di gestione: nel concordato l’imprenditore opera sotto vigilanza del commissario, nella liquidazione perde la gestione. Costi e pubblicità: come detto, costi alti e notorietà pubblica della crisi. Rigidità: le procedure seguono schemi normativi rigidi, con minor margine creativo (anche se il concordato offre diverse opzioni di contenuto, soggette però alle regole di legge). |
Come evidenziato, la scelta tra approccio stragiudiziale e giudiziale dipende molto dalla composizione del ceto creditorio e dai rapporti con esso. Se l’azienda ha pochi creditori essenziali (ad es. due banche principali e il Fisco) con cui è possibile trovare un accordo, le soluzioni negoziali sono preferibili: evitano l’alea del tribunale e preservano rapporti e reputazione. Al contrario, se i creditori sono numerosi e molto conflittuali, o se qualcuno ha già agito aggressivamente, un concordato preventivo può offrire la protezione unitaria necessaria.
Nel nostro caso, ipotizziamo che l’azienda di variatori abbia diversi fornitori, banche e un debito fiscale consistente. Probabilmente la platea è ampia e diversificata: ciò potrebbe far propendere per un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione omologato, strumenti che vincolano la minoranza dissenziente. Tuttavia, prima di arrivare in tribunale, conviene esplorare i tentativi stragiudiziali: spesso una trattativa ben condotta può portare a soluzioni consensuali più rapide ed efficienti.
Passiamo ora in rassegna i principali strumenti utilizzabili.
3.1 Soluzioni stragiudiziali e para-giudiziali
a) Composizione negoziata della crisi (artt. 17-25 quinquies CCII): è uno strumento introdotto di recente (nel 2021, convertito in legge 147/2021, poi confluito nel Codice) che offre all’imprenditore in crisi la possibilità di avviare una trattativa strutturata con i creditori con l’ausilio di un esperto indipendente nominato da un’apposita Commissione. La composizione negoziata è volontaria e riservata: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma online dedicata, indicando la situazione aziendale e le prospettive di risanamento. Viene nominato un esperto (di solito un commercialista o professionista della crisi, formato e iscritto in un elenco ad hoc) che assiste nelle trattative, cercando di facilitare accordi con i creditori. I poteri dell’esperto sono di mediazione e osservazione; egli non può imporre soluzioni ma può formulare proposte e “richiamare le parti al dovere di leale cooperazione”. Durante la composizione negoziata, su richiesta del debitore, il tribunale può concedere misure protettive per evitare che i creditori pregiudichino le trattative (tipicamente sospensione delle azioni esecutive fino a 4 mesi, prorogabili ). Nel nostro caso, l’azienda potrebbe avvalersi di questo strumento per guadagnare tempo e spazio negoziale: ad esempio, potrebbe ottenere dal tribunale il blocco temporaneo di pignoramenti e fermi fiscali mentre tenta un accordo con banche, fornitori e Agenzia Entrate.
La composizione negoziata è flessibile nei punti di arrivo: può concludersi con un nulla di fatto (se le trattative falliscono), oppure con diverse soluzioni: – Un contratto con uno o più creditori (es. accordo bilaterale di moratoria con le banche). – Un accordo di ristrutturazione dei debiti formale da omologare (se si raggiunge la soglia del 60% e si vuole estendere gli effetti). – Un concordato preventivo o un concordato semplificato se le trattative delineano un piano ma manca l’adesione dei creditori (il concordato semplificato, in particolare, è pensato proprio come sbocco di chi ha utilizzato la composizione negoziata senza ottenere accordi soddisfacenti, consentendo al debitore di sottoporre ugualmente al giudice un piano liquidatorio da omologare senza voto).
Un vantaggio importante della composizione negoziata è la possibilità di coinvolgere il Fisco in maniera costruttiva. Il correttivo 2024 (d.lgs. 136/2024) ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 23 CCII che consente, durante la composizione negoziata, di concludere con l’Agenzia Entrate un accordo per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e relativi accessori . Ciò risponde all’esigenza pratica: spesso l’erario è il creditore più rigido, e in mancanza di una cornice legale non accetta falcidie. Ora invece, in sede di composizione negoziata, il debitore può proporre formalmente un taglio o una rateazione del debito fiscale (analogamente alle transazioni fiscali dei concordati), assistita dall’attestazione di un professionista sulla convenienza rispetto alla liquidazione . Sono esclusi dalla trattativa solo i tributi locali (Comuni, Regioni) e i tributi costituenti risorse proprie UE (dazi doganali), mentre l’IVA è inclusa e negoziabile (contrariamente a quanto si crede, l’IVA non è considerata risorsa propria UE in questo contesto) . Questo accordo col Fisco può essere autorizzato dal tribunale e, se il debitore poi accede a un concordato semplificato o altro, rimane valido (purché la nuova procedura non muti lo scenario in modo peggiorativo) . In caso di mancato rispetto delle rate, l’accordo si risolve di diritto e l’Erario potrà far valere l’intero credito . Nota: attualmente tale possibilità di accordo nella composizione negoziata non si estende agli enti previdenziali (INPS), i quali restano fuori da questa procedura e potranno eventualmente essere coinvolti solo in sede di concordato o accordo di ristrutturazione .
Perché l’azienda di variatori dovrebbe considerare la composizione negoziata? Perché essa anticipa soluzioni prima che si arrivi all’insolvenza irreversibile. Ad esempio, se l’azienda intravede che nei prossimi 6 mesi non potrà onorare €500k di debiti, attivando la composizione già ora potrebbe ottenere: – dalle banche, un congelamento delle rate o una rinegoziazione del prestito (magari estensione delle scadenze, o conversione di linee a breve in finanziamenti a medio termine); – dai fornitori strategici, la continuazione delle forniture dietro impegno di pagare regolarmente il “nuovo” e dilazionare l’arretrato; – dal Fisco, come detto, un possibile sconto su sanzioni e interessi e una comoda dilazione del dovuto (ad esempio spalmare in 5 anni il debito IVA) con attestation di convenienza ; – eventuali nuovi finanziamenti prededucibili: durante la composizione, se l’esperto vi consente, la società può contrarre finanziamenti urgenti che saranno privilegiati in caso di successiva procedura (art. 22 CCII) per avere la liquidità necessaria a stare a galla.
Va anche detto che l’adesione alla composizione negoziata comporta alcuni vantaggi normativi introdotti per incentivarla: ad esempio, la sospensione temporanea delle cause di scioglimento della società per perdite (art. 20 co. 3) e protezioni sul fronte penale (in caso di misure protettive concesse, alcuni reati di bancarotta preferenziale e semplice sono attenuati se atti compiuti in funzione del piano).
Limiti della composizione negoziata: richiede un certo grado di collaborazione dai creditori. Se questi sono troppi o troppo conflittuali, l’istituto rischia di non produrre accordi vincolanti. Inoltre, è utile soprattutto per aziende ancora in piedi, non per quelle già totalmente insolventi: se l’impresa è già al collasso, i creditori potrebbero non dare fiducia alle mere negoziazioni.
b) Piano attestato di risanamento (PAR) – art. 56 CCII: è la versione rinnovata di uno strumento storico di risanamento stragiudiziale (già previsto dall’art. 67, co. 3, lett. d) della legge fallimentare). Consiste in un piano di risanamento predisposto dall’impresa (con l’ausilio dei suoi consulenti) e asseverato da un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Il piano deve essere idoneo a consentire il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa entro un termine ragionevole. Una caratteristica chiave del PAR è che non necessita di omologazione giudiziaria né di adesione di tutte le classi di creditori: non è una procedura concorsuale, ma un’iniziativa unilaterale del debitore cui possono aderire i creditori di volta in volta interessati. In sostanza, il debitore elabora il piano e negozia individualmente con i vari creditori modifiche alle condizioni di pagamento in coerenza con il piano. I creditori che accettano, firmano accordi bilaterali (es. accordo di saldo e stralcio, rinuncia a parte del credito, dilazione). Il beneficio legale del piano attestato sta nel fatto che gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di esso non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso poi di fallimento (art. 56 co. 3 CCII): ciò dà sicurezza ai creditori aderenti, che non rischiano di vedersi chiedere indietro i pagamenti ricevuti se il risanamento poi fallisce . Inoltre, il piano attestato non viene pubblicato, quindi è uno strumento che può restare confidenziale (sebbene talvolta il debitore depositi una sintesi presso il Registro Imprese proprio per rendere opponibile ai terzi l’esenzione da revocatoria).
Quando usare un piano attestato? In situazioni di crisi gestibile con accordi privati mirati. Ad esempio, se l’azienda ha pochi debiti cruciali e prevede di risolverli tramite nuove risorse (rifinanziamento, dismissione di un cespite, aumento di capitale dei soci, ecc.), può redigere un piano attestato per dare credibilità alle proprie prospettive e convincere i creditori a concedere respiro. Esempio: i soci decidono di immettere €200k freschi nell’azienda e chiedono alle banche di allungare le scadenze di 3 anni e ai fornitori di accettare un pagamento al 50% dell’arretrato in 12 mesi. Se la quantità di creditori è limitata e c’è fiducia nel management, un PAR può funzionare.
Vantaggi: estrema flessibilità e minima invadenza (nessun tribunale coinvolto), minima pubblicità, preserva l’immagine aziendale. Svantaggi: non offre protezione automatica verso eventuali creditori estranei che decidano di agire esecutivamente; e se anche un singolo creditore importante non collabora, può far saltare l’intero risanamento (non esiste meccanismo di cram down). Inoltre, la qualità del professionista attestatore è fondamentale: la sua relazione deve essere solida, perché in caso di insuccesso e fallimento successivo, l’attestatore potrebbe rispondere di attestazione falsa o negligente.
Nel nostro caso, se i debiti fossero concentrati ad esempio in due banche e pochi fornitori principali, con l’Erario gestibile con una rateazione ordinaria, un piano attestato potrebbe bastare. Tuttavia, avendo tipicamente un debito fiscale di rilievo e vari fornitori, il piano attestato puro rischia di essere insufficiente, a meno di integrarlo poi con accordi di ristrutturazione.
c) Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) – art. 57 e ss. CCII: è un istituto semi-concorsuale: un accordo tra il debitore e una parte significativa dei creditori (almeno 60% dei crediti totali) che, dopo omologazione del tribunale, diventa vincolante per le parti aderenti e offre alcuni effetti protettivi. A differenza del concordato, l’accordo di ristrutturazione non vincola i creditori non aderenti, i quali conservano i loro diritti per intero (devono però essere interamente pagati dal debitore entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza, come condizione di omologazione, a meno che non siano piccole imprese con crediti modesti, art. 61 CCII). Dunque l’accordo serve quando la maggioranza dei creditori è favorevole a un piano di rientro, ma qualche dissenziente resta fuori: questi va liquidato per intero (o segregato in garanzia) per ottenere l’omologa.
Nel CCII esistono varianti: – Accordi “agevolati”: se l’accordo coinvolge creditori rappresentanti almeno il 30% dei crediti, il debitore può chiedere misure protettive (stay) e financo il cram down del Fisco o degli enti previdenziali dissenzienti in certe condizioni (art. 63 co. 4 CCII, introdotto per recepire la Direttiva). Il correttivo 2024, come visto, consente al tribunale di omologare l’accordo anche se manca l’adesione del Fisco e il suo voto contrario è determinante, purché il piano non sia di carattere liquidatorio e il dissenso fiscale sia l’unico ostacolo alle maggioranze . Resta precluso il cram down erariale in caso di grave inadempienza tributaria (comportamento fiscalmente scorretto o accordi recenti già saltati) . – Accordo ad efficacia estesa: riguarda tipicamente le banche e gli intermediari finanziari. Se il debitore ottiene l’adesione di almeno il 75% di creditori appartenenti a una determinata categoria omogenea (ad es. tutti gli istituti finanziatori), può chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori finanziari dissenzienti che appartengono a quella categoria (art. 61 CCII). È una sorta di cram-down settoriale pensato per evitare che un singolo istituto di credito blocchi un piano sostenuto dalla maggioranza delle banche. – Accordi con intermediari speciali: sono previste norme ad hoc per la moratoria dei debiti verso banche e fornitori strategici, con efficacia condizionata se raggiunte certe percentuali (cosiddetti accordi di moratoria ex art. 62 CCII, evoluzione dei protocolli ABI).
Un accordo di ristrutturazione viene formalizzato in un atto contrattuale sottoscritto dal debitore e dai creditori aderenti, corredato da una relazione di un esperto attestatore sull’attuabilità e sulla capacità del debitore di pagare regolarmente i creditori estranei. Il tribunale omologa l’accordo (dopo aver riscontrato il raggiungimento delle percentuali, la fattibilità e l’assenza di pregiudizio per i creditori estranei). Con l’omologa, l’accordo acquista efficacia legale.
Vantaggi rispetto al concordato: è più snello (non c’è voto di tutti i creditori, ma solo trattativa con alcuni), e l’azienda rimane in mano all’imprenditore senza commissari. Inoltre, l’accordo può essere mantenuto riservato fino alla presentazione in tribunale; e l’iter di omologa è tendenzialmente più rapido e meno conflittuale (non essendoci un giudizio di voto). Spesso l’accordo è preferito quando il debitore ha una composizione del passivo polarizzata: ad esempio, se l’80% dei debiti è verso banche e queste concordano un piano, mentre il resto sono piccoli fornitori che verranno pagati integralmente, è inutile fare un concordato che coinvolga tutti: basta un accordo con le banche, e i fornitori fuori saranno saldati in natura.
Svantaggi: se c’è anche un solo grande creditore non collaborativo che il debitore non può permettersi di pagare integralmente, l’accordo di ristrutturazione non è praticabile. Inoltre, finché non è omologato, i creditori dissenzienti possono agire: qui in soccorso viene l’art. 54 CCII che consente di chiedere al tribunale misure protettive (analoghe al concordato) dalla data della pubblicazione dell’accordo (o anche prima, con la domanda di trattativa agevolata). Tali misure, tuttavia, non possono eccedere 4 mesi (prorogabili di 4) e possono essere revocate se l’accordo appare irrealizzabile.
Per la nostra azienda, un accordo di ristrutturazione sarebbe indicato se, ad esempio, riuscisse a ottenere l’impegno di banche e Fisco su un piano di rientro. Immaginiamo: due banche detengono il 50% dei crediti, l’Erario e l’INPS un altro 20%, fornitori il 30%. Se banche e Agenzia Entrate (magari con transazione su sanzioni) aderiscono, già si supera il 70%. A quel punto l’accordo potrebbe essere omologato e i fornitori (rimasti fuori) verrebbero comunque pagati come da piano in tempi brevi (condizione per l’omologa). Questo risparmierebbe di passare per un voto di centinaia di piccoli creditori.
d) Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): come accennato, è uno strumento innovativo, che in pratica costituisce una sorta di “super accordo” totalmente consensuale da omologare. Si colloca a metà tra gli accordi e il concordato. È diverso da un accordo ex art. 57 perché qui è necessaria l’adesione di tutte le classi di creditori (prevede infatti la formazione di classi come nel concordato) . Se si ottiene tale unanimità, il piano può derogare alla parità di trattamento tra creditori e all’ordine dei privilegi (cosa non permessa nel concordato salvo classi tutte consenzienti). In pratica, il PRO serve se il debitore vuole proporre una soluzione molto creativa in cui certe classi di creditori acconsentono a ricevere meno di altri di grado inferiore, oppure a sacrificare garanzie, ecc., magari perché intravedono un beneficio nel tenere in vita l’azienda. Finché c’è accordo totale tra i coinvolti, il giudice può omologare anche se il contenuto non rispetta le regole ordinarie, salvo il limite che i creditori contrari all’omologa (eventuali oppositori isolati) non ricevano meno di quanto avrebbero in liquidazione (art. 64-bis co. 8) . Se non c’è l’unanimità delle classi, il PRO non può essere approvato e ci si dovrà convertire in un concordato preventivo ordinario o rinunciare . Questo istituto è stato criticato da taluni come di scarsa utilità pratica , perché ottenere il consenso integrale è raro; tuttavia in situazioni in cui il debitore ha pochi creditori ben disposti, può essere uno strumento rapido. Ad esempio, se un’unica banca creditrice accetta di falcidiare il proprio credito del 50% e lasciare l’altro 50% in 10 anni, mentre i fornitori prendono il 100% ma in 2 anni, e tutti sono d’accordo, si potrebbe omologare questo piano anche se la banca (creditore privilegiato) formalmente riceve meno del 100% prima di pagare i chirografari – cosa normalmente vietata dalle priorità legali. Nel PRO, col consenso unanime, ciò è possibile.
Nel nostro caso, un PRO sarebbe ipotizzabile se vi fosse un accordo coralizzato con tutti i principali creditori (scenario ottimistico in cui nessuno resta fuori). Onestamente, è più probabile dover gestire qualche dissenso, quindi il concordato classico appare più concreto.
3.2 Procedure concorsuali giudiziali: concordato preventivo e liquidazione giudiziale
Se le trattative stragiudiziali non portano a una soluzione soddisfacente, o se la situazione richiede comunque un intervento autoritativo (per bloccare i creditori o per coinvolgere tutti i creditori in una soluzione), è necessario ricorrere alle procedure concorsuali previste dal CCII. Esaminiamo prima il concordato preventivo, ideale per cercare di evitare la morte dell’azienda, e poi la liquidazione giudiziale (l’extrema ratio liquidatoria). Accenneremo anche al concordato semplificato post-composizione negoziata.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII): è la procedura giudiziale mediante la quale il debitore propone ai creditori un piano per il soddisfacimento parziale o totale dei loro crediti, in alternativa alla liquidazione fallimentare. Il concordato può essere: – In continuità aziendale: se prevede che l’attività d’impresa continui, in gestione diretta del debitore (continuità diretta) o tramite la cessione/affitto dell’azienda ad un terzo che la prosegue (continuità indiretta). La continuità può essere “pura”, se l’azienda prosegue per adempiere il piano, oppure “con riserva di cessione”, se dopo un periodo verrà ceduta l’azienda. In un concordato in continuità diretta, l’impresa durante la procedura rimane nelle mani dell’imprenditore (sotto sorveglianza del commissario giudiziale) e, dopo l’omologa, prosegue la gestione con l’onere di eseguire il piano (pagare i creditori secondo le percentuali e scadenze promesse, magari grazie ai flussi generati dall’attività stessa). In un concordato in continuità indiretta, il piano magari prevede che un investitore acquisti l’azienda (o parte di essa) e il ricavato sia distribuito ai creditori. Qui la continuità economica dell’attività è salva, ma la società proponente spesso al termine si svuota. – Liquidatorio: se prevede la cessazione dell’attività e la mera liquidazione dei beni per pagare i creditori. Tradizionalmente, il concordato liquidatorio serviva al debitore per evitare le sanzioni personali del fallimento (stigma, interdizioni) e per poter condurre la liquidazione in modo più autonomo (spesso con un assuntore che apporta una somma in cambio di rilevare parte dell’attivo). Il CCII ha reso però più rigoroso il concordato liquidatorio, ammissibile solo se assicura un pagamento di almeno il 20% ai chirografari (salvo eccezioni in casi di prevalenza crediti privilegiati).
Procedimento: il debitore presenta ricorso al tribunale, allegando la proposta, il piano, i documenti contabili e la relazione di un attestatore indipendente che certifichi veridicità e fattibilità. Se la società ha bisogno di tempo per definire meglio il piano, può presentare una domanda di concordato con riserva (“concordato in bianco”), ottenendo un termine (fino a 120-180 giorni) per depositare la proposta definitiva, durante il quale beneficia già della protezione dalle azioni esecutive. Una volta depositato il piano definitivo, il tribunale valuta l’ammissibilità (requisiti formali e assenza di cause di inammissibilità come atti fraudolenti). Se ammette la procedura, nomina un Commissario giudiziale (figura di controllo) e fissa l’adunanza dei creditori. I creditori vengono suddivisi in classi secondo posizione giuridica omogenea (obbligatorio classare i creditori con diritti di prelazione diversi, e i chirografari differenziati se trattamenti differenziati; i crediti erariali e contributivi formano di regola classi separate se falcidiati ). Ciascuna classe vota la proposta: serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto in ogni classe, oppure, se le classi sono più di una, almeno la maggioranza delle classi e che il totale dei crediti favorevoli sia ≥2/3 (c.d. duplice maggioranza; nel dettaglio, CCII art. 109). Con la riforma, la mancata approvazione da parte di una o più classi può essere superata tramite l’istituto del cram-down: il tribunale può comunque omologare se: 1) la proposta ha ottenuto il voto favorevole di almeno una classe di creditori impagati in caso di liquidazione (una classe “in the money” consenziente); 2) i creditori dissenzienti non ricevono meno di quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (best-interest test); 3) la proposta rispetta le regole di priorità (assoluta per il valore di liquidazione, relativa per l’extra-valore generato in continuità ). In pratica, se i dissenzienti sono unfair (ingiustificatamente contrari) e il piano conviene comunque, il giudice può imporglielo . Il Correttivo-ter 2024 ha semplificato i criteri, richiedendo solo che vi sia un “pregiudizio” economico per qualcuno se non si omologa – eliminando l’interpretazione più restrittiva che richiedeva la presenza di una classe consenziente di rango immediatamente inferiore a quello della classe dissenziente . Questo allineamento alla direttiva UE 2019/1023 agevola la conferma di piani anche con opposizioni minoritarie.
Dopo l’eventuale voto, il tribunale tiene l’udienza di omologazione in cui verifica la regolarità della procedura, la fattibilità del piano (valutazione di legittimità, poiché il merito economico è lasciato ai creditori, ma il giudice evita piani manifestamente irrealistici) e decide sulle opposizioni dei creditori eventualmente contrari. Se omologa, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori (anche per chi non ha votato o ha votato no, salvi i privilegiati/corporativi che siano stati soddisfatti integralmente o abbiano rinunciato a privilegio per aderire). Da quel momento, il debitore deve eseguire il piano sotto la sorveglianza di un commissario/giudice delegato. L’inadempimento sostanziale può portare alla risoluzione del concordato su istanza dei creditori e alla riapertura della liquidazione giudiziale (eventualità da scongiurare con piani prudenti). Notare anche che un concordato omologato produce effetti definitivi: se poi la società fallisce dopo la scadenza dei termini per chiedere la risoluzione (o a seguito di risoluzione tardiva), i debiti originari ridotti dal concordato restano tali e non “resuscitano” interamente , a meno che il fallimento (liq. giud.) intervenga entro i tempi per la risoluzione e dunque “sovrappolandosi” renda il concordato irrealizzabile (casi di fallimento omisso medio) .
Specificità del concordato in continuità: per favorire la prosecuzione dell’attività, la legge consente alcune deviazioni: – Possibilità di falcidiare crediti privilegiati solo se il piano prevede la continuazione (nel liquidatorio puro, i privilegiati vanno tendenzialmente pagati per intero salvo rinuncia o incapienza). – Possibilità di pagamento dilazionato dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologa (nel liquidatorio c’era limite). – Possibilità di trattamento differenziato dei creditori chirografari con classi, persino offrendo a taluni soddisfazioni in strumenti (azioni, obbligazioni convertende) in luogo di denaro – ciò se giustificato da un piano industriale. – Obbligo che i creditori, se non pagati integralmente, ricevano almeno il valore di liquidazione dei loro crediti (principio del “miglior soddisfacimento possibile” art. 84 co. 7 CCII). – Come contropartita, la legge impone che il piano di continuità sia accompagnato da una rigorosa analisi di fattibilità economica e di prospettive, spesso con l’intervento di consulenti industriali. Il tribunale deve vigilare che non sia un escamotage per ritardare la fine di un’azienda decotta. Nel concordato in continuità diretta, l’attestatore deve certificare che la continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (non un capriccio del debitore) e che l’azienda risanata avrà sostenibilità. – Contratti pendenti: il debitore in concordato può chiedere l’autorizzazione a sciogliersi da contratti in essere onerosi (pagando eventuale indennizzo come credito concorsuale) oppure a sospenderli, strumento utile per liberarsi da forniture o affitti non più utili.
Il concordato nel nostro caso concreto: se la nostra azienda di variatori intende salvarsi, punterà a un concordato in continuità, magari con l’ingresso di un investitore o con un nuovo piano industriale (ad esempio riconversione tecnologica, lancio di nuovi prodotti). Dovrà convincere i creditori che prendendo, poniamo, 40% dei loro crediti in 5 anni, ottengono più di quanto avrebbero da un fallimento immediato (dove magari prenderebbero il 20% e perderebbero un cliente). Un buon concordato in continuità può prevedere: – Il mantenimento dei contratti con i clienti chiave (nessuna interruzione delle commesse). – L’accordo con i fornitori strategici per continuare le forniture (magari pagandoli per intero nel concordato per non perderli, mentre si falcidiano altri crediti meno vitali). – La dilazione del debito fiscale e contributivo secondo transazione fiscale: es. pagamento del 100% dell’IVA e contributi privilegiati ma rateizzati in 4-5 anni, stralcio di interessi e sanzioni grazie alla transazione . – L’apporto di nuova finanza dai soci (equity) o da terzi (finanziamento prededucibile) per sostenere il piano e dare fiducia ai creditori. – Eventualmente, se la proprietà è disposta, una ricapitalizzazione con ingresso di un partner: ciò può avvenire sia dentro il concordato (conversione di crediti in quote di capitale, se qualche creditore lo accetta) sia contestualmente ma fuori piano (i soci potrebbero cedere l’azienda ad un terzo che poi si fa carico del concordato come “assuntore”).
Concordato liquidatorio: se invece si conclude che l’azienda non è più competitiva o i soci vogliono disimpegnarsi, si può optare per un concordato liquidatorio: il piano sarà di vendere l’intero complesso aziendale o i beni e distribuire il ricavato. Il vantaggio rispetto alla liquidazione giudiziale è di avere più controllo sul processo di vendita (si può scegliere l’acquirente in modo privatistico, magari garantendo la continuità del lavoro) e di evitare la dichiarazione di fallimento in sé. Ad esempio, i soci potrebbero proporre: “cediamo l’azienda ad Alfa S.p.A. per €300.000, con cui pagheremo il 30% a tutti i creditori”. Se i creditori accettano e il tribunale omologa, si esegue la cessione e la società poi viene chiusa una volta eseguiti i pagamenti. Il rischio, come sempre, è la fattibilità: se la vendita non si perfeziona, il concordato fallisce e si rischia il fallimento. Quindi serve che l’acquirente sia solido o abbia magari già versato cauzione.
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII): merita un breve cenno. Se la composizione negoziata non porta ad accordo, il debitore può proporre un concordato semplificato per cedere i beni residui. Non c’è voto dei creditori, decide il tribunale se omologare, dopo aver sentito eventuali opposizioni. In tale concordato, per definizione di legge, non è prevista una transazione fiscale specifica (poiché i creditori non votano), ma il debitore può offrire comunque una certa misura di soddisfo al Fisco. Il difetto di questo istituto è che esso non consente la continuità: è concepito solo per liquidare. Quindi serve solo a evitare i costi di una procedura fallimentare quando c’è già un compratore interessato e i creditori recuperano qualcosa. Nel nostro scenario lo considereremmo solo come exit strategy se tutte le altre strade falliscono, per vendere magari i macchinari e brevetti e chiudere.
Liquidazione giudiziale (già fallimento): se si arriva qui, significa che l’insolvenza non ha trovato soluzioni concordate. La liquidazione giudiziale viene aperta dal tribunale su ricorso (creditore, debitore stesso o P.M.), accertato lo stato d’insolvenza. Da quel momento: – Gli amministratori perdono poteri, subentra il curatore, che gestisce e liquida il patrimonio. – L’azienda tipicamente cessa l’attività, salvo casi in cui il curatore la prosegua temporaneamente per vendere l’azienda come going concern (art. 211 CCII consente l’esercizio provvisorio se utile per evitare pregiudizio grave). – Tutti i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo per essere ammessi a distribuzione. I crediti privilegiati, se il bene su cui insiste la garanzia viene venduto, verranno soddisfatti in base ai gradi; i chirografari vedranno se resta qualcosa (spesso poco, e in tempi lunghi). – Gli eventuali contratti in essere si sciolgono o proseguono a seconda delle decisioni del curatore (il curatore può subentrare se è vantaggioso). – Sul piano personale, la liquidazione giudiziale implica per gli amministratori l’apertura del possibile procedimento penale concorsuale (il Tribunale trasmette gli atti alla procura se emergono fatti di reato, e storicamente il fallimento era condizione necessaria perché si parlasse di bancarotta, benché le nuove norme considerino reati anche nella composizione negoziata se c’è frode). Inoltre, i soci e amministratori subiscono per legge alcune conseguenze: i soci di S.r.l./S.p.A. perdono l’investimento (le azioni/quote saranno verosimilmente azzerate dalle perdite) e non rispondono dei debiti residui (società di capitali), mentre gli amministratori possono subire interdizioni dagli uffici direttivi di imprese, se riconosciuti colpevoli di irregolarità.
Una volta liquidati tutti i beni, la procedura si chiude. Se la società è un ente collettivo, essa viene poi cancellata dal registro imprese e cessa di esistere; i debiti insoddisfatti restano inesigibili (non c’è un’entità da perseguire). Se il debitore fosse una persona fisica, avrebbe la chance di chiedere l’esdebitazione dei debiti residui (liberazione dalle obbligazioni insoddisfatte) una volta accertato che ha cooperato lealmente.
Nel contesto della nostra azienda, la liquidazione giudiziale sarebbe la soluzione da evitare, se possibile: la produzione di convertitori di frequenza cesserebbe, i dipendenti perderebbero il posto (salvo essere riassorbiti da chi compra macchinari o licenze all’asta), i creditori chirografari probabilmente incasserebbero poco (specie se il know-how aziendale non è monetizzato bene). Tuttavia, se l’impresa è decotta e non vi è alcuna offerta migliore, la liquidazione è l’esito naturale.
Riassumendo il ventaglio degli strumenti:
- In una prospettiva di risanamento con continuità: preferibile tentare composizione negoziata e/o concordato in continuità (eventualmente con accordi di ristrutturazione su misura per certi creditori).
- In ottica di uscita controllata: valutare accordo di ristrutturazione (se la maggioranza accetta di prendersi una certa percentuale e pagare i dissenzienti), o concordato liquidatorio se c’è la possibilità di vendere l’azienda a valore migliore che in asta fallimentare.
- Se nulla funziona: liquidazione giudiziale.
Nei capitoli seguenti, entreremo nel dettaglio di alcuni aspetti critici: – Come trattare le diverse tipologie di debito all’interno di un piano (cap. 4), poiché il successo di un risanamento dipende anche da come vengono affrontati i crediti erariali, bancari, ecc., ognuno con regole e margini di manovra propri. – Come preservare la continuità aziendale (cap. 5) – ad es. mantenendo le commesse, gestendo i contratti, trovando finanza ponte – per aumentare le chance di risanamento. – Quali sono le tutele personali per soci e amministratori (cap. 6) – cioè come questi soggetti possono difendersi da eventuali pretese personali e responsabilità, a latere del salvataggio societario.
4. Trattamento delle principali categorie di debito nel piano di risanamento
Ogni piano di risanamento o concordatario deve tenere conto delle peculiarità dei vari creditori. Una stessa strategia non vale per tutti: ad esempio, i debiti fiscali seguono norme pubblicistiche, mentre un debito con un fornitore può essere rinegoziato liberamente. Di seguito analizziamo come affrontare, nel contesto italiano, le principali categorie di debito evidenziate nel caso pratico:
4.1 Debiti fiscali (Erario – Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione): Questi includono IVA non versata, imposte dirette (IRES, IRAP) e ritenute non versate, oltre a eventuali accertamenti in corso. Caratteristiche: – Sono in buona parte privilegiati (privilegio generale mobiliare sui beni mobili per IVA, ritenute e altri tributi indiretti ex art. 2752 c.c., e privilegio speciale su immobili per alcune imposte come Ici/IMU). Ciò significa che in un fallimento incasserebbero prima dei chirografari, ma dopo i privilegiati di grado superiore (es. dipendenti). – Le sanzioni tributarie e gli interessi di mora sono invece crediti chirografari puri, senza privilegio, e possono essere falcidiati più liberamente (possono arrivare a zero, come a volte accade nei concordati). – Il Fisco ha poteri di riscossione coattiva mediante ruolo: può aver iscritto ipoteche (che danno un privilegio speciale sui beni ipotecati, equiparabile a un credito ipotecario, se ad esempio c’è ipoteca esattoriale su un capannone). – Gioca un ruolo politico: l’Agenzia delle Entrate vota nei concordati come un creditore qualunque per la parte falcidiata (la cosiddetta transazione fiscale art. 88 CCII). Storicamente il Fisco era restio ad accettare stralci, ma dal 2022 la legge impone che l’Agenzia valuti comparativamente la convenienza. Oggi un voto negativo del Fisco, se preclusivo, può essere superato con cram-down come visto, ma solo se l’indebitamento fiscale non è stato “dolosamente” accumulato . – Strumenti specifici: – Fuori dalle procedure concorsuali, le imprese possono utilizzare le rateizzazioni ordinarie (fino a 72 rate mensili, o straordinarie 120 rate in casi gravi). Questa è spesso la prima mossa se il debito è recente e non ancora in procedura concorsuale: chiedere all’Agente della Riscossione un piano di dilazione evita misure esecutive e dà ossigeno (ma ovviamente non riduce l’importo dovuto). – Inoltre, il legislatore a più riprese ha varato misure di definizione agevolata (“rottamazione delle cartelle”). Ad esempio, la rottamazione-quater (2023-2025) consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, azzerando sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate . La nostra azienda dovrebbe verificare se i propri debiti rientrano (carichi affidati alla riscossione entro il 30/6/2022 per la rottamazione-quater) e aderire eventualmente: il termine di adesione, inizialmente al 30/06/2023, è stato prorogato al 30/04/2025, con prima rata 31/07/2025 . Questa potrebbe essere un’ottima opportunità per abbattere sanzioni e dilazionare su 5 anni. Anche piccoli debiti fino a €1.000 anteriori al 2015 sono stati stralciati d’ufficio dal legislatore (DL 119/2018 e successive reiterazioni). – Nelle procedure concorsuali: la transazione fiscale (disciplinata ora dall’art. 88 CCII) permette di inserire nel piano di concordato o accordo di ristrutturazione una proposta specifica al Fisco: ad esempio, pagamento parziale delle imposte e/o dilazione, e stralcio integrale di sanzioni. Dal 2022 è chiarito che anche nel concordato in continuità si può proporre la falcidia di imposte (prima alcuni la escludevano) . Rimangono vincoli precisi: va assicurato almeno il valore di liquidazione (principio generale), e il trattamento dei crediti fiscali privilegiati deve rispettare la regola di “priorità assoluta” sul valore di liquidazione e “priorità relativa” sull’eventuale valore eccedente generato dal going concern . Tradotto: se i beni aziendali, venduti, avrebbero pagato il 40% del debito IVA, nel concordato non si può offrire meno del 40% a IVA (pena violare best-interest). Ma se il piano genera flussi extra, quei flussi possono essere distribuiti con un certo margine (seguendo regole di priorità relativa, si può deviare dalle classiche graduazioni solo oltre il valore di liquidazione, e comunque i nuovi flussi vanno prima a chi ha priorità).
Strategie per il debito fiscale nel nostro caso: Supponiamo l’azienda abbia €300k di debito fiscale (IVA e ritenute) e €50k di sanzioni. Una strategia sensata: – Se possibile, aderire a definizioni agevolate su cartelle esistenti, così da ridurre almeno le sanzioni prima di formalizzare il piano. – Nel piano concordatario, offrire il 100% del debito IVA e ritenute privilegiato ma dilazionato (es. in 4-5 anni post omologa, prededucibile la parte corrente), perché l’IVA gode di privilegio e di solito bisogna pagarla integralmente a valore di liquidazione. Se però dalla stima di liquidazione emergesse che nemmeno il 100% di IVA si pagherebbe (ad es. carenza di attivo), allora c’è margine per ridurla: es. se in fallimento l’Erario prenderebbe il 50%, il piano potrebbe offrire il 60%. Il professionista indipendente dovrà attestare questa convenienza . – Offrire un trattamento parzialmente migliorativo al Fisco rispetto ad altri chirografari per incentivarne il voto: ad es. pagare un 10-15% ai chirografari comuni e un 20-25% alle sanzioni fiscali (chirografarie). Non è obbligatorio, ma pragmatico: l’Erario spesso vota sì se percepisce di essere trattato equamente e il massimo possibile. – Nota bene: L’azienda dovrà essere in regola con gli adempimenti formali durante la procedura: presentare tutte le dichiarazioni fiscali (anche se non può pagarle), perché omissioni nelle dichiarazioni aggravano la posizione (come visto, un amministratore che non presenta dichiarazioni provoca sanzioni poi addebitabili anche a lui ).
4.2 Debiti verso banche e istituti finanziari: Possono includere mutui, leasing, scoperti di conto, anticipi su fatture. Caratteristiche: – Spesso assistiti da garanzie reali (ipoteche su immobili aziendali, pegni su impianti, riserve di proprietà su beni leasing) o personali (fideiussioni soci). Le banche con garanzia reale sono creditori privilegiati (pignoratizi o ipotecari) e hanno diritto, in concorso, a essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni dati in garanzia. – Nel concordato, i creditori garantiti vanno soddisfatti almeno per il valore di stima del bene su cui hanno prelazione (valutato da perito): la parte di credito che eccede tale valore diventa chirografaria. Ad esempio, se la banca ha ipoteca per €500k su un capannone che ne vale 300, 300 andranno considerati credito privilegiato (da pagare integralmente o al tasso consentito di falcidia se c’è incapienza parziale), e 200 come credito chirografario (falcidiabile come gli altri). – Negoziazione con le banche: conviene affrontarla precocemente. Le banche hanno interesse a evitare classificazioni a sofferenza e a massimizzare il recupero: potrebbero essere disponibili a ristrutturazioni del debito come: – Allungamento dei piani di ammortamento (riducendo l’esborso mensile). – Periodi di pre-ammortamento (sospensione rate per 6-12 mesi). – Riduzione del tasso di interesse. – Haircut (stralcio) sul capitale solo in extremis; più facile ottenere stralcio su interessi di mora e spese. – Conversione di parte del credito in strumenti partecipativi: ad es. un prestito obbligazionario convertendo o strumenti finanziari partecipativi da emettere nell’ambito di un concordato. – Le banche tendenzialmente preferiscono soluzioni stragiudiziali o accordi ex 182-bis, perché nel concordato perdono il controllo e rischiano di dover accettare tempi lunghi e percentuali basse se la maggioranza li supera. Tuttavia, con la riforma del cram-down, anche una singola banca ipotecaria dissenziente può vedersi omologato contro la sua volontà un concordato in cui prende magari meno del 100% ma non meno del valore di mercato del cespite ipotecato. – Un tema fondamentale: se i soci o amministratori hanno dato fideiussioni, qualsiasi riduzione ottenuta dall’azienda non libera automaticamente il garante a meno che la banca acconsenta. Anzi, spesso l’escussione del garante avviene se la società chiede una falcidia. Ad esempio, se nel concordato l’azienda offre 70% sul debito bancario, la banca potrebbe votare sì ma poi rivalersi sui garanti per il restante 30% (il concordato non libera i coobbligati ex art. 184 L.F./Art. 115 CCII, salvo patto contrario) . Dunque: durante la negoziazione, i garanti dovrebbero trattare con la banca un accordo globale (spesso la banca chiede al garante di contribuire a un accordo transattivo pagando una parte del dovuto – es. il garante paga un extra 10% fuori dalla procedura e la banca allora rinuncia a ulteriori pretese e vota il concordato). Attenzione che l’art. 115 CCII prevede espressamente che l’omologazione del concordato non libera i coobbligati e i fideiussori del debitore, né i debitori di regresso, salvo patto contrario. Quindi se vogliamo proteggere i soci garanti, occorre includere nel piano una clausola di esenzione liberatoria (ma ciò richiede di convincere la banca, magari riconoscendole un trattamento di miglior favore). – Leasing: se l’azienda ha contratti di leasing in corso (ad esempio leasing per macchinari o per veicoli industriali), in caso di concordato può decidere di continuare i contratti (pagando i canoni) oppure di scioglierli. Sciogliere un leasing comporta che l’utilizzatore restituisce il bene e il leasing ha un credito per la differenza tra il dovuto da contratto residuo e il valore ricavato dal bene (somma che diventa credito concorsuale, privilegiato per il valore del bene, chirografo per l’eventuale eccedenza). Continuare il leasing richiede di pagare i canoni futuri regolarmente (che sarebbero prededucibili in caso di procedura concorsuale).
Strategie verso banche nel nostro caso: Poniamo la società abbia un mutuo ipotecario su capannone residuo €1M, e un fido scoperto di €100k garantito dai soci. Il capannone vale €800k sul mercato. Possibili linee: – Nel piano proporre di vendere il capannone (magari mantenendo affitto) e con i €800k pagare la banca ipotecaria all’80% del credito, lasciandole un’insoddisfazione del 20% (che diventerebbe chirografa, percependo magari 5% come gli altri). La banca perderebbe €150k circa, ma se i soci garanti garantivano quel mutuo, andrebbe discusso come gestire i garanti: idealmente liberare i soci in cambio di un pagamento immediato di una parte (es. i soci vendono un loro immobile e versano €50k alla banca, e la banca esce). – Oppure negoziare con la banca la rinegoziazione: tenere il capannone, allungare il mutuo di altri 5 anni riducendo la rata. In concordato, è possibile “rischedulare” i pagamenti di un creditore privilegiato oltre la durata originaria purché si paghi per intero il capitale (salvo quell’eventuale falcidia per incapienza). Ad esempio, pagare l’intero €1M in 15 anni al tasso originario: ciò in valore attuale è una perdita per la banca, ma legalmente si considera soddisfatta integralmente (non c’è falcidia nominale, solo dilazione). – Per il fido di €100k con fideiussione: nel concordato la banca come chirografo prendebbe ad es. 10%. Quindi €10k. Al garante la banca potrebbe chiedere i restanti €90k. Si potrebbe intavolare un accordo lato garante: il socio paga €30k extra-lavorativo, e la banca accetta chiusura totale, rinunciando a futuri ricorsi contro il socio per la differenza. Così la banca in totale recupera 10k + 30k = 40k (40%), migliorando rispetto al 10k se confidasse solo nel concordato e nei forse incerti mezzi del socio (che se incapiente può a sua volta fare sovraindebitamento…). Questo tipo di accordo va orchestrato fuori dal concordato, ma può essere condizionato all’omologa (la banca vota sì e rinuncia ad agire sul garante se tutto va a buon fine). – Se la banca fosse l’unica di classe e votasse no, come detto il tribunale potrebbe omologare ugualmente se il piano è equo e la banca ottiene almeno il valore di liquidazione (in esempio: se col fallimento la banca ipotecaria su capannone da 800k avrebbe preso 800k, nel piano gliene vanno dati 800k comunque; se gliene offrissimo 700k, non rispetteremmo la regola e non potremmo forzare). Ecco perché in concordato normalmente i garanti reali ottengono pressoché il full sul valore del loro collaterale; eventuali sacrifici li subiscono più sui tempi che sull’ammontare.
4.3 Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: Fornitori commerciali, consulenti non pagati, locatori per canoni arretrati, e tutti i creditori non privilegiati (o la parte non garantita dei crediti privilegiati). Spesso questa è la massa più numerosa ma con incidenza in valore minore rispetto a banche e fisco. In procedure concorsuali, questi creditori: – Votano in classe (di solito un’unica classe chirografi, salvo si facciano classi separate se alcuni vengono trattati meglio di altri). – Hanno aspettative di solito di recuperare percentuali modeste (dipende dall’attivo disponibile dopo privilegi). – Non hanno tutele particolari come prelazioni, se non la par condicio (uguaglianza di trattamento all’interno della classe salvo consensi a trattamenti differenziati). – Nella fase stragiudiziale, i fornitori spesso vanno in ansia alla notizia di difficoltà: alcuni potrebbero sospendere forniture in assenza di pagamento, aggravando la crisi. Per questo, se l’azienda mira a continuare, deve gestire con diplomazia questi rapporti. Si può: – Selezionare i fornitori strategici (quelli senza cui non si produce) e tenerli soddisfatti il più possibile sul corrente, eventualmente pagando in prededuzione i nuovi ordini (consentito nelle misure protettive in continuità, con autorizzazione). – Proporre accordi individuali di saldo e stralcio: es. offrire subito 30% cash per chiudere un debito pregresso di fornitura. Alcuni fornitori accetteranno pur di incassare qualcosa e mantenere il cliente. – In un accordo di ristrutturazione, decidere di pagare integralmente i piccoli fornitori estranei (per evitare di doverli includere). – Nel concordato, pur essendo chirografari tutti uguali per legge, si può creare classi diverse se c’è diversità di interessi: ad esempio, separare i fornitori continuativi (che magari ricevono un 30% perché servono per il futuro) dai creditori finanziari secondari (che ricevono 5%). Ma bisogna giustificare economicamente la differenza e ottenere le maggioranze per classe senza incorrere in discriminazioni inique. Il CCII consente classi differenziate, ma il Tribunale vigila su abusi: non si può creare classi artefatte solo per ottenere maggioranze (ad es. isolare in una classe un creditore scomodo). – I fornitori locali a volte prediligono la continuità: preferiscono avere la vostra azienda come cliente viva e incassare meno, che vederla fallire e perdere opportunità future. Questo argomento va sottolineato nel persuaderli: “Accettate 30 su 100, così restiamo in attività e continuate a venderci altri prodotti negli anni a venire, con guadagno per tutti”. È un tipico argomento di convenienza commerciale, non solo giuridica.
Nella nostra ipotesi: Se i fornitori vantano €200k di crediti: – Nel piano potremmo proporre di pagarne il 20% in 2 anni dall’omologa, oppure un mix: piccoli fornitori < €5k magari integrale (per questioni pratiche e di mantenere reputazione con i piccoli locali), e i grossi fornitori (ad es. il fornitore di componenti elettronici da €50k) al 20%. I piccoli integralmente soddisfatti potrebbero essere esclusi dal voto (o avere classe a parte) perché irrilevanti sul totale, semplificando. – Durante la procedura, per assicurare le consegne, il tribunale può autorizzare pagamento in prededuzione di nuove forniture essenziali (art. 95 co. 4 CCII): es. ordino nuovi chip elettronici, li pago e i fornitori non corrono rischi su quel venduto, cosicché continuano a spedire.
4.4 Debiti verso INPS e altri enti previdenziali (contributi): Vanno trattati in parallelo ai debiti fiscali: – I contributi INPS non versati hanno privilegio generale sui mobili (simile al Fisco) per la parte dei contributi dei lavoratori e un eventuale privilegio minore per sanzioni. – Le sanzioni civili INPS (interessi di mora sui contributi) sono in genere assimilate a sanzioni amministrative, quindi chirografarie. – L’INPS come creditore segue regole analoghe al Fisco in sede di concordato: si può includere in transazione (art. 88 CCII copre anche contributi e premi assicurativi). Anche per contributi vale l’attestazione di convenienza e la necessità di non peggiorare rispetto alla liquidazione. – Uno scrupolo in più: i contributi previdenziali toccano diritti dei lavoratori, quindi c’è forte attenzione del tribunale a che, ad esempio, le ritenute previdenziali operate e non versate siano considerate come debiti verso lavoratori e abbiano privilegio (devono essere soddisfatte in prededuzione se maturate dopo, o in privilegio se prima). Non si può “tagliare” il netto che spetta ai lavoratori a titolo di contributo figurativo. – L’omesso versamento di contributi per importi > €10.000 l’anno è reato (art. 2, co.1-bis DL 463/1983): un eventuale concordato non estingue il reato (che si estingue solo pagando integralmente i contributi dovuti prima del giudizio penale). Quindi, per l’amministratore, è vitale pagare i contributi entro la soglia penale. Se sta sotto soglia, ha comunque la sanzione amministrativa (come confermato dalla Corte Costituzionale 103/2025 che ha giudicato non irragionevole la sanzione elevata per l’omissione contributiva minore ). – Strategia: trattare contributi come il Fisco. Ad esempio: includere l’INPS nell’accordo di transazione fiscale (ora unificata transazione fiscale/contributiva) proponendo pagamento integrale dei contributi dovuti (magari dilazionati), ed eventualmente ridurre sanzioni e interessi. – Nel caso in cui vi siano debiti verso i dipendenti (stipendi arretrati, TFR), questi hanno il massimo privilegio e vanno di solito pagati integralmente (possono essere dilazionati in concordato, ma entro un anno dall’omologa i salari arretrati e il TFR devono essere saldati per poter omologare se i lavoratori dissentono, salvo diverso accordo sindacale). Inoltre, i dipendenti hanno accesso al Fondo di Garanzia INPS che, in caso di fallimento o concordato, paga loro TFR e ultime 3 mensilità insolute, surrogandosi poi come creditore (ma in concordato l’obiettivo è preferibilmente pagarli in full direttamente). Nel nostro scenario, se vi sono pochi dipendenti, conviene prevedere il pagamento integrale dei loro crediti nel piano per motivi sociali e legali.
4.5 Altre categorie: se l’azienda ha debiti fiscali locali (IMU, Tari comunale) questi di solito seguono le regole fiscali generali (IMU ha privilegio ipotecario su immobili, Tari chirografo). Debiti verso fornitori esteri: partecipano come chirografari (senza differenza, salvo problemi di notifica transfrontaliera). Debiti verso società collegate o soci: questi di solito in un concordato sono postergati (soci e parti correlate spesso rinunciano o vengono trattati a parte, anche perché i finanziamenti soci per legge sono postergati a tutti gli altri crediti ex art. 2467 c.c., quindi in pratica crediti soci si soddisfano solo dopo gli altri chirografari, a meno che i creditori non siano tutti soddisfatti per intero – eventualità remota).
Conclusione sezione 4: un piano di risanamento efficace deve modulare il trattamento dei debiti in modo differenziato ma equilibrato, rispettando i vincoli legali di priorità e ottenendo, ove serve, il consenso di categorie cruciali. La nostra azienda dovrà, come visto, riservare una cura particolare al debito fiscale/previdenziale (negoziandone la transazione con attestazione di convenienza per assicurarsi l’adesione o per poterne forzare l’omologa) , e gestire attentamente i creditori garantiti (banche) e i fornitori strategici per non compromettere la continuazione del business. La tabella 2 seguente riassume, per ciascuna categoria, le opzioni di trattamento:
Tabella 2 – Riepilogo trattamento per categoria di debito
| Categoria Crediti | Esempi | Diritti e tutele | Opzioni di trattamento nel piano |
|---|---|---|---|
| Fiscali (Erario) | IVA, IRES, IRAP, ritenute; Sanzioni tributi | Privilegio generale su mobili (imposte) o ipotecario (es. ipoteca esattoriale); Sanzioni chirografarie. Reato penale per omessi versamenti IVA/ritenute > soglia. | Transazione fiscale: falcidia sanzioni e interessi (anche 100%), pagamento parziale imposte se ≥ valore liquidazione. Rateizzazioni fino 5 anni (o oltre se concordato lungo). Possibile definizione agevolata extra-concordato (rottamazione). Necessaria attestazione convenienza . |
| Previdenziali (INPS) | Contributi obbligatori lavoratori, premi INAIL; sanzioni civili | Privilegio generale (contributi dipendenti), chirografo su sanzioni. Reato se omissione > €10k annui. | Transazione contributiva con INPS analoga a fiscale: possibile diluizione e falcidia interessi. Pagamento prioritario di contributi dovuti (anche per evitare effetti penali). Fondo garanzia INPS copre TFR e 3 mensilità (subentrando). |
| Banche e finanziarie | Mutui, leasing, scoperti fido, derivati | Spesso garantiti (ipoteca, pegno) -> privilegiati fino a valore del bene; eventuale fideiussione soci; in mancanza di garanzie, crediti chirografari. | Se garantiti: soddisfo almeno pari al valore di stima garanzia (falcidia solo sulla parte unsecured). Possibile rinegoziazione tassi/tempi nel piano. Vendita beni in piano per pagarli. Se chirografari: falcidia secondo trattamento generale (es. XX%). Accordi stragiudiziali paralleli coi garanti (fideiussioni) per limitare azioni di regresso . Possibile accordo ad efficacia estesa se finanziatori ≥75% concordi. |
| Fornitori commerciali | Forniture materie prime, servizi, utenze | Chirografari (salvo riserva proprietà su beni forniti). Possono interrompere rapporti se non pagati. | Pagamento parziale dilazionato (percentuale in concordato). Classi separate per fornitori essenziali (eventualmente con trattamento migliore per mantenerli). Nuove forniture in prededuzione per assicurare continuità. Accordi transattivi individuali (saldo e stralcio) con sconto per pagamento immediato (fuori o dentro composizione negoziata). |
| Dipendenti (retribuzioni) | Stipendi non corrisposti, TFR maturato | Privilegio speciale su mobili e immobili (ultimi 3 mesi e TFR) – rango super prioritario. Fondo INPS di garanzia interviene in fallimento. | Solitamente pagati integralmente (nel concordato liquidatorio devono essere soddisfatti almeno 80% se TFR, oppure interviene Fondo; in continuità meglio prevedere pagamento completo per motivi sociali e perché privilegio altissimo). Possibilità di pagamento prededucibile di arretrati autorizzato in continuità. |
| Chirografari vari | Professionisti, consulenti, forniture non privilegiate, clienti con note di credito | Chirografari (nessun privilegio). | Trattamento uniforme in classe o in più classi omogenee. Percentuale di soddisfo determinata dall’eccedenza attivo disponibile. Possibile utilizzo di strumenti come equity o warrants (in concordati creativi) per offrire potenziale upside ai creditori (raro in PMI). |
| Soci e parti correlate | Finanziamenti soci, crediti di società controllanti/collegate | Finanziamenti soci postergati ex lege (art. 2467 c.c.) rispetto agli altri creditori (trattati come subordinati, vengono dopo i chirografari comuni). | Di norma non pagati nel piano (o simbolicamente dopo tutti gli altri). Possono rinunciare formalmente al credito per aiutare il risanamento. Se soci forniscono nuova finanza, è prededucibile se fatta con certe forme. Crediti parti correlate vanno gestiti con trasparenza per evitare censure (possono essere classati a parte ed esclusi dal voto). |
Questa tabella evidenzia come sia fondamentale, nel predisporre un piano, conoscere la natura di ciascun debito e il relativo “trattamento di favore” o “sacrificio” lecito. Ad esempio, non poter imporre agli istituti di previdenza un taglio sui contributi se ciò li rende sotto il livello di liquidazione, oppure dover garantire agli ipotecari il valore di mercato del collaterale, sono vincoli rigidi. Altri crediti invece (es. fornitori generici o sanzioni) possono essere drasticamente ridotti senza ostacoli giuridici (dipende solo dal negoziato o dal voto).
Per la nostra azienda, uno scenario plausibile di trattamento integrato potrebbe essere: – Fisco: pagamento 50-60% imposte in 5 anni, sanzioni zero (transazione fiscale) . – INPS: pagamento 100% contributi in 3 anni, azzeramento sanzioni civili. – Banche: mutuo ipotecario rifinanziato su 10 anni (valore attuale 80%), fidi chirografari pagati 20% e soci garanti che aggiungono 10% fuori piano. – Fornitori: pagamento 20% in 2 anni (in continuità continueranno a vendere). – Dipendenti: pagamento 100% in prededuzione degli arretrati con l’aiuto del Fondo INPS se già insinuato. – Soci: rinuncia rimborso prestiti soci €X per facilitare risanamento (nessun pagamento ai soci).
Il tutto attestato da un professionista che conferma che, in liquidazione, quei creditori avrebbero preso ancora meno. Se il piano è convincente, il tribunale lo ammetterà e la maggioranza dei creditori probabilmente lo sosterrà, preferendolo al fallimento.
5. Continuità aziendale: come preservarla e perché è importante
Continuità aziendale significa mantenere in vita l’attività produttiva o commerciale dell’impresa, evitando l’interruzione definitiva dell’operatività. Per un’azienda manifatturiera come quella di variatori e convertitori di frequenza, la continuità aziendale può essere vista sotto due profili: – Continuità giuridica: l’impresa prosegue all’interno della medesima entità societaria (non viene liquidata, i contratti rimangono in capo alla stessa società). – Continuità economica: l’attività prosegue, anche se la titolarità dell’azienda dovesse passare a un soggetto nuovo (es. cessione dell’azienda a un investitore che la gestisce altrove, garantendo però la produzione e i posti di lavoro).
Preservare la continuità è spesso il modo migliore per massimizzare il valore per tutti gli stakeholder: un’azienda “viva” produce reddito, mantiene occupazione e spesso consente ai creditori di recuperare più di quanto otterrebbero dalla vendita all’asta di macchinari e scorte in una liquidazione spezzatino. Inoltre, dal punto di vista sociale, preservare competenze e posti di lavoro è un valore tutelato dall’ordinamento (il Codice stesso spinge per soluzioni in continuità ove realistiche).
Come difendere la continuità nella fase di crisi? Ci sono vari accorgimenti e misure pratiche: 1. Ricorso tempestivo agli strumenti concorsuali idonei: come evidenziato, l’azienda dovrebbe preferire il concordato in continuità all’ipotesi liquidatoria, se ha chance di risanamento. Anche attivare la composizione negoziata prima di scivolare in insolvenza conclamata è una scelta pro-continuità, perché evita il collasso improvviso per azioni esecutive. 2. Proteggere il circolante e gli asset produttivi chiave: ciò può voler dire, ad esempio, chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare “in prededuzione” taluni fornitori essenziali (fornitura di energia, materie prime vitali, manutenzione macchinari) per assicurarsi che continuino a svolgere la loro prestazione. Il CCII (art. 95 co. 4) consente nel concordato in continuità tali pagamenti preferenziali, purché autorizzati e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Ad esempio, pagare il fornitore di componentistica senza arretrare consente di completare le commesse e generare ricavi a beneficio del piano. 3. Ottenere finanza ponte (finanza interinale): spesso la crisi è accompagnata da carenza di liquidità. Esistono misure per ottenere nuovi fondi: nella composizione negoziata l’art. 22 consente di contrarre finanziamenti prededucibili se l’esperto li ritiene necessari e proporzionati . Nel concordato, il debitore può richiedere di essere autorizzato a prendere finanziamenti urgenti (che se poi la procedura va a buon fine saranno rimborsati in prededuzione, cioè prima degli altri debiti concorsuali). Ad esempio, potrebbe ottenere un prestito emergenziale dal socio o da un investitore esterno per comprare materie prime e finire un ordine importante da consegnare – quell’ordine incassato genera margine per tutti. 4. Comunicazione trasparente e gestione stakeholder: mantenere la fiducia di clienti, fornitori e dipendenti è cruciale. Se trapela che c’è un concordato, l’azienda dovrebbe rapidamente comunicare un piano di continuità: rassicurare che esiste un percorso (magari con un investitore interessato) e che l’attività proseguirà. Talora si siglano accordi di “filiera” con i principali committenti: ad es. se l’azienda insolvente lavora quasi esclusivamente per un grande cliente, quest’ultimo potrebbe impegnarsi a continuare gli ordinativi e magari concedere termini di pagamento più favorevoli o anticipi, per sostenere il fornitore in concordato. Questi accordi vanno evidenziati nel piano come elementi di forza. 5. Salvaguardia del capitale umano: i dipendenti chiave vanno motivati a restare (una crisi può generare fuga di talenti). Magari prevedendo nel piano il pagamento immediato di qualche arretrato salariale o un incentivo per i dipendenti che rimangono (anche i dipendenti sono creditori, possono votare e la loro adesione morale è importante). 6. Possibilità di continuità indiretta (affitto/cessione d’azienda): se i soci attuali non sono in grado di proseguire, si può comunque mantenere in vita la produzione tramite cessione a terzi. Nel concordato questa è una soluzione: es. la società propone di affittare subito l’azienda ad un imprenditore concorrente che ne garantirà l’attività e poi la comprerà all’omologa. I proventi dell’affitto (e successiva vendita) vanno ai creditori, mentre l’azienda stessa non subisce stop (i macchinari continuano a lavorare, i lavoratori passano in affitto al nuovo). Questa formula mantiene il know-how e l’avviamento intatti, anche se la società originaria poi sarà liquidata una volta ceduto tutto. Nel nostro caso, se c’è un competitor interessato a espandersi acquistando l’azienda, un affitto d’azienda in concordato potrebbe essere win-win: il competitor inizia a gestire (assorbendo ordini e personale), e al termine versa un prezzo che soddisfa i creditori. Il CCII favorisce ciò, prevedendo ad esempio che in caso di concordato con affitto d’azienda non si applichino i termini lunghi di opposizione (per accelerare l’operazione), e che l’affitto possa essere autorizzato dal tribunale anche prima dell’omologa, se utile. 7. Monitoraggio e adattamento costante: la gestione aziendale in continuità durante un concordato deve essere molto accorta. Ogni trimestre va verificato l’andamento rispetto al piano. Il commissario chiederà report. Bisogna essere pronti a correggere costi, ridurre sprechi, magari vendere asset non core (anche durante il concordato è possibile vendere beni previa autorizzazione, se serve a migliorare l’esito per i creditori).
Vantaggi concreti della continuità per i creditori: come già detto, aumentano le chance di soddisfo. Ad esempio, in un fallimento i macchinari specializzati magari verrebbero svenduti come ferrovecchio; con la continuità, quei macchinari producono apparecchiature vendibili, generando margini. Inoltre, la continuità evita costi di smantellamento, di licenziamenti (TFR ecc.), e consente di evitare la dispersione di mercato (i clienti potrebbero andare altrove e non tornare più, abbassando il valore di avviamento a zero se l’attività cessasse). Anche per eventuali investitori, acquisire un’azienda ancora operativa è più appetibile che rilevare brand morti: quindi la continuità può attrarre capitali freschi.
Rischi della continuità e come mitigarli: ovviamente ci sono anche rischi. La gestione durante la procedura concorsuale è fragile (si opera con risorse scarse e reputazione minata). C’è rischio di insuccesso del piano se i ricavi non tornano come previsto. Mitigazioni: – Pianificare in modo prudente, con stress test: ad es. assumere vendite più basse del normale per i primi anni di concordato, per non trovarsi corti di cassa. – Prevedere “piani B” nel caso qualcosa vada storto: es. la clausola di conversione del concordato in liquidazione giudiziale è implicita per legge se il piano fallisce, ma l’imprenditore può anche predisporre vendite contingentate per ridurre rischi (tipo vendere immobili non essenziali subito e fare cassa, piuttosto che confidare di pagar debiti col fatturato). – Assicurare un adeguato capitale circolante: se i soci possono, meglio far entrare un nuovo socio con equity o vendere partecipazioni. A volte l’ingresso di un investitore minoritario con capitale durante il concordato è risolutivo per ridare fiducia a tutti.
Nel nostro caso di variatori e convertitori di frequenza, supponiamo l’impresa abbia un know-how specialistico e un portafoglio clienti stabile (industrie che comprano i convertitori). Ciò suggerisce che la continuità avrebbe valore: la clientela non è facile da riconquistare se persa. Anche eventuali certificazioni di qualità o licenze potrebbero andare perse con la cessazione. Quindi, se l’azienda è ancora tecnicamente viva, conviene mantenerla tale.
In termini pratici: – Forse ridimensionare l’organico se era sovradimensionato (ma cercando soluzioni condivise con sindacati, es. contratti di solidarietà). – Concentrarsi sui prodotti a maggiore margine, ridurre linee in perdita. – Se l’edificio è di proprietà, valutare la vendita e il leasing back (trasformare asset fissi in liquidità, pur pagando un affitto, ma per alleggerire il debito). – Valutare partnership: ad es. accordi di fornitura in esclusiva con un grosso cliente in cambio di condizioni di pagamento favorevoli (il cliente garantisce ordini e magari anticipi). – Lavorare sul marketing per far capire al mercato che l’azienda sta ristrutturando ma rimane affidabile (non facile, ma se supportato da nuovi investitori o dal coinvolgimento di figure autorevoli nel CdA può aiutare).
In sintesi, difendere la continuità richiede combinare gli strumenti legali (concordato in continuità, composizione negoziata con misure protettive, finanziamenti prededucibili) con scelte aziendali coraggiose e coordinate. Il premio per il successo è grande: l’azienda salva se stessa e i creditori recuperano di più e prima.
6. Difesa personale di soci e amministratori debitori
Dal punto di vista di soci e amministratori, il sovraindebitamento dell’azienda pone preoccupazioni su due fronti: – Possibili azioni di responsabilità o esecutive dirette contro di loro, come persone fisiche. – L’impatto patrimoniale e reputazionale personale, inclusa la necessità di ricorrere a strumenti di salvaguardia del proprio patrimonio.
Affrontiamo separatamente il caso degli amministratori e quello dei soci (proprietari), sebbene in PMI spesso coincidano.
6.1 Amministratori (e sindaci) – responsabilità e tutele: Un amministratore di S.r.l. o S.p.A. vede aumentare i rischi di responsabilità in caso di insolvenza della società. Ci sono vari possibili fronti: – Azione di responsabilità per mala gestio (artt. 2393, 2394 c.c. e 2476 c.c.): come visto al §1, se dal dissesto emergono condotte negligenti o imprudenti (es. aver aggravato i debiti continuando attività manifestamente perdite, aver violato obblighi contabili, distratto risorse), il curatore (o i creditori in caso di concordato) possono chiedere il risarcimento del danno. Questa è un’azione civile, che può portare a condanne a risarcimenti molto elevati (talora equivalenti all’intero deficit fallimentare, specie con l’art. 2486 c.c. e i suoi criteri presuntivi ). Difendersi: l’amministratore dovrà dimostrare di aver agito con diligenza, di non aver peggiorato la situazione – spesso producendo evidenze che l’insolvenza derivava da cause esterne (calo mercato, insolvenza di cliente importante, pandemia, etc.) e che lui ha tentato rimedi (taglio costi, ricerca capitali, attivazione tempestiva della procedura di concordato). Inoltre, potrà contestare il calcolo del danno, soprattutto sfruttando la clausola “salva la prova di un diverso ammontare” dell’art. 2486 c.c.: ad esempio, provando che anche se avesse liquidato prima, i creditori avrebbero ottenuto poco lo stesso (perché il valore azienda era già compromesso). Sul punto, giurisprudenza recente ha interpretato l’art. 2486 comma 3 come norma sostanziale applicabile anche a fatti antecedenti il 2019, ma con possibilità per l’amministratore di fornire appunto prova contraria . Un buon legale cercherà di ridurre la quantificazione del danno, se non evitare la condanna. – Responsabilità tributaria ex art. 36 d.P.R. 602/1973 (liquidatori e amministratori): se l’Agenzia delle Entrate ha notificato atti (avvisi di accertamento o cartelle) personalmente all’amministratore basandosi su quell’art. 36 (mancato pagamento tributi in liquidazione o mancata liquidazione in presenza di causa di scioglimento), l’amministratore deve impugnarli nelle sedi opportune (Commissione Tributaria, ora Corte di Giustizia Tributaria). Le recenti decisioni sono favorevoli agli amministratori quando il Fisco non prova la colpa grave: come citato, la sentenza n. 752/2025 ha annullato un atto verso un ex amministratore perché mancava prova di condotte illecite specifiche . Quindi la difesa è: contestare la pretesa sottolineando che i debiti fiscali societari non possono essere automaticamente addossati al gestore, serve la dimostrazione che ha violato obblighi (es. preferito altri creditori ai tributi, occultato attivi). In giudizio tributario, si porteranno evidenze di come gli attivi di liquidazione furono usati (se la società fu liquidata) o che non c’era liquidità per pagare e l’amministratore non ha arricchito altri indebitamente. Spesso si discute su aspetti procedurali: la Cassazione a Sezioni Unite nel 2023 (sent. 32790/2023) ha stabilito i presupposti precisi per l’azione verso il liquidatore ex art. 36 (es. deve esserci iscrizione a ruolo del tributo e accertamento che il debito non fu pagato con l’attivo prima di chiamarlo a rispondere) . L’amministratore farà leva su eventuali vizi procedurali (ad es. “il Fisco non ha iscritto a ruolo e notificato avviso di accertamento al liquidatore prima della cartella: ciò rende nulla la pretesa” – tesi confermata in alcune pronunce ). – Sanzioni amministrative tributarie e responsabilità solidale: se la società viene multata per omessi versamenti o altre violazioni, di regola la sanzione colpisce la società. Ma c’è l’art. 11 d.lgs. 472/97 che prevede che i dirigenti rispondono solidalmente delle sanzioni tributarie della persona giuridica se il fatto è a loro imputabile (con beneficio d’escussione). Tuttavia, la Cassazione nel 2019 (sent. 27610/2019 citata) ha affermato che l’amministratore inadempiente può essere tenuto a rifondere alla società (e quindi indirettamente ai creditori) l’importo delle sanzioni subìte dalla società . L’amministratore in sede civile può provare che l’omesso pagamento fu dovuto a mancanza di liquidità non sua colpa, oppure che aveva delegato la gestione fiscale ad altri (nel caso in Fisco e Tasse citato, un manager sosteneva di non aver curato lui fiscalità, ma la Cassazione disse che comunque come presidente di CDA ne era responsabile ). La difesa è complicata qui: se non paghi tasse e contributi, la colpa intrinseca è quasi presunta. Meglio concentrarsi nel limitare il danno, ad esempio ottenendo in concordato la riduzione di queste sanzioni (così riducendo anche l’eventuale rivalsa). – Responsabilità penale: i reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale, bancarotta preferenziale) costituiscono una minaccia seria. Un amministratore che, ad esempio, prima del concordato ha pagato di nascosto un creditore amico, rischia la bancarotta preferenziale se poi la società fallisce. Oppure se ha sottratto beni dell’azienda (distrazioni) o tenuto contabilità caotica, c’è il reato di bancarotta. Difendersi sul penale significa: – Evitare di commettere reati ex ante: in particolare, stop a pagamenti preferenziali non autorizzati dopo che si decide di affrontare la crisi; mantenere la contabilità regolare fino all’ultimo; non occultare o falsificare dati per ottenere il concordato (reato di false attestazioni se si forniscono al professionista dati non veritieri). – Qualora vi sia un’inchiesta, collaborare col curatore e gli inquirenti, mostrando trasparenza, può mitigare. Esistono per la bancarotta anche circostanze attenuanti se, ad esempio, il danno è di speciale tenuità o se l’imputato risarcisce (difficile in insolvenza). – Nel caso di omessi versamenti IVA/contributi: queste fattispecie hanno soglie di non punibilità (sotto €250k per IVA, reato non sussiste; per contributi sotto €10k anno è illecito amm.). Ma se superate, la legge prevede che il pagamento integrale del dovuto prima della dichiarazione dibattimentale estingue il reato (per IVA, art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) o evita la punibilità (per contributi, c’è causa di non punibilità se versi entro 3 mesi da contestazione). Un amministratore quindi deve, se possibile, pagare quell’IVA prima di finire in giudizio. Se non può, richiedere almeno la sospensione del processo in attesa di esito della procedura concorsuale: se il concordato prevede il pagamento integrale dell’IVA dilazionata, alcuni giudici aspettano a vedere se viene pagata. In ogni caso, dotarsi di un penalista e seguire linee difensive appropriate (ad esempio dimostrare la causa di forza maggiore per l’omesso versamento – tesi rara ma tentata: dire che c’era una crisi di liquidità così grave da rendere impossibile, però giurisprudenza non l’accetta facilmente se hai comunque pagato altri creditori preferendo di non versare IVA). – D&O Insurance: se l’amministratore aveva una polizza di responsabilità civile amministratori (D&O), potrebbe attivarla per coprire le spese legali e gli eventuali risarcimenti per azioni di responsabilità civile. Va verificato il massimale e le esclusioni (di solito non copre atti dolosi e reati, ma copre la negligenza). – Patrimonio personale – protezioni generali: l’amministratore se teme attacchi al suo patrimonio (es. da garanzie escusse, o risarcimenti), può valutare strumenti di salvaguardia come: – Fondo patrimoniale per beni destinati ai bisogni familiari: costituito prima della crisi può proteggere la casa dai creditori estranei ai bisogni familiari. Ma attenzione: se i debiti fiscali o bancari sono stati contratti per l’impresa, la giurisprudenza tende a dire che rientrano nei bisogni familiari se l’impresa serviva a produrre reddito per la famiglia, quindi il fondo potrebbe essere aggredito ugualmente. Inoltre, il fondo non protegge da debiti preesistenti se c’è mala fede (revocabile come atto a titolo gratuito). – Trust o vincoli di destinazione: efficaci solo se istituiti in tempi non sospetti e con scopi leciti, altrimenti anch’essi aggredibili come atti in frode. – Esdebitazione personale: se l’amministratore si trova travolto da debiti personali (ad es. la banca ha escusso e lui non può pagare), può valutare la procedura di sovraindebitamento per il consumatore o per l’imprenditore minore. Egli come persona fisica, se non è soggetto fallibile (un amministratore-socio raramente è imprenditore individuale a sua volta a livello di soglie, a meno che abbia altre attività), potrebbe accedere a: – un Piano del Consumatore / piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se i suoi debiti sono per lo più personali o derivati da garanzie prestate, la giurisprudenza non è univoca se ciò tolga qualifica di consumatore perché la fideiussione a favore della propria società è un atto legato ad attività d’impresa… potrebbe dover usare il concordato minore invece), – oppure un Concordato minore (procedura simile al concordato ma per debitore non fallibile, art. 74 CCII) se ha patrimonio da offrire, – oppure la Liquidazione controllata del sovraindebitato (analoga al fallimento personale). – Al termine, chiedere l’esdebitazione (liberazione residui).
Esempio: l’amministratore ha €300k di debiti da fideiussione dopo il concordato. Non li può pagare. Non essendo fallibile come persona (non supera soglie, i debiti da garante non lo rendono imprenditore), può presentare un piano di sovraindebitamento offrendo magari di pagare €50k (che ricava vendendo una casa al mare di sua proprietà) e farlo approvare dai creditori personali (la banca); se omologato, viene liberato del resto. Così salva la prima casa (se non ipotecata e non venduta).
Questo strumento è la “controparte” per la persona fisica di quanto il concordato è per la società. Soci e garanti schiacciati dai debiti residuali possono trovarvi sollievo.
6.2 Soci (proprietari) – rischi e difese personali: I soci di una S.r.l. o S.p.A., di regola, non rispondono con il loro patrimonio dei debiti sociali (limite della responsabilità). Quindi, in teoria, potrebbero defilarsi dalla crisi dicendo “perdo il capitale investito, ma i miei beni restano immuni”. Nella realtà: – Garanzie prestate dai soci: come già trattato, è comune che le banche facciano firmare ai soci (specie nelle S.r.l. piccole) fideiussioni o mettano ipoteca su un loro immobile personale. Questo bypassa la limitazione di responsabilità. Difesa: negoziare con la banca eventuale liberazione (poco probabile gratis: spesso il socio deve offrire qualcosa in cambio) oppure prepararsi alla possibilità di dover onorare la garanzia. Se la garanzia viene escussa e il socio non può pagare, come sopra entrerà nelle procedure di sovraindebitamento. – Postergazione dei crediti dei soci: se i soci negli anni avevano finanziato la società (versamenti soci a titolo di prestito, non di capitale), in situazione di insolvenza quei crediti sono postergati: i soci non li vedranno soddisfatti se prima non paghi tutti gli altri creditori (art. 2467 c.c.). Inoltre, se la società poi fallisce, il curatore può anche agire per far restituire ai soci i rimborsi di finanziamenti avvenuti nell’anno precedente la dichiarazione di insolvenza (azione di restituzione di quanto indebitamente anticipato ai soci violando la postergazione). Difesa: qui la miglior difesa è prevenire: non farsi restituire finanziamenti in prossimità della crisi (sarebbe revocabile e potenzialmente imputabile come atto preferenziale); piuttosto, convertire quel credito in capitale (aumento di capitale con compensazione crediti) prima di aprire la procedura – così il socio perde formalmente quei soldi ma li contabilizza a capitale, migliorando i ratio patrimoniali e mostrando buona fede. – Azione di responsabilità verso soci amministratori di fatto o direttori generali: se un socio svolgeva di fatto funzioni gestorie o era di fatto l’amministratore occulto, può essere chiamato anch’egli in causa ex art. 2394 c.c. (responsabilità verso creditori). Spesso i soci di SRL rispondono come amministratori se erano coinvolti nella gestione pur senza carica. Difesa: dimostrare di non aver inciso sulla gestione (ad es. delegare tutto a amministratori professionisti e restare estranei alle decisioni) o che le loro decisioni non hanno danneggiato la società. Non sempre facile, ma se si è soci non operativi, di solito non vengono perseguiti. – Perdita del capitale e ricostituzione: se la società ha perdite oltre il terzo capitale, i soci dovrebbero ricapitalizzare o liquidare (art. 2482-ter c.c.). Se non lo fanno e procrastinano, rischiano come amministratori di essere considerati responsabili per aggravamento. Ma i soci (non amministratori) in S.p.A. no, in S.r.l. talvolta il confine è labile se i soci sono anche amministratori. In ogni caso, per i soci c’è un rischio: se non ricapitalizzano e poi arrivano sanzioni, una giurisprudenza minoritaria ha ipotizzato abuso della personalità giuridica, ma in Italia il “piercing the corporate veil” è molto raro. Soltanto in casi di frode (società schermo, sovrapposizione patrimonio socio e società) potrebbe un giudice estendere la responsabilità. Difesa: mantenere netta separazione persona-società, non confondere conti, non far pagare alla società spese personali e viceversa, in modo da non dare adito a teorie di confusione patrimoniale. – Responsabilità dei soci per obbligazioni sociali dopo scioglimento e cancellazione: c’è una particolarità: se la società viene cancellata dal Registro Imprese e in seguito emergono debiti non soddisfatti, i soci possono risponderne fino a concorrenza di quanto hanno incassato in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). La Cassazione (es. ord. 20840/2023) ha di recente confermato che i soci di una S.r.l. estinta che hanno riscosso somme dalla liquidazione (anche in anni precedenti) ne rispondono verso i creditori rimasti insoddisfatti . Quindi, se i soci hanno prelevato attivi in liquidazione o rimborso capitale, potrebbero essere chiamati a restituirli pro quota ai creditori non pagati. Difesa: evitare di chiudere la società senza aver soddisfatto i debiti noti o senza accantonamenti. Se la chiusura è già avvenuta, prepararsi a eventuali richieste (questo scenario potrebbe capitare se, ad es., i soci decidevano di liquidare la società e la cancellavano dal registro, poi spunta un debito tributario: il Fisco può colpire i soci entro 5 anni dalla cancellazione, per legge speciale art. 28 d.lgs. 175/2014, e oltre la soglia di quanto riscosso può arguire distrazioni se c’erano attivi). – Reati fiscali imputabili ai soci? Di solito i reati tributari li risponde chi aveva deleghe amministrative. Un socio non operante non viene incriminato per omesso versamento IVA se non era lui il soggetto obbligato (legale rappresentante). Salvo il caso di socio di fatto amministratore occulto, oppure nelle SRL piccole a conduzione familiare dove tutti decidevano: in tali casi, la distinzione formalistica può cadere e il PM considerare tutti complici. Dunque per i soci è importante poter dire “io non gestivo, c’era un amministratore delegato; se lui ha evaso, io non concorso”. – Patrimonio personale: – Se un socio possiede immobili o ricchezza a rischio aggressione (ad es. perché ha garantito debiti sociali), valga quanto detto: valutare trust o fondo patrimoniale prima che la situazione precipiti (ma con coscienza che se lo fa a ridosso e poi fallisce, il curatore può revocare l’atto o farlo dichiarare nullo come atto fraudolento). Se decide per trust, deve avere uno scopo diverso dalla mera sottrazione ai creditori (es. trust per figli – comunque revocabile se recente e debiti già esistenti). – Pianificare la propria insolvenza: i soci-imprenditori che falliscono insieme alla società (socio illimitatamente responsabile fallisce insieme alla società in nome collettivo, ma qui non è il caso essendo società di capitali). In una S.r.l., i soci di norma non falliscono per la società. Però se hanno debiti personali da fideiussioni, come detto useranno il sovraindebitamento o convinceranno la banca ad accettare un accordo stragiudiziale (magari ipotecando la prima casa per ottenere un rifinanziamento e pagare il debito residuo). – Una volta conclusa la procedura societaria, se i soci intendono ripartire con nuova impresa, nessuna norma lo vieta (non c’è interdizione fallimentare per loro, a differenza di amministratori che possono subire interdizione a cariche in caso di bancarotta fraudolenta). Tuttavia, moralmente e commercialmente può essere sensato – per riabilitare la reputazione – che i soci facciano il possibile per soddisfare i creditori, anche oltre gli obblighi di legge. Ad esempio, un socio potrebbe, a concordato eseguito, offrire volontariamente un earn-out ai creditori se l’azienda risanata va molto bene. Non è frequente, ma dà l’idea.
In conclusione per soci e amministratori: – Check-list di autodifesa ex ante: – Documentare ogni decisione in consiglio, le ragioni, per potersi difendere poi (es. verbali dove si spiega perché si continua attività credendo in una commessa, etc.). – Non attendere l’ultimo momento a cercare aiuto: attivare procedure come allerta/composizione negoziata tempestivamente riduce l’accusa di inerzia colposa. – Seguire scrupolosamente i requisiti di legge (assemblee per perdite, convocare soci per ricapitalizzazione, se soci non ricapitalizzano e non c’è soluzione, meglio portare i libri in tribunale tu, piuttosto che far aggravare: un fallimento richiesto dal debitore è visto meglio che un fallimento dopo un anno di inerzia). – Tenere contabilità in ordine fino alla fine. Se mancano fondi, investire quel poco per pagare il commercialista che chiuda i conti annuali: molte condanne per bancarotta documentale avvengono solo perché l’amministratore ha mollato contabilità nel caos (magari perché l’addetto se n’è andato). – Dopo la procedura: – Se c’è un’azione di responsabilità, valutare se è possibile un accordo transattivo con il curatore per chiudere la vicenda (talvolta i curatori accettano un pagamento parziale subito dagli amministratori a chiusura di ogni pretesa, evitando lunghe cause). – Se l’amministratore è stato bandito da incarichi per via del fallimento (in realtà nella legge attuale non c’è più l’interdizione automatica post-fallimentare come un tempo; c’è solo quella penale eventuale), potrebbe comunque attendere la riabilitazione fallimentare (che nel CCII è stata rivista).
6.3 Esempio pratico di difesa personale: Immaginiamo il signor Mario, amministratore unico e socio di maggioranza della S.r.l. di variatori: – Mario aveva dato fideiussione alla banca e ipoteca sulla sua casa per un mutuo societario. Nel concordato, la banca ha ottenuto il 80% dal patrimonio sociale e per il 20% residuo può rivalersi su Mario. Mario negozia e la banca accetta €10k in 24 mesi da Mario per chiudere (perché Mario dimostra di avere reddito modesto, e minaccia altrimenti di fare liquidazione sovraindebitamento). – Mario è accusato dal curatore di aver tardato il fallimento di un anno. Il passivo in quell’anno è salito di €200k. Mario sostiene che sperava ragionevolmente in un contratto che poi è saltato e che quell’anno di attività ha mantenuto comunque stabile l’attivo; il curatore replica con i numeri. Forse transano: Mario, grazie anche alla D&O, versa €50k a titolo transattivo e viene liberato da ulteriori azioni (il giudice approva se è vantaggioso per creditori rispetto all’incertezza della causa). – Mario affronta un procedimento per omesso versamento IVA di €300k. Però nel concordato quell’IVA è stata pagata al 100% (anche se dilazionata). Mario produce la prova che entro la fine del concordato tutto l’IVA sarà pagata: i suoi avvocati chiedono l’applicazione della causa di non punibilità (che nel caso specifico è un po’ complicata: il pagamento integrale entro il dibattimento estingue il reato; qui è dilazionato ma presumibilmente completato prima della sentenza finale). Se riesce, Mario esce senza condanna penale; se no, il suo legale punta alla pena minima e a dimostrare che la crisi di liquidità era così grave che non aveva alternative (linea di difesa difficile ma a volte porta alle attenuanti generiche). – Mario, stressato, decide di non fare più l’imprenditore attivo per qualche anno. Mette l’azienda risanata in mano a un manager e rimane come socio di minoranza (perché magari un investitore è entrato). Questo abbassa il suo profilo di rischio e gli consente di dedicarsi a ripianare i debiti personali residui. – Dopo qualche anno, la società va bene e Mario, per riabilitarsi moralmente, magari versa qualcosa volontariamente ai creditori chirografari che avevano preso il 20% (questo è solo un gesto eventuale, non giuridicamente dovuto, ma talvolta accade per ricucire rapporti commerciali: “ti do un extra bonus ora che posso”).
È importante capire che la strategia difensiva per gli individui coinvolti non è semplicemente legale, ma anche patrimoniale e negoziale: serve pianificare come gestire l’impatto finanziario personale del default, utilizzando i meccanismi di esdebitazione se necessario. Con l’introduzione del Codice della Crisi, l’ordinamento offre anche al privato sovraindebitato (come potrebbe diventare Mario se costretto a onorare garanzie) una via d’uscita legale ordinata.
7. Domande frequenti (FAQ) su debiti aziendali e difesa del debitore
Di seguito una serie di domande e risposte comuni per chiarire dubbi ricorrenti dal punto di vista di imprenditori-debitori e dei loro consulenti.
D1: Un’azienda sommersa dai debiti può davvero salvarsi senza fallire?
R1: Sì, attraverso strumenti di risanamento come il concordato preventivo in continuità o gli accordi di ristrutturazione, un’azienda insolvente ma con un core business valido può evitare la liquidazione giudiziale. L’importante è predisporre un piano realistico che garantisca ai creditori almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione e coinvolgerli nella soluzione . La nuova normativa incoraggia la ristrutturazione precoce, quindi se l’azienda interviene tempestivamente (ad es. avviando una composizione negoziata appena emergono squilibri), le chance di evitare il fallimento aumentano. È fondamentale avere il supporto di professionisti (commercialisti, legali) esperti di crisi per scegliere lo strumento adatto e negoziare con i creditori chiave.
D2: Quali sono i segnali che indicano di attivarsi per tempo con una procedura di crisi?
R2: Alcuni “campanelli d’allarme” sono: incapacità di pagare regolarmente IVA e contributi (si accumulano arretrati), utilizzo costante di fidi oltre il fido con interessi di mora, ritardi nei pagamenti a fornitori essenziali, tensioni di cassa che costringono a scegliere quali bollette pagare. Anche indicatori come patrimonio netto azzerato o negativo, indebitamento finanziario in forte crescita, DSCR (indice di copertura del debito) sotto 1 per vari mesi, sono segnali tecnici di crisi. La legge delega gli organi di controllo a vigilare su questi indizi. Non appena si manifestano, l’imprenditore deve valutarli con il consulente: se sembrano duraturi, meglio attivare uno strumento come la composizione negoziata (che non comporta pubblicità negativa iniziale) per cercare una via d’uscita concordata. Trascurare questi segnali può portare a responsabilità per il management per ritardata emersione dello stato di crisi.
D3: Come funziona il voto dei creditori in un concordato preventivo?
R3: Nel concordato, i creditori sono suddivisi in classi omogenee e votano per classe. Hanno diritto di voto i chirografari e i privilegiati se il piano li altera (falcidia/dilazione). L’approvazione richiede il sì della maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe, oppure – se non tutte le classi approvano – è sufficiente che approvi la maggioranza delle classi e che il totale dei crediti favorevoli sia almeno 2/3 dei crediti ammessi . Se alcune classi votano no, il debitore può chiedere comunque l’omologazione (cram-down) purché la proposta rispetti i criteri di legge e almeno una classe “portante” abbia detto sì. Il voto si esprime in adunanza (ora spesso anche per iscritto) con percentuale di credito. Ad esempio: se c’è unica classe chirografi, serve il voto favorevole di creditori che rappresentino >50% dei crediti chirografari ammessi al voto. In caso di più classi, occorre il quorum in ciascuna o attivare il cram-down. I creditori pubblici (Erario, INPS) votano tramite gli organi competenti (Agenzia Entrate, consigli di amministrazione INPS) sulla base della convenienza economica della proposta . Importante: i privilegiati se soddisfatti integralmente di solito non votano (sono “esteri” perché non toccati dal piano).
D4: Se un solo grande creditore non è d’accordo (es. la banca o il Fisco), può bloccare tutto?
R4: In passato spesso sì, ma con le nuove norme no, non necessariamente. Se la maggioranza degli altri creditori è favorevole, il tribunale può omologare il concordato nonostante il dissenso di uno o più creditori, applicando il cram-down . Bisogna però che il creditore dissenziente non sia trattato in modo peggiore rispetto a un fallimento. Per il Fisco e l’INPS, in particolare, la legge prevede che il cram-down non si applichi se la loro mancata adesione è motivata da circostanze specifiche come un indebitamento tributario superiore all’80% del totale o condotte fraudolente del debitore . Ma se, ad esempio, una banca ipotecaria vota no e tutti gli altri sì, e alla banca il piano offre almeno il valore di perizia del suo immobile (quindi equo), il tribunale può approvare il concordato comunque. Quindi un singolo creditore non ha più potere di veto assoluto come un tempo, a condizione che il piano nel complesso rispetti i suoi diritti minimi. Anche l’Erario, se isolato, può essere crammed-down (ed è una novità rilevante del CCII).
D5: Cosa succede ai debiti dell’azienda se il concordato va a buon fine?
R5: Una volta omologato e adempiuto il concordato, la società è liberata dai debiti pregressi secondo i termini del piano. I creditori chirografari rinunciano definitivamente alla parte non pagata (è un’esdebitazione implicita nel concordato omologato) . Ad esempio, se il piano prevedeva pagamento 30% ai fornitori e la società lo esegue, il restante 70% è inesigibile: i fornitori non possono più pretendere nulla e il debito è estinto. I creditori privilegiati eventualmente falcidiati sono soddisfatti per la quota concordata e per la differenza non possono rivalersi sulla società (ma come visto potrebbero su eventuali coobbligati esterni, tipo garanti). Se però il concordato non viene adempiuto e si chiede la risoluzione, i creditori riacquistano i loro diritti per intero dedotti gli acconti ricevuti, e spesso si finisce in liquidazione giudiziale. Importante: per i coobbligati e fideiussori del debitore, il concordato non li libera a meno che la legge speciale o il piano lo prevedano . Quindi un socio garante potrebbe essere ancora costretto a pagare (salvo accordo) la parte di debito che la società ha tagliato. Dopo esecuzione del concordato, la società risanata riparte con la sola nuova finanza e nuovi debiti eventualmente contratti post-omologa. È priva dello “zaino” del debito precedente (a meno che abbia concordato dilazioni lunghe e stia ancora pagando, ma quelli sono pagamenti dovuti come da piano, comunque senza più rischio di azioni esecutive se li rispetta).
D6: Se la società viene messa in liquidazione giudiziale (fallimento), i soci o amministratori possono perdere la casa?
R6: Dipende. Se soci o amministratori non hanno dato garanzie personali e non hanno commesso illeciti con responsabilità diretta, il fallimento della società di per sé non intacca il loro patrimonio: la casa personale non è tra i beni della società, quindi il curatore non può toccarla. Tuttavia, se quell’immobile era stato ipotecato per un debito sociale (garanzia personale), la banca può espropriare la casa per soddisfarsi, anche indipendentemente dal fallimento (anzi, il fallimento spesso accelera le banche nell’escussione delle garanzie). Inoltre, se l’amministratore viene condannato per danni verso i creditori, quella condanna potrà essere eseguita sui suoi beni, casa compresa (salvo sia prima casa non ipotecata e rientri nei limiti di impignorabilità: la legge vieta di pignorare la prima casa da parte di Fisco, ma un creditore privato può farlo se di valore elevato e non vi risiede il debitore come requisito unico, è un tema tecnico). Quindi, in pratica: – Il fallimento in sé non travolge la casa del socio di S.r.l. – Ma un garante o un amministratore condannato possono rischiarla. I soci e amministratori prudenti, se percepiscono questo pericolo, a volte valutano di proteggere l’abitazione (es. costituendo un fondo patrimoniale se ci sono i presupposti). Notare però che il fondo patrimoniale non protegge la casa dai debiti “per bisogni familiari”; un debito contratto per salvare l’azienda può essere considerato finalizzato al mantenimento della famiglia e dunque aggredibile . Dunque non è una barriera sicura. Una tutela migliore è semplicemente evitare di esporre la propria casa a ipoteche se non strettamente necessario e, se inevitabile, prevedere un piano B: ad esempio vendere la casa volontariamente per pagare i debiti (con eventuale affitto di altro immobile) prima che venga pignorata, così da realizzare magari un valore maggiore e liberarsi dall’incubo.
D7: L’amministratore rischia sanzioni o interdizioni professionali dopo un fallimento?
R7: Solo in conseguenza di reati eventualmente accertati. La vecchia legge fallimentare prevedeva che il fallito imprenditore (persona fisica) subisse alcune limitazioni di diritti (es. non poteva ricoprire cariche in altre società senza riabilitazione). Il CCII ha eliminato molte di queste previsioni per le società di capitali, focalizzandosi su eventuali misure penali. Quindi, un amministratore non viene automaticamente interdetto dal ricoprire altre cariche sociali solo perché c’è stato un fallimento. Tuttavia, se viene condannato per bancarotta fraudolenta, il codice penale prevede l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità a esercitare imprese commerciali e a ricoprire uffici direttivi in imprese per 10 anni (pena accessoria per bancarotta fraudolenta) e 5 anni per bancarotta semplice. Dunque, un amministratore onesto che porta i libri in tribunale e collabora non subisce sanzioni civili ipso iure; uno che ha commesso irregolarità gravi rischia di essere allontanato dalla gestione di aziende per un lungo periodo per ordine del giudice penale. In fase di concordato, invece, non ci sono misure afflittive: anzi, se lo completa con successo, la reputazione può migliorare. Esiste la cosiddetta “esdebitazione dell’imprenditore fallito” che però riguarda l’imprenditore individuale; per gli amministratori di società non c’è un istituto analogo ma, passati i guai, possono continuare la loro vita professionale (salvo, come detto, implicazioni penali).
D8: I crediti dei soci verso la società (finanziamenti soci) che fine fanno nel concordato?
R8: In virtù della legge (art. 2467 c.c.), i finanziamenti dei soci sono postergati, cioè vengono dopo tutti gli altri crediti. In un concordato, spesso i crediti dei soci non vengono neppure considerati, perché se la soddisfazione dei chirografari terzi è inferiore al 100%, ai soci per legge spetterebbe zero (non si arriva a loro). Quindi, generalmente i soci rinunciano ai loro crediti come parte degli impegni per favorire il concordato. Nella documentazione il socio può formalizzare la rinuncia al credito prima dell’omologa, così da rafforzare il patrimonio netto (trasformando il debito in patrimonio). Se non lo fa, comunque il piano di solito prevede che saranno pagati dopo integrale pagamento di tutti gli altri creditori, il che in pratica significa che non verranno pagati. I soci accettano questa perdita perché è coerente con il principio di responsabilità limitata (hanno già beneficiato eventualmente in passato di utili). Questa rinuncia viene vista di buon occhio dal tribunale e dai creditori, perché dimostra che i soci fanno la loro parte di sacrificio. Se invece i creditori “esterni” fossero pagati in full (caso raro di concordato con patrimonio molto capiente), solo allora residuerebbe qualcosa per rimborsare anche i soci dei loro finanziamenti, ma a quel punto non sarebbe neanche necessario un concordato.
D9: In caso di concordato, i fornitori continuano a fornire beni/servizi all’azienda?
R9: Dipende dalla fiducia e dalla gestione. Tecnicamente, dopo il deposito della domanda di concordato, i contratti in corso non si risolvono automaticamente (a differenza del fallimento). Il debitore può chiedere di mantenerli attivi e il commissario monitorerà i pagamenti correnti. Molti fornitori, venendo a sapere del concordato, temono di “gettare buon denaro su cattivo” – ossia fornire altro e non essere pagati. Perciò la legge consente misure per rassicurarli: – Il debitore può pagare in prededuzione le forniture essenziali successive (con autorizzazione del giudice): ciò garantisce al fornitore che quei nuovi crediti verranno comunque soddisfatti con priorità su ogni altro debito . Se l’azienda ha un minimo di cassa e il piano li prevede, può pagare alla consegna la merce nuova. – Oppure può offrire garanzie collaterali sui pagamenti futuri (se il giudice autorizza). – I fornitori essenziali spesso sono messi in classe separata e magari prendono percentuale più alta sui vecchi crediti per tenerli buoni. Nonostante ciò, qualche fornitore può rifiutare nuove ordinazioni se c’è insicurezza. In tal caso l’azienda deve trovare fornitori alternativi o rivolgersi al giudice perché, in rarissimi casi, imponga la continuazione di contratti di fornitura indispensabili (es. energia elettrica e gas non possono essere staccati per morosità pregressa durante il concordato, se si pagano le bollette correnti). Fortunatamente, molti fornitori preferiscono non perdere un cliente e, se vedono serietà nel piano, accettano di proseguire (magari su base contanti per il nuovo e attendendo il concordato per l’arretrato). Quindi sì, è possibile che l’azienda continui a ricevere beni e servizi – ma serve costruire fiducia e dare garanzie sul pagamento del nuovo.
D10: Se l’azienda viene venduta durante la procedura (in tutto o in parte), i lavoratori perdono il posto?
R10: Il trasferimento dell’azienda, anche in ambito concorsuale, comporta per legge (art. 2112 c.c.) la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente, con gli stessi termini (salvo diversi accordi sindacali). Nelle procedure, però, è possibile concordare con i sindacati deroghe (il CCNL Metalmeccanici, ad esempio, prevede che in caso di crisi si possano negoziare condizioni diverse). In un concordato con cessione d’azienda, di solito l’acquirente si impegna ad assorbire la gran parte dei dipendenti. Se alcuni esuberi sono inevitabili, si cerca di gestirli con incentivi all’esodo o strumenti come la NASpI per disoccupazione. Ma la regola base è: se Tizio S.p.A. compra l’intera azienda dalla Alfa S.r.l. in concordato, i dipendenti Alfa passano automaticamente a Tizio, conservando anzianità e diritti. Solo in fallimento la continuità non è garantita (il curatore se cede beni non è tenuto a farsi carico del personale, anche se spesso per vendere meglio include il personale e l’acquirente li assume ex novo). Il concordato in continuità diretta invece vede l’azienda restare la stessa e quindi i rapporti di lavoro non si interrompono affatto, salvo eventuali licenziamenti concordati in piano (che però, essendo ante omologa, avvengono seguendo legge Fornero o accordi collettivi).
Queste domande chiariscono vari aspetti che imprenditori e legali ci pongono di frequente quando affrontano crisi debitorie. Ogni risposta ovviamente andrebbe calibrata sul caso concreto e tenendo conto degli aggiornamenti normativi; in questa guida ci siamo basati sulla situazione a fine 2025, con le ultime modifiche di legge e pronunce giurisprudenziali citate per conferire autorevolezza alle affermazioni.
8. Simulazioni pratiche (casi di studio Italia)
Per meglio comprendere l’applicazione delle nozioni fin qui esposte, presentiamo due casi ipotetici basati su situazioni realistiche che un’azienda di variatori e convertitori di frequenza potrebbe affrontare. Ogni caso descrive uno scenario di debito e la possibile strategia di difesa adottata, con esito.
Caso 1: Risanamento in continuità con accordo di ristrutturazione e concordato preventivo
Scenario: TechConvert S.r.l. produce convertitori di frequenza per macchinari industriali. Negli ultimi anni ha perso un paio di grossi clienti esteri e accumulato debiti: €500k con banche (mutuo e fido), €300k di debiti fiscali (IVA non versata e IRAP), €150k con fornitori, €50k tra TFR e stipendi arretrati. Ha 20 dipendenti e un impianto produttivo di proprietà. I soci hanno dato garanzie personali sul mutuo bancario (ipoteca sulla casa del socio A) e su parte dei debiti fornitori (fideiussioni). La crisi di liquidità è grave ma l’azienda ha ancora ordini annuali per €1,2M e margini lordi del 20%: se fosse snellita dai debiti, sarebbe profittevole. Un investitore del settore (BetaSpA) si è detto interessato a entrare con capitale se la situazione debitoria viene sistemata.
Azione intrapresa: TechConvert avvia una composizione negoziata della crisi. Ottiene misure protettive dal tribunale per 3 mesi, bloccando due decreti ingiuntivi dei fornitori e una cartella esattoriale . Con l’aiuto dell’esperto, negozia un accordo di ristrutturazione con la banca principale e l’Agenzia delle Entrate: – La banca accetta di congelare le rate per 6 mesi e poi riprendere con ammortamento allungato di 5 anni, a tasso invariato (nessuna rinuncia capitale, ma dilazione). Inoltre, se TechConvert trova un investitore che ripaga subito almeno il 30% del mutuo, la banca rinuncerà a escutere la garanzia ipotecaria residua. BetaSpA si dichiara disponibile a versare €200k per acquisire il 60% di TechConvert, a condizione di ottenere un concordato “pulito”. – L’Agenzia delle Entrate (debito IVA e IRAP) accetta, con il beneplacito del suo avvocato erariale, una transazione fiscale: TechConvert pagherà il 100% dell’IVA e IRAP in 4 anni, ma senza sanzioni né interessi (che costituivano ~€50k, falcidiati a zero) . L’esperto attesta che così il Fisco prende più del presumibile in caso di fallimento (dove IVA era chirografa per mancanza attivo sufficiente). – I fornitori strategici (che rappresentano €100k del debito fornitori) aderiscono ad un accordo: forniranno ancora componenti a TechConvert, in cambio del pagamento in prededuzione delle forniture nuove e dell’assicurazione di ricevere il 30% dei crediti pregressi entro 1 anno (BetaSpA metterà parte dei €200k in ciò). – I dipendenti, informati del piano di rilancio, accettano tramite il sindacato il pagamento dilazionato dei loro arretrati su 6 mesi post-omologa, con BetaSpA che anticipa il TFR di due pensionandi (per incentivarli ad uscire volontariamente, riducendo di 2 unità l’organico in esubero). – Il socio A (casa ipotecata) negozia con la banca: BetaSpA paga subito €150k del mutuo (grazie all’aumento di capitale), la banca riduce il debito residuo e svincola l’ipoteca su casa A, liberandolo. In pratica la banca incassa 150k + rientrerà del resto col piano in 5 anni e considera soddisfatta la sua esposizione garantita.
Con questi accordi sulla carta, TechConvert elabora un piano concordatario in continuità: BetaSpA versa €200k freschi (equity nuova) – di cui €150k usati come detto per banca e dipendenti, €50k per liquidità circolante. La produzione continua senza intoppi, i nuovi ordini finanziano i pagamenti correnti. Il piano prevede: pagamento 100% debiti privilegiati (Erario e banca mutuo come modificato) in max 4 anni, pagamento 30% ai fornitori in 1 anno (già concordato con principali), soddisfacimento integrale dipendenti (grazie all’intervento BetaSpA + rate da incassi). I crediti sanzioni ed interessi fiscali sono stralciati. I creditori chirografari non fornitori (es. consulenti €50k) prendono anch’essi 30%. I soci originari rinunciano ai finanziamenti pregressi e perdono parte delle quote a favore di BetaSpA che li ricapitalizza.
Esito: Viene presentato un accordo di ristrutturazione in tribunale (sottoscritto da creditori rappresentanti il 75% del passivo: banca, Fisco, fornitori chiave) . Il tribunale omologa l’accordo rapidamente e contestualmente – per includere anche i piccoli creditori estranei – viene aperto un concordato semplificato per liquidare quel 30% ai restanti chirografari. In pratica, i creditori rilevanti erano già d’accordo; i pochi estranei (fornitori minori €50k) sono pagati 30% dal piano e non fanno opposizione. BetaSpA entra nella società, portando nuove commesse grazie alle sue sinergie. L’azienda continua l’attività, esegue i pagamenti concordati. Dopo 2 anni, TechConvert è tornata in utile, i debiti bancari rifinanziati vengono pagati regolarmente. L’Agenzia Entrate incassa ogni semestre le rate IVA come da transazione . I fornitori hanno ripreso fiducia e dilazioni normali. Il concordato viene dichiarato adempiuto dopo 2 anni. I soci originari hanno perso controllo ma evitato guai peggiori; il socio A ha salvato la casa. L’amministratore non subisce azioni di responsabilità perché la continuità ha massimizzato i valori (anzi, i creditori soddisfatti rinunciano a qualsiasi rivalsa). La votazione nel concordato è stata superflua perché tutti i principali attori erano firmatari dell’accordo ex 182-bis; gli altri, troppo piccoli per formare classi a sé, non hanno fatto storie. Questo caso mostra un salvataggio “misto” negoziale-giudiziale, cucito su misura. È complesso da orchestrare ma possibile con buona volontà di creditori strategici e l’apporto di un investitore.
Caso 2: Liquidazione dell’azienda e tutela personale dell’imprenditore
Scenario: ElettroVar S.r.l. è un’azienda più piccola (10 dipendenti) che produce variatori per piccoli impianti. Purtroppo ha perso mercato a causa di prodotti cinesi a basso costo; fatturato dimezzato in 3 anni. Ha debiti per €400k: in gran parte debiti bancari (€150k mutuo su capannone + €50k fido scoperto), €100k con fornitori, €50k di arretrati contributivi e IVA, €50k debiti vari (bollette, leasing auto), €20k stipendi arretrati. Le macchine e il capannone valgono circa €200k. Il titolare e socio unico, sig. Rossi, 60enne, vuole chiudere e andare in pensione: non vede prospettive di risanamento, anche perché i margini negativi continuano. Non c’è interesse di investitori a rilevare, se non forse a comprare i macchinari usati a prezzo di saldo.
Azione intrapresa: Rossi opta per un concordato preventivo liquidatorio per evitare l’onta del fallimento e gestire la cessazione in modo ordinato. Presenta una proposta: vendita del capannone e dei macchinari in blocco ad un acquirente locale (un’impresa vicina interessata ad ampliare il proprio stabilimento) per €220k, da effettuarsi subito dopo l’omologazione; incasso destinato ai creditori. Non essendoci continuità, la legge richiede almeno 20% ai chirografari: la proposta offre il 30% ai chirografari, grazie al fatto che i privilegiati (banca ipotecaria su capannone e dipendenti) assorbono il grosso del ricavato ma lasciano qualcosa. In dettaglio: – Banca (ipoteca residuo €120k sul capannone): prende €120k dal prezzo (capannone venduto a €180k su €220k totali). – Il fido €50k banca è chirografo: riceverà 30%, quindi €15k. – Fornitori €100k chirografari: 30% = €30k. – IVA e contributi privilegiati €30k: per legge vanno soddisfatti prima dei chirografari. Rossi calcola che dopo aver pagato banca ipotecaria, rimangono €100k; di questi deve dare €30k a IVA/INPS (così li paga 100%). Restano €70k per i chirografi, che in totale sono €200k (fornitori 100 + banca fido 50 + bollette/leasing 50). €70k su €200k = 35%. Lui propone 30% per margine di sicurezza. – Dipendenti: il TFR e 3 mensilità (privilegio super) ammontano a €40k; li anticipa in parte il Fondo di Garanzia INPS. Nel concordato prevede di versare subito €20k di quei €40k (ottenuti vendendo scorte e incassi residui), e far intervenire il Fondo INPS per il resto. I dipendenti sono d’accordo, anche perché la maggior parte troverà lavoro altrove con la mobilità. – Il leasing auto (€20k residuo) restituisce l’auto alla società di leasing, che la venderà e presumibilmente chiude lì (nessun credito concorsuale rilevante resta). – Il socio Rossi rinuncia a credito per finanziamento soci €30k (postergato). – Spese di procedura stimate €10k (commissario, perito stima) da considerare.
Rossi deposita questo piano con l’attestazione di fattibilità. La perizia allegata stima capannone + macchinari appunto €220k, confermando che quell’offerta di acquisto esiste (ha raccolto una proposta d’acquisto vincolante da BetaImmobiliare). La banca ipotecaria vota a favore (prende 100% quindi ok), i dipendenti anche (preferiscono concordato a fallimento per avere subito l’intervento INPS e niente incertezze). I chirografari… alcuni fornitori sono scontenti ma comprendono che fallendo prenderebbero forse 10% o nulla, e qui 30%. Si raggiunge la maggioranza (banca fido e bollette sì, qualche fornitore grosso magari no, ma complessivamente >50% crediti chirografi favorevoli, quindi approvato). Un fornitore dissenziente protesta in omologa, ma il giudice respinge l’opposizione perché la percentuale 30% rispetta il requisito di legge e il fornitore non dimostra frodi.
Esito: Il tribunale omologa il concordato. Subito dopo: – Si stipula l’atto di vendita del capannone e beni: BetaImmobiliare paga €220k, il notaio distribuisce €120k alla banca (che dà assenso a cancellazione ipoteca), e deposita il resto a disposizione del liquidatore concordatario. – Il liquidatore (che era il commissario, nominato liquidatore post-omologa) paga €30k al Fisco (IVA/INPS) , €15k alla banca per il fido, €30k pro-quota ai fornitori e altri chirografari. (In totale €120+30+15+30 = €195k esauriti i €195k netti; i €25k residui vanno a spese di procedura e contributi tardivi se spuntano). – L’INPS Fondo versa ai lavoratori i €20k restanti di TFR/salari. – La società a quel punto non ha più attivo né debiti: il concordato è eseguito e dopo 6 mesi viene chiesta la chiusura e la cancellazione di ElettroVar S.r.l. dal registro imprese.
Rossi ha perso l’azienda ma evitato il fallimento. Per lui questo significa: – Nessuna azione di responsabilità: i creditori hanno accettato il 30% come miglior soluzione, difficile imputargli danni ulteriori. Non emergono irregolarità. – Nessun procedimento penale: l’IVA e contributi sono stati pagati per intero nel concordato, quindi non c’è omesso versamento rilevante. Qualche fornitore ha avuto trattamento preferenziale pre-concordato? Rossi si era guardato bene dal farlo negli ultimi 6 mesi, seguendo il consiglio del legale. Quindi niente bancarotta preferenziale. – La casa di Rossi non era coinvolta (nessuna garanzia personale): rimane sua e al riparo. – Rossi non può più fare l’imprenditore? In realtà può farlo, non essendo incappato in reati. Ma lui ha 60 anni e preferisce ritirarsi. In futuro, se volesse, non ha interdizioni (il concordato non prevede). – I fornitori incassano 30%, un po’ meno se consideriamo tempi, ma accettabile. BetaImmobiliare ha fatto un affare comprando capannone e macchinari a prezzo equo. – ElettroVar come entità sparisce. I dipendenti trovano occupazione altrove (non tutti, ma molti, data la loro specializzazione).
Questo caso evidenzia come, anche senza possibilità di salvataggio, la liquidazione concordata permette di chiudere l’impresa limitando conseguenze: Rossi non viene inseguito per anni dai creditori (che altrimenti l’avrebbero forse citato in giudizio), i creditori ottengono qualcosa in tempi rapidi e senza le incertezze di un fallimento (dove magari alcuni non prendevano nulla), il tutto con costi procedurali contenuti. La chiave è stata predisporre in anticipo l’acquirente per vendere l’azienda in blocco, massimizzando il ricavato – se si fosse andati in fallimento, il capannone venduto all’asta e i macchinari separatamente avrebbero potuto fruttare meno di €180k. Con concordato, tempi rapidi e scelta del miglior offerente (anche senza asta competitiva in certi casi, se offerta è di mercato e attesta come qui).
Considerazioni finali dai casi: – Nel caso 1 vediamo l’importanza di un investitore e della trattativa con creditori: la normativa flessibile post-2022 consente soluzioni creative (un mix di accordo e concordato, transazione fiscale spinta) per salvare un’azienda valida . La difesa del debitore qui è difesa dell’attività: tutti fanno sacrifici ma l’impresa prosegue e ripaga col tempo. – Nel caso 2 c’è la resa dell’attività, ma il debitore ottiene comunque benefici difensivi – principalmente evitare il fallimento e le sue implicazioni. I creditori vedono soddisfatta la regola della priorità e accettano l’esito perché è trasparente e più efficiente del fallimento (che sarebbe l’alternativa).
Ogni situazione è diversa: l’importante è che il debitore non subisca passivamente gli eventi ma usi gli strumenti legali per orchestrare la soluzione migliore possibile, coadiuvato da professionisti. Una società in crisi con debiti ha ancora delle carte da giocare: può proporre un piano, chiedere protezione temporanea, coinvolgere partner, insomma prendere l’iniziativa. Questo non garantisce sempre il successo, ma aumenta notevolmente le probabilità di un esito più favorevole rispetto a lasciare che i creditori procedano in modo disorganizzato (col rischio altissimo del fallimento pilotato dai creditori più aggressivi, che è di solito lo scenario peggiore per il debitore e spesso anche per l’insieme dei creditori).
9. Conclusioni
Dal percorso fatto risulta chiaro che un’azienda di variatori e convertitori di frequenza indebitata dispone di diverse opzioni per difendersi e cercare di risolvere la situazione debitoria, sia mantenendo in vita l’attività (quando vi sono basi industriali valide), sia liquidandola in maniera controllata. La chiave è un’attenta valutazione iniziale dei debiti e della prospettiva di risanamento, seguita da un utilizzo tempestivo e appropriato degli strumenti offerti dalla normativa italiana aggiornata (CCII).
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” non significa sottrarsi illegittimamente alle obbligazioni (ciò porterebbe solo a peggiorare la posizione con sanzioni e azioni legali), bensì utilizzare a proprio favore le regole legali che consentono di ristrutturare i debiti in accordo con i creditori o attraverso una procedura concorsuale equa. Significa anche difendersi dagli effetti personali del dissesto, mettendo in sicurezza per quanto possibile il patrimonio personale di soci e amministratori, nei limiti della legge, e prevenendo situazioni di responsabilità personale attraverso una condotta diligente e collaborativa (ad esempio, evitare la continuazione scriteriata dell’attività in perdita, che potrebbe essere vista come un aggravamento doloso o colposo del dissesto).
Abbiamo visto come le sentenze recenti abbiano in parte rinforzato le tesi a tutela del debitore onesto: ad esempio, la responsabilità degli amministratori per i debiti fiscali sociali va circoscritta a casi di dolo o colpa grave, non è più un riflesso automatico ; oppure, un concordato preventivo ben congegnato può essere omologato anche contro il voto contrario di un creditore dissenziente, impedendo a quest’ultimo di far precipitare l’azienda in fallimento se non ce n’è necessità . Ciò non toglie che resti fondamentale l’elemento della buona fede e correttezza del debitore: i giudici (fallimentari, tributari, penali) sanno distinguere tra chi cerca soluzioni nel rispetto delle regole e chi invece abusa degli strumenti solo per ritardare l’inevitabile o frodare i creditori. Pertanto, la migliore difesa del debitore è agire in modo trasparente, documentato e secondo legge.
In definitiva, un’azienda in crisi può evitare di “subire” il proprio fallimento e invece pilotare la crisi verso un esito più vantaggioso: la ristrutturazione se l’attività merita di proseguire, oppure la liquidazione negoziata se occorre cessare, così da minimizzare le perdite comuni. In entrambi i casi, i soci e amministratori che avranno agito con professionalità e rispetto delle normative potranno salvaguardare anche il proprio futuro, limitando le ripercussioni economiche e legali personali.
La normativa fallimentare italiana, specialmente dopo le riforme del 2022-2024, offre gli strumenti; spetta all’imprenditore debitore, ben consigliato, saperli maneggiare per difendersi dai debiti in modo legittimo e spesso concordato con i creditori stessi, trasformando un possibile scontro distruttivo in una soluzione costruttiva per tutte le parti coinvolte.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a ottobre 2025)
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (Correttivo-ter) – artt. 17-25 (Composizione negoziata), 56 (Piano attestato di risanamento), 57-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti), 64-bis/ter/quater (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), 84-120 (Concordato preventivo), 115 (Effetti verso i coobbligati), 2467 c.c. (Postergazione finanziamenti soci), 2486 c.c. (Responsabilità per attività in perdita con criteri danno) .
- Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 – Quadri di ristrutturazione preventiva, recepita nel CCII (introduzione del cram-down interclassi nel concordato e del PRO all’unanimità ).
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 27 novembre 2023, n. 32790 – Presupposti dell’azione di responsabilità verso il liquidatore (e amministratore) ex art. 36 DPR 602/1973: necessità di preventiva iscrizione a ruolo dei tributi e accertamento mancato pagamento con attivo di liquidazione.
- Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI – 19 dicembre 2023 n. 35497 – Annullamento cartella a carico di ex amministratore per omessi versamenti IVA/IRES della società fallita: confermato che l’art. 36 DPR 602/73 configura obbligazione autonoma e sussidiaria, azionabile solo con atto motivato e previo accertamento; mancata notifica di avviso di accertamento = carenza presupposti. (Cfr. nota studio legale Wise) .
- Sentenza Corte Giustizia Tributaria II grado Lombardia, 18 marzo 2025, n. 752/2025 – Debiti fiscali di società estinta non automaticamente in capo all’amministratore; necessaria prova di condotte illecite individuali. Principio di personalità della responsabilità tributaria ribadito, Agenzia Entrate deve dimostrare coinvolgimento diretto del soggetto .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, 06 giugno 2024, n. 15862 – Fallimento “omisso medio” dopo concordato omologato: richiamo a Cass. SS.UU. n. 4696/2022, effetti esdebitatori del concordato non permangono se fallimento dichiarato entro termine per richiedere risoluzione (art. 186 L.F.), mentre permangono se dichiarato dopo quel termine. (Credito falcidiato nel concordato non rivive salvo ipotesi annullamento/risoluzione tempestiva) .
- Sentenza Corte Costituzionale 8 luglio 2025, n. 103 – Confermata legittimità costituzionale dell’art. 2, co.1-bis, DL 463/1983 (omesso versamento contributi ≤ €10.000 sanzionato con multa 1,5-4 volte l’importo): ritenuta proporzionata e non irragionevole la severità della sanzione amministrativa per evasione contributiva, dato il fine di tutela di diritti essenziali dei lavoratori .
- Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V penale, 29 ottobre 2019, n. 27610 – Responsabilità dell’amministratore per sanzioni tributarie e contributive irrogate alla società: qualificazione come danno risarcibile verso la società. Nel caso, omessa tenuta contabilità e omesse dichiarazioni per più anni: amministratore condannato a risarcire €327.895 pari a circa 30% del debito Equitalia, reputato danno causato alla società .
- Massimario Cassazione: art. 115 CCII (ex art. 184 L.F.) – Effetti del concordato sui terzi: l’omologazione non libera coobbligati e fideiussori del debitore, né obbligati in via di regresso, salvo patto contrario (principio confermato anche nel CCII) .
- Prassi Agenzia Entrate-Riscossione (2023-2025): Definizione agevolata “Rottamazione-quater” (art. 1, commi 231-252, L.197/2022) – possibile riammissione al 30/04/2025 per decaduti, pagamento solo imposta senza sanzioni e interessi, in 18 rate trimestrali .
- Documenti di Confindustria e Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti 2024 su Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) – novità su composizione negoziata (accordo fiscale parziale art. 23 co.2-bis), transazione fiscale nei vari istituti (possibilità cram-down fiscale limitato), ruolo attestatore aumentato (verifica convenienza su debiti tributari), chiarimenti su classi concordato (art. 112 CCII, fairness test per cram-down).
La tua azienda che produce o distribuisce variatori di velocità, convertitori di frequenza, inverter industriali, drive di controllo, soft starter, sistemi di regolazione motori e soluzioni di automazione elettrica si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce o distribuisce variatori di velocità, convertitori di frequenza, inverter industriali, drive di controllo, soft starter, sistemi di regolazione motori e soluzioni di automazione elettrica si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, fornitori, banche, leasing o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi dei fornitori o minacce di pignoramento?
Il settore dei variatori e dei convertitori di frequenza è complesso e costoso: componenti elettronici di potenza, schede digitali, semiconduttori, IGBT, moduli PWM, dissipatori, collaudi, firmware e normative tecniche richiedono liquidità continua.
Basta un rallentamento nei pagamenti dei clienti per far precipitare la situazione finanziaria.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata, difesa e rilanciata, se agisci rapidamente e in modo strategico.
Perché un’Azienda di Variatori e Convertitori di Frequenza Finisce in Debito
Le cause più frequenti includono:
• aumento del costo di semiconduttori, moduli di potenza, componenti elettronici
• ritardi nei pagamenti da parte di integratori, OEM e industrie
• magazzino immobilizzato tra drive finiti, moduli, schede e semilavorati
• investimenti obbligati in R&D, certificazioni EMC e test elettrici
• costi energetici e logistici in aumento
• linee di credito bancarie ridotte o revocate
• cicli produttivi lunghi e collaudi molto complessi
Il problema non è mancanza di ordini: è la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per una Azienda di Convertitori con Debiti
Se non intervieni tempestivamente rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• revoca degli affidamenti bancari
• interruzione delle forniture di componenti elettronici critici
• decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
• sequestro del magazzino e dei semilavorati
• impossibilità di completare commesse, installazioni e collaudi
• ritardi nelle consegne e perdita di clienti strategici
• rischio concreto di fermo produttivo totale
Un debito non gestito può bloccare tutto nel giro di pochi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1) Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
• sospendere pignoramenti e blocchi in corso
• impedire ai fornitori di interrompere le consegne
• fermare le richieste aggressive delle banche
• proteggere i conti correnti aziendali
Prima si stabilizza l’azienda, poi si ristruttura.
2) Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso i debiti includono:
• interessi non dovuti
• sanzioni e more calcolate male
• somme duplicate
• errori della Riscossione
• debiti prescritti
• costi bancari irregolari
Una parte consistente del debito può essere ridotta o completamente azzerata.
3) Ristrutturare i debiti con piani di pagamento sostenibili
Le opzioni più efficaci includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di rientro con fornitori strategici
• rinegoziazione dei fidi bancari
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• accesso alle definizioni agevolate (quando disponibili)
L’obiettivo è recuperare liquidità e non fermare la produzione.
4) Attivare strumenti legali che proteggono l’impresa
Per situazioni debitorie importanti, gli strumenti più efficaci sono:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione dei debiti
• concordato minore
• liquidazione controllata (ultimo rimedio)
Queste procedure permettono di:
• bloccare TUTTI i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti ingiuntivi
• pagare solo una parte del debito
• garantire continuità produttiva e commerciale
• proteggere l’imprenditore a livello personale
Sono strumenti sicuri, approvati dal Tribunale.
5) Proteggere produzione, magazzino e forniture
Nel tuo settore è vitale:
• tutelare moduli di potenza, schede, drive, dissipatori, firmware critici
• mantenere attive le forniture elettroniche e meccaniche
• evitare sequestri che fermerebbero produzione e collaudi
• proteggere macchinari, strumenti di misura e banchi prova
• garantire continuità nelle consegne ai clienti industriali
La produzione non deve fermarsi: è l’unica via per uscire dalla crisi.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco dei debiti (commerciali, fiscali, bancari)
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario magazzino (drive, moduli, schede, componenti)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e programmazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Procedura giudiziaria (se necessaria): 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi dai primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione concreta dei debiti
• Protezione di magazzino, attrezzature e componenti
• Trattative efficaci con fornitori e banche
• Continuità produttiva e commerciale assicurata
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti e atti giudiziari
• Fare nuovi debiti per tamponare i precedenti
• Pagare un creditore tralasciando tutti gli altri
• Lasciare avanzare pignoramenti e decreti
• Affidarsi a società “miracolose” senza esperienza
Ogni errore può aggravare pesantemente la crisi.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato dei creditori
• Piani di ristrutturazione personalizzati
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative dirette con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
• Protezione totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di variatori e convertitori di frequenza non significa dover chiudere.
Con una strategia tempestiva puoi:
• bloccare immediatamente i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• proteggere magazzino, componenti e produzione
• mantenere la continuità dell’azienda
• salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento giusto per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.