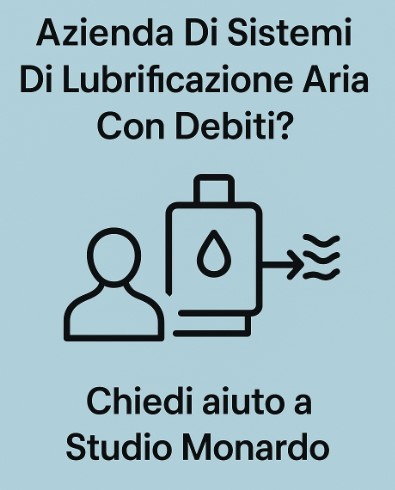Se gestisci un’azienda che produce, assembla o distribuisce sistemi di lubrificazione ad aria, sistemi di micro-lubrificazione, lubrificatori a nebbia d’olio, unità FRL (filtri–regolatori–lubrificatori), dosatori pneumatici e componenti per impianti industriali, e ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente molto critica.
Il settore della lubrificazione ad aria richiede precisione, componenti tecnici, continuità nelle forniture e tempistiche rapide. Per questo un blocco dovuto ai debiti può fermare linee produttive, interrompere commesse e compromettere rapporti con officine, impiantisti e industrie.
La buona notizia è che con una strategia mirata puoi bloccare pignoramenti, ristrutturare i debiti e salvare la tua azienda.
Perché le aziende di lubrificazione aria accumulano debiti
Le cause più comuni sono:
- costi elevati di gruppi FRL, valvole, dosatori e componentistica pneumatica
- pagamenti lenti da parte di industrie e manutentori
- aumento dei prezzi di materiali, guarnizioni, oli e componenti in ottone o acciaio
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi
- investimenti necessari per aggiornamenti, test e certificazioni
- magazzini tecnici complessi con varianti costose
- difficoltà ad accedere a crediti bancari sufficienti
- fornitori strategici che richiedono pagamenti rapidi
Questi elementi possono generare crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
In queste situazioni, il tempo è fondamentale. Ecco cosa devi fare subito:
- far analizzare la situazione debitoria da un avvocato specializzato in debiti aziendali
- verificare quali debiti sono corretti, prescritti o contestabili
- evitare di firmare accordi affrettati o rateizzazioni non sostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti già avviati
- attivare rateizzazioni realmente sostenibili con AE e INPS
- proteggere fornitori critici e componenti indispensabili
- prevenire blocchi del conto corrente o riduzioni dei fidi bancari
- valutare strumenti legali che permettano di ridurre o ristrutturare i debiti
Una valutazione professionale permette di capire quali debiti tagliare, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Ignorare il problema può portare a conseguenze gravi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di attrezzature e mezzi
- blocco delle forniture di gruppi FRL e componenti pneumatici
- impossibilità di consegnare o completare impianti
- perdita di clienti industriali e sistemisti
- danni alla reputazione tecnica
- crisi di liquidità e mancato pagamento del personale
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore della lubrificazione, anche un breve fermo può compromettere commesse fondamentali.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato può intervenire con competenza e rapidità:
- bloccare immediatamente pignoramenti e misure esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative mirate
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- annullare debiti prescritti, mal calcolati o irregolari
- mediare con banche e fornitori essenziali
- proteggere continuità operativa, magazzino e attrezzature
- stabilizzare l’azienda durante la ristrutturazione finanziaria
- evitare che la crisi degeneri in insolvenza o chiusura
Una difesa professionale permette di recuperare margini, continuità e stabilità operativa.
Come evitare il blocco dell’attività
Per non interrompere l’operatività aziendale devi:
- intervenire subito, senza aspettare nuovi solleciti
- non negoziare direttamente con i creditori senza strategia
- proteggere fornizioni e componenti critici
- ristrutturare i debiti prima dell’avvio di pignoramenti
- identificare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare la liquidità per garantire consegne e installazioni
Così puoi evitare ritardi, penali e perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo se:
- hai ricevuto solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS o fornitori stanno crescendo
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità si sta riducendo rapidamente
- hai difficoltà a rispettare scadenze e pagamenti
- vuoi impedire che la crisi evolva in chiusura
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua azienda.
Attenzione
Molte aziende del settore pneumatico e oleodinamico non falliscono per i debiti, ma per aver aspettato troppo prima di intervenire. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, proteggendo davvero la tua impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in debiti aziendali e difesa di imprese meccaniche e industriali – ti aiuta a mettere in sicurezza la tua azienda di sistemi di lubrificazione aria.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare subito le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Un’azienda specializzata in sistemi di lubrificazione ad aria che si trova gravata da debiti può trovarsi in una situazione critica: creditori che reclamano pagamenti, potenziali azioni legali, rischio di insolvenza e conseguenze sul prosieguo dell’attività. In Italia esiste un articolato complesso normativo – aggiornato ad ottobre 2025 – pensato per gestire la crisi d’impresa, bilanciando la tutela dei creditori con la possibilità di risanamento per il debitore. Questa guida, destinata ad avvocati, imprenditori e privati con buona conoscenza giuridica, offre un’analisi approfondita e aggiornata delle strategie difensive e delle soluzioni legali a disposizione di un’azienda debitrice. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico (normativa italiana, sentenze, prassi) ma divulgativo, così da rendere accessibili temi complessi anche ai non addetti ai lavori. Ogni affermazione rilevante è corredata dai riferimenti normativi (codici, leggi speciali) e giurisprudenziali più recenti (fino al 2025), raccolti nella bibliografia conclusiva, per garantire autorevolezza e verificabilità delle informazioni.
Struttura della guida: dapprima esamineremo le tipologie di debiti che un’azienda può accumulare (fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, ecc.) e i rischi legali correlati a ciascuna categoria. Seguirà la trattazione delle azioni che i creditori possono intraprendere (dai decreti ingiuntivi ai pignoramenti) e delle relative difese a disposizione del debitore. Approfondiremo quindi gli strumenti di gestione della crisi d’impresa offerti dall’ordinamento: soluzioni stragiudiziali e procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – come riformato fino al 2024 – tra cui accordi di ristrutturazione, concordati preventivi (anche “semplificati”) e liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”). Ci soffermeremo anche sulle responsabilità degli amministratori e sulle differenze tra imprese individuali e società di capitali dal punto di vista della responsabilità patrimoniale.
La guida include tabelle riepilogative per sintetizzare concetti chiave (ad es. prescrizioni, soglie di allerta, differenze tra strumenti), simulazioni pratiche di casi realistici e una sezione di domande frequenti (FAQ) con risposte chiare ai dubbi più comuni. L’obiettivo è fornire una mappa completa su cosa fare per difendersi quando un’azienda ha debiti: dalle cautele operative quotidiane alle strategie legali difensive in giudizio, fino ai piani di risanamento o alle vie d’uscita in caso di insolvenza conclamata. Il punto di vista adottato è quello del debitore: come può l’imprenditore proteggere l’impresa, il proprio patrimonio e la continuità aziendale, nel rispetto della legge e anticipando le mosse dei creditori. Inizia dunque questo percorso guidato nella crisi d’impresa, con un’attenzione particolare alle ultime novità normative (decreti correttivi del 2022 e 2024, riforma fiscale 2023-2024 in tema di riscossione, ecc.) e alle più recenti sentenze di merito e di legittimità che delineano la materia al 2025.
Tipologie di debiti aziendali e rischi correlati
Una prima distinzione fondamentale riguarda la natura dei debiti contratti da un’azienda, poiché ciascuna categoria di credito segue regole e procedure differenti. In questa sezione analizziamo le principali tipologie di debiti che una società di capitali o un’impresa individuale può avere – debiti fiscali, debiti previdenziali, debiti finanziari verso banche, debiti verso fornitori e altri creditori privati – evidenziando per ognuna i rischi legali specifici e le possibili conseguenze per l’azienda debitrice. Comprendere le caratteristiche di ogni categoria di debito è essenziale per attuare efficaci strategie difensive e di gestione del passivo.
Debiti fiscali (Erario)
I debiti fiscali includono imposte e tributi dovuti all’Erario: ad esempio IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su stipendi e compensi (che il datore di lavoro trattiene e deve versare) e altre imposte dirette o indirette. Questi debiti sorgono tipicamente per insufficiente versamento di imposte dichiarate, per avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o per liquidazioni periodiche (specie nel caso dell’IVA). I debiti fiscali sono soggetti a sanzioni amministrative e interessi in caso di pagamento tardivo o omesso, che fanno lievitare l’importo dovuto. Inoltre, per importi rilevanti, l’omesso versamento di talune imposte può configurare reati tributari (si pensi all’IVA o alle ritenute non versate oltre soglie di punibilità). Approfondiremo più avanti le conseguenze penali, ma basti qui notare che, ad esempio, non versare IVA per importi superiori a determinate soglie annuali costituisce reato punito con la reclusione (ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) .
Dal punto di vista amministrativo, la riscossione dei debiti fiscali è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) (ex Equitalia). Quando un’impresa non paga volontariamente un’imposta dovuta (ad es. IVA dichiarata ma non versata, o somme risultanti da controllo formale), il debito fiscale viene iscritto a ruolo e AER emette la cartella esattoriale (o cartella di pagamento). La cartella esattoriale è l’atto con cui l’Agente della Riscossione intima formalmente il pagamento entro un termine (di norma 60 giorni) di un credito tributario o previdenziale iscritto a ruolo . Deve contenere i dettagli del contribuente, degli importi (imposta, interessi, sanzioni, aggio) e degli enti creditori, oltre alle istruzioni di pagamento . La cartella va notificata secondo legge (PEC, raccomandata o messo notificatore) e, in mancanza di regolare notifica, il debitore potrà contestarla: una cartella non notificata correttamente non può produrre effetti esecutivi .
Trascorso inutilmente il termine di pagamento, o in assenza di accordi (come piani di rateazione) nel frattempo, l’Agenzia Entrate-Riscossione può attivare misure cautelari ed esecutive sul patrimonio dell’azienda debitrice. Le principali azioni esecutive di AER includono :
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (ad es. il fermo del veicolo aziendale): è un provvedimento che blocca la possibilità di utilizzare e vendere il mezzo, iscritto al PRA, finché il debito non è saldato.
- Ipoteca legale su beni immobili di proprietà del debitore: AER può iscrivere ipoteca per tutelare il credito, generalmente previa comunicazione di preavviso. L’ipoteca può essere iscritta per debiti sopra una certa soglia (es. oltre 20.000€) e costituisce prelazione su eventuale vendita forzata.
- Pignoramento presso terzi di crediti del debitore: tipicamente il pignoramento del conto corrente aziendale oppure il pignoramento di crediti verso clienti. AER notifica l’atto al debitore e al terzo (banca o cliente) intimando a quest’ultimo di non pagare il debitore ma di versare a AER fino a concorrenza del debito. Può anche pignorare stipendi o pensioni dovuti al debitore, entro i limiti di impignorabilità previsti dal Codice di procedura civile .
- Pignoramento immobiliare: è la procedura di espropriazione forzata sugli immobili del debitore, con successiva vendita all’asta. Importante: per legge l’Agenzia della Riscossione non può pignorare la “prima casa” del debitore se si tratta dell’unico immobile ad uso abitativo di proprietà, nel quale il debitore risiede anagraficamente, e purché non classificato di lusso (art. 76, co.1, lett. a, DPR 602/1973) . Questo vincolo – introdotto dal 2013 – tutela l’abitazione principale della persona fisica imprenditore. Tale limite però non si applica se l’immobile non è prima casa, se il debitore ha più case, o per i creditori privati (banche, fornitori) che invece possono pignorare anche l’abitazione principale in mancanza di pagamento (vedremo oltre le differenze). Inoltre, l’esproprio immobiliare pubblico è possibile se il debito fiscale supera 120.000 € e l’immobile non è prima casa .
Prima di avviare il pignoramento, AER invia quasi sempre un’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973: si tratta di un ulteriore avviso al debitore, notificato quando la cartella è scaduta da oltre 60 giorni e preannunciante che, se non paga entro 5 giorni, inizieranno le azioni esecutive . L’intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla notifica se nel frattempo non viene iniziata esecuzione. Se l’intimazione manca o è irregolare, anche il successivo pignoramento può essere contestato per nullità (vedremo più avanti le difese possibili).
Prescrizione dei debiti fiscali: i tributi non pagati non restano esigibili indefinitamente; ciascun tipo di imposta è soggetto a termini di prescrizione (estinzione del diritto di credito per mancato esercizio entro un certo periodo) differenti. In generale, i debiti tributari erariali (imposte statali) si prescrivono in 10 anni, mentre altri tributi locali o contributi si prescrivono in 5 anni, salvo atti interruttivi . La tabella seguente riassume i principali termini di prescrizione:
| Tipo di debito fiscale o contributivo | Termine di prescrizione |
|---|---|
| Imposte erariali (IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ecc.) | 10 anni (salvo interruzioni) |
| Contributi previdenziali INPS | 5 anni (10 anni se da cartella notificata prima del 2016) |
| Tasse locali (IMU, TARI, ecc.) | 5 anni |
| Sanzioni amministrative (es. multe stradali) | 5 anni |
Nota: un atto di riscossione validamente notificato interrompe la prescrizione, facendola decorrere nuovamente da capo . Ad esempio, la notifica di una cartella o di un intimazione interrompe i termini. Ciò rende fondamentale verificare se il Fisco abbia notificato atti recenti: se un debito fiscale appare “antico” ma è stato oggetto di atti interruttivi, la prescrizione potrebbe non essersi compiuta. Viceversa, se per molti anni il Fisco non ha notificato nulla, il debitore può eccepire l’estinzione del debito per prescrizione (è una delle difese tipiche, come vedremo).
Inoltre, dall’estate 2022 il legislatore ha introdotto un meccanismo di allerta precoce per debiti fiscali non pagati: l’art. 25-novies del Codice della Crisi d’Impresa obbliga l’Agenzia delle Entrate a inviare una segnalazione formale all’imprenditore (e all’organo di controllo societario, se esiste) quando rileva debiti IVA significativi non versati . In particolare, se l’impresa non versa l’IVA dovuta risultante dalle comunicazioni periodiche per un importo superiore a €5.000 che sia anche maggiore del 10% del volume d’affari annuale, oppure comunque se vi è un debito IVA scaduto > €20.000, l’Agenzia deve segnalare il caso al debitore invitandolo a prendere provvedimenti (ad es. accedere a una procedura di composizione negoziata) . Analoghe soglie di allerta riguardano i debiti affidati ad AER: se un’azienda ha cartelle esattoriali scadute da oltre 90 giorni per importi superiori a €100.000 (imprenditore individuale), €200.000 (società di persone) o €500.000 (società di capitali), l’Agenzia Riscossione deve inviare una segnalazione ai sensi dell’art. 25-novies CCII . Questi avvisi sono pensati per favorire un’emersione tempestiva della crisi: non sono di per sé azioni esecutive, ma costituiscono un campanello d’allarme importante. Dal punto di vista del debitore, ricevere tali comunicazioni significa che la propria esposizione debitoria ha superato livelli di guardia fissati dalla legge e che occorre agire rapidamente (in autonomia o tramite procedure di crisi) per evitare l’aggravarsi della situazione o l’iniziativa giudiziale dei creditori pubblici. In alcuni casi, se l’azienda ignora l’allerta e la crisi peggiora, l’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) potrà intervenire e, nei casi estremi, si potrà arrivare all’istanza di liquidazione giudiziale d’ufficio (fallimento) promossa dal Pubblico Ministero su segnalazione dei creditori pubblici qualificati .
Rischi per l’azienda debitrice (debiti fiscali): oltre alle azioni esecutive (ipoteche, pignoramenti) già menzionate, i debiti tributari comportano ulteriori conseguenze: ad esempio, l’impresa con rilevanti debiti fiscali pendenti non potrà ottenere un DURC fiscale (documento unico di regolarità contributiva-fiscale) regolare se non intraprende misure di regolarizzazione. Senza DURC, l’azienda rischia di essere esclusa da appalti pubblici, di non poter incassare pagamenti da enti pubblici o General Contractor, e di perdere benefici o agevolazioni . Fortunatamente, come vedremo, esistono modi per ottenere un DURC pur avendo debiti, ad esempio tramite la rateizzazione, le definizioni agevolate o l’adesione a procedure concorsuali . Inoltre, un grave indebitamento fiscale può attivare le suddette procedure di allerta e dare luogo a responsabilità personali degli amministratori se questi non agiscono diligentemente: la legge impone agli organi di gestione di attivarsi per adottare misure idonee a evitare la crisi (art. 2086 c.c., riformulato nel 2019) e, in caso di insolvenza, di preservare il patrimonio sociale. Ignorare imposte non pagate per periodi prolungati, continuando l’attività in perdita, può costituire violazione dei doveri gestori, come riconosciuto anche da recenti pronunce (Cass. civ. n. 6893/2023) di cui diremo meglio più avanti.
Come vedremo dettagliatamente oltre, il quadro normativo attuale offre strumenti di difesa e di soluzione per i debiti fiscali, tra cui: il ricorso in Commissione Tributaria per contestare debiti non dovuti; l’istanza di rateizzazione fino a 120 rate per diluire il pagamento ; le procedure di “rottamazione” o definizione agevolata (se previste da leggi speciali, come la recente rottamazione-quater del 2023) che permettono di pagare le imposte senza sanzioni e interessi ; e, in sede concorsuale, la transazione fiscale, ossia un accordo da inserire in piani di ristrutturazione o concordati per pagare in parte o a rate i debiti tributari, accordo che oggi – dopo le riforme 2022-2024 – può essere omologato anche senza il voto favorevole del Fisco, tramite meccanismi di cram-down giudiziale . Ma prima di esplorare le soluzioni, completiamo la panoramica delle tipologie di debito.
Debiti previdenziali (INPS, INAIL)
Accanto ai debiti fiscali, molte imprese accumulano debiti previdenziali, ossia somme dovute agli enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, Casse professionali) per contributi obbligatori e premi assicurativi. Ad esempio: contributi pensionistici e assistenziali dovuti dall’azienda per i dipendenti o per i titolari (gestione IVS artigiani/commercianti), contributi e premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ecc. Come i debiti tributari, anche i debiti verso INPS e INAIL maturano sanzioni civili (interessi e sanzioni per omesso versamento) e seguono procedure di riscossione analoghe: l’INPS emette tipicamente avvisi di addebito immediatamente esecutivi (che hanno valore di titolo esecutivo come le cartelle) o iscrive i crediti a ruolo affinché l’Agenzia Riscossione emetta cartelle esattoriali. Dunque, un debito contributivo non pagato può sfociare nella notifica di una cartella INPS o di un avviso di addebito e, anche qui, se non si paga, l’Agenzia Entrate-Riscossione procederà con fermi, ipoteche, pignoramenti come descritto sopra per i debiti fiscali (valgono le stesse tutele e limiti, ad esempio l’impignorabilità della prima casa per debiti iscritti a ruolo anche INPS).
I termini di prescrizione per i contributi previdenziali sono generalmente di 5 anni, salvo eccezioni . Vale quanto detto sulla possibilità di interruzione della prescrizione tramite notifiche di atti (una diffida di pagamento INPS o un avviso di addebito interrompono e fanno decorrere un nuovo termine di 5 anni). Attenzione: in passato (fino al 2018) la prescrizione dei contributi INPS era decennale in alcuni casi, ma interventi normativi hanno uniformato a 5 anni la maggior parte delle contribuzioni, tranne i contributi oggetto di cartelle già notificate entro fine 2015 che restano decennali .
Conseguenze specifiche: un’impresa con debiti contributivi può incorrere nella revoca del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il DURC attesta l’assenza di irregolarità nei versamenti a INPS, INAIL e Casse edili, e viene richiesto per lavori pubblici, benefici normativi o contributivi, e pagamenti di appalti. Se un’azienda ha anche solo sanzioni o interessi non pagati oltre una certa soglia, il DURC risulterà irregolare, impedendo di fatto all’impresa di operare in settori regolamentati (ad es. partecipare a gare) . Il Ministero del Lavoro ha chiarito che basta un debito anche solo di accessori (sanzioni) sopra €150 per negare il DURC , salvo che l’impresa abbia avviato una regolarizzazione. Come può l’azienda difendersi? Le opzioni principali sono: chiedere una rateizzazione dei debiti INPS/INAIL (anche qui fino a 72 o 120 rate nei casi di grave difficoltà, analogamente alle regole fiscali), oppure aderire a una definizione agevolata se prevista (ad es. la rottamazione cartelle include i contributi), oppure ancora attivare una procedura concorsuale che, come vedremo, consente di bloccare temporaneamente le azioni esecutive e di proporre il pagamento parziale dei contributi mediante transazione previdenziale inserita in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione . Importante: dal 2024, il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha espressamente previsto la transazione contributiva nei piani di ristrutturazione, accordi e concordati, analogamente a quella fiscale, rendendo possibile proporre il pagamento parziale/dilazionato di contributi anche agli enti previdenziali (prima ciò era meno chiaro ed avveniva per prassi). Dunque l’azienda in crisi ha ora strumenti più efficaci per trattare con l’INPS: si pensi che in un concordato preventivo i contributi dei dipendenti sono crediti privilegiati, ma con la transazione l’INPS può accettare di ricevere ad esempio il 80% o il 50% del dovuto se questo consente di salvare l’impresa.
Anche per i debiti contributivi il Codice della Crisi prevede soglie di allerta: l’INPS deve segnalare se un’impresa ritarda di oltre 90 giorni i versamenti e l’importo scaduto supera il 30% di quanto dovuto in un anno e contemporaneamente eccede €15.000 (se l’azienda ha dipendenti) o se supera €5.000 (se l’azienda non ha dipendenti) . L’INAIL segnala debiti di premi non pagati > €5.000 per oltre 90 giorni . Tali segnalazioni, come quelle fiscali, mettono in mora l’imprenditore circa la necessità di attivarsi. Se ignorate, l’azienda rischia che la situazione degeneri sino al coinvolgimento dell’OCRI e all’eventuale apertura d’ufficio di procedure concorsuali.
Rischi penali specifici: da un punto di vista penale, vale la pena menzionare che l’omesso versamento di ritenute previdenziali (i contributi trattenuti al lavoratore in busta paga) oltre una certa soglia è reato (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). Attualmente la soglia è modesta (poche migliaia di euro per periodo): se l’azienda non versa ai fondi pensionistici le quote trattenute ai dipendenti entro il termine (di norma il 16 del mese successivo), e l’omissione supera ad esempio €10.000 annui, l’amministratore rischia una sanzione penale (contravvenzione). Questo per sottolineare che, specie in SRL piccole, il confine tra debito civile e illecito penale può essere superato quando si omettono contributi dei lavoratori o imposte dovute per legge. Un imprenditore debitore deve esserne consapevole e, se necessario, privilegiare il pagamento di queste poste “sensibili” per evitare guai giudiziari personali, oppure ricorrere subito a strumenti (come la rateazione) che, se attivati prima di certi termini, possono escludere la punibilità (per i reati tributari, ad esempio, il D.Lgs. 74/2000 prevede cause di non punibilità se il debito viene saldato prima dell’apertura del dibattimento ).
In sintesi, debiti fiscali e previdenziali sono debiti verso creditori pubblici privilegiati, che comportano: riscossione coattiva mediante cartelle, possibili ipoteche/pignoramenti (con qualche tutela per i beni primari), allerta precoce tramite segnalazioni per evitare inerzie, impatto sul DURC e sull’operatività aziendale, e potenziali risvolti di responsabilità per gli amministratori (civile e penale). Nel prosieguo della guida vedremo come un’azienda può difendersi efficacemente su questo fronte: contestando gli atti viziati (ricorsi, opposizioni), sfruttando piani di rateazione (anche grazie alle recenti riforme sulla riscossione ), aderendo alle definizioni agevolate quando disponibili, e integrando il Fisco e l’INPS in eventuali piani di risanamento (tramite transazione fiscale e contributiva).
Di seguito, una tabella riepilogativa focalizzata sui debiti verso Enti pubblici e relative strategie di regolarizzazione:
| Debito verso Enti Pubblici | Azioni dell’Ente creditore | Strumenti difensivi/solutori per l’impresa |
|---|---|---|
| Agenzia Entrate (imposte) | Avvisi di accertamento; iscrizione a ruolo e cartelle; fermi, ipoteche, pignoramenti; segnalazione allerta se IVA > soglie. | Ricorso tributario se il tributo non dovuto; richiesta di rateizzazione (fino 120 rate) ; adesione a rottamazione/saldo e stralcio (se previsto) ; transazione fiscale in concordato/accordo . Sospensione amministrativa o giudiziale delle cartelle se vizi. |
| Agenzia Riscossione (ruoli) | Cartella di pagamento; intimazione; misure cautelari/esecutive (fermo, ipoteca, pignoramento); segnalazione allerta se ruoli > soglia (100k/200k/500k) . | Opposizione agli atti della riscossione per vizi (notifica, prescrizione) ; istanza di dilazione del ruolo ex art.19 DPR 602/73; istanza di sospensione per dilazione in corso; conversione del pignoramento (art.495 c.p.c.) depositando somme a garanzia. |
| INPS (contributi) | Avvisi di addebito immediatamente esecutivi; cartelle; fermi, ipoteche, pignoramenti tramite AER; segnalazione allerta se > €15.000 (dip.) o €5.000 (no dip.) . | Ricorso amministrativo/giudiziario (es. opposizione ad avviso in Tribunale) per contestare somme non dovute; domanda di rateizzazione piani INPS (72-120 rate) con “temporanea difficoltà”; adesione a definizione agevolata cartelle; transazione previdenziale in concordato/accordo; domanda di esonero sanzioni (nei casi di legge); richiesta DURC provvisorio in presenza di piano in corso . |
| INAIL (premi assicurativi) | Avvisi di addebito; cartelle; misure esecutive via AER; segnalazione allerta se > €5.000 . | Come per INPS: ricorsi per contestare premi non dovuti; rateazioni dirette con INAIL; inclusione del debito in procedure concorsuali (transazione contributiva); richiesta di DURC provvisorio se in regolarizzazione. |
(Dip. = con dipendenti. Le soglie INPS segnalazione: >30% contributi annui e >€15k se ci sono dipendenti; >€5k se senza dipendenti).
Debiti bancari e finanziari
Molte imprese contraggono debiti verso banche o altri intermediari finanziari, sotto forma di affidamenti di conto corrente, mutui, leasing, anticipazioni su crediti, emissione di obbligazioni o finanziamenti soci. Un’azienda di “sistemi di lubrificazione aria” potrebbe aver acceso, ad esempio, un mutuo bancario per acquistare macchinari, oppure utilizzare uno scoperto di conto o linee di credito per la liquidità. Quando l’impresa entra in difficoltà, spesso le linee bancarie vengono a scadenza o revocate, trasformandosi in crediti esigibili immediatamente. I debiti bancari presentano alcune peculiarità:
- In genere sono debiti chirografari o garantiti da pegno/ipoteca. Se è presente un’ipoteca (su un capannone aziendale) o un pegno (es. su titoli), la banca è un creditore garantito che, in caso di insolvenza, avrà prelazione sul ricavato di quei beni. Inoltre, frequentemente gli istituti di credito richiedono garanzie personali: i soci o l’amministratore possono aver firmato una fideiussione a garanzia del debito bancario. Questo implica che, se la società non paga, la banca può agire anche sul patrimonio personale dei garanti (ne parleremo nella sezione sulla responsabilità).
- Le banche tendono a reagire rapidamente allo stato di crisi: se l’azienda ritarda nei pagamenti, la banca può classificare il credito come in sofferenza e segnalare l’impresa alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (pregiudicandone l’accesso al credito). Inoltre, in base all’art. 25-decies CCII, la banca stessa ha un obbligo di segnalazione interna: deve avvisare gli organi di controllo dell’impresa se questa presenta sconfinamenti o inadempimenti gravi oltre 60 giorni rispetto ai fidi concessi . Ciò rientra nell’allerta esterna: la banca informa i sindaci/revisori dell’azienda che i conti sono scoperti, spingendo così l’impresa a prendere provvedimenti.
- Se il debitore non rimborsa, la banca può avviare un’azione legale per il recupero del credito. Spesso il rapporto bancario è documentato da contratti e da un estratto conto certificato ex art. 50 TUB: con questo la banca può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (provvisoria esecuzione) e poi procedere a pignorare beni. In presenza di mutui ipotecari impagati, l’istituto può attivare direttamente il pignoramento immobiliare sull’immobile ipotecato senza bisogno di decreto ingiuntivo, avendo già un titolo esecutivo (il contratto di mutuo con ipoteca iscritto funge da titolo se contiene clausole specifiche).
- Nel caso di leasing finanziario non pagato, la società di leasing può risolvere il contratto e riprendere il bene in leasing (ad es. un macchinario o veicolo), chiedendo contestualmente il pagamento dei canoni scaduti e di un’eventuale maxi-rata finale (dedotto il valore ricavato dalla ri-vendita del bene). Se il leasing è traslativo (bene destinato all’acquisto finale), la società di leasing potrà insinuarsi al passivo per la differenza tra il credito residuo e quanto recuperato dal bene. Da notare che la legge 124/2017 ha introdotto la possibilità di escutere beni in leasing in modo semplificato senza passare dal tribunale, attraverso la rinegoziazione ex art. 1 comma 136 L. 124/2017 o tramite la risoluzione stragiudiziale prevista dal contratto in linea col DLgs 14/2019 (che dedica norme al leasing nel fallimento).
- Interessi e usura: un aspetto difensivo peculiare nei debiti bancari è la possibile contestazione di clausole illegittime nei contratti di finanziamento. Talvolta le aziende, in difficoltà, possono riesaminare i rapporti bancari alla ricerca di anatocismo (interessi composti non leciti), commissioni non trasparenti o tassi di interesse effettivi che sfondano la soglia di usura. Se si ravvisano tali violazioni, il debitore può fare opposizione contestando parte del debito (ad esempio eccependo la nullità di interessi usurari ex art. 1815 c.c., o la non debenza di interessi anatocistici trimestrali se capitalizzati illegittimamente). La giurisprudenza ha prodotto sentenze altalenanti sul calcolo dell’usura nei conti correnti e mutui: un esame tecnico è spesso necessario. Questa strategia rientra nella difesa giudiziale: può ridurre l’ammontare dovuto se accolta, ma va condotta con perizia tecnica in sede di causa (ad esempio in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca).
Riepilogo rischi dei debiti finanziari: la banca può revocare i fidi e chiedere il rientro immediato, segnalando l’impresa come cattivo pagatore (Centrale Rischi); può avvalersi di titoli esecutivi privilegiati (ipoteche, pegni) per aggredire specifici beni; può coinvolgere eventuali fideiussori (escutendo le garanzie personali); e – aspetto spesso trascurato – può anch’essa contribuire a far emergere la crisi tramite comunicazioni all’impresa e all’OCRI (anche se, a differenza di Fisco e INPS, la banca non può far fallire direttamente l’azienda per mancato allerta: può però presentare istanza di fallimento come qualunque creditore se il credito è scaduto e l’impresa insolvente).
Strumenti difensivi e soluzioni (debiti bancari): dal punto di vista del debitore, è fondamentale giocare d’anticipo. Alcune linee di condotta:
– Rinegoziazione del debito: aprire un dialogo con la banca prima del default. Le banche, soprattutto se vedono che l’impresa sta affrontando la crisi con un piano, possono concordare un refinancing o una moratoria temporanea. Ad esempio, durante la pandemia COVID furono introdotte moratorie ex lege. Oggi, su base volontaria, si può chiedere la sospensione di quote capitale del mutuo per alcuni mesi, o l’allungamento del piano di ammortamento, ecc. Se ci sono più banche, un’opzione è il “accordo di ristrutturazione” ex art. 57 CCII (già art. 182-bis L.F.) coinvolgendo il ceto bancario: queste procedure le vedremo più avanti, ma anticipiamo che in un accordo di ristrutturazione dei debiti è possibile includere banche e intermediari, con il vantaggio – se si raggiunge l’adesione di almeno il 60% dei crediti – di ottenere l’omologazione che rende l’accordo vincolante anche per eventuali banche dissenzienti (e dal 2022 esistono accordi ad efficacia estesa che coinvolgono anche creditori non aderenti di certe categorie) .
– Opposizione legale: se la banca ha già agito giudizialmente (ad es. notificando un decreto ingiuntivo), l’azienda può proporre opposizione entro i termini, articolando difese di merito. Come accennato, possibili eccezioni includono il conteggio di interessi non dovuti, l’eccezione di usurarietà, la mancanza di trasparenza contrattuale (violazione normativa sulla trasparenza bancaria), o contestazioni sulla procedura (es. difetto di notifica, prescrizione di parte del credito – a volte gli interessi di vecchi conti correnti possono essere prescritti se la banca non ha inviato estratti conto regolari). Naturalmente queste difese richiedono perizia tecnica e spesso una CTU contabile, ma possono servire a guadagnare tempo e magari portare a una transazione col creditore finanziario a condizioni più favorevoli. – Garanzie personali: se vi sono fideiussioni rilasciate dai soci/amministratori, si può esaminare se tali schemi di garanzia siano nulli per violazione antitrust. La Banca d’Italia nel 2005 censurò lo schema ABI di fideiussione omnibus (clausole standardizzate) e la Cassazione ha confermato la nullità parziale di fideiussioni conformi a quel modello, per contrasto con la normativa sulla concorrenza (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 41994/2017). Dunque, un garante escusso potrebbe difendersi eccependo la nullità della fideiussione omnibus se coincide con quella vietata: in tal caso la banca perderebbe l’ulteriore diritto verso il patrimonio personale del fideiussore. Questa è una difesa indiretta dell’impresa (in realtà del socio debitore), ma rilevante. – Consolidamento debiti: l’impresa, prima di precipitare nell’insolvenza, può valutare di consolidare i debiti finanziari, magari ricorrendo a nuove garanzie. Ad esempio, se la società ha un patrimonio immobiliare libero, potrebbe offrire ipoteca a una banca per ottenere un nuovo finanziamento destinato a pagare i debiti più urgenti (fisco, dipendenti) e “prendere tempo” per il rilancio. Questa mossa va però ponderata: offrire garanzie su beni liberi potrebbe costituire un atto in frode ai creditori se poi si fallisce (perché si preferisce un creditore – la banca nuova – garantendolo rispetto agli altri). Occorre quindi farlo nell’ambito di un piano credibile di risanamento e possibilmente con il consenso degli altri creditori. In un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è tipico includere nuova finanza assistita da garanzie, in quanto tali atti sono esentati dall’azione revocatoria fallimentare . Approfondiremo i piani attestati più avanti.
Riassumendo, i debiti bancari vanno gestiti con approccio negoziale proattivo, ma tenendo pronte difese giudiziarie se la banca adotta una linea dura. Una buona strategia è quella di coinvolgere le banche nel processo di risanamento: il Codice della Crisi promuove esplicitamente la continuità aziendale e l’accordo coi creditori finanziari. Ad esempio, nella composizione negoziata l’esperto potrà aiutare a mediare con le banche per rinegoziare condizioni o ottenere nuova finanza ponte. Va segnalato un recente importante sviluppo giurisprudenziale: la Cassazione n. 30109/2025 ha riconosciuto che l’adesione a una procedura di composizione negoziata può proteggere l’azienda anche sul piano cautelare: in un caso affrontato, la Suprema Corte ha ritenuto che un’impresa in composizione negoziata, con un piano in corso e la relazione positiva dell’esperto, offrisse garanzie tali da escludere o limitare il “periculum in mora” richiesto per misure cautelari a tutela dei creditori . In pratica, l’essere formalmente impegnati in un negoziato di risanamento è stato visto come uno scudo che rende meno urgente e giustificato un sequestro conservativo richiesto da una banca creditrice. Questa pronuncia incoraggia l’utilizzo degli strumenti di composizione della crisi anche come strategia difensiva verso i creditori finanziari aggressivi.
Debiti verso fornitori e altri creditori
Un’ulteriore categoria cruciale di debiti per l’azienda è quella verso i fornitori di beni e servizi e altri creditori contrattuali (es. locatori, consulenti, ecc.). Questi debiti commerciali spesso costituiscono la parte prevalente dell’indebitamento di un’impresa manifatturiera o di servizi. Ad esempio, la nostra ipotetica azienda di sistemi di lubrificazione aria potrebbe avere debiti verso i fornitori di materie prime, componentistica, società di trasporti, fornitori di energia elettrica, etc. Si tratta di debiti chirografari (non assistiti da garanzie reali, salvo eventuali patti di riserva di proprietà o similari) e, in caso di insolvenza, questi creditori sono tipicamente in coda per il pagamento.
Azioni tipiche dei fornitori-creditori: il fornitore insoddisfatto può in primo luogo sospendere ulteriori forniture (in base all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., se previsto pagamento a termine non rispettato). Molti contratti commerciali contengono clausole di solve et repete o di decadenza dal beneficio del termine, che permettono al creditore di esigere subito tutti gli importi se il debitore ritarda anche una rata. Sul piano giudiziale, il fornitore solitamente:
- Si procura un decreto ingiuntivo dal tribunale competente, basato su fatture non pagate, DDT firmati o altri documenti probanti il credito liquido ed esigibile. Il decreto ingiuntivo (monitorio) è un provvedimento sommario emesso inaudita altera parte che ingiunge all’azienda debitrice di pagare entro 40 giorni (o 10 giorni se provvisoriamente esecutivo), salvo opposizione. Approfondiremo a breve il funzionamento del decreto ingiuntivo e dell’opposizione, data la loro importanza nelle dinamiche creditore-debitore.
- Se il debitore non si oppone in tempo utile o comunque non paga, il fornitore, munito di titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo reso esecutivo), può procedere al pignoramento dei beni aziendali o dei crediti dell’azienda (ad esempio pignorare un macchinario, oppure pignorare il credito dell’azienda verso un suo cliente). Diversamente dai creditori pubblici, il creditore privato può pignorare anche beni come l’immobile abitativo del titolare (se si tratta di un’impresa individuale) o altri beni non strettamente legati all’attività. Non esiste infatti una norma generale che vieti di pignorare la prima casa per i creditori privati (il divieto visto prima riguarda solo l’Agente pubblico per debiti fiscali). Quindi, un fornitore potrebbe pignorare l’immobile di proprietà della società (se è una società di persone, i soci illimitatamente responsabili; se è una SRL, i beni intestati alla SRL; ma se i soci hanno prestato garanzie, anche beni dei soci fideiussori).
- In alcuni casi particolari, fornitori possono vantare privilegi speciali: es., l’art. 2756 c.c. dà privilegio al credito del meccanico sui veicoli riparati, o il creditore che ha venduto un macchinario con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.) può esercitare la rivendica del bene se il compratore fallisce . Nel contesto di un’azienda debitrice, ciò significa che se la società ha acquistato beni con patto di riservato dominio (pagamento rateale, proprietà al fornitore fino all’ultima rata), quel fornitore potrà riprendersi i beni in caso di insolvenza del compratore, o pretendere comunque il pagamento integrale per trasferire la proprietà. Queste situazioni non sono la norma, ma vanno segnalate come possibili vantaggi di alcuni creditori rispetto ad altri.
Difendersi dai creditori commerciali: dal punto di vista dell’impresa debitrice, i fornitori sono spesso creditori “diffusi” e meno organizzati del Fisco o delle banche, ma ciascuno può comunque attivare iniziative legali per il recupero. Alcune strategie difensive:
- Negoziazione e piani di rientro informali: spesso la via più efficace è trattare direttamente con i fornitori, soprattutto quelli strategici per la continuità aziendale. Un fornitore preferisce solitamente evitare di mettere in crisi definitiva un cliente (per non perdere futuro fatturato). Dunque si può proporre un piano di rientro dilazionato extra-giudiziale: ad esempio, pagare il 50% subito e il resto in 6 mesi, oppure consegnare cambiali per dare assicurazione di pagamento. Questi accordi è bene formalizzarli per iscritto, così da avere un impegno chiaro e magari ottenere la rinuncia del fornitore a intraprendere azioni esecutive finché il piano è rispettato. Attenzione però: una rinuncia preventiva all’azione esecutiva non è valida se generale, ma si può pattuire contrattualmente una moratoria. Inoltre, se l’azienda poi entra in procedura concorsuale, pagamenti preferenziali a fornitori potrebbero essere oggetto di revocatoria: tuttavia, come vedremo, nel Codice della Crisi vi sono esenzioni di revocabilità per pagamenti effettuati in esecuzione di piani attestati o accordi omologati .
- Contestare il credito: se vi sono motivi sostanziali, l’azienda può contestare ai fornitori l’esistenza o l’entità del debito. Ad esempio, se merci consegnate erano difettose, o se ci sono discrepanze quantitative, l’impresa può sollevare eccezioni di inadempimento o chiedere compensazioni. In giudizio, ciò si traduce in un’opposizione al decreto ingiuntivo in cui il debitore deduce che nulla (o meno) è dovuto per ragioni contrattuali: difetti della fornitura, ritardi, danni subiti, ecc. Addirittura, si potrebbe proporre domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento di danni, da compensare col credito (se l’opposizione al decreto ingiuntivo è avviata, il giudizio diviene a cognizione piena e il debitore-opponente può assumere il ruolo sostanziale di attore su alcune eccezioni ).
- Opposizione e allungamento dei tempi: anche quando il debito è sostanzialmente dovuto, proporre opposizione può servire a guadagnare tempo. L’opposizione a decreto ingiuntivo sospende l’efficacia esecutiva del decreto solo se il giudice, con ordinanza ex art. 649 c.p.c., concede la sospensione . In mancanza, il decreto può essere provvisoriamente eseguito, ma l’opponente può chiedere la sospensione dell’esecuzione forzata. In ogni caso, il giudizio di opposizione può durare mesi o anni, specialmente se complesso, e questo può dare spazio all’impresa per organizzare un piano di ristrutturazione generale. Certo, c’è il rischio di aggravio di spese legali se poi si perde la causa, ma quando la sopravvivenza aziendale è in gioco, dilazionare i pagamenti è spesso vitale. Inoltre, se l’impresa durante quel tempo attiva un concordato preventivo, l’opposizione potrebbe confluire nella procedura concorsuale e il credito contestato verrà vagliato in sede di verifica dello stato passivo.
- Concordato preventivo o accordo anche per i chirografari: i fornitori chirografari, in caso di concordato preventivo, saranno tipicamente la classe più numerosa e dovranno votare il piano. L’azienda indebitata può decidere di utilizzare il concordato per imporre ai fornitori un pagamento parziale e dilazionato (es: 20% in 2 anni) evitando di pagare integralmente tutti. Questa è una soluzione concorsuale di cui diremo più avanti. Tuttavia, quando possibile, è preferibile trovare soluzioni concordate bilateralmente: a volte offrire una piccola percentuale immediata a saldo e stralcio convince il fornitore a chiudere la partita e continuare il rapporto commerciale.
Altri debiti residui: potremmo ricomprendere in questo paragrafo anche altre passività come debiti verso il fisco locale (es. Tari comunale, che rientra nei debiti fiscali di cui sopra, o canoni verso enti pubblici), debiti verso i dipendenti (stipendi e TFR non pagati). Questi ultimi hanno un trattamento peculiare: i lavoratori dipendenti vantano un privilegio generale mobiliare sui beni mobili dell’azienda per le retribuzioni degli ultimi mesi e TFR, nonché un privilegio immobiliare sui beni dell’impresa (in parte). In caso di procedura concorsuale, i loro crediti vengono soddisfatti prima di quelli chirografari. Inoltre, esiste il Fondo di garanzia INPS che in caso di insolvenza dell’azienda interviene a pagare TFR e ultime mensilità ai lavoratori (surrogandosi poi nei loro crediti). Dal punto di vista “difensivo” del debitore, i debiti verso dipendenti sono meno aggressivi nel breve termine (difficilmente un dipendente attiva un’azione esecutiva complessa, anche se può farlo; più frequente è che faccia dimissioni per giusta causa e ottenga la NASpI). Tuttavia, per l’imprenditore morale e giuridicamente prudente, questi debiti andrebbero prioritariamente saldati o gestiti, sia per mantenere la forza lavoro, sia per evitare l’accumulo di morale aziendale negativo e responsabilità (non pagare stipendi integra reato solo se si configura come sfruttamento – molto raro; ma può rilevare come inadempienza contrattuale grave). In un concordato, comunque, i dipendenti devono essere soddisfatti almeno parzialmente entro tempi brevi (la legge ora consente dilazioni massime di 6 mesi per i crediti di lavoro nel concordato in continuità ).
Con i debiti verso locatori (affitti di capannoni non pagati) il padrone di casa può sfrattare per morosità l’azienda, ottenendo un titolo esecutivo per rilascio e per i canoni dovuti. L’azienda può opporsi solo pagando il dovuto (sanando la morosità entro i termini di grazia se concessi dal giudice). Anche qui, la procedura concorsuale sospende eventuali sfratti in corso? In verità, l’apertura di un concordato o liquidazione non sospende di diritto lo sfratto (che riguarda un diritto del locatore), ma il locatore diventa creditore concorsuale per i canoni scaduti. L’impresa può cercare di pagare i canoni correnti prededucibili per non perdere l’immobile fondamentale. La gestione di questi aspetti è delicata e rientra nelle scelte di continuità aziendale.
Dopo questo esame delle tipologie di debito, appare chiaro come l’azienda debitrice si trovi al centro di una rete di pretese eterogenee: Fisco/INPS con poteri pubblicistici, banche con garanzie e strumenti contrattuali forti, fornitori con crediti commerciali diffusi ma indispensabili alla produzione, dipendenti con tutele sociali e privilegio morale. La chiave per difendersi è innanzitutto conoscere le regole del gioco di ciascuno (prescrizioni, priorità, leve contrattuali) e poi adottare misure tempestive: che siano accordi stragiudiziali mirati, azioni legali dilatorie quando servono, o – se il debito complessivo è ingestibile – imboccare la strada di un piano di risanamento o di una procedura concorsuale che risolva in modo ordinato la crisi.
Nel prossimo capitolo, passeremo in rassegna proprio le azioni legali tipiche dei creditori (ingiunzioni, esecuzioni) e le difese processuali che l’ordinamento riconosce al debitore per proteggersi. Successivamente, introdurremo gli strumenti di composizione della crisi d’impresa (piani, accordi, concordati), che rappresentano la risposta sistemica e “proattiva” ai problemi di indebitamento.
Azioni dei creditori e difese del debitore
Quando i creditori iniziano a muoversi per recuperare i propri crediti, l’azienda debitrice deve conoscere come funzionano le azioni legali che può subire e quali strumenti di difesa può attivare in sede giudiziale. In questa sezione analizzeremo dapprima il procedimento monitorio del decreto ingiuntivo (lo strumento più comune con cui un creditore – tipicamente un fornitore o una banca – ottiene un titolo esecutivo in tempi rapidi) e l’opposizione a decreto ingiuntivo da parte del debitore. Successivamente, esamineremo le procedure esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi) e le possibili opposizioni e altri rimedi per il debitore esecutato. Accenneremo anche ad altri istituti utili come la conversione del pignoramento o la sospensione delle misure, per completare la panoramica difensiva. Tenendo presente che, all’avvio di un’eventuale procedura concorsuale (es. concordato preventivo), molte di queste azioni individuali vengono sospese per legge, l’azienda deve sapersi difendere soprattutto nella fase precedente all’accesso a strumenti di regolazione collettiva della crisi.
Decreto ingiuntivo e opposizione
Il decreto ingiuntivo è probabilmente lo strumento giudiziale di cui un debitore imprenditore fa prima o poi esperienza se non onora i propri debiti. Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice su ricorso di un creditore, senza udienza e senza contraddittorio iniziale (“inaudita altera parte”), con cui si ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro (o consegnare una cosa determinata) entro un certo termine . Per ottenerlo, il creditore deve provare il credito con prova scritta (fatture, contratti, cambiali, estratti autentici delle scritture contabili controfirmate dal debitore, etc.). Se la prova è ritenuta idonea, il giudice emette il decreto che viene notificato al debitore. Il contenuto tipico del decreto è: ingiunzione di pagamento di €X entro 40 giorni, con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, e che il debitore può proporre opposizione nei termini . In alcune circostanze il creditore può chiedere che il decreto sia provvisoriamente esecutivo, ossia efficace immediatamente senza attendere i 40 giorni: ciò è possibile se il credito deriva da cambiale, assegno, atto ricevuto da pubblico ufficiale, oppure se c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (art. 642 c.p.c.). Un esempio: la banca che produce estratto notarile di saldo debitore di conto corrente può ottenere un ingiuntivo esecutivo immediatamente. Altrimenti, se il decreto non ha la clausola di provvisoria esecutorietà, il creditore dovrà attendere i 40 giorni per poter iniziare il pignoramento, e solo se nel frattempo non è stata proposta opposizione (o se proposta, potrà chiedere al giudice un’esecutorietà in corso di causa ex art. 648 c.p.c., in presenza di alcune condizioni).
Dal lato del debitore ingiunto, la reazione possibile è l’opposizione a decreto ingiuntivo, da proporsi entro il termine perentorio indicato (40 giorni ordinari, estesi se la notifica è avvenuta all’estero, sospesi nel periodo feriale 1-31 agosto) . L’opposizione si propone di norma con atto di citazione (notificato al creditore che ha richiesto il decreto) davanti al tribunale che ha emesso il decreto. Con l’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena: il decreto ingiuntivo diventa l’atto introduttivo e il processo procede come una normale causa civile di primo grado . Il creditore originario assume la posizione sostanziale di attore (deve provare il suo credito in giudizio) e l’opponente diventa convenuto sostanziale, potendo però svolgere tutte le difese e domande riconvenzionali ammissibili . Lo scopo dell’opposizione è ottenere la revoca o modifica del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte.
Effetti dell’opposizione: l’opposizione in sé non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del decreto. Se il decreto non era provvisoriamente esecutivo, l’opposizione tempestiva impedisce che il decreto diventi definitivo (essendo ora “sub iudice”), ma se il creditore nel frattempo ha chiesto l’esecuzione forzata (capita raramente per decreti non esecutivi, perché dovrebbe aspettare 40 giorni più notifica), l’opposizione comunque la farebbe cessare qualora il decreto fosse non esecutivo per legge. Se invece il decreto era già esecutivo, l’opponente deve chiedere al giudice, con ricorso ex art. 649 c.p.c., la sospensione della sua efficacia, dimostrando gravi motivi . Il giudice può concedere o negare tale sospensione. Se la nega, il creditore può proseguire l’esecuzione durante il processo, salvo poi essere tenuto a restituire se perde la causa.
Prima udienza e rito: dal 2022 la riforma del processo civile ha introdotto un rito semplificato per le opposizioni a decreto ingiuntivo (in alternativa al rito ordinario) in alcuni casi, con ricorso e trattazione più celere . Ciò però attiene ai tecnicismi del procedimento; ciò che conta per l’imprenditore debitore è sapere che l’opposizione apre un confronto pieno nel merito. Tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante possono essere fatte valere. Ad esempio, se un fornitore ha ottenuto ingiunzione per merci fornite, l’impresa potrà eccepire che alcune forniture erano fuori specifica, o che esistono compensazioni (magari l’azienda vanta a sua volta un credito verso quel fornitore), o che il credito è parzialmente prescritto (fatture troppo vecchie oltre 5 anni per le forniture, se il giudice inquadra il rapporto come di fornitura periodica e non c’è riconoscimento di debito) – va ricordato infatti che il riconoscimento di debito interrompe la prescrizione (ad es., una richiesta di rateizzazione fatta dal debitore può valere come riconoscimento ex art. 1988 c.c., come di recente ricordato da Cass. n. 27504/2024 ). La sede dell’opposizione permette dunque di rimettere in discussione ciò che nel procedimento monitorio era stato accettato senza contraddittorio.
Strategie nell’opposizione: un debitore potrebbe usare l’opposizione anche solo per prendere tempo, ma deve comunque allegare motivi non manifestamente infondati per evitare una condanna temeraria. Ad esempio, contestare anche solo l’entità degli interessi o chiedere una consulenza sui conti può giustificare l’opposizione. Durante il giudizio, l’azienda può valutare un accordo transattivo con il creditore: sovente, l’opposizione porta le parti al tavolo negoziale (il creditore magari preferisce uno sconto piuttosto che anni di causa dall’esito incerto).
Da notare: se durante l’opposizione interviene la crisi generalizzata dell’azienda e questa accede a un concordato preventivo, il giudizio di opposizione rientrerà nella competenza del giudice delegato al fallimento/concordato per la verifica dei crediti (nel caso di fallimento) oppure proseguirà se il concordato è in continuità e il debitore conserva l’amministrazione. Comunque, l’apertura di concordato sospende le azioni esecutive individuali (lo vedremo), quindi anche se il creditore opposto avesse un decreto esecutivo, non potrebbe più procedere al pignoramento.
In sintesi, il decreto ingiuntivo è spesso la prima minaccia concreta che un imprenditore debitore riceve; l’opposizione è lo scudo immediato per bloccarne gli effetti e aprire una discussione di merito. Vediamo ora cosa accade quando si passa dalla fase monitoria alla fase esecutiva vera e propria (il pignoramento), e quali rimedi sono previsti.
Esecuzione forzata (pignoramenti) e opposizioni del debitore
Se un creditore è munito di titolo esecutivo definitivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto o divenuto esecutivo) e il debitore ancora non paga, si passa alla esecuzione forzata, disciplinata dal Codice di procedura civile. L’esecuzione consiste nel pignorare e vendere (o assegnare) i beni del debitore per soddisfare il credito col ricavato. Per l’azienda, i tipi di pignoramento rilevanti sono:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: l’ufficiale giudiziario si reca presso la sede aziendale e vincola i beni mobili presenti (macchinari, arredi, merci in magazzino, veicoli se trovati in loco). I beni pignorati verranno poi stimati e venduti all’asta. Spesso, tuttavia, il pignoramento mobiliare presso aziende ha esito limitato, perché i beni possono essere già dati in leasing (non di proprietà) o di valore modesto rispetto al credito. Inoltre, molti beni strumentali essenziali possono non trovare facile realizzo (chi compra un macchinario usato molto specifico?).
- Pignoramento immobiliare: se l’azienda possiede immobili (terreni, fabbricati) o se i soci garanti hanno immobili personali, il creditore iscrive eventualmente ipoteca giudiziale (dopo la sentenza) e notifica atto di pignoramento, trascrivendolo nei registri immobiliari. Segue la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Come già spiegato, per i creditori pubblici c’è il limite della “prima casa” non di lusso; per i privati non vi è tale esenzione: dunque l’abitazione dell’imprenditore individuale può essere pignorata dai creditori privati. Tuttavia, esistono soglie sotto le quali l’esecuzione immobiliare è antieconomica: spesso crediti sotto 20-30 mila euro non giustificano pignoramenti immobiliari per via dei costi. Ma per debiti più grandi, è una minaccia concreta.
- Pignoramento presso terzi: è il mezzo più usato contro le aziende. Consiste nel pignorare i crediti che il debitore vanta verso altri soggetti, soprattutto conti correnti bancari e crediti verso clienti. Il creditore notifica l’atto sia al debitore sia al “terzo” (banca o cliente): quest’ultimo è tenuto a dichiarare l’eventuale debito verso il nostro debitore, e in caso affermativo, quelle somme vengono vincolate a favore della procedura. Ad esempio, il pignoramento del conto corrente blocca le disponibilità fino a concorrenza del credito, costringendo l’azienda a operare senza quei fondi. Il pignoramento di crediti presso clienti (azioni di garnishment) può essere devastante perché il cliente, intimato dal tribunale, dovrà versare le somme dovute all’azienda direttamente all’ufficiale giudiziario invece che pagarle all’azienda stessa.
Opposizioni e difese in sede esecutiva: il debitore esecutato ha a disposizione essenzialmente due tipi di opposizione, regolate dagli artt. 615 e 617 c.p.c.:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione. Può essere proposta prima che l’esecuzione inizi (ad esempio per far valere fatti estintivi sopravvenuti dopo il titolo: pagamento effettuato, transazione raggiunta, prescrizione del titolo, etc.), oppure anche a esecuzione iniziata se i motivi sorgono dopo. Nell’opposizione all’esecuzione, il debitore può far valere che non si doveva proprio iniziare l’esecuzione. Esempi: il titolo esecutivo non è valido o è stato annullato; il credito è già stato pagato o compensato; il creditore procedente non ha più il diritto (magari per intervenuta prescrizione tra titolo e precetto). Un caso frequente per l’azienda: dopo il decreto ingiuntivo, passano più di 10 anni senza che il creditore agisca, il titolo cade in prescrizione e se quello poi notifica un precetto, l’azienda può fare opposizione ex art.615 evidenziando la prescrizione del titolo (Cass. civ. n. 19602/2019 ha confermato che la prescrizione del diritto di procedere esecutivamente è quinquennale per le sentenze, anche se il diritto sostanziale aveva prescrizione decennale). L’opposizione all’esecuzione si propone con atto di citazione al giudice competente (se l’esecuzione già iniziata, al giudice dell’esecuzione). Può portare alla sospensione dell’esecuzione se il giudice la concede (art. 624 c.p.c.).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contestazione di vizi formali della procedura o degli atti (il precetto, il pignoramento, gli avvisi). Ad esempio, il debitore può lamentare che il pignoramento è nullo perché notificato in modo invalido, o perché contiene errori (manca l’ingiunzione al debitore, non è rispettato l’art. 492 c.p.c.), oppure che il precetto è viziato (ad esempio, è stato notificato senza attendere i 10 giorni dopo il precetto precedente, violando il termine di efficacia, oppure la somma indicata è superiore a quanto previsto nel titolo). Queste opposizioni vanno proposte entro termini stringenti (di solito 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato) e anch’esse possono portare all’annullamento dell’atto e all’arresto della procedura se il giudice lo rileva.
Oltre alle opposizioni, il debitore in sede esecutiva ha alcune facoltà per attenuare gli effetti dell’esecuzione:
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al credito, spese e interessi. In pratica, “riscatta” i propri beni dal pignoramento depositando una somma (o prestando garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa). Il giudice, se autorizza, fissa la somma da versare. Il debitore versa subito almeno 1/5 e il resto può ottenerlo in max 18 rate mensili. Se completa i versamenti, i pignoramenti sui beni vengono revocati. Questa è una soluzione spesso salvavita per l’imprenditore che rischia di vedersi vendere macchinari o immobili: depositando gradualmente l’importo, evita la vendita forzata e guadagna tempo per reperire liquidità. Ad esempio, se un fornitore pignora un macchinario chiave valutato €100.000 per un debito di €80.000, l’azienda può proporre conversione: versa subito €16.000 (20%) e il resto €64.000 in 18 mesi (~€3.556 al mese). Se paga queste rate in tribunale, il macchinario non verrà venduto e alla fine il creditore sarà soddisfatto. È importante notare che la conversione è un diritto del debitore, salvo che sia già iniziata la vendita, e in tal caso serve accordo dei creditori per concederla.
- Riduzione o modifica del pignoramento: se il pignoramento riguarda più beni di valore eccessivo rispetto al credito, il debitore può chiedere la riduzione dell’espropriazione a una parte soltanto dei beni (art. 496 c.p.c.). Ad esempio, se hanno pignorato 3 immobili ma uno basterebbe, il debitore può chiedere di liberarne due. Questo per evitare espropriazioni inutilmente afflittive.
- Sospensione volontaria o revoca della procedura: un debitore in trattativa può convincere il creditore a sospendere l’esecuzione, magari concedendo una moratoria (il creditore può chiedere sospensione al GE). Inoltre, se il debitor deposita una domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione e chiede le misure protettive (art. 54 CCII), il tribunale può vietare o sospendere le azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative o fino all’omologazione . In caso di apertura di concordato preventivo, tutte le esecuzioni pendenti sono automaticamente sospese per legge (art. 168 L.F., ora art. 54 CCII), e in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) le esecuzioni in corso diventano inefficaci (art. 150 CCII). Quindi l’accesso a una procedura concorsuale formalmente “congela” il quadro delle esecuzioni – un potente incentivo per il debitore a ricorrervi se troppi creditori stanno pignorando.
Caso particolare – esecuzione fiscale: di fatto, l’Agenzia Entrate-Riscossione segue il suo iter (cartella, intimazione, pignoramento) che è assimilabile all’esecuzione forzata civile ma con alcune peculiarità (pignoramento presso terzi senza bisogno di autorizzazione del giudice, vendita affidata ai suoi concessionari, ecc.). Anche lì il debitore ha strumenti di opposizione: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere ad esempio la prescrizione del credito sottostante o la sospensione legale (in passato ci sono stati provvedimenti di sospensione COVID, ecc.), e l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell’atto di pignoramento o del precetto (che in ambito esattoriale è l’intimazione di pagamento). Inoltre, c’è uno strumento particolare nel processo tributario: la sospensione giudiziale della riscossione concessa dalle Commissioni Tributarie se è stato presentato ricorso e si paventa un danno grave. Un’azienda che ha impugnato un avviso di accertamento può chiedere al giudice tributario di sospendere la riscossione finché decide il merito. Se accordata, AER non può procedere.
Esdebitazione e limite dell’esecuzione individuale: va ricordato che se poi l’azienda o l’imprenditore viene dichiarato fallito/liquidato, i creditori devono presentare domanda di insinuazione nel passivo e non possono più agire individualmente. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, peraltro, l’imprenditore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) alle condizioni di legge . Questo però riguarda la fase successiva all’esecuzione collettiva e lo tratteremo in seguito.
In sintesi su pignoramenti: il pignoramento rappresenta il momento critico in cui il debitore rischia di perdere concretamente i propri beni. Le difese possono essere procedurali (opposizioni per bloccare l’azione se illegittima) o sostanziali (pagare parzialmente tramite conversione, accordarsi per sospendere). Un imprenditore ben consigliato deve valutare rapidamente: c’è un vizio che rende nulla l’azione? Il credito è già stato risolto o ridotto? Posso racimolare un quinto e fare conversione? Posso portare tutti a un tavolo con un concordato preventivo? Ogni caso ha la sua strategia ottimale. Nel dubbio, muoversi subito – perché i termini per opporsi sono brevi e una volta avvenuta la vendita all’asta, rimediare è quasi impossibile.
Responsabilità personali e tutele specifiche del debitore
Prima di passare alle procedure di risanamento e insolvenza, è importante che l’imprenditore comprenda come la legge distingue tra responsabilità della persona giuridica (la società) e responsabilità personali degli amministratori o dei soci, e quali sono le tutele patrimoniali di cui può godere. Dato che la domanda originaria della guida chiede espressamente il “punto di vista del debitore” e come difendersi, rientra in ciò anche proteggere il proprio patrimonio personale e prevenire azioni di responsabilità.
Impresa individuale vs Società di capitali: se la nostra azienda debitrice è un’impresa individuale (il classico “ditta individuale”), allora non c’è distinzione patrimoniale fra impresa e persona: il titolare risponde dei debiti dell’impresa con tutti i suoi beni presenti e futuri, illimitatamente. Ciò significa che il patrimonio personale dell’imprenditore (casa, conto bancario personale, auto, ecc.) può essere aggredito dai creditori dell’impresa. L’unica eccezione è su alcuni beni impignorabili di legge (es. attrezzi indispensabili per il mestiere in parte, letto e oggetti di casa, animali da affezione, ecc., ex art. 514-515 c.p.c.), ma per il resto il rischio è totale. L’imprenditore individuale, se in grave insolvenza, può essere assoggettato a liquidazione controllata (la procedura concorsuale per piccoli debitori nel Codice della Crisi, ex legge sul sovraindebitamento) oppure a liquidazione giudiziale (fallimento) se supera le soglie di fallibilità. In entrambe, tutti i beni personali vanno a soddisfare i creditori, salvo poi chiedere l’esdebitazione a fine procedura per liberarsi degli eventuali residui . La difesa per un imprenditore individuale sta dunque nel pianificare il proprio rischio: ad esempio, molti imprenditori mettono la casa di abitazione in testa al coniuge o in fondo patrimoniale – pratiche che però se fatte in prossimità della crisi possono essere revocate dal fallimento (atti a titolo gratuito entro 2 anni). Esistono strumenti leciti come il fondo patrimoniale o il trust per proteggere beni, ma devono essere costituiti in bonis e con finalità familiari reali, altrimenti rischiano anch’essi l’azione revocatoria se finalizzati a sottrarre garanzie ai creditori.
Nel caso di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), vige la responsabilità limitata: la società risponde con il proprio patrimonio, i soci non rischiano di perdere più di quanto investito (capitale sociale e eventuali finanziamenti soci). Quindi, i creditori sociali non possono aggredire direttamente i beni personali dei soci per soddisfarsi, né la casa dell’amministratore, ecc. Questa separatezza patrimoniale è un caposaldo, ma sono da considerare eccezioni e mitigazioni:
- Se i soci hanno prestato fideiussioni o garanzie personali (evento frequentissimo, specie nelle S.r.l. piccole: le banche spesso lo richiedono), allora per quel debito specifico il socio/garante è obbligato in solido col debitore principale. In tale caso la banca potrà, in caso di insolvenza della società, escutere direttamente il patrimonio del garante (pignorandogli casa, stipendio, ecc.). La difesa qui può essere – come detto – verificare la validità di quella fideiussione (possibile nullità antitrust) o transigere col creditore garantito per liberare la garanzia (magari pagando una parte).
- Gli amministratori e gli organi sociali della società di capitali possono incorrere in responsabilità civili verso la società, verso i creditori sociali o verso terzi, se commettono violazioni dei doveri. In una situazione di crisi, i principali rischi riguardano: la responsabilità per mala gestio (art. 2476 c.c. per Srl, art. 2392 ss. per Spa, nonché artt. 2485-2486 c.c. per gestione dopo perdita capitale). In parole semplici, se gli amministratori aggravano la situazione continuando l’attività in modo imprudente dopo che la società si sarebbe dovuta sciogliere, oppure distraggono risorse, oppure favoriscono indebitamente alcuni creditori (pagamenti preferenziali in danno di altri a ridosso del fallimento), possono essere chiamati a rispondere. Nel fallimento, il curatore ha l’azione di responsabilità ex art. 255 CCII (già art. 146 L.F.) verso amministratori e sindaci . Una volta accertata, il patrimonio personale dell’amministratore può essere aggredito per risarcire i danni causati. Ad esempio, Cassazione 22/4/2024 n.10739 ha ribadito che anche gli amministratori non esecutivi (consiglieri di amministrazione senza deleghe) possono essere chiamati a rispondere in solido con quelli operativi delle condotte illecite se sapevano o avrebbero dovuto accorgersi di segnali d’allarme e non sono intervenuti . Insomma, non basta essere passivi: se c’è dissesto, tutti gli amministratori devono attivarsi o dimettersi. La riforma del Codice della Crisi ha enfatizzato i doveri di attivazione: l’art. 3 CCII e soprattutto il nuovo art. 2086 c.c. impongono adeguati assetti per rilevare la crisi . Un amministratore che ignori i segnali di allerta (come le segnalazioni di INPS o Agenzia Entrate) e tiri avanti accumulando debiti potrebbe essere accusato di culpa in vigilando e violazione del dovere di conservazione del patrimonio sociale. La Cass. 6893/2023 ha chiarito che, dopo una causa di scioglimento (tipicamente la perdita integrale del capitale ex art. 2484 c.c.), gli atti di gestione non finalizzati alla conservazione dell’integrità patrimoniale espongono l’amministratore a responsabilità verso i creditori sociali . In pratica, dal momento in cui la società avrebbe dovuto liquidare, l’amministratore deve solo compiere atti “liquidatori”: se compie nuove operazioni (es: contrae altri debiti, vende sottocosto, paga alcuni a scapito di altri) e poi la società fallisce, i creditori potranno agire contro di lui per il pregiudizio subito. La legge (art. 2486 c.c., come modificato dall’art. 378 CCII) presume anche il danno: salvo prova contraria, si assume come danno l’aggravamento del dissesto o la differenza tra patrimonio netto a scioglimento e patrimonio a fallimento . Questo mette l’amministratore in una posizione delicatissima: deve provare che le operazioni compiute erano nell’ottica di salvare la società (fini liquidatori o conservativi), altrimenti risponde verso i creditori . Dunque, difendersi da questo tipo di rischio significa agire con prudenza e documentazione: quando l’impresa è in crisi conclamata, l’amministratore dovrebbe o attivare immediatamente gli strumenti di composizione negoziata o concorsuale, oppure limitarsi a atti conservativi strettamente necessari (ad es. completare lavori in corso per incassare crediti) e non creare nuovo indebitamento se non coperto da prospettive concrete di risanamento. Inoltre, una volta aperta una procedura concorsuale, può valutare di autodenunciarsi come cooperativo per ottenere eventualmente esdebitazione (se persona fisica) o comunque evitare accuse di bancarotta.
- Responsabilità penale degli amministratori: in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) emergono i noti reati di bancarotta (fraudolenta o semplice) per gli amministratori che abbiano distratto beni, falsificato scritture, aggravato il dissesto con operazioni imprudenti, fatto pagamenti preferenziali, ecc. L’ambito penale esula da questa guida, ma è un ulteriore profilo: per “difendersi” in senso lato, l’imprenditore deve evitare condotte che possano costituire reato fallimentare. È una sorta di difesa preventiva: ad esempio, non nascondere asset, non tenere due contabilità, non dissipare il patrimonio aziendale in attività sproporzionate. La bancarotta fraudolenta patrimoniale è molto severa e basta distrarre (cioè sottrarre alla società) anche un singolo bene rilevante per incorrervi. Anche la bancarotta preferenziale (pagare scientemente un creditore a scapito di altri in stato di insolvenza) è reato. Va però detto che se l’imprenditore agisce tramite concordato preventivo, tali condotte solitamente non integrano reato in caso di successivo fallimento: pagare un fornitore prima del concordato può essere giustificato se funzionale alla continuità aziendale, e comunque l’ammissione al concordato in bonis interrompe la punibilità di alcuni atti rispetto alla successiva dichiarazione di fallimento se il concordato non riesce. Comunque, queste considerazioni travalicano l’aspetto civile, ma devono restare sullo sfondo delle decisioni.
Amministratori di fatto e sindaci: nota bene, la responsabilità può toccare anche amministratori di fatto (chi, pur non formalmente, dirige l’impresa – es. il socio occulto) e i sindaci o revisori se omettono di vigilare. Cassazione penale e civile hanno equiparato la posizione di chi esercita funzioni gestorie di fatto a quella degli amministratori ufficiali, per cui nascondersi dietro un prestanome non esime dalle responsabilità. Recenti casi (ad es. Cass. Pen. 2020 sul caso Parmalat) hanno condannato sindaci e revisori per concorso in bancarotta se chiudono gli occhi sulle irregolarità gravi. In termini di difesa del debitore onesto, può essere opportuno avvalersi di consulenti e collegio sindacale proattivo come supporto: ad esempio, un sindaco che segnala tempestivamente una crisi ai sensi dell’art. 25-octies CCII può mettere gli amministratori nella condizione di attivarsi e magari evitare colpe gravi. La riforma 2024 ha persino esteso l’obbligo di segnalazione interna anche al revisore legale , moltiplicando le sentinelle. Dunque, ascoltare queste segnalazioni e agire di conseguenza è parte della condotta diligente che difende l’imprenditore da future censure.
In conclusione su questo punto: difendersi come debitore non significa solo contrastare pretese immediate, ma anche mettere al sicuro se stessi. Ciò comporta: scegliere forme societarie adeguate (la SRL offre scudo ai soci, ma non agli amministratori negligenti o malfattori); evitare di fornire garanzie personali illimitate se non necessario, o limitarle (ad es. fideiussioni specifiche e non omnibus, importi massimi garantiti, ecc.); in caso di crisi, rispettare i propri doveri di governance (assetti adeguati, emersione tempestiva) per non esporsi a cause risarcitorie e penali. Come recita un adagio tra giuristi d’impresa, “il primo dovere dell’imprenditore in difficoltà è non aggravare il dissesto”: così facendo, tutela i creditori ma anche se stesso. Cassazione 2024 ha sancito che l’amministratore non esecutivo colpevolmente ignaro può essere responsabile al pari dell’AD che compie l’illecito , quindi la vigilanza è parte integrante della difesa.
Avendo coperto le modalità di azione dei creditori e le difese individuali, possiamo ora passare alla parte costruttiva: come risolvere o gestire in modo organico la situazione debitoria attraverso gli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza offerti dalla legge. Questi strumenti – riformati di recente – rappresentano il “come fare” per uscire dai debiti in maniera legalmente protetta, spesso con sacrifici ma anche con la prospettiva di salvare l’azienda (o almeno l’imprenditore dal fallimento totale).
Strumenti per la gestione della crisi d’impresa (risanamento o insolvenza)
Quando i debiti di un’azienda diventano insostenibili con le normali operazioni, occorre valutare soluzioni straordinarie previste dall’ordinamento. Negli ultimi anni il legislatore italiano, anche in attuazione di direttive UE, ha approntato un sistema completo di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, incorporati nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) . Questi strumenti spaziano da procedure stragiudiziali volontarie a procedure concorsuali giudiziali. L’imprenditore debitore, a seconda della gravità della situazione, può tentare un risanamento dell’impresa (mediante accordi e piani che puntano a superare la crisi e continuare l’attività) oppure, se ciò non è possibile, avviare una liquidazione ordinata dell’impresa (chiudendola e distribuendo attivo ai creditori, con eventuale esdebitazione finale). In ogni caso, l’uso di questi strumenti ha due scopi principali dal punto di vista del debitore: mettere sotto controllo il problema debitorio evitando iniziative disordinate dei singoli creditori, e (quando possibile) ridurre l’ammontare complessivo dei debiti tramite accordi, falcidie, stralci consentiti dalla legge. In questa sezione esamineremo in modo sistematico i principali strumenti, distinguendoli in due categorie:
- Strumenti stragiudiziali di risanamento (negoziati privatamente, sebbene spesso regolati dalla legge per alcuni effetti): piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, e il nuovo istituto ibrido della composizione negoziata della crisi.
- Procedure concorsuali giudiziali (avviate col tribunale): concordato preventivo (nelle sue varianti, in continuità o liquidatorio, ed incluso il “concordato semplificato” post-composizione negoziata) e la liquidazione giudiziale (cioè il fallimento). Parleremo anche delle procedure minori di sovraindebitamento per completare il quadro (concordato minore, liquidazione controllata).
L’individuazione del percorso adatto dipende dal profilo dell’impresa (dimensioni, forma giuridica) e dal grado di insolvenza (crisi reversibile vs insolvenza conclamata). Ricordiamo che dal 15 luglio 2022 il CCII è pienamente in vigore e si applica a tutti i debitori, di qualsiasi dimensione (tranne enti pubblici) , con adattamenti per consumatori e piccoli imprenditori. Ciò significa, ad esempio, che anche una piccola ditta individuale può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata ex CCII, mentre una SRL grande può usare concordato preventivo o liquidazione giudiziale.
Prima di entrare nei singoli strumenti, presentiamo una tabella di confronto sintetica tra le opzioni principali:
| Strumento | Norma (CCII) | Cos’è | Obiettivo | Iniziativa | Coinvolgimento creditori | Effetti per il debitore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Art. 56 CCII (già art. 67 L.F.) | Piano privato di risanamento con attestazione da esperto indipendente | Evitare insolvenza, ristrutturare debiti fuori da procedure | Proposto volontariamente dall’imprenditore | Accordi privati con singoli creditori (nessuna maggioranza imposta) | Niente tribunale, ma tutela da revocatoria degli atti eseguiti in piano . Debitore mantiene piena gestione. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Artt. 57-64 CCII (già art. 182-bis L.F.) | Accordo omologato dal tribunale con una parte dei creditori (min 60% credito) | Ristrutturare debiti con efficacia estesa e omologa | Volontaria; necessita adesione di creditori qualificata (60%) | Solo creditori aderenti vincolati (salvo estensioni a dissenzienti in casi particolari) ; creditore pubblico può essere cram-dowm se rifiuta irragionevolm. | Tribunale omologa e concede esenzione revocatorie; possibile moratoria delle azioni esecutive su richiesta (protettive) . Debitore resta alla guida. |
| Composizione negoziata | Artt. 17-25-sexies CCII (da D.L.118/2021) | Procedura stragiudiziale assistita da un esperto indipendente nominato dalla CCIAA | Favorire accordi (anche piani o accordi sopra) o ristrutturazione informale prima dell’insolvenza | Volontaria, l’imprenditore presenta istanza su piattaforma telematica | Non impone accordi, ma facilita le trattative con tutti o alcuni creditori. Può sfociare in accordo, piano, concordato | Possibilità di chiedere misure protettive (stay) dal tribunale ; benefici fiscali su ricapitalizzazioni; esperto supervisiona ma gestione resta al debitore. Se fallisce, accesso a concordato semplificato liquidatorio . |
| Concordato preventivo | Artt. 84-120 CCII (ex L.F.) | Procedura concorsuale giudiziale: piano di regolazione dei debiti con pagamento parziale e/o dilazionato, soggetto a voto dei creditori e omologazione del tribunale | Evitare la liquidazione giudiziale, attraverso una soluzione concordata coi creditori (in continuità aziendale o tramite liquidazione dei beni) | Volontaria da parte del debitore, depositando proposta di concordato e piano | Tutti i creditori concorsuali sono coinvolti; divisi in classi se opportuno. Approvazione per maggioranza (maggioranza dei crediti per classi) . Certe categorie (Fisco/INPS) richiedono transazione per falcidia . | Sospensione di tutte le azioni esecutive (automatic stay) durante la procedura . Debitore rimane in possesso (concordato in continuità) sotto vigilanza di commissario, oppure cede i beni a un liquidatore (concordato liquidatorio). Se omologato, libera dall’insolvenza con pagamento % proposto; se non omologato, può seguire liquidazione giudiziale. |
| Concordato semplificato | Art. 25-sexies CCII (introdotto nel 2021) | Variante speciale di concordato liquidatorio senza voto dei creditori, accessibile solo se fallisce la composizione negoziata | Liquidare patrimonio con soddisfacimento parziale dei creditori, evitando il fallimento tradizionale | Su iniziativa del debitore dopo esito negativo di composizione negoziata, con attestazione esperto | Non prevede voto dei creditori: il tribunale può omologare d’ufficio se ritiene il piano non peggiorativo rispetto a fallimento | Simile a liquidazione giudiziale ma più rapida: nominato liquidatore giudiziale; i creditori possono fare osservazioni ma non votano. Debitore ottiene comunque esdebitazione finale come nel fallimento. (Istituto usato raramente sinora, introdotto per incentivare tentativo di composizione negoziata) |
| Liquidazione giudiziale | Artt. 121-270 CCII (ex fallimento) | Procedura concorsuale di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente, gestita da un curatore nominato dal tribunale | Realizzare l’attivo e distribuirlo ai creditori secondo le cause di prelazione; cessazione dell’attività (salvo esercizio provvisorio limitato) | Può essere richiesta dal debitore stesso (istanza di auto-fallimento) o dai creditori, o dal PM , in presenza di insolvenza accertata | Coinvolge tutti i creditori concorsuali; questi devono insinuarsi al passivo ed eventuali contestazioni vengono decise dal giudice delegato. | Spossessamento del debitore: la gestione passa al curatore. Sospensione di tutte le azioni individuali. Possibile azioni revocatorie su atti pregiudizievoli . A chiusura, esdebitazione del debitore persona fisica (se meritevole) – liberazione dai debiti residui . Società viene cancellata a fine procedura. |
(N.B.: Esistono inoltre gli strumenti per soggetti “minori”: concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore – per imprenditori sotto soglia o persone non fallibili – i quali sono simili rispettivamente al concordato preventivo e al piano del consumatore della vecchia legge 3/2012. Questi strumenti minori consentono dilazioni o stralci per piccoli imprenditori e privati, con omologazione giudiziale ma senza voto dei creditori, purché il piano sia fattibile e non danneggi i creditori.)
Come si evince, la scelta dello strumento dipende dallo stato in cui si trova l’azienda: se la crisi è ancora reversibile e c’è prospettiva di continuità, meglio tentare prima la via stragiudiziale o il concordato in continuità; se invece l’insolvenza è conclamata e irreversibile, sarà necessario optare per concordato liquidatorio o direttamente la liquidazione giudiziale (magari cercando soluzioni di salvaguardia per il debitore come l’esdebitazione). Esaminiamo ora i singoli istituti in maniera discorsiva.
Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 CCII (già art. 67, co.3, lett. d) legge fallimentare) che consente all’imprenditore in crisi di predisporre un piano di risanamento aziendale con l’ausilio di un esperto indipendente che ne attesta la fattibilità e l’idoneità a riportare l’impresa in bonis. È un accordo privatistico: non prevede l’intervento del tribunale per omologa o simili (salvo la facoltativa pubblicazione nel registro imprese). Il suo pregio è che gli atti e pagamenti posti in essere in esecuzione del piano sono protetti dall’azione revocatoria fallimentare : in caso di successivo fallimento, i creditori o il curatore non potranno far annullare quei pagamenti come preferenziali o quelle cessioni come distrattive, purché rientranti nel piano attestato.
Come funziona in pratica: l’imprenditore (coadiuvato da advisor finanziari e legali) redige un piano industriale e finanziario dettagliato in cui analizza le cause della crisi e prevede le strategie di risanamento (ristrutturazione del debito, reperimento nuova finanza, taglio costi, dismissioni di asset, ecc.). Ad esempio, il piano potrebbe prevedere che l’azienda ottiene nuovi investimenti dai soci per €X, vende un immobile non strategico per far cassa, ottiene dagli istituti di credito una dilazione dei mutui su 5 anni, e dai fornitori uno stralcio del 30% sui crediti in cambio di equity, il tutto permettendo di superare la crisi di liquidità e tornare redditizia in 2 anni. Questo documento viene sottoposto ad un attestatore (dottore commercialista o altro professionista indipendente con requisiti di legge) che deve verificare i dati e rilasciare un’attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano, dichiarando che le ipotesi sono ragionevoli e che il piano è idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria (nel CCII è richiesto che il piano appaia idoneo a prevenire o superare la crisi e assicurare la sostenibilità dell’indebitamento). Con quest’attestazione, il piano viene formalmente “chiuso” e deliberato dall’organo amministrativo.
Effetti: il piano può (facoltativamente) essere comunicato al registro delle imprese per dare pubblicità. Non c’è un voto dei creditori: saranno i singoli creditori che, caso per caso, decideranno se aderire alle proposte contenute nel piano. Ad esempio, la banca firmerà un accordo di moratoria, i fornitori firmeranno accordi transattivi per ridurre i crediti, ecc. Non serve il consenso di tutti: ogni creditore non aderente resta fuori ed eventualmente potrà agire per conto proprio, ma tipicamente l’impresa cercherà di coinvolgere la maggior parte dei creditori chiave. Non essendoci un congelamento automatico delle azioni esecutive, il rischio del piano attestato è che un creditore dissenziente potrebbe iniziare un’azione esecutiva mentre si attua il piano. Per questo, il piano attestato funziona meglio se c’è un numero limitato di creditori e un consenso diffuso.
Vantaggi per il debitore: estrema flessibilità (nessuna formalità giudiziaria), riservatezza (si evita lo stigma pubblico di una procedura concorsuale), e come detto protezione dalle revocatorie: i pagamenti fatti ai creditori secondo il piano non potranno essere contestati se poi la società fallisce, perché la legge li dichiara esenti (purché il piano abbia i requisiti formali e l’attestazione) . Ciò incentiva anche i creditori ad aderire: sanno di poter incassare senza rischio di dover restituire.
Limiti: non c’è coattività sui dissenzienti. Se uno o pochi creditori non vogliono saperne, l’azienda non può imporgli di aderire (come potrebbe invece con un accordo omologato o un concordato). Inoltre, non scatta alcuna automatic stay: se la situazione precipita, nulla impedisce a un creditore isolato di portare i libri in tribunale e chiedere il fallimento durante l’esecuzione del piano attestato. Un buon piano però prevede fin dall’inizio la soddisfazione di quei creditori pericolosi, così da neutralizzarli.
Quando usarlo: il piano attestato è tipicamente usato in situazioni di crisi incipiente o temporanea dove l’imprenditore è ancora credibile e ha l’appoggio delle banche. Ad esempio, se l’azienda soffre una crisi di liquidità ma ha prospettive di commesse future solide, può convincere i creditori a una ristrutturazione informale con l’attestazione come “bollino di qualità” sul piano. È anche utilizzato come esecuzione di obblighi derivanti da covenant bancari: spesso le banche chiedono un piano attestato come condizione per concedere nuove linee.
Da notare, con il terzo correttivo 2024 sono stati introdotti requisiti più stringenti sul contenuto del piano attestato (elencazione elementi minimi) , per migliorarne la qualità e l’attendibilità.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (con e senza estensione)
Gli accordi di ristrutturazione (spesso detti in gergo “182-bis” dal vecchio articolo) sono un gradino più formalizzato rispetto ai piani attestati. Previsti oggi dagli artt. 57-64 CCII, consentono all’imprenditore di concludere un accordo con una porzione significativa dei creditori (almeno il 60% in valore dei crediti) e di sottoporlo all’omologazione del tribunale, così da renderlo efficace e vincolante. Il concetto è: non serve avere il 100% di adesione, basta una maggioranza qualificata, e il tribunale omologa rendendo l’accordo opponibile anche ai creditori che hanno aderito ma non a priori ai dissenzienti (salvo eccezioni introdotte di recente).
Procedimento: l’imprenditore elabora un piano di risanamento (simile a come farebbe per un concordato) e negozia con i creditori la misura delle soddisfazioni (pagamenti integrali o parziali, tempi, eventuali garanzie). Raccoglie l’adesione formale di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali. Il piano deve essere accompagnato da una attestazione di un esperto indipendente circa la veridicità dei dati e l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non aderenti nei 120 giorni dall’omologa o dalle scadenze di legge (quindi i non aderenti vanno comunque soddisfatti per intero, se privilegiati secondo il loro rango, se chirografari anche con moratoria max 120 gg dal termine concorsuale). Questo per garantire che i dissenzienti non siano pregiudicati. Presentata la domanda di omologazione, il tribunale verifica la regolarità e può omologare l’accordo (sentito eventualmente il parere del commissario giudiziale nominato ex art. 44 CCII se c’è richiesta di misure protettive interim). Con l’omologa, l’accordo diventa efficace. I creditori aderenti sono tutti vincolati secondo i termini pattuiti (anche se fossero meno del 100%). I dissenzienti restano fuori: il loro credito non è modificato dall’accordo, però, come vedremo, la riforma ha introdotto due importanti meccanismi: gli accordi agevolati (con soglia ridotta di adesione ma efficaci solo su aderenti) e gli accordi ad efficacia estesa (che possono vincolare anche certi creditori dissenzienti omogenei, come banche dissenzienti se il 75% della categoria banca ha aderito).
Un beneficio degli accordi omologati è che, su domanda del debitore, il tribunale può sospendere le azioni esecutive individuali dal deposito della domanda fino all’omologazione (misure protettive, durata max 4+4 mesi) . Questo crea uno scudo temporaneo simile a quello del concordato, ma circoscritto.
Transazione fiscale/contributiva e cram-down fiscale: uno scoglio classico era convincere l’Erario e gli Enti previdenziali ad accettare stralci. Il CCII come aggiornato prevede che negli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi (transazione fiscale e contributiva). L’adesione di Agenzia Entrate e INPS deve giungere entro 90 giorni (prorogabili) . Importante: se l’ente pubblico rifiuta ingiustificatamente ma l’accordo è comunque approvato dalla maggioranza di legge senza considerare quel rifiuto, il tribunale può omologare lo stesso l’accordo estendendolo all’ente dissenziente (il cosiddetto cram-down fiscale introdotto dal 2020 e confermato dal correttivo 2024) . Ciò avviene se l’offerta fatta a Fisco/INPS nel piano è almeno pari a quanto otterrebbero in un’alternativa liquidazione fallimentare. In tal modo, il debitore può superare il veto dell’Erario (cosa prima non possibile, se il Fisco non firmava la transazione fiscale il concordato rischiava di saltare se c’erano crediti privilegiati erariali scoperti). Questa è una innovazione fondamentale: ad esempio, un’azienda propone di pagare il 70% del debito IVA (il che nel concordato sarebbe di regola fattibile solo con transazione fiscale approvata); se l’Agenzia rifiuta senza ragione e quell’offerta è migliore di una prospettiva di fallimento, oggi il giudice può omologare ugualmente l’accordo e quell’accordo verrà imposto anche all’Agenzia delle Entrate .
Accordi con omologazione “estesa” ad altre categorie: il CCII ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 introducendo il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) , che in sostanza è un accordo di ristrutturazione con classi di creditori e possibilità di cram-down tra classi (simile a un concordato ma senza voto formale, solo con omologa se alcune classi approvano). Per semplicità, basta dire che oggi esistono accordi di ristrutturazione agevolati dove la soglia di adesione è ridotta al 30% se l’imprenditore paga integralmente i non aderenti nei 120 gg (opzione poco usata finora), e accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa dove, ad esempio, se il 75% delle banche (per valore credito) aderisce, l’accordo omologato si estende anche alle banche dissenzienti della stessa classe . Questo per evitare hold-out di singoli istituti. Analoghe estensioni possono riguardare i creditori finanziari non aderenti se omogenei e altre convenzioni di moratoria. Sono meccanismi tecnici che elevano la forza cogente degli accordi, avvicinandoli in efficacia al concordato ma con un iter più snello e senza coinvolgere tutti i creditori.
Quando usarli: gli accordi di ristrutturazione sono idonei per aziende con debito finanziario rilevante e pochi creditori “istituzionali” (banche, fondi, leasing) che insieme compongono almeno il 60-75% del passivo. Permettono di tagliare fuori piccole sacche di creditori eventualmente pagando questi ultimi per intero o comunque fuori dall’accordo. Si evitano i tempi e costi di un concordato (che richiede il voto di tutti). È dunque preferibile se c’è consenso tra i principali creditori ma magari non su tutti. Ad esempio, un pool di banche e grandi fornitori sono d’accordo su un piano di rientro all’80% in 5 anni, ma qualche piccolo creditore no: con accordo 182-bis, i grandi vincolano l’accordo e i piccoli verranno pagati a parte (integralmente in 120 giorni dall’omologa, come richiesto dalla legge, altrimenti se non c’è capienza integrale per i piccoli, li si include e serve allora il concordato).
Vantaggi: possibilità di ottenere finanza interinale (le banche possono erogare nuova finanza prededucibile con maggiore fiducia), riservatezza maggiore (si pubblica solo l’accordo finale per omologa), velocità (non c’è fase di voto lungo). E dopo l’omologa, l’accordo violato permette comunque ai creditori di agire come da contratto (ad es. se debito non pagato, risoluzione dell’accordo e possono chiedere fallimento).
Difetti: come per piano attestato, i non aderenti vanno soddisfatti interamente (salvo includerli poi in un concordato minore se troppi). E c’è la fase di eventuali opposizioni all’omologa: i creditori esclusi o dissenzienti potrebbero opporsi lamentando pregiudizio. Il tribunale infatti omologa solo se i creditori estranei sono pagati per intero o adeguatamente protetti .
Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata è uno strumento innovativo introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) e confluito nel CCII Titolo II . Non è una procedura concorsuale né un accordo in sé, ma un percorso assistito per aiutare l’imprenditore a trovare una soluzione alla crisi mediante un mediatore esperto. È volontaria, riservata e molto flessibile.
Accesso: l’imprenditore percepisce “segnali di crisi” o viene sollecitato (es. da segnalazione dei creditori pubblici qualificati) e presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio. Deve caricare dati aziendali, ultime dichiarazioni, situazione debitoria e un piano ipotetico di rilancio. Una commissione nomina un esperto indipendente (scelto da elenchi di professionisti qualificati) . L’esperto convoca l’imprenditore e insieme esaminano la situazione. L’esperto ha il compito di favorire le trattative con i creditori, trovando punti d’incontro e suggerendo soluzioni. Non ha poteri decisori, ma funzione di facilitazione e di garante di trasparenza. La procedura dura inizialmente 3 mesi, prorogabile fino a 6 se utile . Durante questo periodo, l’imprenditore resta alla guida dell’azienda (non c’è spossessamento), ma deve informare l’esperto su atti di straordinaria amministrazione. L’esperto a fine percorso redige una relazione finale sul tentativo svolto.
Misure protettive e cautelari: l’imprenditore può chiedere al tribunale la concessione di misure protettive del patrimonio per la durata delle trattative . In pratica, può ottenere un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e sospende le eventuali istanze di fallimento. Ciò crea un ambiente protetto per negoziare. La Cassazione, come richiamato prima, ha valorizzato questo aspetto ritenendo che l’ammissione alla composizione negoziata (con perizia positiva e risultati economici dimostrabili) può influire sul giudizio cautelare ordinario riducendo il periculum . Le misure protettive sono essenziali se il debitore rischia pignoramenti imminenti. Il tribunale le concede se c’è un prospetto di risanamento plausibile e le trattative appaiono serie. Può anche nominare un ausiliario per vigilare.
Esito: se la composizione negoziata ha successo, può sfociare in diversi esiti a seconda di cosa le parti concordano:
– Un contratto di ristrutturazione bilaterale o plurilaterale (ad es. accordo stragiudiziale con banche e fornitori) senza necessità di omologa, eventualmente con l’attestazione dell’esperto se si vuole protezione revocatoria;
– Un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII da sottoporre a omologa (l’esperto può aiutare a raccogliere consensi per arrivare al 60% e poi attestare l’accordo stesso se è il caso);
– Un piano attestato di risanamento (l’esperto può contribuire e poi attestare);
– Un concordato preventivo “in continuità” pre-pack: l’esperto può attestare che la proposta di concordato riflette le trattative fatte e l’imprenditore può depositare direttamente la domanda di concordato con un piano già definito. Questo spesso dà più chance di approvazione.
– Se l’azienda non è risanabile come going concern ma ha ancora un patrimonio da liquidare, e la composizione non produce un accordo con creditori, l’imprenditore ha la chance (entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto negativo) di proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio . Questo concordato, come detto, non prevede voto dei creditori: il tribunale lo omologa se reputa che i creditori ottengono almeno quanto otterrebbero in un fallimento. È una soluzione di “chiusura” se le trattative falliscono ma l’imprenditore vuole evitare la liquidazione giudiziale pura e magari salvaguardare alcuni elementi.
Vantaggi della composizione negoziata: è confidenziale (l’apertura non viene pubblicata se non se ne richiede l’effetto protettivo), e consente soluzioni molto flessibili perché non vincolate sin da subito a regole rigide di par condicio. Si possono fare trattative separate con singoli creditori, fermo restando che l’esperto vigila sul rispetto della legge (ad esempio evitare pagamenti preferenziali non autorizzati: durante la composizione, alcuni pagamenti possono farsi se funzionali a miglior sorte di creditori, con il placet dell’esperto). Ciò consente, ad esempio, di ottenere nuova finanza prededucibile (i finanziamenti durante la composizione, se l’esperto li valida e il tribunale li autorizza, sono prededucibili ex art. 25-bis CCII). Inoltre, la presenza di un soggetto terzo (esperto) è utile per convincere i creditori della serietà del piano (spesso un creditore diffidente è rassicurato dall’avere un professionista imparziale sul tavolo).
Limiti: essendo volontaria, se l’imprenditore non collabora o omette informazioni, l’esperto può chiudere la procedura segnalando la situazione al tribunale (il che potrebbe preludere a iniziative d’ufficio). Inoltre, se ci sono troppi creditori conflittuali, l’esperto non ha poteri per imporre una soluzione: si potrà dover virare su un concordato con cram-down.
Novità 2024: il terzo correttivo ha introdotto la possibilità di concludere, in sede di composizione negoziata, accordi stragiudiziali con efficacia esdebitativa per l’imprenditore che cessa l’attività, se tutti i creditori concordano (specie per piccoli imprenditori). Inoltre, consente di negoziare la transazione fiscale direttamente in questa sede (prima l’Agenzia Entrate era restia a transare fuori dalle procedure formali, ora è autorizzata a farlo) .
La composizione negoziata è insomma il veicolo consigliato dal legislatore come prima risposta alla crisi: l’idea è intervenire prima che si arrivi all’insolvenza irreversibile, con uno strumento meno traumatico e con il coinvolgimento di figure professionali e stakeholder. Non a caso, la normativa di allerta esterna (segnalazioni Fisco, INPS, banche) invita esplicitamente l’imprenditore a fare ricorso alla composizione negoziata come rimedio.
L’imprenditore debitore dovrebbe dunque considerare: se la mia azienda è ancora salvabile ma ho bisogno di tempo e di accordi, la composizione negoziata mi offre un quadro protetto per trattare; se invece sono già in stato di insolvenza conclamata, allora passo alle procedure concorsuali vere e proprie.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale tradizionale che permette al debitore di evitare il fallimento presentando un piano di ristrutturazione dei debiti ai creditori, il quale – previa approvazione a maggioranza dei creditori stessi – viene omologato dal tribunale e diventa vincolante per tutti. È disciplinato dal Titolo IV Capo III del CCII, con molte innovazioni rispetto alla vecchia legge fallimentare ma la struttura di base resta: proposta del debitore, voto dei creditori, omologazione giudiziale.
Tipologie di concordato: principalmente in continuità aziendale (quando l’impresa prosegue, direttamente o indirettamente, l’attività – art. 84 co.3 CCII) oppure liquidatorio (quando l’obiettivo è liquidare il patrimonio e cessare l’attività). Ci sono poi forme miste. Nel concordato in continuità, l’azienda viene mantenuta operativa, magari con ristrutturazione, nuovi investitori, taglio di debiti e provento della continuazione per pagare i creditori. Nel concordato liquidatorio, si procede a vendere beni (anche l’azienda nel suo complesso a terzi) e distribuire il ricavato.
Procedura: l’imprenditore (non necessariamente più in bonis – spesso è insolvente o lo sta per diventare, ma comunque deve presentare una proposta che dia ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile da fallimento, c.d. test di convenienza) deposita un ricorso al tribunale con la proposta di concordato, il piano e la documentazione contabile richiesta, più la relazione di un attestatore indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano. Può anche depositare un ricorso “con riserva” (concordato in bianco) se ancora deve comporre il piano, ottenendo intanto le protezioni legali – ma dal 2022 le norme sul concordato “in bianco” sono più restrittive per evitare abusi e la concessione dei termini è legata a dimostrazione che c’è trattativa in corso o possibilità seria di piano. Comunque, presentato il piano, il tribunale ammette alla procedura, nomina un commissario giudiziale (figura di controllo), e indice l’adunanza dei creditori per il voto. Intanto scatta l’automatic stay: divieto di azioni esecutive o cautelari, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, impossibilità di iniziare o proseguire cause di pagamento (art. 54 CCII) . Ciò blocca i creditori e dà respiro al debitore. La gestione dell’impresa durante la procedura rimane all’imprenditore (debitore in possesso), sotto supervisione del commissario, salvo casi di abuso in cui il tribunale può togliere l’amministrazione.
I creditori vengono classificati in classi se hanno posizioni giuridiche ed interessi economici differenti (nel CCII 2022 è stato reso di regola facoltativo creare classi, non più obbligatorio, salvo in casi di trattamenti differenziati rilevanti) . Ogni classe vota la proposta: serve il voto favorevole (di persona o per delega) dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se ci sono classi, serve la maggioranza in ogni classe o, almeno, che in caso di dissenso di qualche classe il tribunale possa applicare il cram-down se ritiene comunque equa la proposta (il CCII mantiene il cram-down interclassi se almeno una classe approva e quella dissenziente è soddisfatta almeno in misura pari a una di pari rango che ha approvato, etc.). Se la maggioranza approva, il tribunale procede all’omologazione verificando legalità e fattibilità. A omologa avvenuta, il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per i non votanti o dissenzienti. I crediti vengono “soddisfatti” come da piano, e le eventuali garanzie eccedenti vengono meno (in quanto il concordato è novazione parziale). Il debitore adempie il piano sotto controllo del commissario (che post omologa diventa liquidatore giudiziale se c’è liquidazione di beni, o comunque vigilante sulla esecuzione).
Soddisfazione dei creditori: nel concordato liquidatorio, la legge richiede un soddisfacimento minimo del 20% per i chirografari (salvo che apporti anche continuità indiretta con prevalente, regola complicata, ma in generale c’è soglia 20%). Nel concordato in continuità, non c’è soglia fissa di soddisfo, però è obbligatorio che i creditori ottengano più di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale (principio generale) e in particolare i lavoratori devono essere pagati entro il limite di 6 mesi di ritardo (non si possono dilazionare i crediti da lavoro oltre 6 mesi dall’omologa se concordato in continuità). Inoltre, eventuali creditori privilegiati: se non vengono pagati integralmente, occorre il loro consenso o la perizia che dimostra che riceveranno almeno quanto otterrebbero liquidando le garanzie in scenario fallimentare (classico tema del cram-down sui privilegiati). I creditori pubblici (Erario, INPS) per ridurne i crediti devono passare per la transazione fiscale/contributiva all’interno del concordato, con voto assimilato: il CCII consente il cram-down fiscale anche qui, simile a quello negli accordi, per cui il tribunale può omologare anche senza l’adesione del Fisco se l’offerta era migliorativa rispetto al fallimento .
Concordato in continuità: è incoraggiato dalla riforma. Prevede che l’impresa continui, magari con ristrutturazione (si parla di “continuità diretta” se la stessa azienda prosegue, o “indiretta” se l’azienda viene affittata o ceduta a un terzo che la prosegue). Il vantaggio è che la continuità preserva il valore aziendale e i posti di lavoro. Il piano in continuità può prevedere soddisfacimento dei creditori con i proventi futuri della gestione (es. utili futuri, o vendita di prodotti, o apporto di investitori) oltre che con dismissione di attivi non strategici. Ci sono regole speciali: l’imprenditore può ottenere in continuità la facoltà di sciogliersi o sospendere contratti pendenti con autorizzazione del tribunale, per liberarsi da contratti onerosi (es: affitto sede troppo caro) – art. 97 CCII. Inoltre, per favorire la continuità, i crediti dei fornitori per beni/servizi forniti durante la procedura sono prededucibili, così i fornitori saranno incentivati a continuare a lavorare con l’azienda (sanno che verranno pagati con preferenza). Anche nuova finanza può essere prededucibile se autorizzata. La riforma ha ridotto alcuni tempi: ha fissato in 12 mesi il termine per chiudere l’omologazione (onde evitare concordati eterni) .
Concordato liquidatorio: qui la finalità è vendere i beni. Può includere un’offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo sin dall’inizio, oppure la liquidazione verrà condotta dal liquidatore nominato. Dal 2022, per proporre un concordato meramente liquidatorio (senza continuità), occorre o offrire quel 20% minimo ai chirografari, oppure includere apporto di risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo liquidabile (regola del “contributo esterno” codificata nel CCII art. 84, per evitare concordati liquidatori troppo penalizzanti per creditori). Nel concordato liquidatorio, di solito l’imprenditore perde l’azienda, ma evita gli stigma del fallimento e può ottenere la esdebitazione immediata per le persone fisiche (nel fallimento occorre attenderne la chiusura per chiedere esdebitazione).
Esempio pratico (per capire l’utilità): la nostra azienda di lubrificazione aria ha 100 di debiti verso banche, 50 verso fornitori, 20 verso Fisco e INPS, totale 170. Purtroppo il settore è in calo e decidono di chiudere l’attività. Hanno però un capannone e macchinari vendibili, stimati 100 netti. Propongono un concordato liquidatorio offrendo il ricavato 100 ai creditori (che farebbe 59% ai chirografari supponendo che 20 vada a Fisco privilegiato e qualche privilegio). I creditori votano e accettano. La società liquida i beni tramite il commissario e dopo l’omologa paga: Fisco e dipendenti prendono per intero i privilegi, i chirografari prendono ad es. il 50%. La società viene poi cancellata, i soci escono puliti. Se invece fosse fallita, avrebbero preso forse meno per via di costi e tempi.
Vantaggi per il debitore nel concordato: blocca i creditori (appena depositi la domanda ottieni protezione), permette di ristrutturare l’azienda sotto supervisione ma restando al comando (specie in continuità), scarica i debiti eccedenti con il soddisfo parziale concordato (la parte di debito stralciata viene perdonata con l’omologa), consente di sciogliere contratti onerosi, sospendere procedure esecutive e anche contributi Inps avviati. Per i soci, se riescono a conservare l’azienda attraverso un concordato in continuità, evitano la perdita totale dell’investimento e la dispersione dell’avviamento; se la devono cedere, possono magari pilotare la cessione verso un compratore gradito (ci sono casi famosi di concordati con offerte di management buyout, ecc.). Sul piano reputazionale, oggi un concordato porta comunque pubblicità negativa, ma meno dell’onta del fallimento (che per i privati implica anche restrizioni personali immediate, come divieto di espatrio senza permesso, ecc., assenti nel concordato).
Svantaggi: è una procedura onerosa e complessa – servono professionisti, attestazioni, spese di giustizia, più tempo e formalità. Va convinta la maggioranza dei creditori, il che richiede trasparenza e spesso sacrifici anche per soci (non di rado i creditori chiedono ai soci di rinunciare ai crediti soci o di immettere denaro nuovo per votare sì). Inoltre, se il concordato fallisce (non è approvato o non omologato), quasi inevitabilmente si finisce in liquidazione giudiziale (il CCII prevede conversione in fallimento se omologa negata salvo casi eccezionali). Altro svantaggio: eventuali fideiussori dei debiti sociali non sono coperti dal concordato (se la società paga 50%, i fideiussori possono essere escussi per l’altro 50% salvo transazioni). Quindi, l’imprenditore persona fisica che avesse garantito i debiti sociali potrebbe dover valutare un concordato personale (non esiste in Italia, dovrebbe fare sovraindebitamento a titolo personale) o cercare liberatoria dalle banche. Per questo, spesso nei concordati le banche chiedono che i soci-fideiussori mettano soldi in piano in cambio di liberazione delle garanzie. Infine, un concordato mal gestito può sfociare in revoca e fallimento se non lo si rispetta (risoluzione per inadempimento ex art. 121 CCII su istanza dei creditori, con possibilità di conversione in liquidazione giudiziale).
In ogni caso, il concordato preventivo rimane l’strumento principe per risanare grandi imprese o liquidarle ordinatamente. Le riforme ne hanno fatto uno strumento più flessibile e con tempi più certi, e promuovono la continuità come valore prioritario .
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Se nessuna delle soluzioni sopra riesce o è praticabile, rimane l’extrema ratio: la liquidazione giudiziale, che nel nuovo Codice ha sostituito il termine “fallimento” . È la procedura concorsuale involontaria (o volontaria, se chiesta dallo stesso imprenditore, magari perché non c’è prospettiva concordataria) che porta alla spossessione totale del debitore e alla liquidazione di tutti i beni sotto il controllo di un curatore nominato dal tribunale. La liquidazione giudiziale viene aperta quando ricorre lo stato di insolvenza (incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni). Possono richiederla il debitore, i creditori o il Pubblico Ministero (quest’ultimo per segnalazioni da autorità di vigilanza, o in caso di fughe, atti fraudolenti, ecc.) . Nel contesto che trattiamo (azienda con debiti), di solito il fallimento è richiesto dai creditori esasperati o è conseguenza di un concordato fallito.
Effetti principali: con la sentenza dichiarativa, l’imprenditore è spossessato dei beni (che entrano nella massa fallimentare gestita dal curatore). Gli amministratori decadono (nelle società) e subentra il curatore nella gestione e rappresentanza legale. Tutte le azioni individuali dei creditori sono bloccate e sostituite dal concorso formale: i creditori devono presentare entro un termine domanda di insinuazione al passivo al curatore, specificando credito e garanzie. Il curatore prepara uno stato passivo ed esprime pareri; le eventuali contestazioni sono decise dal giudice delegato nell’udienza di verifica del passivo. Si forma così l’elenco ufficiale dei crediti ammessi e le loro categorie (prededucibili, privilegiati con graduatorie, chirografi, ecc.). Dopodiché il curatore procede a liquidare i cespiti: vendere immobili, magazzino, macchinari, eventualmente cedere l’azienda intera se c’è qualcuno interessato (le vendite fallimentari possono essere in blocco se conviene). Il ricavato va distribuito seguendo l’ordine delle cause di prelazione: prima i creditori prededucibili (costituiti dalle spese di procedura e dai crediti sorti dopo l’apertura autorizzati, come eventuale esercizio provvisorio), poi i privilegiati (erario, dipendenti, ipoteche, ecc.), e infine ai chirografari pro-quota se avanza qualcosa.
La procedura di liquidazione giudiziale, sebbene efficiente in astratto, spesso comporta realizzi bassissimi per chirografari (vendite all’asta ribassate, tempi lunghi con spese). Ha inoltre una componente sanzionatoria: l’imprenditore fallito persona fisica subisce alcune incapacità personali (non può ricoprire cariche societarie senza riabilitazione, etc.), e può subire indagini per bancarotta come detto.
Perché allora l’imprenditore dovrebbe mai chiedere il proprio fallimento? In alcuni casi, può essere tattico farlo per evitare conseguenze peggiori: ad esempio, se l’imprenditore individuale non riesce a pagare i debiti, avendo subito pignoramenti sparsi, può trovare “ sollievo” nel fallimento perché accorpa tutto e sospende le azioni (in cambio però perde i beni). Inoltre, a fine liquidazione giudiziale l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione: la liberazione da tutti i debiti residui non soddisfatti . Questa è una seconda chance: la legge (art. 278 CCII) prevede che se il fallito collabora e non ha commesso irregolarità gravi, può ottenere dal tribunale la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti, tornando “pulito” economicamente (c.d. fresh start). Per la società, invece, che viene estinta, il problema residuo non si pone (i debiti insoddisfatti muoiono con essa, salvo garanzie personali su di essi).
La liquidazione giudiziale può a volte essere pilotata in modo meno traumatico: ad esempio, prima di dichiarare il fallimento, l’imprenditore potrebbe aver individuato un investitore disposto a rilevare l’azienda dal curatore. Il CCII consente al debitore o a terzi di presentare proposte di concordato semplificato in sede fallimentare (c.d. concordato fallimentare, art. 240 CCII) per chiudere prima la procedura offrendo un certo attivo ai creditori. Dunque, anche dopo la dichiarazione di liquidazione, non tutto è perduto: si possono studiare soluzioni concordate col curatore e i creditori, benché il debitore in quanto tale non abbia più l’iniziativa (può però favorire i negoziati per un concordato fallimentare magari presentato da un socio o terzo).
Peculiarità introdotte dal CCII: la liquidazione giudiziale conserva le linee base del vecchio fallimento, ma con alcuni aggiustamenti: tempi più stretti (il curatore deve presentare relazione iniziale entro 60 giorni), maggiori poteri al curatore (può promuovere azioni di responsabilità contro amministratori senza dover aspettare autorizzazioni del GD e comitato, velocizzando recuperi ), uso di strumenti telematici (registro digitale della procedura consultabile dai creditori ), e meccanismi per coordinare procedure in caso di gruppi di imprese. Non ultimo, è stata ridotta la durate della esdebitazione per consumatori incapienti: ora c’è l’esdebitazione di diritto per il debitore meritevole che non ha nulla da distribuire, immediatamente (principio “fresh start”), ma questo più per persone fisiche non imprenditrici minori. Ad ogni modo, per l’imprenditore fallito onesto, l’esdebitazione è generalmente ottenibile entro l’anno dalla chiusura.
Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è un male necessario solo quando non si riesce a far altro. Va evitata se possibile, perché implica la perdita del controllo totale e una marcata compressione dei propri diritti. Tuttavia, una volta avvenuta, l’imprenditore deve collaborare strettamente col curatore: oltre a essere un dovere giuridico (la mancata collaborazione è bancarotta semplice), è nel suo interesse per massimizzare il realizzo (ogni euro in più realizzato è un euro di debiti in meno residui, e facilita l’esdebitazione). L’imprenditore può suggerire al curatore strade per cedere al meglio i beni (es. segnalare potenziali acquirenti interessati).
Se la nostra azienda di lubrificazione aria finisse in liquidazione giudiziale, i macchinari verrebbero venduti, magari l’immobile anch’esso, e i creditori soddisfatti in parte. Ai dipendenti subentrerebbe il Fondo di Garanzia INPS per TFR e stipendi. I fornitori probabilmente recupererebbero poco. I debiti fiscali sarebbero pagati per quel che c’è (spesso il 0-30% a seconda). Gli amministratori potrebbero subire azione di responsabilità se emergesse che hanno tardato il fallimento peggiorando i danni (col curatore come attore in giudizio). E dopo qualche anno, chiusa la liquidazione, se i soci o l’imprenditore personale non hanno commesso irregolarità, potrebbero ottenerne l’esdebitazione e lasciarsi alle spalle i debiti non pagati.
In Italia, il fallimento era visto come uno stigma di disfatta totale. L’evoluzione normativa mira a farlo percepire come un meccanismo ordinario di uscita dal mercato quando necessario, e a bilanciare punizione e riabilitazione. Non a caso si è cambiato il nome in “liquidazione giudiziale”, più neutro. Ciò non toglie che per la maggior parte degli imprenditori, dichiarare fallimento resta l’ultimo tabù: per questo il legislatore incentiva in ogni modo l’uso di soluzioni intermedie come quelle illustrate sopra.
Dopo questo lungo percorso attraverso normative e procedure, è utile proporre alcune simulazioni pratiche e domande frequenti, per chiarire i concetti con un taglio ancora più concreto.
Simulazioni pratiche
Caso 1: Risanamento attraverso accordo stragiudiziale e composizione negoziata
Azienda Alfa S.r.l. (settore impiantistico, 20 dipendenti) accumula debiti per 800.000 €: 300k con banche (mutui e fidi), 100k con fornitori, 200k debiti fiscali e contributivi, 200k altri (leasing, canoni). Il mercato è in ripresa e l’azienda ha ordini potenziali, ma serve liquidità e dilazione dei debiti per evitare il collasso. Gli amministratori hanno ricevuto segnalazioni da Equitalia (debiti oltre soglia) e dalla banca (sconfinamenti >60gg) . Punto di vista debitore: come difendersi e uscirne?
Step 1: Alfa attiva subito la Composizione Negoziata sulla piattaforma CCIAA, nominato un esperto. Chiede al tribunale misure protettive per sospendere due pignoramenti avviati dal Fisco e da un fornitore . Il tribunale le concede per 4 mesi.
Step 2: Con l’aiuto dell’esperto, Alfa prepara un piano di risanamento: i soci sono disposti ad apportare 100k fresh money; si propone alle banche di prorogare i mutui + 2 anni; ai fornitori pagamento del 50% a 12 mesi; all’Agenzia Entrate-Riscossione una rateazione 120 rate (10 anni) con transazione fiscale sul dovuto (stralcio sanzioni, interessi).
Step 3: Durante le trattative, l’esperto convoca banche e fornitori in meeting con management Alfa. Viene presentata una perizia che stima che, se l’azienda prosegue, genererà utili sufficienti a pagare le proposte; se invece fallisce ora, i creditori prenderebbero forse il 20%. Ciò convince la maggior parte ad aderire.
- Le banche accettano un accordo ex art. 58 CCII: allungano i piani di rimborso e rinunciano a parte interessi futuri.
- I fornitori (85% per valore) firmano un accordo stragiudiziale per saldo e stralcio al 50% in 12 mesi. L’esperto suggerisce di includere clausola che se Alfa non paga puntualmente, torna dovuto il 100% (così i fornitori si cautelano).
- L’Agenzia Entrate concorda in via transattiva il pagamento integrale dell’IVA e contributi in 5 anni ma abbuona sanzioni (grazie alla norma sulla transazione fiscale in composizione negoziata, novità introdotta dal 2024 ).
Step 4: Dopo 3 mesi, l’esperto attesta che l’accordo quadro raggiunto è sostenibile. I creditori rappresentanti l’80% del debito totale hanno aderito formalmente. Per sicurezza, Alfa decide di “cristallizzare” gli accordi con un Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato . Raggiunge abbondantemente il requisito 60%. Deposita in tribunale l’accordo firmato + piano + attestazione. Chiede contestualmente l’omologa e proroga delle misure protettive fino a omologa.
Step 5: Il tribunale omologa l’accordo. Un fornitore 15% dissenziente aveva fatto opposizione lamentando di ricevere solo il 50% mentre altri col privilegio incassano di più. Il tribunale respinge l’opposizione perché il fornitore in questione ha rifiutato un’offerta che comunque gli dà più del fallimento e perché i privilegiati per legge vanno pagati prima . L’omologazione rende vincolante l’accordo per tutti gli aderenti; i dissenzienti rimangono creditori per intero ma, come previsto dall’accordo, Alfa li pagherà comunque integralmente a scadenza (li aveva tenuti fuori apposta, preferendo pagarli per intero per non avere opposizioni).
Step 6: Nei 18 mesi successivi, Alfa esegue l’accordo: nuovi ordini migliorano la cassa, i soci mettono i 100k promessi (prededucibili, incentivati dal mantenere loro partecipazione di controllo). I fornitori ottengono le rate concordate – alcuni che non hanno aderito vengono pagati integralmente alle scadenze preesistenti, grazie al beneficio di cassa dato dalla moratoria delle banche e dal cash dei soci. Le banche vedono Alfa rispettare i nuovi piani; l’erario incassa secondo transazione.
Esito: Alfa SRL ha evitato il fallimento, ha ridotto la sua esposizione debitoria (fornitori stralciati al 50% = 50k risparmiati; parte interessi bancari futuri tagliati) e soprattutto ha preservato l’avviamento e i posti di lavoro. L’esperto dichiara chiusa con successo la composizione negoziata. I creditori, pur avendo rinunciato a qualcosa, probabilmente recuperano più di quanto sarebbe accaduto in un fallimento (dove magari i fornitori avrebbero preso <20%). I soci hanno diluito le loro quote per far entrare un investitore di minoranza (apporto di 100k) ma mantengono controllo – ciò era parte dell’accordo. L’azienda ora è risanata e può proseguire.
Caso 2: Liquidazione tramite concordato semplificato
Impresa Beta SNC (due soci illimitatamente responsabili) ha debiti per 400k verso vari fornitori e banche. Il settore è in crisi irreversibile, i soci vogliono chiudere l’attività. Non ci sono le condizioni per un concordato preventivo ordinario (manca liquidità, i creditori sono troppi per coordinare un piano). Beta attiva la composizione negoziata ma l’esperto, dopo 2 mesi, rileva che non c’è fattibilità di risanamento: la situazione è insolvente e i creditori non accettano stralci significativi (ognuno vuole essere pagato per intero).
Tuttavia, Beta possiede un capannone libero da ipoteche del valore stimato 300k e qualche macchinario (altri 50k). I soci dicono all’esperto: “meglio far vendere tutto e dare ai creditori qualcosa in tempi rapidi, piuttosto che fallire”. Poiché la composizione negoziata non ha prodotto accordo, Beta può proporre al tribunale un concordato semplificato per liquidazione : offre di liquidare subito il capannone tramite una vendita già individuata (c’è un acquirente interessato a 280k) e di ripartire il ricavato tra i creditori, stimando che essi riceveranno circa il 70%.
Il tribunale valuta la proposta: c’è la relazione dell’esperto che attesta che le trattative si sono svolte correttamente ma senza esito positivo e che la proposta di Beta appare conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (nel fallimento, stima che i creditori, detratte le spese, avrebbero preso solo ~60%). Non essendoci voto dei creditori, il tribunale indice solo udienza per sentire eventuali loro osservazioni. Alcuni creditori contestano perché pensano si potrebbe ricavare di più aspettando, ma l’acquirente vincola l’offerta a rapida chiusura. Il tribunale ritiene la proposta meritevole e omologa il concordato semplificato.
Si nomina un liquidatore giudiziale (che può essere lo stesso esperto) per vendere il capannone all’offerta pattuita e distribuire il 70% ai creditori chirografari. La procedura si chiude in pochi mesi. Beta SNC viene cancellata. I creditori hanno preso 0.70 sull’euro, meglio di un fallimento incerto. I soci, pur perdendo l’immobile aziendale e ogni bene sociale, evitano il marchio del fallimento personale (che avrebbero avuto essendo SNC) e non subiscono restrizioni. Potranno dedicarsi ad altra attività e, se dovessero ancora dei soldi a qualcuno (debiti residui 30% che in concordato sono estinti verso la società), attenzione: siccome erano soci illimitatamente responsabili, i creditori non soddisfatti integralmente nel concordato potrebbero rivalersi sui soci a meno che anche a questi venga estesa la esdebitazione. Il CCII prevede che l’esdebitazione per soci illimitatamente responsabili in concordato può ottenersi, di fatto analogamente all’esdebitazione post-fallimentare, su istanza. In pratica, i soci di Beta chiederanno al tribunale di essere esdebitati dal residuo 30% non pagato, essendo meritevoli. Il tribunale concede se sono rispettate le condizioni (ad esempio, i soci hanno collaborato e non ci sono atti di frode). Così i soci fisici escono puliti e i creditori non possono più perseguirli nemmeno per quel residuo.
Questo caso mostra come la via semplificata post-composizione negoziata può servire per chiudere velocemente situazioni compromesse, quando i creditori sono troppi per organizzare un voto ma c’è comunque un attivo da distribuire.
Caso 3: Opposizione a decreto ingiuntivo e salvaguardia dell’azienda
Gamma S.r.l. ha un contenzioso con un fornitore su una partita di merce asseritamente difettosa del valore di 100. Il fornitore non riconosce il difetto e ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 100. Gamma ritiene di doverne solo 50 per via dei difetti. Se pagasse 100 subirebbe un colpo finanziario grave. Allora propone opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni, eccependo inadempimento parziale del fornitore (merce difettosa, perizia tecnica a supporto) e chiedendo la sospensione ex art. 649 c.p.c. Il giudice concede la sospensione, riconoscendo che c’è fumus boni juris sull’eccezione di difetto qualità.
Grazie all’opposizione, Gamma guadagna tempo: per 1-2 anni la causa va avanti. Nel frattempo, Gamma inserisce questo fornitore tra i creditori di un eventuale concordato preventivo (perché Gamma nel frattempo avvia una ristrutturazione più ampia). Nel concordato, il fornitore viene considerato con credito contestato e accantonato in caso di esito favorevole. Il fornitore capisce che rischia, e all’udienza conciliativa dell’opposizione accetta un accordo transattivo: Gamma paga 60 subito e chiudono lì la causa. L’opposizione ha portato il creditore a miti consigli: invece di 100 ottiene 60 (forse timoroso di perderne 50 in giudizio e di finire in un concordato con chirografari che magari paga 50%). Gamma, con quell’accordo, riduce il suo esborso e toglie un contenzioso.
Se Gamma non fosse ricorsa in opposizione e non avesse contestato, avrebbe dovuto pagare 100 subito col rischio di crisi di liquidità. L’opposizione è stata una difesa efficace per spuntare un risultato equo.
Caso 4: Utilizzo del DURC “regolare” con debiti in corso
Imprenditore Delta (ditta individuale edile) ha debiti previdenziali per €20.000 verso INPS e qualche cartella fiscale. Gli serve il DURC per partecipare a una gara pubblica. Attualmente gli verrebbe negato per irregolarità contributiva . Delta segue i passi della guida: verifica esattamente le pendenze; fa domanda di rateizzazione all’INPS per il dovuto in 24 rate (che l’INPS concede visto che rientra nei parametri) e aderisce alla rottamazione quater per le cartelle esattoriali includendo i suoi debiti fiscali (quindi la sua posizione risulta “in regolarizzazione”) .
Una volta ottenute le comunicazioni di accoglimento del piano di dilazione e della definizione agevolata, Delta le allega alla richiesta DURC sul portale. Secondo la normativa, avendo una rateizzazione in corso e una definizione agevolata accettata, la posizione di Delta è considerata regolare . INPS rilascia un DURC regolare provvisorio valido 120 giorni . Delta così può partecipare alla gara e, se vince, continuare l’attività. Senza questa difesa (rateizzare e documentare), la sua impresa sarebbe stata esclusa automaticamente per DURC irregolare .
Questa simulazione sottolinea come un debitore con pendenze possa difendersi dagli effetti interdittivi dei debiti (esclusione appalti) sfruttando gli strumenti normativi (piani di rientro, definizioni agevolate) per ottenere i certificati di regolarità .
Domande frequenti (FAQ)
D: La mia azienda è sommersa dai debiti e non riesco a pagarli tutti: devo per forza portare i libri in tribunale e fallire?
R: Non necessariamente. L’ordinamento offre vari strumenti per evitare il fallimento purché tu sia proattivo. Puoi ad esempio tentare di rinegoziare i debiti privatamente con accordi (rateizzazioni, stralci parziali) e formalizzare un piano attestato di risanamento . Oppure, se la situazione è più seria, puoi avviare un accordo di ristrutturazione con i creditori principali e farlo omologare . Ancora, dal 2022, puoi accedere alla composizione negoziata della crisi, un percorso assistito da un esperto che ti aiuta a trovare intese con i creditori chiave, con il beneficio di bloccare eventuali azioni esecutive durante le trattative . Solo se nessuna di queste strade funziona e l’insolvenza è conclamata si valuterà il concordato o la liquidazione giudiziale. L’obiettivo delle norme attuali è salvare l’impresa dove possibile, o quantomeno regolare la crisi in modo ordinato. Quindi non dare per scontato il fallimento: esplora prima soluzioni negoziali e concordatarie.
D: Ho ricevuto un decreto ingiuntivo per un debito che in parte contesto. Cosa posso fare per difendermi?
R: Puoi proporre un’opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica. Nell’opposizione spiegherai al giudice le tue ragioni (es. la merce era difettosa, il credito è già parzialmente pagato, ecc.) . Ciò apre un giudizio ordinario in cui il creditore dovrà provare il suo credito e tu potrai far valere tutte le eccezioni di merito . Importante: se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo, chiedi subito al giudice la sospensione dell’esecuzione ex art. 649 c.p.c. ; se concessa, il creditore non potrà nel frattempo pignorare. L’opposizione ti dà tempo e voce in capitolo. Molti decreti si risolvono poi in transazioni in corso di causa, con il creditore che accetta un compromesso (magari perché la tua opposizione ha evidenziato qualche punto debole del suo credito). Attenzione però ai termini e alle formalità: l’opposizione va notificata al creditore nei tempi previsti, altrimenti il decreto diventa definitivo e non più contestabile . Se hai fondati motivi di contestazione, l’opposizione è la tua difesa naturale.
D: Ho subito un pignoramento sul conto corrente aziendale: come posso fermarlo?
R: Se il pignoramento è già stato notificato alla banca, di regola l’unico modo di “fermarlo” è pagare o trovare un accordo col creditore. Tuttavia, puoi valutare due cose: (1) presentare un’opposizione all’esecuzione se ritieni che il creditore non avesse diritto di procedere (es. il debito era già stato pagato, o manca valida notifica del titolo) ; oppure (2) chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), che ti consente di sostituire ai soldi bloccati una dilazione di pagamento (versando un acconto 1/5 e il resto rateizzato fino a 18 mesi) così da sbloccare il conto . L’opposizione va fatta entro 20 giorni se contesti vizi del pignoramento stesso (es. notifica errata) , o prima possibile se contesti il diritto sostanziale del creditore. La conversione invece è una tua facoltà: devi depositare un’istanza al giudice dell’esecuzione prima che il bene venga assegnato o il denaro versato al creditore, offrendo il pagamento rateale. Se autorizzata, versi subito almeno il 20% e il resto secondo il piano approvato . In pratica “compri” la liberazione del pignoramento. Questo ti ridà operatività sul conto (una volta depositata la cauzione il GE sospende la procedura). Tieni presente che serve comunque disporre di liquidità per l’acconto. In parallelo, nulla vieta di negoziare direttamente col creditore: se riesci a concordare un pagamento a condizioni che può accettare, il creditore può sempre rinunciare al pignoramento in corso.
D: La banca mi ha chiesto una fideiussione personale per i debiti della mia SRL. Se la SRL non paga, posso oppormi a pagare io come fideiussore?
R: Se hai firmato una fideiussione “standard” omnibus (spesso su modulo ABI), verifica con un legale se contiene clausole dichiarate nulle dall’autorità Antitrust (clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ecc.). Molte fideiussioni bancarie precedenti al 2018 ricalcano un modello sanzionato da Banca d’Italia nel 2005 come anticoncorrenziale. La Cassazione ha stabilito che tali fideiussioni possono essere nulle in parte . Ciò significa che potresti eccepire in giudizio la nullità del contratto di fideiussione se identico allo schema vietato, e dunque non essere tenuto a pagare. Questa è una difesa tecnica ma spesso efficace – ci sono state pronunce di merito che liberano i garanti per nullità antitrust. Fai controllare la tua fideiussione a un avvocato esperto. In mancanza di profili di nullità, l’obbligo del fideiussore è generalmente solidale: la banca può chiedere a te l’intero importo anche senza escutere prima la società (salvo tu abbia previsto beneficium excussionis). In tal caso, l’unica difesa è pagare e poi rivalerti sulla società (ma se la società è insolvente, è un panno poco utile). Quindi la miglior difesa è preventiva: negoziare limiti all’impegno (importo massimo garantito, durata limitata) quando si firma. A posteriori, la via della nullità per violazione Antitrust è la più promettente se applicabile.
D: La mia SRL è in liquidazione e i creditori chirografari prenderanno poco o nulla. Possono rivalersi su di me personalmente come amministratore o socio?
R: I soci di una SRL hanno responsabilità limitata, quindi di regola i creditori sociali non possono attaccare il patrimonio personale dei soci per soddisfarsi . Fa eccezione il caso in cui abbiano impegni personali (es. fideiussioni, ne abbiamo parlato) o in cui la società sia stata sottocapitalizzata e funzioni come schermo fraudolento – in casi estremi la giurisprudenza ha risposto con la teoria del abuso di personalità giuridica, ma sono situazioni limite. Quanto agli amministratori, se hanno agito correttamente, non rispondono dei debiti sociali. Tuttavia, attenzione: se durante la crisi l’amministratore ha aggravato il dissesto violando gli obblighi (continuando ad assumere debiti insostenibili, pagando preferenzialmente alcuni a scapito di altri, distraendo beni), il curatore fallimentare o i creditori potrebbero intentare un’azione di responsabilità. In base all’art. 2486 c.c., l’amministratore deve conservare l’integrità del patrimonio sociale dopo che emersa causa di scioglimento (perdita capitale, insolvenza) e se compie nuove operazioni risponde del danno . Danno che la legge presume pari al deficit aggravato . Quindi, se la SRL va in decozione, i creditori potranno ottenere soddisfazione dal tuo patrimonio solo se dimostrano mala gestio: ad esempio, che hai ritardato il fallimento per un anno facendo sparire attivo o preferendo taluni creditori. Se invece hai gestito con diligenza, provando soluzioni e poi messo in liquidazione appena capito che non c’era via, difficilmente sarai ritenuto responsabile. In pratica, i creditori chirografari non possono automaticamente rivalersi su di te come amministratore; possono però chiedere al curatore o autonomamente di citarti se ravvisano condotte colpose o dolose che hanno leso le loro possibilità di recupero. Esempio: non hai versato IVA e hai usato quei soldi per pagare un fornitore “amico” poco prima del crack – i creditori (il Fisco o altri pretermessi) potrebbero agire contro di te per quell’atto in frode. In sintesi, soci di SRL al sicuro salvo garanzie personali; amministratori al sicuro salvo malagestione.
D: In un concordato preventivo, posso decidere di pagare alcuni fornitori strategici al 100% e altri molto meno?
R: In linea di massima, il concordato deve rispettare la parità di trattamento tra creditori della stessa classe (principio di par condicio attenuata dalle classi). Ciò significa che non puoi discriminare arbitrariamente: i fornitori chirografari vanno trattati ugualmente, salvo tu li divida in classi diverse giustificate da differente posizione. Puoi ad esempio creare una classe di “fornitori strategici continuatori” distinguendoli dagli altri fornitori cessati, e prevedere per i primi un pagamento percentuale superiore (per incentivarli a continuare con te). Questo è ammesso se c’è giustificazione economica e la maggioranza dei creditori approva la formazione di classi con trattamenti differenziati . La legge consente classi differenziate e trattamenti non uniformi solo se la diversità di situazione lo giustifica e comunque nel rispetto delle cause di prelazione (non puoi pagare un chirografario più di un privilegiato se quest’ultimo non viene soddisfatto integralmente). Quindi sì, in concordato puoi pagare diversamente i fornitori, ma devi collocarli in classi distinte e giustificare la ragione (continuità aziendale, necessità di mantenere quel fornitore) e far approvare il piano con tali differenze. Fai attenzione: i creditori penalizzati potrebbero opporsi se ritengono ingiustificata la disparità. Il tribunale in sede di omologa verifica che il piano non favorisca indebitamente alcuni creditori a scapito di altri nello stesso grado. Se la differenza è funzionale alla riuscita del piano (pagare di più chi continua a fornire merce essenziale), di solito viene accettata, purché comunque i creditori “non strategici” ricevano almeno quanto in liquidazione alternativa. In sintesi: non è totalmente libero il chi paga di più o di meno – è uno dei motivi per usare la composizione negoziata, dove invece puoi trattare caso per caso fuori da un procedimento formale. Nel concordato, trasparenza e ragionevolezza delle differenze sono fondamentali.
D: Quali debiti sono esclusi dall’esdebitazione? Dopo il fallimento o la liquidazione controllata, qualche creditore può ancora perseguitarmi?
R: L’esdebitazione è l’istituto che cancella i debiti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della procedura concorsuale . Per le persone fisiche (imprenditori individuali, soci illimitatamente responsabili, consumatori) di solito è generale, con poche eccezioni. Debiti esclusi tipicamente: debiti per obblighi di mantenimento e alimentari (es. assegni familiari), debiti da risarcimento di danni da fatto illecito non connessi all’attività d’impresa, multe e sanzioni penali e amministrative di natura punitiva (non vengono esdebitate per ragioni di ordine pubblico). I debiti fiscali e contributivi sono esdebitabili invece (lo ha chiarito la Cassazione e il CCII conferma, salvo che ci fossero sanzioni per violazioni penali, es. multa penale, quella no). Dunque, se ottieni l’esdebitazione post-fallimento, l’Agenzia Entrate, la banca, il fornitore non potranno più nulla per la parte non soddisfatta. Resteresti eventualmente debitore per multe penali, ammende, sanzioni amministrative pecuniarie (ad es. sanzioni Antitrust, sanzioni tributarie pure? Quelle tributarie dovrebbero rientrare nell’esdebitazione come credito concorsuale chirografario, c’è dibattito ma la tendenza è includerle; invece la multa penale o ammenda no). Se eri un imprenditore consumatore, attento che l’esdebitazione non copre i debiti verso creditori che non hai volontariamente indicato nella procedura: devi essere trasparente con tutti i creditori, altrimenti per quelli occultati niente esdebitazione. Nel concordato preventivo, tecnicamente non c’è un “esdebitazione” giudiziale, ma l’effetto dell’omologa è simile: i creditori concorsuali non possono pretendere oltre quanto stabilito dal piano omologato, e le eventuali garanzie (salvo patto contrario) decadono una volta eseguito il concordato. L’unica differenza: se sei socio illimitatamente responsabile o hai garantito personalmente, la tua liberazione non è automatica col concordato della società salvo che anche tu abbia fatto parte del concordato o chieda esdebitazione successiva. In definitiva, dopo il completamento di un fallimento o concordato, il debitore persona fisica può ritenersi liberato dai debiti residui (salvo eccezioni menzionate) – è il cosiddetto “fresh start” che l’Europa e il nostro ordinamento vogliono assicurare all’imprenditore onesto ma sfortunato . Ad esempio, la Legge Salva Suicidi (L.3/2012, ora inglobata nel CCII) prevede esdebitazione di diritto per il sovraindebitato che non ha nulla da offrire, subito dopo la liquidazione controllata, anche senza pagare nulla ai creditori, purché meritevole .
D: Cosa rischia penalmente un imprenditore indebitato?
R: Sul piano penale, i momenti delicati sono principalmente due: prima dell’eventuale fallimento, ci sono reati tributari con soglie (es. omesso versamento IVA > €250k per anno; omesso versamento ritenute > €150k) puniti con la reclusione (ma con possibilità di non punibilità se paghi il dovuto tardivamente o ti metti in regola con un piano prima del dibattimento ). Quindi se hai grossi debiti IVA/INPS non pagati, potresti subire un procedimento penale tributario: la miglior difesa è attivarsi per saldare o rateizzare prima possibile (la legge delega 2023 ha spostato il termine di rilevanza penale al 31/12 dell’anno successivo per dare tempo di ravvedersi ). Dopo (o in vista di) un fallimento, i reati tipici sono quelli di bancarotta: fraudolenta se hai distratto beni, sottratto atti, simulato passività; semplice se hai aggravato il dissesto con imprudenza (es. continuando ad acquistare merce senza speranza di pagare). Anche favorire alcuni creditori su altri, in stato di insolvenza, è reato di bancarotta preferenziale. Quindi, se sei in crisi, devi stare molto attento a non occultare asset (vende sotto costo a parenti, sposta soldi all’estero, etc.), a non documentare il falso (bilanci falsi per ottenere credito, ad es.), e a non pagare solo i “preferiti” a ridosso del fallimento. Nei concordati, l’ordinamento tende a non punire atti esecutivi del piano (anche se preferenziali, perché autorizzati) e la Cassazione ha assimilato il concordato preventivo a causa di non punibilità per bancarotta fraudolenta, in quanto il patrimonio è gestito sotto controllo . Insomma, la miglior difesa penale è la trasparenza e correttezza: tieni le scritture contabili in ordine (la bancarotta documentale è reato se mancano libri); non fare sparire niente (se devi dismettere beni, fallo a valori di mercato e traccia i ricavi); non gonfiare le passività fittiziamente. Se segui le regole civilistiche, in genere eviti il penale. E ricorda: la composizione negoziata e il tempestivo accesso a procedure concorsuali volontarie sono considerati indice di buona fede: ad esempio, un imprenditore che chiede concordato prima di accumulare altri debiti difficilmente sarà accusato di bancarotta semplice per aggravamento. Viceversa, uno che aspetta l’ultimo e poi fallisce con il magazzino sparito si espone a bancarotta fraudolenta patrimoniale, punita severamente (da 3 a 10 anni reclusione).
D: La mia società sta andando verso il fallimento. Posso “salvare” qualche bene, ad esempio vendendolo a un’altra mia società, prima che sia troppo tardi?
R: Attenzione: qualunque atto a titolo gratuito o a sottoprezzo fatto nei 2 anni prima del fallimento è revocabile dal curatore ; per atti a titolo oneroso con parti correlate o che squilibrano il patrimonio, c’è revocatoria 1 anno. Quindi se vendi beni a prezzo di mercato effettivo, forse l’atto regge (non revocabile se il corrispettivo giusto è entrato in società). Ma se stai pensando di “parcheggiare” beni altrove per non farli cadere in massa fallimentare, sappi che è fraudolento: il curatore li rivorrà indietro e tu rischi bancarotta. La via lecita per limitare i danni è magari costituire per tempo patrimoni separati (es. fondo patrimoniale per la casa di famiglia, trust per i figli) ma va fatto quando non sei ancora in stato di insolvenza conclamata e comunque quei strumenti hanno opponibilità limitata (i creditori dell’impresa non ne sono vincolati se il fondo patrimoniale è successivo ai debiti di impresa). Dunque, negli ultimi metri prima del fallimento, l’unica cosa sensata è pagare alcuni debiti essenziali (ma ciò potrebbe essere bancarotta preferenziale, a meno che serva a evitare danni maggiori – es. paghi fornitore per completare un lavoro che aumenta attivo: le norme ora lo consentono se autorizzato in concordato). La legge talora esclude la revocatoria per atti normalissimi (pagamenti a termine effettuati nei termini d’uso, vendite a equo prezzo per continuare l’impresa). Quindi se vendi un macchinario al suo valore di mercato e usi i soldi per pagare stipendi arretrati, probabilmente l’atto non sarà revocato (o almeno hai giusta causa). Se invece svendi il macchinario alla società di tuo cugino per 1 euro, stai certo che sarà revocato e pure indagato penalmente. In conclusione: non esistono trucchi leciti per salvare patrimoni a ridosso dell’insolvenza, a parte destinare ricavato a soddisfare creditori in modo oggettivamente utile e predisporre eventuale concordato. Meglio negoziare con i creditori in trasparenza piuttosto che tentare furbizie rischiose.
D: Se aderisco a una definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle e poi non riesco a pagare tutte le rate, cosa succede?
R: Le definizioni agevolate (come la Rottamazione-quater 2023) prevedono che devi pagare puntualmente le rate secondo calendario di legge. Se salti una rata, generalmente c’è una tolleranza di 5 giorni, dopodiché decadi dai benefici: significa che tornerà esigibile l’intero debito originario al netto di quanto già versato, con sanzioni e interessi ripristinati. Ad esempio, se hai rottamato €50k in 18 rate e paghi solo le prime 5, poi smetti, decadrai e l’Agenzia Riscossione potrà riprendere le azioni sul debito residuo come se non avessi mai rottamato (ti scaleranno ciò che hai versato, ma il resto torna comprensivo di aggi e interessi di mora). Su questo la Cassazione ha stabilito chiaramente che la decadenza dalla rateazione o rottamazione fa rivivere il debito originario con tutti gli accessori . Tuttavia, con la L. n.15/2025 (Milleproroghe 2025) si è data chance di rimessione in termini per chi decadeva dalla rottamazione-quater, consentendo di riammettersi pagando entro 2025 alcune rate . Ma queste sono normative eccezionali. Quindi, difesa principale: se vedi che non riesci a sostenere le rate di una definizione, puoi chiedere eventualmente di dilazionare (purtroppo le rate della rottamazione di solito non sono ulteriormente dilazionabili salvo legge ad hoc). Oppure, ricorrere ad altre procedure concorsuali: in un concordato preventivo, ad esempio, potresti includere quel debito residuo e ristrutturarlo ulteriormente (ci sono stati casi in cui la decadenza dalla rottamazione ha costretto l’azienda a un concordato). In sintesi, se decadi, i debiti risorgono e il Fisco può attivarsi subito. Pianifica bene prima di aderire: la rottamazione conviene se sei sicuro di poter rispettare i pagamenti, altrimenti potresti peggiorare la situazione (perché perdi tempo e opportunità di altre dilazioni ordinarie, e magari accumuli more).
D: I soci di una SRL fallita possono aprire una nuova società e continuare l’attività con quella?
R: In linea di massima, sì, non c’è una preclusione automatica. I soci non falliscono con la SRL (solo la società fallisce), quindi sono liberi di costituire una nuova società. Devono però fare attenzione a vari aspetti: se usano beni o asset della vecchia società, questi vanno acquisiti alle condizioni di mercato e col benestare del curatore. Spesso succede che i soci aprano “Beta SRL” mentre “Alfa SRL” fallisce, e comprino dal fallimento gli asset di Alfa (macchinari, magazzino) all’asta. È lecito, purché trasparente e non un mezzo per frodare (ad esempio, far fallire Alfa apposta per liberarsi dei debiti e trasferire tutto a Beta – se provato, è bancarotta fraudolenta per distrazione a mezzo preordinato fallimento). Ma se il fallimento è genuino e i soci semplicemente ripartono da capo, acquistando dal curatore ciò che resta dell’azienda al prezzo giusto, nulla lo vieta. Attenzione però: gli amministratori falliti (cioè dichiarati in proprio fallimento o di società di persone) avrebbero limitazioni a fare i gestori di nuova impresa finché non chiusa la procedura. Ma se erano solo soci di SRL, possono amministrarne un’altra. Va anche considerato il profilo reputazionale e di credito: banche e fornitori potrebbero essere diffidenti nel trattare con “Nuova società dei vecchi soci falliti di…”. Giuridicamente comunque possibile. Ricorda anche che se la vecchia società fallita aveva pendenze penali (bancarotta), i soci e amministratori potrebbero averne implicazioni – ma l’attività della nuova società, se indipendente, non è toccata, salvo se risulta mera continuità per aggirare il fallimento (in tal caso il curatore potrebbe provare a far estendere il fallimento alla nuova se configura “abuso di personalità giuridica”, ipotesi estrema e rara). Quindi, in pratica, spesso succede e con accortezza si può fare. È comunque consigliabile ottenere consulenza legale quando si tenta la strada della “phoenix company” per farlo in modo rispettoso della legge (ad esempio partecipando regolarmente alle vendite competitive del fallimento per acquisire i beni).
Conclusione
Affrontare una situazione di debiti aziendali gravosi richiede un mix di strategie legali difensive (per reagire alle azioni immediate dei creditori) e di strumenti proattivi per ristrutturare o liquidare in modo organizzato l’impresa. Il quadro normativo italiano, aggiornato al 2025, offre al debitore una gamma senza precedenti di opportunità per “difendersi” dai creditori e al contempo trovare una via d’uscita sostenibile: dalle opposizioni giudiziali per guadagnare tempo o ridurre pretese infondate , fino a sofisticate procedure concorsuali che permettono persino il taglio di percentuali di debito con l’avallo del tribunale . La chiave di tutto è la tempestività: prima si affronta la crisi – attivando adeguati assetti interni , allertando i soci e i professionisti, dialogando con i creditori magari attraverso la Composizione negoziata – maggiori sono le chance di evitare soluzioni traumatiche come il fallimento.
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” dai debiti non significa dunque sfuggire alle proprie obbligazioni, ma gestirle in modo intelligente e legale, minimizzando i sacrifici e massimizzando le opportunità di continuare l’attività (se profittevole) oppure di liquidare con onore, pagando il giusto possibile. Le difese processuali – ricorsi, opposizioni, sospensive – servono a prevenire esecuzioni precipitose e guadagnare spazio di manovra, ma vanno sempre affiancate da una visione di insieme: un’opposizione al decreto ingiuntivo blocca un creditore, ma se l’azienda ha cento creditori occorre una soluzione concorsuale. Viceversa, buttarsi in un concordato senza aver prima esplorato accordi bonari può alienare taluni creditori disponibili. Ogni strumento ha il suo momento opportuno.
In questa guida abbiamo fornito gli elementi tecnici e pratici – con fonti normative, sentenze e esempi concreti – per orientare l’imprenditore indebitato e i suoi consulenti verso la scelta più adatta. Difendersi efficacemente significa combinare tali strumenti: ad esempio, utilizzare la composizione negoziata per ottenere protezione giudiziale e negoziare accordi (piano attestato) con i maggiori creditori, oppure proporre un concordato preventivo che contempli anche una transazione fiscale innovativa (ora possibile in cram-down) . Il tutto mantenendo sempre la buona fede, la trasparenza e il rispetto delle gerarchie di creditori imposte dalla legge – aspetti su cui vigilano il tribunale e gli organi come commissari o esperti.
Infine, è bene ricordare all’imprenditore-debitore che non è solo in questo percorso: il Codice della Crisi ha voluto responsabilizzare anche soggetti terzi (collegi sindacali, revisori, creditori pubblici, banche) perché segnalino e assistano l’impresa in difficoltà . Il debitore che si muove per tempo troverà in questi soggetti non degli antagonisti, ma degli alleati istituzionali nel risanamento. Al contrario, l’inazione o i tentativi illeciti di eludere i debiti porteranno a sanzioni e al fallimento, dal quale comunque – grazie alle norme sulla esdebitazione – il debitore persona fisica potrà rialzarsi pulito , pur avendo perso l’impresa.
In definitiva: “cosa fare per difendersi e come” dipende dalla specifica situazione debitoria, ma come linea guida occorre analizzare il debito, suddividerlo per tipo e priorità, interagire con i creditori mostrando un piano realistico, e utilizzare senza timore gli strumenti legali a disposizione, dall’opposizione al decreto ingiuntivo sino al concordato preventivo, con l’ausilio di professionisti competenti. Questa guida, di livello avanzato, ha inteso offrire gli strumenti teorici e pratici per affrontare consapevolmente tale percorso, col conforto delle norme e della giurisprudenza più recente.
Fonti e Riferimenti Normativi
- Codice Civile:
– Art. 2086 c.c.: Dovere degli imprenditori (societari e non) di istituire assetti organizzativi adeguati e di attivarsi per tempestiva emersione della crisi . Introdotto dal D.Lgs. 14/2019, impone agli amministratori un obbligo di organizzazione funzionale a rilevare squilibri.
– Art. 2447 e 2482-ter c.c.: Riduzione del capitale per perdite oltre il terzo e obbligo di ricapitalizzazione o liquidazione se capitale < minimo legale. Norme societarie che impongono interventi appena la situazione patrimoniale si deteriora (collegate alla responsabilità da continuazione oltre soglia).
– Art. 2484 e 2485 c.c.: Cause di scioglimento delle società di capitali (es. perdita integrale del capitale) e obbligo degli amministratori di accertarle e iscrivervi. Collegato all’art. 2486 c.c. sulla gestione successiva.
– Art. 2486 c.c.: Poteri degli amministratori dopo scioglimento e divieto di nuove operazioni non conservatorie. Come modificato dall’art. 378 CCII, contiene ora il terzo comma che introduce criteri presuntivi di quantificazione del danno in caso di violazione (differenza patrimoni o aumento indebitamento) . La Cass. civ. n. 6893/2023 ha interpretato la natura di tale responsabilità come extracontrattuale sui generis e chiarito oneri probatori delle parti .
– Art. 2519, 2257 c.c.: (richiamati) responsabilità illimitata soci S.n.c. e poteri amministratori società di persone. Soci illimitatamente responsabili restano obbligati residuali anche in concordato (possono tuttavia ottenere esdebitazione). - Codice di Procedura Civile:
– Art. 615 c.p.c.: Opposizione all’esecuzione. Consente al debitore di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, in tutto o in parte. È la base per opporsi ad un pignoramento per motivi sostanziali (es. pagamento già avvenuto, prescrizione) .
– Art. 617 c.p.c.: Opposizione agli atti esecutivi. Consente di far dichiarare nulli/irregolari atti del processo esecutivo per vizi formali (es. difetto di notifica, mancata indicazione di elementi essenziali). Da proporre entro 20 giorni dal deposito o dalla conoscenza dell’atto viziato .
– Art. 642 c.p.c.: Provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Casi in cui il giudice può autorizzare l’immediata esecuzione: in particolare cambiale, assegno, atto ricevuto da pubblico ufficiale o pericolo grave nel ritardo. Fondamentale perché il creditore possa pignorare prima dei 40 giorni.
– Art. 645 c.p.c.: Opposizione a decreto ingiuntivo. Termini (40 giorni dalla notifica) e forma (atto di citazione, salvo eccezioni) per instaurare il giudizio di opposizione . Se proposta, il giudizio prosegue a cognizione piena.
– Art. 648-649 c.p.c.: Esecuzione provvisoria e sospensione nell’opposizione. L’art. 648 consente al giudice, su istanza del creditore opposto, di concedere comunque l’esecuzione provvisoria del decreto se l’opposizione non è fondata su prova scritta di pagamento. L’art. 649, viceversa, consente al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto per gravi motivi (tutela per il debitore opponente).
– Art. 495 c.p.c.: Conversione del pignoramento. Istituto che permette al debitore di evitare la vendita forzata dei beni pignorati, sostituendoli con una somma di denaro (comprensiva di capitale, interessi e spese). Richiede versamento di almeno 1/5 subito e il resto al massimo in 18 rate mensili . Utile per preservare beni strumentali.
– Art. 510 c.p.c.: Riparto. Norme sul riparto tra creditori dell’importo ricavato dall’esecuzione. Rileva per capire come vengono pagati i creditori (privilegi prima, etc.) anche nel contesto delle procedure concorsuali (che sono esecuzioni collettive).
– Art. 514-515 c.p.c.: Beni mobili impignorabili o relativamente pignorabili. Elenco di beni che non possono essere pignorati: es. cose sacre, letti, indumenti, cibo, animali da compagnia (legge 2015), strumenti necessari all’esercizio della professione (nei limiti della stretta necessità). L’art. 515 limita il pignoramento di beni strumentali d’azienda: possibile ma il giudice può escludere quelli indispensabili se il valore eccede il credito. Importante protezione per l’impresa (non si porta via l’unico macchinario se valore sproporzionato).
– Art. 567-569 c.p.c.: Pignoramento immobiliare e vendita. Prevede, tra l’altro, la necessità della nota di iscrizione a registro e stima. (Rilevante perché combinato con art. 76 DPR 602/73 che esenta prima casa da esproprio esattoriale – ma il cpc consente in generale di pignorare immobili senza tali limitazioni per creditori privati). - Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) [abrogata] e Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019):
– D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), come modificato dai Decreti correttivi: D.Lgs. 147/2020 (correttivo 1), D.Lgs. 83/2022 (correttivo 2, attuazione Dir. UE 2019/1023), D.Lgs. 136/2024 (correttivo 3) . Questo corpo normativo ha rivoluzionato la disciplina delle procedure concorsuali, introducendo misure di allerta e nuovi strumenti.- Composizione negoziata: Artt. 17-25-sexies CCII. Istituita dal D.L. 118/2021 e poi integrata nel Codice . Disciplina: nomina esperto (art. 17), misure protettive (art. 18) , esecuzione delle trattative, possibilità di autorizzazioni (finanza interinale prededucibile, atti dispositivi). L’art. 23 CCII consente all’esperto di segnalare ipotesi di frode al tribunale. L’art. 25-sexies regola il concordato semplificato (accesso se esito negativo, entro 60gg) . Importante: D.Lgs. 83/2022 ha integrato la composizione negoziata (inserendola al posto dell’allerta obbligatoria) e D.Lgs. 136/2024 ha introdotto novità come accordi fiscali transattivi (art. 25-quater) e obblighi dei revisori nelle segnalazioni interne .
- Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: Art. 25-novies CCII . Stabilisce soglie e modalità con cui AE, INPS, INAIL, Agenzia Riscossione devono avvisare l’impresa (e organo di controllo) del superamento di debiti scaduti, invitandola a attivare strumenti di regolazione . Soglie: INPS >15k o >5k a seconda dipendenti, INAIL >5k, IVA >5k+10% fatturato o >20k assoluto, AER >100k/200k/500k in base al tipo di impresa . Il fine è anticipare la crisi. Obbligo in vigore dal 15/7/2022.
- Procedure di regolazione della crisi:
– Piano attestato di risanamento: Art. 56 CCII. Conferma l’istituto ex art. 67 L.F., delineando contenuto minimo (introdotto dal D.Lgs. 136/2024) e la fondamentale esenzione da revocatoria per atti e pagamenti coerenti col piano attestato .
– Accordi di ristrutturazione dei debiti: Artt. 57-64 CCII (corrispondenti a art. 182-bis, 182-septies L.F.). Prevede soglia 60%, attestazione di solvibilità verso estranei , omologa tribunale. Comprende varianti: accordi agevolati (art. 60-bis CCII, adesioni 30% se integrali estranei – introdotto dal D.Lgs. 83/2022), accordi ad efficacia estesa (ex art. 182-septies L.F., ora art. 61 CCII, per banche e finanziari dissenzienti se >=75% aderisce) , accordi con intermediari finanziari (moratorie) e possibilità di cram-down fiscale (art. 63 CCII post correttivo 2024) .
– Concordato preventivo: Artt. 84-120 CCII. Diversi punti:
Art. 84 definisce concordato in continuità vs liquidatorio, requisiti (continuità = soddisfacimento anche con reddito atteso, liquidatorio = richiesta apporto esterno 10% attivo o pagamento min.20% chirog.) .
Art. 85 requisiti di ammissibilità, Art. 90 sulla domanda di concordato “in bianco” con riserva (termini max 60+60gg), Art. 94-96 contenuto piano e proposta, classi e trattamenti (facoltà classi salvo obbligo se trattamenti differenziati rilevanti). Art. 98 disciplina voto, maggioranze (maggioranza semplice crediti ammessi per classi; se dissenso classi, art. 112 consente omologa cram-down se almeno una classe approva e dissenzienti trattati non peggio di alternative) . Art. 100 pagamento creditori privilegiati (possibile falcidia se attestazione miglior soddisfo e voto classe). Art. 102 tratta dei crediti tributari e contributivi: transazione ex art. 63 CCII necessaria per stralcio (ora con possibilità cram-down). Art. 108 disciplina effetti dell’omologazione (vincola tutti i creditori anteriori). Art. 111 risoluzione del concordato per inadempimento e annullamento per dolo. Art. 112 omologazione forzata (cram-down interclassi). Art. 117 (già 169-bis L.F.) possibilità di scioglimento/sospensione di contratti pendenti con autorizzazione tribunale (importante per alleggerire l’azienda in continuità). Art. 120 conversione in liquidazione giudiziale se concordato non omologato o risolto/annullato (il tribunale dichiara il fallimento su istanza).
Norme specifiche aggiornate:
– D.Lgs. 83/2022 ha introdotto obbligo di non superamento 6 mesi per pagamento crediti lavoratori nei concordati in continuità , facoltatività classi , durata massima 12 mesi per omologa .
– D.Lgs. 83/2022 e 136/2024 hanno modificato transazione fiscale nel concordato (se dissenso Fisco ma proposta >= valore in liquidazione, omologa lo stesso: art. 180 co.4 L.F. analogamente recepito).
– Introduzione concordato semplificato (D.L. 118/21, art. 25-sexies CCII): senza voto creditori, su proposta debitore entro 60 gg da esito negativo composizione negoziata . È liquidatorio puro ma richiede relazione esperto positiva sulle trattative.
– Liquidazione Giudiziale: Artt. 121-270 CCII, che sostituiscono l’intera legge fall. Principali disposizioni:
Art. 121-125 presupposti e iniziativa (stato insolvenza, soglie dimensione non più previste – il CCII formalmente include tutti imprenditori, ma art. 2 CCII definisce “imprenditore minore” sotto certi parametri e destina costoro a procedura semplificata di sovraindebitamento salvo loro richiesta di fallimento). Art. 270 abroga l L.Fall.
Art. 189-197 Azione di responsabilità contro amministratori, sindaci (specie art. 189 riprende 146 L.F. – curatore esercita azioni sociali di resp.); art. 201 su azione di responsabilità dei creditori sociali (ex 2394 c.c.) esercitata dal curatore ex lege. Art. 214-216 revocatoria fallimentare (atti a titolo gratuito ultimi 2 anni, atti onerosi/con pagamenti preferenziali ultimi 6 mesi/1 anno) con esenzioni (pagamenti correnti, ecc.). Art. 222-223 bancarotta fraudolenta e semplice (rinvia al codice penale per definizioni e pene).
Art. 233-240 concordato nella liquidazione giudiziale (cd. concordato fallimentare): proposta da terzi o debitore per chiudere anticipatamente distribuendo attivo in percentuale.
Art. 278-279 Esdebitazione del debitore. Prevista di diritto per persona fisica fallita una volta chiusa procedura (o anche prima se ripartizione parziale integrale). Condizioni: cooperazione, meritevolezza (no frodi, no atti in frode ultimi 5 anni, no condanne per bancarotta fraudolenta). Effetti: libera da debiti residui escluse obblighi di mantenimento, risarcimenti danni extracontrattuali, sanzioni penali/amministrative pecuniarie e debiti per fatto illecito non inclusi nel passivo . Prevista anche esdebitazione di diritto del sovraindebitato incapiente (art. 282 CCII) per una volta, se non ha da offrire nulla, salvo debiti espressamente esclusi.
Art. 280 esdebitazione soci illimitatamente responsabili (in estensione del fallimento società) su istanza.
- Normativa Fiscale e Contributiva collegata:
– D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: Ruolo e riscossione delle imposte.
Art. 19 DPR 602/73: Rateazione delle cartelle esattoriali . Fissa la possibilità di dilazione fino a 72 rate (6 anni) ordinaria e fino a 120 rate (10 anni) straordinaria in caso di grave difficoltà . Modificato dal D.Lgs. 110/2024 (riforma riscossione attuazione delega fiscale) che dal 2025 eleva gradualmente il numero massimo di rate (84, 96, 120) e semplifica l’accesso (soglia automatica 120k, come da L. 160/2019) . L’art. 19 è la base per tutte le rateizzazioni coi concessionari.
Art. 48 DPR 602/73: (non citato sopra, ma rilevante) Divieto pagamenti PA a imprese con debiti >5k.
Art. 50 DPR 602/73: Intimazione di pagamento . L’Agente Riscossione deve notificare un’intimazione (preavviso) se tra notifica cartella e atti esecutivi passano >12 mesi. Il debitore ha 5 giorni dal ricevimento per pagare, poi può iniziare esecuzione.
Art. 76 DPR 602/73: Limiti espropriazione immobiliare esattoriale . Vietato pignorare abitazione principale non di lusso se il debitore vi risiede e ha un solo immobile, a meno che il debito superi 120k e non altri immobili (in tal caso ipoteca sì ma esproprio no). Comunque se debito < €120k mai espropriazione immobiliare esattoriale; se tra 120k e 20% valore immobile si può ipotecare ma attendere 6 mesi prima di iniziare esecuzione, ecc. (dettagli normativi).
Art. 77 DPR 602/73: Ipoteca esattoriale. Possibile iscriverla su immobili per debiti > €20k (soglia attuale), con preavviso 30gg.
Art. 86 DPR 602/73: Fermo amministrativo beni mobili registrati (ganasce fiscali). Preavviso 30gg, debito > €1000.
– D.Lgs. 74/2000: Reati tributari.
Art. 10-bis: Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Reato se > €150k di ritenute non versate entro la scadenza (termine versamento 770, rivisto da riforma sanzioni 2023). Punito con reclusione fino a 3 anni . Soglia ed elementi modificati da D.Lgs. 158/2015 e da D.Lgs. 156/2023: ora soglia 150k ma verifica protratta entro 31 dicembre anno successivo (possibilità di ravvedersi entro quell’anno) .
Art. 10-ter: Omesso versamento IVA. Reato se IVA dovuta > €250k per periodo d’imposta e non versata entro termine acconto anno successivo (termine spostato al 31/12 anno successivo da D.Lgs. 156/2023 per dare tempo di sanare) . Pena 6 mesi – 2 anni reclusione . Soglia di punibilità ridotta a 150k (come ipotesi) non risulta dalle modifiche del 2023, ma dal riferimento in sembra nuove soglie post-rateazione di 75k (forse condizionate a decadenza piani). In ogni caso, è reato significativo.
Art. 13 D.Lgs. 74/2000: Causa di non punibilità per pagamento integrale del debito tributario (imposta + interessi + sanzioni) prima della dichiarazione apertura dibattimento . Incentiva il ravvedimento operoso anche tardivo. Dal 2019 estesa anche a chi concorda piani di rateazione (purché versato il dovuto prima del dibattimento).
Cass. pen. sez. III, 19/01/2021 n. 3304: ha affermato che l’omologazione del concordato preventivo (che prevede pagamento parziale IVA) non estingue il reato di omesso versamento IVA se l’imposta non è stata integralmente assolta entro termini di legge. Questione controversa poi risolta dal 2021 con innalzamento termini e forse con interpretazione che se rate concordato pagate, si applica art. 13 (ma non certo).
– D.L. 119/2018, L. 145/2018, L. 197/2022: Norme sulle Definizioni agevolate (rottamazione cartelle) e Stralcio mini-debiti. Ad es. L. 197/2022 (Legge bilancio 2023) commi 231-252: introdotta Rottamazione-quater per ruoli 2000-2017: stralcio integrale sanzioni e interessi di mora, paghi solo imposta + interesse ridotto 2%, in max 18 rate . Ha previsto anche Stralcio automatico dei ruoli ≤ €1000 anni 2000-2015. L. 15/2023 (conv. Milleproroghe 2023) ha prorogato adesione al 30/6/23 e reintrodotto chi decadde da rottamazioni precedenti. L. 15/2025 (Milleproroghe 2025) ha introdotto riammissione per decadenza rottamazione-quater con domanda entro 30/4/25 e pagamento in 10 rate . – D.Lgs. 110/2024 (Riforma riscossione, attuazione L. 111/2023 delega fiscale): ha modificato l’art. 19 DPR 602/73 incrementando possibilità rate (85-120 rate per richieste 2025-26), alzato soglia per accesso automatico a 120k, e introdotto criteri oggettivi di difficoltà (indici Alfa e Beta) demandati a DM 27/12/24 . Inoltre integrata disciplina decadenza e riammissibilità piani. Queste norme entreranno in vigore 1/1/2025, aggiornando quindi la prassi di Agenzia Riscossione. Comunicati AdeR 17/1/2025 e Guida “La nuova rateizzazione” (fonte AER citata) spiegano le novità . - Giurisprudenza rilevante (massimata):
– Cass. civ. Sez. I, 22/04/2024 n. 10739: Responsabilità amministratori non esecutivi nel fallimento di società . Principio: rispondono solidalmente con gli esecutivi se, pur sapendo (o dovendo sapere) di atti illeciti di questi, omettono di attivarsi diligentemente. Colpa ravvisabile sia come ignoranza colposa di segnali d’allarme, sia come inerzia nel prevenire danni. Non vale a discolpa dire “non sapevo perché delegato non informava” . Riferimento a obbligo di agire informati e dovere di intervento. (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo). Questa sentenza evidenzia standard di diligenza elevati anche per consiglieri di amministrazione privi di deleghe, in coerenza con l’art. 2392 c.c. e con il dovere di predisporre assetti.
– Cass. civ. Sez. I, 08/03/2023 n. 6893: Azione individuale del creditore ex art. 2395 c.c. in contesto di perdita capitale sociale. Conferma che la responsabilità degli amministratori per violazione dell’art. 2486 c.c. non rientra nello schema generale aquiliano ex art. 2043, ma è categoria speciale: basta consapevolezza dello stato di scioglimento e compimento di nuove operazioni, senza necessità di dolo o colpa specifica . Onere della prova invertito in parte: i creditori provano atti gestori successivi e nocumento, l’amministratore per liberarsi deve provare che erano atti conservativi funzionali a liquidazione . (Conforme Cass. 9846/2020 S.U. su natura responsabilità ex art. 2486).
– Cass. civ. Sez. I, 23/10/2024 n. 27504: Rilevante in tema di effetti riconoscimento del debito sulla prescrizione . Ha statuito che la presentazione da parte del contribuente di una domanda di rateizzazione del debito tributario equivale a riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. e contestualmente interrompe la prescrizione del credito, precludendo successive eccezioni di mancata notifica di atti presupposti (in quanto il debitore con l’istanza ha mostrato piena conoscenza del debito). Ciò in ambito fiscale/ruoli implica che chi rateizza non potrà poi eccepire vizi della cartella né prescrizione maturata prima. Sentenza importante per la difesa del Fisco nelle opposizioni.
– Cass. civ. Sez. III, 07/06/2023 n. 16062: In tema di decadenza da rateazione ex art. 19 DPR 602, conferma la rigidità normativa: basta l’omesso pagamento di una rata nei termini per far decadere l’intero beneficio, senza ammettere cause di lieve ritardo. Nella specie, contribuente pagò ultima rata con lieve ritardo sperando nella tolleranza, invece decadenza confermata . Rimarca che solo un intervento normativo (come c’è stato per Covid, aumentando soglia rate omesse a 10) può mitigare, altrimenti è automatica.
– Cass. civ. Sez. Un. 30/01/2017 n. 24148 (ord. 05/12/2017 n. 29810) – c.d. Sentenza “fideiussioni ABI”: Ha sancito che le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI censurato dall’Antitrust (Provv. Banca d’Italia n. 55/2005) sono nulle per violazione della normativa antitrust, in quanto volte a restringere la concorrenza tra banche. In particolare, le clausole di reviviscenza, di rinuncia termini ex art.1957 c.c., etc., se presenti congiuntamente come da schema, determinano nullità totale per contrarietà a norme imperative (L. 287/90). Tale nullità è rilevabile d’ufficio e può essere eccepita dal fideiussore per non pagare. Numerose pronunce di merito dal 2017 ad oggi hanno applicato tale principio, liberando garanti. Riferimento in a Eutekne e renatodisa su Cass. 41994/2017 S.U. .
– Cass. pen. Sez. V, 12/04/2021 n. 15835: (non citato su ma di interesse) Ha affermato che l’omologazione del concordato preventivo non estingue i reati di bancarotta per fatti antecedenti, ma incide sulla valutazione del dolo di bancarotta preferenziale se i pagamenti incriminati erano funzionali ad un tentativo di risanamento poi sfociato in concordato. Indica un atteggiamento più benevolo verso chi ha pagato creditori in vista di un concordato.
– Cass. pen. Sez. Unite, 27/01/2011 n. 19601 “Dei Cas”: storica, afferma che i pagamenti effettuati in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F. non costituiscono reato di bancarotta preferenziale, essendo effettuati in base ad un piano conforme a legge. Principio poi esteso anche a concordato preventivo: il debitore che paga un fornitore strategico nel mentre attua il piano concordatario non commette reato. Tendenza quindi a esonerare condotte autorizzate dagli strumenti di soluzione crisi.
– Tribunale di Firenze, 08/01/2025: Ha stabilito, in sede di comparazione ex art. 112 CCII per omologare un concordato in continuità, che nel valutare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, bisogna tenere conto non solo dell’attivo formale ma anche delle possibili azioni risarcitorie che il curatore eserciterebbe in caso di fallimento . In altre parole, se in fallimento si potrebbero esperire azioni di responsabilità contro gli amministratori stimabili X, il piano di concordato deve considerare di migliorare l’assorbimento anche di quel valore. Ciò pone l’accento sul fatto che nel concordato i creditori rinunciano alle “azioni post-fallimentari” e dunque il piano deve compensare tale rinuncia. Questo per dire: i creditori giudicheranno un concordato meno conveniente se sanno che in fallimento ci sarebbero cause contro amministratori con chance di successo. L’imprenditore debitore deve essere conscio di questo aspetto nella predisposizione del piano. - Altro (prassi e dottrina):
– Circolare INPS n. 63/2020: in tema di DURC, conferma che il DURC online viene rilasciato positivo se i debiti contributivi sono in corso di regolarizzazione (rateazione attiva, domanda di rottamazione accolta ecc.) . Ribadisce soglia di tolleranza €150 per scostamento non grave .
– Circolare Agenzia Entrate-Riscossione, “La nuova rateizzazione delle cartelle” (Guida maggio 2024) : documento ufficiale post-riforma riscossione, illustra procedure per chiedere dilazioni, indici di difficoltà, ecc. Fondamentale come riferimento pratico per contribuenti (sito AER).
– Relazione Illustrativa al D.Lgs. 83/2022: chiarisce ratio delle novità come transazione fiscale “cram-down”, PRO, concordato semplificato ecc. Sottolinea allineamento alla Direttiva UE su ristrutturazioni. Non citata direttamente, ma contestualizza molte norme qui esposte.
– Raccomandazione UE 2014/135 e Direttiva UE 2019/1023: influenzano interpretazione pro-debitore e “fresh start”. Il legislatore italiano vi si è adeguato con le riforme 2020-2022, enfatizzando misure di allerta precoce e remissione debiti.
La tua azienda che produce o vende sistemi di lubrificazione aria, unità FRL (filtro-regolatore-lubrificatore), lubrificatori pneumatici, sistemi di trattamento aria compressa, filtri, regolatori di pressione e accessori per impianti pneumatici sta affrontando una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce o vende sistemi di lubrificazione aria, unità FRL (filtro-regolatore-lubrificatore), lubrificatori pneumatici, sistemi di trattamento aria compressa, filtri, regolatori di pressione e accessori per impianti pneumatici sta affrontando una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, fornitori, banche o Agenzia Entrate-Riscossione?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi dei fornitori o minacce di pignoramento?
Il settore della lubrificazione aria è molto tecnico: materiali costosi, lavorazioni meccaniche, assemblaggi complessi, componenti pneumatici speciali, valvole, guarnizioni, serbatoi e test di tenuta. Basta un calo di liquidità per far precipitare la situazione.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata, protetta e rilanciata, se intervieni subito e con la strategia corretta.
Perché un’Azienda di Sistemi di Lubrificazione Aria Finisce in Debito
Le cause più frequenti includono:
• aumento dei costi di componenti pneumatici e materiali tecnici
• ritardi nei pagamenti da parte di clienti industriali
• magazzino immobilizzato tra filtri, regolatori, lubrificatori, valvole e raccordi
• lavorazioni esterne costose (tornitura, anodizzazione, trattamenti superficiali)
• investimenti obbligati in test, certificazioni e strumenti di misura
• costi energetici e logistici sempre più alti
• linee di credito bancarie ridotte o revocate
• cicli di produzione lunghi o basati su preassemblaggio
Il problema non è la mancanza di domanda: è la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per una Azienda di Lubrificazione Aria con Debiti
Se non agisci subito rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti bancari
• interruzione delle forniture di componenti pneumatici essenziali
• decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
• sequestro delle scorte e dei semilavorati
• impossibilità di consegnare ordini o fare manutenzioni
• perdita dei clienti principali
• rischio concreto di fermo totale della produzione
Un debito non gestito può paralizzare l’attività in pochissimo tempo.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1) Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
• sospendere pignoramenti in corso
• bloccare richieste aggressive delle banche
• proteggere i conti correnti aziendali
• intervenire sui fornitori più pressanti
Prima si stabilizza la situazione, poi si procede alla ristrutturazione.
2) Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molti debiti includono:
• interessi e more illegittime
• somme duplicate
• posizioni prescritte
• errori nei conteggi della Riscossione
• costi bancari abusivi
Una parte significativa del debito può essere ridotta o eliminata.
3) Ristrutturare i debiti con piani di pagamento sostenibili
Le soluzioni più efficaci sono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di rientro con fornitori strategici
• rinegoziazione di affidamenti e mutui bancari
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• accesso alle definizioni agevolate (se disponibili)
L’obiettivo è liberare liquidità e mantenere la produzione attiva.
4) Attivare strumenti legali che proteggono l’azienda
Per situazioni debitorie gravi, gli strumenti più efficaci sono:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione
• concordato minore
• liquidazione controllata (come ultima opzione)
Questi strumenti consentono di:
• bloccare TUTTI i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte del debito
• continuare la produzione
• proteggere l’imprenditore
Sono strumenti legali, sicuri e regolati dal Tribunale.
5) Proteggere produzione, forniture e magazzino
In questo settore è essenziale:
• tutelare filtri, lubrificatori, serbatoi, valvole e componenti critici
• evitare sequestri che fermerebbero l’intera produzione
• preservare i rapporti con fornitori pneumatici strategici
• proteggere macchinari, test bench e strumenti di controllo
• mantenere continuità nelle consegne
La produzione deve continuare: è la base per uscire dalla crisi.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco completo dei debiti (bancari, fiscali e commerciali)
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Elenco fornitori strategici e insoluti
• Inventario del magazzino (filtri, regolatori, lubrificatori, valvole, semilavorati)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e pianificazione delle consegne
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria: 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e richieste di rientro
• Riduzione concreta e rilevante dei debiti
• Protezione del magazzino e dei macchinari
• Trattative efficaci con banche e fornitori
• Continuità operativa assicurata
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti o atti giudiziari
• Fare nuovi debiti per coprire quelli vecchi
• Pagare un creditore trascurandone altri
• Permettere che pignoramenti e decreti avanzino
• Affidarsi a società improvvisate senza competenza reale
Ogni errore può aggravare drasticamente la crisi.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato delle azioni dei creditori
• Piani di ristrutturazione efficaci e su misura
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
• Tutela totale di azienda e imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di sistemi di lubrificazione aria non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia tempestiva puoi:
• fermare i creditori
• ridurre in modo significativo i debiti
• proteggere produzione, materiali e magazzino
• salvare l’azienda e il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per intervenire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La protezione e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.