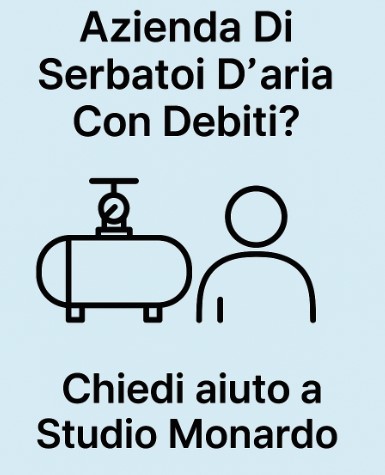Se gestisci un’azienda che produce, assembla o distribuisce serbatoi d’aria compressa, serbatoi verticali e orizzontali, bombole per aria, serbatoi pressurizzati, accumulatori e componenti per impianti pneumatici, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può degenerare rapidamente e compromettere la continuità della tua attività.
Il settore dei serbatoi d’aria richiede materiali certificati, controlli severi, lavorazioni di precisione e consegne puntuali. Per questo un blocco dovuto ai debiti può fermare intere commesse, bloccare le forniture e far perdere clienti cruciali, con danni immediati.
La buona notizia è che con la strategia giusta puoi bloccare pignoramenti, rinegoziare i debiti, ridurli e salvare la tua azienda.
Perché le aziende di serbatoi d’aria accumulano debiti
Le cause più comuni sono:
- costi elevati di acciaio, flange, saldature certificate, trattamenti e collaudi
- aumento dei costi energetici e dei materiali pressurizzati
- pagamenti lenti da parte di industrie, integratori e manutentori
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini complessi con scorte costose e materiali speciali
- difficoltà nell’ottenere credito o affidamenti bancari adeguati
- investimenti necessari per certificazioni PED, test e prove di tenuta
- fornitori strategici che richiedono pagamenti immediati
Questi elementi possono portare rapidamente a crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
Intervenire subito è fondamentale. Ecco cosa devi fare immediatamente:
- far analizzare la tua situazione debitoria da un avvocato esperto
- verificare quali debiti sono corretti, contestabili o prescritti
- non firmare piani di rientro affrettati o accordi rischiosi
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso
- avviare rateizzazioni sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
- proteggere fornitori fondamentali e materiali critici
- prevenire il blocco del conto corrente o riduzione dei fidi
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Con una diagnosi professionale puoi capire quali debiti ridurre, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni tempestivamente, rischi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di mezzi, bombole o attrezzature
- blocco delle forniture di materiali per serbatoi e componenti critici
- impossibilità di completare commesse o consegne
- perdita di clienti industriali e integratori di impianti
- danni pesanti alla reputazione aziendale
- crisi di liquidità e mancato pagamento dei dipendenti
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore dei serbatoi d’aria, anche pochi giorni di fermo possono compromettere contratti importanti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili con AE e INPS
- far annullare debiti irregolari, prescritti o mal notificati
- trattare con fornitori e banche per evitare sospensioni
- proteggere magazzino, attrezzature e continuità produttiva
- stabilizzare l’azienda mentre si ristrutturano i debiti
- evitare la crisi di insolvenza
Una strategia professionale può salvare l’azienda anche in condizioni molto difficili.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere operativa la tua azienda devi:
- intervenire immediatamente
- evitare trattative con i creditori senza una strategia chiara
- tutelare fornitori essenziali e materiali critici
- ristrutturare i debiti prima che arrivino pignoramenti
- identificare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare la liquidità per garantire produzione e consegne
Così puoi evitare fermi, ritardi e la perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
È il momento di farlo se:
- hai ricevuto solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS o fornitori sono in crescita
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità cala rapidamente
- hai difficoltà a rispettare scadenze e pagamenti
- vuoi evitare che la crisi sfoci in chiusura
Un avvocato esperto può bloccare subito le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
Attenzione: molte aziende non falliscono per i debiti, ma per aver aspettato troppo. Con la giusta strategia puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, salvando davvero l’impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese pneumatiche e industriali – ti aiuta a proteggere la tua azienda di serbatoi d’aria.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare subito le procedure, ridurre i debiti e mettere in sicurezza l’attività.
Introduzione
Un’azienda manifatturiera specializzata in serbatoi d’aria – chiamiamola Alfa S.r.l. – si trova oberata dai debiti. Le scadenze verso fornitori non vengono rispettate, le rate dei finanziamenti bancari sono arretrate, e l’Agenzia delle Entrate ha notificato cartelle esattoriali per imposte non pagate. La situazione è critica: il timore è quello di dover chiudere l’attività o, peggio, subire una liquidazione giudiziale (il procedimento un tempo chiamato “fallimento” ). Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, è fondamentale capire quali strumenti giuridici esistono – stragiudiziali e giudiziali – per difendersi dai creditori, ristrutturare il debito e magari salvare l’azienda. In questa guida forniremo un quadro avanzato, aggiornato a ottobre 2025, delle soluzioni offerte dall’ordinamento italiano per gestire lo stato di crisi o insolvenza di un’impresa, con riferimenti normativi (il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, detto CCII) e alle più recenti sentenze rilevanti.
Affronteremo il tema dal punto di vista del debitore (l’azienda indebitata e i suoi titolari), con un linguaggio giuridicamente accurato ma divulgativo. Saranno presentate tabelle riepilogative per confrontare i diversi strumenti, e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi pratici più comuni. Inoltre, tramite una simulazione pratica ambientata in Italia, mostreremo come applicare queste soluzioni in uno scenario reale. L’obiettivo è consentire a imprenditori, professionisti e privati di orientarsi tra le molte possibilità di difesa, tutela del patrimonio e regolazione dei debiti offerte dalle norme italiane, evitando errori che potrebbero aggravare il dissesto o addirittura sfociare in responsabilità personali.
Scenario attuale: negli ultimi anni il legislatore ha rivoluzionato la materia delle crisi d’impresa. Dal 15 luglio 2022 è entrato pienamente in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) , che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942. Questa riforma – attuata anche in recepimento della Direttiva UE 2019/1023 – ha introdotto nuovi strumenti di allerta e di composizione negoziale della crisi, privilegiando soluzioni conservative (risanamento o ristrutturazione del debito) rispetto alla liquidazione distruttiva . Concetti come stato di crisi (difficoltà che rendono probabile l’insolvenza futura) e insolvenza conclamata (incapacità attuale di pagare regolarmente i debiti) sono ora formalmente definiti e distinguono fasi diverse di difficoltà aziendale . Per l’imprenditore debitore, questo significa che esistono vie d’uscita se si agisce tempestivamente e in buona fede. L’ordinamento premia chi affronta subito la crisi con trasparenza (ad esempio attivando una procedura di composizione negoziata) e sanziona chi la trascura lasciando precipitare l’azienda nell’insolvenza .
Nei paragrafi che seguono esamineremo dapprima come riconoscere lo stato di crisi e quali obblighi gravano sull’imprenditore (o sugli amministratori) in difficoltà. Illustreremo poi le diverse tipologie di debiti (fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, ecc.) e le relative azioni tipiche dei creditori, così da comprendere da chi e cosa bisogna difendersi. Entreremo quindi nel vivo degli strumenti di gestione della crisi: dagli accordi stragiudiziali volontari (come il piano attestato di risanamento) alle procedure concorsuali vere e proprie (come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale), senza tralasciare le novità più recenti – ad esempio la composizione negoziata introdotta nel 2021 e i nuovi istituti come il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) . Dedicheremo attenzione anche alla responsabilità patrimoniale dell’imprenditore e dei soci: capiremo in quali casi i debiti aziendali possono “colpire” il patrimonio personale di amministratori o partecipanti e come limitare questi rischi. Infine, una sezione di FAQ e una simulazione pratica aiuteranno a chiarire come applicare teoria e norme a situazioni concrete, ad esempio cosa può fare Alfa S.r.l. per evitare il collasso e risollevarsi.
Nota: Tutti i riferimenti normativi sono alla legislazione italiana vigente (aggiornata a fine 2025). Le sentenze citate sono pronunce di merito e di legittimità che offrono chiarimenti interpretativi importanti. Al termine della guida, è presente un elenco completo di fonti e giurisprudenza utilizzate. Ricordiamo che ogni caso concreto ha le sue peculiarità: le informazioni fornite mirano a dare una conoscenza approfondita degli strumenti generali, ma per decisioni operative è sempre consigliabile consultarsi con professionisti qualificati (commercialisti, avvocati specializzati in crisi d’impresa, ecc.).
Riconoscere la crisi: definizioni, indici di allerta e doveri dell’imprenditore
Il primo passo per “difendersi” dai debiti è riconoscere per tempo la gravità della situazione finanziaria della propria azienda. Il Codice della Crisi distingue formalmente tra stato di crisi e stato di insolvenza . In termini semplici:
- Lo stato di crisi è una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile in futuro l’insolvenza del debitore. Per un’impresa, la crisi si manifesta tipicamente come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi . In altre parole, l’azienda prevede di non avere liquidità sufficiente per pagare i debiti quando verranno a scadenza nell’anno a venire. È dunque una situazione di tensione finanziaria, ancora reversibile se affrontata.
- Lo stato di insolvenza è invece la conclamata incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni già scadute . Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (es. pignoramenti subiti, assegni scoperti, protesti) che indicano che l’impresa non è più in grado di pagare i debiti in modo regolare. L’insolvenza è quindi uno stadio più avanzato e grave, che spesso conduce all’apertura di una procedura concorsuale di liquidazione se non vi sono alternative.
Questa distinzione non è solo teorica ma ha effetti pratici importanti. Molti strumenti offerti dal CCII devono o dovrebbero essere attivati già nello stato di crisi, prima che l’insolvenza si manifesti, in un’ottica di prevenzione e tempestività . Ad esempio, la composizione negoziata o il piano attestato di risanamento possono essere avviati in fase di “crisi” (quando l’azienda è in tensione ma ancora in attività), mentre la liquidazione giudiziale richiede l’insolvenza conclamata. Agire durante la crisi (anziché aspettare l’insolvenza conclamata) consente di avere più strumenti di ristrutturazione a disposizione e spesso di evitare misure più drastiche.
Obblighi di monitoraggio e allerta interna: Il legislatore ha imposto agli imprenditori (specie societari) precisi doveri di organizzazione per rilevare tempestivamente i segnali di crisi. L’art. 2086 del codice civile, novellato nel 2019, impone all’organo amministrativo di ogni impresa collettiva di istituire un assetto organizzativo adeguato ai fini della rilevazione di squilibri economici o finanziari e di attivarsi senza indugio per adottare soluzioni . In pratica, gli amministratori devono dotarsi di sistemi di controllo di gestione, budgeting, indicatori che segnalino in anticipo se l’azienda sta andando in sofferenza (ad es. se i debiti a breve superano certi parametri rispetto ai crediti, se il margine operativo è in forte calo, ecc.). Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha anche individuato indicatori di allerta (indici finanziari) che possono indicare una crisi, come un eccesso di debiti scaduti verso fornitori, stipendi arretrati oltre 30 giorni per più della metà dell’importo mensile, esposizioni bancarie sconfinanti da oltre 60 giorni per più del 5% del totale, ecc. . Questi “segnali interni” devono mettere in guardia l’imprenditore e spingerlo ad agire prontamente.
Allerta esterna dei creditori pubblici: Oltre al monitoraggio interno, il Codice della Crisi prevede un sistema di segnalazioni d’allerta esterne da parte di alcuni creditori qualificati (in particolare, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della Riscossione) quando l’azienda accumula debiti rilevanti verso lo Stato. A partire dal 2024, infatti, se le esposizioni superano certe soglie, questi enti hanno l’obbligo di avvisare l’imprenditore (e, se presente, l’organo di controllo della società) del grave indebitamento e di invitarlo a intraprendere iniziative come la composizione negoziata . Ad esempio: un debito verso l’INPS superiore a €15.000 (per aziende con dipendenti) e scaduto da oltre 90 giorni farà scattare la segnalazione da parte dell’ente previdenziale ; oppure debiti tributari affidati all’Agente della Riscossione superiori a €500.000 (per società di capitali) con ritardo oltre 90 giorni porteranno a un alert da parte di Agenzia Entrate Riscossione . Anche l’Agenzia delle Entrate invia segnalazione se l’IVA periodica non versata supera determinate soglie (in genere almeno €20.000 o il 10% del volume d’affari, comunque oltre €5.000) . Questi “allarmi” esterni mirano a sollecitare l’imprenditore a reagire prima che sia troppo tardi: in particolare, l’invito formale è quello di presentare un’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi entro 90 giorni dalla segnalazione . È importante sottolineare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha giudicato legittimi questi obblighi di segnalazione imposti ai creditori pubblici qualificati, ritenendoli compatibili con i principi costituzionali in quanto bilanciati dall’interesse generale a far emergere tempestivamente la crisi d’impresa . La Consulta ha osservato che tale meccanismo tutela il credito erariale/previdenziale senza ledere in modo irragionevole i diritti dell’imprenditore, il quale anzi trae beneficio dall’allerta precoce per attivare strumenti di soluzione della crisi.
Doveri di attivazione tempestiva: Una volta emersi segnali di crisi, l’imprenditore (o gli amministratori, se parliamo di società) ha il dovere di attivarsi prontamente per trovare una soluzione. Il CCII prevede incentivi per chi agisce presto e sanzioni per chi indugia. Ad esempio, se un imprenditore presenta istanza di composizione negoziata non appena i parametri d’allerta sono superati, potrà beneficiare di misure protettive (sospensione di azioni esecutive) e di alcune agevolazioni fiscali (riduzione di interessi e sanzioni come vedremo) , nonché di attenuanti in caso di eventuali reati di bancarotta di speciale tenuità . Di contro, ignorare una situazione di insolvenza e ritardare indebitamente la richiesta di procedura concorsuale può avere gravi conseguenze. Sul piano civile, gli amministratori che proseguono l’attività aggravando il dissesto societario rischiano un’azione di responsabilità da parte del curatore fallimentare (o liquidatore giudiziale) per i danni causati ai creditori. La riforma ha persino introdotto una presunzione di danno in caso di tardiva liquidazione: l’art. 2486 c.c., comma 3, stabilisce che se è accertata la responsabilità degli amministratori per violazione dell’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale (ad esempio continuando l’attività nonostante perdite rilevanti), il danno risarcibile è quantificato in via presuntiva con il peggioramento del deficit patrimoniale durante la gestione illegittima, salvo prova di un diverso ammontare . In pratica, viene confrontato il patrimonio netto al momento in cui si sarebbe dovuto interrompere l’attività con quello al momento dell’apertura della liquidazione: la differenza negativa costituisce il danno minimo a carico degli amministratori negligenti . Questo per evitare che la mala gestio resti impunita per difficoltà probatorie – è un forte deterrente contro l’inerzia colpevole. Anche sul piano penale, continuare ad accumulare debiti può integrare il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. Fall. previgente, ora corrispondente a fattispecie del CCII): la Cassazione ha chiarito però che il mero ritardo nel deposito di istanza di fallimento non è di per sé reato, a meno che abbia arrecato un effettivo pregiudizio ai creditori e sia frutto di colpa grave . Tuttavia, se dall’omissione derivano distrazioni di attivo o aggravamenti del dissesto, possono configurarsi anche ipotesi più gravi (bancarotta fraudolenta patrimoniale o preferenziale). Insomma, mantenere lo status quo inerte quando l’azienda è insolvente espone l’imprenditore a seri rischi giuridici.
In sintesi, riconoscere la crisi per tempo e agire con tempestività sono due principi cardine introdotti dalla riforma. Dal punto di vista del debitore: appena ci si accorge che l’azienda non riesce più a generare cassa sufficiente (crisi) o, peggio, non paga più i debiti (insolvenza), occorre valutare le soluzioni offerte dalla legge. I paragrafi successivi illustreranno queste soluzioni, ma prima è utile capire la natura dei diversi debiti che può avere un’azienda come la nostra Alfa S.r.l. e perché alcuni creditori sono più pericolosi di altri.
Tipologie di debiti e creditori: rischi e priorità
Un’azienda indebitata normalmente ha esposizioni verso diverse categorie di creditori. Ciascuna tipologia di debito ha caratteristiche giuridiche specifiche, che si riflettono sia sulle azioni che il creditore può intraprendere, sia sul grado di priorità con cui il credito verrà soddisfatto in caso di procedura concorsuale. Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, è importante mappare i propri debiti, distinguendoli ad esempio in: debiti fiscali, contributivi, bancari, finanziari (leasing, mutui), verso fornitori, verso dipendenti, ecc. Questa analisi consente di valutare i rischi (chi può aggredire subito l’azienda? Chi ha tutele particolari?) e di impostare adeguate strategie di difesa o negoziazione con ciascuno.
Ecco una panoramica delle principali categorie di creditori e debiti che una PMI manifatturiera come Alfa S.r.l. può avere, con le relative peculiarità:
- Debiti fiscali (Erario): comprendono imposte dovute e non versate (IVA, IRES, IRAP), ritenute non versate, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, ecc. Questi debiti spesso vengono affidati per la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), che può emettere cartelle esattoriali. Il Fisco dispone di potenti strumenti di riscossione coattiva: dopo la notifica della cartella e decorso il termine per pagare o fare ricorso, può avviare pignoramenti senza bisogno di una sentenza (la cartella è già titolo esecutivo). In più, il Fisco può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per crediti sopra certe soglie e può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli. Nei confronti di una società, l’Agente della Riscossione pignora tipicamente conti correnti aziendali, crediti verso terzi (es. tramite pignoramento presso cliente dell’azienda debitore), beni mobili e immobili sociali. È un creditore implacabile, anche se soggetto a precise regole procedurali e a possibili sospensioni se si avvia una procedura concorsuale. In caso di concorso tra creditori, i crediti fiscali godono di privilegi generalizzati sul patrimonio (ad esempio l’IVA è credito privilegiato ex art. 2752 c.c.) e devono essere soddisfatti prima di molti altri (sono considerati crediti pre-deducibili o privilegiati di vario grado nelle graduatorie fallimentari). Un aspetto importante è che le somme dovute per IVA e ritenute operate e non versate, se di importo rilevante, possono esporre l’amministratore a responsabilità penale (reati tributari di omesso versamento IVA o ritenute, puniti dagli artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000), anche se ciò non crea una responsabilità civile diretta per il debito tributario (la responsabilità resta della società, salvo casi di abuso). L’ordinamento prevede però la possibilità di definire i debiti fiscali in modo agevolato (es. “rottamazione” delle cartelle che periodicamente viene varata con legge di bilancio, permettendo il pagamento senza sanzioni e interessi) o di dilazionarli (rateizzazioni fino a 6 anni o 10 anni in certi casi). Inoltre, negli strumenti di composizione della crisi (accordi o concordati) è possibile proporre una transazione fiscale, cioè un trattamento dei debiti fiscali con pagamento parziale e/o dilazionato, che se approvato (o omologato) vincola l’Erario . Per il debitore, i debiti tributari sono tra i più “sensibili” perché il Fisco è sia incentivato dalla legge a segnalare la crisi (allerta) sia dotato di prelazioni sul patrimonio. Ignorare il Fisco significa quasi certamente subire azioni esecutive aggressive o opposizioni ai piani di rientro. Pertanto, la difesa su questo fronte consiste nell’attivare per tempo gli strumenti (chiedere rateazioni, aderire a eventuali sanatorie, inserire il Fisco in un piano di ristrutturazione con transazione fiscale) e nel rispettare i pagamenti correnti (ad esempio l’IVA corrente andrebbe versata, se possibile, per non aggravare la posizione con nuovi debiti prededucibili).
- Debiti previdenziali e verso enti (INPS, INAIL ecc.): sono somme dovute per contributi pensionistici dei dipendenti e altre contribuzioni obbligatorie. Hanno natura simile ai debiti tributari: l’INPS, così come l’INAIL (assicurazione infortuni), può iscrivere a ruolo i crediti e affidarli all’Agenzia Riscossione per la riscossione forzata. Anche questi crediti godono di privilegio generale sul patrimonio del debitore (ex art. 2753 c.c. per i contributi). Inoltre, l’omesso versamento di contributi previdenziali per i dipendenti oltre una certa soglia (€10.000 annui) costituisce reato (art. 2 D.L. 463/1983, conv. L. 638/1983), esponendo l’amministratore a sanzioni penali salvo pagamento entro termini di legge. L’INPS ha anch’esso obblighi di segnalazione in caso di ritardi contributivi significativi . Non di rado, l’INPS può insinuarsi in procedure concorsuali non solo per contributi, ma anche come surroga del Fondo di Garanzia (che anticipa TFR e ultime mensilità ai dipendenti in caso di insolvenza del datore). Dal punto di vista difensivo, valgono considerazioni analoghe a quelle fiscali: si possono chiedere dilazioni (l’INPS concede rateazioni del debito contributivo), oppure includere l’ente in un accordo o concordato con trattamento dei crediti contributivi (analogamente alla transazione fiscale, da estendere ai contributi). Il CCII consente di trattare insieme tributi e contributi negli accordi di ristrutturazione . La legge n. 159/2020 ha chiarito la possibilità del cram-down sui crediti erariali e contributivi: il tribunale può omologare un concordato o accordo anche senza l’adesione dell’INPS, purché il trattamento offerto non sia inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione . Difendersi dai debiti contributivi significa anche evitare che lievitino per sanzioni: se l’azienda non riesce a pagarli integralmente, può essere opportuno avviare una procedura concorsuale che congeli sanzioni e interessi (nel concordato spesso sanzioni e interessi possono essere falcidiati).
- Debiti bancari e finanziari: comprendono mutui, finanziamenti, scoperti di conto, anticipazioni su fatture, leasing, ecc. Le banche e le società di leasing sono creditori molto organizzati e reattivi. In caso di insolvenza dell’azienda, le banche possono revocare gli affidamenti (fidi di cassa o castelletto effetti), chiedere il rientro immediato e, se la società non paga, avviare azioni legali. Spesso i debiti bancari sono garantiti da pegno su beni mobili (es. pegno su macchinari acquistati in leasing sino a riscatto) o da ipoteca su immobili aziendali. Inoltre, non è raro che i soci o amministratori abbiano firmato fideiussioni personali a garanzia dei debiti bancari della società. Ciò significa che, in caso di insolvenza della società, la banca potrà aggredire anche il patrimonio personale dei fideiussori (si pensi all’abitazione di un socio data in garanzia ipotecaria). Le società di leasing, se l’azienda non paga i canoni, possono procedere a risolvere il contratto e a riprendere i beni in leasing (macchinari, veicoli) in tempi rapidi. Nei confronti delle banche, un’azione immediata che queste intraprendono sono i decreti ingiuntivi: data l’evidenza del credito da estratti conto, la banca ottiene un decreto ingiuntivo esecutivo e procede a pignoramenti (ad esempio c/c, attrezzature non vincolate, crediti verso clienti). I crediti bancari garantiti (mutuo ipotecario, leasing traslativo) hanno privilegi speciali sui beni dati in garanzia: in una eventuale liquidazione i creditori ipotecari e pignoratizi vengono soddisfatti con precedenza sul ricavato del bene vincolato. Spesso però i beni a garanzia coprono parzialmente il credito, per cui la banca rimane anche creditore chirografario per la differenza. Per difendersi dai crediti bancari l’azienda ha alcune leve: può cercare una rinegoziazione del debito (ad esempio un allungamento dei piani di rientro) con accordo stragiudiziale; in prospettiva concorsuale, può inserirli in un accordo di ristrutturazione con falcidia (se la banca aderisce) oppure in un concordato preventivo suddividendoli in classi e proponendo il pagamento parziale secondo le stime di realizzo dei beni. Le banche sono spesso disposte a trattare all’interno di un piano concordatario se vedono che la soluzione proposta offre più di quanto otterrebbero da un fallimento (liquidazione giudiziale). Una tutela per l’imprenditore è la moratoria delle azioni esecutive: come vedremo, presentando domanda di concordato o accordo con misure protettive, si blocca temporaneamente l’aggressione bancaria. Inoltre, per i fideiussori, la legge prevede che se il debitore principale accede a una procedura di concordato, i creditori finanziari non possano pretendere subito l’intero importo dai garanti: c’è il beneficio della preventiva escussione del debitore principale fino a concorrenza di quanto pagherà in procedura (art. 184 L.F. prev., ora analogamente nel CCII). Tuttavia, questo non impedisce che se l’azienda paga solo una percentuale del debito in concordato, la banca agirà sul fideiussore per la differenza. Nella gestione della crisi, potrebbe convenire coinvolgere le banche in accordi di ristrutturazione dedicati: il CCII ha introdotto figure come l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ai creditori finanziari dissenzienti se il 75% di quella categoria aderisce . Ciò significa che convincendo una larga parte di banche, l’accordo può vincolare anche eventuali banche che non firmano, evitando azioni isolate di disturbo. In sostanza, i debiti bancari vanno affrontati di petto, presentando piani credibili e coinvolgendo le banche nella soluzione (spesso con l’ausilio di un attestatore indipendente che certifichi la fattibilità del piano, condizione cui gli istituti tengono molto).
- Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: sono i debiti commerciali (fatture non pagate ai fornitori di materie prime, servizi, ecc.), i debiti verso professionisti, e più in generale tutti i crediti non privilegiati (chirografari) che non rientrano nelle categorie sopra. Questi creditori normalmente non hanno garanzie reali né strumenti speciali: devono tutelarsi agendo in via giudiziale ordinaria (ingiunzioni, cause) e, una volta ottenuto un titolo, tramite pignoramenti. Il singolo fornitore tuttavia spesso ha importi modesti in credito e potrebbe non attivarsi subito giudizialmente per costi/benefici, preferendo magari sospendere le forniture in attesa di un pagamento. Tuttavia, quando la crisi si protrae, è frequente che alcuni fornitori strategici (quelli senza cui la produzione si ferma) esercitino una forte pressione, mentre altri possano minacciare cause. Nelle procedure concorsuali, i fornitori chirografari sono i creditori meno tutelati, in quanto verranno soddisfatti solo residualmente, dopo privilegiati e garantiti, spesso con percentuali basse. Ciò li rende in generale ben disposti a trattare stragiudizialmente con l’azienda un accordo (meglio ricevere magari il 40% in tempi certi che rischiare il 10% dopo anni di fallimento). L’imprenditore debitore può quindi cercare accordi individuali di saldo e stralcio con alcuni fornitori (ad esempio offrendo una percentuale immediata e il resto dilazionato, magari con promessa di continuare il rapporto commerciale). Attenzione però: se l’azienda poi entra in liquidazione giudiziale, i pagamenti preferenziali fatti ai fornitori prima della procedura (nell’ultimo semestre/anno) possono essere revocati dal curatore come pagamenti preferenziali o atti a titolo oneroso a seconda dei casi , salvo che rientrino nei pagamenti “nei termini d’uso” (pagamenti ordinari alle scadenze normali) che sono esenti . È quindi rischioso pagare alcuni fornitori e lasciarne altri a bocca asciutta quando si è in odore di fallimento: ciò può essere annullato e generare anche responsabilità penale per bancarotta preferenziale. Meglio è gestire i fornitori all’interno di un piano unitario (accordo o concordato) in cui tutti ricevono un trattamento paritario (ad es. tot% in X anni). In un concordato, i fornitori chirografari possono essere messi in un’unica classe o in più classi omogenee e hanno diritto di voto: se la maggioranza approva la proposta, anche i dissenzienti sono obbligati (si forma la maggioranza concorsuale). Nella pratica, i fornitori, se opportunamente coinvolti e informati, possono sostenere un concordato votandolo favorevolmente se la percentuale offerta è ragionevole rispetto alle alternative. Dal lato difensivo, quindi, è essenziale comunicare con i fornitori strategici durante la crisi, evitare di nascondersi (atteggiamento che spesso li spinge subito dall’avvocato), magari concordare moratorie temporanee sulle forniture o dilazioni brevi in attesa di presentare un piano di ristrutturazione. Ci sono anche strumenti formalizzati come la convenzione di moratoria (art. 62 CCII) che è un accordo stipulato con una categoria di creditori – ad esempio un gruppo di fornitori – per differire le scadenze di comune intesa . È uno strumento poco usato finora, ma previsto dalla legge, con effetti protettivi verso coloro che vi aderiscono (possono impegnarsi a non agire esecutivamente per un certo periodo in attesa del piano).
- Debiti verso dipendenti: riguardano stipendi non pagati, TFR maturato, ecc. I dipendenti hanno privilegi speciali sia generali che sui beni mobili e immobili (fino a certi importi) ai sensi degli artt. 2751-bis c.c. e ss. In caso di procedura concorsuale, i loro crediti per retribuzioni degli ultimi mesi e per TFR sono soddisfatti in prededuzione o privilegio molto elevato. Inoltre, se l’azienda va in liquidazione giudiziale, interviene il Fondo di Garanzia INPS a pagare TFR e ultime tre mensilità ai lavoratori, surrogandosi poi nel credito in procedura. Durante la crisi, se la società ritarda gli stipendi, i dipendenti possono agire sia in giudizio (decreto ingiuntivo in tempi rapidi) sia, in casi estremi, tramite istanza di fallimento (un singolo dipendente come creditore può chiederlo, se il credito è certo, liquido ed esigibile). Tuttavia, l’esperienza insegna che i dipendenti sono spesso più pazienti di altri creditori se credono nel salvataggio dell’azienda, anche perché sperano di conservare il posto di lavoro. Nei concordati in continuità, la legge tutela fortemente i diritti dei lavoratori: i piani devono assicurare il pagamento integrale delle retribuzioni pregresse entro un breve termine. Ad esempio, nel Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO) introdotto nel 2022, i lavoratori non votano ma devono essere pagati entro 30 giorni dall’omologazione . Dunque, per il debitore, i debiti verso dipendenti sono una priorità morale e legale: occorre prevederne il pagamento integrale in qualsiasi scenario di continuità. Diverso è se l’attività cessa: allora subentrerà il Fondo di garanzia. La miglior difesa qui è la trasparenza e la lealtà con i dipendenti: informarli della situazione, spiegare che si sta preparando un piano che tutela i loro crediti (magari anticipando qualche mensilità grazie a accordi col fondo di tesoreria), per evitare che perdano fiducia e si rivolgano subito al tribunale.
- Debiti verso soci o parti correlate: a volte l’azienda ha ricevuto finanziamenti dai soci (finanziamenti infruttiferi) o da parti correlate. Questi crediti, in caso di procedura, sono postergati (i soci vengono rimborsati per ultimi, ex art. 2467 c.c. per le SRL). Dunque in un concordato raramente prendono qualcosa. È utile saperlo perché eventuali rimborsi fatti ai soci prima della procedura potrebbero essere contestati come atti in frode. Dal lato difesa, coinvolgere i soci-creditori significa anche chiedere loro di convertire quei crediti in capitale o rinunciarvi, come gesto per facilitare la ristrutturazione (spesso richiesto dai commissari/giudici come segnale di assunzione di responsabilità da parte della proprietà).
Questa disamina evidenzia che non tutti i debiti “pesano” allo stesso modo. Alcuni creditori (Stato, enti, banche) hanno armi più affilate o posizioni privilegiate, altri sono più deboli ma numerosi (fornitori, soci). Nella tabella seguente riassumiamo le caratteristiche chiave:
Tabella 1: Tipologie di debiti e strategie di gestione
| Tipo di debito | Strumenti del creditore | Grado di priorità in concorso | Strategie di difesa del debitore |
|---|---|---|---|
| Fiscale (Erario) | Cartella esattoriale; ipoteca; pignoramenti senza giudizio; possibile insinuazione al fallimento. | Privilegi su beni mobili e immobili (es. IVA privilegiata); prededuzione per IVA trattenuta. | Rateizzazioni; transazione fiscale in accordi/concordati; attivare composizione negoziata per sospendere interessi; pagare l’IVA corrente; sfruttare “rottamazioni” normative. |
| Contributivo (INPS) | Avviso di addebito e cartella; pignoramenti tramite AER; segnalazione d’allerta. | Privilegio generale sui beni (contributi); intervento Fondo di Garanzia su TFR e ultime 3 mensilità. | Rateizzazioni con INPS; transazione su contributi insieme al Fisco; versare contributi correnti (per evitare reati); includere nel piano concordatario con stessa percentuale del Fisco. |
| Bancario/Leasing | Decreto ingiuntivo; esecuzione immobiliare/ipotecaria; risoluzione leasing e ritiro bene; escussione fideiussioni personali. | Ipoteca o pegno (crediti ipotecari e pignoratizi soddisfatti sul ricavato bene); chirografo per parte scoperta; eventuale prededuzione se finanziamenti in procedura autorizzati. | Negoziare ristrutturazione del debito (allungamento, riduzione tasso); coinvolgere banche in accordo ristrutturazione (anche ad efficacia estesa) ; utilizzare misure protettive del tribunale per congelare esecuzioni; in concordato, classare le banche separate dai chirografari comuni; attenzione alle fideiussioni (valutare procedura sovraindebitamento per i garanti se l’azienda fallisce). |
| Fornitori (trade) | Azione ordinaria (ingiunzione) e pignoramento su conti, magazzino, crediti; sospensione forniture; possibile istanza di fallimento se credito rilevante. | Chirografari (nessuna garanzia), salvo talvolta piccoli privilegi ex art. 2751-bis (es. artigiani, professionisti ultimi 2 anni). Di solito soddisfatti con percentuale bassa se liquidazione. | Negoziare dilazioni e saldo a stralcio individuali con accordi stragiudiziali (rischio revocatoria se favoritismi); ricorrere a convenzione di moratoria (accordo collettivo per aspettare) ; in concordato, offrire una percentuale ragionevole e tempi certi per ottenere il loro voto; comunicare trasparenza per evitare cause isolate; evitare pagamenti preferenziali a pochi (rischio revoca). |
| Dipendenti | Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; insinuazione privileggiata; istanza di fallimento (meno frequente). | Privilegi altissimi su attrezzature e su attivo (ultimi 6 mesi pagati in prededuzione; TFR privilegiato); Fondo INPS paga e surroga. | Dare priorità assoluta: cercare di pagare stipendi correnti; includere eventuali arretrati nel piano con pagamento integrale o utilizzare il Fondo di Garanzia se liquidazione; mantenere la forza lavoro motivata spiegando il piano di rilancio; considerare cassa integrazione straordinaria per crisi, se disponibile, per alleviare costi del personale durante il risanamento. |
| Altri (soci, parti correlate) | Azione legale come chirografari (ma spesso attendono esito procedura); crediti postergati ex lege. | Postergazione (soci finanziatori sono soddisfatti dopo tutti gli altri creditori, se avanza attivo). | Far convergere i crediti soci in capitale (rinunce, conversioni) per migliorare patrimonio netto; astenersi dal rimborsare soci in crisi (sarebbe atto in frode); eventualmente includere solo se necessario e subordinatamente agli altri creditori nei piani. |
(Legenda: AER = Agenzia Entrate-Riscossione; prededuzione = pagamento prioritario perché credito sorto durante procedura o così qualificato dalla legge.)
Questa panoramica consente al debitore di capire chi può fare cosa: ad esempio, se Alfa S.r.l. ha 100 mila euro di debiti con fornitori e 100 mila con il Fisco, quest’ultimo è più probabile che avvii pignoramenti a breve tramite la riscossione coattiva, mentre i fornitori potrebbero temporeggiare ma hanno comunque diritto di fare istanza di fallimento se il credito è certo e scaduto. Anche la priorità in caso di default influisce: i fornitori sanno di essere ultimi in coda e quindi tendono a preferire soluzioni concordate; il Fisco e le banche con ipoteca sanno di avere precedenze e potrebbero essere meno flessibili, ma il nuovo quadro normativo impone anche a loro di sedersi al tavolo (pena il cram-down).
In definitiva, una buona strategia difensiva per l’imprenditore con debiti multi-tipologia è: mappare i debiti, avviare un dialogo (diretto o tramite professionisti) con i creditori maggiori e qualificati (Erario, banca, fornitori principali), congelare le azioni esecutive attivando per tempo una procedura del Codice (che sospende pignoramenti e cause) e predisporre un piano di ristrutturazione sostenibile che offra a ciascun creditore un trattamento ragionevole e legalmente ammissibile. A tal fine, passiamo ora in rassegna gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal nostro ordinamento, distinguendo tra quelli negoziali stragiudiziali e quelli concorsuali giudiziali.
Strumenti stragiudiziali (negoziali) per regolare la crisi d’impresa
Quando un’azienda è in difficoltà ma vuole evitare di finire direttamente in procedura concorsuale giudiziale, esistono diverse soluzioni stragiudiziali – cioè che non richiedono l’apertura immediata di una procedura davanti al tribunale – per risanare o ristrutturare il debito. Questi strumenti puntano essenzialmente su un accordo volontario tra il debitore e i suoi creditori (tutti o una parte di essi), se necessario con l’ausilio di professionisti terzi. Il Codice della Crisi disciplina e favorisce tali soluzioni, in quanto spesso permettono di evitare il default formale e di preservare la continuità aziendale. Vediamo i principali.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è una procedura innovativa, introdotta nell’ordinamento italiano nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora regolata negli artt. 12-25 del CCII , pensata per aiutare l’imprenditore in crisi a trovare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. Si tratta di uno strumento volontario e riservato (non comporta pubblicità né il formale stigma del fallimento) e può essere attivato dall’imprenditore commerciale che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza (quindi già in crisi o anche in prima fase di insolvenza reversibile). Ecco come funziona a grandi linee:
- L’imprenditore presenta istanza di accesso alla composizione negoziata tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio). Nella domanda fornisce informazioni economiche e le cause delle difficoltà.
- Un’apposita commissione nomina un esperto indipendente (di norma un commercialista o esperto di ristrutturazioni iscritto in un elenco ministeriale) il cui compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori. L’esperto, terzo e imparziale, analizza la situazione aziendale e convoca i creditori chiave per cercare una soluzione concordata.
- Durante la composizione negoziata, l’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda (non c’è spossessamento), ma deve operare in buona fede e in collaborazione con l’esperto, il quale a sua volta deve adoperarsi per trovare punti di convergenza e soluzioni praticabili.
- Uno dei vantaggi è che l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee: il tribunale, valutati i presupposti, può disporre la sospensione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori per la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili di altri 4). Questo scudo serve a creare uno spazio di negoziazione libero dalla pressione dei pignoramenti . Le misure protettive sono pubblicate nel registro delle imprese, ma la procedura in sé resta riservata (non viene dichiarata ai terzi la situazione di crisi, se non appunto per l’effetto notorio di sospensione procedimenti).
- L’obiettivo finale è raggiungere un accordo (anche plurilaterale) che può assumere diverse forme: accordo stragiudiziale libero (una semplice rinegoziazione privata con alcuni creditori), oppure uno degli strumenti che vedremo (un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato). La composizione negoziata può quindi sfociare in un accordo contrattuale oppure fungere da preludio a un concordato semplificato se le trattative non riescono. In ogni caso, l’esperto redige una relazione finale sull’esito.
La composizione negoziata è una sorta di “camera di mediazione” della crisi: non è una procedura concorsuale, nessun tribunale dichiara lo stato dell’impresa, ma c’è un supporto esperto e una cornice normativa che favorisce il dialogo. Se l’accordo riesce, può restare riservato e l’azienda esce dalla crisi senza passare dal tribunale (ad esempio l’imprenditore ottiene nuovi fidi dalla banca, i fornitori accettano un piano di rientro e l’Erario concede la rateizzazione straordinaria – tutte intese che l’esperto può facilitare). Da notare che gli atti compiuti durante le trattative autorizzati dall’esperto o coerenti col piano non possono essere revocati in seguito (c’è un’esenzione da revocatoria per finanziamenti e pagamenti eseguiti nell’ambito della composizione negoziata, ex art. 23 CCII). Il legislatore ha anche previsto incentivi fiscali e penali, come la riduzione degli interessi e sanzioni fiscali se poi l’azienda accede a concordato , e attenuanti in caso di bancarotta semplice se il titolare ha attivato per tempo la composizione negoziata .
Se la composizione negoziata fallisce (cioè non si raggiunge alcun accordo e l’azienda è insolvente), l’esperto lo comunica e l’imprenditore può decidere di accedere a un’altra procedura. In tale caso, la legge ha previsto una via d’uscita semplificata: il concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio. Questo strumento, introdotto inizialmente in via transitoria e poi confermato, consente al debitore, in caso di esito negativo della composizione negoziata, di chiedere direttamente l’omologazione di un concordato liquidatorio senza passare per il voto dei creditori . È una soluzione “d’emergenza” per liquidare l’azienda con l’ausilio del tribunale, presentando un piano di realizzo di tutti i beni e riparto ai creditori. Nel concordato semplificato, i creditori non votano (proprio perché le trattative precedenti sono fallite), il tribunale valuta la fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e può omologare il piano anche se i creditori sono scontenti, purché sia garantito un trattamento non inferiore a quello fallimentare. Ad esempio, Alfa S.r.l. tenta la composizione negoziata ma i creditori non trovano accordo; l’esperto certifica il tentativo infruttuoso; l’azienda allora può proporre un concordato semplificato dove magari vende l’attività a un terzo e distribuisce il ricavato – il tribunale può approvarlo tagliando fuori il voto dei creditori, a patto che a questi arrivi almeno quanto otterrebbero in fallimento. Questa è una forte leva per evitare di passare immediatamente alla liquidazione giudiziale. Recentemente il Tribunale di Mantova (ord. 16 febbraio 2024) ha ammesso che anche nel concordato semplificato il debitore può inserire classi di creditori differenziate (pur senza voto) per trattare diversamente certe posizioni, giudicando ciò compatibile col carattere “semplificato” e finalizzato all’equità . Tale prassi è stata poi espressamente legittimata con le modifiche di fine 2024 (D.Lgs. 136/2024) che hanno ulteriormente chiarito la disciplina.
In definitiva, la composizione negoziata è consigliabile quando l’impresa è in uno stadio iniziale di crisi: offre un tentativo economico e rapido di evitare il default, con la comodità di tenere riservata la situazione e di congelare temporaneamente le aggressioni. Dal lato “difensivo”, consente all’imprenditore di guadagnare tempo e costringere tutti i creditori attorno a un tavolo, senza però cedere il controllo dell’azienda. Bisogna però arrivarci preparati: il piano che si negozia deve essere realistico e l’impresa deve avere prospettive di risanamento (la composizione negoziata non è adatta a chi è già totalmente decotto e senza alcuna possibilità se non liquidare).
Esempio: Alfa S.r.l. con debiti bancari e verso fornitori per 1 milione attiva la composizione negoziata. L’esperto nominato riesce a far accordare la banca a non revocare i fidi ma a confermarli per 6 mesi, i fornitori ad accettare pagamenti parziali a 120 giorni, mentre l’azienda cerca un investitore. In 3 mesi Alfa trova un partner che apporta capitali freschi: a quel punto viene formalizzato un accordo di ristrutturazione (vedi oltre) con cui i creditori tagliano il 30% dei crediti e ottengono il resto a rate grazie all’ingresso dei nuovi fondi. Il tutto senza mai passare per una dichiarazione di fallimento né interrompere la produzione. Questo scenario ideale è ciò a cui punta la composizione negoziata.
Va notato che se durante la composizione l’esperto si accorge che l’imprenditore sta agendo in mala fede (es. distrae beni) o che l’insolvenza è irreversibile, può segnalarlo al tribunale e ciò può condurre all’apertura di una liquidazione giudiziale su istanza del PM. Quindi va utilizzata seriamente e non per perdere tempo.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento stragiudiziale puro, già previsto dalla vecchia legge fallimentare (art. 67 co. 3 lett. d) L.F.) e ora disciplinato dall’art. 56 CCII. Consiste in un piano industriale e finanziario predisposto dall’imprenditore in crisi o insolvente, avente l’obiettivo di risanare l’esposizione debitoria e assicurare la continuità aziendale, corredato da una relazione di un professionista indipendente (l’“attestatore”) che ne certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità.
In sostanza, l’imprenditore elabora un piano di rilancio (ad esempio: ristrutturazione del debito con dilazioni, taglio costi, cessione di asset non strategici, apporto di nuovi capitali) e un professionista (es. commercialista o revisore, iscritto agli albi e indipendente dalle parti) redige un’attestazione scritta in cui dichiara che i numeri di partenza sono corretti e che il piano è idoneo a garantire il risanamento dell’impresa e il riequilibrio della situazione finanziaria. Questo piano, con l’attestazione, viene “pubblicato” nel Registro delle Imprese su istanza del debitore. La pubblicazione ha l’effetto di rendere opponibile ai terzi la data del piano.
Il vantaggio di un piano attestato è duplice:
1. Effetto protettivo sulle azioni revocatorie: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato e coerentemente indicati nel piano stesso non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . Ciò significa che, se malauguratamente la società dovesse fallire dopo aver tentato il risanamento, le operazioni compiute in buona fede secondo il piano (ad es. pagamenti a fornitori strategici, vendite di beni per pagare debiti) non potranno essere annullate dal curatore – salvo casi di dolo. Questo dà sicurezza a chi contratta col debitore in crisi: se fornitore e debitore seguono un piano attestato, i pagamenti ricevuti dal fornitore non saranno restituiti.
2. Nessuna pubblicità di una procedura concorsuale: il piano attestato non è una procedura giudiziaria, quindi l’impresa non subisce la dichiarazione di insolvenza né la nomina di organi concorsuali. Rimane sotto controllo dell’imprenditore. È una soluzione privata – seppur con il bollino dell’attestatore – e come tale spesso preferita quando il numero di creditori è limitato e c’è fiducia reciproca.
Tuttavia, il piano attestato di risanamento di per sé non vincola i creditori a meno che essi aderiscano contrattualmente. È in sostanza un accordo stragiudiziale che poggia sul piano attestato: il debitore normalmente negozia con ciascun creditore chiave un accordo (es: “ti pago il 80% del dovuto in 24 mesi, come da piano attestato”). Se i creditori accettano e il piano è attestato, quell’accordo beneficia delle protezioni suddette. Ma se un creditore non aderisce, non c’è modo di imporgli il piano (a differenza del concordato, qui manca il voto e l’omologazione). Quindi il piano attestato funziona bene quando c’è un consenso quasi unanime dei creditori principali. Di solito lo si usa in imprese non troppo grandi, con pochi creditori rilevanti, oppure come cornice per rifinanziamenti bancari (le banche spesso chiedono il piano attestato prima di concedere nuova finanza per attestare la tenuta prospettica).
Un aspetto tecnico: il professionista attestatore si assume una grande responsabilità, anche penale, se attesta il falso o omette informazioni rilevanti. Quindi in pratica il piano attestato è credibile sul mercato se fatto con serietà e da professionisti stimati. La relazione deve espressamente concludere che l’impresa uscirà dalla crisi attuando il piano (non basta pagare i debiti, deve risultare ragionevole la continuazione).
Il piano può prevedere diverse operazioni: ristrutturazione dei debiti (anche falcidia, ma solo se creditori consenzienti individualmente), interventi sul capitale (aumenti di capitale, ingresso di soci), cessione di beni non strategici per fare cassa, conversione di crediti in capitale (se i creditori accettano diventano soci), ecc. L’importante è che l’attestatore valuti che, facendo tutto ciò, l’azienda tornerà in bonis entro un orizzonte definito.
In sintesi, il piano attestato è uno strumento di difesa soft: l’imprenditore mantiene il timone, evita pubblicità negativa, ottiene protezione per gli atti esecutivi del piano, ma deve convincere i creditori uno per uno. Se c’è un creditore ostile con quota significativa di debito, il piano attestato può non bastare – in tal caso occorrerà un procedimento omologato (accordo o concordato).
Esempio: Alfa S.r.l. ha 5 banche finanziatrici e 10 fornitori principali. La situazione è di crisi ma recuperabile con nuove commesse in arrivo. Alfa elabora un piano a 5 anni dove promette pagamento integrale dei debiti con un periodo di moratoria di 6 mesi e poi rate semestrali, grazie a nuove linee di credito che due banche concedono e a un nuovo socio che apporta liquidità. Un attestatore indipendente verifica i dati (ordini futuri, costi, fatturato atteso) e certifica che il piano è fattibile e ridurrà l’esposizione entro 5 anni. Tutte le banche e fornitori firmano un accordo di ristrutturazione aderendo a questo piano. L’accordo non passa dal tribunale, ma viene semplicemente “accompagnato” dalla pubblicazione del piano attestato. Le banche continuano a sostenere Alfa, i fornitori continuano a fornire materiale secondo i nuovi termini. Dopo 3 anni Alfa è risanata e i debiti pregressi risultano pagati secondo il piano. Questo è il caso di successo tipico di un piano attestato – spesso basato su relazioni di fiducia tra azienda e creditori (capita in distretti industriali in cui la crisi è percepita come temporanea e tutti fanno squadra).
Uno svantaggio del piano attestato è la mancanza di misure protettive automatiche: non c’è un automatic stay, quindi durante la predisposizione del piano i creditori potrebbero agire. Tuttavia, l’imprenditore può combinare gli strumenti: ad esempio, aprire una composizione negoziata per ottenere la moratoria delle azioni, e parallelamente predisporre un piano attestato da chiudere poi con accordi, terminando così la composizione negoziata con successo. Questo uso ibrido è consentito e anzi spesso suggerito (la composizione negoziata può preludere a un piano attestato pubblicato che sancisce la fine delle trattative con accordo raggiunto).
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso indicati con l’acronimo ADR – accordi di ristrutturazione) sono anch’essi strumenti di natura negoziale ma con un intervento giudiziale di omologazione. Rappresentano un “punto di incontro” tra soluzioni private e procedure concorsuali: il debitore e una parte significativa dei creditori trovano un accordo sulle modalità di ristrutturazione del debito, e successivamente chiedono al tribunale di omologare (convalidare) tale accordo, rendendolo vincolante anche per eventuali minoranze. Si evitano così il voto assembleare tipico del concordato e la procedura lunga, ma si ottiene un decreto giudiziale che “sigilla” l’accordo dandogli efficacia esecutiva e alcune protezioni.
Le caratteristiche salienti degli accordi di ristrutturazione sono:
- Devono coinvolgere un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali del debitore (nel formato “ordinario” previsto dall’art. 57 CCII) . Ciò significa che il debitore deve ottenere l’adesione formale (sottoscrizione dell’accordo) da creditori che detengono almeno il 60% del valore complessivo dei debiti. Non occorre il 100%, ma almeno più della metà in valore. È una soglia più alta rispetto al concordato (dove basta la maggioranza dei votanti), ma è calcolata sull’intero monte debiti.
- Deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la idoneità dell’accordo a assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti nei termini di legge (entro 120 giorni da omologazione o scadenza, se privilegiati) e in generale la fattibilità del piano di accordo. Questa attestazione serve a tutelare i creditori estranei. Ad esempio, se il 70% dei creditori firma e accetta di prendere il 70% del credito, per l’omologazione l’attestatore deve confermare che il restante 30% che non ha firmato verrà comunque pagato per intero nei tempi previsti, oppure depositato in conti vincolati (a meno che anch’essi decidano di aderire in seguito).
- Una volta depositato l’accordo e la documentazione, il tribunale apre un procedimento ma non c’è una votazione. Il tribunale verifica la regolarità e, se tutto è a posto (quorum raggiunto, attestazione positiva, convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria assicurata per i non aderenti), emette un decreto di omologazione. Da quel momento, l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori aderenti e per l’eventuale “minoranza forzata” in base al tipo di accordo (come vedremo).
- Durante il periodo tra il deposito e l’omologazione (e anche già con il deposito della domanda di omologazione), su istanza del debitore il tribunale può disporre le solite misure protettive (sospensione azioni esecutive dei creditori per dare respiro sino all’omologa, simile al concordato) .
- L’accordo omologato è riconosciuto dall’ordinamento come titolo non soggetto a revocatoria (come per il piano attestato: gli atti eseguiti in suo adempimento sono protetti ) e offre alcuni benefici (sospensione obblighi di ricapitalizzazione se perdite, ecc., analogamente al concordato, vedi art. 64 CCII ).
Il CCII prevede vari tipi di accordo di ristrutturazione, recependo innovazioni anche dal correttivo 2022:
- Accordo “semplice” o ordinario (art. 57): richiede il 60% dei crediti. I creditori non aderenti restano estranei, cioè conservano i loro diritti per intero (devono essere pagati integralmente). L’utilità di omologare un accordo al 60% sta soprattutto nel fatto che i creditori aderenti godono della moratoria e dell’esenzione da revocatoria, e si ottiene un effetto di “stabilità” (l’accordo omologato non può essere attaccato successivamente se il debitore adempie, e in caso di inadempimento si possono usare rimedi contrattuali). Ma i creditori fuori accordo possono agire normalmente, salvo chiedere misure protettive temporanee.
- Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60): è un’introduzione nuova. Permette di omologare un accordo anche con una percentuale di creditori inferiore al 60%, purché non inferiore al 30%, in presenza di determinate condizioni che rendono più agevole la formazione dell’accordo . È chiamato “agevolato” perché riduce il quorum necessario rispetto al 60%. Ad esempio, se solo il 50% dei crediti aderisce, l’accordo può comunque essere omologato come “agevolato” se il debitore dimostra che ha difficoltà a raggiungere 60 ma quell’accordo conviene a tutti. Questo strumento è stato previsto per facilitare le imprese che hanno molti piccoli creditori dispersi: un blocco di creditori forte che aderisce può bastare. Chiaramente valgono le stesse tutele: i non aderenti vanno soddisfatti integralmente (hanno diritto di “veto” sostanziale se non vengono pagati per intero).
- Accordo ad efficacia estesa (art. 61): qui l’attenzione è su particolari categorie di creditori. In origine, la L.F. prevedeva (art. 182-septies) la possibilità di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori finanziari dissenzienti (banche e obbligazionisti) se almeno il 75% di quella categoria aveva aderito, e analogamente (art. 182-octies) per creditori fiscali e previdenziali con determinate condizioni. Il CCII ha ripreso queste figure: l’accordo ad efficacia estesa consente che, se certi creditori qualificati aderenti raggiungono una maggioranza qualificata, il tribunale possa omologare l’accordo estendendone gli effetti anche ai creditori della stessa categoria che non hanno aderito . In particolare, la norma attuale consente efficacia estesa: (i) ai creditori finanziari (banche, intermediari) se almeno il 75% di essi ha sottoscritto l’accordo, estendendolo al restante 25% circa che non ha firmato (ma solo se offerto loro lo stesso trattamento); (ii) ai creditori con forniture strategiche (fornitori essenziali, ecc.) se almeno 75% di essi aderisce; (iii) in certi casi anche al Fisco e INPS, ma qui la situazione è stata evolutiva – oggi, grazie alla modifica del 2023, è possibile l’omologazione forzosa del trattamento fiscale e contributivo anche senza adesione delle Agenzie, a patto di rispettare la convenienza rispetto alla liquidazione (il cosiddetto cram-down fiscale). In pratica, l’accordo ad efficacia estesa è utile quando si ha quasi tutti i membri di una classe omogenea d’accordo tranne qualcuno: invece di far saltare l’intesa per pochi contrari, il tribunale li “aggrega” lo stesso. La ratio è evitare il free-riding: se 3 banche su 4 accettano un piano di rientro, la quarta non deve poter rovinare tutto sperando di essere pagata al 100% comunque. Con l’efficacia estesa, quella quarta banca è costretta ad accettare lo stesso trattamento approvato dalla maggioranza qualificata dei suoi pari. Naturalmente deve essere soddisfatto il test di convenienza: l’attestatore e il tribunale verificano che anche per il dissenziente l’accordo è migliorativo rispetto a quel che otterrebbe dal fallimento.
- Accordi in esecuzione di piani attestati (art. 57 co. 3): il CCII menziona anche la possibilità di omologare accordi conclusi in attuazione di un piano attestato pubblicato . È una sorta di combinazione: magari il debitore ha già un piano attestato firmato coi creditori, ma vuole l’omologazione per avere le protezioni di legge. Questa è una fattispecie tecnica meno utilizzata nella prassi finora.
- Convenzione di moratoria (art. 62): non è esattamente un accordo di ristrutturazione, ma la citiamo qui per completezza sugli strumenti negoziali. Si tratta di un accordo stipulato con creditori appartenenti a una o più categorie omogenee (ad es. tutte le banche) che ha per oggetto la moratoria temporanea dei crediti di tali creditori e l’eventuale esenzione da revocatoria dei pagamenti fatti in attuazione. Serve a “prendere tempo” in attesa di un successivo accordo più ampio o di un concordato. La convenzione di moratoria vincola anche la minoranza dissenziente di quella categoria se approvata da almeno il 75% dei crediti di quella categoria . È insomma un patto di standstill: i creditori finanziari ad esempio concordano di congelare le escussioni per X mesi, cosicché l’impresa possa predisporre il piano. È uno strumento di nicchia, intermedio tra composizione negoziata (che comunque può prevedere misure protettive generali) e accordo vero e proprio.
Iter pratico di un accordo di ristrutturazione ordinario: il debitore, con l’aiuto di consulenti, negozia con i creditori principali un certo trattamento del debito (ad es. pagamento del 40% in 5 anni per chirografari e 100% a scadenze originali per privilegiati). Raccoglie le adesioni firmate per iscritto di creditori rappresentanti almeno il 60%. Predispone un piano e lo fa attestare. Deposita ricorso in tribunale con tutta la documentazione contabile. Il tribunale può concedere subito la sospensione delle azioni esecutive (moratoria), poi fissa un’udienza. Se nessun creditore (né eventuali terzi) fa opposizione o se le opposizioni vengono respinte, omologa l’accordo. Da quel momento, i creditori che hanno firmato sono vincolati alla nuova scadenza/importo concordati; i creditori estranei restano fuori ma il debitore deve comunque pagargli il 100% come da scadenze originarie salvo diverso accordo (oppure li liquida subito se preferisce). Se l’accordo prevede nuovo finanziamento, quei finanziatori avranno protezioni (prededuzione). Se durante l’esecuzione dell’accordo il debitore non rispetta i patti, l’accordo può risolversi secondo le condizioni contrattuali e i creditori riprendono i loro diritti originari (fatti salvi i pagamenti già ricevuti).
Perché scegliere un accordo omologato invece di un concordato? I motivi sono vari: in un accordo, non si è costretti a coinvolgere tutti i creditori (basta il 60% e gli altri puoi lasciarli fuori pagando integralmente); non c’è la complessità del voto in classi; la procedura è più veloce e con minore pubblicità mediatica (anche se l’omologa è pubblica, non c’è la dichiarazione formale di crisi o insolvenza); inoltre l’impresa può contrattare liberamente i contenuti del piano con i creditori “forti” senza dover sottostare ad alcuni paletti di legge del concordato (ad esempio nel concordato liquidatorio c’è la regola del 20% minimo, qui no perché i dissenzienti devi comunque pagarli al 100% se chirografari, quindi il 20% è superfluo in quell’ottica). D’altro canto, un accordo funziona solo se c’è una massa critica di consenso già ottenuto: se hai troppi creditori eterogenei difficili da contattare, meglio il concordato dove la maggioranza si forma per voti. Storicamente gli accordi erano usati soprattutto per ristrutturazioni finanziarie (banche) nelle grandi aziende, oppure per aziende non troppo indebitate dove si poteva arrivare a 60% facile. Con le nuove varianti agevolato e ad efficacia estesa, l’ambito si è ampliato: oggi è possibile ad esempio omologare un accordo con solo 30% di adesioni (agevolato) se il resto sono tanti piccoli creditori che verranno pagati per intero man mano – di fatto è come ottenere le protezioni del concordato mantenendo un accordo confidenziale con i pochi creditori rilevanti.
Transazione fiscale e contributiva negli accordi: merita un cenno la cosiddetta transazione fiscale. Negli accordi (così come nei concordati) il debitore può proporre all’Erario e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei loro crediti, in deroga al principio che i privilegiati vanno pagati integralmente . Tale proposta deve garantire che fisco/INPS non prendano meno di quanto otterrebbero in una liquidazione. Se l’Erario/INPS aderiscono formalmente, l’accordo viene omologato con quel contenuto e li vincola. Se invece non aderiscono, oggi grazie alle modifiche del 2023-2024, il tribunale può omologare lo stesso se ritiene soddisfatta la convenienza (in pratica li cram-downa) . Questa è una novità importante: prima il loro diniego bloccava l’accordo, ora non più, purché il piano sia conveniente. Quindi l’accordo di ristrutturazione è un mezzo per gestire anche debiti fiscali e contributivi potendo ridurli tramite omologa giudiziale – un grande passo avanti per il debitore, che in passato era spesso ostaggio del veto fiscale. Naturalmente serve l’attestazione rigorosa che dimostri la convenienza (es: “in liquidazione il Fisco prenderebbe 5%, qui ne offriamo 30%, quindi conviene”).
Riassumendo, gli accordi di ristrutturazione sono strumenti molto flessibili e potenti se l’imprenditore riesce a coagulare il consenso di una maggioranza qualificata di creditori. Sono un compromesso tra la pura negoziazione privata e la procedura concorsuale: meno pubblici e rigidi del concordato, ma più strutturati e sicuri di un semplice accordo privato. Dal punto di vista difensivo, l’imprenditore li sceglie quando vuole evitare la parola “concordato preventivo” (che talvolta ha impatti negativi su reputazione, contratti in essere, ecc.) e ha già avviato contatti fruttuosi con i creditori. Se invece i creditori sono litigiosi o dispersi, può essere necessario passare al concordato.
Il nuovo Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO)
Accenniamo brevemente a un nuovo strumento, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 (correttivo al CCII) per recepire la direttiva UE, denominato Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (in acronimo PRO, artt. 64-bis, 64-ter, 64-quater CCII) . Il PRO è una via di mezzo innovativa tra accordo e concordato: è un piano proposto dal debitore che prevede il soddisfacimento dei creditori senza rispettare necessariamente le regole di graduazione dei crediti (quindi può derogare alla par condicio e all’ordine dei privilegi) , ma richiede che il piano sia approvato da tutte le classi di creditori in cui sono suddivisi i crediti . In altre parole, nel PRO il debitore ha ampia libertà di distribuzione del valore creato dal piano (ad esempio può pagare di più un chirografario strategico e meno un altro, indipendentemente dai privilegi legali) creando classi ad hoc, a patto che vi sia unanimità di consenso a livello di classi . Non serve quindi l’adesione del 100% dei singoli creditori, ma il 100% delle classi votanti sì. In mancanza di unanimità, il PRO non è omologabile (non è previsto cram-down di classi dissenzienti in questo strumento – se c’è dissenso si dovrebbe passare al concordato preventivo classico). Perché mai un debitore dovrebbe scegliere il PRO invece di un concordato in continuità? Perché, avendo tutti d’accordo, il PRO consente di derogare alle cause legittime di prelazione e alla par condicio , distribuendo il valore generato dal piano secondo logiche negoziali e di rilancio, anche in deroga alle priorità legali (cosa vietata nel concordato salvo eccezioni). È quindi uno strumento super flessibile ma dal consenso elevatissimo richiesto. Di fatto, se un debitore riesce ad avere tutte le classi concordi, può chiedere l’omologa di questo “piano contrattualizzato” che avrà forza esecutiva erga omnes. Si perde la necessità di rispettare ad esempio il 20% ai chirografari o il pagamento integrale dei privilegiati, purché chi subisce decurtazioni le abbia accettate in classe. Il PRO è destinato agli imprenditori non piccoli (non vi accedono le imprese minori sotto soglie, art. 64-bis CCII) . Viene definito dalla dottrina come un modello a metà tra accordo e concordato: negoziale come un accordo (niente commissario, gestione rimane al debitore salvo nomina eventuale di un supervisore) , ma con omologa e alcune garanzie simili al concordato (ad es. test del best interest of creditors – i dissenzienti in ogni classe devono prendere almeno quanto la liquidazione giudiziale darebbe ).
Per un’azienda debitrice, il PRO potrebbe essere attraente se si ha un progetto di ristrutturazione complesso che crea nuovo valore e i creditori sono molto collaborativi (praticamente un scenario di workout quasi totale). Non è banale da realizzare, infatti alcuni commentatori dubitano sarà usato spesso. Ad ogni modo, poiché parliamo di strumenti di difesa, era giusto citarlo: può succedere che un’azienda come Alfa S.r.l. trovando pieno accordo con tutte le classi di creditori opti per un PRO per avere massima libertà di modulare i pagamenti e gli strumenti di ristrutturazione (es. conversione di crediti in partecipazioni societarie per alcuni, stralcio maggiore per altri, ecc.) senza le rigidità del concordato. Ma se anche una sola classe non ci sta, bisognerà allora scegliere un concordato (dove però c’è la possibilità di cramdown di classi dissenzienti se certe condizioni di maggioranze sono soddisfatte).
Tavola di confronto strumenti stragiudiziali vs concorsuali: per fissare le idee, ecco una tabella riassuntiva dei principali strumenti fin qui illustrati, comparati su alcuni parametri chiave:
| Strumento | Natura | Quorum/Adesioni richieste | Intervento del Tribunale | Effetti principali | Utilizzo tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Negoziato assistito (non omologato). | Volontario, nessun quorum (debitoriale). Coinvolgimento su base volontaria creditori chiave. | Nomina esperto da commissione. Tribunale può concedere misure protettive. Niente omologazione finale (a meno di concordato semplificato). | Sospensione temporanea delle azioni su richiesta (stay); supporto di esperto; esenzione revocatorie per atti autorizzati. Conclusione: accordo stragiudiziale, accordo omologato o concordato semplificato. | Crisi iniziale gestibile. Cercare accordo in bonis con banche/fornitori. Guadagnare tempo per piano o investitore. Evitare stigma di procedure formali. |
| Piano attestato di risanamento | Privato (accordo contrattuale accompagnato da piano pubblicato). | 100% dei creditori rilevanti di fatto, perché quelli fuori devono essere pagati regolarmente (non vincolati se non aderiscono). | Nessuno (solo deposito al Registro Imprese del piano, no giudice). | Atti e pagamenti eseguiti secondo piano esenti da revocatoria ; niente pubblicità di insolvenza; continuità aziendale preservata. | Crisi gestibile privatamente. Pochi creditori e fiducia reciproca. Necessità di proteggere finanziatori terzi (banche richiedono attestazione per nuovi crediti). |
| Accordo di ristrutturazione (ordinario) | Ibrido (negoziale con omologa). | ≥ 60% del totale crediti aderenti (possono escludersi alcune classi pagandole 100%). | Sì, omologazione tribunale. Possibili opposizioni da creditori estranei (che però devono essere garantiti al 100%). | Misure protettive su richiesta (stop azioni); efficacia vincolante per aderenti; esenzione revocatoria atti esecuzione ; stabilità legale dell’accordo (titolo esecutivo se necessario). | Ristrutturazione debito con base creditori ampia ma non unanime. Tipicamente usato con banche e grandi creditori, pagando integralmente trade piccoli. Minor impatto reputazionale rispetto a concordato. |
| Accordo agevolato | Ibrido (omologato). | ≥ 30% crediti (soglia ridotta). | Sì, omologa. | Come sopra, facilita raggiungere accordo con bassa adesione, ma debitore deve comunque pagare i non aderenti integralmente. | Imprese con tanti micro-creditori dispersi non contattabili facilmente, ma con alcuni creditori maggiori pronti a sostenere piano. |
| Accordo ad efficacia estesa | Ibrido (omologato, con cramdown settoriale). | ≥ 75% di una categoria omogenea (es. finanziari) per estendere agli altri . Adesione complessiva min. 60% (salvo esenzioni particolari). | Sì, omologa. | Vantaggi di accordo + estensione vincolo ai dissenzienti di quella categoria (es. minoranza banche dissenzienti vincolata a stesso trattamento della maggioranza) . Transazione fiscale cram-down possibile (voto fisco non vincolante) . | Debiti concentrati su alcune categorie (banche, obbligazionisti) con pochi dissenzienti. Permette di superare l’opposizione di creditori istituzionali minoritari. |
| PRO (Piano ristrutturazione omologato) | Concorsuale negoziale (procedura nuova, omologa senza voto assembleare classico ma con consenso classi). | Unanimità per classi create dal debitore . Tutte le classi devono approvare piano. | Sì, omologa. | Deroga a par condicio e ordine privilegi se piano approvato da tutti ; gestione continua in capo debitore con supervisione minima; vincola tutti i creditori delle classi votanti. | Ristrutturazioni complesse con pochi grandi stakeholder tutti concordi. Permette soluzioni creative (es. equity swap) con accordo universale senza passare per regole concordato rigide. |
| Concordato preventivo (vedi sezione successiva) | Concorsuale giudiziale (voto maggioranze, omologa). | ≥ 50% crediti votanti favorevoli (calcolo per classi e sommatoria) se classi omogenee approvano. Consenso di capitali, non unanimità. | Sì, procedura completa (tribunale, commissario, voto creditori, omologa). | Sospensione azioni da inizio; possibile continuità aziendale o liquidazione; esdebitazione finale imprenditore; vincolo erga omnes compreso chi vota contro (se maggioranza approva). | Situazioni di insolvenza conclamata o elevata conflittualità tra creditori dove serve decisione a maggioranza. Debitore vuole imporre soluzione a dissenzienti garantendo però trattamento minimo di legge. |
(NB: Il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale saranno trattati nella sezione successiva in dettaglio, qui anticipati per confronto.)
Come si nota, la gamma di strumenti è ampia. Dal punto di vista del debitore, in un crescendo di formalità: piano attestato (minima formalità, massima volontarietà), accordi di ristrutturazione (moderata formalità, volontarietà parziale con omologa), PRO (alta formalità ma basata su accordo totale), concordato (massima formalità, votazione a maggioranza). La scelta dipende dal livello di consenso che realisticamente il debitore può ottenere e dalla necessità di includere anche i creditori dissenzienti nel perimetro. La prossima sezione approfondirà gli strumenti concorsuali giudiziali puri, ovvero concordato e liquidazione.
Procedure concorsuali giudiziali: concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento
Quando la situazione debitoria è troppo complessa per essere risolta con i soli accordi negoziali, o quando il consenso tra creditore e debitore non è sufficiente a coprire tutti i soggetti coinvolti, si fa ricorso alle procedure concorsuali vere e proprie. Queste procedure sono aperte e gestite sotto l’egida dell’autorità giudiziaria, con nomina di organi (commissari, curatori, OCC) e con regole legali più stringenti. Dal punto di vista del debitore, attivare una procedura concorsuale comporta inevitabilmente una perdita di controllo (in misura variabile) e una pubblicità della situazione di insolvenza. Tuttavia, può essere l’unico modo per risolvere definitivamente la crisi, perché grazie alla forza della legge permette di superare i dissensi di minoranze di creditori e di definire la posizione debitoria in modo organico, arrivando anche alla esdebitazione (liberazione dai debiti residui) a fine procedura.
Esaminiamo le principali procedure concorsuali previste dal CCII dal punto di vista del debitore: concordato preventivo, liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento) e le procedure di sovraindebitamento per debitori non fallibili (come piccoli imprenditori e privati).
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è la procedura grazie alla quale l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza può proporre ai creditori un accordo concorsuale per evitare la liquidazione giudiziale, soddisfacendo in qualche misura le loro ragioni attraverso un piano di risanamento o di liquidazione parziale. È “preventivo” nel senso che si svolge prima (e al fine di evitare) la liquidazione fallimentare.
Tipologie di concordato: Il CCII distingue principalmente due forme:
- Concordato in continuità aziendale (art. 84 comma 1 lett. a): quando l’imprenditore propone di soddisfare i creditori tramite la prosecuzione dell’attività, direttamente o indirettamente. In pratica, l’azienda (o parte di essa) resta in esercizio, assicurando la produzione di valore con cui pagare i creditori. La continuità può essere diretta (il debitore stesso continua a gestire l’impresa durante e dopo il concordato) o indiretta (ad esempio l’azienda viene affittata o venduta a un terzo che la prosegue, e il corrispettivo finanzia il concordato). Il concordato in continuità è orientato al risanamento e al mantenimento dei posti di lavoro. La legge prevede incentivi, ma anche oneri: ad esempio, il piano deve indicare dettagliatamente come la continuità genera cassa sufficiente, e i creditori privilegiati non integralmente pagati devono ricevere almeno il valore di mercato dei beni dati a garanzia (best interest test). Inoltre sono ammesse alcune classi speciali (creditori strategici, finanziatori).
- Concordato liquidatorio (art. 84 comma 1 lett. b): quando l’imprenditore, riconoscendo di non poter proseguire l’attività proficuamente, propone di liquidare tutto o parte del proprio patrimonio per pagare i creditori. In sostanza è una liquidazione dei beni sotto il controllo del tribunale, ma effettuata in modo ordinato e possibilmente più efficiente di un fallimento tradizionale. Poiché la liquidazione non genera di per sé valore aggiuntivo (oltre al ricavato dei beni), la legge richiede delle condizioni di convenienza: almeno il 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari (salvo alcune eccezioni) e comunque che l’alternativa concordataria dia qualcosa in più ai chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale (test di convenienza). Il limite del 20% serve a evitare concordati liquidatori “abusivi” dove si propone poco più di zero solo per congelare per anni le azioni esecutive: se non c’è prospettiva di almeno 20 centesimi per i creditori chirografari, meglio la liquidazione giudiziale immediata. Fanno eccezione i casi in cui un terzo apporti finanza esterna tale che, pur non raggiungendo 20%, sia comunque il miglior ricavabile (ma sono situazioni particolari).
C’è anche il concordato misto (parte in continuità, parte liquidazione di asset), ma ai fini pratici rientra in una delle due categorie a seconda del prevalente.
Iter del concordato: L’azienda debitrice presenta un ricorso al tribunale chiedendo l’ammissione al concordato, allegando una proposta dettagliata, un piano e la documentazione contabile. Viene nominato dal tribunale un Commissario Giudiziale (figura terza, solitamente un commercialista avvocato esperto in procedure) che ha funzione di vigilanza e di informazione dei creditori. Il tribunale, verificati requisiti iniziali, ammette l’azienda alla procedura, apre il concordato e fissa termini per le varie fasi (votazione, ecc.). Da quel momento si attua la protezione: ai sensi dell’art. 54 CCII, dal deposito della domanda o dall’ammissione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquisire privilegi sul patrimonio del debitore (scatta il c.d. automatic stay generalizzato). L’impresa continua ad operare, ma sotto sorveglianza: per gli atti di straordinaria amministrazione occorre autorizzazione del tribunale e parere del commissario; eventuali atti in frode ai creditori possono portare a revoca.
Si apre così la fase di voto dei creditori: il Commissario redige un relazione in cui informa i creditori sulla fattibilità e convenienza del concordato (e segnala eventuali criticità). I creditori vengono suddivisi in classi se hanno posizione giuridica ed interessi economici differenti (es. una classe di chirografari trade, una di banche chirografarie, classi separate per diversi ordini di privilegiati se non pagati al 100%, ecc.). Ogni classe esprime un voto (positivo/negativo) attraverso le maggioranze di legge: serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se le classi sono più d’una, serve che la maggioranza delle classi approvi e, in ogni caso, che complessivamente il totale dei crediti favorevoli sia almeno il 50% di quelli votanti. Esistono meccanismi di cram-down nel concordato: se una o più classi vota contro ma il tribunale ritiene che la proposta sia comunque conveniente e non li danneggi ingiustamente (rispettati i requisiti di legge), può omologare il concordato nonostante il dissenso di classi minoritarie (purché almeno una classe di creditori non privilegiati abbia votato favorevolmente) – questo è il cosiddetto cram-down interclassi, recepito dall’art. 112 CCII e in linea con la direttiva UE.
A seguito del voto, se questo è favorevole secondo le maggioranze richieste, si passa all’udienza di omologazione davanti al tribunale. I creditori dissenzienti (o altri interessati) possono presentare opposizioni per contestare la legittimità o convenienza del concordato. Il tribunale valuta il tutto: verifica il rispetto delle norme (es. il minimo 20% se liquidatorio, il trattamento non deteriore per eventuali creditori che non hanno diritto di voto come Fisco se non votante ecc.), la regolarità del voto, e giudica sulle eventuali opposizioni. Se ritiene il concordato corretto e conveniente per i creditori (ovvero che nessuno riceve meno di quanto avrebbe in fallimento, test del “miglior interesse dei creditori” ex art. 112 CCII), emette decreto di omologazione. Da quel momento il concordato è efficace per tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro o non partecipato: i crediti restano “cristallizzati” e verranno soddisfatti secondo le modalità e percentuali previste in proposta.
Esecuzione del concordato: l’imprenditore (o un liquidatore nominato, se concordato liquidatorio) procede poi ad attuare il piano: ad esempio paga le prime rate ai creditori chirografari, liquida eventuali beni da vendere, prosegue l’attività se in continuità e fa i pagamenti nei tempi. Il commissario può diventare organismo di vigilanza sull’esecuzione. Se tutto va bene, dopo l’ultimo adempimento il tribunale dichiara chiuso il concordato per esecuzione completata. A quel punto, il debitore è liberato dei debiti secondo quanto previsto dall’accordo: se aveva debiti chirografari per 1 milione e ne ha pagati 300 mila pari al 30%, il residuo 700 mila è cancellato (in gergo: esdebitato). Il concordato comporta quindi l’esdebitazione immediata per la parte falcidiata con l’omologazione (è un effetto obbligatorio dell’omologazione verso tutti i creditori concorsuali).
Se invece il voto dei creditori è negativo (manca la maggioranza), il tribunale non può omologare e dichiara, su istanza, la liquidazione giudiziale (salvo il caso in cui ci sia un piano alternativo proposto da terzi concorrenti, possibilità prevista in certe situazioni, ma che non analizziamo qui per brevità). Lo stesso accade se il tribunale non omologa per ragioni di legge (ad es. scopre frodi, o violazione di norme inderogabili): in quel caso il concordato viene “ bocciato” e di norma si apre il fallimento (liquidazione).
Vantaggi del concordato preventivo dal punto di vista del debitore: consente di risolvere la crisi evitando la cessazione traumatica dell’attività; permette di imporre un sacrificio anche ai creditori dissenzienti in modo ordinato; sospende le azioni individuali (i creditori non possono fare più cause o pignoramenti, e quelli già iniziati sono sospesi); il debitore conserva in continuità la gestione (sotto vigilanza, ma non viene spossessato come nel fallimento); può anche ottenere finanziamenti durante la procedura che saranno prededucibili (art. 99 CCII) e continuare i contratti essenziali; infine, evita le conseguenze infamanti di un fallimento (nel fallimento vi sono interdizioni personali per l’imprenditore come l’inabilitazione ad esercitare impresa, in concordato no).
Svantaggi/costi del concordato: è una procedura complessa, che richiede tempo (diversi mesi almeno), l’intervento di professionisti (costi di attestatore, commissario, legali), e vincola fortemente l’impresa a un percorso concordato (ogni deviazione può farlo saltare). Inoltre, una volta presentata domanda di concordato, se poi questa viene abbandonata o respinta e segue un fallimento, la posizione dell’imprenditore può peggiorare (ad es. potenziali accuse di aver aggravato il dissesto nel frattempo). Quindi è una carta da giocare seriamente e con un piano solido.
Nel caso di Alfa S.r.l. indebitata che non riesce a ottenere accordo sufficiente coi creditori, il concordato può essere la via per evitare la liquidazione giudiziale e gestire lei stessa la sistemazione: supponiamo proponga ai chirografari il 40% in 4 anni, ai privilegiati il 100% in 1 anno (magari vendendo un capannone), e offra la continuità aziendale con un nuovo investimento che arrivi a esecuzione avvenuta. I creditori, valutata la relazione del commissario, potrebbero ritenere di incassare 40% ora meglio di attendere anni in fallimento con recupero incerto e votano sì. L’azienda continua e salda quel 40% puntualmente – i fornitori magari perdono il 60% ma mantengono un cliente vivo per il futuro. In tal modo tutti escono ragionevolmente soddisfatti.
Va menzionato che nel concordato, come negli accordi, il Fisco e l’INPS possono essere trattati con falcidia (transazione fiscale) e, se dissentono, oggi il tribunale può comunque omologare (cram-down fiscale) . Questo è stato definitivamente chiarito dal legislatore nel 2022-2023 per adeguare il CCII: non c’è più il veto assoluto del Fisco, se il piano è conveniente. Ciò elimina uno dei problemi storici dei concordati (dove prima l’Erario spesso bloccava l’omologa votando no se non otteneva il 100% – ora non può più far fallire da solo un concordato se tutti gli altri sono d’accordo e la proposta gli dà il massimo possibile) .
Esdebitazione dell’imprenditore: Nel concordato l’esdebitazione è implicita per la società (che una volta soddisfatto il piano si considera liberata dai debiti residui concorsuali). Se però il debitore è un imprenditore individuale, occorre distinguere: nel concordato preventivo il benefico dell’esdebitazione in senso tecnico è una novità introdotta dal CCII (prima l’esdebitazione era istituto previsto solo post-fallimento per persone fisiche). Ora anche il debitore persona fisica in concordato può ottenere l’esdebitazione di eventuali debiti rimasti insoddisfatti all’esito (art. 118 CCII). Ma attenzione: se l’impresa è societaria, la società una volta eseguito il concordato rimane attiva semplicemente con i debiti ridotti (quindi la società di capitali non ha un problema di “esdebitazione” in quanto ente – eventualmente se la società fosse poi liquidata volontariamente, la liquidazione finale estingue l’ente e con esso i debiti residui).
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che ha preso il posto del “fallimento”. Interviene quando l’insolvenza dell’imprenditore è conclamata e non vi sono altre soluzioni percorribili o proposte. Viene aperta con una sentenza del tribunale su ricorso di uno o più creditori, del debitore stesso (che si dichiara insolvente) o del pubblico ministero in determinati casi. Per la dichiarazione occorre che l’imprenditore sia assoggettabile (escluse imprese minori sotto soglie, e enti pubblici) e insolvente.
Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è chiaramente l’esito meno desiderabile: comporta la spoliazione della gestione dell’impresa e del patrimonio, che passano nelle mani di un Curatore nominato dal tribunale; l’impresa viene di norma cessata (salvo esercizio provvisorio temporaneo se utile per miglior realizzo); tutti i creditori concorsuali devono far valere i propri diritti nello stato passivo (cioè insinuandosi con domanda, non possono più agire individualmente); si procede a vendere i beni (liquidare) e a distribuire il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione. Al termine, l’impresa debitrice viene cancellata (se società) o il debitore persona fisica subisce comunque la chiusura senza aver pagato tutto il dovuto.
Per Alfa S.r.l., significherebbe la fine: un fallimento vorrebbe dire nominare un curatore che prende i libri contabili, chiude o vende l’attività magari a pezzi, licenzia i dipendenti, vende macchinari e immobili all’asta. I creditori incassano ciascuno una percentuale in base ai privilegi: tipicamente privilegiati soddisfatti fino a capienza, chirografari percentuali basse. I soci perderebbero l’investimento (le quote della società fallita non valgono più nulla) e gli amministratori potrebbero subire azioni di responsabilità se hanno colpe nel dissesto.
Ci sono casi dove la liquidazione giudiziale è inevitabile e perfino auspicabile: ad esempio quando il debitore ha compiuto atti in frode (il curatore può con azioni revocatorie farli annullare) o quando il patrimonio dev’essere gestito da un terzo imparziale per massimizzare l’equità (pensa a situazioni di conflitti tra creditori, accuse incrociate). Ma in ottica difensiva del debitore, la liquidazione giudiziale dovrebbe essere l’ultima spiaggia. Spesso il debitore può cercare almeno di gestire la propria uscita di scena tramite un concordato liquidatorio (che è comunque una liquidazione ma sotto la sua regia e con eventuali benefici di esdebitazione immediati, come visto).
Un aspetto importante è l’esdebitazione del fallito persona fisica: la legge (art. 283 CCII, ex art. 142 L.F.) prevede che l’imprenditore persona fisica, una volta chiuso il fallimento (liquidazione giudiziale) con ripartizione dell’attivo, possa chiedere di essere esentato dal pagare i debiti residui non soddisfatti, a condizione di aver cooperato lealmente nella procedura, non aver commesso irregolarità gravi o reati fallimentari e non essere stato già esdebitato nei 5 anni precedenti. Se il tribunale accoglie la domanda, il debitore viene esdebitato: ciò significa che, pur non avendo pagato magari che una piccola parte dei debiti, non è più giuridicamente obbligato per il rimanente. I creditori insoddisfatti non possono più pretendere nulla da lui. Questo istituto, introdotto nel 2006, mira a dare al fallito onesto una “fresh start”. La Cassazione ha chiarito (sent. n. 27562/2024) che l’esdebitazione va concessa se il debitore è meritevole e ha soddisfatto almeno in parte i creditori in fallimento, e che può essere negata solo se il pagamento ottenuto dai creditori è stato meramente simbolico . Ciò significa che non esiste una percentuale minima di legge: basta che i creditori abbiano ricevuto qualcosa più di zero (oltre a verificare la condotta corretta del fallito). La Corte esclude che si possa negare il beneficio solo perché la percentuale pagata è bassa, se il debitore ha fatto tutto il possibile . Questo orientamento pro-debitore è importante: anche chi ha pagato solo ad es. il 5% dei debiti in fallimento può essere esdebitato, purché non abbia colpe nella rovina. L’esdebitazione è dunque la vera “difesa finale” del debitore persona fisica: consente di tornare economicamente vivo, senza le ipoteche dei debiti impagati, dopo aver subito la procedura.
In parallelo, va menzionata un’altra figura: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 282 CCII). Questa è introdotta per le situazioni di sovraindebitamento (non fallibili) in cui il debitore non ha alcun attivo da liquidare: la legge consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui anche senza pagamento (o con pagamento “simbolico”), una volta ogni vita, purché il debitore sia meritevole e non abbia dolosamente indebitato. Questo è peculiare per i privati, ne parliamo a breve nella sezione sovraindebitamento.
In conclusione, la liquidazione giudiziale non è una strategia ma un evento da evitare per l’imprenditore debitore, tranne forse quando la situazione è talmente irreversibile che è meglio dichiarare il fallimento ed eventualmente puntare all’esdebitazione dopo. Ad esempio, se Alfa S.r.l. fosse di un piccolo imprenditore individuale che ha anche debiti personali, e nessun concordato è fattibile, dichiarare fallimento (liquidazione giudiziale) e poi chiedere l’esdebitazione in 3-4 anni potrebbe essere un percorso per ripulirsi e magari ripartire altrove.
Procedure di sovraindebitamento: il concordato minore e la liquidazione controllata
Non tutti i debitori insolventi possono accedere al concordato preventivo o essere assoggettati a liquidazione giudiziale. Le micro-imprese, i piccoli imprenditori sotto soglie di fallibilità, i professionisti, i consumatori privati e altri soggetti non fallibili rientrano nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (disciplina originariamente introdotta con L. 3/2012, ora integrata nel CCII al Titolo IV). Dal punto di vista del debitore, queste procedure rappresentano l’equivalente di concordato e fallimento ma su misura ridotta e con maggior attenzione alla persona.
Le principali sono:
- Concordato minore: disciplinato dagli artt. 74-83 CCII. È sostanzialmente l’erede dell’“accordo di composizione” e del “piano del consumatore” della L.3/2012. Possono proporlo l’imprenditore sotto soglie (cosiddetto imprenditore minore definito dall’art. 2 lett. d CCII ), il professionista, la start-up innovativa, l’ente non commerciale sovraindebitato. Si tratta di una procedura concorsuale semplificata: il debitore, assistito da un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), presenta un piano di ristrutturazione dei debiti fattibile e pagabile anche in parte coi suoi redditi futuri. Non c’è un minimo percentuale imposto (eccetto che devono essere pagati almeno in misura prevalente i crediti che il debitore garantisce personalmente se coobbligato con altri). Serve il voto dei creditori (maggioranza del 50% dei crediti) , tranne che per i debiti verso il fisco se il tribunale approva in difetto (anche qui c’è cram-down fiscale). Se omologato, vincola tutti, e previa esecuzione il debitore viene esdebitato. Il concordato minore è dunque lo strumento di elezione per il piccolo imprenditore individuale sovraindebitato che voglia evitare il fallimento: più semplice e con costi minori, gestito da OCC (che fa da commissario e attestatore). Una differenza notevole col concordato grande è che il controllo di meritevolezza è più stringente: il debitore non deve aver colposamente causato l’eccessivo indebitamento o violato obblighi (specialmente per i consumatori c’è proprio un giudizio di meritevolezza).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente del fallimento per chi non può fallire. Viene richiesta dal debitore sovraindebitato o da creditori o dall’OCC se salta un concordato minore. Il tribunale nomina un liquidatore (spesso l’OCC stesso) che liquida tutti i beni del debitore (compresi eventualmente stipendio per la parte pignorabile etc.), salvo escludere i beni impignorabili o il minimo vitale. Dopo la liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione anche se il ricavato è stato insufficiente a soddisfare i crediti (in pratica quasi sempre, visto che era sovraindebitato). A differenza del vecchio fallimento, qui c’è ancor più la filosofia della seconda chance: anche un debitore del tutto incapiente può liberarsi dai debiti residui, addirittura – come accennato – anche senza alcuna soddisfazione dei creditori, mediante l’istituto dell’esdebitazione “di diritto” dell’incapiente (art. 282 CCII) per il quale il debitore meritevole che non ha nulla da dare ai creditori può comunque, una volta ogni vita, ottenere la cancellazione dei debiti immediata, con l’impegno morale di pagare se nei 4 anni successivi sopravvengono utilità (oltre un certo limite) . Ciò è davvero a tutela della persona in grave difficoltà, per non condannarla a debiti eterni.
Per un piccolo imprenditore/socio illimitatamente responsabile, questi strumenti sono cruciali. Ad esempio, i soci di una SNC insolvente, non fallibile per via delle soglie, potrebbero ricorrere a un concordato minore per chiudere l’attività pagando il 30% ai creditori e poi ripartire senza strascichi. Oppure, un consumatore sommerso dai debiti (pensiamo a garanzie prestate e fatte valere) potrebbe accedere a liquidazione controllata e subito all’esdebitazione incapiente.
Dal punto di vista del debitore, le procedure di sovraindebitamento rappresentano la rete di sicurezza finale: prima di rimanere schiacciato a vita dai debiti, la legge offre la chance di rimettersi in gioco, sacrificando ovviamente il patrimonio disponibile ma salvando la futura capacità produttiva dell’individuo. Dunque, in situazioni personali disperate, la strategia di difesa è proprio utilizzare queste procedure per ottenere l’esdebitazione. Molti imprenditori individuali che non riescono col concordato minore ripiegano su liquidazione controllata + esdebitazione.
Responsabilità patrimoniale di soci e amministratori in fallimento: un cenno va fatto: se l’impresa è società di persone (SNC, SAS) dichiarata insolvente (liquidazione giudiziale estesa anche ai soci illimitatamente responsabili), i soci falliscono con la società e i loro beni personali entrano nella liquidazione. Se l’impresa è società di capitali (SRL, SPA) fallisce solo la società, ma i soci potrebbero rispondere per parti di debito se avevano dato garanzie personali. Gli amministratori e i sindaci non rispondono dei debiti sociali in sé, ma nel fallimento il curatore può esercitare l’azione di responsabilità per atti di mala gestio (art. 255 CCII e 2476 c.c. per SRL) chiedendo loro risarcimento se con atti illeciti hanno causato danno ai creditori. Oppure i creditori stessi potrebbero, se il curatore non agisce, promuovere azioni di responsabilità in via di massa (azione ex art. 2394 c.c. per SPA, analoghe per SRL) sostenendo che la gestione colposa ha eroso il patrimonio vincolato alla garanzia. Queste sono situazioni delicate: per l’amministratore, difendersi significa dimostrare di aver fatto tutto il possibile e di non aver aggravato l’insolvenza. Pena dover rispondere con proprio patrimonio per il danno quantificato (magari con la presunzione art. 2486 c.c. comma 3: differenza netti come danno ). In tal caso l’amministratore, se condannato, diventa debitore egli stesso e può dover far fronte. Se non ci riesce, paradossalmente anche l’amministratore potrebbe poi cercare rifugio nell’esdebitazione post liquidazione giudiziale (qualora sia anch’egli insolvente).
In conclusione su questa parte, il concordato preventivo è uno strumento potente di difesa – perché consente al debitore di dettare i termini (entro certi limiti) del proprio “uscire dai debiti” coinvolgendo tutti i creditori in una soluzione vincolante – mentre la liquidazione giudiziale è la sconfitta, mitigata però dalla possibilità di esdebitazione per la persona fisica. E per i soggetti minori, procedure ad hoc forniscono simili opportunità calibrate. L’importante, per un debitore, è comprendere che entrare in una procedura concorsuale non equivale a resa senza condizioni: con una buona gestione anche della crisi, il concordato può salvare l’azienda e la liquidazione può comunque aprire la via a una liberazione dai debiti personali (fresh start).
Responsabilità patrimoniale dell’imprenditore e dei soci: come proteggersi
Un tema cruciale per chi ha un’azienda indebitata è capire fino a che punto i debiti sociali possono intaccare il patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci. In altre parole: se l’azienda non paga, chi ne risponde? E come tutelare i beni personali (la casa di famiglia, i risparmi personali) dalle pretese dei creditori aziendali?
Il principio generale nel nostro ordinamento è quello della responsabilità patrimoniale universale (art. 2740 c.c.): ciascuno risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri . Quindi un imprenditore individuale, che si identifica con l’azienda, risponde dei debiti d’impresa con tutto il suo patrimonio personale, senza limitazioni. Discorso diverso per le società di capitali: qui vige la regola della autonomia patrimoniale perfetta, per cui la società è persona giuridica distinta e risponde dei debiti sociali solo con il proprio patrimonio; i soci di SRL o SPA hanno responsabilità limitata alla quota conferita (art. 2462 c.c. per SRL).
Tuttavia, questa separatezza può attenuarsi in vari modi:
- Garanzie personali volontarie: spessissimo, soprattutto nelle PMI, i soci-amministratori rilasciano fideiussioni personali a garanzia di debiti sociali (soprattutto verso banche, locatori, fornitori rilevanti). In tal caso, benché la società sia l’obbligata principale, se essa non paga il creditore può escutere direttamente il garante sui suoi beni privati. Quindi, se Alfa S.r.l. è insolvente verso la banca e il suo amministratore ha firmato fideiussione, la banca potrà iscrivere ipoteca sulla casa personale di lui e procedere a pignoramento indipendentemente dalla sorte della società. Lo stesso dicasi se sono state concesse ipoteche su beni personali o pegni come collaterali per debiti societari: quei beni rispondono immediatamente. Difesa: l’unica è cercare di liberarsi da queste garanzie (ad esempio convincendo la banca a escuterle all’interno di un concordato e liberare i beni – spesso i concordati di società prevedono espressamente un trattamento a parte per i creditori garantiti da fideiussioni, con impegni dei soci; oppure far subentrare un garante terzo). In mancanza, il socio rischia di dover ricorrere lui stesso a procedure da sovraindebitamento per gestire i debiti di regresso. In prospettiva, un imprenditore dovrebbe ponderare bene prima di offrire garanzie personali: di fatto annulla il beneficio della responsabilità limitata.
- Tipologia di società: nelle società di persone (S.n.c, S.a.s. per i soci accomandatari) i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c. e 2313 c.c.). Ciò significa che se la società non paga, il creditore sociale può chiedere l’adempimento anche ai singoli soci (previa escussione del patrimonio sociale, ossia deve risultare insufficiente). Il patrimonio personale dei soci è dunque esposto. In caso di liquidazione giudiziale di una società di persone, la legge prevede l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F. prev., ora art. 256 CCII). Come difendersi? La miglior difesa è costituire fin dall’inizio una società di capitali per limitare il rischio. Se ciò non è stato fatto, i soci di fatto sono equiparati all’imprenditore individuale: devono poi puntare su soluzioni concorsuali “personali” (possono accedere al concordato minore se non fallibili, o subire il fallimento e chiedere esdebitazione). Un socio illimitatamente responsabile con beni personali può tentare, ad esempio, di convenire i creditori in un accordo di ristrutturazione a lui esteso, ma non c’è tutela giuridica se non tramite concordati che coinvolgano anche la sua posizione. In pratica, i creditori di SNC spesso colpiscono subito i soci. Un approccio difensivo è cercare di trasformare la società di persone in società di capitali prima che la situazione degeneri, ma attenzione: se fatto in prossimità dell’insolvenza, potrebbe configurare un atto in frode o i creditori potrebbero comunque far valere i debiti pregressi sui soci (la trasformazione di per sé non li libera dalla responsabilità per le obbligazioni sorte prima).
- Obblighi verso il fisco e altri per legge: generalmente i debiti fiscali e contributivi di una società di capitali restano a carico solo della società. Tuttavia, esistono ipotesi in cui gli amministratori o i liquidatori possono essere chiamati a risponderne personalmente per legge. Ad esempio: l’art. 2476 comma 7 c.c. (responsabilità verso creditori sociali) può far rispondere gli amministratori di SRL che con atti di mala gestio non hanno conservato l’integrità patrimoniale e questo ha impedito ai creditori di soddisfarsi . Il caso tipico: amministratori che continuano l’attività dissestata e pagano alcuni creditori preferiti lasciando nulla agli altri – i creditori danneggiati possono agire per responsabilità extracontrattuale. Oppure, sul fronte tributario, i liquidatori di società (art. 2495 c.c. e DPR 602/73 art. 36) possono essere chiamati a rispondere delle imposte se, avendo attivi nel bilancio finale, li ripartiscono ai soci senza prima pagare i tributi dovuti: in tal caso rispondono nei limiti di quanto distribuito. Anche i membri di organi di controllo potrebbero essere coinvolti se omisero di vigilare (rare ma possibili azioni). Queste sono responsabilità per atti o omissioni e non automatiche: il creditore deve dimostrare l’illecito. Ma in sede fallimentare spesso emergono condotte censurabili: il curatore e i creditori possono allora aggiungere il patrimonio personale degli amministratori come bersaglio (azioni ex art. 2394 c.c., come già detto). Difesa: la miglior difesa è prevenire tali situazioni – quindi una gestione diligente e rispettosa del patrimonio sociale. Se l’imprenditore percepisce che la società sta andando male, fermarsi e non aggravare il buco è anche protezione personale. Ad esempio, contrarre nuovi debiti sapendo di non poterli onorare può configurare profili di responsabilità (o addirittura reato di insolvenza fraudolenta). Dal lato pratico, se il danno è fatto, l’amministratore può cercare di transare con il curatore un importo per evitare causa lunga, oppure se viene condannato e non può pagare, come ultimo rimedio, anche lui deve valutare l’esdebitazione.
- Reati e confische: se l’imprenditore incorre in reati (es. bancarotta fraudolenta, frodi fiscali), oltre a pene personali può subire confisca dei proventi illeciti, etc. Non è esattamente una responsabilità civile verso i creditori, ma impatta sul patrimonio (lo Stato confisca beni). Questo esula dallo schema civile, ma è un rischio. Difesa: non commettere reati, e se succede cercare patteggiamenti per contenere misure ablative.
In sostanza, per un imprenditore debitore la forma giuridica dell’attività e le scelte fatte in gestione fanno la differenza sulla protezione del patrimonio personale. Di seguito alcune situazioni sintetiche e possibili difese:
- Ditta individuale: nessuna distinzione patrimonio. Debiti d’impresa = debiti personali. Difesa: utilizzare gli strumenti concorsuali per persone fisiche (concordato minore, liquidazione controllata) per limitare i danni ed esdebitarsi. Valutare la convenienza di far subentrare magari un veicolo societario (ma se i debiti sono già presenti, spostare l’attività in una SRL non sposta i debiti pregressi a carico del titolare).
- Società di persone (SNC, SAS): soci illimitatamente responsabili. Difesa: simile a ditta individuale. Soci e società possono provare concordati unici (ora la legge prevede anche concordati “di gruppo” o collegati). Se fallisce, i soci falliscono con e poi esdebitazione personale. Prevenire con eventuale trasformazione prima delle difficoltà (anche se la trasformazione non libera i soci per i debiti già sorti).
- SRL/SPA: soci non rispondono per legge. Difesa: non prestare garanzie a cuor leggero. Se possibile, patrimonializzare l’azienda con equity invece di finanziarla a debito con garanzie personali – così se va male, il socio perde il capitale conferito ma salva il resto. Occhio ai finanziamenti soci: essi sono postergati (vengono dopo tutti i creditori) e in concorso spesso azzerati, quindi tanto vale eventualmente trasformarli in capitale. Per l’amministratore: gestire con correttezza, attivarsi appena crisi per evitare di incorrere in accuse di aggravamento del dissesto. Un amministratore di SRL che ferma l’attività e chiede concordato/fallimento appena capisce l’insolvenza ha buone chance di non dover rispondere oltre. Al contrario, chi brucia cassa inoperosamente o favorisce taluni creditori su altri rischia cause e perfino querele.
- Soci di SRL e “abuso di schermo societario”: È raro in Italia, ma la giurisprudenza ammette in casi eccezionali la possibilità di “far rispondere i soci” se la società è usata in modo fraudolento come schermo per danneggiare i creditori. Sono casi di piercing the corporate veil: ad esempio società sottocapitalizzata ad arte, confusione di patrimoni, utilizzo della società come alter ego personale senza autonomia. In taluni casi i creditori hanno ottenuto dal giudice di poter aggredire direttamente i soci, qualificando il loro comportamento come illecito extracontrattuale. Tuttavia, si tratta di ipotesi limite (dolo evidente). Difesa: mantenere sempre una netta separazione contabile e finanziaria tra conti azienda e conti personali, e ricapitalizzare se servono fondi invece di finanziare in modo anomalo.
In merito a beni impignorabili: la legge tutela ad esempio alcuni beni familiari (es. gli strumenti indispensabili per il lavoro, una parte dello stipendio minimo, ecc.). Ma la casa di abitazione non è di per sé protetta (lo è solo nel piano del consumatore in certi casi se i creditori acconsentono; oppure l’art. 41-bis L. 3/2012 prevedeva che il giudice potesse impedirne la vendita se non incideva su ritorno creditori – principio ora integrato nel CCII). In un concordato, il debitore può cercare di salvare la casa offrendo ai chirografari una soddisfazione equivalente senza venderla – se i creditori accettano va bene. C’è pure la possibilità di esdebitazione con mantenimento casa per il consumatore meritevole, ma paga un surplus su 4 anni se risparmia la casa. Insomma, qualche spiraglio umanitario c’è.
In sintesi, per difendere il patrimonio personale l’imprenditore deve agire su due fronti: ex ante, scegliere strutture a responsabilità limitata e tenere separate le finanze; ex post, se la crisi arriva, attivare subito procedure concorsuali adeguate (concordati, accordi) che contengano anche la disciplina di eventuali garanzie personali. In sede concordataria, spesso i soci/garanti offrono un contributo al piano (ad es. mettendo a disposizione parte del proprio patrimonio per aumentare la percentuale ai creditori in cambio della liberazione delle loro garanzie). Tale approccio può convincere creditori a votare a favore perché vedono uno sforzo anche personale. Ad esempio, Alfa S.r.l. nel suo concordato propone: ai creditori chirografari 30% coi flussi aziendali + ulteriore 10% grazie a un contributo dei soci (che vendono un immobile privato e mettono soldi); in cambio i creditori accettano espressamente di liberare i soci dalle fideiussioni. Questo modo di includere i soci è abbastanza comune nei concordati, detti con apporto di terzi. I giudici lo vedono di buon occhio perché migliora il soddisfacimento. I soci così sacrificano qualcosa ma comprano la tranquillità futura (niente cause personali dopo).
Chiudiamo questa parte con un concetto: merito creditizio e responsabilità. Se un imprenditore accumula debiti, inevitabilmente deve fare un po’ di mea culpa (salvo eventi imprevedibili). In Italia però la cultura della seconda chance sta migliorando: l’imprenditore non è più visto come “disonorevole” in automatico. Ciò significa che gli strumenti concorsuali, se ben usati, permettono di risolvere la crisi senza annientare chi c’era dietro. L’importante è agire con correttezza, collaborazione e trasparenza verso creditori e organi procedurali. Questo riduce il rischio di conseguenze patrimoniali personali e permette di ripartire.
Domande Frequenti (FAQ) sulla difesa del debitore d’impresa indebitato
- ❓ Cosa rischio personalmente se la mia S.r.l. ha molti debiti e non riesce a pagarli?
✅ Risposta: In una S.r.l. i soci non rispondono con i loro beni dei debiti sociali, salvo abbiano fornito garanzie personali (fideiussioni, ipoteche su beni propri). Quindi, se la società è insolvente, i creditori possono aggredire i beni della società (conti aziendali, immobili aziendali, merci, crediti verso clienti) ma non la casa o i conti personali dei soci . Fanno eccezione le garanzie: se hai firmato una fideiussione in banca, la banca potrà chiedere a te personalmente di pagare il debito della società. Inoltre, se hai gestito male la società (ad esempio hai sottratto beni o hai favorito alcuni creditori a scapito di altri), potresti subire un’azione di responsabilità dal curatore fallimentare per i danni causati . In estrema sintesi: con una società di capitali il tuo patrimonio personale è tendenzialmente protetto, ma solo finché non dai garanzie personali e ti attieni a una gestione corretta. Se la società andrà in liquidazione giudiziale (fallimento), come socio perderai il capitale investito (quote) ma i creditori sociali non potranno chiedere altro a te (a meno di comportamenti illeciti). Se sei anche amministratore, evita di aggravare i debiti: presentare tempestivamente una domanda di concordato o liquidazione limitando il dissesto ti mette al riparo da accuse di mala gestione. - ❓ Ho debiti tributari e con l’INPS non pagati: possono chiedere a me amministratore di S.r.l. di pagarli?
✅ Risposta: Di regola, no: i debiti fiscali e contributivi sono a carico della società. L’Agenzia Entrate Riscossione o l’INPS colpiranno la società (pignorando conti aziendali, macchinari, etc.). Tu come amministratore non sei obbligato in solido. Tuttavia, ci sono casi in cui potresti rispondere: ad esempio se, come liquidatore della società, hai distribuito attivi ai soci lasciando impagate imposte dovute – in tal caso la legge (art. 2495 c.c. e art. 36 DPR 602/73) permette al Fisco di rivalersi sul liquidatore nei limiti di quanto indebitamente distribuito. Oppure se hai commesso reati tributari (es. non versato IVA o ritenute per importi rilevanti), potresti avere conseguenze penali ma non un obbligo civile di pagare il tributo (sarà la società a restare debitrice, salvo confisca penale su tuoi beni per l’equivalente). In generale, per debiti IVA, IRES, INPS della S.r.l., non rispondi tu come persona. Fai attenzione però: se la società fallisce e risulta che con una gestione imprudente hai eroso le risorse con cui si sarebbero potute pagare le imposte, il curatore potrebbe farti causa per il danno ai creditori (tra cui Erario e INPS) – non per farti pagare il tributo in sé, ma per risarcimento da mala gestio. E se emergono omessi versamenti di ritenute o IVA, incorrerai in possibili sanzioni penali personali. Quindi, pur non avendo responsabilità diretta per legge sui tributi sociali, è nel tuo interesse gestire con correttezza quei debiti (ad esempio privilegiando il pagamento di IVA e contributi correnti, e usando gli strumenti di transazione fiscale nei piani di ristrutturazione per regolarizzare il pregresso ). - ❓ La mia società di persone (S.n.c.) è piena di debiti: i creditori verranno sicuramente anche su di me come socio. Posso evitare di pagare con i miei beni?
✅ Risposta: In una S.n.c. i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti sociali. Questo significa che, se la società non paga, ogni socio può essere costretto a pagare col suo patrimonio . Non c’è distinzione tra patrimonio della società e dei soci agli occhi del creditore (sebbene quest’ultimo debba prima escutere la società, ma se la società è insolvente ciò è una formalità). Quindi, sì, i creditori potranno aggredire i tuoi beni personali (es. la casa, salvo eventuale residuo impignorabile se è prima casa non di lusso ipotecata). Come evitare? L’unico modo legale per liberarti da quella responsabilità è pagare i debiti o ottenere una liberatoria individuale in un accordo (improbabile). Potresti anche trasformare la società di persone in S.r.l., ma ciò non libera i soci per i debiti già esistenti. Dunque la protezione preventiva andava fatta costituendo una S.r.l. dall’inizio. Ora come ora, se la S.n.c. è insolvente, la strada per proteggerti è gestire la crisi con uno strumento concorsuale in cui anche la tua posizione personale venga risolta. Ad esempio: proporre un concordato preventivo o concordato minore che coinvolga la società e preveda l’esdebitazione anche per i soci. Oppure far dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale) di società e soci e poi chiedere l’esdebitazione come persona fisica . Quest’ultima opzione, estrema ma efficace, ti libererebbe dai debiti residui post-fallimento, se hai cooperato correttamente. In sintesi, in una società di persone non c’è scudo: devi affrontare il problema e risolverlo attraverso le procedure di legge (concordato, liquidazione controllata, esdebitazione) per liberare i tuoi beni futuri. - ❓ Posso “salvare” la casa di abitazione dai creditori della mia azienda?
✅ Risposta: Dipende. Se l’azienda è un’entità separata (es. S.r.l.) e tu non hai dato l’immobile in garanzia, i creditori sociali non possono ipotecare o pignorare la tua casa per i debiti della società. Quindi in quel caso la casa è salva per definizione. Se invece sei personalmente obbligato (come nel caso di impresa individuale o socio di S.n.c., o hai firmato fideiussioni), allora la casa è aggredibile come qualsiasi altro tuo bene. La legge italiana non prevede un’esenzione generale della prima casa dai debiti (contrariamente a quanto alcuni credono). C’è stata negli ultimi anni una disposizione che vieta l’esproprio della prima casa da parte dell’Agente della Riscossione per debiti tributari sotto certe condizioni (se è l’unico immobile, non di lusso, residenza anagrafica) – ma ciò vale solo per l’Erario; gli altri creditori (banche, fornitori) possono comunque pignorarla. Nei piani di sovraindebitamento del consumatore, il giudice può valutare soluzioni per evitare la vendita forzata della casa se il debitore può offrire ai creditori un soddisfacimento equivalente in altro modo. Per esempio, potresti proporre un piano pagando rate grazie al tuo stipendio, lasciando la casa fuori: se i creditori ottengono il dovuto possono accettare che la casa non venga toccata. Anche nel concordato preventivo di un imprenditore individuale si può prevedere di non vendere la casa ma pagare i creditori in percentuale con altri beni o flussi, se i creditori (o il tribunale) ritengono equo il trattamento. Invece, in un fallimento tradizionale purtroppo la casa entra tra i beni da liquidare, salvo sia ipotecata e l’ipoteca ecceda il valore (in tal caso potrebbe non essere venduta per mancanza di convenienza). Quindi, per salvare la casa la strategia è: 1) se i creditori non vi hanno ancora ipoteca, evitare che la mettano magari attivando subito una procedura concorsuale (nel concordato scatta il blocco delle ipoteche giudiziali ex art. 168 L.F., ora art. 54 CCII); 2) predisporre un piano di ristrutturazione dove offri pagamento ai creditori senza vendere la casa, convincendoli che ottengono uguale o di più rispetto a metterla all’asta (spesso le case all’asta vanno a realizzi bassi, quindi questo può essere convincente) . In sintesi: sì, c’è qualche spiraglio per proteggere la casa, ma richiede di passare da un accordo o concordato. Se invece subisci passivamente le esecuzioni, prima o poi la casa rischia. - ❓ La mia azienda è in crisi, ma ho ancora ordini e potenziale di ripresa: meglio tentare un accordo stragiudiziale con i creditori o chiedere subito il concordato preventivo?
✅ Risposta: Dipende dal grado di crisi e dal livello di consenso che riesci ad ottenere. Un accordo stragiudiziale (ad esempio un piano attestato con accordi individuali) ha il vantaggio di essere più informale, rapido e senza pubblicità – ma funziona solo se quasi tutti i creditori chiave sono d’accordo e disposti ad aspettare/rinunciare a parte dei crediti. Se hai pochi creditori importanti, magari dialogando con loro (possibilmente con l’aiuto di un esperto) puoi trovare un’intesa fuori dal tribunale. Per esempio, un paio di banche prorogano i fidi, il fisco accetta una rateazione, i fornitori principali riducono qualcosa: metti tutto in un piano, un professionista lo attesta, e lo esegui. Se invece i creditori sono tanti e disorganizzati (es. molti piccoli fornitori) o alcuni sono aggressivi (hanno già avviato pignoramenti) – allora un accordo puramente stragiudiziale rischia di fallire o di essere vanificato da uno-due “dissidenti”. In tal caso, conviene passare a uno strumento concorsuale più strutturato: ad esempio la composizione negoziata per congelare le azioni e poi, se raccogli abbastanza adesioni, un accordo di ristrutturazione omologato , oppure direttamente un concordato preventivo se ti serve coinvolgere e obbligare tutti i creditori. Il concordato è più costoso e “traumatico” (nominano un commissario, si viene a sapere, etc.), ma ti dà il potere della maggioranza: non serve avere tutti d’accordo, basta la maggioranza in voto e l’omologa per imporlo erga omnes. Quindi, se la tua azienda ha prospettive e vuoi guadagnare tempo per risanarti, il primo tentativo consigliabile è la Composizione Negoziata – ti permette di vedere se un accordo è fattibile con supporto di un esperto e intanto bloccare i creditori . Se da lì vedi che la maggior parte collabora, potresti chiudere con un accordo attestato o un accordo di ristrutturazione; se invece emergono troppi dissidi, allora sfrutti la stessa composizione per preparare un concordato (puoi addirittura chiedere il concordato “semplificato” se la negoziazione fallisce completamente). In breve: prova prima la via negoziale, tieniti però pronto al piano B concorsuale. - ❓ Qual è la percentuale minima che devo offrire ai creditori chirografari in un concordato?
✅ Risposta: Se è un concordato in continuità aziendale, non c’è una soglia fissa di legge: potresti anche offrire meno del 20%, purché sia il massimo ottenibile in quella situazione e i creditori lo approvino convinti che l’alternativa (liquidazione) darebbe ancora meno. Invece, in un concordato puramente liquidatorio, la legge impone che il piano assicuri almeno il 20% ai creditori chirografari (salvo il caso di apporti di terzi che non siano di rango inferiore a crediti chirografari, dettaglio tecnico). Questo 20% non garantisce che il concordato venga accettato – è solo la soglia per potersi presentare. I creditori poi valuteranno se conviene loro. La prassi mostra che percentuali troppo basse (es. 5-10%) raramente ottengono i voti, a meno che davvero il fallimento darebbe zero e lo si dimostri. Quindi, al di là della soglia legale, devi proporre una percentuale attrattiva rispetto all’alternativa fallimentare. Se in fallimento i chirografari stimano di prendere ipotesi 15%, offrire 25-30% potrebbe convincerli al sì. Invece offrire giusto il 20% con scenario fallimento 30% li porterebbe a votare contro (e il tribunale non omologherebbe perché non c’è convenienza). Tieni presente: puoi comporre la proposta con elementi non monetari (ad es. attribuire ai creditori azioni della società ristrutturata, o altri asset). Ma per parlare semplice: 20% è la soglia per i concordati liquidatori classici . Nel concordato minore (per piccoli debitori) non c’è soglia numerica, vale solo la convenienza e il voto. Nel dubbio, farti assistere da un professionista che faccia simulazioni di riparto in fallimento vs concordato ti aiuterà a calibrare l’offerta. Una percentuale onorevole e tempi di pagamento brevi migliorano di molto le chance di approvazione. - ❓ Se la mia società va in liquidazione giudiziale (fallimento), poi io come imprenditore potrò liberarmi dai debiti che non vengono pagati?
✅ Risposta: Se sei un imprenditore individuale (o socio illimitatamente responsabile) fallito, sì, puoi ottenere l’esdebitazione al termine della procedura . È un beneficio che devi richiedere al giudice: se hai collaborato e non hai frodato, il giudice normalmente te la concede e tutti i debiti residui anteriori si cancellano . Questo ti permette di ripartire senza quei vecchi debiti (restano però eventuali obblighi verso fideiussori che ti hanno pagato debiti, e in generale i debiti esclusi per legge come alimenti, risarcimenti da illecito extra contrattuale etc.). La giurisprudenza recente è molto favorevole: ha stabilito che l’esdebitazione va concessa anche se i creditori hanno ricevuto solo una minima parte (non deve essere “meramente simbolica”, diciamo almeno qualcosa più di zero) . In pratica anche chi in fallimento ha pagato il 5% ai chirografari di solito viene esdebitato, se meritevole. Se invece sei un imprenditore societario (S.r.l., S.p.a.), la società in quanto tale non ha bisogno di esdebitazione perché con la chiusura del fallimento viene cancellata e cessa di esistere insieme ai suoi debiti. Ma tu personalmente non eri obbligato, dunque la “liberazione” non serve. Attenzione però: se avevi garanzie personali attivate nel fallimento (es. la banca non soddisfatta al 100% può venire contro il garante per il residuo), quell’obbligazione di garanzia è un tuo debito personale post-fallimentare e non viene cancellato dall’esdebitazione della società (che tra l’altro non è prevista per la società). In tali casi, tu come persona fisica potresti dover considerare un tuo percorso di esdebitazione attraverso le procedure da sovraindebitamento se rimani esposto. In generale comunque, il sistema consente al debitore onesto, dopo aver subito la liquidazione dei suoi beni, di essere sollevato dal peso di eventuali debiti non soddisfatti. Quindi la risposta breve: sì, dopo il fallimento puoi liberarti dei debiti residui (salvo eccezioni tipo debiti alimentari, malus per frodi, etc.). - ❓ Durante il concordato o la composizione negoziata, i creditori possono continuare a perseguitarmi con azioni legali e pignoramenti?
✅ Risposta: No, uno dei principali vantaggi di attivare una procedura di regolazione della crisi è proprio la protezione dalle azioni individuali (le cosiddette “misure protettive” o automatic stay). Nel caso del concordato preventivo, dalla data di pubblicazione del ricorso in tribunale nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore . Eventuali pignoramenti in corso vengono sospesi, i termini di prescrizione congelati. Anche i creditori con pegno/ipoteca non possono escutere (hanno un blocco per 120 giorni dal deposito salvo autorizzazione). Quindi il concordato “congela” la situazione: niente aste, niente decreti ingiuntivi nuovi. Nella composizione negoziata, il blocco non è automatico ma puoi chiederlo: il debitore può fare istanza al tribunale per misure protettive, e il tribunale può vietare o sospendere per un certo periodo le azioni di recupero dei creditori . Una volta concesse (e pubblicate nel registro imprese), i creditori sono informati e devono fermarsi. Queste misure durano inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili. Anche negli accordi di ristrutturazione è previsto che il debitore possa depositare l’accordo e chiedere misure cautelari e protettive, ottenendo di fatto un effetto simile (sospensione dei procedimenti esecutivi sino all’omologazione) . In sintesi, se stai seguendo la strada di una soluzione concordata, la legge ti mette al riparo dai singoli creditori impazienti: questi dovranno partecipare alla procedura collettiva e non possono fare più di tanto individualmente. Ovviamente, se la procedura fallisce (non omologhi l’accordo o concordato), allora le protezioni cessano e i creditori riprendono le azioni (anzi, il tribunale in quel caso spesso dichiara la liquidazione giudiziale). Ma finché sei “dentro” una procedura, godi di uno stay. Nota: ciò non significa che i creditori smettono di mandare solleciti o lettere (possono farlo), ma non possono pignorare conti o cose del genere. Se qualcuno viola le misure protettive, l’atto è nullo e potresti segnalarlo al giudice. - ❓ Che differenza c’è tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti?
✅ Risposta: Entrambi sono strumenti per evitare il fallimento regolando i debiti, ma funzionano in modo diverso:
– Nel concordato preventivo tutti i creditori sono coinvolti in una procedura giudiziale unitaria. Il debitore propone un piano e i creditori votano a maggioranza; con l’omologazione il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori (anche quelli che non hanno acconsentito) . È dunque una soluzione “collettiva” imposta dalla maggioranza, sotto controllo del tribunale sin dall’inizio (commissario, ecc.).
– Nell’accordo di ristrutturazione (ex art. 57 CCII ordinario) invece c’è una adesione volontaria da parte di alcuni creditori (almeno il 60% in valore) ; poi il tribunale omologa quell’accordo, rendendolo efficace e proteggendolo giuridicamente, ma i creditori non aderenti restano estranei e vanno pagati integralmente fuori dall’accordo . In pratica l’accordo è un contratto tra debitore e una parte significativa dei creditori, con il bollino del giudice che gli dà valore legale forte, ma non coinvolge per forza tutti i creditori (puoi decidere di lasciarne fuori alcuni – di solito quelli minori li paghi cash e non li fai aderire).
Dal punto di vista pratico: il concordato richiede il voto dei creditori in una procedura formale, ha costi e tempi maggiori e vincola tutti; l’accordo di ristrutturazione è più rapido, non ha una votazione formale (le adesioni si raccolgono individualmente), e puoi essere più flessibile decidendo chi far aderire. Tuttavia, con l’accordo non puoi intaccare i diritti di chi non firma – se un 40% di creditori non vuole sconti, devi pagarlo integralmente (oppure convertirlo in soddisfazione diversa, ma con il loro consenso altrimenti no). Con il concordato invece puoi anche imporre tagli a tutti i creditori chirografari se la maggioranza approva. Insomma, l’accordo funziona bene se c’è già un largo consenso spontaneo (è un “concordato semplificato” potremmo dire), mentre il concordato serve se hai molti dissensi da gestire ma puoi contare su una maggioranza. Un vantaggio dell’accordo: meno pubblicità e stigma (si risolve con meno clamore, benché l’omologa sia pubblica). Vantaggio del concordato: mette in riga anche i piccoli creditori e minoranze dissenzienti. Inoltre, l’accordo di ristrutturazione ha oggi varianti (agevolato, ad efficacia estesa) che ne aumentano l’utilità in situazioni particolari, ma rimane un negozio tra “pochi” con l’approvazione del giudice, mentre il concordato è la procedura concorsuale classica aperta a tutti i creditori noti. - ❓ Dopo aver risolto la crisi con concordato o accordo, potrò continuare a fare l’imprenditore o avrò limitazioni?
✅ Risposta: Uno dei vantaggi della riforma è aver eliminato molti degli stigma che colpivano l’imprenditore fallito in passato. Oggi, se tu concludi un concordato preventivo con successo (omologato e poi eseguito regolarmente), non subisci alcuna interdizione: puoi continuare ad amministrare società, aprirne di nuove, partecipare a gare pubbliche (salvo restrizioni contrattuali che erano state poste). Insomma, il concordato non è considerato un’infamia, anzi si chiama “riabilitazione dell’impresa”. Diverso il vecchio fallimento: fino al 2020 circa, il fallito persona fisica subiva l’incapacità per 5 anni di assumere cariche, l’interdizione ai pubblici uffici etc. Con il CCII queste misure sono in gran parte soppresse o ridotte. Ad esempio, la riabilitazione del fallito è pressoché automatica con l’esdebitazione, e le incapacitazioni personali (come l’ineleggibilità o decadenza da cariche) ora scattano solo per il periodo di procedura e cessano con la chiusura (art. 327 CCII). Quindi, dopo un fallimento chiuso ed eventualmente esdebitato, puoi tornare a fare impresa. Ci sono però cautele nel sistema bancario: la Centrale Rischi e banche dati conservano i dati negativi (ad es. il fallimento) per un tot di anni, il che può rendere difficile ottenere credito nel breve periodo. Ma legalmente non sei impedito. Se hai commesso reati fallimentari condannati, quella è un’altra storia (potrebbe esserci l’interdizione dai pubblici uffici per tot anni come pena accessoria, ecc.). Ma assumendo condotta regolare, puoi proseguire. Con un accordo di ristrutturazione concluso, ugualmente nessuna limitazione: quell’accordo è solo un contratto omologato, non comporta status di “ex insolvente” neppure. Addirittura, se salvi l’azienda via accordo, l’azienda mantiene l’agibilità (anche per appalti pubblici: ora il concordato con continuità o l’accordo non impediscono di contrattare con la PA, cosa che prima era problematica, grazie alla modifica del Codice Appalti). Dunque la filosofia attuale è: crisità != disonore. L’importante è aver agito con buona fede. In sintesi, dopo aver risolto la crisi, potrai continuare a fare l’imprenditore, aprire nuove società, ecc., salvo circostanze eccezionali. Piuttosto, valuta tu stesso di non ricadere negli errori precedenti: molte procedure concorsuali prevedono programmi di education del debitore, ma sta alla tua esperienza evitare un secondo tracollo.
Simulazione pratica: il caso Alfa S.r.l. e le strategie di salvataggio
Scenario: Alfa S.r.l. è un’azienda di Pontedera che produce serbatoi d’aria compressa per impianti industriali. Negli ultimi anni ha subito un calo di commesse e un aumento dei costi delle materie prime, accumulando debiti per circa 800.000 € così ripartiti: 200.000 € verso fornitori di acciaio e componenti; 150.000 € di scoperto con la banca locale (affidamenti su c/c e anticipo fatture); 100.000 € di mutuo ipotecario residuo su capannone; 80.000 € di leasing macchinari; 120.000 € di debiti tributari (IVA non versata e qualche cartella per IRES e IMU); 50.000 € di contributi INPS arretrati per i dipendenti; 100.000 € di debiti verso due subfornitori artigiani locali; infine stipendi arretrati e TFR maturato per 10 dipendenti pari a 70.000 €. Il totale debiti è 800.000 €. L’azienda ha in attivo: un capannone del valore stimato 300.000 € (ipotecato per il mutuo residuo 100k); macchinari per valore di libro 200.000 € (leasing in corso per 80k residui, riscatto tra 2 anni); magazzino materiali per 50.000 €; crediti verso clienti (non incassati) per 90.000 €; cassa e banca praticamente zero. Ha tuttavia buone prospettive: un nuovo ordine importante da un cliente, per il quale però servono fondi per acquistare materiali. I soci di Alfa S.r.l. (due fratelli) hanno già immesso in passato 100.000 € in conto finanziamento soci, ma ora non hanno liquidità disponibile. Essi hanno però immobili personali: il fratello A ha una casa del valore di 250.000 € con un piccolo mutuo residuo, il fratello B possiede due appartamenti dati in affitto. Entrambi hanno firmato fideiussioni omnibus alla banca locale per 150.000 € a testa, e il fratello B ha garantito anche il leasing con ipoteca su uno degli appartamenti.
L’azienda inizia a trovarsi a corto di liquidità: alcuni fornitori rifiutano di consegnare materiali senza pagamento di arretrati; la banca ha ridotto l’affido del conto costringendo a pagare scoperto; Equitalia minaccia pignoramento. Gli stipendi di 3 mesi sono in sospeso e i dipendenti rumoreggiano. Il nuovo grosso ordine è un’ancora di salvezza perché porterebbe 500.000 € di fatturato con margine del 20%, ma servono almeno 100.000 € per comprare materie prime e pagare spese vive.
Che fare? Ecco come potrebbe svolgersi il salvataggio passo per passo, applicando quanto illustrato:
- Attivazione della Composizione Negoziata: I fratelli soci, tramite il consulente legale che li assiste, decidono di iscriversi alla piattaforma di composizione negoziata. La situazione di Alfa S.r.l. presenta squilibri significativi (indici di allerta certamente superati: debiti verso fornitori > crediti; debiti tributari > soglia; retribuzioni arretrate). In effetti ricevono proprio in quei giorni una PEC dall’INPS che, ai sensi dell’art. 25-novies CCII, segnala il superamento delle soglie di contributi non pagati (50.000 € > 15.000 € con dipendenti) e li invita ad attivare la composizione negoziata . Questo li tutela anche rispetto a possibili responsabilità: agendo tempestivamente evitano sanzioni per inerzia. Presentano dunque istanza e ottengono la nomina di un esperto indipendente, il dott. Rossi, commercialista iscritto nell’elenco ministeriale, con esperienza nel settore metalmeccanico.
- Misure protettive dal Tribunale: Appena nominato l’esperto, Alfa S.r.l. tramite avvocato chiede al Tribunale una protezione temporanea ex art. 18 CCII: il tribunale di Pisa emette decreto che sospende per 4 mesi le azioni esecutive dei creditori . Ciò comporta che la banca non può pignorare i crediti sul conto, Equitalia non può avviare nuovi pignoramenti (il fermo amministrativo sull’unico furgone aziendale viene sospeso), i fornitori non possono far sequestrare beni. I dipendenti però non subiscono divieti: teoricamente potrebbero dimettersi o fare vertenze, ma sono al corrente dello sforzo di risanamento e, grazie anche alla cassa integrazione per Covid residua su cui l’azienda fa domanda, accettano di attendere ancora un po’ i pagamenti.
- Trattative con i creditori chiave: L’esperto Rossi convoca subito un incontro con la banca creditrice e la società di leasing. In questo incontro Rossi presenta una bozza di piano: Alfa S.r.l. ha un grosso ordine in portafoglio e altri in prospettiva, quindi chiede alla banca di concedere nuova finanza di 150.000 € (per materie prime e pagamento dipendenti) garantita dal privilegio di cui all’art. 10 CCII (finanziamenti prededucibili). La banca è cauta: chiede garanzie aggiuntive. I soci offrono in pegno il magazzino e impegnano a ipotecare il secondo appartamento del fratello B (già garante). Rossi attesta che con quell’ordine i flussi di cassa a 6 mesi permetteranno di rientrare del nuovo finanziamento. La banca, vedendo anche il coinvolgimento dell’esperto e notando che una liquidazione fallimentare le farebbe perdere buona parte dello scoperto, accetta in linea di principio di erogare 100.000 € subito come “finanziamento interinale” e di mantenere le linee esistenti (fidi) congelate senza pretenderne il rientro per la durata delle trattative. Chiede in cambio che entro 4 mesi sia presentato un piano definitivo omologato o un concordato, altrimenti si rivalrà su tutto (compresi i garanti). Nel frattempo viene iscritta ipoteca di 2° grado sul capannone per sicurezza aggiuntiva. La società di leasing, su pressing dell’esperto, accetta di non risolvere il contratto per i 4 mesi delle trattative e di sospendere i canoni, spostandoli in coda (convenzione di moratoria). Questo perché intravede la possibilità di continuare a percepire i canoni se l’azienda riprende l’attività, mentre se fallisce recupererebbe i macchinari usati di dubbio realizzo. Per formalizzare ciò, viene sottoscritta una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII con la società di leasing (creditore finanziario) approvata anche dalla banca , che differisce i pagamenti delle rate leasing e blocca eventuali azioni di escussione per 6 mesi. In parallelo, l’esperto contatta l’Agenzia delle Entrate e l’INPS: propone loro di attendere senza iscrivere ipoteche e fermi (protetti dalle misure del giudice) perché a breve la società presenterà un’istanza di transazione fiscale in un piano di rientro.
- Coinvolgimento fornitori e altri creditori: Rossi convoca anche una riunione con i fornitori principali (i due fornitori di acciaio per 200k e i due subfornitori artigiani per 100k). Spiega la situazione e la prospettiva: se l’azienda riesce a completare l’ordine X, otterrà margini per iniziare a pagarli. Chiede quindi una moratoria di 120 giorni sulle fatture scadute e magari uno sconto. I fornitori, sapendo che se Alfa chiude perderanno quasi tutto, accettano di buon grado una convenzione informale: consegneranno i materiali per l’ordine nuovo e attenderanno 4 mesi per iniziare a ricevere pagamenti, a patto che l’ordine sia effettivamente confermato. Gli artigiani subfornitori (che lavorano quasi solo per Alfa) vengono tranquillizzati: si studia anche la possibilità di coinvolgerli nel futuro piano come eventualmente soci di una newco, ma per ora si accontentano di non perdere il cliente – accettano una riduzione del 10% sui loro crediti se il pagamento avviene entro 1 anno. Questi accordi vengono messi per iscritto come accordi in esecuzione di piano attestato (in prospettiva).
- Predisposizione del piano di risanamento attestato: Dopo un mese di lavoro, l’esperto Rossi con il management di Alfa elabora un piano di risanamento triennale. Prevede: focalizzazione su prodotti più redditizi, licenziamento di 2 dipendenti (con costo coperto dal fondo di garanzia INPS per TFR), contributo dei soci di 50.000 € (raccolti ipotecando uno degli immobili personali a garanzia di un prestito dei soci da parte di un parente), e un accordo di ristrutturazione del debito così congegnato:
– Banca: mantiene affidamenti, nuovo finanziamento 150k prededucibile; il vecchio scoperto di 150k viene trasformato in mutuo a 5 anni; interessi ridotti al tasso legale; i soci garanti rimangono tali ma banca rinuncia ad escussione salvo in caso di inadempimento del piano.
– Leasing: rinuncia a risoluzione, accetta di riscadenzare le ultime 5 rate diluendole su 12 mesi in più senza interessi di mora. Garanzie personali invariate.
– Fornitori (300k totali): propongono loro il pagamento del 50% del credito in 24 mesi, a partire dal 6° mese, e rinuncia al restante 50%. (Molti di loro nelle trattative si erano detti disposti a tagliare il 20-30%, quindi il 50% è aggressivo; ma Alfa conta su un loro voto favorevole se si va in concordato, offrendo un po’ di più di quanto prenderebbero in fallimento – stimato 30%).
– Subfornitori artigiani (100k): pagamento 60% in 18 mesi, il 40% abbuonato (loro avevano già accettato informalmente 90% su 1 anno; qui gli si chiede un sacrificio maggiore, ma si valutano possibili compensazioni future, come contratti di collaborazione garantiti).
– Fisco (120k): si propone una transazione fiscale pagando il 60% del dovuto in 6 anni senza interessi e sanzioni . L’attestatore calcola che in caso di fallimento l’Erario prenderebbe circa 30% (sui beni liberi), quindi 60% è congruo. L’IVA è compresa (quota IVA 80k, ne verrebbero pagati 48k).
– INPS (50k): analoga proposta di pagamento 50% in 4 anni, saldo stralcio sul resto, includendo anche le sanzioni civili condonate.
– Dipendenti (70k): previsione di pagamento integrale degli arretrati e TFR in prededuzione (cioè prima di tutti gli altri) entro 6 mesi dall’omologa, grazie anche a un finanziamento del Fondo di Garanzia INPS per il TFR.
– Soci finanziatori (100k): i loro vecchi finanziamenti sono postergati e di fatto convertiti in capitale a copertura perdite (vengono azzerati, i soci lo accettano).
– Nuovo investitore: il piano prevede eventualmente di aprire a un investitore esterno se entro 1 anno i risultati migliorano (non c’è un nome ancora, ma l’attestatore indica che i soci sono disposti a cedere quote).
Rossi attesta che con queste misure Alfa S.r.l. è in grado di risanarsi: i flussi di cassa futuri (basati su ordini già contrattualizzati e su previsioni caute di ripresa post-pandemia) mostrano che l’azienda potrà rispettare il piano di pagamenti e tornare in utile dal secondo anno. L’attestazione inoltre conferma che i creditori che non aderiscono (se ce ne saranno) comunque riceveranno almeno quanto in una liquidazione giudiziale (best interest test positivo).
- Scelta dello strumento formale: Con il piano pronto, Alfa S.r.l. valuta come implementarlo. Molti creditori già informali sono d’accordo, ma formalmente servono adesioni e/o voti. Ci sono due opzioni: (a) tentare un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, raccogliendo firme per almeno 60% dei crediti; (b) andare direttamente in concordato preventivo con continuità aziendale, classando i creditori e facendoli votare. Quale scegliere? Alfa ha dalla sua la banca (20% del totale crediti) e i fornitori principali (diciamo un 40%); i subfornitori (12%) e forse qualcuno ancora. Potrebbe raggiungere vicino al 60-65% di adesioni. L’Erario però per legge non conta in quel quorum se non aderisce (ma serve comunque convincerlo per l’omologa). L’esperto Rossi suggerisce: fare sottoscrivere l’accordo a banca, leasing, fornitori e subfornitori – questo porta al 70% di crediti aderenti (infatti la banca 150k + fornitori 300k + subfornitori 100k + leasing 80k = 630k su 800k = ~78%). Con tale percentuale, depositare un Accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII presso il tribunale , includendo la proposta di transazione fiscale e contributiva. L’AdE e l’INPS a quel punto dovranno essere chiamate in giudizio: se aderiscono formalmente, bene; se non aderiscono, Alfa può chiedere comunque l’omologazione con cram-down fiscale dimostrando che 60% di tutti gli altri crediti è d’accordo e che lo Stato non riceverebbe di più dal fallimento . Nel frattempo, grazie alla composizione negoziata, Alfa ha tenuto a bada le azioni. Dunque, Alfa S.r.l. procede così: fa firmare a tutti i creditori disponibili un documento di Accordo di ristrutturazione dei debiti contentente gli impegni secondo il piano. Ottenute le firme raggiungendo il 75% dei crediti totali, deposita a fine mese 4 al Tribunale l’istanza di omologa di tale accordo, allegando il piano e la relazione attestativa di Rossi.
- Omologazione e soddisfazione dei creditori: Il tribunale concede subito le misure protettive fino all’omologazione (continuano a essere sospese eventuali azioni). Fissa udienza entro 60 giorni. Nel frattempo comunica l’accordo ai creditori estranei: l’Agenzia Entrate ed INPS vengono formalmente invitate ad aderire. L’AdE tuttavia non risponde (tattica attendista), l’INPS invece aderisce per la sua parte (contenta di prendere 50% su contributi non privilegiati in quanto in fallimento forse nulla avrebbe visto). All’udienza, AdE solleva opposizione sostenendo che l’IVA non può essere falcidiata e chiedendo di non omologare. Gli avvocati di Alfa replicano che la legge ora lo consente previa verifica di convenienza , e l’attestazione di Rossi certifica che offrire 60% sull’IVA è ampiamente conveniente rispetto alla prospettiva di <30% in liquidazione . Il tribunale, verificati tutti gli atti, e considerato che l’accordo ha avuto il plauso della maggioranza schiacciante dei creditori, decide di omologare l’accordo di ristrutturazione includendo la transazione fiscale cram-down: ovvero dichiara approvato ed efficace l’accordo anche senza il consenso formale dell’Erario . Ciò significa che ora anche l’Agenzia Entrate è vincolata al piano (dovrà incassare 60% in 6 anni e rinunciare al resto). L’omologa avviene al mese 6 dall’inizio della vicenda. Da quel momento, Alfa S.r.l. esce dalla composizione negoziata e torna in bonis (non è fallita, ha solo un accordo finanziario da rispettare). Nel frattempo il grosso ordine è stato prodotto e consegnato, portando incassi freschi. Con quelli, Alfa paga subito: stipendi arretrati e TFR (come promesso, integralmente – i dipendenti tirano un sospiro di sollievo); versa un primo acconto ai fornitori (ad esempio 10% subito); paga interamente i subfornitori lotti futuri (aveva negoziato il taglio sul vecchio). La banca erogante il nuovo finanziamento viene anch’essa soddisfatta: con i ricavi la società comincia a rimborsare le rate. L’accordo di ristrutturazione prevede test di cassa semestrali e li supera. A fine primo anno, grazie alla continuità, l’azienda genera utili modesti ma li reinveste per accelerare i pagamenti. In 2 anni, Alfa riesce addirittura ad anticipare parte dei pagamenti ai fornitori, che pertanto sul finale rinunciano a un altro 10% di credito residuo (volontariamente, come gesto di partnership). Dopo 3 anni, tutti i crediti sono stati regolati come da accordo (alcuni con percentuale ridotta come concordato). L’AdE incassa l’ultima rata del suo 60%. A quel punto l’accordo si intende eseguito al 100%. Alfa S.r.l. è di nuovo un’azienda solvibile, con bilanci risanati (i debiti abbuonati sono stati stornati a perdite nel primo anno). I soci hanno mantenuto la proprietà e l’hanno addirittura valorizzata perché la reputazione di Alfa è aumentata (è noto che ha superato la crisi). I dipendenti sono tutti ancora al lavoro (tranne i due usciti incentivati).
Se, per ipotesi, qualcosa fosse andato storto (es. nel secondo anno un altro shock e Alfa incapace di rispettare l’accordo), i creditori avrebbero potuto chiedere la risoluzione dell’accordo e Alfa sarebbe probabilmente finita in liquidazione giudiziale. Ma in tal caso i creditori comunque avrebbero ricevuto nel frattempo più di quanto avrebbero preso 3 anni prima da un fallimento immediato – quindi nessuno avrebbe rimpianto la scelta. Fortunatamente, ciò non è avvenuto.
Analisi del risultato: In questo scenario di simulazione, Alfa S.r.l. e i suoi soci hanno sfruttato in pieno gli strumenti della riforma. La composizione negoziata ha congelato le aggressioni e creato lo spazio per un accordo . L’esperto terzo ha facilitato la fiducia reciproca. Un paio di misure premiali sono state usate: ad esempio, la società ha beneficiato dell’art. 25-bis CCII (riduzione interessi e sanzioni) per i debiti fiscali durante il periodo negoziale . Inoltre, attivandosi presto, gli amministratori hanno evitato denunce e azioni di responsabilità – anzi, i creditori hanno apprezzato la trasparenza. La scelta di un accordo di ristrutturazione invece del concordato ha permesso di evitare la procedura lunga di voto e commissari. Tutto si è risolto in 6 mesi di trattative e un’udienza, con costi di procedura minori. I creditori hanno accettato sacrifici (tagli dal 40% al 50%) ma sanno che in fallimento magari avrebbero avuto il 20-30% e niente prospettive di business futuro. Così invece hanno conservato un cliente attivo (i fornitori) o rientrato di buona parte (banca, Fisco). I soci hanno dovuto comunque contribuire: hanno perso i finanziamenti soci (100k), hanno dovuto mettere un po’ di soldi freschi e dare garanzie, ma hanno salvato la loro “creatura” imprenditoriale e anche i beni personali (la banca non ha escusso le fideiussioni, quindi le case sono salve e le ipoteche aggiuntive verranno poi cancellate a fine accordo). L’esempio mostra il principio-chiave del Codice della Crisi: favorire soluzioni che preservano il valore aziendale e dare soddisfazione ai creditori in misura migliore di quella fallimentare . Tutti ne escono meglio rispetto a uno scenario di liquidazione forzata e spezzettamento dell’azienda.
Naturalmente non tutte le storie reali hanno un lieto fine così lineare: a volte la negoziazione fallisce per l’irrigidimento di qualche attore (es. se in questo caso la banca avesse rifiutato di finanziare il nuovo ordine, la storia poteva finire diversamente). È compito dell’esperto e dei consulenti saper convincere i creditori che la collaborazione conviene a tutti. Il quadro normativo odierno aiuta perché, ad esempio, il Fisco non può più far saltare tutto con un veto ingiustificato – il giudice può imporgli la soluzione . Questo rimuove uno dei colli di bottiglia del passato.
Variante: Se Alfa S.r.l. fosse stata più piccola, sotto soglia di fallibilità (art. 2 lett d CCII: attivo < 300k, debiti < 500k), non avrebbe potuto fare un concordato preventivo ordinario. In tal caso avrebbe usato il concordato minore: simile nelle logiche, ma gestito dall’Organismo di Composizione Crisi locale. I creditori avrebbero votato comunque sul piano proposto. La differenza è che in tali casi il tribunale valuta di più la condotta del debitore (meritevolezza). Nel nostro scenario i soci si sono comportati bene, quindi avrebbero avuto merito.
In definitiva, la simulazione evidenzia i punti cardinali per un imprenditore-debitore: tempestività, trasparenza, utilizzo combinato degli strumenti e sacrificio condiviso. Così si può riuscire a difendersi dai debiti senza soccombere.
Conclusioni
Un’azienda indebitata non è necessariamente un’azienda condannata. L’ordinamento italiano, specialmente dopo la riforma del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019 e correttivi), offre un ventaglio articolato di strumenti per affrontare la crisi in modo ordinato, contenere i danni e – laddove possibile – salvaguardare la continuità aziendale. Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, “difendersi dai debiti” non significa fuggire dalle proprie responsabilità, bensì gestire attivamente la situazione di insolvenza o pre-insolvenza utilizzando le soluzioni legali disponibili, in modo da minimizzare le perdite e ripartire su basi sostenibili. Abbiamo visto come strumenti stragiudiziali (piani attestati, accordi negoziati) possano risolvere situazioni incipienti di crisi con discrezione e rapidità, mentre procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) intervengono quando serve una cornice vincolante erga omnes, cercando comunque di premiare l’imprenditore onesto con la chance dell’esdebitazione .
È fondamentale, per chi si trova in tali difficoltà, non aspettare passivamente che i creditori aggrediscano l’azienda, ma attivarsi in modo propositivo e informato. Dotarsi per tempo di assetti adeguati (controllo di gestione, indici) aiuta a cogliere i segnali di allarme e a intervenire prima che sia troppo tardi . Coinvolgere professionisti esperti (commercialisti, avvocati d’impresa) e – se del caso – l’Organismo di Composizione della Crisi consente di valutare la strada migliore: che sia un accordo stragiudiziale supportato da un piano attestato, oppure l’accesso a una composizione negoziata e poi a un concordato preventivo in continuità, o ancora la via dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale. Ogni caso ha le sue peculiarità: non esiste una soluzione unica valida per tutti.
Dal punto di vista giuridico, il quadro delineato nella guida indica che l’ordinamento favorisce la conservazione dei valori aziendali quando possibile (principio della continuità), ma al contempo predispone meccanismi per garantire la soddisfazione equa dei creditori (principio di par condicio con temperamenti negoziali). Il debitore, se vuole difendere i propri interessi (salvare l’impresa e ridurre l’esposizione personale), deve agire in buona fede e con trasparenza. Le procedure concorsuali moderne premiano la buona fede: ad esempio, la concessione dell’esdebitazione è vincolata al fatto che il debitore non abbia frodato i creditori . Al contempo, chi tenta di approfittare della procedura per scaricare indebitamente i debiti rischia sanzioni (il codice prevede ad es. la revoca del concordato se risultano atti in frode non dichiarati).
Un punto cruciale è la tutela del patrimonio personale dell’imprenditore e dei soci. Qui la guida ha evidenziato come la forma societaria e le garanzie prestate influenzino enormemente i rischi: una S.r.l. offre uno schermo, ma fideiussioni e condotte illecite possono perforarlo. Pianificare la struttura finanziaria dell’impresa in modo da limitare le garanzie personali e capitalizzarla adeguatamente riduce l’esposizione dei soci. In caso di crisi, in ogni strumento concorsuale c’è margine per negoziare la posizione dei soci garanti (spesso liberandoli dalle garanzie dietro contributo al piano).
Per i creditori – anche se questa guida era dal lato debitore – va notato che una gestione attiva della crisi tramite le procedure può portare benefici rispetto alla corsa disordinata al pignoramento. Un concordato o accordo ben congegnato può far ottenere percentuali più alte e più in fretta di un fallimento. Ciò spiega perché sempre più spesso banche e fornitori preferiscono trattare dentro un quadro concordatario invece che spingere per il fallimento immediato. L’esperienza applicativa a fine 2025 mostra un incremento nell’uso di composizioni negoziate e accordi omologati, segno che la cultura sta cambiando in senso collaborativo (anche grazie al fatto che l’ordinamento ora lo consente in modo più efficiente, ad esempio con il cram-down fiscale introdotto nel 2022-2023 ).
In conclusione, un imprenditore con “l’acqua alla gola” per i debiti ha oggi molti strumenti per costruire un paracadute e atterrare in sicurezza, invece di precipitare al suolo. Deve però saperli aprire al momento giusto e con l’aiuto di chi conosce i meccanismi. Il messaggio chiave è: non isolarsi e non nascondere la testa sotto la sabbia. Affrontare apertamente i creditori, possibilmente con un piano in mano e l’ombrello della legge, è la via maestra. Questo trasforma un rapporto conflittuale “creditore vs debitore” in una ricerca comune della miglior soluzione possibile, sotto lo sguardo garante del giudice quando serve. La legge supporta il debitore diligente (ad esempio con la protezione dell’art. 51 L.F., ora 54 CCII durante il concordato, o con l’assenza di sanzioni personali dopo concordato) , mentre punisce chi aggrava o dilapida (azioni di responsabilità, bancarotta).
Dalla prospettiva dell’imprenditore, quindi, “difendersi” dai debiti si traduce in “gestire consapevolmente” la crisi di debiti: sapere quali leve normative tirare e quale prezzo si dovrà pagare (in termini di rinunce e impegni futuri) per uscire dal tunnel. Questa guida ha fornito una mappa dettagliata di tali leve – dalla A di Allerta alla Z di esdebitazione (licenza poetica) – con l’augurio che, usandole a dovere, un’impresa come la nostra ipotetica produttrice di serbatoi d’aria possa tornare a riempire di aria compressa i suoi cilindri e, metaforicamente, riprendere fiato verso un futuro sostenibile.
Fonti e Giurisprudenza utilizzate
- Codice Civile, art. 2740 – Responsabilità patrimoniale.
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, aggiornato). Definizioni di crisi e insolvenza (art. 2 c.1 lett. a, b) ; obblighi organizzativi e allerta (artt. 3, 375 CCII) ; composizione negoziata (artt. 12-25 novies CCII) ; strumenti regolazione crisi (artt. 56-64 CCII: piano attestato, accordi ristrutturazione, PRO) ; concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) ; liquidazione giudiziale (artt. 121-270 CCII); sovraindebitamento (artt. 65-83 e 268-283 CCII).
- Corte Costituzionale, sentenza n. 190/2023 – Legittimità costituzionale dell’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (allerta esterna) . Conferma compatibilità obblighi di allerta con Costituzione.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 24 ottobre 2024 n. 27562 – In tema di esdebitazione del fallito: va concessa se il debitore è meritevole e l’eventuale soddisfacimento parziale dei creditori non è meramente simbolico . Non si può negare il beneficio solo per percentuale bassa indipendente dalla volontà del debitore.
- Corte di Cassazione, Sez. Un. civ., sentenza 27 marzo 2023 n. 8557 – Principi in tema di insinuazione al passivo di creditori con ipoteca su beni di terzi falliti (massima su portata soggettiva del concorso) . (Nella guida, citata come contesto per par condicio).
- Tribunale di Mantova, ordinanza 16 febbraio 2024 – Concordato semplificato ex DL 118/2021: ammissibile formazione di classi differenziate anche in assenza di voto, per equa distribuzione . Confermato poi dal D.Lgs. 136/2024.
- Tribunale di Milano, decreto 30 settembre 2022 – Omologazione forzosa (cram-down) della transazione fiscale nel concordato: applicazione della L. 118/2022 (recepimento Dir. UE) che consente l’omologa nonostante il voto negativo Erario, se soddisfatto interesse dei creditori pubblici .
- Legge 10 agosto 2023 n. 103 (conversione DL 69/2023) – Introduce condizioni all’omologazione forzosa fiscale negli accordi: conferma possibilità cram-down ma con necessaria convenienza e percentuale minima di adesione (norma citata in Osservatorio Insolvenza) .
- Direttiva UE 2019/1023 – Artt. 9-11 (piani di ristrutturazione, voto per classi, cram-down interclassi). Recepita dal D.Lgs. 83/2022 introducendo il PRO .
- Esempi di giurisprudenza di merito recente:
- Tribunale di Napoli, decr. 28 luglio 2023 – Omologazione accordo ristrutturazione agevolato con 45% adesioni, ritenuto valido ex art. 60 CCII (non ufficiale);
- Tribunale di Roma, sent. 15 giugno 2023 – Azione di responsabilità contro amministratori per ritardata richiesta liquidazione giudiziale: conferma responsabilità ex art. 2486 c.c. (caso di “wrongful trading” italiano) ;
- Corte di Cassazione, Sez. Penale, sent. 34495/2021 – Bancarotta semplice: ritardo nel fallimento punibile solo se doloso e con aggravamento dissesto .
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce serbatoi d’aria compressa, serbatoi in pressione, accumulatori, bombole, recipienti certificati PED e componenti per impianti pneumatici e industriali sta vivendo una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce serbatoi d’aria compressa, serbatoi in pressione, accumulatori, bombole, recipienti certificati PED e componenti per impianti pneumatici e industriali sta vivendo una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori, leasing o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento?
Il settore dei serbatoi d’aria è complesso: lamiere certificate, saldature speciali, test in pressione, controlli PED, trattamenti, collaudi e logistica richiedono investimenti costanti.
Una sola interruzione nei flussi di cassa può trasformarsi in una crisi immediata.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata e protetta, se intervieni rapidamente e con la strategia giusta.
Perché un’Azienda di Serbatoi d’Aria Finisce in Debito
Le cause più comuni includono:
• aumento dei costi di acciai, lamiere e componenti certificati
• saldature e lavorazioni esterne molto costose
• test e collaudi obbligatori (PED, prove in pressione) che richiedono risorse
• ritardi nei pagamenti di clienti industriali e contractor
• magazzino immobilizzato tra scocche, gusci, flange e serbatoi finiti
• costi energetici e logistici elevati
• riduzione degli affidamenti bancari
• cicli produttivi lunghi con incassi differiti
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per una Azienda di Serbatoi in Pressione con Debiti
Se non intervieni tempestivamente rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco delle linee di credito
• sospensione delle forniture di acciaio e componenti critici
• decreti ingiuntivi e azioni esecutive
• sequestro di materiali, semilavorati e serbatoi in produzione
• impossibilità di completare collaudi e consegne
• perdita dei clienti principali
• rischio concreto di fermo totale dell’attività
Un debito non gestito può paralizzare l’intero ciclo produttivo in pochi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1) Bloccare immediatamente i creditori
Con l’intervento di un avvocato puoi:
• sospendere pignoramenti e blocchi in corso
• impedire il congelamento dei conti correnti
• fermare richieste aggressive delle banche
• evitare stop improvvisi dei fornitori
La priorità è mettere in sicurezza l’azienda.
2) Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso i debiti includono:
• interessi non dovuti
• somme duplicate
• debiti prescritti
• errori della Riscossione
• costi bancari irregolari
• more e sanzioni calcolate in modo errato
Ridurre il debito è possibile e spesso in modo significativo.
3) Ristrutturare i debiti con piani di pagamento sostenibili
Le soluzioni includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di pagamento con fornitori chiave
• rinegoziazione degli affidamenti e dei mutui
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• utilizzo delle definizioni agevolate (se attive)
Obiettivo: ripristinare la liquidità senza fermare la produzione.
4) Attivare strumenti legali che proteggono l’azienda
Quando i debiti sono elevati puoi utilizzare strumenti molto efficaci:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione
• concordato minore
• liquidazione controllata (ultima alternativa)
Queste procedure permettono di:
• bloccare TUTTI i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte dei debiti
• continuare a produrre e consegnare
• proteggere l’imprenditore personalmente
Sono strumenti sicuri e riconosciuti dal Tribunale.
5) Proteggere produzione, magazzino e forniture
Nel tuo settore è fondamentale:
• tutelare lamiere, componenti, scocche, flange e serbatoi in lavorazione
• evitare sequestri che bloccherebbero saldature e collaudi
• mantenere attivi i fornitori strategici
• proteggere macchinari, attrezzature e banchi prova
• garantire continuità nelle consegne
La produzione deve continuare per superare la crisi.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco completo dei debiti (commerciali, fiscali e bancari)
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori critici e insoluti
• Inventario di magazzino (lamiere, scocche, flange, semilavorati, serbatoi)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria: 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi già dai primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e richieste di rientro
• Riduzione concreta e rilevante dei debiti
• Protezione del magazzino, delle scorte e dei macchinari
• Trattative efficaci con banche e fornitori
• Continuità produttiva garantita
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti e decreti
• Accendere nuovi debiti per pagare debiti vecchi
• Favorire un creditore ignorando gli altri
• Lasciare andare avanti pignoramenti e atti esecutivi
• Affidarsi a società “miracolose” senza competenza reale
Ogni errore peggiora la crisi e aumenta i rischi.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato dei creditori
• Piani di ristrutturazione su misura
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
• Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di serbatoi d’aria non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia tempestiva puoi:
• bloccare i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• proteggere magazzino, materiali e produzione
• garantire la continuità aziendale
• salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento giusto per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.