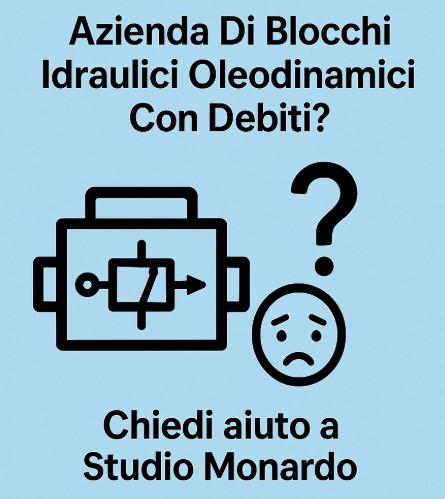Se gestisci un’azienda che progetta, produce o distribuisce blocchi idraulici, manifold oleodinamici, valvole integrate, piastre idrauliche, distributori modulari e componenti per circuiti ad alta pressione, e ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente delicata e pericolosa per la continuità operativa.
Il settore oleodinamico richiede precisione estrema, materiali certificati, lavorazioni costose e forniture costanti. Anche un breve blocco causato dai debiti può compromettere consegne, fermare impianti, far perdere clienti industriali e danneggiare la reputazione.
La buona notizia è che, intervenendo tempestivamente, puoi bloccare le procedure, ridurre i debiti e proteggere la tua azienda.
Perché le aziende di blocchi idraulici accumulano debiti
Le cause più frequenti includono:
- costi elevati dei materiali (acciai speciali, flange, valvole, guarnizioni)
- aumento dei prezzi di lavorazioni meccaniche complesse
- pagamenti lenti da parte di industrie, integratori e costruttori di macchine
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi INPS
- magazzini tecnici con scorte costose e componentistica su misura
- investimenti costanti in macchinari, attrezzature e collaudi ad alta pressione
- difficoltà nell’ottenere credito bancario
- fornitori strategici che richiedono pagamenti rapidi
Questi fattori possono creare crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
La rapidità è fondamentale. Ecco cosa devi fare subito:
- far analizzare la situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verificare quali debiti sono corretti, prescritti o contestabili
- evitare accordi improvvisati con i creditori
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti
- avviare rateizzazioni realmente sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
- proteggere fornitori e materiali essenziali
- prevenire blocchi del conto corrente o riduzioni dei fidi bancari
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o rinegoziare i debiti
Una diagnosi professionale permette di capire quali debiti puoi ridurre, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni in tempo, ti esponi a conseguenze gravi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di mezzi, attrezzature e macchinari essenziali
- blocco delle forniture di materiali ad alta pressione
- impossibilità di completare commesse e lavorazioni personalizzate
- perdita di clienti industriali e integratori di impianti
- danni alla reputazione tecnica dell’azienda
- crisi di liquidità con mancato pagamento di dipendenti e fornitori
- rischio effettivo di chiusura dell’attività
Nel settore oleodinamico, anche un breve ritardo può bloccare interi impianti dei clienti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e altre misure esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative mirate
- ottenere rateizzazioni sostenibili con AE e INPS
- annullare debiti irregolari, prescritti o calcolati male
- trattare con banche e fornitori per evitare sospensioni e interruzioni
- proteggere magazzino, macchinari e continuità produttiva
- stabilizzare l’azienda mentre ristruttura il debito
- evitare l’insolvenza e salvare l’attività
Una strategia professionale può fare la differenza tra sopravvivere e fallire.
Come evitare il blocco dell’attività
Per assicurare la continuità della tua azienda devi:
- intervenire immediatamente
- evitare trattative senza un piano preciso
- proteggere fornitori e componenti critici
- ristrutturare i debiti prima dell’avvio di pignoramenti
- identificare debiti contestabili o notificati in modo errato
- salvaguardare la liquidità necessaria a consegne e lavorazioni
Così puoi evitare ritardi, fermi produttivi e perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
È il momento di farlo se:
- hai ricevuto solleciti, avvisi o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS o fornitori sono diventati ingestibili
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità si sta riducendo rapidamente
- fai fatica a rispettare scadenze e forniture
- vuoi evitare la chiusura dell’attività
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e mettere al sicuro la tua azienda.
Attenzione: molte aziende non falliscono per i debiti, ma per aver agito troppo tardi. Con una strategia adeguata puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti, salvando davvero la tua impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali e difesa di imprese oleodinamiche – ti aiuta a proteggere la tua azienda di blocchi idraulici oleodinamici.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare subito le procedure, ridurre i debiti e mettere in sicurezza la tua attività.
Introduzione
Un’azienda manifatturiera – ad esempio una S.r.l. produttrice di blocchi idraulici oleodinamici – può trovarsi a fronteggiare una grave esposizione debitoria verso banche, fornitori, Fisco e altri enti. Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha profondamente riformato gli strumenti per gestire queste situazioni, con l’obiettivo di favorire il risanamento dell’impresa e prevenire il fallimento. Il fulcro è il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, detto CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 , dopo vari rinvii. Questo Codice ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, introducendo procedure moderne orientate alla continuità aziendale e alla regolazione anticipata della crisi.
La normativa è in costante evoluzione: sono intervenuti correttivi e nuove leggi per adeguare il Codice alle direttive europee e alle esigenze pratiche. In particolare:
- Il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (Secondo Correttivo) ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva , introducendo novità come le classi obbligatorie di creditori e la relative priority rule (regola di priorità relativa tra classi) nei concordati.
- Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (Terzo Correttivo), in vigore dal 28 settembre 2024, ha ulteriormente perfezionato il CCII , chiarendo aspetti procedurali (ad esempio sul nuovo concordato semplificato) e allineando la normativa agli ultimi orientamenti.
- Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modif. in L. 147/2021, ha introdotto in via emergenziale l’istituto della composizione negoziata (CNC) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Queste misure, inizialmente transitorie, sono poi confluite nel Codice (con articoli 17 e seguenti CCII, e art. 25-sexies CCII rispettivamente) .
In questa guida offriremo un’analisi organica e approfondita (oltre 10.000 parole) delle soluzioni giuridiche disponibili al debitore (imprenditore o società) che si trovi sommerso dai debiti. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma al contempo divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati interessati a capire come difendersi. Casi pratici, tabelle riepilogative, domande e risposte aiuteranno a chiarire i concetti. Il punto di vista è quello del debitore in difficoltà, che vuole evitare il fallimento, ristrutturare i debiti e proteggere il proprio patrimonio personale entro i limiti di legge.
Da dove partire? Innanzitutto occorre riconoscere i segnali di crisi e capire gli obblighi legali dell’imprenditore; poi esaminare i vari tipi di debiti (tributari, bancari, verso fornitori, previdenziali) e le relative conseguenze; infine valutare gli strumenti offerti dalla normativa per gestire e superare la crisi d’impresa. Procediamo con ordine.
Segnali di crisi e obblighi dell’imprenditore
Quando un’azienda è in crisi? Si parla di stato di crisi quando l’impresa non genera più flussi di cassa sufficienti a far fronte regolarmente alle obbligazioni, pur senza essere ancora in insolvenza irreversibile. Alcuni segnali d’allarme da non ignorare sono:
- Insoluti e ritardi nei pagamenti: ripetuti mancati pagamenti o ritardi oltre 90 giorni verso fornitori, banche o erario indicano tensione finanziaria . Ad esempio, se la nostra azienda di blocchi oleodinamici inizia ad accumulare fatture scadute con i fornitori di materiali, è un campanello d’allarme.
- Blocco dei fidi bancari o sconfinamenti: la banca riduce o revoca le linee di credito, oppure il conto è costantemente “in rosso” oltre i fidi disponibili . Una revoca dei fidi è spesso preludio ad azioni legali delle banche se il debitore non rientra.
- Decreti ingiuntivi e atti legali: l’arrivo di decreti ingiuntivi da creditori (fornitori, istituti finanziari) o il pignoramento di beni aziendali mostra che la situazione debitoria è degenerata al punto di coinvolgere il tribunale .
- Calo del fatturato e perdite: un significativo calo dei ricavi unito a perdite di esercizio riduce il patrimonio netto e la liquidità. Se i costi superano stabilmente i ricavi, il debito accumulato potrebbe non essere ripagabile nei tempi previsti.
- Tensione nei rapporti commerciali: fornitori che chiedono pagamenti anticipati, clienti che ritardano i pagamenti, protesti a carico dell’azienda, ecc., indicano che la fiducia nel business è compromessa .
Dal 2019 il Codice Civile impone agli amministratori un preciso obbligo di attivarsi al manifestarsi di segnali di crisi. L’art. 2086 c.c., comma 2, introdotto dal Codice della Crisi, stabilisce che l’imprenditore collettivo deve istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per la sua composizione . Ciò significa che il management ha il dovere legale di monitorare costantemente la situazione finanziaria dell’impresa e, in caso di squilibrio, non può rimanere inerte. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che l’inerzia di fronte alla crisi può costituire un grave inadempimento degli obblighi degli amministratori . In particolare, la Cassazione (SS.UU. 26 maggio 2020 n. 7877) ha affermato che l’amministratore che omette di attivarsi tempestivamente per far accedere la società a una procedura concorsuale o a misure di ristrutturazione risponde dei danni causati dall’aggravamento del dissesto, misurati come la differenza tra il patrimonio netto quando avrebbe dovuto intervenire e quello riscontrato poi all’apertura della procedura . Questo principio sprona gli amministratori ad agire subito, per evitare che la situazione peggiori e aumentino le perdite a carico di creditori e soci.
In sintesi, appena si manifestano i primi segnali di crisi, l’imprenditore è chiamato a reagire: ad esempio convocando consulenti, analizzando il piano industriale, trattando con i creditori o valutando l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Agire presto è fondamentale: ogni mese di ritardo può ridurre le opzioni legali disponibili e aggravare la responsabilità personale degli organi sociali . Nel prossimo paragrafo vedremo quali sono i rischi concreti che corre un’azienda indebitata se non interviene in tempo, e come difendersi dalle diverse categorie di creditori.
Rischi per l’azienda indebitata e conseguenze del mancato intervento
Un’azienda gravata dai debiti e in stato di crisi va incontro a molteplici rischi se non attiva tempestivamente una strategia di risanamento o di composizione. Dal punto di vista del debitore (società o imprenditore), i principali pericoli sono:
- Azioni esecutive individuali: i creditori possono agire in via giudiziale per recuperare i propri crediti. Ciò include ottenere decreti ingiuntivi (titoli esecutivi rapidi) e avviare pignoramenti di beni aziendali (macchinari, merci in magazzino, conti correnti) o crediti verso terzi (es. crediti verso clienti). Ad esempio, fornitori non pagati oltre i termini possono depositare ricorso per ingiunzione e, una volta ottenuto il decreto, notificare pignoramenti sui conti bancari aziendali, bloccando di fatto la liquidità necessaria alla gestione corrente. Senza misure protettive, ogni creditore può agire individualmente, con il rischio di una corsa disordinata ai beni dell’impresa.
- Sospensione di forniture essenziali: i fornitori strategici (materie prime, componenti) possono interrompere le forniture o pretendere pagamento anticipato. Ciò può mettere in ginocchio la produzione di un’azienda manifatturiera come quella di blocchi oleodinamici, che dipende da una filiera di approvvigionamenti continua. Inoltre, i fornitori potrebbero segnalare la situazione ad altri operatori, minando la reputazione commerciale dell’impresa.
- Revoca di affidamenti bancari e escussione garanzie: le banche, appena percepiscono un deterioramento del merito creditizio dell’azienda (ad esempio ritardi nelle rate dei mutui o covenant finanziari non rispettati), tendono a revocare i fidi e le linee di credito a breve termine. Il fido di cassa o lo scoperto bancario vengono chiusi, costringendo l’impresa a restituire immediatamente le somme utilizzate. Se l’azienda non è in grado, la banca potrebbe escutere eventuali garanzie: pegni su beni mobili, ipoteche su immobili aziendali, o fideiussioni personali degli imprenditori. Molte PMI italiane, infatti, ottengono credito bancario solo dietro garanzia personale del socio/amministratore. L’escussione di queste garanzie trasferisce il problema sul piano personale: il patrimonio privato dell’imprenditore (case, conti personali) diventa aggredibile dalla banca.
- Procedure cautelari ed esecutive fiscali: i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali comportano l’intervento dell’Agenzia Entrate-Riscossione (AER) (ex Equitalia). Questa ha poteri di riscossione coattiva come il fermo amministrativo sui veicoli e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili intestati al debitore, oltre al pignoramento di beni e crediti. La legge prevede soglie minime: ad esempio, l’ipoteca esattoriale è iscritta solo per debiti complessivi sopra 20.000 € , con obbligo di preavviso 30 giorni prima . Il fermo amministrativo su autoveicoli in genere non viene attivato per importi irrisori (sotto 1.000 € l’agente della riscossione attende almeno 120 giorni dopo un sollecito ), ma per debiti maggiori può bloccare i mezzi aziendali, impedendone l’utilizzo. Se la nostra azienda utilizza furgoni per le consegne, un fermo amministrativo significherebbe doverli tenere inutilizzati (con pregiudizio sull’attività). Inoltre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere con pignoramenti presso terzi (ad esempio sequestrando crediti verso clienti, o prelevando forzosamente dai conti bancari) e pignoramenti immobiliari se ci sono beni intestati all’azienda su cui non grava l’esenzione di impignorabilità.
- Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): uno o più creditori, oppure un pubblico ministero, possono presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale) dell’azienda se ritengono integrato lo stato di insolvenza (incapacità definitiva di adempiere regolarmente) e l’impresa supera le soglie dimensionali previste dalla legge (vedi infra). L’apertura di una procedura concorsuale maggiore di liquidazione porterebbe alla spogliazione dell’imprenditore dalla gestione: un tribunale nominerebbe un curatore fallimentare che prende il controllo di tutti i beni aziendali, li liquida e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Inoltre scatterebbero possibili azioni di responsabilità verso gli amministratori per le condotte anteriori al fallimento (es. bancarotta semplice o fraudolenta se vi sono stati illeciti). Evitare la dichiarazione di liquidazione giudiziale è dunque fondamentale per il debitore che voglia mantenere il controllo della situazione e massimizzare le chance di risanamento.
Riassumendo i rischi principali in una tabella:
| Rischio/Evento | Descrizione e conseguenze |
|---|---|
| Decreti ingiuntivi e pignoramenti | Creditori ottengono titoli esecutivi e pignorano beni aziendali (conti, merci, macchinari), bloccando attività e cassa. |
| Revoca fidi bancari | Banche chiudono linee di credito e chiedono rientro immediato. Se non si paga, escussione di garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni personali) con impatto sul patrimonio personale del socio. |
| Interruzione forniture | Fornitori sospendono consegne o chiedono pagamento anticipato, causando stop produttivi e perdita di clienti. |
| Azioni esattoriali (AER) | Agenzia Entrate-Riscossione attiva misure cautelari/esecutive: fermi amministrativi su veicoli; ipoteche su immobili aziendali; pignoramenti su conti e crediti. Necessario debito > €20.000 per ipoteca (con preavviso) e preavviso per fermi (attesa 120 gg se debito < €1.000) . |
| Istanza di fallimento (Liquidazione Giudiziale) | Creditori o PM chiedono apertura di procedura concorsuale. Se accolta, l’imprenditore perde la gestione; un curatore liquida l’azienda. Possibili azioni legali contro amministratori (es. bancarotta). Grande impatto reputazionale e rischio chiusura definitiva. |
Come si vede, non intervenire significa subire passivamente queste iniziative, spesso scoordinate e potenzialmente disastrose: l’azienda rischia di venire “smembrata” dai vari creditori senza un piano unitario, e l’imprenditore può trovarsi coinvolto sia sul fronte penale (reati fallimentari o fiscali, se vi sono omissioni come il mancato versamento di IVA o ritenute oltre soglie penalmente rilevanti) sia sul fronte civile (perdita del patrimonio personale dato a garanzia o aggredito per responsabilità).
Fortunatamente, l’ordinamento mette a disposizione del debitore vari strumenti per difendersi e reagire. Cosa fare dunque se la nostra azienda di blocchi oleodinamici è sommersa dai debiti? Le strategie si sviluppano su due fronti paralleli:
- Gestire le pressioni dei singoli creditori nel breve termine, evitando per quanto possibile azioni esecutive irreparabili. Ciò può includere richieste di sospensioni, dilazioni di pagamento, opposizioni legali mirate (quando vi sono vizi nelle pretese) e sfruttare eventuali provvedimenti emergenziali (come le definizioni agevolate dei debiti fiscali, v. infra).
- Predisporre un piano organico di risanamento o regolazione della crisi, utilizzando uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi (piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata, ecc.). Questo piano dovrà riequilibrare la situazione finanziaria, ad esempio tramite ristrutturazione del debito (taglio e/o dilazioni), nuovi apporti di capitale o finanza, dismissione di asset non strategici, ecc., il tutto con l’obiettivo di rendere l’azienda nuovamente solvibile o, se non è possibile salvarla integralmente, di liquidarla in modo ordinato limitando i danni.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio gli strumenti di difesa e di soluzione a disposizione del debitore insolvente o in crisi, distinguendo prima le possibili azioni per tipologia di debito (tributario, bancario, commerciale, previdenziale) e poi esaminando le procedure formalizzate di ristrutturazione e insolvenza introdotte dal Codice della Crisi.
Debiti tributari: difendersi da Fisco e Agenzia Entrate-Riscossione
I debiti tributari (imposte, tasse, IVA, ritenute) e i debiti verso enti previdenziali (contributi INPS) costituiscono una categoria particolare, poiché il creditore è pubblico e dispone di poteri e procedure proprie per la riscossione. Dal punto di vista del debitore, occorre distinguere due fasi:
- La fase amministrativa fino all’iscrizione a ruolo del debito (accertamenti, avvisi bonari, cartelle);
- La fase esattiva in mano all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, AER) una volta emessa la cartella di pagamento o titolo esecutivo.
Possibili iniziative del debitore in fase amministrativa (accertamenti e cartelle):
- Verificare la legittimità degli atti: se l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento fiscale o l’INPS un avviso di addebito contributivo, il debitore può valutarne la fondatezza con il proprio consulente fiscale. In presenza di errori o pretese infondate, si può presentare ricorso alle Commissioni Tributarie (per tributi) o al Comitato provinciale/tribunale (per contributi). Un ricorso accolto annulla (in tutto o in parte) il debito.
- Adesione o conciliazione: spesso, prima di arrivare in giudizio, il contribuente può attivare procedure deflattive come l’adesione all’accertamento (cercando uno sconto su sanzioni) o la conciliazione giudiziale se la causa è iniziata. Queste soluzioni possono ridurre l’importo dovuto (specie sanzioni) e ottenere una dilazione.
- Definizioni agevolate (“pace fiscale”): il legislatore negli ultimi anni ha varato misure di sanatoria straordinarie. Ad esempio, la Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater prevista dalla L. 197/2022) ha consentito di pagare le cartelle esattoriali affidate entro il 2017 senza sanzioni né interessi di mora, in max 18 rate fino al 2027 . Ancora più recente, la legge di Bilancio 2024 e i provvedimenti del 2024-2025 hanno introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies per i carichi affidati fino al 2024, permettendo il pagamento del solo capitale e spese (no sanzioni e interessi) in 54 rate bimestrali dal 2026 al 2035 . Se la tua azienda ha debiti con cartelle rientranti in queste finestre temporali, aderire alla definizione agevolata può abbattere notevolmente l’esposizione. Occorre presentare l’istanza telematica entro i termini (ad esempio, per la quinquies il termine è fissato al 30 aprile 2026 con prima rata 31 luglio 2026 ) e rinunciare ai ricorsi pendenti sui carichi inclusi . Nota: queste misure sono straordinarie e soggette a precise scadenze di legge; vanno seguite le indicazioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione, che pubblica moduli e istruzioni e comunica gli esiti (calcolo delle somme dovute) entro date prefissate .
Una volta che il debito tributario o contributivo è definitivo e passato alla riscossione coattiva (cartella esattoriale notificata), entrano in gioco le azioni dell’Agente di riscossione. Come difendersi in questa fase?
- Richiesta di rateizzazione ordinaria: il debitore può chiedere all’AER una dilazione del debito iscritto a ruolo. Fino a €120.000 di debito complessivo, la rateazione è concessa in modo semplificato (fino a 72 rate mensili) . Oltre tale soglia, occorre documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e si può chiedere un piano straordinario fino a 120 rate. La presentazione dell’istanza di rateazione sospende le azioni esecutive: l’AER non può iscrivere ipoteca o fermo mentre la domanda è in istruttoria, e se la dilazione è concessa e si paga regolarmente, i provvedimenti cautelari non vengono attivati . Perciò, se l’azienda ha un debito fiscale elevato ma dilazionabile, conviene attivarsi subito per ottenere un piano di rientro, anche al fine di evitare che scattino misure come il pignoramento dei conti.
- Sospensione legale della riscossione: in alcuni casi previsti dalla legge il debitore può ottenere una sospensione. Ad esempio, se ha presentato ricorso e chiesto la sospensiva al giudice tributario per fondati motivi, o se rileva vizi di notifica della cartella (l’AER prevede una procedura di sospensione amministrativa su istanza, con cui se il debitore dimostra che il debito è già pagato, prescritto, sgravato o oggetto di contenzioso, la riscossione è sospesa in sospensiva) . Anche le sospensioni di legge (ad esempio nei periodi di emergenza COVID furono sospesi i pagamenti e le azioni di riscossione per alcuni mesi) vanno tenute in conto.
- Opposizioni ed eccezioni: qualora l’Agenzia della Riscossione avvii pignoramenti, il debitore può presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, davanti al giudice competente, per far valere eventuali irregolarità (ad es. prescrizione del credito – i tributi erariali si prescrivono in 10 anni, i contributi in 5 ; mancato invio del preavviso di ipoteca 30gg prima; vizi di notifica; decadenza della cartella, ecc.). Queste opposizioni possono bloccare o ritardare la procedura esecutiva, guadagnando tempo per trovare soluzioni.
- Negoziare una transazione fiscale/previdenziale: se l’impresa sta predisponendo un piano di ristrutturazione nell’ambito di una procedura concorsuale (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo), può proporre al Fisco e all’INPS una transazione fiscale e contributiva, cioè un trattamento falcidiante o dilazionato dei loro crediti (ne parleremo a parte più avanti) . In sede extragiudiziale pura (fuori da procedure), l’amministrazione finanziaria non può autonomamente “remitire” imposte dovute per legge, ma all’interno di un piano concordatario omologato dal tribunale sì. Fuori da procedure, l’unica via di saldo e stralcio con il Fisco resta aderire alle definizioni agevolate previste per legge (come la rottamazione).
Va evidenziato che con le riforme del 2020-2022 l’ordinamento ha facilitato l’inclusione dei debiti tributari nei piani di ristrutturazione: oggi è possibile tagliare anche l’IVA e i contributi in un concordato o accordo omologato , cosa prima vietata (in passato l’IVA era considerata intangibile per vincoli UE, ma una sentenza della Cassazione del 2020 aveva già anticipato la possibilità di falcidiare l’IVA in assenza di divieti europei , poi il legislatore ha modificato espressamente la norma). Inoltre, in procedura concorsuale omologata, il debitore beneficia di norme fiscali di favore: ad esempio, le eventuali sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non sono tassate (art. 88, comma 4-ter TUIR, che esenta i “guadagni” da stralcio dei debiti in concordati e accordi omologati ). Ciò per evitare che la rinuncia parziale dei creditori generi un reddito tassabile e quindi un nuovo debito fiscale.
In sintesi, per difendersi efficacemente dai debiti fiscali/previdenziali bisogna: sfruttare i rimedi amministrativi (rateazione, sospensioni, rottamazioni) e, in un contesto di ristrutturazione più ampio, ricorrere alla transazione fiscale nelle procedure previste. Un aspetto cruciale, tuttavia, è coordinare queste mosse con il resto del piano di risanamento, perché tassazioni e contributi spesso costituiscono una quota significativa del passivo aziendale. Nel caso della nostra ipotetica azienda di blocchi oleodinamici, immaginiamo abbia €300.000 di debiti tra IVA non versata e contributi arretrati: ignorarli porterebbe a ipoteche legali sul capannone e potenziali conseguenze penali (omesso versamento IVA > €250k annui, reato ex D.Lgs. 74/2000). Diventa perciò fondamentale includere il Fisco nel piano di sistemazione dei debiti, offrendo un pagamento anche parziale ma conveniente rispetto alla liquidazione (come richiesto per ottenere l’omologa forzata, il cosiddetto cram-down fiscale ). Su questo torneremo nella sezione sulla transazione fiscale.
Debiti bancari e finanziari: come trattare con le banche
Le banche e gli intermediari finanziari (leasing, factoring, società di finanziamento) sono creditori particolarmente importanti, poiché generalmente vantano garanzie reali o personali e il loro atteggiamento può determinare le sorti di un’azienda in crisi (basti pensare alla revoca dei conti anticipi o delle linee di liquidità). Ecco le azioni da valutare per gestire i debiti bancari:
- Analisi delle posizioni e covenants: per prima cosa, il debitore deve mappare tutti i rapporti bancari: affidamenti a breve (conto corrente affidato, castelletto SBF, anticipi fatture), mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, leasing, garanzie prestate. Occorre verificare l’esposizione attuale, le rate scadute, l’eventuale presenza di clausole di decadenza del beneficio del termine o covenants (indicatori finanziari contrattuali, il cui mancato rispetto dà diritto alla banca di chiedere il rimborso immediato). Ad esempio, se un mutuo bancario prevede che il patrimonio netto non scenda sotto un certo importo, l’erosione del capitale per perdite potrebbe aver fatto scattare il covenant, rendendo l’intero debito esigibile subito (technical default). Conoscere queste condizioni è essenziale per anticipare le mosse della banca.
- Moratorie e rinegoziazioni bilaterali: in una fase iniziale di tensione, l’imprenditore può tentare un approccio stragiudiziale con le banche per concordare una moratoria sui pagamenti o una rinegoziazione. Ad esempio, chiedere una sospensione delle rate per 6-12 mesi (magari limitata alla quota capitale) o l’allungamento dei piani di ammortamento dei mutui. Nel 2020, durante la pandemia, provvedimenti legislativi hanno imposto o incentivato moratorie generalizzate; oggi è su base volontaria, ma alcune banche potrebbero accettare se intravedono prospettive di recupero migliore attendendo, soprattutto in presenza di garanzie statali (es. Garanzia MCC su finanziamenti COVID) o altre tutele. Ogni accordo andrebbe formalizzato per iscritto (es. piano di rientro).
- Accordi di forbearance multi-bancari: se l’azienda ha più banche finanziatrici, si può promuovere un accordo di moratoria collettivo (talora chiamato standstill agreement). In ambito associativo, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) spesso promuove linee guida per ristrutturazioni del debito PMI: ad esempio, un imprenditore in difficoltà può presentare un piano di risanamento condiviso con i propri consulenti e chiedere alle banche di congelare le azioni esecutive per un certo periodo (forbearance) mentre negozia una soluzione. Questo somiglia molto alla convenzione di moratoria prevista dal CCII (art. 62), con cui una pluralità di banche e intermediari convenuti accettano di sospendere o posticipare i pagamenti e non revocare le linee, in attesa dell’esito di un piano concordato . La convenzione di moratoria è efficace solo per chi vi aderisce e ha una durata limitata; di solito, viene utilizzata come preludio a un accordo di ristrutturazione vero e proprio o un concordato, al fine di dare respiro immediato all’impresa.
- Verifica di anomalie contrattuali: un aspetto difensivo, benché non risolutivo da solo, è far controllare i contratti bancari a caccia di eventuali illeciti civili: tassi di interesse usurari, clausole anatocistiche illegittime, commissioni non pattuite (CMS), oppure verificare se eventuali fideiussioni omnibus rilasciate dai soci contengano clausole censurate da Banca d’Italia (schema ABI 2003) e quindi potenzialmente nulle per violazione antitrust. Se emergono profili del genere, il debitore può contestare il conteggio del saldo, chiedere perizie econometriche e aprire un contenzioso. Questo può diventare strumentale per guadagnare tempo (una causa bancaria dura anni) e anche come leva negoziale: la banca, a fronte di un’azione legale su usura o nullità di interessi, potrebbe essere più incline a trattare una riduzione transattiva del debito. Nota bene: queste contestazioni vanno però maneggiate con cura e solo se fondate, perché un approccio troppo aggressivo può incrinare definitivamente i rapporti e spingere le banche al fallimento immediato dell’impresa. Spesso, la strategia vincente è usarle come deterrente in negoziati riservati.
- Utilizzare strumenti concorsuali per coinvolgere le banche: qualora la ristrutturazione avvenga attraverso un accordo ex art. 57 CCII o un concordato, le banche saranno interlocutori chiave. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) è richiesto, come regola generale, l’assenso di creditori rappresentanti almeno il 60% del debito (ma esistono forme agevolate al 30%, vedi oltre). È quasi scontato che le banche – spesso titolari di buona parte del debito finanziario – debbano essere tra i firmatari per raggiungere le percentuali. In un concordato preventivo, le banche detentrici di garanzie reali (ipoteche) rientrano nei creditori privilegiati: saranno soddisfatte almeno nei limiti del valore delle garanzie, e per l’eventuale parte residua (chirografaria) concorreranno con gli altri chirografari. In concordato le banche votano nell’ambito delle classi di creditori. Importante: Il nuovo Codice ha previsto la possibilità di cram-down di classe: ad esempio, se una classe di creditori (che può essere formata anche da una o più banche) vota contro, il tribunale può ugualmente omologare il concordato forzando quella classe dissenziente, purché sia rispettata la regola di trattamento migliore rispetto all’alternativa liquidatoria (e, nel concordato in continuità, la relative priority rule fra classi) . In pratica, la banca non ha più potere di veto assoluto come avveniva in passato, se il piano dimostra che sta ricevendo più di quanto otterrebbe da un fallimento.
- Nuova finanza con prededuzione: un’azienda in crisi potrebbe aver bisogno di nuova liquidità (ad es. per completare commesse o per gestire la continuità). Convincere una banca a erogare nuovo credito a un’impresa decotta è arduo, ma la legge offre un incentivo: nel contesto di un accordo o concordato, i finanziamenti nuovi destinati al piano possono essere dichiarati prededucibili, ossia verranno rimborsati con priorità assoluta (anche prima dei creditori pregressi) . Questo dà alla banca una ragione per credere di essere al sicuro: se il concordato/accordo va a buon fine, verrà pagata, se va male e si finisce in liquidazione giudiziale, comunque quel credito prededucibile sarà soddisfatto prima di altri (salvo mala fede). Quindi, una mossa utile è inserire nel piano la richiesta di nuova finanza e magari coinvolgere le stesse banche esposte invitandole a convertire parte del vecchio credito in finanziamento “fresco” (o in equity) garantito dalla prededuzione. Nella simulazione che vedremo più avanti, ad esempio, una banca accetta di convertire €100k di credito in capitale sociale della società debitrice, diventandone socia: ciò riduce il debito e allo stesso tempo rende la banca partecipe dell’eventuale rilancio.
In concreto, come proteggere l’azienda dai creditori bancari nell’immediato? Se si anticipa che la banca sta per revocare gli affidamenti, un’azione possibile è utilizzare la Composizione Negoziata: con la semplice presentazione dell’istanza di CNC, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono (per la durata della negoziazione) le revoche di fidi e le escussioni . Addirittura, il CCII ha previsto una norma (art. 55 CCII) secondo cui, durante le trattative della composizione negoziata, i contratti bancari di finanziamento non possono essere risolti o modificati dalle banche solo perché l’impresa è in crisi, salvo autorizzazione del giudice . Questa è una tutela importante: impedisce al singolo istituto di “staccare la spina” appena sa che la società ha avviato un percorso di risanamento. Naturalmente, trascorsi i mesi di protezione senza un accordo, la banca potrebbe riprendere le sue azioni – dunque la CNC va usata per guadagnare tempo e giungere a una soluzione concordata (accordo o concordato).
Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
I debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi sono spesso il primo indicatore della sofferenza dell’impresa: si comincia a pagare in ritardo i fornitori quando manca liquidità. I fornitori, dal canto loro, non godono di garanzie particolari (salvo che qualcuno abbia riservato proprietà sulla merce fornita, o salvo il privilegio per alcune categorie come i fornitori di affitto d’azienda o gli agricoltori per i prodotti agricoli, ecc.), quindi di regola sono creditori chirografari. Tuttavia, sono numerosi e determinanti per la continuità aziendale. Ecco come un debitore può gestire questa categoria:
- Comunicazione e trasparenza: sembra banale, ma mantenere aperto il dialogo con i fornitori è vitale. Un approccio corretto è informare i principali fornitori della situazione prima che degeneri, prospettando un piano di rientro (es. “Vi pagherò il 20% del vostro credito subito, il resto in 6 mesi, se nel frattempo continuate a rifornirci”). Molti fornitori preferiscono accettare un compromesso piuttosto che perdere il cliente e non veder pagato nulla in caso di fallimento. Questa sorta di accordo stragiudiziale bilaterale (spesso denominato saldo e stralcio o dilazione bonaria) se coinvolge la maggior parte dei partner può tenere a galla l’impresa nel breve termine. Naturalmente, va tenuto sotto controllo il rischio “free rider”: qualche fornitore potrebbe fare il furbo e, mentre gli altri aspettano, lui andare dal giudice per primo. Bisogna quindi valutare attentamente chi sono i fornitori strategici e quelli più critici o con atteggiamento aggressivo.
- Opposizione ai decreti ingiuntivi se vi sono contestazioni: se un fornitore agisce legalmente e notifica un decreto ingiuntivo, l’azienda può decidere di fare opposizione (entro 40 giorni) contestando la pretesa. Ci deve essere un motivo non pretestuoso (merce non conforme, vizi nei prodotti, errori nei conteggi, ecc.). L’opposizione trasforma il procedimento in una causa ordinaria, guadagnando mesi o anni. Tuttavia, attenzione: il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo per legge se fondato su fatture e estratti autentici delle scritture (art. 642 c.p.c.); quindi, fare opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione, a meno che il giudice non sospenda l’efficacia esecutiva in presenza di gravi motivi. In pratica, se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, potrebbe pignorare i conti anche durante la causa di opposizione. Quindi questa strategia difensiva serve solo se si riesce anche a ottenere dal giudice la sospensione, dimostrando che l’ingiunzione è probabilmente infondata. Diversamente, conviene piuttosto cercare un accordo col fornitore.
- Predisposizione di classi dedicate nei concordati: in un concordato preventivo, il debitore può suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei (art. 85 CCII). Spesso i fornitori vengono messi in una o più classi separate rispetto ad altre categorie (banche, erario, ecc.), specialmente se si intende riservare loro un trattamento particolare. Ad esempio, in concordati del settore industriale, è prassi creare la classe fornitori strategici da pagare in misura maggiore rispetto ad altri chirografari, per incentivarli a continuare il rapporto post-concordato. La legge incoraggia questo approccio: nel concordato in continuità, è possibile pagare integralmente i fornitori “essenziali” (anche chirografari) se ciò è funzionale a garantire la continuità aziendale (art. 95 CCII stabilisce che i contratti in corso non possono essere risolti dal contraente per la mera insolvenza, e consente al debitore di richiedere l’autorizzazione a pagare crediti pregressi di fornitori strategici, in deroga alla par condicio, quando indispensabile per la prosecuzione dell’attività) . Dunque, il messaggio per il debitore è: coinvolgere i fornitori nel piano di risanamento, offrendo magari un mix di pagamento parziale dei vecchi crediti e la prospettiva di futuri ordini se l’azienda sopravvive.
- Strumenti di tutela individuale: ricordiamo che i fornitori, se non pagati, possono anche reagire in altri modi: ad esempio, un fornitore con cui l’azienda ha un contratto in corso (fornitura periodica) potrebbe minacciare la risoluzione contrattuale per inadempimento. In sede di concordato, il debitore può sfruttare l’art. 94 CCII che consente di chiedere l’autorizzazione del tribunale a sciogliersi da alcuni contratti in corso o, viceversa, a impedirne la risoluzione da parte dell’altra parte. Questo serve per evitare che un partner rescinda un contratto chiave mettendo in pericolo la continuità. Inoltre, se un fornitore ha già ottenuto un pignoramento su merci o attrezzature vitali, il debitore in concordato può chiederne la sospensione. Tutte queste misure rientrano nelle protezioni offerte dall’apertura di una procedura concorsuale.
- Piano del consumatore o liquidazione controllata per debiti personali: qualora alcuni debiti commerciali fossero intestati personalmente all’imprenditore (ad es. un professionista fornitore pagato personalmente, o acquisti fatti dal socio), e l’imprenditore non sia fallibile come persona fisica, potrebbe valutare le procedure di sovraindebitamento (adesso parte del CCII): piano di ristrutturazione del consumatore (se il debito è prevalentemente personale e non professionale) o concordato minore (se imprenditore minore non fallibile). Questo è però un tema diverso che riguarda il lato personale, di cui diremo più avanti se parliamo di protezione patrimonio personale.
In sintesi per i debiti verso fornitori: evitare di lasciare che la situazione precipiti nel silenzio. Meglio portare i fornitori dalla propria parte in un tentativo di risanamento, offrendo qualcosa subito (anche parziale) e fiducia per il futuro. Se ciò non è sufficiente e partono cause, usare il cappello protettivo di una procedura concorsuale (concordato o accordo) per congelare le azioni esecutive e fare sì che il soddisfacimento dei fornitori avvenga in modo ordinato e proporzionale, e non in base a chi corre prima in tribunale.
Debiti verso INPS e per contributi: specificità e tutele
Un capitolo a parte meritano i debiti previdenziali e assistenziali, principalmente verso l’INPS (contributi obbligatori per i dipendenti, contributi IVS per i soci artigiani/commercianti, contributi gestione separata per collaboratori, ecc.) e verso l’INAIL (premi assicurativi obbligatori). Essi spesso si accumulano quando l’impresa in crisi, dovendo scegliere, paga prima stipendi netti ai lavoratori ma omette di versare i contributi. Ci sono alcune particolarità rilevanti:
- Profili penali per omesso versamento: il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (cioè la quota trattenuta al lavoratore) oltre una soglia di importo è reato. In particolare, l’art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 (conv. L. 638/1983) punisce l’omesso versamento di ritenute INPS superiori a €10.000 annui per ciascun periodo d’imposta, salvo che il datore versi il dovuto entro il termine di legge (30 giorni dall’ingiunzione). Analogamente, sul fronte tributario, l’omesso versamento di ritenute fiscali certificate oltre €150.000 è reato (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) così come l’omesso versamento IVA oltre €250.000 (art. 10-ter). È importante segnalare che le procedure concorsuali non estinguono la rilevanza penale di tali omissioni: se il reato si è consumato (scaduto il termine per versare), la successiva omologazione di un concordato che prevede il pagamento parziale dei contributi non evita il processo penale, anche se talvolta il giudice può valutare l’attenuante dell’aver poi saldato in parte. Dunque, un imprenditore debitore con contributi dipendenti non versati deve prioritariamente gestire questo rischio: spesso la soluzione è correre ai ripari versando almeno le ritenute entro la soglia (se possibile) o avvalendosi della causa di non punibilità per pagamento tardivo (che scatta se paga integralmente il dovuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale). In una logica di risanamento, può darsi priorità al pagamento integrale delle ritenute per evitare guai penali, inserendo semmai nel piano di concordato la falcidia solo della parte di contributi a carico ditta.
- Transazione previdenziale: come per i tributi, il CCII consente di includere in un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo una proposta di transazione contributiva verso gli enti previdenziali . L’art. 63 CCII (accordi) e l’art. 88 CCII (concordato) disciplinano unitariamente la transazione fiscale e contributiva. INPS e INAIL possono aderire a un piano che preveda il pagamento parziale o dilazionato dei contributi dovuti . In mancanza di adesione, è possibile il cram-down contributivo alle stesse condizioni dei tributi (adesione determinante e attestazione di miglior soddisfazione rispetto alla liquidazione) . Le prassi mostrano che l’INPS tende ad allinearsi all’Agenzia Entrate nelle decisioni: se il piano garantisce il massimo ottenibile in liquidazione, può essere omologato anche senza il loro consenso. Attenzione però: come già accennato, se l’esposizione verso Erario+INPS supera l’80% del totale debiti, la legge ora non consente l’omologa forzata senza adesione (art. 48, co.5 CCII introdotto dal correttivo) , per evitare che un debitore con quasi soli debiti pubblici bypassi completamente la volontà del Fisco. Quindi se l’azienda ha debiti contributivi ingenti, è opportuno cercare di ottenere l’adesione dell’INPS nel piano.
- Iniziative esecutive dell’INPS: l’INPS, per tramite dell’Agente di Riscossione, può iscrivere ipoteca o disporre pignoramenti come visto. Non ci sono differenze nelle soglie e procedure rispetto ai tributi (tutto confluisce in cartelle esattoriali, spesso cumulative). Ciò che cambia è che alcuni crediti contributivi godono di privilegio generale mobiliare (quelli per contributi obbligatori sono privilegiati ex art. 2753 c.c.), quindi in caso di concorso con altri crediti nella liquidazione fallimentare, i contributi sono preferiti rispetto ai chirografari. Questo privilegio incide anche nel concordato: i crediti INPS privilegiati vanno soddisfatti almeno in misura pari alla percentuale che avrebbero dalla liquidazione, o se si vuole degradarli a chirografari (per falcidiarli) bisogna applicare le regole di falcidia dei privilegi (artt. 84 e 87 CCII richiedono che il piano concordatario garantisca ai privilegiati il cosiddetto test di soddisfazione). Non entriamo troppo nel tecnico, ma in pratica il debitore non può semplicemente non pagare i contributi privilegiati senza che ciò abbia giustificazione nell’insufficienza dei beni su cui hanno prelazione.
- Rateazione amministrativa dei contributi: l’INPS, indipendentemente dalle procedure concorsuali, concede dilazioni fino a 24 o 36 mesi per contributi non versati, su domanda dell’azienda (con interessi di rateazione). Tuttavia, in caso di grave crisi, spesso l’INPS richiede che la società sia “in bonis” (non fallita) e che non ci siano cause ostative. Se si prospetta un concordato, di solito la dilazione amministrativa viene sostituita dalla transazione contributiva concordataria.
Come evitare il fallimento (liquidazione giudiziale)
Uno dei principali obiettivi del debitore è evitare la dichiarazione di fallimento (oggi definita liquidazione giudiziale). Ciò non solo per la perdita di gestione che ne deriva, ma anche perché il fallimento può comportare l’estinzione dell’attività (salvo esercizio provvisorio) e stigmatizzare l’imprenditore per anni (si pensi alle incapacità personali conseguenti e alle lunghe attese per l’esdebitazione). Vediamo quali strategie e strumenti consentono di scongiurare questa evenienza:
- Verificare la fallibilità dell’impresa: non tutte le imprese sono soggette a fallimento/liquidazione giudiziale. Il Codice della Crisi definisce l’impresa minore (art. 2, c.1, lett.d CCII) quella che congiuntamente, nei tre esercizi precedenti, non ha superato tre soglie: attivo patrimoniale €300.000, ricavi €200.000 annui, debiti totali €500.000 . Se l’azienda rientra in questi limiti (ad es. una micro-SRL familiare con piccoli fatturati), allora è esclusa dalla liquidazione giudiziale e dalle altre procedure maggiori: in tal caso i creditori non possono chiederne il fallimento. Eventualmente potranno accedere solo alle procedure “minori” di sovraindebitamento (come il concordato minore o la liquidazione controllata). Dunque, la prima difesa del debitore è valutare: sono sopra o sotto soglia? – se sotto, un’istanza di fallimento va contestata eccependo il difetto dei presupposti dimensionali, onere della prova a carico dell’impresa (art. 121 CCII) . Va però considerato che i bilanci depositati dovranno supportare la tesi . Nel caso della nostra azienda ipotetica, probabilmente essendo manifatturiera con 50 dipendenti e debiti totali ~€3 milioni, supererà i limiti, quindi è fallibile.
- Composizione Negoziata e concordato in bianco: uno scudo efficace contro le istanze di fallimento dei creditori è l’accesso a una procedura che congeli temporaneamente tali iniziative. La Composizione Negoziata della crisi (CNC) – procedura stragiudiziale assistita – quando viene attivata consente di chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive (art. 18 CCII) che sospendono le azioni esecutive e inibiscono i creditori dal proporre istanza di fallimento . Tali misure hanno durata iniziale di 120 giorni (prorogabili di 60). Ciò significa che, durante la CNC con misure protettive attive, nessun creditore può far dichiarare il fallimento. In alternativa, esiste sempre la possibilità (prevista dall’art. 44 CCII) di depositare un ricorso “in bianco” per concordato preventivo o per accordo di ristrutturazione (con riserva), ottenendo un termine per presentare la proposta definitiva e nel frattempo godendo del automatic stay: anche il deposito di un ricorso di concordato con riserva blocca le azioni esecutive e impedisce iniziative fallimentari . L’azienda ottiene così tempo (fino a 120 + 60 giorni) per preparare un piano senza dover combattere istanze di fallimento. Ovviamente, tale strumento va usato in buona fede, ossia con l’intenzione genuina di presentare poi un piano. Le norme puniscono eventuali abusi (se il debitore dissipa l’attivo durante la protezione, può essergli revocata e può incorrere in responsabilità).
- Pagare i creditori strategici o pericolosi: può sembrare un consiglio “poco giuridico”, ma talvolta, per evitare una istanza di fallimento imminente, l’azienda potrebbe valutare di soddisfare (anche parzialmente) quei creditori che avrebbero la legittimazione e il potenziale interesse a chiedere il fallimento. Ad esempio, un fornitore importante e molto esposto potrebbe perdere la pazienza e rivolgersi a un avvocato: se gli si offre un pagamento (anche parziale a saldo e stralcio con quietanza tombale), magari rinuncia a vie legali. Ovviamente questo crea disparità di trattamento rispetto ad altri e potrebbe essere soggetto a revocatoria fallimentare se poi la società fallisse nei 6 mesi (quel pagamento preferenziale potrebbe esser dichiarato inefficace). Ma se l’obiettivo di quel pagamento mirato è evitare il fallimento e poi non fallire, la revocatoria non diventa un problema. Questa è spesso la logica del “gestire i creditori” in fase pre-crisi: calmierare quelli più aggressivi, compatibilmente con le risorse disponibili.
- Dimostrare la continuità aziendale: quando un creditore deposita un’istanza di fallimento, l’imprenditore può difendersi evidenziando che esiste la possibilità di risanamento dell’impresa e che l’istanza è prematura. Con il CCII il tribunale può, in presenza di concrete trattative in corso per un accordo, posticipare la decisione di alcune settimane dando tempo all’impresa di formalizzare la richiesta di accesso a una procedura regolatrice (accordo, piano attestato, concordato) che soddisfi i creditori. Ad esempio, se l’azienda depositasse all’udienza un accordo di moratoria già sottoscritto da banche e i principali fornitori, potrebbe persuadere il giudice a non dichiarare insolvenza e attendere l’evoluzione. Non è una garanzia (la legge non prevede un obbligo in tal senso, se lo stato di insolvenza è conclamato), ma nella prassi i tribunali sono diventati più attenti all’interesse dei creditori alla conservazione del valore d’impresa. La Corte d’Appello di Bologna in una pronuncia del 18 luglio 2023 ha confermato un’omologa di concordato preventivo rigettando il reclamo di un singolo creditore, proprio in forza dell’interesse generale dei creditori e dei lavoratori a vedere attuato il piano . Questo approccio privilegiato dal CCII (art. 114) spinge a considerare il concordato come preferibile al fallimento quando può dare maggior soddisfazione collettiva.
Concludendo, evitare il fallimento significa agire d’anticipo: utilizzare gli strumenti di allerta e negoziazione, depositare per tempo una domanda di concordato o accordo, placare i creditori più minacciosi e far percepire che è in corso un processo di ristrutturazione serio. Se invece l’inerzia fa arrivare l’azienda “sotto attacco” senza nulla in mano, allora l’istanza di fallimento potrebbe essere inevitabile. In tal caso l’ultima chance – poco decorosa ma talvolta usata – è opporre ogni argomento dilatorio in tribunale: contestare l’importo del credito istante (se sub judice), eccepire limiti dimensionali, chiedere termini per memorie, ecc., per guadagnare qualche settimana magari utile a completare un accordo nel frattempo. Ma questa è davvero l’extrema ratio. Meglio agire prima secondo le linee guida viste sopra.
Strumenti di ristrutturazione del debito e soluzioni alla crisi d’impresa
Passiamo ora in rassegna gli strumenti formali previsti dal Codice della Crisi (e dalla normativa collegata) per affrontare in modo strutturato l’indebitamento dell’azienda e tentare il risanamento o, se ciò non è possibile, una liquidazione ordinata e controllata. Li esamineremo in ordine crescente di “invasività” e formalità, tenendo a mente che spesso possono combinarsi tra loro:
Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)
Cos’è: È il più “leggero” tra gli strumenti, in quanto privo di intervento del tribunale. Consiste in un piano di risanamento redatto dall’imprenditore in crisi e asseverato (attestato) da un professionista indipendente, idoneo a riequilibrare l’esposizione debitoria dell’impresa e a garantirne la continuità. Il piano può prevedere accordi stragiudiziali con alcuni creditori, ristrutturazioni del debito (anche parziali remissioni), investimenti, dismissioni di cespiti ecc.
Vantaggi: Il piano attestato, se formalizzato ai sensi dell’art. 56 CCII, gode di alcune protezioni: gli atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione di esso non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare ; inoltre eventuali finanziamenti effettuati in funzione del piano possono (ricorrendone i presupposti) essere prededucibili in caso di successivo fallimento . Non c’è pubblicità né deposito in tribunale, per cui l’operazione rimane riservata, limitando danni reputazionali. Non richiede soglie di adesione dei creditori (può essere fatto anche unilateralmente, purché realisticamente l’impresa riesca a eseguirlo).
Svantaggi: Non offre alcun automatismo di moratoria legale. I creditori non firmatari non sono vincolati e possono agire liberamente . In sostanza, l’efficacia del piano attestato dipende dalla volontaria collaborazione dei creditori: se non ottengo un numero sufficiente di accordi individuali, il piano rischia di non risolvere la crisi. In più, non vi è alcun controllo giudiziale sul contenuto: se il piano non è robusto, un eventuale successivo fallimento potrebbe esporre l’imprenditore a contestazioni (ad esempio, i creditori esclusi potrebbero lamentare che il piano li ha pregiudicati). Va segnalato però che la Legge accorda una sorta di implicit safe harbor all’imprenditore che segue un piano attestato: se successivamente fallisce, non sarà automaticamente colpevole di mala gestio per averci provato, a patto che si sia attenuto al piano asseverato in buona fede.
Quando usarlo: Il piano attestato è indicato quando la crisi è ancora moderata e circoscritta a pochi creditori che si può ragionevolmente convincere. Ad esempio, se la nostra azienda di blocchi oleodinamici avesse solo un eccesso di debito bancario ma rapporti buoni con le banche, si potrebbe elaborare un piano attestato di risanamento con le banche e gli eventuali soci (per nuovi apporti) e poi eseguirlo, confidando che nessun fornitore minore faccia precipitare le cose. In situazioni più complesse con molti creditori, il piano attestato rischia di essere inadeguato.
Differenze rispetto ad accordo di ristrutturazione: Giova ribadirlo sinteticamente – mentre l’accordo di ristrutturazione (ADR) richiede maggioranze qualificate (60% dei crediti) e l’omologa del tribunale, il piano attestato non richiede percentuali fisse né omologa . Questo lo rende più flessibile ma meno “protetto”. Anche gli effetti differiscono: sia piano attestato sia ADR proteggono da revocatorie e sanzioni penali per atti eseguiti in loro funzione , ma solo l’ADR comporta il divieto di azioni esecutive dei creditori e la prededucibilità dei nuovi finanziamenti automaticamente . In altre parole, con il piano attestato queste tutele non scattano a meno di pattuizioni specifiche con i creditori, mentre l’ADR le attiva ex lege (una volta omologato) . La scelta tra i due dipende dalla scala della crisi: un piano attestato è un vestito su misura per crisi affrontabili con pochi aggiustamenti e tanta privacy; l’ADR è per crisi più gravi dove serve l’ombrello giudiziale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Cos’è: È un accordo giuridico-formale, depositato in tribunale, tra l’imprenditore in crisi e una parte consistente dei suoi creditori (almeno il 60% dei crediti totali) , avente ad oggetto un piano di ristrutturazione (simile a un concordato ma senza coinvolgere per forza tutti i creditori). Il tribunale, verificati i presupposti, omologa l’accordo rendendolo efficace.
Caratteristiche principali:
- Percentuale di adesione standard: 60% dei crediti. I creditori aderenti rimangono vincolati dall’accordo, quelli estranei invece hanno diritto ad essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (se loro crediti già scaduti) o dalla scadenza naturale (se successiva) . In pratica, non posso coinvolgere coercitivamente un creditore dissenziente nell’accordo: devo pagarlo fuori, a meno che non sfrutti varianti normative particolari.
- Varianti agevolate: se il debitore rinuncia alla moratoria di 120 giorni per i non aderenti, impegnandosi a pagarli alle scadenze contrattuali originarie, la soglia di adesione richiesta scende al 30% (cosiddetto accordo di ristrutturazione agevolato, art. 60 CCII) . Inoltre, la riforma ha introdotto gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): in certi casi, se ottengo l’adesione del 75% dei crediti di una categoria omogenea (es. banche), posso chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori di quella categoria che non hanno aderito . Questo è pensato soprattutto per le banche dissenzienti minoritarie, in modo da evitare il problema del holdout (banca che resta fuori sperando di essere pagata al 100%). Ad esempio, il Tribunale di Roma nel 2023 ha applicato questa norma forzando le banche non aderenti a un accordo sottoscritto dal 90% degli istituti coinvolti .
- Omologa e cram-down Fisco/INPS: se tra i creditori c’è l’Erario o l’INPS, l’imprenditore può proporre nell’accordo il pagamento parziale anche di questi crediti (transazione fiscale e contributiva) . Se Fisco o enti previdenziali non aderiscono ma la loro adesione sarebbe determinante per raggiungere la maggioranza, il tribunale può ugualmente omologare (cram-down fiscale) purché un professionista attesti che l’accordo è più conveniente per loro rispetto alla liquidazione giudiziale . Le Sezioni Unite Cassazione nel 2021 avevano anticipato questo principio , ora codificato. Inoltre, in caso di diniego formale del Fisco, si è chiarito che vale come mancata adesione (non possono bloccare omologa votando no) , confermato dalla Cassazione n. 27782/2024 .
- Effetti durante la procedura: dal momento della pubblicazione della domanda di omologa nel registro delle imprese, scattano automaticamente le misure protettive (simili a quelle del concordato): stop alle azioni esecutive e cautelari dei creditori e divieto di acquisire titoli di prelazione su crediti anteriori (salvo autorizzazione) . Il debitore però resta in possesso dell’azienda e la gestisce normalmente, senza organi nominati dal tribunale (a differenza del concordato che prevede almeno un commissario giudiziale).
- Possibilità di opposizione: dopo il deposito dell’accordo e degli atti (tra cui la relazione dell’attestatore indipendente), i creditori non aderenti possono proporre opposizione in tribunale prima dell’omologa. Se le opposizioni non fanno emergere irregolarità o iniquità, il giudice omologa comunque. Questo introduce un fattore di incertezza: se c’è un creditore estraneo scontento (specialmente se non viene pagato integralmente entro 120 giorni per qualche ragione, o contesta le attestazioni), potrebbe ritardare l’omologa. Tuttavia, le riforme hanno cercato di limitare le opposizioni pretestuose: l’omologa verrà negata solo se l’accordo pregiudica i diritti degli estranei in misura peggiore rispetto a fallimento, oppure per mancanza delle condizioni legali.
Vantaggi: L’accordo di ristrutturazione, rispetto al concordato, è più snello (meno formalità, niente votazioni), più riservato (meno pubblicità mediatica, anche se l’iscrizione nel registro imprese comunque c’è) e lascia maggiore autonomia contrattuale alle parti. Può essere veloce se c’è consenso (si può ottenere omologa in pochi mesi). Inoltre, consente di modulare molto le soluzioni: non c’è l’obbligo di par condicio tra aderenti, è un contratto negoziato – anche se in pratica occorre trattare tutti sufficientemente bene da convincerli.
Svantaggi: Occorre raggiungere accordo con i creditori maggioritari, e convincerli uno ad uno può essere complesso. I piccoli creditori estranei vanno pagati per intero rapidamente, il che richiede liquidità. Inoltre, i costi professionali non sono trascurabili (attestatore, legali, eventuali consulenti finanziari). E se salta l’accordo (opposizioni o revoche di consenso) si rischia di perdere tempo prezioso.
Esempio pratico: Nel Caso Alfa S.r.l. (che riprenderemo nella sezione simulazioni) l’azienda in crisi con debiti verso banche (garantite) e fornitori ha utilizzato un Accordo di ristrutturazione agevolato: rinunciando a qualsiasi moratoria verso i fornitori estranei e promettendo di pagarli subito, è bastato avere il 30% di adesioni – superato agevolmente in quanto banche e fornitori principali rappresentavano circa il 75% dei crediti . L’accordo è stato depositato e omologato in circa 2 mesi, con transazione fiscale inclusa . I fornitori estranei sono stati saldati integralmente con la liquidità raccolta dalla vendita di un immobile; i fornitori aderenti hanno accettato un saldo del 70% in pochi mesi ; le banche hanno prolungato i finanziamenti e convertito una parte a capitale. Grazie all’omologa, l’azienda ha potuto rispettare l’accordo senza disturbi, e dopo un anno è tornata in bonis . Questo caso dimostra l’efficacia dell’ADR quando costruito bene.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
Cos’è: Il concordato preventivo è la procedura concorsuale “classica” di regolazione della crisi, alternativa al fallimento, in cui l’imprenditore propone ai creditori un piano – sotto controllo del tribunale – che può essere di risanamento (concordato in continuità) oppure di liquidazione (concordato liquidatorio). Si chiama “preventivo” perché interviene prima dell’eventuale fallimento, per prevenirlo appunto.
Tipologie:
- Concordato in continuità aziendale: caratterizzato dal fatto che l’attività d’impresa prosegue, durante la procedura e dopo l’omologazione. La continuità può essere diretta (lo stesso debitore continua a gestire l’azienda) oppure indiretta (il piano prevede la cessione o il conferimento dell’azienda a un altro soggetto che proseguirà l’attività) . L’obiettivo è ristrutturare l’impresa e i debiti, mantenendo la produzione e i posti di lavoro.
- Concordato liquidatorio: prevede la cessione o liquidazione di tutti i beni del debitore per pagare i creditori, senza prosecuzione dell’attività oltre quanto necessario alla cessione. È simile a un fallimento ma volontario e con alcune condizioni di maggior favore. Ad esempio, nel concordato liquidatorio “ordinario” la legge impone un apporto di risorse esterne almeno del 10% a beneficio dei creditori chirografari, salvo che questi siano pagati almeno al 20% (regola introdotta per evitare concordati “tombali” troppo penalizzanti). NB: Questo 10% è il requisito attuale nel CCII, mentre in passato la giurisprudenza (Cass. SS.UU. 2019 n.7166) pretendeva un 20% minimo ; il CCII ha abbassato la soglia in recepimento della Direttiva UE.
Procedura: Il concordato è molto più strutturato:
- Domanda: si deposita un ricorso presso il tribunale competente, corredato da relazione sulla situazione patrimoniale, elenco creditori, elenco beni, piano e proposta, e relazione giurata di un attestatore indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano.
- Ammissione: il tribunale fa un primo esame; se il piano è ammissibile e non manifestamente irrealizzabile, emette un decreto di apertura della procedura, nomina un Commissario Giudiziale (figura di controllo) e stabilisce la data per l’adunanza dei creditori . Da qui scattano effetti protettivi analoghi a quelli già descritti (sospensione azioni, divieto pagamenti pregresse salvo autorizzati, ecc.). Nel concordato in continuità l’imprenditore rimane alla guida (sorvegliato dal commissario); nel liquidatorio può restare come “custode” ma di fatto le operazioni rilevanti sono in mano al commissario.
- Voto dei creditori: i creditori vengono suddivisi per classi (se previste) e categorie giuridiche (privilegiati, chirografari, ecc.). Entro l’adunanza o poco dopo, esprimono il voto sulla proposta. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (ovvero il 50% + 1 in valore dei crediti votanti; e almeno il 50% di tutte le classi votanti, se classi) . Alcuni creditori non votano (privilegiati soddisfatti integralmente, ecc.).
- Omologazione: se la maggioranza approva, il tribunale passa all’udienza di omologazione. Se ci sono classi dissenzienti o opposizioni di creditori contrari, il tribunale valuta se la proposta è comunque fattibile e conveniente per i creditori e se rispetta le norme (par condicio, cause di prelazione, ecc.). Può omologare anche in presenza di voti contrari di talune classi (cram-down di classi), applicando la regola di priorità relativa: basta che nessuna classe dissenziente riceva più di una classe inferiore (non serve rispettare l’assoluta priorità integrale) . Questo recepisce la Direttiva UE 1023/2019. Inoltre, come già visto, può omologare nonostante il voto contrario del Fisco/INPS (cram-down fiscale) .
Effetti: Con l’omologazione, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti (a differenza dell’ADR che vincola solo aderenti, salvo efficacia estesa). Il debitore esce dalla procedura e attua il piano sotto la sorveglianza finale del commissario (che diventa liquidatore giudiziale se c’è da vendere beni) . I crediti vengono pagati secondo le percentuali e tempistiche stabilite. I creditori non possono più agire individualmente (i pignoramenti decadono). Se il debitore adempie al concordato, la crisi è risolta; se inadempie, i creditori possono chiederne la risoluzione e a quel punto si apre la liquidazione giudiziale.
Concordato semplificato: Introdotto nel 2021 e ora integrato negli artt. 25-sexies e segg. CCII , è una forma particolare riservata ai casi di composizione negoziata fallita: se un imprenditore ha tentato la CNC senza trovare un accordo soddisfacente, può proporre al tribunale un concordato liquidatorio senza voto dei creditori . Il tribunale valuta la proposta ed eventualmente omologa dopo aver sentito i creditori (possono fare osservazioni, ma non c’è votazione) . È semplificato perché elimina la fase del voto e anche la fase di ammissione/commissario: il tribunale può nominare un ausiliario per esaminare il piano e poi direttamente un liquidatore per l’esecuzione . Il concordato semplificato è solo liquidatorio e mira a vendere rapidamente l’azienda o i beni, evitando il fallimento ma portando comunque alla cessazione dell’attività (salvo cessione a terzi). Si tratta di un’extrema ratio quando non c’è tempo o consenso per un concordato normale. La recente riforma del 2024 ha introdotto alcune modifiche per perfezionare l’istituto (ad esempio, prevedendo criteri per la nomina del liquidatore, ecc.) .
Vantaggi del concordato: Offre il più ampio raggio di ristrutturazione: puoi includere tutti i creditori e imporre una falcidia anche drastica (nel rispetto dei privilegi), purché raggiungi le maggioranze. Consente soluzioni creative (continuità, affitto d’azienda durante procedura, intervento di nuovi investitori, ecc.). Dal 2022, con l’introduzione delle classi e del cram-down, è diventato più flessibile: non è più sufficiente che una banca ipotecaria dissenziente blocchi tutto, se la proposta è comunque migliore del fallimento per tutti.
Svantaggi: È lungo e costoso. Richiede l’intervento di almeno un paio di professionisti indipendenti (attestatore, commissario) e di avvocati; le spese di procedura e i compensi devono poi essere pagati e normalmente hanno prededuzione. Finché non è omologato c’è incertezza sull’esito. Inoltre, l’azienda “marchia” pubblicamente che è in concordato, il che può generare sfiducia in clienti e fornitori (anche se ormai è percepito come strumento di risanamento, c’è sempre uno stigma). Infine, il concordato in continuità è soggetto a stringenti controlli di fattibilità economica: il giudice non entra nel merito industriale, ma se il piano appare manifestamente irrealizzabile può non ammettere o non omologare (il concetto di “fattibilità nel limite della non manifesta irrealizzabilità” è consolidato ).
Quando preferirlo: Se la situazione coinvolge tante parti e serve un fresh start generale. Ad esempio, se la nostra azienda di blocchi idraulici non fosse riuscita a ottenere l’accordo con i creditori fuori dal tribunale (come nel Caso Alfa), avrebbe potuto presentare un concordato preventivo in continuità: il piano probabilmente simile, ma soggetto a voto. Avrebbe creato classi di banche, fornitori, Fisco ecc., e chiesto l’approvazione. Con un 75% di crediti già favorevole (come ipotizzato prima), avrebbe sicuramente ottenuto la maggioranza. In concordato, avrebbe potuto anche chiedere misure come la moratoria biennale sui creditori ipotecari (che il CCII consente: pagare i privilegiati entro 2 anni dall’omologa, anche senza il loro consenso, se il concordato è in continuità, art. 86). Insomma, il concordato è duttile ma va intrapreso con preparazione, perché un fallimento di un concordato (non approvazione o revoca) peggiora la situazione.
Strumenti di allerta e composizione negoziata (artt. 12-25 CCII)
Prima di passare ai casi pratici e alle FAQ, spendiamo qualche parola sugli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi introdotti dalla riforma. Il legislatore, recependo anche la direttiva UE, ha voluto incentivare la diagnosi precoce della crisi:
- Assetti organizzativi adeguati (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII): come già detto, ogni società deve dotarsi di sistemi interni per monitorare la propria situazione (bilanci infrannuali, indici di allerta). Ci sono degli indici di allerta che il CNDCEC (Consiglio dei commercialisti) e il MISE hanno elaborato come soglie (ad esempio indice di sostenibilità degli oneri finanziari, indice di liquidità, ecc.) per capire se l’azienda sta scivolando verso la crisi. Tali indici ufficiali al momento sono soft law, ma possono servire come riferimento per gli organi di controllo (sindaci, revisori) che hanno l’obbligo di segnalare agli amministratori eventuali sintomi di crisi.
- Segnalazioni obbligatorie esterne: il CCII prevedeva (Titolo II) un sistema di “Allerta” con segnalazioni obbligatorie da parte di alcuni creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, Agente Riscossione) al superamento di certe soglie di debito scaduto, e la creazione di un Organismo di Composizione assistita (OCRI) presso le Camere di Commercio. Questo sistema, però, ha subito varie proroghe e in parte è stato superato dalla composizione negoziata. Al 2025, le segnalazioni dei creditori pubblici non sono ancora operative automatiche, mentre resta l’obbligo interno degli organi di controllo di avvisare gli amministratori e, se persistono inerzia e squilibrio, di informare il tribunale (art. 25-octies CCII).
- Composizione negoziata della crisi: è uno strumento volontario a disposizione dell’imprenditore in crisi (anche sotto soglia, anche agricolo) consistente nel farsi affiancare da un esperto indipendente nominato dalla Commissione della Camera di Commercio per cercare soluzioni stragiudiziali. La procedura è riservata: l’esperto valuta la situazione dell’impresa, convoca i creditori e tenta di facilitare un accordo (che può essere un contratto, un accordo di ristrutturazione, un piano attestato, o anche la cessione dell’azienda). L’esperto ha circa 3+2 mesi per la negoziazione. Durante questo periodo, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (come visto: sospensione azioni esecutive) e anche alcune autorizzazioni (per contrarre finanziamenti prededucibili, cedere magazzino, sciogliersi da contratti onerosi, ecc.). La CNC è stata molto utilizzata dall’entrata in vigore (novembre 2021) perché offre un percorso guidato ma flessibile per evitare il default: non c’è pubblicità (a meno di misure protettive richieste, che vanno iscritte nel registro imprese) e l’esperto funge da mediatore qualificato. Se la CNC ha successo, si chiude con un accordo (privato o omologato). Se fallisce, l’imprenditore può valutare il concordato semplificato o altre procedure.
In pratica, la CNC è consigliabile come primo intervento quando la crisi è gestibile e si vuole evitare di partire subito con procedure concorsuali formali. È stata definita un “tavolo negoziale protetto”: la sua efficacia dipende molto dalla collaborazione dei creditori. Ad esempio, se i creditori finanziari si rifiutano di sedersi al tavolo, la CNC servirà a poco. Invece, se c’è apertura, l’esperto può convincere le parti sulla convenienza di una soluzione concordata piuttosto che del fallimento.
Un punto di forza della CNC è la possibilità, se l’esperto lo certifica, di ottenere fiscalità di vantaggio: l’impresa può chiedere il trattamento fiscale di esenzione delle sopravvenienze e la non punibilità per il reato di bancarotta preferenziale per i pagamenti effettuati durante la negoziazione, purché coerenti col piano di risanamento in corso (art. 23 CCII).
Cruciale: la CNC non è una procedura concorsuale, l’imprenditore non perde la gestione, ma deve cooperare con l’esperto in modo trasparente, altrimenti l’esperto può porre fine alla negoziazione. Se va bene, benissimo; se va male, almeno si è tentato e c’è ancora la chance del concordato semplificato come via d’uscita.
Confronto tra strumenti principali
Proponiamo una tabella riepilogativa dei principali strumenti e delle loro caratteristiche chiave, utile all’imprenditore e ai suoi consulenti per scegliere la strada più appropriata:
| Strumento | Coinvolgimento Tribunale | Adesione creditori richiesta | Effetti protettivi | Obiettivo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | No omologa; solo asseverazione di un attestatore. | Nessuna soglia fissa, accordi stragiudiziali con chi si vuole. | Nessuna protezione automatica (solo accordi privati). Revocatoria esclusa per atti esecutivi del piano . | Risanamento fuori dal tribunale. | Riservato. Necessita collaborazione volontaria creditori. Uso per crisi lieve/moderata. |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII) | Sì, omologa da parte del tribunale; no commissario di norma. | ≥60% dei crediti (o ≥30% se “agevolato” senza moratoria ). Possibile estensione a dissenzienti in alcune classi (75%). | Sospende azioni esecutive dalla pubblicazione . Creditori estranei da pagare entro 120 gg (se scaduti) . | Risanamento con accordo contrattuale + decreto giudice. | Flessibile, rapido. Creditori estranei tutelati (full payment). Include transazione fiscale con cram-down . |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) | Sì, controllo tribunale + commissario nominato. Omologa finale. | Approvazione ≥50% crediti votanti (salvo cram-down classi) . Coinvolge tutti i creditori. | Automatic stay da apertura. Contratti pendenti tutelati (no risoluzioni per insolvenza) . Pagamenti prededucibili autorizzabili. | Continuità o liquidazione guidata, a seconda del piano. | Procedura pubblica e articolata (mesi/anni). Costi alti. Possibile cram-down fiscale e di classi dissenzienti. Garantisce esdebitazione imprenditore onesto a fine (art. 278 CCII). |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) | Sì, ma senza voto creditori né commissario pre-omologa . Nomina liquidatore dopo omologa. | Nessuna maggioranza: è imposto dal giudice se equo. Creditori possono solo fare osservazioni. | Misure protettive ottenute già in CNC. Omologa chiude procedure esecutive. | Liquidazione rapida dell’azienda sotto controllo giudice. | Solo se CNC fallita. Debitore rinuncia a continuità. Strumento residuale ma utile per evitare fallimento e chiudere subito le pendenze. |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Sì, totale: nomina curatore; imprenditore esautorato. | Nessuna adesione: è procedimento avviato da terzi o d’ufficio se insolvenza. | N/A (è procedura esecutiva collettiva). | Liquidazione patrimonio per soddisfare creditori secondo prelazioni. | Da evitare se possibile. L’imprenditore può ottenere esdebitazione residui debiti dopo chiusura , ma azienda normalmente sparisce. |
Ogni strumento ha requisiti e vantaggi diversi. La scelta giusta dipende dal caso specifico: ad esempio, per un’azienda con prospettive di rilancio e creditori collaborativi, un accordo stragiudiziale o un concordato in continuità possono salvare il business; per un’azienda decotta senza speranze di continuità, meglio un concordato liquidatorio (tradizionale o semplificato) per chiudere dignitosamente evitando il fallimento.
Nei prossimi paragrafi metteremo “in azione” questi strumenti attraverso delle simulazioni pratiche e poi risponderemo ad alcune domande frequenti che imprenditori e professionisti si pongono in queste circostanze. Infine, tratteremo il tema cruciale della protezione del patrimonio personale dell’imprenditore-debitore.
Simulazioni pratiche (casi reali ipotetici)
Presentiamo ora alcune simulazioni ipotetiche, ispirate a casi reali, per illustrare come gli strumenti descritti possano essere applicati e con quali effetti. Ogni caso evidenzia il tipo di impresa, la natura della crisi e il percorso di risanamento o liquidazione adottato.
Caso 1: PMI manifatturiera in crisi finanziaria – Ristrutturazione tramite Accordo e Concordato
Scenario: Alfa S.r.l. è una PMI metalmeccanica (50 dipendenti) che produce componenti oleodinamici per macchine agricole. Negli ultimi 2 anni ha subito un calo di fatturato del 30% e ha accumulato debiti: €2 milioni verso banche (scoperti di conto e mutui), €800k verso fornitori, €300k tra debiti fiscali e contributivi non versati. Il patrimonio aziendale comprende un capannone industriale (valore €1M su cui una banca ha ipoteca da €600k) e macchinari per €500k (liberi da vincoli). I segnali di crisi ci sono tutti: ritardi oltre 90 giorni nei pagamenti a fornitori per €400k; sconfinamenti continuativi sulle linee di fido; alcune commesse importanti perse per difficoltà a finanziare l’acquisto di materie prime. Il titolare, ing. Alfa, ha inizialmente sperato in nuovi ordini e ha ritardato l’azione. A inizio 2025, però, la crisi diventa conclamata: l’azienda non ha liquidità per pagare tutti gli stipendi e i fornitori; due banche inviano preavvisi di revoca fidi e un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo di €50k.
Azione intrapresa: Ing. Alfa, consigliato dal proprio commercialista, decide di attivare subito una Composizione Negoziata della crisi (CNC) per congelare la situazione e cercare una soluzione. Tramite la piattaforma nazionale nominano un esperto indipendente a febbraio 2025 . Contestualmente, Alfa S.r.l. richiede al tribunale misure protettive: il giudice emette un decreto che sospende temporaneamente tutte le azioni esecutive dei creditori . Ciò significa che i decreti ingiuntivi dei fornitori non possono essere trasformati in pignoramenti, e le banche non possono revocare formalmente i fidi né escutere i pegni (c’è una norma nel CCII che vieta alle banche di revocare le linee durante la CNC se non autorizzate) . Questa boccata d’ossigeno dà all’esperto e all’azienda 3 mesi per trattare con i creditori senza l’assillo di vedere i beni bloccati.
Con l’aiuto dell’esperto, Alfa S.r.l. elabora un piano di risanamento integrato:
- Vendere il capannone industriale (non essenziale, l’azienda può affittarne uno più piccolo) a un investitore locale per €1M, con contestuale stipula di un contratto di locazione del medesimo capannone (operazione di sale & lease-back informale) a un canone sostenibile .
- Far entrare un nuovo socio finanziatore disposto a investire €500k in equity per rafforzare il capitale circolante (si tratta di un cliente estero interessato a una partnership).
- Rinegoziare i debiti bancari: proporre alle banche un allungamento delle scadenze dei mutui di ulteriori 2 anni, un periodo di grazia di 6 mesi senza rate, e la conversione di €100k di esposizione di conto in partecipazione al capitale (una banca accetta di capitalizzare una quota del credito, diventando socia al 10%).
- Proporre ai fornitori uno stralcio del 30%: pagare cioè 70% dei debiti fornitori, ma in tempi brevi (6-12 mesi), in cambio della rinuncia al restante 30%. Ai fornitori “critici” (quelli che servono per continuare a produrre) promettere pagamento integrale di futuri ordini e continuità di rapporto.
- Includere nel piano una transazione fiscale: offrire al Fisco e all’INPS di pagare il 50% dei €300k di debiti tributari/contributivi in 24 rate (2 anni) con attivazione del cram-down se necessario .
L’esperto convoca banche e fornitori principali. Dopo intense trattative, ottiene un consenso di massima: le banche, vedendo che entrano €1,5M freschi (vendita immobile + nuovo socio) e che eviterebbero un probabile fallimento disastroso, accettano di congelare i pagamenti per qualche mese e rinegoziare secondo le condizioni proposte . I fornitori, che temono di perdere tutto in caso di fallimento (le stime di realizzo nel caso liquidatorio erano del 20% per i chirografari), si dichiarano disponibili ad accettare 70% a saldo, purché i pagamenti siano rapidi .
Soluzione adottata: Verso la fine di aprile 2025, con l’assistenza legale, Alfa S.r.l. formalizza un Accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori aderenti. Poiché l’azienda si impegna a pagare subito i fornitori non aderenti (con i proventi attesi della vendita del capannone), sceglie la formula dell’accordo agevolato ex art. 60 CCII, che richiede solo il 30% di adesioni . Nel caso di Alfa, però, l’adesione raccolta è molto superiore: 75% del totale crediti (tutte le banche e il 65% dei fornitori in valore, insieme superano tale quota) . Dunque, anche un accordo “ordinario” sarebbe bastato, ma aver rinunciato alla moratoria sui dissenzienti è servito a convincere i più scettici. L’accordo viene depositato in tribunale per l’omologazione. Nel frattempo viene presentata all’Agenzia Entrate la proposta di transazione fiscale: pagando 50% del dovuto in 2 anni, con attestazione che in caso di fallimento l’Erario recupererebbe solo 20% . L’Agenzia, valutando la convenienza, aderisce formalmente (dando così il suo consenso ed evitando di dover ricorrere al cram-down) .
A maggio 2025, il Tribunale omologa l’accordo. Non risultano opposizioni significative: i fornitori estranei sono soddisfatti al 100% e non hanno motivo di opporsi . Immediatamente dopo l’omologa, il piano va in esecuzione: Alfa S.r.l. finalizza la vendita dell’immobile incassando €1M (avendo ottenuto dall’esperto e dal tribunale l’autorizzazione a impegnarsi in tal senso durante la CNC stessa) , con quei soldi paga integralmente entro 60 giorni tutti i fornitori estranei e versa un primo acconto ai fornitori aderenti (che riceveranno il 70% in 6 mesi) . Le banche proseguono i rapporti: non revocano le linee di credito anzi ne concedono di nuove per permettere all’impresa di acquistare materie prime (forniscono nuove fideiussioni per ordini, garantite anch’esse in prededuzione) . Il nuovo socio apporta €500k in aumento di capitale, usati in parte per pagare debiti (quote ai fornitori aderenti) e in parte come capitale circolante per riprendere la produzione . Nel frattempo, l’accordo transattivo fiscale viene rispettato: vengono versate regolarmente le rate semestrali all’Erario, il che consente all’azienda di ottenere la cancellazione delle ipoteche esattoriali che gravavano sul capannone (ora venduto) e sugli altri beni, oltre a beneficiare dello stralcio sanzioni .
Esito: Nell’estate 2025 Alfa S.r.l. torna operativa a pieno ritmo. I debiti finanziari sono stati “spalmati” e in parte convertiti in capitale, i debiti verso fornitori ridotti e onorati in parte, e il debito fiscale dimezzato e dilazionato . L’azienda ha perso la proprietà del capannone, ma lo utilizza in affitto a canone sostenibile, liberando risorse. Soprattutto, ha evitato la liquidazione giudiziale e mantenuto i posti di lavoro: tutti i 50 dipendenti sono rimasti a bordo. Dopo un anno, grazie anche a nuovi contratti dall’estero (favoriti dalla ritrovata stabilità), Alfa S.r.l. genera utili modesti ma sufficienti a rispettare il piano di ristrutturazione. I creditori hanno ottenuto in media circa il 70% dei loro crediti (banche ipotecarie qualcosa di più considerando la conversione in equity, fornitori tra 50% e 70%, Fisco 50%) . In caso di fallimento, stimato, i fornitori avrebbero recuperato forse il 20%, le banche ipotecarie si sarebbero contese un capannone svenduto a metà del valore, i dipendenti avrebbero perso il lavoro. Tutti escono meglio da questo concordato stragiudiziale.
Considerazioni: La combinazione CNC + accordo di ristrutturazione agevolato + transazione fiscale ha funzionato egregiamente in questo caso . La chiave è stata agire tempestivamente (la crisi era seria ma ancora gestibile), avere asset liquidabili (immobile) e un partner che ha creduto nel rilancio. Se però i fornitori non avessero aderito in numero sufficiente – ipotizziamo solo il 40% – allora Alfa S.r.l. avrebbe ripiegato su un concordato preventivo in continuità . In tale scenario alternativo, il piano sarebbe stato presentato al tribunale con classi: ad esempio una classe banche (privilegiati ipotecari parzialmente degradati per la parte chirografa), una classe fornitori chirografari, una classe Fisco chirografo. Se i fornitori erano recalcitranti, con le banche e l’Erario dalla sua parte, l’azienda avrebbe puntato a convincere il tribunale dell’utilità del piano anche contro il voto negativo dei fornitori (cram-down di classe). Avrebbe dovuto rispettare comunque le soglie minime (pagare almeno 20% ai fornitori in caso di concordato liquidatorio, ma in continuità non c’è soglia minima specifica oltre al test di convenienza). Dato che nel caso reale l’ADR è riuscito, non è stato necessario. Ma questa variante fa capire che l’imprenditore aveva comunque un “piano B” per evitare il fallimento.
Caso 2: Impresa Edile di medie dimensioni – Concordato Preventivo in Continuità Indiretta
Scenario: Beta Costruzioni S.p.A. è un’impresa edile con 3 cantieri aperti e circa 80 dipendenti. La crisi scoppia quando uno dei principali progetti (un complesso residenziale) subisce uno stop per problemi autorizzativi: i flussi di cassa attesi saltano, Beta si trova esposta con le banche (mutui cantiere per €5 milioni garantiti da ipoteche sugli immobili in costruzione) e con decine di subappaltatori e fornitori (€2 milioni di debiti). Inoltre, i preliminari di vendita degli appartamenti comportano obblighi verso acquirenti che hanno versato caparre. Nel 2024 Beta S.p.A. inizia a non pagare puntualmente i subappaltatori, alcuni lasciano il cantiere. Arrivano ingiunzioni e il cantiere si ferma definitivamente. L’azienda è insolvente ma possiede ancora l’asset principale: il cantiere stesso (terreno ed opere per ora coperte dal mutuo).
Problema: In edilizia, un fallimento può essere rovinoso perché i cantieri in sospeso svalutano moltissimo (acquirenti scappano, ditte portano via materiali, ecc.). Il CEO di Beta vorrebbe salvare almeno il progetto, magari coinvolgendo un investitore esterno che subentri.
Soluzione adottata: Beta S.p.A. opta per un concordato preventivo in continuità indiretta: propone ai creditori che l’azienda, una volta in concordato, cederà l’intero cantiere e ramo d’azienda a una società terza (un General Contractor più grande) che si impegna a finirlo e a consegnare gli immobili agli acquirenti. In cambio, questo soggetto paga un corrispettivo che andrà a beneficio dei creditori. Essenzialmente è una vendita dell’azienda “sana” all’interno del concordato, con prosecuzione dell’attività in mano al subentrante (continuità indiretta). Il piano prevede che i dipendenti siano assorbiti dal nuovo costruttore, i debiti verso fornitori siano falcidiati al 50%, e i debiti bancari (garantiti da ipoteca sugli immobili incompleti) siano rimborsati al 70% grazie all’apporto di finanza del soggetto subentrante. Si configura quindi un concordato misto: in parte liquidatorio (perché Beta esce cedendo tutto), in parte in continuità (perché l’opera viene completata da altri).
Iter: Beta deposita domanda di concordato con riserva, ottiene le misure protettive (i subappaltatori non possono pignorare macchinari né le banche avviare espropri sugli immobili). Presenta poi la proposta definitiva con l’offerta vincolante del investitore terzo. Il commissario giudiziale nominato verifica la fattibilità e redige la sua relazione. Nelle classi, Beta mette: classe 1 banche ipotecarie (privilegiate, proposte 70% entro 1 anno dalla cessione); classe 2 subappaltatori e fornitori (chirografari, proposti 50% in 2 anni, fondi provenienti in parte dall’investitore e in parte da un finanziamento dilazionato con garanzia sui futuri incassi delle vendite); classe 3 acquirenti di immobili (trattati fuori concorso: non chiedono soldi ma la consegna delle case, che avverrà dal nuovo costruttore). I creditori votano: banche (classe 1) favorevoli perché prenderebbero forse meno in caso di fallimento forzato; fornitori (classe 2) inizialmente divisi, ma si rendono conto che se Beta fallisce probabilmente il cantiere resta fermo anni e loro recuperano forse il 20% o nulla. Alla fine, la maggioranza in valore approva (70% dei chirografari dice sì, banche unanimi). Un paio di subappaltatori dissenzienti fanno reclamo sostenendo di meritare di più, ma il tribunale – vista l’adesione larga e l’attestazione che avrebbero avuto il 0-20% in fallimento – omologa il concordato.
Esito: Beta S.p.A. cede il cantiere e l’azienda al nuovo costruttore subito dopo l’omologa (autorizzazione già nel decreto di omologa). I creditori ricevono i pagamenti secondo il piano: banche il 70% (meglio di far liquidare semi-fabbricati invendibili), fornitori 50%. Gli appartamenti vengono completati e consegnati: gli acquirenti non agiscono contro Beta (che sennò rischiava cause). Beta come società viene poi sciolta una volta eseguito il piano. Questo esempio mostra un uso virtuoso del concordato in continuità indiretta per risolvere crisi di imprese di costruzioni, dove l’obiettivo è evitare di “spezzare” la continuità dei lavori.
Caso 3: Liquidazione di una Startup Innovativa fallita – Sovraindebitamento del Fondatore
Scenario: Delta Digital S.r.l. è una startup innovativa fondata nel 2022 da un giovane ingegnere (Mr. Delta) per sviluppare un software industriale. Ha ricevuto finanziamenti pubblici e prestiti bancari garantiti dal Fondo PMI per €200k, oltre a forniture di hardware da vari vendor per €100k. Purtroppo nel 2024 la tecnologia non dà i frutti sperati e i soci non investono più. Delta Digital cessa l’attività a fine 2024, di fatto insolvente con debiti totali €300k. Tra l’altro, Mr. Delta aveva dato una garanzia personale su parte dei finanziamenti bancari (fideiussione da €50k) e aveva pure contratto debiti personali (carte di credito, un mutuo) confidando nel successo della startup.
Problema: La S.r.l. è “fallibile”? I numeri sono al limite: attivo < €100k, ricavi < €50k, debiti €300k – è esattamente la soglia massima per impresa minore. Potrebbe sostenere di essere sotto soglia e quindi evitare la liquidazione giudiziale. In ogni caso, anche se la società non fallisse, i creditori (soprattutto la banca) inseguiranno il fondatore sul piano personale grazie alla fideiussione.
Soluzione legale: Delta Digital S.r.l. decide di utilizzare le procedure di sovraindebitamento ora ricomprese nel CCII. Non essendo certa la “fallibilità”, si muove come se fosse non fallibile: di fatto la società ha cessato e non ha beni se non qualche PC, quindi non ha senso un concordato preventivo (non c’è continuità né asset per pagare i creditori più di tanto). Presenta istanza di liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): una procedura concorsuale semplificata prevista per i soggetti non fallibili, simile al vecchio liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. Il tribunale nomina un liquidatore che liquida quel poco di attivo della startup e ripartisce ai creditori (ricavato 10k, briciole per tutti). Mr. Delta, trovandosi a titolo personale sovraindebitato (tra la garanzia escussa e i debiti personali per altri 50k), ricorre anch’egli agli strumenti: propone un Piano di ristrutturazione del consumatore (artt. 67-73 CCII), impegnandosi a pagare in 5 anni il 50% dei suoi debiti usando i proventi di un nuovo lavoro dipendente che ha trovato, e chiedendo la remissione del resto. I creditori personali (banca e finanziarie) non votano, decide il giudice sulla fattibilità e meritevolezza (verifica che il sovraindebitamento non sia colpa grave o malafede, e qui trattandosi di insuccesso imprenditoriale e non spese voluttuarie, passa). Il piano del consumatore viene omologato dal tribunale.
Esito: La startup viene cancellata. Mr. Delta per 5 anni paga una rata sostenibile ai suoi creditori personali. Trascorso il periodo, otterrà l’esdebitazione: la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati nel piano, compresi quelli eventualmente rimasti dalla liquidazione della società di cui era fideiussore. Questo caso evidenzia come anche per i piccoli imprenditori o startup esista la possibilità di un’uscita ordinata, senza doversi trascinare debiti a vita: se non fallibili, c’è il concordato minore o piano del consumatore; se poi rimangono debiti insoddisfatti, la legge prevede l’esdebitazione di diritto (cancellazione debiti) per l’imprenditore onesto ma sfortunato, una volta conclusa la liquidazione (art. 282 CCII e seguenti) .
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo brevemente ad alcune domande frequenti che sorgono in tema di imprese indebitate e strumenti di difesa, dal punto di vista pratico del debitore. Le risposte fanno riferimento alla normativa aggiornata a ottobre 2025.
D1: Quali segnali indicano che la mia azienda è in crisi e non un semplice momento difficile?
R: I principali indicatori di crisi sono: incapacità persistente di pagare puntualmente debiti e spese correnti (es. ritardi > 90 giorni con fornitori, rate mutuo saltate), flussi di cassa operativi negativi, erosione del patrimonio (perdite che riducono il capitale netto sotto i limiti di legge), tensioni con banche (fidi revocati, sconfinamenti continui), oltre ad eventuali atti legali (ingiunzioni, pignoramenti) . Se la gestione ordinaria mostra squilibri di carattere duraturo – ad esempio, serve continuamente nuovo debito per pagare debito esistente, o non si riescono a pagare stipendi e tasse – non è più solo un momento difficile ma uno stato di crisi (probabile insolvenza). A livello normativo, esistono indici elaborati (indici di allerta) per misurare tali segnali; ma empiricamente, quando l’imprenditore si accorge di dover scegliere chi pagare e chi no ogni mese, significa che la crisi c’è.
D2: Cosa prevede il Codice della Crisi riguardo all’obbligo di attivarsi?
R: Prevede che l’organo amministrativo deve attivarsi tempestivamente appena emerge la crisi, adottando e attuando uno degli strumenti di regolazione previsti (piani, accordi, concordato). Questo obbligo discende dall’art. 2086 c.c. (adeguati assetti per rilevare la crisi) e dagli artt. 3 e 24 CCII. In caso di inerzia colpevole, gli amministratori possono essere ritenuti responsabili dei maggiori danni causati ai creditori per il ritardo . Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2020 hanno sancito che l’amministratore che non richiede una procedura concorsuale e continua l’attività aggravando il dissesto risponde verso i creditori (azione ex art. 2486 c.c. e 2476 c.c. per SRL) . Inoltre, il CCII ha rafforzato i doveri degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore) che devono sollecitare gli amministratori e, se questi omettono, informare il tribunale. In sostanza, la legge oggi impone una sorta di “dovere di emersione anticipata” della crisi per evitare che diventi insolvenza irreversibile.
D3: Quali sono le opzioni legali per ristrutturare i debiti ed evitare il fallimento?
R: Le opzioni vanno dal meno invasivo al più strutturato, e spesso possono combinarsi:
- Ristrutturazione “in house”: negoziazioni private con i creditori (piani di rientro, saldo e stralcio), eventualmente formalizzate in un piano attestato di risanamento . Utile se pochi creditori e collaborazione possibile.
- Composizione Negoziata: procedura di allerta assistita da un esperto, senza tribunale, per trovare accordi stragiudiziali con protezione temporanea dalle azioni (si può sfociare in qualunque soluzione: piano, accordo, concordato, cessione azienda).
- Accordo di Ristrutturazione dei debiti (ADR): contratto con vincolo legale omologato con i creditori che rappresentano almeno il 60% (o 30%) dei debiti . Mantiene l’azienda viva e ferma le azioni esecutive durante l’omologa. Adatto se hai il consenso dei principali creditori.
- Concordato Preventivo: procedura concorsuale giudiziale in cui tutti i creditori sono coinvolti e votano un piano di risanamento o liquidazione. Permette soluzioni più drastiche (taglio dei debiti anche senza consenso unanime) e protezione più lunga, evitando il fallimento. Può prevedere continuità aziendale (impresa che prosegue) o liquidazione di beni.
- Concordato Semplificato: se fallisce la negoziazione, consente una sorta di “concordato imposto” liquidatorio, rapido, che però porta alla chiusura attività. Si evita il fallimento, ma l’azienda non prosegue (a meno che qualcuno rilevi l’attività).
- Procedure di sovraindebitamento: per micro imprese non fallibili e persone fisiche: concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata. In casi estremi, c’è anche l’esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione debiti residui per chi proprio non ha nulla da offrire, una tantum).
D4: Cos’è la Composizione Negoziata della crisi e come funziona?
R: È un percorso stragiudiziale volontario, introdotto nel 2021, in cui l’imprenditore in crisi chiede l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio per negoziare con i creditori . Funziona così: tramite una piattaforma online si invia istanza con i dati aziendali; se l’azienda ha prospettive di risanabilità (c’è un test auto-diagnosi iniziale), viene assegnato un esperto (spesso un commercialista esperto in ristrutturazioni). Si tengono incontri riservati con i creditori per trovare un accordo: può essere una moratoria, una ristrutturazione del debito, la ricerca di nuovi investitori o la cessione dell’azienda. Durante la CNC, su istanza del debitore, il tribunale può emettere misure protettive (sospensione dei pagamenti dovuti e divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive) . La durata è di 3 mesi + eventuali 3 di proroga. Se si trova una soluzione, si formalizza (es. accordo stragiudiziale o richiesta di concordato). Se non si trova, la procedura si chiude. La CNC non è pubblica, salvo annotazione delle misure protettive; ciò la rende appetibile perché non etichetta subito l’azienda come “in concordato”. Può essere attivata da tutte le imprese, anche di piccole dimensioni e agricole. In sintesi, è un tavolo di conciliazione protetto: vantaggi = flessibilità, riservatezza, stop temporaneo dei creditori; svantaggi = non vincola i creditori dissenzienti (a meno di accordi formalizzati), quindi se non c’è collaborazione potrebbe risolversi in un nulla di fatto. Comunque, anche in quel caso, l’esperto redige una relazione finale che può esonerare da responsabilità l’imprenditore per i pagamenti fatti in buona fede durante la negoziazione, e apre la porta al concordato semplificato.
D5: Che differenza c’è tra un accordo di ristrutturazione dei debiti e un concordato preventivo?
R: Pur avendo finalità simili (evitare il fallimento ristrutturando i debiti), accordo e concordato differiscono per natura giuridica e iter:
- L’accordo di ristrutturazione è in sostanza un contratto tra debitore e creditori qualificati (60% dei crediti) omologato dal tribunale . Non c’è voto di tutti i creditori: conta solo la percentuale di adesione. I creditori che non aderiscono rimangono estranei, e vanno pagati integralmente fuori dall’accordo (entro 120 giorni dall’omologa) . Non si nominano commissari o organi (salvo eventualmente un attestatore per la relazione). È più rapido e con meno formalità. Tuttavia, non consente di imporre sacrifici ai creditori non consenzienti (salvo l’estensione per classi omogenee ex art. 61 CCII in casi limitati).
- Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale. Coinvolge tutti i creditori, che votano in maggioranza per approvare (o meno) la proposta . Ha organi nominati (commissario, eventuale liquidatore). Consente di imporre tagli anche ai creditori contrari, purché si raggiungano le maggioranze o tramite cram-down. Offre quindi un respiro più ampio e definitivo: dopo l’omologa, tutti i creditori sono vincolati. D’altro canto, richiede più tempo e pubblicità, e i costi di procedura sono maggiori.
- In sintesi, l’accordo è “più consensuale”, il concordato “più autoritativo”. Un’altra differenza: nell’accordo le parti possono concordare molti aspetti liberamente e non c’è giudizio di merito del tribunale (solo legittimità e convenienza per estranei), nel concordato il tribunale valuta anche la fattibilità del piano e il rispetto di norme inderogabili (priorità dei crediti privilegiati ecc.). Inoltre, effetti: l’accordo omologato dà esenzione da revocatoria e consente prededuzione nuovi finanziamenti , e sospende azioni esecutive durante l’iter, ma non prevede commissari; il concordato invece attiva una procedura complessa con eventuale moratoria sui privilegiati (fino 2 anni), possibilità di sciogliere contratti con autorizzazione, ecc., e prevede l’esdebitazione del debitore persona fisica a fine procedura (nel concordato, diversamente dall’accordo, l’imprenditore individuale può essere liberato dai debiti residui dopo l’adempimento).
D6: Che cos’è la transazione fiscale e contributiva e quando conviene utilizzarla?
R: La transazione fiscale e contributiva è lo strumento che permette di includere i debiti verso Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione e INPS/INAIL in un piano di ristrutturazione concordatario, proponendo di pagarli in parte e/o dilazionarli . Originariamente (con la vecchia legge fallimentare art. 182-ter) era facoltativa, ora nel CCII è integrata: l’art. 63 CCII per gli accordi ADR e l’art. 88 CCII per il concordato stabiliscono che il debitore può presentare una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, allegando un piano di pagamento parziale/dilazionato . L’ente ha 90 giorni per rispondere; se tace, vale dissenso (non c’è più il silenzio-assenso delle vecchie norme) . Conviene utilizzarla praticamente sempre quando il debito fiscale/previdenziale è significativo, perché:
- Permette di ottenere formalmente lo sconto su sanzioni e interessi (di solito nella proposta si paga almeno il capitale in una certa percentuale e si stralciano sanzioni).
- Dopo le riforme, è ammessa anche la falcidia dell’IVA e delle ritenute (un tempo vietata) , per cui si può proporre di pagare solo una quota dell’IVA dovuta, cosa che altrimenti fuori dalle procedure non è possibile (il Fisco fuori pretenderebbe sempre 100% dell’IVA).
- Se l’ente rifiuta senza motivo valido ma la proposta garantisce il massimo utile, il tribunale può cramdown: omologare lo stesso l’accordo/concordato, forzando il Fisco/INPS . Ad esempio, Cass. 27782/2024 ha chiarito che anche un voto negativo espresso dal Fisco può essere superato dal giudice . Quindi la transazione consente di aggirare un eventuale diniego irragionevole.
- Una volta omologata, la transazione sostituisce il debito originario: per dire, se dovevo €1.000.000 di tasse e con transazione omologata ne pago €400.000 in 5 anni, l’omologa cristallizza questo come nuovo debito fiscale. Se poi rispetto i pagamenti, l’Erario non potrà mai più pretendere l’eccedenza .
- Attenzione però: se dopo l’omologa non pago le rate della transazione, quel mancato pagamento costituisce titolo per la riscossione coattiva immediata del residuo e di solito comporta la risoluzione del concordato/accordo . Quindi va presa con impegno.
In pratica conviene inserirla quando i debiti verso Stato e previdenza sono tali che pagarli integralmente è impossibile e/o ingiusto rispetto agli altri creditori. Oggi è diventata prassi standard nei concordati e accordi: quasi tutti i piani la prevedono perché difficile avere aziende in crisi senza debiti fiscali. Le uniche cautele: se il debito Erario+INPS > 80% del totale, serve l’adesione perché la legge preclude cram-down in tal caso . Inoltre, prima di avviare la transazione, valutare se c’è in corso una rottamazione o definizione agevolata più conveniente: es. se il Governo ha aperto una finestra di rottamazione con stralcio sanzioni e interessi, a volte può convenire aderire a quella per abbattere il debito, anziché inserire la transazione nel concordato. Ma spesso i tempi della crisi non coincidono con quelli della “pace fiscale”, quindi la transazione è la via necessaria.
D7: Aprire una procedura (accordo o concordato) mi protegge subito dai creditori?
R: Sì, con alcune differenze tra strumenti:
- Accordo di ristrutturazione ADR: la protezione scatta da quando si pubblica il ricorso di omologa nel Registro delle Imprese. Da quel momento e fino all’omologazione, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari . Possono però, nel frattempo, maturare interessi su crediti (salvo patti contrari).
- Concordato preventivo: la protezione scatta già dal decreto di ammissione (o dalla pubblicazione della domanda “in bianco”). Vieta azioni esecutive e cautelari, e sospende i procedimenti in corso. Inoltre, nel concordato in continuità c’è il divieto di eseguire la risoluzione dei contratti di fornitori per causa di fallimento/insolvenza (famosa norma “anti-ipso facto”) .
- Composizione negoziata: non è automatica, bisogna chiedere al tribunale le misure protettive (art. 18 CCII). Una volta concesse (il decreto è pubblicato anch’esso al Registro Imprese), vietano temporaneamente ai creditori di iniziare o proseguire esecuzioni e anche di acquisire prelazioni (non possono ipotecare all’improvviso) . Queste durano al massimo 4 mesi (prorogabili).
- Piano attestato: qui non c’è automatismo legale. La protezione è solo “contrattuale”: se i creditori si impegnano a non agire mentre segui il piano, bene; ma la legge in sé non blocca chi resta fuori.
In generale, dunque, sì: accordo, concordato e CNC offrono uno stay sulle aggressioni dei creditori. Questo è uno dei motivi per cui conviene attivarli appena capisci che non riesci più a tenere a bada i creditori: ti consente di evitare che uno di loro ti porti via un macchinario cruciale o ti paralizzi il conto proprio mentre cerchi di risanare. La raccomandazione è: non aspettare l’ultimo minuto. Se i fornitori hanno già pignorato tutto il magazzino quando chiedi il concordato, magari è tardi perché ti manca l’operatività per portarlo avanti. Attiva la protezione quando hai ancora qualcosa da proteggere e un piano credibile.
D8: Cosa rischia personalmente l’imprenditore (amministratore o socio) se la società ha debiti?
R: Se la società è di capitali (S.r.l., S.p.A.), in linea di principio vige la responsabilità limitata: i debiti sociali si pagano col patrimonio sociale, e i soci non rispondono con i propri beni. L’amministratore risponde verso la società per mala gestione, ma non direttamente verso i creditori (se non in casi eccezionali, es. continuazione abusiva di attività ai sensi art. 2486 c.c.). Tuttavia, in pratica l’imprenditore può rischiare personalmente in diversi modi:
- Fideiussioni e garanzie personali: Molti soci/amministratori sottoscrivono garanzie personali a favore di banche o fornitori strategici. Tipico il socio che firma la fideiussione omnibus alla banca per lo scoperto di conto, o il contratto di leasing che include la fideiussione. Queste garanzie sono valide: il creditore può escuterle se la società non paga. Non vengono automaticamente cancellate da un accordo o concordato della società, salvo che il creditore stesso acconsenta liberando il fideiussore. Nota importante: il CCII ha introdotto all’art. 123, co.5, un meccanismo (ripreso dal 182 bis l.f.) per cui se il debitore principale (la società) raggiunge un accordo di ristrutturazione omologato, la remissione parziale del debito principale libera il fideiussore in corrispondenza . In pratica, se la banca aderisce a un accordo dove rinuncia al 30% del credito, non potrà poi pretendere quel 30% dal garante (Cass. SU 2010 n. 1521 lo aveva già affermato). Quindi l’imprenditore che abbia dato garanzia su un credito incluso nell’accordo, beneficerà della falcidia.
- Azioni di responsabilità per mala gestio: in caso di fallimento (liquidazione giudiziale), il curatore spesso promuove azioni contro gli amministratori per danni. Esempio: aver aggravato il dissesto, aver distratto beni, pagato preferenzialmente qualche creditore a scapito di altri (bancarotta preferenziale). Queste azioni, se provate, colpiscono il patrimonio personale dell’amministratore (non sono coperte da responsabilità limitata in quanto sono “colpa” personale). Anche in un concordato, i creditori o il commissario potrebbero promuovere (dopo omologa) azione di responsabilità se emergono condotte dannose pre-concordato. Però, se l’imprenditore segue la strada giusta e agisce in trasparenza, di solito tali azioni vengono meno (anche perché i creditori sono soddisfatti dal piano).
- Responsabilità tributaria e penale: come detto, l’amministratore rischia sul piano penale per alcuni debiti erariali (omesso versamento IVA, ritenute, contributi) e se condannato, la sanzione pecuniaria e la confisca possono intaccare i suoi beni. Inoltre, esistono casi di responsabilità solidale per tributi: ad esempio, se la società non versa ritenute previdenziali, pure il legale rappresentante è obbligato in solido (art. 29 D.Lgs. 276/03 per appalti in caso di inadempienze retributive e contributive), o in certi casi di gruppi societari il fisco può invocare l’amministratore di fatto.
- Revocatorie e atti in frode: se prima del fallimento l’imprenditore ha fatto movimenti per salvare il proprio patrimonio (es. ha venduto la villa alla moglie per 1 euro, o costituito un fondo patrimoniale per sottrarre la casa ai creditori), il curatore può agire in revocatoria o dichiarare inefficaci quegli atti, facendo rientrare i beni nel patrimonio aggredibile . Anche un trust o trasferimento a figlio può essere revocato se fatto “in frode ai creditori”. Quindi, giocare d’anticipo spostando i beni personali quando la situazione è già compromessa raramente funziona: rischi di perderli lo stesso e magari commettere reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (se la società poi fallisce).
- Sanzioni interdittive: il fallimento comportava l’inabilitazione all’esercizio d’impresa e la perdita dei diritti elettorali per qualche tempo. Col CCII, l’apertura della liquidazione giudiziale comporta la sospensione temporanea di alcune facoltà (es. non puoi essere amministratore di altre società durante la procedura se non autorizzato), ma soprattutto l’imprenditore individuale fallito deve aspettare l’esdebitazione per essere libero dai debiti residui. Chi chiude con un concordato, invece, mantiene la capacità di fare impresa (anzi, se è in continuità rimane in sella).
D9: Posso proteggere in qualche modo i miei beni personali dal rischio d’impresa?
R: La miglior protezione è a monte, separando nettamente il patrimonio personale da quello aziendale e non offrendo garanzie personali. Usare una società di capitali è già uno scudo (ma come visto non totale se poi firmi fideiussioni). Ci sono alcuni strumenti giuridici per blindare i beni personali:
- Fondo patrimoniale: destinare tramite atto notarile alcuni beni (es. casa di famiglia) a un fondo per bisogni della famiglia. I creditori per debiti estranei ai bisogni familiari non possono attaccare quei beni (art. 170 c.c.). Dunque, se il debito è dell’impresa, in teoria il fondo patrimoniale lo protegge. Tuttavia, la giurisprudenza interpreta in modo restrittivo: se l’obbligazione è connessa all’attività d’impresa del coniuge, spesso la considera riferibile ai bisogni familiari in senso lato, specie se da quell’impresa traeva reddito per la famiglia. Inoltre, se il fondo è costituito quando i debiti già c’erano o erano prevedibili, è suscettibile di revocatoria fallimentare (entro 2 anni dall’atto costitutivo, azione molto comune).
- Trust o vincoli di destinazione: simile al fondo, con un trust l’imprenditore trasferisce beni a un trustee per gestirli a beneficio di certi beneficiari, con scopo segregativo. Vale lo stesso discorso: ottimo se fatto in tempi non sospetti e per scopi meritevoli, ma se appare come fatto per sfuggire ai creditori, può essere dichiarato inefficace. Vi sono state sentenze (Cass. 2021 n.7877 ad es.) che condannano la creazione di trust “distrattivi” in prossimità dell’insolvenza.
- Assicurazioni vita o polizze: somme versate in polizze vita sono impignorabili (entro certi limiti) finché non riscattate. Però se versi ingenti somme poco prima del crack, possono configurare distrazione o essere revocate.
- Società holding o immobiliare separata: alcuni imprenditori costituiscono una s.r.l. a parte dove far confluire gli immobili e beni di valore, e poi la società operativa in crisi è giuridicamente separata. Questo può funzionare in parte, ma le banche spesso chiedono garanzie incrociate o consolidano il rischio (specialmente se la holding presta fideiussioni alla operativa). In aggiunta, se l’operazione è fatta ad hoc per isolare i beni quando la crisi già cova, può essere considerata lesiva dei creditori.
In concreto, un titolare che voglia proteggere la casa di famiglia dovrebbe idealmente non intestarsela proprio se fa un’attività rischiosa, o intestarla al coniuge non responsabile. Ma attenzione: se poi il coniuge la mette a disposizione del fallito con un fondo patrimoniale, si rischia revoca. Insomma, c’è un detto: “il modo migliore per proteggere il patrimonio dai creditori è non fare debiti”. Al secondo posto: struttura societaria e niente garanzie personali. Se le hai già date, valuta di rinegoziarle (es. quando rifinanzi un debito, chiedi di liberare la fideiussione in cambio di altre cose).
D10: Che succede se non riesco comunque a salvare l’azienda?
R: Se nonostante i tentativi la situazione precipita, l’ultima risorsa è gestire la liquidazione in modo ordinato per poi ottenere l’esdebitazione. Se l’impresa è fallibile, si va in liquidazione giudiziale: il curatore liquida i beni; alla fine della procedura, l’imprenditore individuale (o socio illimitatamente responsabile) può chiedere di essere esdebitato, cioè liberato dai debiti residui non soddisfatti . Il CCII prevede che l’esdebitazione sia quasi automatica se il fallito ha collaborato e non ci sono ragioni ostative (tipo condanne per bancarotta fraudolenta). Se l’impresa non è fallibile, c’è la liquidazione controllata (ex legge 3/2012) e ugualmente, a chiusura, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione dei debiti rimasti . Esiste anche l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente: un debitore persona fisica meritevole, che non abbia nessuna possibilità di pagare neppure parzialmente i creditori, può chiedere al tribunale di essere esdebitato integralmente subito, senza neanche aprire una procedura di liquidazione, purché nei 4 anni successivi se sopravvengono utili li devolva ai creditori (art. 283 CCII).
In sostanza, la legge cerca di dare sempre una via d’uscita all’imprenditore onesto ma sfortunato: fallire non è più una condanna a vita. Certo, l’ideale è risolvere prima e salvare anche l’impresa. Ma se ciò non è possibile, dopo la “punizione” della liquidazione c’è la possibilità di ripartire da zero senza zavorra di debiti passati.
Protezione del patrimonio personale dell’imprenditore
Dal punto di vista del debitore, uno degli aspetti più delicati è la tutela dei beni personali di chi sta dietro l’impresa (siano essi i soci o l’amministratore). Abbiamo toccato il tema nelle FAQ; qui lo approfondiamo in modo sistematico, con specifico riguardo al contesto italiano e agli aggiornamenti normativi.
Responsabilità patrimoniale nelle società di capitali (S.r.l. e S.p.A.)
Nelle società a responsabilità limitata e per azioni vige il principio cardine della separazione patrimoniale: la società risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni sociali, i soci rischiano solo il capitale investito (art. 2462 c.c. per S.r.l.; art. 2325 c.c. per S.p.A.). Dunque, in teoria, se Blocco Oleodinamico S.r.l. fallisce con milioni di debiti, i creditori non possono aggredire i beni personali dei soci (casa, auto, conti personali). Questa è una delle ragioni per cui è bene esercitare attività rischiose tramite società di capitali e non come ditta individuale.
Eccezioni alla limitazione di responsabilità:
Tuttavia, ci sono diverse situazioni in cui, anche in presenza di società di capitali, il patrimonio personale dell’imprenditore viene intaccato:
- Fideiussioni e avalli personali: come già evidenziato, gli istituti di credito chiedono spesso al socio di maggioranza o all’amministratore di firmare una fideiussione a garanzia dei debiti della società. Molti fornitori, in rapporti con S.r.l. piccole, pretendono il avallo cambiario o la firma di un socio su effetti o contratti. Queste sono obbligazioni personali del garante, del tutto valide ed esigibili se la società non paga. Non c’è scudo societario che tenga: una volta sottoscritta la garanzia, il patrimonio personale è “aggredibile”. L’unico limite – come visto – è che la liberazione del debitore principale attraverso un accordo omologato libera anche il garante per la parte rimessa , e che eventuali clausole anticoncorrenziali nelle fideiussioni bancarie (famoso schema ABI 2003) possano portare a nullità parziale della garanzia (questione di antitrust, in cui Banca d’Italia ritenne nulle tre clausole tipiche; la Cassazione a Sezioni Unite nel 2017 n.29810 ha confermato la nullità antitrust se la fideiussione ricalca quel modello standard). Quindi un socio potrebbe provare ad eccepire quella nullità per non pagare la banca, ma è un esito incerto e va valutato caso per caso.
- Reati tributari e previdenziali: se l’imprenditore viene condannato per omesso versamento di IVA o ritenute, oltre alle sanzioni penali c’è il obbligo di pagamento del debito tributario. In sede penale, a volte la confisca per equivalente può colpire i beni personali per l’importo evaso. Anche senza condanna penale, se trattasi di società di persone o ditte, l’amministratore risponde personalmente dei debiti tributari; per le società di capitali ciò di regola no, salvo alcuni casi (ad esempio, liquidazione IVA di gruppo con responsabilità solidale delle controllanti).
- Debiti erariali per cui la legge prevede responsabilità solidale del rappresentante legale: Esempio, l’art. 35 D.Lgs. 241/1997 prevede che il rappresentante di sostituto d’imposta che non versa le ritenute operate risponde in solido se il mancato pagamento è dovuto a sua colpa grave. Oppure, in materia di sanzioni tributarie amministrative, se la società non paga, l’amministratore potrebbe essere chiamato in solido in alcuni contesti (art. 11 D.Lgs. 472/1997 per sanzioni relative a violazioni tributarie dipendenti da dolo degli amministratori).
- Inesatto adempimento di obblighi legali: ad es., in SRL se i soci non ricapitalizzano a seguito perdite oltre soglia e continuano attività senza adeguarsi, possono incorrere in responsabilità per i nuovi debiti (teoria della perdita di capitale e postergazione). C’è l’art. 2486 c.c. che prevede che dal momento dello scioglimento di società (es. per perdite azzeranti il capitale) gli amministratori rispondono dei danni se proseguono l’attività provocando aggravamento del dissesto. Il danno calcolato in questo caso è differenziale (netto peggiorato) . Se il curatore fallimentare esercita questa azione con successo, il risarcimento entra nell’attivo fallimentare a beneficio creditori – ed esce dal patrimonio personale dell’amministratore.
- Soci che hanno percepito utili fittizi o restituzioni illegali di conferimenti: se negli anni precedenti i soci hanno preso dividendi non spettanti (perché bilancio falso) o rimborsi di finanziamenti soci preferenziali, il curatore può agire per far restituire quelle somme (azione ex art. 2467 c.c. per postergazione finanziamenti soci, se la società fallisce i soci devono restituire i rimborsi ricevuti negli ultimi 2 anni precedenti se la società era sottocapitalizzata). Anche i finanziamenti soci infatti vanno considerati capitale di rischio: l’art. 2467 c.c. dice che se fatti in situazioni di eccessivo squilibrio o crisi, sono postergati e se rimborsati prima del fallimento, il curatore può chiederne la restituzione. Quindi il patrimonio dei soci può dover ridare quei soldi per far pari tra i creditori.
- “Velo societario” sollevato: in casi estremi la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di ignorare la personalità giuridica quando usata in frode alla legge. Ad esempio, se Tizio usa la sua SRL come schermo per compiere atti fraudolenti ai danni dei creditori (patrimonio zero, indebita sottocapitalizzazione, confusione di patrimoni), può configurarsi un abuso di personalità giuridica con responsabilità diretta di Tizio. È concetto simile alla “teoria dell’etero-direzione” o socio tiranno: il socio unico di fatto che gestisce la società come alter ego e causa danno ai creditori potrebbe risponderne. Tuttavia, non c’è una normativa esplicita sul “velo societario” nel nostro diritto, è per lo più dottrina e qualche pronuncia isolata.
Strumenti leciti di tutela patrimoniale preventiva
Se l’imprenditore vuole tutelare la famiglia e il patrimonio personale, può porre in essere ex ante alcune strategie:
- Patto di famiglia: se si pensa al passaggio generazionale e si vuole segregare l’azienda da altri beni, c’è l’istituto del patto di famiglia (art. 768 bis c.c.) per trasferire l’azienda o partecipazioni ai figli, liquidando gli altri eredi. Questo riguarda successione, non proprio protezione dai creditori, ma evita liti future.
- Assicurazioni professionali: stipulare polizze ad hoc (es. D&O – Directors and Officers liability insurance) che coprano rischi di responsabilità degli amministratori. Non salvano il patrimonio se la società non paga i debiti, ma possono coprire eventuali azioni di terzi per danni da mala gestione.
- Accordi coniugali: regime di separazione dei beni può aiutare a tenere distinto ciò che è intestato al coniuge non debitore. Se la casa è intestata alla moglie in separazione beni e il marito ha debiti, i creditori del marito non possono aggredire i beni intestati esclusivamente alla moglie (salvo dimostrare che erano stati sottratti fraudolentemente). Anche qui: se fai il passaggio di intestazione quando i debiti sono già sorti, è potenzialmente revocabile entro 2 anni (se atto tra vivi a titolo gratuito).
- Strutture societarie di gruppo: come detto, tenere immobili e attività in società separate può compartimentare il rischio. Ad esempio, una holding immobiliare possiede il capannone e lo dà in locazione alla società operativa. Se quest’ultima fallisce, il capannone resta alla holding (che però sarà un creditore insinuato per canoni). Bisogna tuttavia prestare attenzione a garanzie intragruppo e a non configurare dominanza che faccia estendere il fallimento (l’azione di estensione fallimento ex art. 147 L.F. per società occulte o confuse).
Ruolo delle procedure concorsuali nella protezione del socio
Può sembrare paradossale, ma a volte aprire una procedura concorsuale per la società aiuta indirettamente il socio/garante: perché durante la procedura:
- Scatta la regola del freeze delle azioni: ad esempio, se la società entra in concordato, il creditore garantito dal socio non può escutere subito il socio: deve attendere l’esito e in caso di soddisfazione parziale in concordato, il garante risponde eventualmente del resto. Se il concordato va a buon fine e come visto prevede la liberazione parziale del debitore, il garante è libero per la parte remissata . (Nota: la Cassazione del 2021 a Sezioni Unite n. 41994 ha affermato che nel concordato preventivo il creditore può escutere la fideiussione anche durante il concordato, perché la sospensione delle azioni in procedura riguarda il debitore, non i garanti. Tuttavia, se poi il concordato viene omologato e prevede un certo pagamento, oltre tale importo il creditore non può arricchirsi: dovrà restituire al fideiussore l’eventuale incasso eccedentario. Dunque al fideiussore conviene attendere l’esito, potendo far valere la beneficium deductionis).
- Permette al socio di evitare di intervenire disordinatamente: se si vuole evitare che la banca attacchi la casa del socio, ad esempio, il socio potrebbe preferire mettere un po’ di soldi nel concordato societario per pagare la banca e liberare la fideiussione in quel contesto ordinato, piuttosto che farsi pignorare casa. Nel concordato, i piani possono prevedere espressamente la liberazione di garanzie reali e personali a fronte di un certo soddisfo: ad esempio, pagando il 70% al creditore ipotecario X, si considera liberato il pegno del socio Y.
Infine, ricordiamo l’esdebitazione: se il socio avesse prestato fideiussioni e viene escusso e poi pure lui va in insolvenza, potrà liberarsi dei debiti residui attraverso l’esdebitazione dopo un fallimento o liquidazione controllata . C’è anche l’esdebitazione “immediata” per il socio fideiussore che ha solo quella posizione e nulla più (debitore incapiente) – con impegno a pagare eventuali utili futuri (art. 283 CCII). Insomma, il sistema è calibrato per dare sempre un’opportunità di ripartenza all’individuo: la controparte è che richiede di passare attraverso la procedura concorsuale o comunque una valutazione giudiziale.
Conclusione su patrimonio personale: La miglior strategia è prevenire (non esporsi personalmente, tenere separate le sfere). Se però l’imprenditore ha già messo a rischio i propri beni (garanzie, confusione patrimoni), in caso di crisi conviene agire legalmente in modo da limitare i danni: ad esempio, ristrutturare anche quei debiti garantiti, inserendoli nel piano, oppure se la situazione è irreversibile, considerare un accordo personale con i creditori (magari extraconcordatario per il garante: capita che il socio garante negozi a parte con la banca per un saldo e stralcio della sua fideiussione, parallelamente al concordato della società).
Va sottolineato che la maggior parte delle norme di tutela (fondo patrimoniale, trust) offrono protezioni relativamente deboli di fronte a debiti d’impresa contratti in epoca successiva. Le sentenze più aggiornate mostrano che i giudici sono attenti a evitare abusi: se percepiscono che il debitore ha creato schermi per sottrarre garanzie ai creditori, trovano modi per farli cadere . Per contro, se uno ha sempre operato correttamente e la crisi deriva da cause esterne, c’è un certo favore nel concedergli l’esdebitazione e non punirlo oltre misura.
Come abbiamo visto, gestire un’azienda di blocchi idraulici oleodinamici con debiti richiede un approccio multidisciplinare: tecnico-giuridico (conoscere strumenti e leggi), finanziario (predisporre piani realistici) e umano (negoziare con le persone, siano creditori, lavoratori, soci). L’ordinamento italiano, aggiornato al 2025 con il Codice della Crisi e le relative riforme, fornisce un arsenale di strumenti efficaci per chi, in buona fede, vuole tentare il risanamento o almeno evitare una fine disordinata dell’impresa. Dal canto suo, l’imprenditore deve attivarsi per tempo e farsi assistere da professionisti esperti (avvocati d’impresa, commercialisti) per scegliere la strategia migliore e attuarla correttamente.
Nel peggiore dei casi, se il salvataggio non è possibile, è comunque preferibile percorrere la via di una procedura concorsuale minore (concordato semplificato o liquidazione controllata) piuttosto che subire passivamente pignoramenti a tappeto e un fallimento giudiziale. Così facendo, si può ottenere la responsabile chiusura della vicenda debitoria, preservando quel che resta del valore aziendale e liberando l’imprenditore dal peso dei debiti passati, pronto – perché no – a ricominciare con un nuovo progetto, facendo tesoro delle esperienze maturate.
Fonti normative e giurisprudenziali (agg. 2025)
Normativa di riferimento:
- Codice Civile: artt. 2086 c.c. (assetti organizzativi adeguati e dovere di attivazione in caso di crisi introdotto dall’art. 375 D.Lgs. 14/2019) ; artt. 2446-2447 c.c. (riduzione del capitale per perdite); artt. 2484-2487 c.c. (scioglimento e liquidazione volontaria); art. 2477 c.c. (sindaco o revisore nelle S.r.l., soglie ridotte dal CCII); art. 2476 e 2486 c.c. (responsabilità degli amministratori verso società e creditori); art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti soci); art. 1239 c.c. (remissione del debito principale libera il fideiussore, rilevante negli accordi) ; art. 2560 c.c. (debiti dell’azienda ceduta, per citare casi di cessione in continuità).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022 , come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (Secondo Correttivo) e D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (Terzo Correttivo) . Principali articoli citati:
- Allerta e composizione assistita: artt. 12-15 CCII (indicatori di crisi), art. 18 CCII (Composizione negoziata e misure protettive) , art. 23 CCII (misure premiali in composizione negoziata), art. 25-sexies CCII (Concordato semplificato) .
- Strumenti di regolazione stragiudiziale: art. 56 CCII (Piano attestato di risanamento) , art. 57-64 CCII (Accordi di ristrutturazione dei debiti – incl. art. 60 accordi agevolati , art. 61 accordi ad efficacia estesa), art. 63 CCII (transazione su crediti tributari e contributivi negli ADR) .
- Concordato preventivo: artt. 84-120 CCII (disciplina generale; art. 84 tipologie e requisiti, art. 85 classi, art. 86 moratoria pagamenti privilegiati in continuità; art. 94-95 effetti sui contratti pendenti – divieto di esecuzione clausole insolvency ; art. 88 CCII trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato, consente falcidia IVA ; art. 112 giudizio di omologa e cram-down di classi e Fisco ; art. 114 CCII tutela interesse dei creditori/lavoratori in sede di reclamo ).
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento): artt. 121 CCII (presupposti di liquidazione, soglie d’impresa minore) , art. 2 lett. d CCII (definizione di impresa minore, soglie €300k/200k/500k) , art. 49 CCII (ulteriori limiti dimensionali valutati in istruttoria) , art. 282-283 CCII (esdebitazione del sovraindebitato e debitore incapiente).
- Procedure da sovraindebitamento: artt. 65-73 CCII (piano di ristrutturazione del consumatore), artt. 74-83 CCII (concordato minore per imprenditori sotto soglia), artt. 268-277 CCII (liquidazione controllata).
- Leggi speciali: D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (norme emergenziali recepite nel CCII: composizione negoziata e concordato semplificato) ; D.Lgs. 270/1999 (Amministrazione Straordinaria grandi imprese insolventi – non trattata qui perché settore specifico); L. 3/2012 (vecchia legge sovraindebitamento, abrogata dal CCII ma utile per principi).
- Normativa fiscale collegata alla crisi: art. 88, comma 4-ter TUIR (DPR 917/86) – sopravvenienze attive da riduzione debiti in concordato o ADR non imponibili ; art. 14, comma 3, DL 91/2014 conv. in L. 116/2014 – sopravvenienze attive da esdebitazione non tassabili ; art. 26 DPR 633/72 (IVA) – modificato dal DL 119/2018: consente l’emissione di note di credito per recuperare l’IVA su crediti non riscossi a causa di procedure concorsuali (importante per fornitori post-concordato); art. 3 D.L. 125/2020 conv. L. 159/2020 – ha introdotto il cram-down fiscale anticipatamente nella legge fallimentare, recepito poi nel CCII.
- Norme Riscossione ed esecuzioni: DPR 602/1973 art. 19 (rateazione cartelle); art. 77 DPR 602/73 (ipoteca esattoriale, soglia €20.000) ; art. 86 DPR 602/73 (fermo amministrativo, soglia €1.000 per preavviso) ; Codice Proc. Civile art. 168 (effetti domanda concordato: sospensione esecuzioni); RD 267/42 (vecchia legge fallimentare) per riferimenti storici giurisprudenziali.
- Altro: D.Lgs. 74/2000 art. 10-bis e 10-ter (reati omesso versamento tributi) e L. 638/1983 art. 2 (omesso versamento contributi > €10k); Legge 898/86 (Amministrazione straordinaria grandi imprese, per completezza, casi Parmalat ecc.); Norme su privilegi: artt. 2751-bis, 2777 c.c. (privilegi lavoratori, erario, ecc., rilevano nel concordato per trattamento classi).
Giurisprudenza rilevante (massime e sentenze recenti):
- Cass., Sez. Unite, 25 marzo 2021, n. 8504 – Principio sul cram-down fiscale ante CCII: ha stabilito che il tribunale fallimentare può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche senza adesione del Fisco (introdotto dal DL 125/2020 conv. L.159/2020) e che le controversie sul diniego del Fisco spettano al giudice civile ordinario, non a quello tributario . Questa pronuncia storica, antecedente al CCII, è stata recepita espressamente nelle norme del Codice (art. 48 c.5 e art. 63 CCII).
- Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 – Concordato preventivo e voto negativo del Fisco: ha confermato che nel concordato la “mancata adesione” del Fisco che legittima il cram-down include anche il voto negativo espresso (non solo il silenzio o l’astensione) . Ciò in linea col Terzo Correttivo 2024 che ha chiarito la definizione di mancata adesione. Questa sentenza segna una svolta perché mette fine ai dubbi: il tribunale può imporre il concordato al Fisco anche se ha votato no, se il piano è migliorativo rispetto alla liquidazione.
- Cass., Sez. Unite, 26 maggio 2020, n. 7877 – Nozione di crisi e responsabilità per tardiva richiesta di procedura: ha sancito che la crisi va affrontata secondo l’art. 2086 c.c. (adeguati assetti) e l’inerzia degli amministratori nel proporre tempestivamente un concordato può costituire inadempimento degli obblighi verso la società e i creditori . Ha inoltre delineato il concetto di “crisi” distinto dall’insolvenza e richiamato il dovere di iniziativa. È importante perché fornisce base giuridica alle azioni di responsabilità per aggravamento del dissesto, quantificando il danno come differenza di patrimonio netto .
- Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, decreto 14 ottobre 2022 – Primo caso di applicazione del DLgs 83/2022 (Secondo Correttivo) in tema di classi obbligatorie e relative priority rule: ha ammesso un concordato preventivo con classi di creditori obbligatorie e applicato per la prima volta in Italia la relative priority rule fra classi in sede di cram-down. Il caso riguardava un concordato in continuità in cui una classe di chirografari dissenzienti è stata soddisfatta con il criterio della priorità relativa (ogni classe superiore prende di più, ma non necessariamente il 100% prima che quella inferiore prenda qualcosa). Questo apre la strada ai concordati “cross-class cram down” in linea con la direttiva europea.
- Tribunale di Roma, decreto 4 aprile 2023 – Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa ex art. 61 CCII: ha omologato un accordo di ristrutturazione che prevedeva l’estensione degli effetti ai creditori finanziari non aderenti (banche dissenzienti) avendo raggiunto la soglia del 75% e verificato le condizioni di legge (buona fede nelle trattative, trattamento non deteriore dei dissenzienti) . È una delle prime applicazioni pratiche della nuova norma, confermando che se la maggior parte delle banche concorda, l’accordo può vincolare anche le restanti.
- Corte d’Appello di Bologna, decreto 18 luglio 2023 – Concordato preventivo e reclamo su omologa: tutela dell’interesse generale dei creditori: ha confermato la decisione di primo grado che omologava un concordato nonostante il reclamo di un singolo creditore dissenziente, richiamando l’art. 112 CCII e sottolineando la prevalenza dell’interesse della massa dei creditori e dei lavoratori alla prosecuzione del piano rispetto alla volontà del singolo . Questo ribadisce come l’orientamento del CCII sia favorire soluzioni concordate se nel complesso migliori, anche a scapito dell’opposizione individuale (salvaguardia dell’utilità per la collettività dei creditori).
- Cass., Sez. Unite, 15 novembre 2016, n. 23218 – Fattibilità del concordato preventivo: ha distinto tra fattibilità giuridica (rispetto norme inderogabili, da valutarsi dal giudice) e fattibilità economica (aspetto riservato al giudizio dei creditori, sindacabile dal giudice solo se manifesta irrealizzabilità). Principio ancora oggi valido nel CCII: il tribunale non deve spingersi in valutazioni economiche di merito se non per evidenti deficit di realizzabilità .
- Cass., Sez. I, 7 settembre 2017, n. 20793 – Contratti pendenti e clausole risolutive per insolvenza: ha affermato che nel concordato con continuità, il divieto di risoluzione dei contratti per il solo fatto dell’insolvenza opera ex lege anche senza una specifica clausola contrattuale contraria . Questo è il precursore dell’art. 95 CCII che generalizza il divieto di esecuzione di clausole ipso facto (clausole che prevedono risoluzione in caso di procedura concorsuale).
- Cass., Sez. V, 17 dicembre 2020, n. 28895 – Transazione fiscale e falcidia IVA: ha ritenuto ammissibile la falcidia dell’IVA nei concordati, argomentando che non vi era un espresso divieto comunitario, anticipando così la riforma legislativa che lo ha permesso . Sentenza ormai superata dalla norma (che dal 2022 consente falcidia IVA in transazione), ma storicamente importante perché segna un cambio di orientamento della Suprema Corte in senso più pragmatico.
- Cass., Sez. Unite, 8 marzo 2019, n. 7166 – Abuso del concordato preventivo: ha stabilito che proporre un concordato preventivo liquidatorio con pagamento irrisorio ai chirografari e senza apporti esterni adeguati può costituire abuso dello strumento e essere dichiarato inammissibile. In particolare ha escluso la proponibilità di concordati liquidatori che non assicurino almeno il 20% ai chirografari (salva diversa giustificazione). Questo principio è stato normativizzato nel CCII con la regola dell’apporto minimo 10% (o 20% se niente continuità) come requisito di ammissibilità .
- Cass., Sez. I, 27 maggio 2021, n. 14714 – Azione di responsabilità verso amministratori per tardiva dichiarazione di fallimento: ha sancito che il danno da ritardata iniziativa concorsuale (azione ex art. 2486) va quantificato nella differenza tra il patrimonio netto (o attivo realizzabile) al momento in cui si sarebbe dovuto aprire la procedura e quello alla data effettiva di apertura . È importante perché fornisce una metodologia chiara per le azioni risarcitorie contro amministratori per aggravamento del dissesto, dando sostanza all’obbligo di tempestività.
La tua azienda che produce o commercializza blocchi idraulici, distributori oleodinamici, valvole integrate, collettori, piastre, manifold, componenti in pressione e parti per impianti idraulici industriali sta affrontando una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce o commercializza blocchi idraulici, distributori oleodinamici, valvole integrate, collettori, piastre, manifold, componenti in pressione e parti per impianti idraulici industriali sta affrontando una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore dei blocchi idraulici è particolarmente esigente: richiede acciai speciali, lavorazioni CNC ad alta precisione, trattamenti, test in pressione, componentistica tecnica e approvvigionamenti costanti.
Un rallentamento dei pagamenti dei clienti può provocare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, difesa e rimessa in equilibrio, se intervieni con una strategia efficace e tempestiva.
Perché un’Azienda di Blocchi Idraulici Finisce in Debito
Spesso i debiti derivano da:
• aumento dei costi di acciai legati, valvole, cartucce, raccordi, tappi e componenti
• lavorazioni esterne costose: forature profonde, fresatura, trattamenti termici, collaudi
• ritardi nei pagamenti da parte dei clienti industriali e OEM
• magazzino bloccato tra blocchi finiti, semilavorati e materiali grezzi
• investimenti obbligati in macchinari, utensili e attrezzature tecniche
• aumenti di costi energetici e spese di produzione
• linee di credito bancarie ridotte o revocate
• cicli produttivi lunghi, con incassi ritardati e margini compressi
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per una Azienda Oleodinamica con Debiti
Se non intervieni subito rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti bancari
• interruzione delle forniture di componenti fondamentali
• decreti ingiuntivi, precetti e azioni esecutive
• sequestro di magazzino, blocchi, materiali e utensili
• fermo delle lavorazioni CNC e stop della produzione
• ritardi nella consegna e perdita di clienti chiave
• possibile fermo totale dell’attività
Quando il debito non viene gestito, l’attività può bloccarsi nel giro di pochi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
- Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato può sospendere pignoramenti, sbloccare conti correnti, fermare richieste aggressive delle banche e gestire fornitori pressanti. Prima si mette in sicurezza l’azienda, poi si lavora sul riequilibrio. - Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso emergono interessi illegittimi, somme duplicate, errori della Riscossione, debiti prescritti, sanzioni gonfiate, costi bancari irregolari. Una parte importante del debito può essere ridotta o completamente eliminata. - Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni possibili: rateizzazioni fiscali fino a 120 rate, accordi di pagamento con fornitori strategici, rinegoziazione dei fidi bancari, sospensioni temporanee dei pagamenti, accesso alle definizioni agevolate quando disponibili. L’obiettivo è recuperare liquidità per non fermare la produzione. - Utilizzare strumenti legali che proteggono l’azienda
Per situazioni più gravi esistono strumenti potentissimi come PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti, accordi di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata (solo come ultima scelta). Queste procedure bloccano tutti i creditori, sospendono pignoramenti e permettono di pagare solo una parte dei debiti garantendo continuità produttiva. - Proteggere produzione, magazzino e forniture
In un’azienda di blocchi idraulici è fondamentale tutelare semilavorati, blocchi lavorati, valvole, cartucce, guarnizioni, prevenire sequestri che bloccherebbero i CNC, mantenere attivi i fornitori di materiali e trattamenti, proteggere macchinari e strumenti di misura, garantire consegne ai clienti industriali.
La produzione deve continuare: senza produzione il debito cresce, con la produzione attiva l’azienda può riprendersi.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco completo dei debiti
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo
• Bilanci e documenti fiscali
• Elenco fornitori strategici e insoluti
• Inventario di magazzino (blocchi, valvole, semilavorati, materiali)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini in corso e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare in 24–72 ore
• Blocco dei creditori in 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione in 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria in 3–12 mesi
Le protezioni legali possono attivarsi già dai primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione reale e consistente dei debiti
• Protezione del magazzino, delle lavorazioni e dei macchinari
• Trattative efficaci con banche e fornitori
• Continuità produttiva garantita
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti o atti giudiziari
• Accendere nuovi debiti per coprire debiti vecchi
• Pagare un solo fornitore lasciandone indietro altri
• Lasciare avanzare pignoramenti e precetti
• Affidarsi a società “miracolose” senza vera competenza
Ogni errore rende la crisi più grave e difficile da risolvere.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi tecnica della situazione debitoria
• Blocco immediato delle azioni dei creditori
• Piani di ristrutturazione personalizzati
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
• Massima tutela per azienda e imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di blocchi idraulici oleodinamici non significa essere destinati alla chiusura. Con la strategia giusta puoi:
• fermare subito i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• salvare produzione e magazzino
• mantenere la continuità aziendale
• difendere il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata: la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.