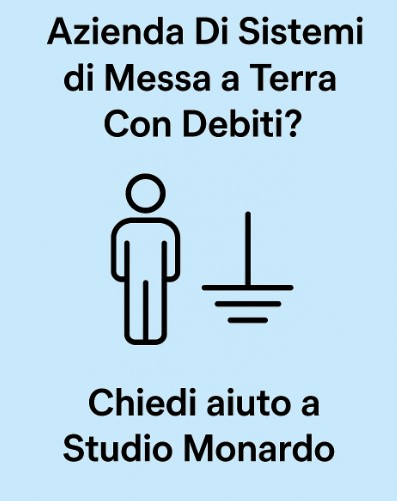Se gestisci un’azienda che produce, installa o distribuisce sistemi di messa a terra, dispersori, picchetti, cordini, conduttori in rame, barre equipotenziali, morsetti, accessori di sicurezza elettrica e soluzioni per impianti industriali, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione è seria ma assolutamente recuperabile.
Il settore della messa a terra è delicato e normato: affidabilità, continuità delle forniture e tempi rapidi di intervento sono essenziali.
Per questo un blocco causato dai debiti può interrompere commesse, fermare cantieri e danneggiare la reputazione con impiantisti, industrie e appaltatori.
La buona notizia è che con una strategia corretta puoi bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua azienda.
Perché le aziende di messa a terra accumulano debiti
Le cause più ricorrenti includono:
- costi elevati del rame, acciaio zincato e materiali di protezione
- magazzini complessi con molti codici tecnici
- pagamenti lenti da parte di impiantisti, enti e industrie
- aumento dei costi logistici e di approvvigionamento
- ritardi nei versamenti IVA, imposte e contributi INPS
- difficoltà nell’ottenere credito bancario adeguato
- investimenti richiesti per certificazioni e normative di sicurezza
- fornitori strategici che richiedono pagamenti rapidi
Questi elementi possono portare rapidamente a una crisi di liquidità e aumento dei debiti.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
Agire subito è essenziale per evitare blocchi e pignoramenti. Ecco cosa fare immediatamente:
- far analizzare la situazione debitoria da un avvocato esperto in crisi aziendali
- verificare quali debiti sono corretti, irregolari, prescritti o contestabili
- non firmare accordi affrettati o piani di rientro non sostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali procedure esecutive
- attivare rateizzazioni sostenibili con Agenzia delle Entrate e INPS
- proteggere fornitori critici e materiali indispensabili
- prevenire blocchi del conto corrente o riduzioni dei fidi bancari
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o eliminare parte dei debiti
Una diagnosi professionale permette di capire quali debiti ridurre, congelare o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Ignorare la crisi può portare a conseguenze molto gravi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di mezzi o attrezzature
- blocco delle forniture di rame, picchetti e materiali di messa a terra
- impossibilità di completare cantieri e installazioni
- perdita di clienti industriali e impiantisti
- danni alla reputazione e perdita di appalti
- crisi di liquidità e mancato pagamento di personale e fornitori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Nel tuo settore, anche un breve fermo può interrompere lavori già avviati e creare penali contrattuali.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato specializzato in debiti aziendali può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative e strumenti legali
- ottenere rateizzazioni sostenibili
- annullare debiti irregolari, prescritti o mal notificati
- mediare con fornitori e banche per evitare blocchi delle consegne
- proteggere magazzino, attrezzature e continuità produttiva
- stabilizzare la situazione finanziaria dell’azienda
- evitare che la crisi sfoci in insolvenza o chiusura
Con la giusta strategia puoi fermare l’emergenza e riprendere il controllo dell’azienda.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere l’azienda operativa è fondamentale:
- intervenire subito senza attendere ulteriori solleciti
- non negoziare con creditori senza una strategia definita
- proteggere fornitori strategici e materiali critici
- ristrutturare i debiti prima dell’avvio di pignoramenti
- individuare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare la liquidità per continuare lavorazioni e consegne
Così puoi evitare fermi, ritardi e rescissioni contrattuali.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo se:
- hai ricevuto solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
- non riesci più a sostenere i debiti con AE Riscossione, INPS o fornitori
- temi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità sta scendendo rapidamente
- hai difficoltà a rispettare scadenze e impegni contrattuali
- vuoi impedire che la crisi sfoci in chiusura
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
Attenzione: molte aziende non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi. Con una strategia mirata puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare davvero la tua impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali, riscossione e difesa di imprese industriali – ti aiuta a proteggere la tua azienda di sistemi di messa a terra.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare immediatamente le procedure, ridurre i debiti e mettere in sicurezza l’attività.
Introduzione
Un’azienda operante nel settore dei sistemi di messa a terra (ad esempio una S.r.l. o S.p.A. che fornisce impianti e servizi elettrici industriali) può trovarsi in grave difficoltà finanziaria a causa di debiti accumulati verso diversi creditori. I debiti possono riguardare il Fisco (imposte non versate), gli enti previdenziali (contributi INPS e INAIL arretrati), i fornitori (fatture insolute per materiali e servizi), le banche (mutui o fidi non rimborsati) e altre passività. In tale scenario, l’imprenditore e gli amministratori devono agire con urgenza per difendere l’azienda dalle azioni esecutive dei creditori e trovare soluzioni di risanamento, il tutto nel rispetto della normativa italiana vigente (aggiornata a ottobre 2025). Questa guida – scritta in un linguaggio giuridico ma accessibile – offre un quadro avanzato e aggiornato degli strumenti di difesa e ristrutturazione del debito aziendale, corredata da fonti normative, sentenze recenti e casi pratici. L’attenzione è posta sul punto di vista del debitore, ossia dell’azienda indebitata e dei suoi amministratori, illustrando come tutelarsi dalle iniziative dei creditori e come sfruttare le procedure previste per superare la crisi.
Struttura della Guida: Dopo aver classificato i tipi di debiti aziendali e le relative conseguenze legali, esamineremo le azioni esecutive tipiche dei creditori (ad es. pignoramenti, decreti ingiuntivi, ipoteche) e i rimedi a disposizione del debitore per contrastarle. Successivamente illustreremo i principali strumenti di gestione e ristrutturazione del debito previsti dall’ordinamento italiano – dai piani di risanamento “attestati” alle procedure concorsuali come l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo – evidenziandone requisiti, benefici e limiti. Un focus specifico sarà dedicato alla responsabilità degli amministratori e degli organi sociali in caso di mala gestio o gestione tardiva della crisi, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Saranno inoltre proposti consigli pratici e misure preventive (come la predisposizione di assetti adeguati e l’utilizzo tempestivo della composizione negoziata della crisi) per evitare il degenerare dell’insolvenza. Infine, la guida include una sezione di Domande e Risposte che affronta i dubbi più comuni (FAQ) dal punto di vista del debitore, nonché tabelle riepilogative che sintetizzano le informazioni chiave sulle procedure di risanamento e sulle possibili difese contro le azioni esecutive.
N.B.: Tutti i riferimenti normativi sono aggiornati al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dai più recenti interventi (D.Lgs. 83/2022 di attuazione della direttiva UE 2019/1023, e il “correttivo-ter” D.Lgs. 136/2024) . Le sentenze citate includono le ultime pronunce di merito e di legittimità sino al 2025, tratte da fonti istituzionali autorevoli (Corte di Cassazione, tribunali specializzati, ecc.). Le fonti complete (normative e giurisprudenziali) sono elencate in fondo alla guida, per permettere ai professionisti (avvocati, consulenti) e agli imprenditori interessati di approfondire ulteriormente. Ora entriamo nel vivo della materia, partendo dall’analisi dei debiti che più frequentemente gravano su un’azienda in crisi e delle loro possibili conseguenze.
Tipologie di Debiti Aziendali e Loro Conseguenze
La prima mossa per difendere efficacemente un’azienda indebitata è mappare i debiti esistenti e comprendere le conseguenze legali di ciascuna categoria. Non tutti i debiti, infatti, sono uguali: alcuni creditori godono di privilegi o poteri particolari (si pensi al Fisco o all’INPS), altri sono creditori chirografari ordinari (fornitori, banche senza garanzie, ecc.). Di seguito esaminiamo le principali tipologie di debiti aziendali rilevanti in Italia e cosa accade in caso di mancato pagamento.
Debiti Fiscali (Erario)
I debiti verso il Fisco includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP), ritenute fiscali non pagate, accertamenti tributari definitivi, ecc. Questi debiti sono particolarmente insidiosi perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) dispone di poteri esecutivi speciali. In caso di mancato pagamento entro le scadenze: – L’Erario iscrive a ruolo gli importi dovuti e notifica una cartella di pagamento tramite AER. La cartella esattoriale intimata deve essere saldata entro 60 giorni, salvo che il contribuente presenti una contestazione o richiesta di rateizzazione. – Se la cartella non viene pagata né impugnata nei termini, AER può procedere con atti di esecuzione forzata. In particolare, può emettere un avviso di intimazione e successivamente attivare misure cautelari come il fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. automezzi aziendali) e l’ipoteca legale su beni immobili dell’azienda per garantire il credito. – Trascorsi i termini di legge (ridotti dalle recenti riforme), l’Agenzia Entrate-Riscossione può avviare il pignoramento dei beni aziendali. Ad esempio, può effettuare un pignoramento presso terzi bloccando i conti correnti aziendali o aggredendo crediti verso clienti, oppure un pignoramento mobiliare di macchinari e attrezzature presenti in magazzino, o ancora un pignoramento immobiliare su immobili di proprietà della società.
Le conseguenze per l’azienda sono serie: conti bancari bloccati e beni pignorati possono paralizzare l’attività. Inoltre, il Fisco ha il privilegio di iscrivere ipoteca sugli immobili dell’azienda anche per debiti relativamente modesti (la soglia attuale è di 20.000 € di debito iscritto a ruolo per ipoteche, e 5.000 € per fermi amministrativi). Bisogna anche tener presente che l’inadempimento fiscale prolungato può portare l’Agenzia a valutare l’insolvenza dell’impresa e, in casi estremi, a presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se ricorrono i presupposti di legge.
Difese e strumenti di gestione: Davanti a debiti fiscali l’azienda può adottare diverse strategie di difesa: – Rateizzazione: La legge consente di chiedere ad AER la dilazione del pagamento. Dal 2025 sono state introdotte condizioni più favorevoli: per importi fino a 120.000 €, si possono ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate nel 2025-2026 (soglia elevata rispetto alle 72 rate precedenti) . In caso di debiti maggiori, dimostrando una temporanea situazione di difficoltà, la dilazione può arrivare fino a 120 rate (10 anni) . La rateazione, se concessa, sospende le azioni esecutive già iniziate dall’AER purché il debitore rispetti i pagamenti concordati. Attenzione: la rateizzazione non cancella sanzioni o interessi, ma evita l’aggravarsi immediato della posizione debitoria e consente di guadagnare tempo. – Definizioni agevolate (rottamazione): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto procedure temporanee di condono parziale (es. “rottamazione delle cartelle”). Ad ottobre 2025, ad esempio, è in corso la “Rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022, che permette di estinguere i debiti fiscali iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2022 pagando il solo capitale e una quota ridotta di interessi. Queste opportunità, se disponibili, vanno colte per ridurre il carico fiscale pregresso. Occorre però verificare i bandi di volta in volta (la Rottamazione Quinquies per il 2023-2024 è in fase di studio ). – Opposizione e contenzioso tributario: Se l’azienda contesta il merito del debito fiscale (ad esempio perché l’accertamento è errato o il tributo non dovuto), può presentare ricorso alla giustizia tributaria (oggi dinanzi alle nuove Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado). Il ricorso sospende l’obbligo di pagamento solo se si ottiene una sospensiva dal giudice tributario; altrimenti, il debito rimane esigibile. In ogni caso, un contenzioso aperto (se fondato) può essere utilizzato come leva nelle trattative con il Fisco, o per guadagnare tempo in attesa di una definizione. – Transazione fiscale nelle procedure concorsuali: Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato (di cui diremo oltre), l’azienda può proporre al Fisco una transazione fiscale ex art. 63 Cod. Crisi. Significa offrire il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari privilegiati (IVA, ritenute, ecc.), dietro approvazione dell’Agenzia Entrate. Novità importante: dal 2023 la legge consente al tribunale di omologare forzosamente la transazione fiscale anche senza il voto favorevole dell’Erario, a condizione che la proposta garantisca al Fisco una soddisfazione minima (almeno il 30% del credito complessivo se i crediti fiscali/previdenziali sono prevalenti, elevato ad 40% se il Fisco è minoritario, con dilazione massima di 10 anni) e che la soluzione proposta sia più vantaggiosa per l’Erario rispetto alla liquidazione . Questa possibilità di cram-down fiscale (introdotta in via sperimentale dal DL 69/2023, conv. L. 103/2023, e resa permanente dal D.Lgs. 136/2024) consente oggi di ridurre legalmente i debiti tributari in sede di ristrutturazione, superando l’ostruzionismo del creditore pubblico, purché si rispettino le soglie di soddisfacimento richieste. Ad esempio, se un’azienda in concordato in continuità propone di pagare il 40% dell’IVA dovuta, il tribunale può imporre tale accordo al Fisco anche in caso di silenzio o rifiuto, a patto che quel 40% superi la soglia minima di legge e sia almeno pari a quanto il Fisco otterrebbe in caso di fallimento . – Sospensione delle esecuzioni – misure protettive: Qualora l’azienda abbia già avviato una procedura di composizione della crisi (si pensi al deposito di un’istanza di concordato preventivo “in bianco” o all’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive), può ottenere dal tribunale un decreto di sospensione delle azioni esecutive, che impedisce temporaneamente ad Agenzia Entrate-Riscossione di proseguire con pignoramenti, fermi o ipoteche. Tali “scudi” però richiedono che sia in corso una trattativa o procedura formale per il risanamento. Nel frattempo, l’azienda può anche valutare di pagare parzialmente il Fisco per rientrare sotto soglie critiche (ad esempio sotto 5.000 € per evitare fermi amministrativi, o sotto 120.000 € per accedere a rateazioni semplificate).
Responsabilità degli amministratori per debiti fiscali: Un importante chiarimento giurisprudenziale va segnalato a tutela degli amministratori: la Corte di Cassazione ha ribadito che, salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, gli amministratori non rispondono in proprio dei debiti tributari della società . In particolare, la recente Cass. 8696/2025 ha escluso ogni “coobbligazione” automatica a carico dell’ex amministratore per l’IVA non versata dalla società, affermando che il principio di autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali vale anche per le obbligazioni tributarie . Fanno eccezione solo le ipotesi previste dall’art. 36 D.P.R. 602/1973, ad esempio nel caso di società in liquidazione in cui l’amministratore/liquidatore abbia distribuito attivi ai soci senza pagare le imposte dovute: in tal caso egli può essere chiamato a risponderne civilmente, per violazione dei doveri di diligenza (artt. 1176, 1218 c.c.) . Al di fuori di queste fattispecie, però, il Fisco non può escutere il patrimonio personale dell’amministratore per soddisfare i crediti tributari della società. Questa è una garanzia importante, purché l’operato dell’amministratore sia lecito: se invece emergono condotte distrattive o irregolari (es. non versare l’IVA incassata per finanziare spese personali), potranno eventualmente configurarsi altri tipi di responsabilità (civile verso la società/creditori o addirittura penale, come si vedrà più avanti).
Debiti Contributivi (INPS, INAIL)
Simili ai debiti fiscali, i debiti verso gli enti previdenziali – principalmente INPS per i contributi obbligatori dei dipendenti e gestione separata, e INAIL per i premi assicurativi – godono di un regime di riscossione analogo. L’INPS, una volta accertato l’omesso versamento di contributi (ad esempio tramite avvisi di addebito), ne affida la riscossione all’Agente (Agenzia Entrate-Riscossione) che procede con cartelle, fermi e pignoramenti come visto sopra. Anche qui, i contributi previdenziali sono crediti privilegiati e l’ente può: – Iscrivere ipoteca sugli immobili dell’azienda per contributi non pagati oltre certe soglie. – Agire in via esecutiva rapida: ad esempio un’ingiunzione INPS (titolo esecutivo immediato) che, se non opposta, porta al pignoramento di beni o conti. – In caso di crisi grave, intervenire in una procedura concorsuale o chiedere il fallimento (l’INPS può presentare istanza di liquidazione giudiziale come creditore se il debito supera le soglie di fallibilità e vi è insolvenza conclamata).
Difese e soluzioni: Per i debiti contributivi l’azienda può: – Rateizzare i contributi dovuti: L’INPS consente piani di dilazione simili a quelli fiscali (fino a 24 mesi o più in casi eccezionali), che vanno richiesti tramite domanda motivata prima che la posizione venga iscritta a ruolo. Se la cartella contributiva è già in mano ad AER, si applicano le stesse regole di rateazione viste per i debiti fiscali . – Opporsi ad addebiti non dovuti: se l’azienda contesta l’avviso di addebito INPS, può fare ricorso al Comitato dei ricorsi o al tribunale del lavoro (a seconda dei casi) entro i termini, chiedendo eventualmente la sospensione. – Transazione contributiva: Analogamente al Fisco, anche l’INPS può essere coinvolta in una transazione nell’ambito di accordi di ristrutturazione o concordati. Le regole sono le stesse della transazione fiscale (art. 63 CCII) e dal 2023 è possibile l’omologazione forzata nonostante il dissenso dell’ente, alle condizioni di percentuale minima già viste (30-40% almeno) . – Fondo di Garanzia e surroga: Se l’azienda ha debiti verso i propri dipendenti per TFR o ultime mensilità, l’INPS interviene tramite il Fondo di Garanzia a pagare i lavoratori (in caso di insolvenza conclamata o fallimento) e poi si surroga nei loro crediti. Pertanto, un debito verso dipendenti può trasformarsi in debito verso INPS. Il debitore può cercare di saldare direttamente i dipendenti (magari privilegiandoli nei pagamenti) per evitare che intervenga il fondo, ma ciò deve avvenire prima di una procedura concorsuale altrimenti subentrano le regole di par condicio.
Nota sugli obblighi penali: L’omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti oltre una soglia (oggi oltre €10.000 annui di omissione) costituisce reato (art. 2 D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983). Ciò significa che se l’azienda trattiene in busta paga i contributi del lavoratore (le quote a carico dipendente) ma non li versa all’INPS, l’amministratore rischia una sanzione penale (punita con la reclusione fino a 3 anni o multa) per importi elevati. Va ricordato però che il pagamento dei contributi dovuti entro termini di legge (oggi entro 3 mesi dall’accertamento) estingue il reato. È dunque fondamentale non trascurare i contributi: se l’azienda non può pagarli per intero, è opportuno attivarsi immediatamente per una rateazione o accordo, al fine di evitare conseguenze penali per gli amministratori.
Debiti verso Fornitori e Altri Creditori Privati
I debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi, consulenti, fitto di locali, e in generale verso qualsiasi creditore non privilegiato, rappresentano spesso la parte più consistente dell’indebitamento aziendale. Questi creditori chirografari (senza garanzie) hanno strumenti ordinari di tutela: – Possono richiedere un decreto ingiuntivo dal tribunale per ottenere un titolo esecutivo di pagamento (solitamente in tempi brevi se la fattura è incontestata). Trascorsi 40 giorni senza opposizione, il decreto diviene esecutivo e il fornitore può procedere con pignoramenti. – Possono agire con pignoramenti mobiliari o presso terzi: ad esempio far pignorare merci in magazzino, veicoli aziendali, o crediti della società verso terzi (come crediti verso clienti, bloccandone il pagamento per dirottarlo al creditore procedente). – Possono richiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda: un singolo creditore commerciale con credito certo, scaduto e di importo rilevante (superiore alle soglie di legge, ad esempio 30.000 € circa, salvo diversa disposizione del CCII) può depositare un’istanza di fallimento sostenendo l’insolvenza della società. Questo è uno scenario estremo ma realistico se il debitore accumula ritardi e non dà garanzie.
Conseguenze: Le esecuzioni individuali da parte dei fornitori possono portare al blocco operativo (si pensi al pignoramento del conto corrente aziendale da parte di un fornitore impagato, che impedisce di pagare dipendenti e forniture correnti) o alla vendita forzata di beni essenziali (macchinari, automezzi). Inoltre, l’incubo del fallimento pendente può distruggere la reputazione commerciale dell’azienda, aggravandone la crisi.
Difese e soluzioni: Nei confronti dei fornitori e creditori privati, il debitore ha vari strumenti: – Negoziazione stragiudiziale: Spesso il primo passo è contattare il fornitore per trovare un accordo bonario di rientro (un piano di rientro). Molti fornitori preferiscono evitare lunghe cause e accettano una dilazione del debito o uno sconto a saldo e stralcio (es. pagare il 50% subito e chiudere il debito) se l’alternativa è non ricevere nulla da un debitore insolvente. Conviene dunque proporre tempestivamente soluzioni sostenibili, magari supportate da garanzie (es. cambiali, riconoscimento del debito) che diano fiducia al creditore. Ogni accordo va messo per iscritto e, se possibile, formalizzato in modo da sospendere eventuali azioni legali in corso. – Opposizione a decreto ingiuntivo: Se il fornitore ottiene un ingiuntivo e l’azienda ritiene di avere contestazioni legittime (merce non conforme, errori nei conteggi, ecc.), può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica, aprendo un giudizio ordinario. L’opposizione, se accolta dal giudice, può sospendere provvisoriamente l’esecuzione. Tuttavia, opporsi solo per guadagnare tempo senza reali motivi può essere controproducente (si rischiano spese legali aggiuntive e la concessione della provvisoria esecutorietà all’avversario). Occorre valutare con l’avvocato se vi siano fondati motivi di contestazione o se sia meglio cercare un accordo. – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: Se il fornitore passa al pignoramento, il debitore può verificare eventuali vizi di procedura (es. vizi nella notifica del precetto, errata individuazione dei beni pignorati, importi non aggiornati) e, in presenza di tali vizi, proporre le relative opposizioni in sede di esecuzione per far correggere o estinguere l’esecuzione. Queste sono difese tecniche e spesso non risolvono il problema di base (il debito), ma servono a guadagnare tempo o costringere il creditore a rifare da capo la procedura, concedendo spazio per trattative. – Conversione del pignoramento: Un rimedio previsto dal codice di procedura civile (art. 495 c.p.c.) permette al debitore esecutato di chiedere la conversione del pignoramento, cioè di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da depositare in tribunale (pari al debito e spese, eventualmente rateizzabile fino a 18 mesi). In pratica, l’azienda potrebbe salvare un macchinario pignorato offrendo al giudice un pagamento dilazionato dell’importo dovuto al creditore. Questo richiede liquidità (almeno parziale) o magari il supporto della proprietà che versi la cauzione. Se concessa, la conversione estingue l’esecuzione sui beni pignorati. – Procedure concorsuali (concordato, accordo di ristrutturazione): L’apertura di una procedura concorsuale ha l’effetto di sospendere e poi vietare le azioni esecutive individuali dei creditori chirografari. Ad esempio, se l’azienda deposita una domanda di concordato preventivo con riserva (il cosiddetto “concordato in bianco”), ottiene immediatamente una protezione (“automatic stay”) che congela i pignoramenti in corso e impedisce nuovi sequestri. Lo stesso vale per la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, per cui il tribunale può concedere misure protettive fino a 4 mesi . Questa strategia formale – di cui tratteremo in dettaglio più avanti – può essere l’ultima risorsa se le trattative informali falliscono e i creditori aggrediscono il patrimonio sociale. Chiaramente, attivare una procedura concorsuale comporta obblighi stringenti (predisporre un piano, coinvolgere un attestatore, ecc.), ma offre un respiro all’azienda accerchiata dai creditori. – Resistenza all’istanza di fallimento: Se un fornitore (o altro creditore) ha chiesto il fallimento dell’azienda, quest’ultima può resistere in tribunale dimostrando che lo stato di insolvenza non sussiste (ad esempio esibendo prospettive di continuità, accordi in corso con altri creditori, o contestando il credito del ricorrente). Inoltre, il debitore in pendenza di istanza di fallimento può depositare una proposta di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione: la legge prevede che il tribunale, se vede concrete possibilità di risanamento, preferisca la soluzione concordata al fallimento immediato. Presentare in extremis un concordato “prenotativo” con riserva, dunque, può bloccare la dichiarazione di fallimento (salvo abuso) e dare all’azienda qualche mese di tempo per predisporre un piano di risanamento . Tuttavia, bisogna agire tempestivamente e in buona fede: l’uso meramente dilatorio del concordato per frenare il fallimento è scoraggiato dalla giurisprudenza (il tribunale potrebbe dichiarare improcedibile la domanda di concordato se la ritiene solo un escamotage privo di reale fattibilità) .
Debiti Bancari e verso Istituti di Credito
Le banche e gli altri finanziatori (società di leasing, società di factoring, ecc.) costituiscono una categoria a parte di creditori, spesso muniti di garanzie. Se l’azienda ha contratto mutui ipotecari, finanziamenti garantiti da pegno su beni o secured da garanzie statali, oppure se ci sono fideiussioni personali di soci/amministratori a garanzia, il mancato pagamento comporta: – Decadenza dal beneficio del termine: la banca, in caso di rate non pagate, può revocare il finanziamento e chiedere il rientro immediato di tutto il capitale residuo. Questo pone l’azienda in situazione di insolvenza tecnica se non dispone della liquidità per estinguere subito. – Escussione delle garanzie: la banca potrà attivare le garanzie acquisite. Se c’è un’ipoteca su un immobile aziendale, avvierà un pignoramento immobiliare su quell’immobile, mettendolo all’asta giudiziaria. Se c’è un pegno su macchinari o su crediti (ad es. pegno su polizza, su quote societarie, ecc.), procederà a far vendere i beni in pegno. Se ci sono fideiussori personali (tipicamente l’imprenditore o i soci garanti per il debito sociale), la banca potrà chiedere il pagamento direttamente a loro, aggredendo il patrimonio personale dei garanti (conto bancario personale, immobili privati, stipendio). – Revoca degli affidamenti: inoltre, la banca revocherà eventuali fidi di cassa o linee di credito di conto corrente, causando spesso uno scoperto che viene immediatamente richiesto. Questo può bloccare l’operatività quotidiana (niente più anticipi su fatture, niente scoperto di conto per pagare fornitori).
Difese e negoziazione con le banche: – Moratorie e rinegoziazioni: È spesso possibile negoziare con la banca una ristrutturazione del debito. Le banche, soprattutto per le PMI, possono concedere piani di rientro (ad esempio trasformare uno scoperto esigibile a vista in un mutuo rateizzato, allungare la durata di un mutuo riducendo la rata mensile, o concedere periodi di pre-ammortamento in cui si pagano solo interessi). In tempi di crisi economica, anche misure legislative generali (come le moratorie COVID del 2020) hanno sospeso per mesi le rate dei mutui. Nel 2025 non vi è una moratoria generalizzata, ma tramite accordi ABI (Associazione Bancaria Italiana) le banche possono valutare la sospensione del rimborso del capitale per 6-12 mesi a imprese in difficoltà temporanea. Agire presto è cruciale: se la banca ancora non ha classificato l’azienda in default e vede la volontà di risanare, sarà più disponibile a rinegoziare. Conviene presentare un piano finanziario credibile, magari con l’assistenza di un consulente finanziario, dimostrando come l’azienda intende tornare solvibile (ad es. dismissione di un immobile non strategico per pagare parte del debito, aumento di capitale dai soci, nuovo investitore in ingresso, ecc.). – Accordi quadro con pool di banche: Se l’azienda ha più istituti finanziatori, è utile cercare un accordo coordinato. In Italia esistono il “piano attestato di risanamento” (art. 56 CCII) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII) che possono coinvolgere le banche. Spesso le banche sono disposte a aderire a un accordo collettivo se ciò offre maggiori garanzie (ad esempio, possono richiedere la nomina di un professionista attestatore che validi il piano di risanamento). Un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale è particolarmente utile perché consente di cristallizzare la posizione: le banche aderenti si impegnano a rispettare il piano e quelle eventualmente non aderenti (se minoritarie) vengono comunque soddisfatte entro certi limiti senza poter agire (grazie agli effetti dell’omologa, come vedremo). Si può anche ricorrere alla procedura di composizione negoziata con l’ausilio di un esperto indipendente per facilitare l’intesa con i creditori finanziari. – Opposizione a decreti e pignoramenti bancari: Sul piano giudiziario, se la banca agisce esecutivamente, ci sono poche possibilità di opposizione sul merito (il credito di solito è certo e documentato). Ci si può concentrare su aspetti formali (ad es. verificare la correttezza del calcolo interessi, soprattutto se ci sono interessi di mora elevati: se vi sono tassi usurari, si può fare opposizione chiedendo la rideterminazione del dovuto). Oppure verificare se la banca ha rispettato gli obblighi di segnalazione e trasparenza (talvolta vengono contestati in giudizio addebiti di interessi non dovuti o invalidità di fideiussioni per violazione normativa antitrust – ma sono eccezioni che richiedono tempi lunghi in tribunale). – Estinguere le garanzie più critiche: In alcuni casi, la scelta strategica è concentrare le risorse disponibili per estinguere quei debiti che, se non pagati, attiverebbero conseguenze irreparabili. Ad esempio, se con una somma limitata si può pagare le rate arretrate di leasing di un macchinario indispensabile, ciò evita che il lessor lo revochi e se lo riprenda. Oppure, se pagando un 10-20% di un fido sconfinato si rientra entro il plafond, la banca potrebbe non revocare l’intera linea di credito. Si tratta di valutare quali passività hanno il maggiore impatto sull’operatività e allocare lì le risorse scarse, sacrificando temporaneamente altri pagamenti meno pericolosi (questa è una scelta di “graduazione” dei pagamenti che però espone a rischi di azioni revocatorie se poi si andrà in fallimento, attenzione). – Garanzie personali: Se l’imprenditore (o i soci) hanno prestato garanzia personale, la difesa del patrimonio personale diventa prioritaria. Il garante deve partecipare alle trattative: ad esempio potrebbe offrire un’ipoteca su un immobile privato per ottenere dalla banca una moratoria sul debito sociale, oppure cercare di concordare col creditore una rinuncia parziale del debito in cambio di un pagamento a saldo (spesso le banche, se vedono che l’azienda non pagherà mai e che l’unica chance è escutere il garante, possono accettare dal garante stesso un pagamento ridotto in via transattiva). In ogni caso, ignorare le fideiussioni è pericoloso: il creditore, se non riesce a recuperare dal patrimonio sociale, quasi certamente colpirà quello dei garanti.
Debiti verso Dipendenti e TFR
Un capitolo a parte meritano i debiti verso i dipendenti, quali stipendi arretrati, tredicesime non corrisposte, trattamento di fine rapporto (TFR) maturato e non versato, ecc. I dipendenti sono creditori privilegiati di massimo grado: la legge tutela il lavoro subordinato prevedendo un privilegio generale mobiliare (sui beni mobili e crediti del datore) per gli ultimi stipendi dovuti e addirittura un privilegio super-assistito (di grado ancora superiore, paragonabile ai crediti di massa) per alcune mensilità e indennità in caso di fallimento. Ciò significa che, in caso di insolvenza, i dipendenti verranno soddisfatti prima di gran parte degli altri creditori con le somme ricavate dall’attivo.
In pratica: – Se l’azienda non paga le retribuzioni, i dipendenti possono agire in giudizio con un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (spesso il giudice del lavoro rilascia decreti provvisoriamente esecutivi per crediti salariali). Questo consente loro di pignorare conti o beni aziendali con rapidità. – Tuttavia, molti lavoratori preferiscono rivolgersi ai sindacati o attendere (entro certi limiti) che la situazione si sblocchi, sapendo che se l’azienda fallisse comunque interverrebbe il Fondo di Garanzia INPS a coprire TFR e ultime tre mensilità (entro massimali di legge). – Se la crisi aziendale degenera, i dipendenti potrebbero anche presentare essi stessi istanza di fallimento come creditori (ciò avviene raramente, ma è legalmente possibile qualora vi sia insolvenza conclamata e magari il datore ritardi illegittimamente nel prendere iniziative).
Difese e considerazioni: Un’azienda in crisi dovrebbe, per ragioni sia etiche che strategiche, cercare di soddisfare per quanto possibile i dipendenti. Questo perché: (a) mantenere il personale motivato e pagato è essenziale per proseguire l’attività e tentare il risanamento; (b) in caso di concordato preventivo, i crediti dei lavoratori per stipendio antecedenti si possono pagare integralmente anche durante la procedura con autorizzazione del tribunale (essendo creditore privilegiato strategico); (c) se l’azienda poi andasse in liquidazione, l’INPS interverrebbe comunque ma rivalendosi, e gli amministratori potrebbero incorrere in responsabilità per non aver tempestivamente attinto al fondo di garanzia. Pertanto: – Pagamenti preferenziali mirati: Durante lo stato di crisi, pagare i dipendenti può essere fatto senza incorrere nel rischio di revocatoria fallimentare (i pagamenti di lavoro non sono revocabili ex art. 150 CCII, salvo eccezioni). Quindi, l’azienda può legittimamente preferire i dipendenti rispetto ad altri creditori meno tutelati, senza timore di sanzioni future. – Accordi sindacali: In situazioni di difficoltà, si può tentare un accordo con i dipendenti (collettivo se c’è una rappresentanza sindacale) per differire il pagamento di alcune competenze (es. “congelare” temporaneamente il TFR o le ferie maturate) o ridurre l’orario di lavoro (cassa integrazione straordinaria, contratti di solidarietà) così da diminuire il costo del lavoro e gli arretrati. Chiaramente ciò richiede trasparenza verso i lavoratori, spiegando la situazione e coinvolgendoli nel piano di salvataggio. – Strumenti di integrazione salariale: Lo Stato mette a disposizione ammortizzatori (Cassa Integrazione Guadagni) per le imprese in crisi temporanea. Se l’azienda ottiene una CIG straordinaria per crisi, i dipendenti ricevono un’indennità dall’INPS e l’azienda può sospendere i pagamenti salariali per le ore non lavorate. Questo allevia l’accumulo di nuovi debiti verso il personale durante la ristrutturazione. – Fondo di garanzia INPS: In caso di procedura concorsuale (fallimento o concordato liquidatorio omologato), i dipendenti non pagati attiveranno il Fondo di Garanzia. Questo pagherà TFR e ultime retribuzioni dovute, e subentrerà come creditore. Per il datore insolvente, è un paracadute per i lavoratori ma non elimina il debito – semplicemente cambia il creditore (da tanti lavoratori a un ente pubblico). Da notare che, se vengono stralciati i debiti verso i dipendenti in un concordato (cosa rara, di solito si prevede il pagamento integrale), i dipendenti potrebbero opporsi all’omologa se non garantisce loro almeno quanto otterrebbero dal Fondo di Garanzia, in base al best interest test. Il tribunale non omologherà piani che ledano indebitamente i loro diritti.
Riassumendo, i debiti verso il personale hanno priorità sostanziale: difendersi da essi significa soprattutto assicurarsi che siano gestiti attraverso gli strumenti di sostegno disponibili, e che il personale non intraprenda azioni giudiziarie individuali disordinate che potrebbero peggiorare la situazione (ad esempio pignorando conti aziendali). Una gestione condivisa e trasparente con i lavoratori può trasformarli da possibili creditori aggressivi a alleati nel salvataggio dell’azienda.
Riepilogo delle Conseguenze per Categoria di Debito
Per chiarire, la tabella seguente sintetizza come ogni tipologia di debito può ripercuotersi sull’azienda indebitata e quali strumenti immediati di difesa sono disponibili:
Tabella 1 – Debiti dell’azienda, azioni dei creditori e prime difese del debitore
| Tipo di Debito | Azioni tipiche del Creditore | Conseguenze per l’Azienda | Difese/Rimedi Immediati |
|---|---|---|---|
| Fiscale (Erario) | Cartella di pagamento da AER; Fermo amministrativo veicoli; Ipoteca su immobili; Pignoramento (conti, beni); Istanza di fallimento (in casi gravi) | Conti bloccati; beni vincolati o espropriati; aggravio di sanzioni e interessi; rischio di azioni penali per omessi versamenti rilevanti (IVA, ritenute) | Rateizzazione del debito fiscale (fino 84-120 rate) ; Ricorso tributario con istanza di sospensione; Rottamazione cartelle se vigente; Transazione fiscale in concordato/accordo (anche cram-down se >30-40%) ; Misure protettive dal tribunale (sospensione esecuzioni) |
| Contributivo (INPS/INAIL) | Avviso di addebito INPS; Cartella AER; Ipoteca su immobili; Pignoramento; Segnalazione per fallimento | Simili al Fisco: blocco liquidità, beni espropriati; possibili denunce per omesso versamento contributi (se > €10.000) | Rateizzazione contributi con INPS; Ricorso a giudice del lavoro; Transazione contributiva (art.63 CCII) con cram-down come per il Fisco; Fondo garanzia INPS attivabile per pagare lavoratori (subentro del credito) |
| Fornitori (chirografari) | Sollecito e messa in mora; Decreto ingiuntivo (40 gg per opporsi); Pignoramento beni aziendali o crediti; Istanza di fallimento (se insolvenza) | Blocco operativo (es. conto pignorato, merci o crediti sequestrati); danno reputazionale; rischio insolvenza manifesta | Negoziazione stragiudiziale (piani di rientro, saldo e stralcio); Opposizione a ingiunzione se contestazioni fondate; Conversione dei pignoramenti (art.495 cpc) depositando somme a garanzia; Attivazione di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione per congelare le azioni esecutive (automatic stay) |
| Banche/Finanziatori | Decadenza dal termine su mutui; Revoca fidi e scoperti; Escussione garanzie (es. pignoramento immobiliare su beni ipotecati, escussione pegni); Escussione fideiussioni personali; Decreti ingiuntivi per saldo c/c scoperto | Perdita di asset strategici (immobili, macchinari) a seguito di esecuzioni; Azioni sui garanti personali (soci/amministratori); restrizione immediata credito (fidi revocati) -> crisi liquidità acuta | Moratoria o ristrutturazione del debito bancario mediante accordo (allungamento piani di ammortamento, nuove garanzie, ecc.); Accordo di risanamento attestato o ex art.67 LF (ora art.56 CCII) con banche; Coinvolgimento banche in Accordo di ristrutturazione ex art.57 CCII (60% crediti) o in piano concordatario; Opposizione solo per vizi (es. contestare interessi usurari) – da valutare caso per caso; Eventuale apporto di finanza esterna per ridurre l’esposizione critica |
| Dipendenti | Decreto ingiuntivo per stipendi; Vertenza sindacale; Denuncia ITL per mancato pagamento; Istanza di fallimento (rara, ma possibile se stipendi non pagati a lungo) | Tensione interna, calo produttività; possibili scioperi o dimissioni; esecuzioni sui conti (pignoramenti rapidi); intervento INPS (Fondo garanzia) e sostituzione creditore; in fallimento, crediti lavoro superprivilegiati da soddisfare per primi | Pagamento prioritario di stipendi correnti (pagabili anche in prededuzione in concordato); Accordo sindacale per dilazionare alcuni istituti (es. pagamento differito TFR); Cassa integrazione o contratti solidarietà per ridurre oneri; Utilizzo del Fondo garanzia INPS a tutela dei lavoratori in concordato/liquidazione (non una difesa, ma una gestione ordinata del debito salariale) |
(Legenda: AER = Agenzia Entrate-Riscossione; CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; ITL = Ispettorato Territoriale del Lavoro.)
Procedure Esecutive dei Creditori e Come Bloccarle
Affrontate le tipologie di debito, vediamo ora in dettaglio le procedure esecutive che i creditori possono intraprendere e come un’azienda debitrice possa difendersi nel concreto. Dal decreto ingiuntivo al pignoramento, fino all’istanza di liquidazione giudiziale, ogni azione ha tempi e modalità specifiche previsti dalla legge. Conoscere questi meccanismi consente al debitore (assistito dal proprio legale) di intervenire tempestivamente, esercitando i diritti oppositivi e sfruttando gli spazi di manovra che l’ordinamento concede.
Decreto Ingiuntivo e Precetto
Il decreto ingiuntivo è spesso il primo passo dell’azione legale di un creditore insoddisfatto. Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice, su ricorso del creditore, che ingiunge al debitore di pagare una somma (o consegnare un bene) entro 40 giorni, sotto pena di esecuzione forzata. Esso viene concesso inaudita altera parte (senza sentire il debitore) se il creditore fornisce prova scritta del credito (fatture, contratti, estratti conto autenticati, ecc.). Dal momento della notifica all’azienda: – Termine di 40 giorni: Il debitore ha 40 giorni per pagare o proporre opposizione. Pagare estingue la procedura (ma attenzione a eventuali spese legali da aggiungere). L’opposizione va depositata in tribunale, ed avvia un giudizio ordinario in cui il debitore diventa attore opponente, potendo contestare il credito o la procedura. – Provvisoria esecutorietà: Se il creditore lo ha chiesto e i documenti appaiono di particolare solidità (assegni, cambiali protestate, oppure fatture confermate da estratto notarile delle scritture contabili), il giudice può dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo. In tal caso, il creditore non deve attendere 40 giorni: può notificare subito un precetto e iniziare il pignoramento, anche se il debitore propone opposizione. Questo complica la difesa, perché l’esecuzione prosegue parallelamente alla causa di merito. – Precetto: È l’intimazione di pagamento che il creditore notifica dopo il decreto ingiuntivo (o dopo una sentenza, o altro titolo esecutivo). Il precetto concede 10 giorni per adempiere spontaneamente prima di avviare il pignoramento. Può essere notificato contestualmente al decreto se già dichiarato esecutivo, altrimenti trascorsi i 40 giorni senza opposizione.
Difese possibili: – Opposizione a decreto ingiuntivo: Deve essere valutata seriamente. Se l’azienda contesta l’esistenza o l’entità del debito, l’opposizione è doverosa (ad esempio: merce non consegnata interamente, lavori eseguiti male, importi già pagati in parte, prescrizione del credito, mancanza di documenti probatori, ecc.). L’opposizione si propone con atto di citazione entro 40 giorni dalla notifica del decreto. Può chiedersi la sospensione dell’efficacia esecutiva (se il decreto non era già esecutivo) oppure, se lo era, si può chiedere al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione per gravi motivi. Nel giudizio di opposizione, il creditore diventa l’attore sostanziale che deve provare il suo credito, mentre l’opponente può eccepire tutto ciò che avrebbe potuto opporre se fosse stato citato in giudizio ordinario. Questo processo può durare mesi o anni; nel frattempo, se non c’è sospensione, il creditore può proseguire l’esecuzione. – Effetto: L’opposizione in sé non blocca automaticamente il pignoramento (a meno che il giudice non disponga la sospensione). Tuttavia, spesso i creditori attendono l’esito della fase di sospensione prima di procedere, o comunque l’esecuzione può non produrre esiti rapidi (p.es. un’asta immobiliare richiede mesi). – Opposizione al precetto: Si può fare un’opposizione specifica entro i 20 giorni successivi alla notifica del precetto (anche oltre se limitata a vizi formali), se si rilevano vizi nel precetto stesso (es.: somme indicate in modo errato, difetto di requisiti formali, avvenuto pagamento non considerato). Questa opposizione (detta anche opposizione all’esecuzione se contesta il diritto a procedere) può portare a sospendere l’inizio del pignoramento se il giudice rileva un fumus (es. il credito è dubbio perché c’è un pagamento effettuato non scalato). In pratica, però, è un’arma limitata, perché se il decreto ingiuntivo è regolare, difficilmente il precetto avrà vizi. – Soluzioni alternative entro i termini: Il periodo tra la notifica dell’ingiunzione e l’avvio dell’esecuzione può essere usato proficuamente per trattare col creditore. Spesso i creditori concedono più tempo se vedono una concreta proposta di accordo. Ad esempio, si può chiedere al creditore di aspettare sulla procedura in cambio di un piano di pagamento rateale garantito da titoli (cambiali mensili, oppure la firma di un accordo di transazione). In caso di successo della trattativa, il creditore potrà rinunciare all’ingiunzione (o tenerla come “spada di Damocle” sospendendo comunque l’azione esecutiva fintanto che il debitore rispetta l’accordo). – Pagare per evitare il peggio: Se non ci sono vie di scampo legali, l’unico modo di bloccare il pignoramento imminente dopo il precetto è pagare. È duro a dirsi, ma a volte racimolare i fondi (magari chiedendo ai soci un prestito ponte o vendendo in fretta qualche cespite liquido) per saldare quel creditore può evitare che scattino pignoramenti a catena. Bisogna valutare il danno minore: pagare uno scomodo fornitore che minaccia il fallimento può essere preferibile al rischio di un’insolvenza conclamata che coinvolga tutti.
In sintesi, il decreto ingiuntivo è un procedimento rapido e implacabile se non ci si muove. Il debitore deve decidere subito se opporsi (per ragioni fondate) o transigere/pagare. Ignorarlo porta in breve tempo al precetto e al pignoramento, stadi in cui le opzioni si restringono.
Pignoramento Mobiliare, Immobiliare e presso Terzi
Il pignoramento è l’atto con cui inizia l’esecuzione forzata vera e propria: il creditore, munito di titolo esecutivo (ingiunzione non opposta, sentenza, cambiale protestata, ecc.) e precetto, individua i beni del debitore da aggredire e notifica il pignoramento, ottenendo poi l’intervento dell’ufficiale giudiziario o di altri soggetti preposti (ad es. notaio per le aste immobiliari). Vediamo le forme principali e le possibilità di difesa in ciascuna.
- Pignoramento mobiliare diretto presso il debitore: L’ufficiale giudiziario si reca nella sede dell’azienda (o nei locali dove questa ha beni) e redige un verbale sequestrando beni mobili presenti (macchinari, computer, arredi, merci), fino a concorrenza del credito. I beni pignorati restano in custodia (spesso lasciati allo stesso debitore come custode) e, se non si trova un accordo o opposizione valida, verranno messi all’asta.
- Difesa: Qui la collaborazione col l’ufficiale può aiutare: l’azienda può indicare beni di minor importanza da pignorare in sostituzione di altri vitali (nei limiti di legge). Ad esempio, se sono presenti macchinari essenziali alla produzione, si può tentare di convincere l’ufficiale a pignorare altri beni non strumentali (materiale non strategico, veicoli inutilizzati, ecc.). Non c’è garanzia, ma l’ufficiale ha discrezionalità nel preferire beni più facilmente liquidabili. Inoltre, il debitore può dichiarare se esistono beni già ipotecati o sottoposti a leasing (non pignorabili, o pignorabili con vincoli) per orientare altrove il pignoramento.
- Sul piano legale, le opposizioni possibili sono: l’opposizione all’esecuzione (se si contesta il diritto del creditore a procedere, ad esempio perché il debito è già pagato o il titolo è invalido) e l’opposizione agli atti esecutivi (se il pignoramento presenta irregolarità formali). L’opposizione all’esecuzione va proposta di regola entro l’inizio (per crediti sopravvenuti) o al massimo entro il pignoramento, salvo motivi sopravvenuti; quella agli atti entro 20 giorni dall’atto viziato. Entrambe però di solito non fermano l’esecuzione immediatamente (serve chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione e motivarla).
- Un rimedio efficacissimo, come detto sopra, è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): se l’azienda riesce a racimolare liquidità o garanzie, può chiedere al giudice di poter sostituire tutti i beni pignorati con una somma di denaro (corrispondente all’importo dovuto aumentato di spese) da pagare in un’unica soluzione o a rate (massimo 18 mensilità). Per ottenere la rateazione, occorre versare subito almeno 1/5 del totale pignorato. Se il giudice accoglie, l’esecuzione sui beni si estingue e i beni tornano liberi, mentre il debitore deve poi versare le rate residue nel tempo concesso. Questa è spesso l’ultima spiaggia per salvare macchinari o merci indispensabili: ad esempio, se un creditore ha pignorato il magazzino di prodotti finiti pronti per la vendita, l’azienda potrebbe volerli recuperare subito per venderli e pagare i debiti. Chiedendo la conversione, deposita una somma (ottenuta magari da un prestito urgente) e ottiene di rimettere in circolazione la merce, utilizzandone il ricavato per onorare il piano di conversione.
- Limiti: Ci sono beni impignorabili anche per un’azienda, ma pochi: ad esempio, nei luoghi di residenza (non applicabile se è una sede aziendale commerciale), esistono limiti per gli oggetti di stretta utilità. In ambito aziendale, strumenti indispensabili all’attività possono essere pignorati ma con criteri: il codice (art. 515 c.p.c.) tutela gli strumenti indispensabili all’esercizio della professione del debitore fino a un certo valore, ma ciò è pensato per professionisti, non per società (una S.r.l. non può invocare la “impignorabilità” dei beni d’ufficio come una persona fisica). Quindi, quasi tutto può essere pignorato, salvo merce in leasing (che è di proprietà altrui), e beni già ipotecati (che si preferisce pignorare con procedura ipotecaria).
- Pignoramento presso terzi (crediti del debitore): Il creditore può pignorare crediti che l’azienda vanta verso altri soggetti o somme presso terzi dovute all’azienda. Il caso più comune è il conto corrente bancario: il pignoramento presso terzi viene notificato alla banca, la quale è tenuta a congelare le somme sul conto fino a concorrenza del credito pignorato. Altri esempi: pignorare i crediti verso clienti (notificando l’atto al cliente che deve pagare l’azienda, intimandogli di pagare invece il creditore procedente), pignorare i canoni di locazione dovuti da eventuali affittuari dell’azienda, pignorare eventuali polizze assicurative in caso di indennizzo dovuto, ecc.
- Effetti: Il conto corrente pignorato è devastante: l’azienda perde l’accesso alla liquidità depositata e non può operare su quel conto (sebbene possa aprirne un altro su cui incassare d’ora in poi, ma il danno è immediato). Il pignoramento dei crediti verso clienti fa sì che il cliente trattenga i pagamenti all’azienda e li versi in tribunale, con evidenti problemi di immagine e liquidità.
- Difesa: Anche qui, opposizione agli atti se vi sono vizi (ad es. importo del pignoramento superiore al dovuto, crediti non pignorabili – se il terzo deve somme impignorabili per legge, come certi crediti alimentari, ma non tipico per aziende). L’opposizione all’esecuzione se si contesta il titolo. Spesso però l’arma migliore è negoziare col creditore: ad esempio, se un fornitore ha pignorato il conto, si può offrire di pagargli subito una certa somma in cambio della liberazione del conto. In molti casi il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza di assegnazione delle somme anche 2-3 mesi dopo il pignoramento: c’è quindi una finestra per trattare. Se si trova un accordo, il creditore può dichiarare di essere soddisfatto e far estinguere la procedura, liberando il conto prima dell’udienza.
- Nel pignoramento di crediti, il terzo pignorato (banca o cliente) dichiara quanto deve. Se la banca, ad esempio, dichiara che sul conto c’erano €50.000, il giudice potrà assegnare quell’importo al creditore. Se i fondi erano insufficienti a coprire tutto il credito, il creditore può procedere su altri beni per il residuo.
- Conversione: Anche per il pignoramento presso terzi è teoricamente possibile la conversione ex art. 495, ma avendo ad oggetto somme di denaro, di solito non si applica in senso pratico (il pignoramento di danaro è già liquido).
- Un espediente talvolta usato è cambiare banca rapidamente: se l’azienda teme il pignoramento del conto, può aprire un nuovo conto in un altro istituto e trasferirvi i fondi, lasciando “vuoto” il conto noto ai creditori. Tuttavia, ciò deve avvenire prima che il pignoramento sia notificato, altrimenti la banca è tenuta a congelare ciò che c’è al momento. Inoltre, trasferire asset per sottrarli ai creditori può esporre a azioni revocatorie o a contestazioni di frode ai creditori se fatto in mala fede sistematica.
- Pignoramento immobiliare: Se l’azienda possiede immobili (capannoni, uffici, terreni), i creditori – soprattutto quelli garantiti da ipoteca, ma anche chirografari se ne vale la pena – possono iscrivere pignoramento immobiliare. Si tratta di un atto notificato al debitore e trascritto nei registri immobiliari, in cui l’immobile viene vincolato per l’esecuzione. Segue poi la perizia di stima e la procedura d’asta.
- Effetti: L’immobile non può più essere venduto liberamente dall’azienda (la trascrizione del pignoramento lo rende invendibile se non liberato dal debito). Dopo alcune fasi, il tribunale procederà con la messa all’asta. I tempi qui sono più lunghi: spesso molti mesi prima della prima asta. Nel frattempo l’azienda può continuare ad usarlo (se ne ha possesso), ma non più disporne. Se però l’attività contava sul valore dell’immobile per ottenere crediti o investimenti, il pignoramento ne compromette la capacità d’uso come garanzia.
- Difese: L’opposizione formale è analoga (errori nel titolo o nell’atto). Ma pragmaticamente, c’è più tempo per trovare una soluzione. Fino a quando l’asta non avviene e il decreto di trasferimento non è emesso, il debitore può:
- Vendere privatamente l’immobile ad un terzo, ma ciò richiede prima di cancellare il pignoramento (quindi di pagare il debito o accordarsi col creditore per farlo cancellare a fronte magari del pagamento diretto dal compratore delle somme dovute). Spesso, se l’immobile è valido e il debitore trova un acquirente disposto a pagare un prezzo congruo, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’autorizzazione a vendere all’accordo col creditore per evitare l’asta (che di solito deprezza l’immobile). Il creditore deve acconsentire di solito, perché incasserà in modo più efficiente.
- Accordo col creditore ipotecario: se il creditore pignorante è una banca con ipoteca, si può trattare un saldo e stralcio. Esempio: debito €1 milione, immobile valore €800k, la banca potrebbe accettare €800k direttamente senza passare dall’asta (dove magari ricaverebbe 600k netti). Questo accordo può coinvolgere un terzo investitore o i soci che trovano fondi. Formalmente la banca chiede sospensione dell’asta e poi rinuncia al pignoramento a pagamento avvenuto.
- Conversione del pignoramento immobiliare: è ammessa ex lege, ma implica depositare l’intera somma del debito (non c’è rateazione facile qui, perché parliamo spesso di grandi importi). Raramente utilizzabile a meno di liquidità consistente.
- Concordato preventivo: L’apertura di un concordato preventivo dopo che un immobile è pignorato non libera quell’immobile dall’esecuzione se il creditore è ipotecario (nel concordato le esecuzioni individuali chirografarie sono sospese, ma i creditori privilegiati con pegno/ipoteca possono chiedere di proseguire se il valore a garanzia rischia di calare e non sono pagati integralmente nel piano). Tuttavia, in un concordato in continuità spesso si prevede di soddisfare i creditori ipotecari integralmente (magari rinegoziando il debito), quindi il tribunale potrebbe sospendere temporaneamente la vendita forzata se c’è la prospettiva di pagamento integrale a breve. In sostanza, l’ombrello del concordato può fornire protezione anche su immobili se il piano è convincente sulla tutela dei garantiti.
- Va notato inoltre che i creditori chirografari difficilmente pignorano immobili se ci sono ipoteche iscritte da banche o Stato, perché avrebbero poco margine (il prezzo d’asta va prima ai creditori ipotecari in ordine di grado). Quindi, se un immobile è già ipotecato, il debitore può aspettarsi che solo il garantito (banca) proceda. Se l’immobile è libero da ipoteche, può far gola anche ad altri creditori: per prevenire ciò, a volte il debitore può costituire garanzia ipotecaria volontaria a favore di qualcuno (ad esempio i soci stessi) prima che arrivi un pignoramento – ma attenzione, questa sarebbe considerata con ogni probabilità una garanzia per debiti preesistenti revocabile in caso di fallimento (se costituita nell’anno prima) e potrebbe configurare atti in frode.
- Sequestro conservativo: Vale la pena menzionare che, prima del pignoramento definitivo, alcuni creditori possono chiedere un sequestro conservativo dei beni del debitore se temono di perdere la garanzia del proprio credito durante la causa. Ad esempio, un fornitore che avvia una causa ordinaria perché il credito è contestato, può chiedere al giudice un sequestro dei beni del debitore a tutela (bloccandoli in attesa della sentenza). Il sequestro conservativo si tramuta in pignoramento automatico se poi il creditore ottiene vittoria. Come difendersi? In sede di istanza cautelare, il debitore può opporsi dimostrando che non vi è pericolo nel ritardo (cioè che non sta nascondendo beni né la sua situazione peggiorerà), magari offrendo egli stesso una garanzia alternativa (cauzione, fideiussione). Se concesso il sequestro, i beni restano vincolati e non alienabili, quindi di fatto l’azienda è come se li avesse pignorati già. Bisogna quindi combattere sul piano cautelare con serie argomentazioni (e il giudice spesso chiede al creditore una controgaranzia, una cauzione, per procedere al sequestro – a volte ciò dissuade azioni temerarie).
Istanza di Fallimento (Liquidazione Giudiziale)
La misura più drastica che un creditore possa prendere è chiedere la liquidazione giudiziale dell’azienda (quella che sotto la vecchia legge si chiamava “istanza di fallimento”). Questa non è un’esecuzione su un singolo bene, ma su tutto il patrimonio, con l’effetto di espropriare l’imprenditore dalla gestione e affidare i beni a un curatore per liquidarli a favore di tutti i creditori. In sostanza, è un’azione collettiva.
Presupposti: Un creditore può presentare istanza se: – Il credito è certo, scaduto ed esigibile (basta anche una singola fattura incontestata, se non pagata da tempo; tipicamente però i creditori allegano un decreto ingiuntivo o titolo esecutivo, ma non è strettamente necessario averlo). – Il debitore si trova in stato di insolvenza. Ciò significa incapacità strutturale di adempiere regolarmente alle obbligazioni. Di solito il creditore prova l’insolvenza elencando vari inadempimenti, protesti, pignoramenti non fruttuosi, ecc. Anche il mancato pagamento del singolo credito può bastare se inserito in un quadro di difficoltà conclamata.
Procedura: Il tribunale, ricevuta l’istanza, convoca l’azienda debitrice in camera di consiglio. L’azienda può difendersi depositando memorie e comparendo all’udienza con un avvocato. – Se il tribunale accerta l’insolvenza, emette la sentenza di liquidazione giudiziale (fallimento), nominando il curatore ecc. Se invece ritiene l’insolvenza non provata, rigetta l’istanza (magari condannando il creditore alle spese). – L’azienda ha possibilità, nel frattempo, di evitare la dichiarazione di fallimento intraprendendo una procedura alternativa: presentando, ad esempio, un ricorso per concordato preventivo prima che il tribunale decida. In tal caso, la legge (art. 49 CCII) dispone che l’istanza di fallimento rimanga sospesa in attesa di vedere come procede il concordato. Se poi il concordato viene ammesso e omologato, la richiesta di fallimento decade . Questa è una forma di coordinamento: il concordato preventivo ha priorità come soluzione perché mira alla continuazione aziendale (il sistema favorisce le soluzioni di risanamento rispetto alla liquidazione forzata) . Tuttavia, se il concordato proposto fosse palesemente irrealistico o fatto solo per prendere tempo, il tribunale può revocare la procedura concordataria per abuso e riprendere l’istanza di fallimento. – Un’altra opzione è che il debitore paghi il creditore istante prima dell’udienza, ottenendo la rinuncia all’istanza. Ma attenzione: pagare un creditore istante isolatamente mentre si è insolventi può configurare una preferenza vietata se poi comunque si fallisce (il curatore potrebbe agire in revocatoria contro quel pagamento privilegiato). Tuttavia, se quel pagamento evita il fallimento e poi l’azienda risana, è un rischio calcolato.
Difese nel merito: L’azienda, per evitare il fallimento, può sostenere: – Insussistenza dell’insolvenza: ad esempio producendo un piano finanziario, prospettando entrate imminenti (contratti firmati con clienti, aumento di capitale sottoscritto dai soci, ecc.), e dichiarando di essere disposta a pagare tutti se le viene dato tempo. Se il tribunale crede alla temporaneità delle difficoltà, può rinviare o rigettare. A volte, le prassi dei tribunali consentono di concedere un breve rinvio (qualche settimana) se il debitore dice di avere una trattativa di finanziamento in corso che risolverebbe tutto. – Inammissibilità giuridica: l’azienda può eccepire di non essere soggetta a fallimento (ad esempio perché è piccolo imprenditore sotto le soglie: fatturato sotto 200.000 €, attivo sotto 300.000 e debiti sotto 500.000, cumulativamente – criteri ex art. 2 CCII ). Oppure può eccepire un vizio procedurale nella notifica dell’istanza. – Composizione negoziata: dal 2022 esiste un meccanismo per cui, se l’imprenditore ha avviato una composizione negoziata della crisi, può chiedere al tribunale di sospendere le istanze di fallimento pendenti, in attesa dell’esito delle trattative (fino a 4+4 mesi). Questo per incoraggiare il risanamento. Deve essere chiesto formalmente e l’azienda deve dimostrare la serietà del percorso intrapreso.
Se, nonostante tutto, viene dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale), l’azienda perde il controllo: gli amministratori decadono, subentra il curatore, l’attività di impresa generalmente cessa (salvo esercizio provvisorio se autorizzato per salvare valore), e i beni vengono liquidati per pagare i creditori secondo la graduatoria. Dal punto di vista del debitore, a quel punto non c’è più “difesa”: subentra la gestione della procedura concorsuale dove semmai il debitore collabora per minimizzare i danni (ad esempio proponendo un concordato fallimentare, oppure cercando intese per rilevare l’azienda dal fallimento attraverso terzi).
In sintesi: L’istanza di liquidazione giudiziale è il pericolo maggiore per l’azienda indebitata, perché ne sancisce la fine come entità economica autonoma. Difendersi significa anticiparla – prevenire che i creditori arrivino a quel punto – e se arriva, mettere in campo rapidamente un’alternativa concorsuale (concordato, accordo omologato) che rassicuri i giudici e i creditori sul fatto che esiste un modo migliore per soddisfare tutti rispetto alla distruzione del valore aziendale. Nei prossimi capitoli vedremo proprio questi strumenti alternativi di regolazione della crisi che il debitore può attivare.
Strumenti di Gestione e Ristrutturazione del Debito (Italia 2025)
Quando l’indebitamento di un’azienda diventa insostenibile con i soli mezzi ordinari (utili di esercizio o piccole dilazioni concordate informalmente), è il momento di ricorrere agli strumenti straordinari di ristrutturazione previsti dalla legge. L’ordinamento italiano, specialmente dopo la riforma introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) in vigore dal luglio 2022, mette a disposizione diverse procedure concorsuali o para-concorsuali che consentono di gestire la crisi in modo ordinato e con effetti legali protettivi. Tali strumenti, se utilizzati correttamente, possono evitare la liquidazione giudiziale e preservare la continuità aziendale, sia tramite accordi con i creditori, sia attraverso piani di risanamento.
In questa sezione illustreremo i principali meccanismi di risanamento del debito aziendale: – Il piano di risanamento attestato (strumento contrattuale privato con attestazione di un professionista). – Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (accordi omologati dal tribunale con una parte dei creditori, secondo varie tipologie). – Il concordato preventivo (procedura concorsuale giudiziale con coinvolgimento di tutti i creditori, in continuità aziendale o liquidatorio). – La nuova composizione negoziata della crisi (procedura stragiudiziale assistita da un esperto, finalizzata a individuare una soluzione, che può sfociare in accordi o concordato). – Altri istituti speciali, come il concordato semplificato post-negoziazione e la liquidazione controllata (per debitori non fallibili), che però riguardano più le micro-imprese o situazioni particolari.
Per ciascun strumento, vedremo quando usarlo, quali vantaggi offre (es. sospensione delle azioni esecutive, taglio dei debiti, ecc.) e quali condizioni/requisiti lo governano. È importante notare che spesso tali procedure richiedono l’intervento di figure specializzate (professionisti attestatori, esperti negoziali) e il controllo del tribunale, pertanto vanno affrontate con preparazione tecnica e con la consapevolezza che comportano costi e vincoli, ma in cambio offrono la possibilità di risolvere definitivamente l’indebitamento in eccesso.
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento di natura privata: consiste in un piano industriale e finanziario predisposto dall’impresa in crisi, volto a riequilibrarne la situazione, che viene sottoposto alla verifica di un professionista indipendente (attestatore). Se il professionista attesta che il piano è idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a assicurare la continuità aziendale, il piano produce effetti protettivi specifici: in particolare, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano non potranno essere soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . Questo scudo revocatorio è il principale beneficio di un piano attestato.
Caratteristiche salienti: – Volontario e contrattuale: Non c’è coinvolgimento del tribunale (se non eventuale registrazione della data di pubblicazione nel registro imprese di un eventuale accordo finanziario allegato). L’azienda negozia con i suoi creditori in modo puramente stragiudiziale. Il successo dipende dalla volontà di adesione di ciascun creditore: il piano attestato non è vincolante per i dissenzienti. Ogni creditore deve accettare individualmente la ristrutturazione proposta (dilazioni, rinunce parziali, ecc.). – Attestazione obbligatoria: Un professionista (revisore o esperto ex art. 2 CCII) redige una relazione in cui dichiara la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento. Questa relazione è cruciale per dare credibilità al piano verso i creditori e per attivare le protezioni legali. – Nessuna percentuale minima di adesione richiesta: A differenza degli accordi e concordati, qui non c’è una soglia legale di consensi. In teoria, il piano potrebbe coinvolgere anche solo alcuni creditori (ad es. le banche principali) e lasciarne fuori altri. Tuttavia, un piano che non includa la totalità dei creditori rilevanti è fragile: i non aderenti potrebbero agire esecutivamente e farlo fallire. Quindi nella prassi l’azienda cerca di includere nel piano tutti (o la stragrande maggioranza) dei creditori, soprattutto quelli strategici. – Segretezza/riservatezza: Il piano attestato non richiede pubblicità (se non facoltativa per opponibilità ai terzi). Molte imprese preferiscono questa via proprio per evitare lo stigma di un “concordato” pubblico. Si può negoziare sotto traccia con i creditori e, una volta ottenute le adesioni, avere il piano formalizzato. Ciò minimizza l’impatto su fornitori e clienti, che magari neppure vengono a conoscenza della crisi. – Nessun “freeze” automatico: Di contro, il piano attestato non offre di per sé alcuna sospensione legale delle azioni esecutive. Se un creditore non collabora e vuole pignorare, non c’è uno strumento giuridico che glielo impedisca (a meno di chiedere misure protettive ex altre procedure). Questo è un limite: per attuare un piano attestato serve un certo “ordine” tra i creditori, spesso garantito dal fatto che tutti quelli principali aderiscono e magari la banca concede nuova finanza con priorità (anch’essa protetta da esenzione revocatorie).
Quando usarlo: Un piano attestato è indicato quando: – La crisi è ancora affrontabile in modo consensuale con i principali creditori, senza necessità di imporre sacrifici coattivi alle minoranze. – L’azienda ha prospettive concrete di risanamento e continuità, magari con qualche intervento (nuovi capitali, dismissione di rami d’azienda, ecc.), su cui un attestatore può esprimersi positivamente. – Si vuole evitare la pubblicità e la rigidità delle procedure giudiziali. – Esempio tipico: PMI manifatturiera con debiti bancari e fornitori ingenti ma gestibili: si redige un piano in cui i soci apportano liquidità, le banche allungano i mutui e rinunciano a parte degli interessi, i fornitori strategici accettano pagamenti dilazionati, l’azienda vende un immobile non strumentale per fare cassa. L’attestatore verifica che, così facendo, entro 5 anni l’azienda torna in equilibrio. I creditori aderiscono perché preferiscono recuperare in parte col piano piuttosto che rischiare un default. Nessun tribunale è coinvolto; gli atti compiuti (tipo l’accensione di nuove ipoteche a garanzia delle banche che finanziano la ripresa, o pagamenti anticipati a fornitori critici) non saranno revocabili se poi malauguratamente si fallisse.
Documentazione: Il piano deve essere completo e dettagliato: situazione economico-patrimoniale aggiornata, cause della crisi, misure previste (taglio costi, aumento ricavi, ristrutturazione debiti), piano finanziario su 2-5 anni con proiezione flussi di cassa e indicatori. L’attestatore deve avere accesso a tutti i dati e redige la relazione di attestazione, da allegare al piano firmato. Generalmente si chiede ai creditori di sottoscrivere accordi bilaterali (es. standstill e poi rimodulazione del debito secondo il piano).
Limiti: Il piano attestato non permette di alterare unilateralmente i diritti dei creditori: se uno non ci sta, resta fuori col suo diritto integro. Inoltre, non consente di “stralciare” crediti privilegiati come quelli tributari se non pagando integralmente la parte di privilegio (il Fisco ad esempio, fuori da procedure omologate, non può accettare rinunce su IVA o ritenute per legge, potrebbe solo dilazionare). Quindi, se ci sono grossi debiti fiscali da ridurre, il piano attestato potrebbe non bastare. In tal caso si valuta l’accordo di ristrutturazione o il concordato.
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono il passo successivo al piano attestato quando serve la forza del tribunale per dare efficacia generale e protezione dalle minoranze dissenzienti. In sostanza, sono accordi negoziati con una parte significativa di creditori che vengono poi omologati dal tribunale, acquistando efficacia anche verso eventuali creditori non aderenti. Introdotti nel 2005 (art. 182-bis Legge Fallimentare) e oggi disciplinati dagli artt. 57-64 CCII, rappresentano una soluzione intermedia tra il piano privatistico e il concordato preventivo .
Il CCII prevede tre tipologie principali di accordi di ristrutturazione : 1. Accordo ordinario (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dell’ammontare totale dei crediti dell’impresa . È la forma standard, sostanzialmente analoga al vecchio 182-bis L.F. Una volta che i creditori rappresentativi di questa maggioranza qualificata firmano l’accordo, esso viene sottoposto al tribunale per l’omologazione. Con l’omologa, l’accordo diviene vincolante per tutti i creditori aderenti e anche per quelli estranei, purché questi ultimi vengano integralmente pagati entro 120 giorni dall’omologa (se già scaduti) o dalla scadenza naturale del credito . Durante il processo di omologa, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive (automatic stay) per sospendere azioni esecutive . Questo tipo di accordo è indicato quando si riesce a ottenere il consenso della stragrande maggioranza dei creditori (60% è una soglia elevata) e si hanno risorse per pagare per intero i pochi eventuali estranei in tempi brevi. 2. Accordo agevolato (art. 60 CCII): è una variante che abbassa la soglia di adesione al 30% dei crediti . Pensato per le imprese che non riescono a raggiungere il 60%, consente di chiudere un accordo con una minoranza qualificata di creditori. Tuttavia, impone condizioni stringenti: (a) niente misure protettive richieste contestualmente – quindi durante le trattative e fino all’omologa l’azienda non è protetta da esecuzioni (un trade-off: soglia più bassa ma nessun automatic stay); (b) pagamento integrale e immediato dei creditori estranei all’accordo . In altre parole, chi non aderisce deve essere soddisfatto al 100% prima o al più tardi contestualmente all’omologazione, con risorse esterne o dell’impresa. Questo significa che l’accordo agevolato è fattibile solo se l’impresa ha liquidità sufficiente o supporto finanziario per liquidare tutti i dissenzienti. È adatto per situazioni dove c’è un gruppo ristretto di creditori con cui ristrutturare (es. le banche) mentre gli altri debiti sono pochi e si riescono a pagare cash. Vantaggio: non c’è udienza di omologa per misure protettive, il che può velocizzare i tempi, e la soglia del 30% lo rende accessibile; però il rischio è che nel frattempo un estraneo possa iniziare azioni (che comunque verranno estinte quando lo si paga per intero all’omologa). 3. Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): è una novità ispirata alla direttiva UE 2019/1023. Consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti a determinate categorie omogenee, purché all’interno di ciascuna categoria l’accordo sia stato approvato da almeno il 75% dei crediti di quella categoria (soglia ridotta al 60% se l’accordo è preceduto da composizione negoziata ). In pratica, il debitore può suddividere i creditori in classi (ad esempio: banche chirografarie in una classe, fornitori chirografari in un’altra, fornitori strategici in un’altra, ecc. in base a posizione giuridica e interesse economico omogeneo) . Se in una classe si ottiene il 75% di consensi, l’accordo omologato sarà efficace anche nei confronti del restante 25% dissenziente di quella classe . Questa è una forma di cram-down settoriale, molto utile per superare l’opposizione di piccole minoranze di creditori (tipicamente finanziari) che potrebbero bloccare la ristrutturazione. Condizioni: le classi devono essere formate correttamente, rispettando la parità di trattamento intra-classe e la diversità di posizione tra classi; e per i non aderenti “crammed-down” va rispettato il best interest test, cioè non possono ricevere meno di quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale . Inoltre, originariamente questa efficacia estesa era limitata ai piani in continuità, ma una modifica del 2023 l’ha estesa anche a piani liquidatori purché oltre la metà dei debiti sia verso banche/finanziatori (indice che è pensata soprattutto per ristrutturare debiti finanziari). L’accordo ad efficacia estesa di fatto crea un meccanismo simile al concordato preventivo in termini di vincolo anche sui dissenzienti, ma rimane tecnicamente un accordo negoziale (ha bisogno comunque del 75% in ogni classe: se c’è una classe dove ciò non si raggiunge, i creditori di quella classe restano fuori e vanno pagati integrali entro 120 giorni come estranei).
Procedimento di Omologazione: Per qualunque accordo (ordinario, agevolato, esteso) il procedimento prevede: – Deposito del ricorso in tribunale con allegati il testo dell’accordo sottoscritto dai creditori aderenti, il piano economico-finanziario che lo supporta, le attestazioni di un professionista sull’idoneità del piano a risanare l’impresa e sulla solvibilità verso i creditori estranei (nonché l’attestazione speciale sulla convenienza per il Fisco se c’è transazione fiscale con falcidia) . Per gli accordi con efficacia estesa, serve dimostrare il rispetto delle condizioni di legge (classi omogenee, percentuali raggiunte, ecc.). – Il tribunale verifica la regolarità e può concedere subito le misure protettive su richiesta (tranne che nell’accordo agevolato, dove non è permesso) . Le misure protettive, se concesse, sospendono tutte le azioni esecutive dei creditori sul patrimonio del debitore durante le trattative e fino all’omologazione (in genere per max 4 mesi prorogabili di 4) . La stragrande maggioranza delle imprese in crisi ne fa richiesta: nel report 2025 risulta che circa il 78% delle imprese che hanno avviato procedure di composizione hanno richiesto misure protettive per tutelare il patrimonio durante le trattative . – Se ci sono creditori non aderenti, essi vengono informati e possono proporre opposizione all’omologazione entro 30 giorni dal deposito del ricorso (per gli estranei che ricevono un trattamento differente) . Le opposizioni possono lamentare: violazione di legge, convenienza insufficiente (ad es. un creditore dissenziente dice “col fallimento prenderei di più di quanto mi offrono nell’accordo”), irregolarità nel quorum, ecc. . Il tribunale fissa udienza per discutere eventuali opposizioni e poi decide. – Criterio di giudizio: il tribunale omologa l’accordo se ritiene che il piano è idoneo a superare la crisi e che i creditori estranei verranno integralmente soddisfatti nei termini previsti . In pratica, se le opposizioni non dimostrano seri rischi e i requisiti formali sono a posto, l’omologa viene concessa anche in presenza di qualche dissenso. La legge infatti incoraggia il giudice a privilegiare la riuscita dell’accordo se esso appare solido e rispettoso dei diritti essenziali dei non aderenti (nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione ). – Riguardo ai creditori pubblici (Fisco e INPS) dissenzienti, come già trattato, dal 2023 il giudice può omologare ugualmente imponendo la transazione fiscale se la proposta soddisfa le soglie minime (30-40%) e il piano non è liquidatorio . Questa è una novità di enorme rilievo: in passato bastava il “no” dell’Erario per affossare l’accordo, ora non più (purché l’azienda offra almeno quel minimo legale e rispetti la convenienza ex art. 63 CCII) . – Se tutto è in regola, il tribunale pronuncia il decreto di omologazione dell’accordo .
Effetti dell’omologazione: – I creditori aderenti sono definitivamente vincolati al nuovo accordo. Le condizioni concordate (riduzioni, dilazioni) sostituiscono le obbligazioni originarie . Ad esempio, un fornitore aderente che vantava 100.000 € da subito e ha accettato 80.000 € in 24 mesi, dopo l’omologa potrà pretendere solo 80.000 € alle scadenze pattuite . Se aveva garanzie reali o personali, di solito restano in essere ma adeguate al nuovo credito ridotto . – I creditori non aderenti (estranei) formalmente conservano i loro diritti per intero, ma l’accordo omologato impone di soddisfarli entro un certo termine (max 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza originaria) . Finché quel termine non scade, tali creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali . Si configura una sorta di “moratoria legale”: il creditore estraneo deve attendere. Se poi il debitore non lo paga entro i 120 giorni, allora potrà attaccare (e probabilmente a quel punto l’accordo fallirà). Ma fintantoché il debitore rispetta il piano e li paga nei termini previsti, non possono fare nulla autonomamente. – Per i creditori dissentienti inclusi per efficacia estesa, l’effetto è simile ai non aderenti: non potranno agire e dovranno accettare quanto l’accordo prevede per la loro classe, senza però essere “aderenti” volontari. Essi vengono soddisfatti come da piano e non oltre, quindi di fatto subiscono una falcidia o dilazione contro la loro volontà, ma resa legittima dall’omologa. Hanno comunque diritto di opporsi prima se ritengono violato il best interest test. – L’accordo omologato è pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia verso tutti. Se l’imprenditore non adempie agli obblighi dell’accordo, i creditori possono chiedere la risoluzione dell’accordo e a quel punto presentare istanza di fallimento immediatamente (l’inadempimento dell’accordo è un fattore di insolvenza conclamata, salvo si rimedi con altro accordo o concordato in extremis).
Vantaggi dell’accordo di ristrutturazione: – Flessibilità contrattuale: pur essendo sotto omologa giudiziale, l’accordo rimane un contratto tra debitore e creditori: le parti hanno ampia libertà di prevedere soluzioni creative (conversione di crediti in quote di capitale, assegnazione di beni ai creditori, piani di amortamento personalizzati, ecc.) , con meno rigidità rispetto a un concordato standard. Ad esempio, è possibile pagare certi creditori fuori accordo (purché integrali) e ristrutturarne altri. – Rapidità: spesso l’accordo, non dovendo passare per votazioni in adunanza come il concordato, può essere definito più rapidamente (il tempo dipende dalle trattative ma l’omologa una volta depositato il ricorso può arrivare in pochi mesi se non ci sono opposizioni). – Minor impatto reputazionale: anche se pubblicato, l’accordo viene percepito come un’intesa con i creditori, meno stigmatizzante del “concordato preventivo” che suona più prossimo al fallimento. Inoltre, durante la fase delle trattative protette, l’impresa può mantenere riservatezza (solo eventuali provvedimenti di misure protettive sono pubblici). – Protezione dalle revocatorie: analogamente al concordato, l’accordo omologato impedisce azioni revocatorie fallimentari su pagamenti/garanzie effettuati in esecuzione dell’accordo. – Cram-down del Fisco e delle minoranze: come visto, gli accordi 2023+ permettono di superare anche il veto erariale e di legare minoranze ostili entro certi limiti. Questo li rende strumenti molto potenti per risolvere crisi di aziende medio-grandi con molti creditori.
Svantaggi/limiti: – Soglia di consenso necessaria: il 60% (o 30% negli agevolati con però pagamento integrale degli altri) richiede comunque di convincere un numero significativo di creditori. Non è uno strumento utilizzabile se c’è una frammentazione di piccoli creditori tutti ostili, o se ci sono creditori determinanti che non vogliono aderire e non li si può pagare fuori. – Costo e complessità: bisogna predisporre un piano di ristrutturazione ben dettagliato, nominare un attestatore per la relazione di fattibilità, pagare i professionisti legali e finanziari coinvolti, e seguire un iter giudiziale (seppur semplificato). Per una micro impresa potrebbe essere sproporzionato. – Nessun esdebitamento finale per l’imprenditore: a differenza delle procedure di sovraindebitamento personali dove c’è l’esdebitazione del debitore persona fisica a fine procedura, qui l’accordo riguarda la società: se poi non tutto viene pagato come da accordo e si finisce in liquidazione, non c’è remissione automatica residua (il concetto di esdebitazione può riguardare l’imprenditore individuale post liquidazione controllata, ma non una società che se fallisce viene estinta). – Impegno contrattuale rigoroso: una volta omologato, l’accordo va rispettato puntualmente. Se il debitore sgarra, i creditori tornano liberi e spesso più aggressivi di prima (perché magari hanno rinunciato a qualcosa contanto sul rispetto del piano). Quindi il margine di errore dopo l’omologa è minimo.
Esempio pratico (caso ipotetico): Beta S.r.l. ha 10 milioni di debiti: 5 con banche, 2 con Fisco/INPS, 3 con fornitori. Banche e fornitori sono disponibili a un accordo, il Fisco è incerto. Beta propone: le banche prorogano le scadenze e riducono il tasso, i fornitori accettano il 80% del credito in 2 anni, il Fisco ottiene 40% del suo credito in 6 anni (falcidiando sanzioni). Il tutto supportato da un piano industriale di rilancio e da 1 milione di nuova finanza dai soci (che va a pagare i creditori estranei). Banche, fornitori e INPS aderiscono coprendo il 75% dei crediti totali – il Fisco (25%) non aderisce. Si deposita accordo ex art.61 CCII con classi: classe banche 80% consensi, classe fornitori 85% consensi, classe erario 0% (non aderisce). Ma poiché altre classi superano 75% e l’erario rappresenta il 25%, con la nuova norma il tribunale può omologare comunque imponendo la falcidia fiscale (piano in continuità, soglia 40% offerta = ok) . L’accordo viene omologato: banche e fornitori vincolati alle nuove condizioni, il Fisco dovrà accontentarsi del 40% in 6 anni (cram-down) e non può procedere (purché Beta paghi puntuale). Beta S.r.l. evita il fallimento e prosegue l’attività, con debito ridotto e dilazionato. Se Beta non pagasse il Fisco come da accordo, l’erario potrebbe poi agire, ma Beta avrebbe nel frattempo migliorato i conti e potrebbe reggere o trovare altro accordo.
Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale classica in cui l’imprenditore in crisi propone a tutti i creditori un piano di regolazione del debito sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione giudiziale. A differenza degli accordi, il concordato coinvolge la totalità dei creditori (anche se suddivisi eventualmente in classi) e l’omologazione si basa sul voto dei creditori, non solo su adesioni contrattuali. Il concordato può prevedere la continuità aziendale (cioè l’impresa prosegue, eventualmente ristrutturata) oppure la liquidazione dell’attivo (concessione di beni a terzi) – con differenze normative tra i due casi.
Tipologie principali: – Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): Il piano concordatario prevede che l’azienda continui l’attività, sia essa la stessa impresa (continuità diretta) sia tramite cessione o conferimento a un altro soggetto che la prosegue (continuità indiretta, es. affitto d’azienda e successiva vendita). Il fulcro è che i creditori verranno soddisfatti col ricavato della prosecuzione del business, oltre che con eventuali apporti, e non solo con la liquidazione dei beni attuali. La legge privilegia il concordato in continuità con alcune agevolazioni: ad es. soglie di soddisfacimento dei chirografari meno rigide (non c’è percentuale minima garantita per legge, mentre nel concordato liquidatorio puro serve almeno 20%) . Inoltre, in continuità, è possibile il pagamento parziale dei creditori privilegiati se essenziale per la continuità e se ottengono non meno del ricavabile in liquidazione (ciò grazie alle novità del 2022). Si possono anche trattare i contratti pendenti per mantenerli attivi ecc. – Concordato liquidatorio: Il piano mira a liquidare tutto il patrimonio aziendale (vendere beni, crediti, ecc.) e ripartire il ricavato tra i creditori, offrendo però ad essi un quid pluris rispetto alla liquidazione giudiziale. La legge richiede che nel concordato liquidatorio i creditori chirografari ottengano almeno il 20% dei loro crediti (soglia introdotta nel CCII) a meno che un apporto di finanza esterna aumenti significativamente il soddisfacimento. Inoltre, una novità del 2021 è il concordato semplificato per la liquidazione: riservato al caso in cui una composizione negoziata fallisce, l’imprenditore può chiedere un concordato liquidatorio senza voti dei creditori (sarà il tribunale a valutare e decidere) – ma è una fattispecie eccezionale. – Concordato misto: Spesso i piani sono ibridi (parte continuità, parte dismissioni). Ad es. vendere un ramo d’azienda non strategico e continuare col core business, oppure proseguire l’attività per tot anni e poi liquidare i beni restanti. La distinzione formale serve per capire quali regole applicare: se c’è una continuità significativa, il concordato è trattato come in continuità.
Procedura in breve: – L’impresa deposita ricorso per concordato con il piano, la proposta ai creditori e tutta la documentazione (bilanci, elenco creditori, relazione attestatore, ecc.). Può anche iniziare con un ricorso “in bianco” (concordato con riserva, art. 44 CCII) cioè senza piano completo, ottenendo subito protezione e un termine (da 60 a 120 giorni prorogabili) per presentare il piano definitivo. – Il tribunale verifica i requisiti formali e ammette la procedura, nominando un commissario giudiziale (figura di controllo). Da quel momento, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive (c’è una sospensione generale) e i contratti in corso proseguono regolarmente (salvo eccezioni). L’azienda continua a operare sotto la vigilanza del commissario e necessita di autorizzazione del giudice per atti straordinari. – I creditori vengono informati e convocati all’adunanza dei creditori. Prima dell’adunanza, presentano al commissario le proprie insinuazioni (domande di ammissione del credito nello stato passivo del concordato). Nell’adunanza (o anche per via telematica prima/dopo) i creditori votano sulla proposta concordataria. Per l’approvazione, se non ci sono classi distinte, serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se ci sono più classi di creditori, serve il sì della maggioranza dei crediti in ciascuna classe (o almeno in la maggioranza delle classi e nessuna classe dissenziente pregiudicata oltre certi limiti, con possibili cram down di classi dissenzienti se il piano è equo e ragionevole secondo l’art. 112 CCII). – Se i creditori approvano, il tribunale passa alla fase di omologazione: verifica il rispetto di legge (ad es. che i creditori dissenzienti prendano almeno quanto in liquidazione, etc.) e omologa con decreto. I creditori e altri interessati possono fare opposizione (reclamo) se ritengono lesi i loro diritti, ma se la maggioranza ha votato sì, di norma l’omologa segue a meno di vizi. – Se i creditori bocciano (mancata maggioranza), il concordato non è approvato e l’azienda di solito viene dichiarata in liquidazione giudiziale subito (salvo che abbia presentato contestualmente un accordo di ristrutturazione con sufficienti adesioni, ipotesi rara). – Una volta omologato, il concordato viene eseguito sotto il controllo del commissario che diventa liquidatore giudiziale (se ci sono beni da liquidare) o supervisore della continuità. – A esecuzione completata (pagamento delle percentuali promesse), l’azienda ottiene l’esdebitazione residua (nel senso che i creditori chirografari non possono più pretendere oltre quanto ricevuto, anche se era una percentuale ridotta).
Vantaggi del concordato: – Coinvolgimento universale: Si possono regolare i debiti verso tutti i creditori in un colpo solo, anche contro la loro volontà, grazie alla forza della maggioranza e all’omologa. Ciò include anche il taglio di debiti fiscali (previa transazione ex art. 63, soggetta oggi a cram down se Erario dissente ma soglie rispettate, simile agli accordi) . – Protezione massima: Dalla presentazione della domanda (anche in bianco) c’è il blocco delle esecuzioni. L’azienda può operare in un regime di sospensione di pagamenti pregressi e in “respiro” per attuare il risanamento. Ad esempio, si possono sospendere temporaneamente anche i contratti onerosi con autorizzazione del tribunale, o scioglierli pagando indennizzo, se non servono al piano. – Possibilità di finanza interinale e prededucibile: Nel concordato, l’azienda può ottenere nuova finanza (prestiti) o continuare rapporti essenziali (forniture) con la garanzia che i nuovi crediti sorti durante la procedura saranno prededucibili (pagati prima degli altri) . Questo aiuta a reperire risorse fresche per il rilancio. – Gestione controllata ma non completamente sottratta: A differenza del fallimento dove arriva un curatore esterno, nel concordato in continuità gli amministratori restano in carica e gestiscono, sebbene sotto la vigilanza del commissario e con poteri limitati sugli atti straordinari. Ciò conserva know-how e rapporti, utili per salvare l’impresa. (Nel concordato liquidatorio invece spesso l’impresa cessa subito e la liquidazione passa al liquidatore nominato). – Esdebitazione della società (di fatto): Se il concordato va a buon fine, la società riparte pulita dai debiti concorsuali insoddisfatti (che si estinguono per quanto non pagato). Non c’è un formale provvedimento di esdebitazione perché la società continua, ma di fatto i creditori chirografari perdono il diritto alla parte eccedente la percentuale concordataria.
Svantaggi: – Procedura complessa e pubblica: Il concordato è gravoso: richiede preparazione di un piano dettagliato, la nomina obbligata di un attestatore indipendente, spese legali e amministrative considerevoli, e tempi procedurali (qualche mese per la votazione, poi eventuali opposizioni). Inoltre, la notizia diventa di dominio pubblico, con possibili impatti negativi su reputazione, fiducia di clienti/fornitori, ecc. Serve una strategia di comunicazione per spiegare che è una ristrutturazione e non la fine (specie nel caso di continuità). – Rigidità e controllo: Ogni mossa fuori dall’ordinario deve passare dal giudice (ad es. vendere un bene, contrarre nuovi prestiti ipotecari, ecc. richiede autorizzazione). Anche gli amministratori rischiano la revoca se mancano ai doveri di trasparenza. La procedura è dunque invasiva (ma per necessità, visto che tutela i creditori). – Esito incerto: Il concordato dipende dal voto dei creditori. Se questi lo ritengono non conveniente, possono bocciarlo. A differenza dell’accordo di ristrutturazione dove il giudice può bypassare minoranze se soglie raggiunte, nel concordato ci vuole comunque la maggioranza (salvo il caso particolarissimo del concordato semplificato post negoziazione, dove il tribunale può omologare senza voto ma solo in quella circostanza straordinaria). Quindi c’è sempre il rischio di spendere sforzi e soldi per predisporre il piano, e vedere i creditori votare contro (magari perché sperano in soluzioni migliori). – Necessità di liquidità per gestione interinale: Durante il concordato, l’azienda deve comunque reggere: pagare i fornitori correnti, i dipendenti correnti, tasse correnti, ecc. Non può aggravare l’esposizione. Se l’attività non genera abbastanza cassa e nessuno finanzia l’interim, si rischia di andare in stallo. Un concordato in continuità senza adeguata cassa è destinato a convertirsì in liquidatorio o fallire. – Vincoli di legge sulle classi e trattamento: Ci sono regole dettagliate su come trattare i crediti (es. i creditori privilegiati vanno pagati integralmente salvo che rinuncino o salvo offerte specifiche se il bene su cui hanno privilegio non copre tutto il loro credito, etc.). Non si ha la libertà contrattuale che c’è in un accordo privato: bisogna rispettare la par condicio all’interno delle classi e certe priorità inderogabili (come che i creditori con privilegio sul bene X prendano quanto quel bene vale, etc.). Quindi l’ingegneria del piano è delicata: non si possono fare disparità ingiustificate senza incorrere in bocciature o censure in omologa.
Concordato e responsabilità degli amministratori: Va menzionato che decidere per tempo un concordato, invece di lasciare incancrenire la situazione, è considerato un dovere degli amministratori in crisi. La Cassazione ha affermato che proseguire l’attività con capitale azzerato senza attivare strumenti di risanamento configura gestione irresponsabile con responsabilità personale ex art. 2486 c.c. . Quindi paradossalmente, avviare un concordato per risanare può proteggere gli amministratori da accuse future di aver aggravato il dissesto: dimostra che hanno tentato di salvare l’impresa nei modi previsti dalla legge (questo non li esime da responsabilità se il piano era infattibile e solo dilatorio, ma li pone nella condotta diligente se effettivamente c’era una chance ragionevole).
Integrazione con composizione negoziata: Oggi un percorso virtuoso spesso suggerito è: crisi iniziale -> attivare la composizione negoziata (ne parliamo tra poco) -> se non si trova accordo stragiudiziale, utilizzare l’esito delle trattative per predisporre un concordato “su misura” con già il consenso informale di vari creditori. Così il concordato ha più chance di essere approvato. Inoltre, il CCII prevede qualche premialità se il concordato è frutto di composizione negoziata: p.es. riduzione maggioranze in classi per cram-down fiscale, come visto .
Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi
Introdotta col D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) e ora disciplinata nel CCII, la composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale di allerta e gestione assistita della crisi. Non è una procedura concorsuale in sé, ma un percorso in cui l’imprenditore, riconoscendo di trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, chiede l’ausilio di un esperto indipendente per tentare di raggiungere un accordo con i creditori e risanare l’impresa .
Caratteristiche: – Accesso su istanza dell’imprenditore: Si accede presentando istanza via piattaforma telematica (gestita dalle Camere di Commercio) con allegati gli elementi sull’attività e sulla situazione di crisi. Non serve essere già insolventi, basta uno stato di crisi o anche solo di difficoltà prospettica. In pratica è uno strumento di prevenzione: si può attivare ai primi segnali di tensione, senza attendere l’insolvenza conclamata. – Nomina dell’esperto: Un’apposita commissione nomina un esperto (di norma un commercialista, avvocato o consulente d’azienda con formazione sulla crisi) che agirà da facilitatore nelle trattative. L’esperto esamina l’azienda, convoca il debitore e in seguito i creditori principali per iniziare un dialogo. L’esperto non impone decisioni, ma media e suggerisce soluzioni, verificando la percorribilità del risanamento. – Riservatezza: La procedura è tendenzialmente riservata. La sua apertura non è pubblicata (salvo che l’imprenditore chieda misure protettive al tribunale, in tal caso il decreto del tribunale è pubblicato). Questo consente di lavorare “dietro le quinte” senza allarmare l’ambiente esterno. – Misure protettive e cautelari: L’imprenditore può chiedere al tribunale di disporre la sospensione delle azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative (in genere 4 mesi prorogabili di altri 4) . Il tribunale, verificati i presupposti (p.es. che la situazione non sia manifestamente compromessa e che ci sia possibilità di successo), concede le misure protettive, che vengono pubblicate (quindi i creditori tutti ne vengono a conoscenza). Da quel momento, nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti, né acquisire titoli di prelazione (no ipoteche volontarie su beni del debitore, ecc.). Ciò crea un periodo di tregua in cui concentrarsi sulle trattative. – Ruolo dell’esperto: L’esperto, nominato, verifica l’andamento e deve redigere relazioni periodiche. Può convocare le parti, fare proposte, ma non ha poteri coercitivi. Se il debitore non collabora in buona fede o occulta informazioni, l’esperto può interrompere la procedura. Allo stesso modo, se i creditori chiamati al tavolo rifiutano ogni negoziazione, l’esperto può concludere negativamente. Se invece intravede soluzioni, le incentiva. Può suggerire di percorrere strumenti come accordi, concordati o anche soluzioni extra-giudiziali (es. aumenti di capitale, ingresso di investitori, cessione di asset). – Esito: La composizione negoziata può portare a vari risultati: – Accordo stragiudiziale semplice: l’imprenditore e alcuni creditori trovano un’intesa privata (per esempio, un riscadenzamento dei debiti, magari assistito da nuove garanzie). L’esperto conclude la sua funzione con esito positivo e redige una relazione finale. L’accordo può rimanere riservato o essere eventualmente formalizzato con atti (tipo moratorie, nuovi contratti) ma non passa per tribunale. – Accordo di ristrutturazione ex art.57: se le trattative portano a raccogliere adesioni di oltre 60% dei crediti, si può formalizzare un accordo di ristrutturazione dei debiti e sottoporlo a omologa. La composizione negoziata confluisce così in quell’istituto, con il vantaggio eventuale di soglie di voto ridotte per efficacia estesa . – Piano attestato: l’esperto può aiutare a predisporre un piano attestato e convincere i creditori a fidarsi di esso. – Concordato preventivo: se non si riesce a ottenere consensi sufficienti, l’imprenditore può optare per un concordato. In certi casi, esiste anche la possibilità di un “concordato semplificato” (se l’esperto attesta che nessuna altra soluzione è praticabile), con cui il debitore chiede al tribunale l’omologazione di un concordato liquidatorio senza passare per il voto dei creditori. Questo concordato semplificato per la liquidazione è una novità introdotta per evitare il fallimento quando la negoziata fallisce, ma richiede che l’esperto concluda che non vi è migliore alternativa e comunque il tribunale valuta che i creditori ricevano almeno quanto in un fallimento. – Abbandono o fallimento: Se l’esperto vede che il risanamento è impossibile (azienda decotta), chiude la procedura. A quel punto l’imprenditore dovrebbe attivarsi per liquidare l’azienda (anche facendo istanza di autofallimento se necessario). Se non lo fa, i creditori potranno ovviamente riprendere le azioni (scaduti i termini protettivi) e/o chiederne il fallimento.
Vantaggi della composizione negoziata: – Tempestività e obbligo di attivazione: Da settembre 2021, grazie anche alla modifica dell’art. 2086 c.c., gli amministratori hanno un preciso dovere di attivarsi senza indugio in caso di crisi . La composizione negoziata è lo strumento disegnato per assolvere a questo dovere in fase precoce: è volontaria (non scatta automaticamente, differenza col vecchio “allerta” obbligatorio che è stato di fatto accantonato), ma fortemente incoraggiata. Consente di affrontare la crisi prima che degeneri, aumentando le probabilità di salvarsi. I dati mostrano un crescente utilizzo: nel 2024, solo in Lombardia, 258 imprese hanno avviato la composizione negoziata (+87% sul 2023) . A livello nazionale dal 2021 a fine 2024 furono 1.723 imprese, di cui il 70% S.r.l. e 18% S.p.A. . Ciò indica che sta diventando uno strumento riconosciuto per PMI e anche aziende più grandi. – Costi relativamente contenuti: L’esperto viene remunerato con compenso stabilito secondo parametri ministeriali (non eccessivo, spesso qualche migliaio di euro, a carico dell’impresa) e non ci sono le spese di una procedura concorsuale lunga. Se si riesce a trovare un accordo privato, si esce in pochi mesi con costi limitati rispetto a concordati o fallimenti. – Flessibilità nelle soluzioni: Non essendo incanalata in regole rigide, la negoziazione può portare a soluzioni tailor-made. Ad esempio, l’azienda potrebbe convincere una banca a concedere nuova finanza super-prioritaria (grazie a possibili incentivi normativi: la legge prevede che i finanziamenti autorizzati durante la composizione negoziata, se l’esperto li ritiene funzionali e il tribunale li “valida”, siano prededucibili ed esenti da revocatoria). Oppure si può ottenere la moratoria di alcuni crediti mentre se ne pagano altri cruciali. – Premialità e protezioni legali: Durante la composizione negoziata, la legge prevede delle tutele per l’imprenditore virtuoso: ad esempio, sospensione di cause per rescissione di contratti (non possono essere risolti contratti essenziali tipo fornitura energia per il solo fatto di aver avviato la procedura), limitazione della possibilità per i finanziatori di revocare fidi solo perché l’azienda è in negoziazione, esonero parziale da responsabilità penale per alcune condotte di pagamento preferenziale se fatte nel contesto della negoziazione autorizzata dall’esperto. Inoltre, l’art. 14 CCII prevede possibili esenzioni da revocatoria per atti compiuti in coerenza col piano di risanamento individuato con l’esperto. Quindi c’è un contesto normativo “protetto” per chi segue l’iter negoziato. – Coinvolgimento di terzi sponsorizzatori: L’esperto può aiutare l’impresa a trovare un investitore o acquirente. Ad esempio, se la continuità è possibile solo cedendo l’azienda a un soggetto più forte, l’esperto può facilitare tale ricerca. Diverse composizioni negoziate si sono concluse con la vendita dell’azienda o l’ingresso di un socio nuovo, evitando il fallimento e salvando l’attività (nel report lombardo 2024, 38 imprese sono state risanate con salvataggio di 2.100 posti di lavoro) .
Limiti: – Non è garantito il successo: È un tavolo di trattativa – se i creditori rifiutano di venire incontro o se la situazione è troppo compromessa, non c’è omologazione che tenga. Può fallire e allora l’azienda avrà solo guadagnato (si spera) un po’ di tempo e di organizzazione, ma dovrà comunque passare a procedure più drastiche. – Richiede collaborazione in buona fede: Sia del debitore (che deve aprire i libri e raccontare la verità) sia dei creditori (che devono accettare di sedersi e discutere piuttosto che agire isolatamente). Non tutti i contesti sono maturi per questo: se ci sono decine di piccoli creditori arrabbiati, è difficile negoziare con tutti. In quei casi la composizione negoziata funziona meglio se il debitore ha pochi creditori principali con cui trovare un’intesa, e gli altri possono essere poi gestiti a traino. – Nessun effetto esdebitativo automatico: La negoziata di per sé non “taglia” debiti. Occorre comunque un accordo concretizzato o una procedura concorsuale. Quindi è un mezzo, non il fine. Se uno spera di uscire dalla crisi solo con la negoziazione ma i numeri non tornano, dovrà concludere con un concordato o accordo formale.
Conclusione di sezione: La scelta tra piano attestato, accordo di ristrutturazione e concordato dipende dallo scenario specifico dell’azienda: – Se si può evitare il tribunale e c’è fiducia tra le parti, il piano attestato è preferibile (meno costi, meno clamore). – Se serve un po’ di forza vincolante ma con flessibilità, l’accordo omologato è l’ideale (specie per medie imprese con poche banche e qualche fornitore grosso). – Se la crisi è molto profonda e diffusa, solo il concordato può imporre sacrifici erga omnes e gestire l’insolvenza in modo ordinato. – In ogni caso, la composizione negoziata è oggi il “filtro” consigliato: provarci per vedere qual è la via di uscita migliore col supporto di un esperto e con la protezione temporanea, prima di lanciarsi in procedure più impegnative.
Tabella 2 – Principali strumenti di regolazione della crisi a confronto
Per facilitare la comprensione, presentiamo una tabella comparativa dei principali strumenti di risanamento:
| Strumento | Cos’è | Consenso richiesto | Ruolo Tribunale | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento <br/>(art. 56 CCII) | Piano di rilancio con accordi privati, attestato da professionista indipendente. | Nessuna soglia legale (accordi individuali con creditori principali). | Nessuna omologa; può essere depositato per data certa ma resta stragiudiziale. | – Riservato (no pubblicità) <br/> – Flessibile nei contenuti <br/> – Protegge da revocatorie gli atti esecutivi del piano . | – Nessun blocco azioni esecutive automatico <br/> – Vincola solo chi aderisce (dissenzienti vanno pagati a parte) <br/> – Necessita alta fiducia tra le parti. |
| Accordo di ristrutturazione ordinario <br/>(art. 57 CCII) | Contratto con una quota qualificata di creditori, soggetto a omologazione. | ≥ 60% dei crediti totali . | Omologato dal tribunale; possibili misure protettive interim . | – Azioni esecutive sospese durante iter (su richiesta) <br/> – Vincola anche creditori non aderenti (purché pagati integralmente entro 120 gg) <br/> – Procedure più snelle del concordato. | – Richiede ampio consenso (60%) <br/> – Creditori estranei da pagare per intero (richiede risorse) <br/> – Se molti piccoli creditori, difficile gestirli fuori accordo. |
| Accordo “agevolato” <br/>(art. 60 CCII) | Variante con soglia ridotta di adesioni, senza stay. | ≥ 30% dei crediti . | Omologazione analoga; no misure protettive consentite . | – Consenso richiesto dimezzato (30%) <br/> – Procedura rapida (niente sospensione = niente udienza di conferma stay) . | – Creditori estranei da pagare integralmente prima/durante omologa (serve liquidità) <br/> – Nessuna tutela contro azioni esecutive durante trattative (rischioso se qualcuno agisce). |
| Accordo ad efficacia estesa <br/>(art. 61 CCII) | Accordo con classi di creditori, efficace anche sui dissenzienti di una classe se c’è larga maggioranza. | ≥ 75% dei crediti in ciascuna classe omogenea (≥ 60% se successivo a composizione negoziata) ; oltre 50% debiti finanziari se piano liquidatorio. | Omologa tribunale, con verifica best interest e correttezza classi . | – Permette cram-down di minoranze dentro una classe (utile contro holdout) <br/> – Ridotte maggioranze (60%) se preceduto da negoziazione assistita . | – Struttura complessa (richiede classi sensate e attestazione convenienza per dissenzienti) <br/> – Procedura e costi quasi da concordato (ma senza voto formale). |
| Concordato preventivo in continuità <br/>(artt. 84-94 CCII) | Procedura concorsuale con prosecuzione dell’attività (diretta o tramite terzi). L’impresa propone un piano a tutti i creditori e lo sottopone al voto. | Voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi (calcolo per teste/valore o per classi a seconda dei casi). | Ammissione + omologazione da parte del tribunale; commissario e giudice delegato vigilano; misure protettive automatiche. | – Coinvolge e vincola tutti i creditori (anche dissenzienti, se maggioranza approva) <br/> – Sospende tutte le azioni esecutive dall’ammissione <br/> – Possibilità di trattamento differenziato classi, continuità operativa, taglio debiti anche fiscali (con transazione) . <br/> – Finanza nuova prededucibile, contratti mantenuti. | – Procedura pubblica e costosa (oneri legali, commissario) <br/> – Necessita votazione creditori (esito incerto) <br/> – Tempi medio-lunghi (diversi mesi) <br/> – Gestione limitata dalla vigilanza giudiziaria (minore autonomia). |
| Concordato preventivo liquidatorio <br/>(art. 84 co. 4) | Concordato che prevede la liquidazione del patrimonio (cessazione attività), con distribuzione ai creditori di quanto ricavato più eventuali apporti esterni. | Come sopra (maggioranza crediti votanti). | Come sopra (commissario, giudice, omologa). | – Consente liquidazione ordinata evitando fallimento <br/> – Possibilità di vendite più vantaggiose (ad es. azienda venduta unita e non spezzettata) <br/> – Richiede comunque 20% minimo ai chirografari (maggior tutela) salvo apporti esterni . | – Implica la fine dell’azienda come entità operativa (perdita continuità) <br/> – Spesso poco gradito ai creditori se percentuali basse (possono preferire fallimento e azioni di responsabilità) <br/> – Tempi di liquidazione possono essere lunghi. |
| Composizione negoziata <br/>(D.Lgs. 118/2021, art. 12-25 CCII) | Procedura volontaria di assistenza alla crisi con esperto indipendente, finalizzata a trovare accordi (stragiudiziali o concorsuali). | Non si basa su consenso di una soglia, ma su trattative facilitate. Può sfociare in accordo o piano con relative soglie. | Tribunale non coinvolto tranne che per concessione misure protettive o autorizzazioni (es. finanziamenti urgenti). | – Approccio precoce e riservato (no stigma) <br/> – Misure protettive possibili (stop azioni per max 8 mesi) <br/> – Esperto neutrale aiuta a trovare soluzioni creative <br/> – Premialità (esoneri responsabilità limitati, riduzione maggioranze in eventuale accordo successivo) . | – Non obbliga i creditori a accordarsi (dipende da buona volontà) <br/> – Successo non garantito, soprattutto se troppi creditori o situazione compromessa <br/> – Se fallisce, rimane solo rinvio a procedure concorsuali o fallimento (anche se si può tentare concordato semplificato per liquidare). |
(Nota: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019. L.F. = legge fallimentare previgente. Cram-down = imposizione coatta a dissenzienti. Prededuzione = pagamento prioritario rispetto ad altri crediti.)
Come si evince dalla tabella, ogni strumento ha la sua “nicchia” di utilizzo. Il piano attestato è informale e funziona se c’è cooperazione; l’accordo di ristrutturazione introduce la mano del giudice quanto basta per vincolare una larga maggioranza e congelare le azioni; il concordato è la soluzione globale e coercitiva se serve un intervento profondo e collettivo; la negoziazione assistita è il preludio ormai consigliato per qualunque opzione, sfruttando la fase protetta per capire quale uscita è praticabile.
Responsabilità degli Amministratori e degli Organi Sociali
Dal punto di vista del debitore, la situazione di crisi non comporta solo problemi verso i creditori, ma innesca anche delicate questioni di responsabilità civile (e talvolta penale) a carico di chi ha gestito la società. Gli amministratori di S.r.l. o S.p.A. hanno precisi doveri legali nella conduzione dell’impresa, che diventano ancora più stringenti in contesti di difficoltà economica. Inoltre, i soci (soprattutto se con ruoli gestori) e i sindaci o revisori possono essere chiamati in causa se non vigilano correttamente.
In questa sezione analizziamo: – I doveri degli amministratori in fase di crisi (assetto organizzativo adeguato e obbligo di attivarsi). – Le possibili azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori da parte di società, creditori o curatore fallimentare, con focus sulle più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno ampliato le ipotesi di responsabilità. – I profili di responsabilità verso il Fisco e gli enti (ad esempio, in caso di violazioni tributarie o contributive). – La responsabilità degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore) e dei soci amministratori di facciata. – I possibili rilievi penali in caso di mala gestio (reati fallimentari, omessi versamenti, false comunicazioni sociali, ecc.) e come evitarli con una gestione trasparente.
L’argomento è cruciale: spesso l’imprenditore si concentra sul “salvare l’azienda” ma deve anche tutelare se stesso da conseguenze personali. La normativa italiana, soprattutto con la riforma della crisi, ha accentuato l’idea che gli amministratori debbano agire tempestivamente e con professionalità per evitare di aggravare la situazione, pena risponderne di tasca propria. Vediamo dunque quali sono le linee di confine tracciate dalla legge e dai tribunali.
Doveri degli Amministratori in Situazione di Crisi
1. Adeguati assetti organizzativi e rilevazione tempestiva della crisi: L’art. 2086 c.c., come modificato dal D.Lgs. 14/2019, impone all’imprenditore (società di capitali in particolare) di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità, nonché di attivarsi prontamente per adottare uno strumento idoneo a superare la crisi . Questo significa che gli amministratori devono predisporre sistemi di controllo interno e pianificazione che permettano di cogliere i segnali di difficoltà (indicatori di bilancio, flussi di cassa prospettici, indici di allerta elaborati dal CNDCEC, ecc.) . Non solo: appena tali segnali indicano che la continuità aziendale è a rischio, gli amministratori sono obbligati ad attivarsi, ossia a studiare e mettere in campo misure correttive o a ricorrere agli strumenti offerti dal diritto concorsuale (composizione negoziata, accordi, concordato, ecc.) . L’obiettivo è prevenire l’aggravamento della situazione – il legislatore vuole evitare che si arrivi al fallimento “al buio” quando ormai è troppo tardi.
Questo dovere generale si concreta in varie azioni pratiche: – Monitorare costantemente la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno su 12 mesi . Se i flussi di cassa previsti indicano tensioni, va predisposto un piano di emergenza. – Rilevare eventuali squilibri (patrimoniali: eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio; finanziari: mancanza di liquidità per fare fronte alle scadenze; economici: perdite rilevanti) e valutarne la natura (temporanei o strutturali) . – Utilizzare strumenti come la lista di controllo particolareggiata e il test pratico di risanabilità predisposti (es. dall’art. 13 CCII, che dà parametri per capire se esiste ragionevole prospettiva di risanamento) . – Coinvolgere subito l’organo di controllo se c’è (sindaci o revisori) informandoli delle difficoltà – loro a loro volta hanno il dovere di segnalare agli amministratori eventuali indizi di crisi non affrontati. – Documentare tutte le iniziative intraprese: convocare CDA e assemblee se necessario (ad esempio, art. 2446-2447 c.c. impongono in S.p.A. di agire su perdite oltre 1/3 capitale; in S.r.l. normative analoghe art. 2482-bis/ter).
In poche parole, l’inerzia non è più consentita: la gestione “a vista”, sperando che le cose migliorino da sole, può integrare violazione di legge.
2. Divieto di aggravare il dissesto – gestione conservativa dopo perdita capitale: Un caso particolare di dovere in crisi è quello previsto dall’art. 2486 c.c.: quando si verifica una causa di scioglimento della società (tipicamente, perdita integrale del capitale per S.r.l./S.p.A.), gli amministratori devono limitarsi a compiere atti di ordinaria amministrazione conservativa e atti urgenti per evitare pregiudizi alla società. Ogni prosecuzione dell’attività che introduca nuovi rischi o nuovi debiti senza adeguata giustificazione può essere considerata illecita. La violazione di questo obbligo comporta che gli amministratori siano responsabili del danno cagionato, quantificato di regola nella perdita ulteriore subita dal patrimonio netto da quando avrebbero dovuto cessare (c’è ora una presunzione legale di danno pari alla differenza tra patrimonio netto alla data della causa di scioglimento e patrimonio netto al fallimento, salvo prova contraria dell’amministratore – art. 2486 comma 3 c.c., introdotto dal Codice della Crisi).
La Cassazione 2024 su questo punto (gestione dopo perdita capitale) è stata netta: continuare ad operare dopo l’azzeramento del capitale sociale senza un concreto piano di risanamento costituisce gestione temeraria e l’amministratore risponde personalmente dell’aggravamento del dissesto . In quel caso, gli amministratori avevano tirato avanti per due esercizi con patrimonio negativo, non convocando l’assemblea né liquidando, e contrassero nuovi debiti per centinaia di migliaia di euro. La Suprema Corte ha affermato il principio: accertata la perdita del capitale, le uniche condotte lecite sono sospendere l’attività o attivare strumenti di risanamento; qualsiasi prosecuzione non giustificata genera responsabilità personale .
Quindi l’amministratore non può più invocare la buona fede (“speravo in una ripresa, volevo salvare l’azienda”) se alla fine ha solo peggiorato il buco: i giudici rileggono questo comportamento come aggravamento colposo o doloso della crisi, e il danno emergente è l’aumento del passivo durante quel periodo . Questo è estremamente rilevante per il nostro imprenditore: se la sua azienda di sistemi di messa a terra ha eroso il capitale e accumula debiti, continuare le operazioni business as usual nella speranza di un colpo di fortuna può significare esporsi poi ad azioni di responsabilità con condanna a risarcire di tasca propria i creditori per l’aggravio.
3. Dovere di attivazione degli organi sociali: Collegato a quanto sopra, se la società ha organi collegiali o di controllo: – Gli amministratori non esecutivi (o senza deleghe operative) non sono esonerati: l’art. 2392 c.c. per le S.p.A. e il 2476 c.c. per S.r.l. implicano che tutti gli amministratori devono vigilare sull’andamento e intervenire se qualcosa non va. Una recente sentenza Appello Bologna 2024 ha sancito che anche gli amministratori “di facciata” (nel caso concreto, due figli nel CDA senza deleghe mentre il padre gestiva tutto) sono stati ritenuti responsabili per omesso controllo: non avevano mai obiettato o segnalato nulla mentre il padre commetteva distrazioni e falsificava bilanci, quindi condannati in solido col padre . Il principio: accettare la carica comporta sempre un obbligo di vigilanza attiva; restare inerti equivale a complicità colposa . Ciò per dire che se in azienda c’è un CDA con più persone, ognuna deve essere proattiva specialmente se la società va male – chi tace e subisce rischia di pagare anch’egli i danni. – I sindaci e revisori hanno a loro volta l’obbligo di monitorare la continuità aziendale. Dal Codice della Crisi è previsto che se i sindaci rilevano fondati indizi di crisi, devono segnalare per iscritto all’organo amministrativo la necessità di intervenire. Se gli amministratori ignorano l’allerta, il sindaco può attivare l’OCRI (nel vecchio schema di allerta, in parte superato) o comunque prendere iniziative. Omesso controllo del collegio sindacale che porta a danno ai creditori può generare responsabilità verso la società e anche verso i creditori (art. 2407 c.c.). Insomma, la governance tutta è chiamata a reagire tempestivamente alla crisi. – La giurisprudenza recente è severa: “il silenzio del sindaco o dell’amministratore non operativo di fronte a condotte distrattive o gestioni anomale equivale ad acquiescenza colpevole”. Il suggerimento pratico: ogni membro degli organi sociali dovrebbe mettere a verbale i propri dissensi e, se non ottiene correzione, dimettersi tempestivamente, piuttosto che figurare a posteriori come connivente . Nella vicenda di Bologna, i figli-amministratori non partecipavano ma neanche si sono mai dissociati formalmente né dimessi: ciò è bastato per addebitare loro la mancata vigilanza e condannarli .
Azioni di Responsabilità: profili civili
In caso di dissesto, scattano tipicamente due tipi di azioni civili contro gli amministratori: – Azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c. per S.p.A., art. 2476 c.c. per S.r.l.): viene promossa dalla società (su delibera assembleare) o, se intervenuto fallimento, dal curatore (ex art. 255 CCII) . Serve a risarcire la società per i danni che gli amministratori hanno causato violando i loro doveri. Esempi: sperpero di risorse, atti in conflitto di interessi dannosi, mala gestio che ha eroso patrimonio. Nel fallimento, i soldi eventualmente recuperati vanno ad aumentare l’attivo a beneficio di tutti i creditori (anche se tecnicamente risarciscono la società). – Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c. per S.p.A., principio applicabile anche a S.r.l.): se per le violazioni degli amministratori il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i creditori (erosione garanzia patrimoniale), i creditori possono chiederne conto agli amministratori. Questa azione però in caso di fallimento è esercitata anch’essa dal curatore per conto di tutti i creditori (e confluisce di fatto nell’azione di cui sopra, per CCII art. 255). Se non c’è fallimento, singoli creditori possono tentarla, ma devono provare che il default patrimoniale è dipeso da atti colposi o dolosi degli amministratori.
Elementi chiave per la responsabilità civile: – Va provato un inadempimento ai doveri (violazione di legge o statuto, o mancanza di diligenza ex art. 2392 c.c.), un danno e il nesso causale. In ambito crisi, l’inadempimento può essere: aver occultato perdite, non aver reagito alla crisi, aver pagato preferenzialmente taluni soggetti a scapito di altri (pregiudicando la par condicio e portando poi al fallimento peggiore per i creditori). – La legge richiede anche la colpa o dolo dell’amministratore. Non basta che l’azienda sia fallita per farlo colpevole; occorre dimostrare che egli non ha agito con quella diligenza professionale richiesta. Su questo, la giurisprudenza ha raffinato il concetto di business judgment rule: non si giudica l’opportunità delle scelte imprenditoriali col senno di poi, ma se sono state prese con razionalità e informazione ex ante . Tuttavia, come nota Cass. 23963/2025, la discrezionalità gestionale non salva l’amministratore se la scelta è stata irragionevole, imprudente o arbitraria in base alle informazioni che avrebbe dovuto considerare . Ad esempio, se un amministratore paga taluni debiti sociali preferendo un proprio interesse extrasociale, ciò è atto illecito anche se erano debiti dovuti: la Cassazione (ord. 23963/25) ha condannato un amministratore che aveva pagato un fornitore per lui “comodo” (forse perché quell’altro soggetto era debitore a sua volta della società, generando un conflitto di interessi) causando pregiudizio alla società . Il tribunale valuterà con riguardo ex ante se l’amministratore ha adottato le cautele e verifiche normali per una decisione del genere . In quell’ordinanza si richiama proprio la business judgment rule: le scelte restano insindacabili nel merito, ma non se manifestamente avventate o viziate da conflitto di interessi . – Onere della prova invertito in parte: Una volta che i creditori (o il curatore) allegano un comportamento negligente e un ammanco, spetta all’amministratore dimostrare di avere agito con diligenza e nell’interesse sociale . Questo è stato ribadito: l’attore (curatore) indica la condotta e il danno, l’amministratore per evitare la condanna deve provare di aver fatto tutto il possibile diligentemente . Ciò sprona gli amministratori a tenere traccia (verbali, documenti) di come hanno affrontato la crisi. Infatti, Matteo Rinaldi notava: “Alle spiegazioni fornite a posteriori nessuno dà peso. Conta solo la prova scritta predisposta prima dell’atto.” . Se non c’è traccia documentale, ogni decisione appare sospetta e l’amministratore difficilmente vince in giudizio, perché non riesce a dimostrare di aver agito oculatamente. – Distrazioni e false comunicazioni: Casi eclatanti di mala gestio includono la distrazione di attivi (trasferire risorse societarie altrove senza giustificazione). Esempio: Tribunale di Milano sent. n. 6406/2025 – amministratore di S.r.l. che aveva regalato un credito di €400k a un terzo per saldare un suo debito privato, e fatto bonifici a sé stesso per €200k senza causale, mantenendo l’attività malgrado il capitale azzerato e bilanci falsificati. Condannato a risarcire mezzo milione . Principio: sta all’amministratore provare che quelle uscite di cassa erano nell’interesse sociale, con motivazioni e documenti; altrimenti ogni atto privo di causa apparente è considerato distrattivo e quindi fonte di responsabilità . – Falsi bilanci: La Cassazione 2025 (pronuncia non specificata nel testo Rinaldi) ha enfatizzato che la falsità di bilancio di per sé dà origine a responsabilità civile verso soci e creditori, anche senza fallimento . Un bilancio inattendibile infatti induce terzi in errore (soci che non ricapitalizzano credendo tutto ok, creditori che continuano a fiancheggiare l’azienda) . Gli amministratori che occultano perdite (gonfiando attivi) e ritardano così le misure necessarie commettono un illecito e possono essere chiamati a risponderne, dovendo risarcire il pregiudizio causato a chi ha fatto affidamento su quei dati falsi . Dunque, in fase di crisi è essenziale rappresentare correttamente la situazione nei bilanci: se per “far bella figura” l’amministratore nasconde la polvere sotto il tappeto, rischia poi grosso. La Cassazione ha chiarito che non conta l’esito finale (fallimento o no), il danno risarcibile non è solo la perdita per la società ma anche il danno causato a chi ha preso decisioni basandosi su dati falsi . Quindi un creditore potrebbe dire: “Ho concesso ulteriore credito all’azienda confidando sul bilancio che mostrava patrimonio positivo, ma era falso, adesso non vedrò indietro i soldi – amministratore paghi quel danno”.
Azioni contro soci e altri soggetti: Normalmente i soci di S.r.l./S.p.A. non rispondono delle obbligazioni sociali (beneficio della responsabilità limitata). Tuttavia: – Se la società si scioglie e viene cancellata dal Registro Imprese con debiti non pagati, i soci che hanno ricevuto riparti di attivo in liquidazione sono responsabili verso i creditori per quanto incassato (art. 2495 c.c.). In pratica, se i liquidatori distribuiscono ai soci beni o denaro e poi saltano fuori debiti non saldati, i creditori possono pretendere dai soci la restituzione di quelle somme. Questo succede spesso col Fisco su società estinte: il Fisco recupera dai soci se hanno preso quote di liquidazione . – Se i soci hanno di fatto gestito l’azienda (amministratori di fatto) possono essere soggetti alle stesse azioni di responsabilità degli amministratori formali. Ad esempio, un socio unico che faceva di testa sua senza carica potrà difficilmente sfuggire ad accuse del curatore in caso di fallimento, qualificandolo come amministratore di fatto e quindi responsabile per mala gestio. – Soci e terzi che hanno beneficiato di atti in frode: se, ad esempio, l’amministratore ha venduto sottocosto un asset a un complice prima del fallimento (classica operazione in pregiudizio dei creditori), oltre all’azione di revocatoria fallimentare per riprendersi il bene o il valore, è possibile talvolta agire in responsabilità extracontrattuale verso chi ha cooperato nel causare danno alla società. Le Sezioni Unite 2023 hanno ad esempio stabilito che atti infragruppo privi di causa reale possono essere dichiarati inefficaci in revocatoria ; ma in parallelo l’amministratore del gruppo che ha orchestrato la distrazione potrebbe essere responsabile verso la fallita. Insomma, c’è una tendenza a sanzionare chi, pur esterno, concorre con l’amministratore a svuotare la società.
Profili di Responsabilità Fiscale e Contributiva
Si è già detto che non esiste una responsabilità diretta per i debiti fiscali in capo agli amministratori, salvo il caso particolare dell’art. 36 DPR 602/73 in liquidazione . Tuttavia, gli amministratori possono incorrere in: – Sanzioni amministrative tributarie personali: ad esempio, se la società non presenta dichiarazioni fiscali, il rappresentante legale può essere destinatario di sanzioni amministrative (che però in caso di società di capitali di solito restano a carico della società stessa; diverso se è una ditta individuale). – Responsabilità solidale per mancato versamento di ritenute previdenziali: normative come l’art. 11 D.Lgs. 46/1999 prevedono che se una società non versa ritenute previdenziali (trattenute ai dipendenti), l’INPS può escutere direttamente gli amministratori per quel mancato versamento, qualificandolo come credito verso il soggetto obbligato al versamento. Questo è dibattuto, ma certe prassi INPS hanno tentato di colpire amministratori in carica nel periodo di omissione. La giurisprudenza però, richiamando i principi del 602/73 per le imposte, tende a escludere responsabilità dirette senza norma di legge espressa. Si rimane quindi nel campo penale piuttosto che civile su questi aspetti. – Obblighi in procedure concorsuali: nel concordato preventivo, gli amministratori devono pagare regolarmente imposte e contributi correnti; se non lo fanno, rischiano la revoca della procedura o la non omologazione. Nel fallimento, l’inosservanza di obblighi fiscali prima del fallimento non crea debito personale ma può alimentare accuse di mala gestio (ad es. sanzioni e interessi che maturano a danno dei creditori sono addebitabili come danno da negligente gestione).
Responsabilità Penale e Reati Fallimentari
Un capitolo da non trascurare è quello penale: quando la crisi degenera e l’impresa fallisce (o anche prima, durante la gestione in dissesto), alcuni comportamenti degli amministratori possono integrare reato. In particolare: – Reati tributari: Abbiamo citato due fattispecie comuni: – Omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000): se l’IVA annuale dovuta e non versata supera €250.000, e non viene versata entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo, l’amministratore commette reato (punibile con reclusione fino a 3 anni). In situazioni di crisi, l’IVA viene spesso “usata” come fonte di finanziamento (non versandola); se l’importo è rilevante, scatta il penale. Idem per l’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) sopra €150.000. – Emissione di fatture false per creare crediti IVA: non tanto collegato alla crisi, ma talvolta imprese disperate si mettono in pratiche illecite (frodi IVA, ecc.) peggiorando la posizione degli amministratori con reati gravi (dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione, ecc.). – Questi reati sono evitabili se si prendono misure come la composizione negoziata e la transazione fiscale: infatti, se un concordato transattivo prevede la falcidia dell’IVA con omologa, l’omesso versamento cessa di essere penalmente rilevante (perché viene meno l’obbligo integrale originario, essendo sostituito dall’obbligo concordatario, in base a giurisprudenza che reputa il concordato esimente penale in questo contesto). Ma finché non c’è quell’esito, il reato si consuma. – Reati societari: In contesti di crisi, per coprire buchi è facile scivolare nel reato di false comunicazioni sociali (bilanci falsi). Questo è un reato punibile con sanzioni variabili (nel 2025, se non quotata, fino a 2-5 anni a seconda gravità). Le condotte tipiche: occultare perdite, inventare ricavi. Abbiamo visto che questo comporta anche responsabilità civile, ma penalmente può portare a condanne e interdizioni (e se fatto per ingannare i creditori, è un’aggravante rilevante). – Reati fallimentari: Se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, si aprono le maglie del diritto penale fallimentare (R.D. 267/42 ancora in vigore parti penali). Gli amministratori rischiano: – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: se prima del fallimento hanno distratto beni, sottratto o occultato parte dell’attivo, simulato passività, od effettuato pagamenti o operazioni in frode ai creditori. Ad esempio, vendere a prezzo vile un macchinario a un amico, oppure prelevare fondi sociali per scopi personali, configura distrazione -> reclusione da 3 a 10 anni. – Bancarotta fraudolenta documentale: se tengono i libri e scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento d’affari, o li sottraggono/distruggono. Per esempio, gettare libri contabili prima del fallimento = grave reato. – Bancarotta semplice: anche senza dolo specifico, se l’amministratore ha aggravato la crisi per imprudenza (es: esorbitanti spese personali, ritardo nell’aver chiesto il fallimento, ecc.), punita più lievemente ma comunque con interdizioni possibili. – Altri reati fallimentari: preferenze dolose a taluni creditori (bancarotta preferenziale), violazione obblighi post-fallimento (es: non consegnare beni o documenti al curatore), etc. – È ovvio che per chi gestisce la crisi con correttezza, questi scenari possono essere evitati. Se si procede col concordato e lo si esegue, non c’è fallimento e dunque niente bancarotta. Se anche poi si fallisce, ma l’amministratore ha tenuto contabilità regolare e non ha nascosto/distratto, risponderà al più per bancarotta semplice (se tardivamente ha cessato pagamenti). – Altri reati correlati: Falso in attestazioni (se un amministratore collude con l’attestatore di un piano per falsificare la situazione, c’è reato di falso in attestazioni di un professionista ex art. 236-bis L.F.); usura se ricorre a finanziatori illeciti per tamponare; reati ambientali o di sicurezza sul lavoro se in crisi taglia su misure di sicurezza causando eventi lesivi, ecc. Non attinenti direttamente al debito, ma la crisi a volte porta a tagliare investimenti in sicurezza con possibili conseguenze in caso di incidenti (con amministratori ritenuti penalmente responsabili).
Best practice per evitare guai personali: – Mantenere una contabilità ordinata e trasparente. In caso di ispezione o curatore, poter esibire libri puliti riduce sospetti di dolosità. – Non mescolare conto azienda e conto personale: prelievi “a piacere” dai conti sociali per tamponare finanze personali sono visti malissimo e configurano distrazione. Qualunque utilità data a un amministratore/socio deve avere titolo lecito (stipendi, rimborsi, dividendi se ammessi, etc.). – Se la liquidità è poca, non fare il furbo pagando magari solo i creditori “amici” (bancarotta preferenziale) o te stesso (distrazione). Meglio affidarsi a una procedura concorsuale dove c’è regola di par condicio e prededuzione, piuttosto che prendere iniziative arbitrarie. – Documentare nel dettaglio qualsiasi operazione straordinaria: vendite di asset in crisi, ad esempio, devono avvenire a valori di mercato e preferibilmente con perizia, così da difendersi da eventuali accuse di averli svenduti dolosamente. – Far deliberare ai soci eventuali decisioni cruciali (aumento capitale, tentativo concordato, rinuncia a crediti, etc.) in modo che anche loro siano coinvolti e non possano poi dire “non sapevamo”. L’assemblea può anche approvare un atto di gestione rilevante e ciò offre un certo riparo all’amministratore (in S.r.l., i soci possono autorizzare atti e l’amministratore ne risponde meno se esegue mandato assembleare, ferma restando la legge). – Dimettersi al momento giusto: se l’amministratore ha fatto il possibile ma i soci rifiutano di supportare o prendere decisioni (ad es. non vogliono sentir parlare di concordato, preferendo strategie dilatorie), egli deve valutare di lasciare l’incarico per non aggravare la propria posizione. Continuare a “traghettare” la società verso il baratro su pressione dei soci può costare caro poi in tribunale. La Cassazione ha più volte affermato che l’amministratore che dissente e si dimette tempestivamente si mette al riparo da molte responsabilità , a differenza di chi rimane passivo.
In conclusione, dal punto di vista dell’amministratore-debitore, difendersi non significa solo proteggere l’azienda ma anche se stessi: adottare una condotta diligente, informata e trasparente è la migliore difesa contro future azioni di responsabilità e sanzioni. La crisi d’impresa oggi è vista sì come evento fisiologico che può capitare, ma la legge pretende che venga gestita con professionalità e tempestività. Chi lo fa potrà invocare l’esimente della diligenza (es. “ho attivato la composizione negoziata non appena ho visto i segnali, ho predisposto un piano, ho informato i creditori” – difficile accusarlo di mala gestio). Chi invece naviga a vista sperando di sfangarla rischia, oltre al danno, la beffa di dover rispondere personalmente per i debiti che cercava di scaricare sulla società.
Strategie Preventive e Consigli Pratici per il Debitore in Crisi
Fin qui abbiamo parlato di cosa fare durante la crisi conclamata. Ma è altrettanto importante capire cosa il debitore (imprenditore e amministratori) può fare prima che la situazione precipiti, al fine di prevenire o attenuare la crisi stessa e le sue conseguenze. Ecco alcuni consigli pratici e “simulazioni” di buone prassi da adottare nel contesto italiano attuale:
1. Monitorare costantemente la salute aziendale: Implementare sistemi di controllo di gestione che forniscano indicatori di allerta. Ad esempio: indici di liquidità, andamento margini, indice di Debt Service Coverage Ratio (DSCR) prospettico. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato indici utili (es. patrimonio netto negativo, oneri finanziari/ricavi > determinate soglie, ecc.). Se uno o più di questi indici sforano, è segno di allerta. Questo è un obbligo di legge – non è solo management prudente, è dovuto per art. 2086 c.c. Adeguarsi significa investire in contabilità analitica, software di reporting, formazione del personale amministrativo. Simulazione: l’azienda Alfa S.r.l. imposta mensilmente un cruscotto con: liquidità disponibile, fatture scadute, previsioni incassi/pagamenti 6 mesi, bilancio previsionale. A giugno vede che a settembre ci sarà un picco di pagamenti (IVA trimestre + rate mutui + fornitori grossi) che non sarà coperto dai flussi. Questo è un segnale di tensione finanziaria futura. Grazie al monitoraggio, Alfa può muoversi già a giugno (contatta la banca per estendere il fido, avvisa i soci della necessità di liquidità aggiuntiva, inizia a negoziare consegne con fornitori per spostare pagamenti). Se non avesse guardato avanti, a settembre sarebbe stata insolvente.
2. Agire subito ai primi sintomi di crisi: Tempestività è la parola chiave. Ogni giorno perso restringe le opzioni. L’esempio lampante: Beta S.p.A. nota che nel 2023 il fatturato cala del 30% e chiude in perdita, erodendo metà del capitale. Invece di aspettare il 2024 “per vedere se il mercato si riprende”, i suoi amministratori già a bilancio 2023 convocano i soci, espongono il problema e propongono di attivare la composizione negoziata. Coinvolgono un advisor per redigere un mini-piano di emergenza. Questo permette a Beta di arrivare a febbraio 2024 con un tavolo di trattative aperto con banche e fornitori, evitando che qualcuno faccia mosse aggressive. Confronto: Gamma S.r.l., situazione simile di perdite, però minimizza (“è un momento passeggero”) e continua come niente fosse. Nel 2024 la situazione peggiora, i fornitori iniziano a non essere pagati e a luglio 2024 uno di essi deposita istanza di fallimento. Gamma si attiva solo a quel punto, presentando concordato in fretta e furia – con minori chance di successo e costi più alti rispetto a Beta che ha agito prima. Lezione: meglio trattare da impresa “viva” e proattiva, che da impresa in punto di morte sotto pressione giudiziaria.
3. Comunicazione trasparente e credibile coi creditori chiave: Molti imprenditori tendono a chiudersi e a non comunicare la crisi, temendo reazioni negative. In realtà, coinvolgere i creditori chiave in modo trasparente può generare fiducia e collaborazione. Se banche e fornitori importanti conoscono il piano di risanamento e vedono l’impegno dell’imprenditore (magari con sacrifici personali, come immettere denaro proprio), saranno più inclini a supportare la ristrutturazione, ad esempio concedendo standstill (sospensione temporanea delle azioni esecutive e delle scadenze) e partecipando a eventuali accordi. Il silenzio, invece, porta spesso i creditori a temere il peggio e quindi ad agire per primi (chi corre ad aggredire per timore di restare a mani vuote). Dunque il consiglio è: non aspettare la lettera dell’avvocato del creditore, prendi tu il telefono e chiama i creditori per spiegare la situazione e la strategia di soluzione. Molti casi di successo partono da questa onestà. Ovviamente va calibrata: non annunciare a tutti in massa “siamo alla frutta”, ma selezionare quelli con cui hai relazione più solide e iniziare con loro un dialogo costruttivo.
4. Proteggere e ottimizzare la cassa (cash is king): In crisi la liquidità è scarsa e vitale. Occorre: – Ridurre spese superflue: tagliare costi non essenziali immediatamente (dismettere auto aziendale lussuosa in leasing, eventi, consulenze non strategiche, etc.). – Ottimizzare magazzino: vendere scorte obsolete per fare cassa, anche sottocosto se necessario, pur di monetizzare. – Recuperare crediti attivi: attivarsi con solleciti, eventuali factoring (anche se costoso, aiuta a incassare prima), transare crediti incagliati (meglio incassare il 70% subito che 100% mai). – Segregare la liquidità per pagare le necessità vitali (stipendi, fornitori critici, utenze): assicurarsi che quelle uscite siano coperte, eventualmente ritardando altro. – Valutare vendite di asset non core: possiede un immobile inutilizzato? Meglio venderlo e incassare che tenerlo come garanzia ipotecata che poi andrà all’asta se fallisci. – Attenzione ai pagamenti preferenziali: se pensi di poi fare un concordato o rischi fallimento, evita di pagare fuori dall’ordinario un creditore non privilegiato a scapito di altri (bancarotta preferenziale). Se devi proprio perché essenziale (es. un fornitore senza cui ti fermi), fallo emergere come parte di un piano, magari con l’assenso dell’esperto o commissario se in procedura, così da giustificarlo.
5. Patrimonio personale: valutare rischi e contromisure lecite: L’imprenditore sovente garantisce con beni propri (fideiussioni, ipoteche su casa). In previsione di una crisi, bisogna essere molto cauti: – Non fare movimenti anomali sul patrimonio personale a ridosso della crisi: ad esempio, cedere la villa alla moglie, donare proprietà ai figli – sono atti a fortissimo rischio di revocatoria fallimentare se poi c’è fallimento entro 2 anni (per le donazioni) o se erano sotto prezzo (per cessioni a terzi compiacenti, revocabili un anno). Inoltre, potrebbero integrare reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se c’erano grossi debiti fiscali (art. 11 D.Lgs. 74/2000 punisce chi aliena beni per evadere il fisco). – Se si dispone di liquidità personale, valutare se sostenere l’azienda (ad esempio finanziandola) o se tenerla da parte. Finanziarla potrebbe salvare la società, ma se è un pozzo senza fondo si rischia di perdere anche il salvagente. Una via di mezzo: mettere i fondi personali a disposizione del concordato come finanza esterna (che gode di prededuzione e va solo ai creditori, ottenendo magari trattamenti di favore in omologa). Così almeno quei soldi servono a chiudere la procedura con successo e liberare l’azienda dai debiti residui. – Polizze assicurative: Esistono polizze D&O (directors and officers) che coprono parzialmente i rischi di responsabilità civile degli amministratori. Val la pena, in tempi non sospetti, valutarne la stipula. Se poi il curatore fa causa, la compagnia pagherà eventuali risarcimenti (entro massimali), proteggendo il patrimonio personale. Attenzione però: dolo e atti in malafede sono esclusi di solito. – Valutare l’opportunità di procedure personali di esdebitazione: se l’imprenditore è anche garantore e ha altri debiti personali, in caso di default dell’azienda potrebbe trovarsi egli stesso insolvente. Oggi la legge offre la liquidazione controllata del sovraindebitato (ex legge 3/2012) con esdebitazione finale per la persona fisica. In casi estremi, può essere un’ancora per l’ex imprenditore pulirsi dai debiti non soddisfatti (anche se perderebbe sostanzialmente tutti i beni personali liquidabili). Non auspicabile se si può evitare, ma è bene sapere che esiste un “fresh start” personale come ultima risorsa.
6. Consulenza professionale specializzata: Gestire una crisi richiede competenze multidisciplinari (legali concorsuali, finanziarie, operative). Un piccolo imprenditore potrebbe sottovalutare aspetti critici. È consigliabile farsi affiancare da un advisor esperto di ristrutturazioni o da un legale esperto di crisi d’impresa fin dalle fasi iniziali. Certo, comporta dei costi, ma affrontare un concordato senza saperlo maneggiare è ricetta per il disastro. Molti errori (es. non presentare in tempo un documento, non considerare un certo credito in piano, sbagliare valutazione di fattibilità) possono causare il fallimento del piano e quindi della società. Un professionista aiuta anche a interfacciarsi con banche e creditori in modo credibile (presentare un piano redatto da un advisor qualificato fa un altro effetto rispetto a un foglio Excel improvvisato dall’imprenditore). Simulazione: Omega S.r.l., azienda familiare indebitata, tenta per mesi di negoziare con le banche da sola ma senza progressi; decide di incaricare un advisor finanziario. Questi riformula la proposta di ristrutturazione con numeri ben argomentati e relazioni a supporto, e convoca un meeting con tutte le banche parlando il loro linguaggio. Nel giro di settimane, ottiene un accordo quadro che Omega da sola non era riuscita a strappare in un anno. Il costo dell’advisor è stato ripagato dal risultato (risparmi di interessi, stop a revoca fidi, ecc.).
7. Pianificare scenari e soluzioni prima di trovarvisi (cultura della prevenzione): Un imprenditore prudente, anche quando l’azienda va bene, dovrebbe pensare “E se andasse male, cosa farei?”. Questo porta a: – Conoscere in anticipo gli strumenti legali (magari far formazione al proprio CFO su concordati & co., così da non farseli spiegare in fretta all’ultimo). – Costruire rapporti contrattuali robusti: es., se stipula un contratto di fornitura pluriennale importante, prevedere clausole che in caso di concordato la controparte non receda (clausole ipso facto di risoluzione per concordato sono nulle per legge, ma farlo sapere serve). – Mantenere una governance documentata: tutto quello che si decide in CDA, in assemblea, scriverlo nero su bianco con motivazioni. Questo salva in tribunale come visto. – Non accumulare distrazioni: se sei un piccolo imprenditore che ogni tanto confonde cassa azienda/famiglia, poni rimedio ora, perché in bonis si può sistemare (es. trasformare prelievi in dividendi, con tasse pagate, o in compensi). Farlo in crisi è troppo tardi.
In sintesi, la miglior difesa è l’attacco: anticipare i problemi, dotarsi di strumenti per rilevarli, affrontarli di petto e con trasparenza, cercando aiuto professionale quando serve. Chi adotta questo approccio proattivo riduce drasticamente la probabilità di un collasso disordinato e di conseguenti strascichi giudiziari personali. L’ordinamento italiano, aggiornato al 2025, fornisce le armi (dalla composizione negoziata ai concordati), ma sta all’imprenditore impugnarle in tempo. Come recita un vecchio adagio: “Un grammo di prevenzione vale un chilo di cura.”
Domande Frequenti (FAQ) – Difendersi dai Debiti Aziendali
Di seguito una serie di domande e risposte comuni che imprenditori, amministratori o professionisti si pongono quando un’azienda accumula debiti significativi e rischia azioni dei creditori. Le risposte fornite tengono conto della normativa e prassi aggiornate a ottobre 2025, con taglio pratico ma basato sul quadro giuridico illustrato.
- Domanda: La mia azienda ha grossi debiti fiscali arretrati. Posso davvero rischiare il fallimento per questo?
Risposta: Sì, se i debiti fiscali sono ingenti e l’azienda è insolvente (incapace di pagarli insieme alle altre obbligazioni), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può chiedere la liquidazione giudiziale (il “fallimento”). Tuttavia, in genere il Fisco preferisce usare le procedure di riscossione individuale (pignoramenti, ipoteche) . Diventa più probabile un’istanza di fallimento se l’azienda accumula anche molti altri debiti e appare irreversibilmente insolvente. Ad ogni modo, per evitare il fallimento, è possibile attivarsi con gli strumenti di ristrutturazione del debito: ad esempio un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione che includa la transazione fiscale (cioè un accordo col Fisco per pagare parzialmente/dilazionato il dovuto) . Oggi il tribunale può omologare l’accordo anche senza il consenso del Fisco se gli garantisci almeno il 30-40% e se il piano è migliore per l’Erario rispetto a liquidarti . Quindi, puoi evitare il fallimento presentando un piano serio: mostrati proattivo con l’Erario (chiedi rateazione, proponi transazione) e, se c’è rischio concreto, ricorri al concordato prima che lo faccia il Fisco. Se l’istanza di fallimento è già stata depositata, puoi ancora bloccarla depositando una domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”) : il tribunale di solito sospende la decisione sul fallimento in attesa di vedere se il concordato va a buon fine. Dunque, il debito fiscale di per sé non è una condanna inevitabile al fallimento, a patto di muoversi con gli strumenti giusti in tempo. - Domanda: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mi ha pignorato il conto corrente aziendale per le cartelle esattoriali non pagate. Posso fare qualcosa per sbloccarlo?
Risposta: Quando AER pignora un conto, la banca è tenuta a congelare le somme presenti fino all’udienza in tribunale per l’assegnazione . Per sbloccarlo, ci sono alcune possibilità: - Pagare o accordarsi con AER: Se riesci a versare l’importo dovuto (magari chiedendo una rateizzazione e pagando un anticipo), AER può rinunciare al pignoramento. Talvolta, in sede di accordo (ad esempio se presenti istanza di rateizzazione e versi subito le prime rate), l’Agente sospende le azioni esecutive. Dovrai però trovare la liquidità da fonti esterne al conto pignorato.
- Conversione del pignoramento: Puoi chiedere al giudice di sostituire al pignoramento una somma di denaro (art. 495 c.p.c.), depositando il 1/5 dell’importo e rateizzando il resto . In pratica, versi una cauzione al tribunale e chiedi la liberazione del conto. Questo è fattibile se hai almeno una parte di fondi (es. su altri conti o dai soci) da mettere subito.
- Opposizione per vizi formali: verifica con un legale se il pignoramento ha irregolarità (errori nell’atto, importi prescritti, mancata notifica di atti precedenti come l’intimazione). Un’opposizione agli atti esecutivi può ritardare l’assegnazione e in certi casi portare all’estinzione del pignoramento se ci sono vizi gravi. È però un rimedio tecnico e non risolutivo del debito: serve soprattutto per guadagnare tempo.
- Procedure concorsuali protette: Se l’azienda accede a una procedura concorsuale (concordato, accordo in omologa) e ottiene misure protettive, il pignoramento in corso non potrà proseguire. In concreto, se presenti un concordato e il tribunale emette il decreto di protezione, l’udienza di assegnazione del pignoramento verrà sospesa e AER non potrà ottenere le somme. Questo “freezerà” la situazione in attesa della soluzione concordataria. Attenzione però: il provvedimento protettivo dovresti ottenerlo prima che il giudice assegni le somme ad AER.
In sintesi, se il conto è pignorato la via più rapida è trovare un accordo con AER (pagando qualcosa). Se non hai mezzi, valuta il ricorso a uno strumento concorsuale per congelare l’azione e poi includere il debito fiscale in un piano di ristrutturazione. L’importante è non restare passivo: se non fai nulla, il denaro sul conto verrà assegnato all’Erario e il pignoramento potrebbe ripetersi su nuove entrate in conto fino a soddisfacimento completo.
- Domanda: La banca ha revocato gli affidamenti e minaccia di escutere la fideiussione personale che ho firmato. Posso oppormi legalmente alla revoca o al pagamento come garante?
Risposta: In generale, la banca ha il diritto di revocare gli affidamenti a vista (scoperti di conto, anticipo fatture) secondo le condizioni contrattuali, specie se l’azienda è in difficoltà (di solito c’è una clausola per “giustificato motivo” come il peggioramento del merito creditizio). Non c’è un modo legale per “obbligarla” a mantenere aperto un fido se ha rispettato il preavviso contrattuale (di solito 10-15 giorni). Quindi, sul fronte revoca affidamenti c’è poco da opporre giuridicamente. Puoi però negoziare con la banca: presentando un piano di rientro del fido revocato (es. pagare lo scoperto in 12 mesi) oppure offrendo garanzie aggiuntive per farlo convertire in finanziamento rateale. Alcune banche aderiscono a protocolli ABI che prevedono moratorie o soluzioni di ristrutturazione per PMI in crisi, vale la pena chiedere.
Quanto alla fideiussione personale: se la banca ha titolo (il contratto di garanzia valido e il debito certo/liquido dell’azienda), purtroppo lei può chiederti il pagamento integrale in qualità di garante, senza bisogno di passare per tribunale (dopo la revoca spesso notificano un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo al fideiussore, o agiscono in base alla formula esecutiva del contratto se prevista). Opporsi è difficile a meno che la fideiussione sia nulla per vizi propri: ad esempio, alcune fideiussioni bancarie omnibus anteriori al 2018 sono state ritenute nulle dall’Antitrust e Cassazione perché redatte su schema ABI anticoncorrenziale (famosa vicenda fideiussioni ABI). Se la tua garanzia rientra in quel caso, potresti eccepire la nullità parziale. Ma attenzione: non tutte le fideiussioni lo sono, e nel frattempo la banca procederebbe.
Cosa fare quindi? Strategie: – Trattativa: Spiega alla banca che escutere la garanzia mettendo in crisi anche te personalmente potrebbe precludere qualsiasi recupero (es. se ti pignorano casa e vai insolvente, poi la banca comunque non recupera tutto). Proponi soluzioni: magari ipotecare l’immobile personale in cambio di un piano di rientro più lungo e interessi ridotti. La banca potrebbe preferire una soddisfazione più certa nel tempo che una causa con esito incerto. – Concordato preventivo personale: Non esiste formalmente per l’imprenditore individuale, ma se sei anche consumatore o piccolo imprenditore, potresti valutare la procedura di sovraindebitamento (oggi “concordato minore” o liquidazione controllata) per ristrutturare i debiti personali compresa la fideiussione. In tal caso, se ammesso, la banca come creditore verrebbe soddisfatta in parte secondo il piano e non potrebbe agire esecutivamente intanto. È un percorso estremo, ma se l’importo è insostenibile e la banca non sente ragioni, dichiarare il sovraindebitamento personale e attivare quella procedura può bloccare le esecuzioni sul tuo patrimonio. – Opposizione in sede esecutiva: Se la banca ti notifica un atto di pignoramento (su stipendio, su conto o immobile tuo), puoi verificare con avvocato eventuali irregolarità. Ma se il debito dell’azienda verso banca è reale e tu hai garantito, l’opposizione serve solo se ci sono bug formali.
In conclusione, non esistono bacchette magiche per impedire alla banca di revocare o di chiedere al fideiussore. La chiave è anticipare: appena vedi segni di peggioramento, contatta la banca per rinegoziare e, se hai garanzie personali, cerca di limitare l’esposizione (ad esempio non garantire oltre il necessario, diversificare banche per non concentrare troppi rischi su di te). Se ormai è tardi, la via preferibile è trovare un accordo di ristrutturazione con la banca medesima, magari inserito nel contesto di un accordo più ampio (coinvolgendo anche altri creditori – le banche spesso vogliono vedere che anche altri fanno sforzi, non solo loro).
- Domanda: Ho fornitori piccoli che iniziano a protestare perché non li pago da mesi. Uno ha minacciato di portarmi i libri in tribunale per farmi fallire. Può davvero un singolo piccolo fornitore causare il fallimento della mia azienda?
Risposta: Anche un singolo creditore (non importa se “piccolo” come dimensione aziendale, conta l’importo del credito) può presentare istanza di fallimento se il suo credito è sopra una certa soglia (€30.000 di solito, somma delle pretese) e se dimostra che l’azienda è insolvente. In passato servivano più creditori, ora basta uno. Quindi sì, in linea teorica quel fornitore potrebbe depositare l’istanza. Se il tuo debito verso di lui è modesto, potrebbe non avere convenienza a spendere per la procedura; spesso queste minacce servono a spingere a pagare. Ma legalmente la minaccia è credibile se tu davvero non paghi molti e sei insolvente. Per evitare che arrivi a tanto, conviene negoziare subito: puoi proporre a quel fornitore un piano di rientro o un pagamento parziale immediato pur di evitarlo. Potresti anche offrirgli una camBiale o un effetto a termine, in modo da formalizzare l’impegno – alcuni creditori lo accettano perché se non altro hanno un titolo esecutivo certo (anche se va in protesto, poi possono escutere più facilmente, ma almeno aspettano quella scadenza).
Se pensi che possa procedere comunque, valuta di giocare d’anticipo: ad esempio, presentando tu un ricorso per concordato preventivo (anche prenotativo). Quando depositi un concordato con riserva, il tribunale nomina un commissario e rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti . Quindi batteresti sul tempo il fornitore. Ciò non toglie che poi dovrai risolvere la crisi con il concordato. Un’alternativa meno drastica: se la tua crisi è temporanea, puoi cercare di ottenere un finanziamento ponte (magari dai soci) per pagare questo fornitore e altri imminenti e togliere loro motivazione a presentare istanza.
Tieni conto che un creditore che chiede il fallimento di solito lo fa se vede che: 1. Non ci sono prospettive di recuperare diversamente (nessun piano credibile né garanzie). 2. Magari sospetta che tu stia pagando altri e non lui (allora vuole par condicio, col fallimento tutti sulla stessa barca). 3. Oppure per “punizione”. Ma se è un fornitore che vorrebbe continuare a lavorare con te, di solito preferisce un accordo a vederti fallire.
Quindi, sì può farlo, ma tu puoi: – Evitarlo pagando/accordandoti con lui velocemente. – Oppure anticiparlo con una procedura concorsuale tua. – Oppure, se depositasse istanza, potresti ancora farlo desistere magari pagando almeno lui (attenzione però: se poi fallirai comunque entro 6 mesi, quel pagamento potrebbe essere revocato come preferenziale). In emergenza, alcuni usano risorse personali per saldare il creditore istante, di modo che ritiri l’istanza. È un’azione estrema e da valutare con legale, ma a volte salva temporaneamente.
Il consiglio: non sottovalutare nemmeno un singolo creditore, perché la legge oggi non richiede di essere “grandi” per attivare il fallimento. Piuttosto, cerca di tenere tutti i fornitori informati e di evitare che qualcuno si senta abbandonato al punto da voler procedere legalmente.
- Domanda: La società sta andando male e temo di non riuscire a pagare stipendi e TFR ai dipendenti. Cosa succede ai dipendenti se l’azienda fallisce? Devo pagarli prima degli altri?
Risposta: I dipendenti hanno una tutela forte: - Se l’azienda fallisce (liquidazione giudiziale), i crediti dei dipendenti per retribuzioni degli ultimi mesi e TFR sono crediti privilegiati di massimo grado. Questo significa che quando il curatore raccoglierà attivo, soddisferà prima di tutto loro (dopo aver pagato eventualmente le spese della procedura) . Inoltre, interviene il Fondo di Garanzia INPS che anticipa ai dipendenti il TFR e le ultime 3 mensilità non pagate (fino a un massimale) e poi si insinua al loro posto. Quindi i dipendenti non restano (almeno in parte) senza soldi: il Fondo INPS paga di solito entro qualche mese dalla richiesta, a condizione che ci sia stata la dichiarazione di insolvenza/fallimento o un concordato liquidatorio omologato. Quindi, i dipendenti recuperano in larga parte il dovuto, anche se attraverso INPS – e quell’obbligo tuo passa al Fondo (che diventa creditore).
- Se invece intraprendi un concordato preventivo, normalmente prevede il pagamento integrale dei dipendenti (per legge, i crediti di lavoro maturati prima depositi il concordato devono essere soddisfatti almeno in misura pari a quanto avrebbero dal Fondo INPS, quindi praticamente integrale per le voci coperte). Inoltre, puoi chiedere in concordato l’autorizzazione a pagare subito i dipendenti per mantenerli operativi (pagamenti in prededuzione).
- In ogni caso, dare priorità ai dipendenti è sia eticamente che strategicamente giusto: la legge ti consente di pagarli anche prima di altri creditori in crisi, perché quei pagamenti non sono soggetti a revocatoria (art. 150 CCII esenta i pagamenti di lavoro correnti). Dunque, sì, dovresti pagarli prima degli altri chirografari. Se non ce la fai, sappi che i dipendenti hanno diritto al loro e lo otterranno dal Fondo, ma poi quell’INPS surrogato sarà tuo creditore privilegiato (comunque uno dei primi in fila).
- Dal lato pratico: se temi di non farcela a pagarli tutti, parla con i lavoratori e magari con i sindacati. Si possono concordare soluzioni come cassa integrazione straordinaria (lo Stato paga parte degli stipendi per un periodo) o accordi per rateizzare il TFR.
- Attenzione: se non paghi le retribuzioni per mesi senza attivarti, i dipendenti possono dimettersi per giusta causa (con diritto a tutte le indennità come TFR immediato) e potrebbero anche presentare istanza di fallimento (anche i lavoratori sono legittimati come creditori, sebbene raramente lo facciano se sanno del Fondo). Quindi dialoga con loro, spiegando la situazione. Spesso i dipendenti preferiscono salvare l’azienda e il posto di lavoro, accettando magari un ritardo se c’è un piano serio.
In sintesi: in caso di procedura concorsuale, i dipendenti sono protetti dal privilegio e dal Fondo di Garanzia. Non perderanno completamente i loro crediti. Ma come datore di lavoro è importante gestire correttamente la situazione: se tieni aggiornati i lavoratori e li tuteli nei limiti del possibile (es. chiedendo cassa integrazione per loro, pagando almeno una parte), eviti conflitti e magari cause di lavoro individuali. Giuridicamente, i lavoratori non possono pignorare beni essenziali dell’impresa come i macchinari? In realtà possono, perché il privilegio è generale sui mobili: però spesso attendono il fallimento per passare al Fondo. Alcuni però potrebbero fare decreti ingiuntivi subito. Quindi sì, conviene pagarli prima e meglio degli altri.
- Domanda: Ho sentito parlare di “bancarotta” e che potrei avere problemi penali. Ma se io non ho rubato nulla, devo preoccuparmi? Quali sono i comportamenti da evitare per non incorrere in reati?
Risposta: Il reato di bancarotta fraudolenta non riguarda solo il furto di beni, ma in generale qualsiasi atto che intenzionalmente lede i creditori in previsione di fallimento. Esempi classici: - Distrazioni: portare via beni o soldi dall’azienda a proprio vantaggio o per favorire terzi, lasciando i creditori a bocca asciutta, è bancarotta fraudolenta patrimoniale. Non serve “rubare” in senso classico; basta anche vendere sottocosto un immobile ad un amico prima del fallimento: è come se tu avessi distratto la differenza di valore.
- Preferenze: pagare di nascosto un creditore, soprattutto un creditore personale o un parente, prima del fallimento può essere bancarotta preferenziale (fraudolenta se c’è doloso intento di favorirlo su altri).
- Libri contabili in disordine: se non hai tenuto la contabilità o l’hai fatta sparire/incenerita, anche se non hai rubato nulla, hai commesso bancarotta fraudolenta documentale, perché impedisci ai creditori (via curatore) di ricostruire cosa è successo.
- Aggravamento colposo: se non c’è malafede ma sei stato negligente e hai aggravato il buco (tipo hai continuato a fare operazioni azzardate e poi sei fallito), potresti incorrere in bancarotta semplice. È meno grave (penalmente sanzionata con pene minori e spesso solo multa/interdizione).
Quindi, anche un amministratore “onesto” deve stare attento: il confine tra cercare di salvare l’azienda e commettere bancarotta può essere sottile se non rispetti le regole. Cosa fare per evitare guai penali: – Tieni la contabilità ordinata e non alterarla. Mai pensare di far sparire fatture o registri per nascondere perdite o debiti. Al contrario, documenta tutto. – Non fare pagamenti preferenziali sospetti. Se proprio devi pagare qualcuno prima di altri (es. fornitore indispensabile), motivalo bene nei documenti (per la continuità) e, se possibile, fallo con il benestare di un organo (commissario giudiziale se sei in concordato, o l’esperto se in negoziazione) per dimostrare che non era per frodare. – Non mescolare soldi aziendali e personali. Prelevare cassa per fini personali, soprattutto in prossimità dell’insolvenza, è una grossa red flag. Se ti serve stipendio come amministratore, ok, ma dev’essere congruo e deliberato formalmente. – Evita la falsa rappresentazione: bilanci falsi possono portare a reato (false comunicazioni sociali) e, se fallisci, costituiscono bancarotta impropria. Quindi anche se la verità è brutta (perdite), riportala correttamente. – Se vedi che il fallimento è inevitabile, adotta un comportamento cristallino: consegna subito libri e beni al curatore, collabora, non nascondere niente. La cooperazione post-fallimento può attenuare il giudizio su di te ed evitarti il dolo (magari te la cavi con bancarotta semplice anziché fraudolenta).
In conclusione, preoccuparti devi nel senso di essere consapevole: la stragrande maggioranza delle bancarotte fraudolente derivano da comportamenti “disinvolti” degli amministratori in crisi. Se tu eviti quelle furbizie e anzi gestisci la crisi con trasparenza (magari avviando una procedura regolare come concordato), riduci moltissimo il rischio penale. Ricorda: se porti l’azienda in concordato preventivo e lo segui correttamente, anche se poi finisse in fallimento, tutte le operazioni approvate nel concordato non potranno essere contestate come bancarotta (perché autorizzate dal tribunale). Diverso se agisci nell’ombra. Quindi onestà e trasparenza sono la migliore “assicurazione” contro problemi penali.
- Domanda: Come faccio a capire se è meglio un accordo stragiudiziale (piano o accordo di ristrutturazione) o direttamente il concordato preventivo?
Risposta: La scelta dipende da vari fattori: - Composizione e numero dei creditori: Se hai pochi creditori principali (ad esempio 2 banche e 5 fornitori grossi) e sono ben disposti, può bastare un accordo stragiudiziale o un accordo ex art.57 CCII . Se invece hai centinaia di piccoli creditori, il concordato è quasi inevitabile perché non li potrai mai far aderire tutti.
- Necessità di riduzione del debito: Se devi imporre tagli (stralci) ai crediti di molti, il concordato ti dà uno strumento di voto a maggioranza per farlo. Un piano attestato non può imporre tagli a chi non li accetta, un accordo vincola solo i consenzienti (salvo efficacia estesa ma serve 75% per classe) . Quindi se c’è bisogno di falcidiare pesantemente i debiti chirografari e prevedi dissensi, col concordato hai la forza della maggioranza.
- Presenza di crediti pubblici: Se il grosso sono debiti fiscali e contributivi e vuoi pagarli parzialmente, ormai sia accordo che concordato permettono transazione fiscale. Il concordato però storicamente era l’unico strumento per falcidiare IVA e ritenute (ora c’è cram-down fiscale anche per accordi, ma con percentuali minime) . Se il Fisco è contrario e tu puoi offrire solo ad esempio il 20%, col solo accordo non omologherebbero (minimo 30-40% richiesto) , mentre con un concordato liquidatorio potresti teoricamente offrirgli anche meno se rispetti il 20% minimo per chirografari e quello è ciò che prenderebbe in fallimento (anche se il Fisco non vota a favore potresti comunque avere l’omologa se altre classi approvano). Quindi, debito fiscale molto elevato e poca capacità di soddisfarlo -> concordato è spesso preferibile.
- Tempistiche e pubblicità: Un accordo di ristrutturazione può essere (ma non sempre) più rapido e meno pubblico. Se la riservatezza e la celerità sono cruciali e pensi di poter portare a casa il consenso richiesto in tempi brevi, tenta prima l’accordo. Tieni però in conto che se anche un creditore chiave si mette di traverso, rischi di dover passare poi al concordato e hai perso tempo. Spesso una strategia è: avvia composizione negoziata -> se vedi che raggiungi consensi verso 60-75%, vai su accordo; se vedi troppo disaccordo, ripieghi su concordato.
- Costi e oneri di gestione: Un concordato è più costoso (commissario da pagare, legali, ecc.) e vincolante (ogni atto sotto controllo). Un accordo è più leggero, niente commissario, tu gestisci l’impresa quasi normalmente durante le trattative (a parte eventuali misure protettive). Quindi se la situazione è ancora “gestibile” senza stampelle giudiziarie, l’accordo è meno invasivo e costoso.
In pratica, molti adottano un criterio: tentare prima la via meno traumatica. Ad esempio, provare un piano attestato con i creditori principali; se fallisce, passare a accordo ex 57; se non basta, ultima spiaggia concordato. Però devi stare attento a non consumare troppo tempo e cassa in tentativi vani. Ecco perché la composizione negoziata è utile: entro 3-4 mesi ti rendi conto di cosa è fattibile. L’esperto magari ti dirà “guarda i creditori sono troppo distanti, ti conviene il concordato”. Oppure “puoi fare un accordo agevolato col 30% perché hai liquidità per gli estranei”.
Quindi, se: – l’azienda ha ancora chance concrete di risanamento e creditori collaborativi → accordo stragiudiziale o omologato. – l’azienda è insolvente conclamata e serve trattamento uniforme → concordato (soprattutto se continui l’attività, per bloccare le azioni ed evitare istanze dei singoli).
Ricorda comunque: non devi scegliere da solo al buio. Consulta un professionista esperto di crisi. Spesso fanno simulazioni di fattibilità: ad esempio, redigono ipotesi di accordo vs ipotesi di concordato e valutano percentuali di soddisfo e reazioni attese. In base a quello, si decide. In generale, finché puoi evitare il concordato, evitalo, perché è comunque un “quasi fallimento” come impatto. Ma se serve per salvare l’impresa e non ci sono altre vie, allora va fatto senza indugio.
- Domanda: Dopo aver superato la crisi con un accordo o concordato, cosa succede se poi non riesco a rispettarlo?
Risposta: Dipende dallo strumento: - Se hai fatto un accordo di ristrutturazione omologato e poi non rispetti i pagamenti nei termini, i creditori estranei (che dovevi pagare entro 120 giorni) possono riprendere le azioni esecutive . E i creditori aderenti, se l’inadempimento è rilevante, possono chiedere al tribunale di risolvere l’accordo. Una volta risolto, tutti riacquistano pieni diritti come prima (salvo aver già incassato acconti). Quindi il rischio è che torni tutto come all’inizio, con in più la sfiducia dei creditori che magari a quel punto punteranno al fallimento. Di fatto, un accordo non eseguito porta quasi sicuramente al fallimento, a meno che non si trovi subito un’alternativa (ad esempio convertire in concordato preventivo).
- Nel concordato preventivo, se non adempi al piano omologato, qualsiasi creditore può chiedere la risoluzione del concordato (art. 121 CCII, ex art. 186 L.F.). Il tribunale, verificato l’inadempimento non di scarsa importanza, dichiara la risoluzione e contestaualmente può aprire la liquidazione giudiziale (fallimento “omisso medio”) . In pratica, il fallimento viene solo posticipato dalla parentesi concordataria e si realizza se non hai rispettato i patti. Ci sono stati casi in Cassazione (es. Cass. 15862/2024) che confermano: si può dichiarare il fallimento dopo risoluzione di concordato senza bisogno di un’ulteriore insolvenza sopravvenuta, basta l’inadempimento del concordato stesso .
Quindi, non rispettare un accordo o concordato è uno scenario pessimo: perdi la protezione e verosimilmente ti ritrovi in procedura liquidatoria. Inoltre, per gli amministratori può significare: – Responsabilità personale riattivate (i creditori torneranno eventualmente con cause di responsabilità se c’è stato aggravio nel frattempo). – Impossibilità per qualche tempo di accedere a nuovi strumenti (ad esempio, dopo risoluzione concordato, fare un altro concordato è possibile ma il tribunale sarà molto più severo nel valutarlo). – Perdita totale di credibilità sul mercato (già un concordato è uno stigma, se poi pure lo buchi, fornitori e banche in futuro scapperanno).
Conclusione pratica: se fai un accordo o concordato, devi essere ragionevolmente certo di poterlo sostenere. Meglio prevedere un margine di sicurezza nei piani (es. includere clausole che se il fatturato ritarda di tot, si allunga un po’ il piano, con consenso del giudice). Ci sono possibili “aggiustamenti” entro limiti: ad esempio l’art. 48 CCII consente al tribunale di omologare anche se c’è opposizione, purché i creditori estranei siano comunque pagati integrali entro 120 giorni . Ma una volta fissato nell’omologa, non puoi cambiare a piacere. Nel concordato, c’è la possibilità di modifica del piano prima del voto se emergono fatti nuovi, ma dopo omologa no, a parte chiedere piccoli proroghe se tutti i creditori sono d’accordo (ma basta uno contrario e non puoi).
Se vedi che non riuscirai a rispettare, l’unica è cercare un nuovo accordo modificativo prima che scadano i termini e i creditori si alterino. Ad esempio, potresti proporre un accordo transattivo ai creditori per evitare la risoluzione: “mi restano da pagarvi 50, vi do subito 30 e chiudiamo” – praticamente un secondo concordato ma stragiudiziale, può funzionare se i creditori valutano che è meglio prendere subito qualcosa che rischiare il fallimento dove magari prenderebbero meno. Questa è un’opzione estrema, ma a volte funziona se il gap non è enorme e i creditori hanno fretta di incassare. Però è a discrezione loro ormai.
In sintesi: rispettare l’accordo/concordato è fondamentale. Pianificalo realistico dall’inizio. Altrimenti, il castello crolla e torni alla casella fallimento.
Conclusioni
Affrontare una situazione di grave indebitamento aziendale è una sfida complessa che richiede tempestività, competenza e trasparenza. La legislazione italiana, con le riforme più recenti, offre una gamma di strumenti per evitare che un’impresa in difficoltà sia travolta dai debiti: dalle trattative assistite (composizione negoziata) alle soluzioni concordate (accordi di ristrutturazione e concordati preventivi) . Tuttavia, nessun strumento può avere successo senza l’impegno attivo dell’imprenditore e dei suoi consulenti.
Dal punto di vista pratico del debitore, i passi fondamentali per “difendersi” da una crisi di debiti includono: – Conoscere la propria situazione finanziaria in modo approfondito e continuo, attuando gli adeguati assetti obbligatori per legge . – Non isolarsi: coinvolgere tempestivamente creditori chiave, organi sociali e professionisti in un dialogo costruttivo, prima che la sfiducia provochi azioni legali irreversibili. – Sfruttare le protezioni legali esistenti: se necessario, attivare per tempo la composizione negoziata con misure protettive , o presentare un’istanza di concordato preventivo per congelare le aggressioni dei creditori. È meglio chiedere una pausa legale per riorganizzarsi che subire passivamente pignoramenti e decreti. – Elaborare un piano credibile di risanamento o liquidazione ordinata: che sia un piano attestato, un accordo ex art.57 o un concordato, il fulcro è un progetto realistico, sostenuto da numeri e garanzie, da sottoporre ai creditori. Un piano vago o irrealistico verrà respinto e peggiorerà solo la situazione. – Agire con correttezza e buona fede: sul piano sostanziale (evitando atti in frode, preferenze occulte, distrazioni) e sul piano formale (documentando decisioni e operazioni). Ciò non solo aumenta le chance di salvare l’impresa, ma tutela gli amministratori da future responsabilità. Le più recenti sentenze dimostrano che i tribunali non tollerano più gestioni opache: ogni decisione deve essere giustificata e tracciabile . – Valutare le responsabilità personali: gli amministratori devono sempre chiedersi “questa scelta nuoce ingiustificatamente ai creditori? Sto aggravando il dissesto senza prospettive concrete di recupero?”. Se la risposta è sì, occorre cambiare rotta – anche rinunciando all’incarico se i soci impediscono le azioni doverose. Meglio un passo indietro dignitoso che incorrere in condotte di mala gestio che possano portare a dover risarcire milioni di euro . – Considerare l’opzione liquidatoria come ultimo rimedio: se il risanamento non è possibile, è preferibile gestire la liquidazione dell’impresa in modo ordinato (tramite concordato liquidatorio o liquidazione controllata) piuttosto che lasciare che il fallimento arrivi disordinatamente. Ciò consente di massimizzare il valore residuo a favore dei creditori e spesso di evitare imputazioni penali. Anche l’imprenditore individuale ha oggi possibilità di esdebitazione dopo la liquidazione, se agisce onestamente.
In definitiva, “difendersi” dai debiti non significa attuare stratagemmi per sfuggire ai creditori – quell’epoca è finita, perché la legge e la giurisprudenza moderne individuano e sanzionano tali condotte. Significa piuttosto governare attivamente la crisi, scegliendo la strategia legale più adatta e portandola avanti con professionalità e buona fede. Una gestione accorta può spesso trasformare una crisi mortale in un’occasione di ristrutturazione e rilancio; al contrario, l’immobilismo o i tentativi illeciti di sopravvivere portano quasi sempre alla fine dell’impresa e a gravi conseguenze per chi la guida.
Come questo lungo percorso argomentativo ha mostrato, esistono soluzioni anche nelle situazioni più difficili: abbiamo visto aziende salvarsi grazie ad accordi innovativi con i creditori, o imprenditori evitare la rovina personale adottando le misure giuste al momento giusto. L’augurio per chi legge – avvocato, imprenditore o privato interessato – è di poter mettere in pratica questi principi e strumenti all’occorrenza, preservando il valore dell’impresa e i propri diritti nella cornice della legalità.
Fonti e Riferimenti
- Codice Civile: artt. 2086, 2392, 2393, 2394, 2476, 2486 c.c. – Doveri dell’imprenditore e degli amministratori, azioni di responsabilità. (Modifiche introdotte dal D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022): artt. 12-25 (Composizione negoziata della crisi) ; artt. 56 (Piani attestati di risanamento) ; 57-64 (Accordi di ristrutturazione, incl. art. 60 “agevolati” e 61 “ad efficacia estesa”) ; artt. 84-120 (Concordato preventivo – in continuità e liquidatorio) ; artt. 121-122 (Risoluzione del concordato); art. 255 (Azione di responsabilità esercitata dal curatore) .
- D.Lgs. 83/2022 (Attuazione direttiva UE 2019/1023): modifiche al CCII, in particolare nuove soglie per cram-down fiscale e introduzione accordi ad efficacia estesa .
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021: istituzione Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato (art. 25-sexies CCII).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): ancora vigente per reati fallimentari (artt. 216 ss. R.D. 267/42 – bancarotta fraudolenta, semplice, preferenziale).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: art. 36 – Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per distribuzioni in pregiudizio al Fisco .
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): art. 10-bis (Omesso versamento ritenute ≥ €150k), art. 10-ter (Omesso versamento IVA ≥ €250k).
- Cass., Sez. Unite, 1989, n. 2079 e n. 2767 – Principio di esclusiva responsabilità patrimoniale della società per debiti tributari, salvo art.36 DPR 602/73 .
- Cass. civ. sez. I, 2 aprile 2025 n. 8696 – Esclusione di una responsabilità generale degli amministratori per i debiti fiscali sociali: l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali impedisce coobbligazioni degli amministratori, salvo ipotesi specifiche ex art.36 DPR 602/73 .
- Cass. civ. sez. I, 28 agosto 2025 n. 23963 – Responsabilità dell’amministratore che esegue pagamenti in conflitto di interessi a danno della società: violazione dovere diligenza ex artt. 2476 c.c. e 1176 c.c.; business judgment rule e suoi limiti .
- Cass. civ. sez. I, 2024 (pronuncia richiamata da dottrina) – Gestione continuata dopo perdita capitale sociale = gestione temeraria: amministratori responsabili ex art. 2486 c.c. per aggravamento del dissesto .
- Tribunale di Milano, sent. n. 6406/2025 – Caso di distrazione di attivi da parte di amministratore (crediti ceduti gratuitamente e prelievi ingiustificati): condanna dell’amministratore a risarcire ~€500.000; onere a suo carico di provare l’interesse sociale degli atti, altrimenti sono qualificati come distrazioni .
- Corte d’Appello di Bologna, 2024 – Responsabilità dei consiglieri di amministrazione “silenti” privi di deleghe per omesso controllo: obbligo di attivarsi, il mero silenzio = colpa grave, condanna degli amministratori non operativi che non hanno vigilato .
- Cass. civ. 2025 (richiamata da dottrina Rinaldi) – Falsità del bilancio come fonte autonoma di responsabilità verso soci e creditori, anche senza fallimento: amministratori condannati per aver occultato perdite e indotto terzi in errore .
- Cass. civ. sez. I, 6 maggio 2021 n. 8811 – Conferma inesistenza di responsabilità personale degli amministratori per debiti tributari societari (precedente citato da Cass.8696/2025) .
- Cass. civ. sez. I, 17 giugno 2021 n. 16410 – Nullità delle fideiussioni omnibus conformi schema ABI 2003 per violazione antitrust (rilevanza nelle opposizioni dei garanti).
- Cass. pen. sez. V, 29 luglio 2022 n. 30477 – False comunicazioni sociali: anche omissioni informative e bilanci “abbreviati” che occultano dati possono integrare il reato; rilevanza in contesto di crisi (massimata in dottrina Rinaldi).
- Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2023 n. 15200 – Revocatoria ex art. 166 CCII di atti a titolo gratuito compiuti prima del concordato preventivo; (in tema di atti in frode e ruolo organi controllo).
- Cass. civ. sez. I, 8 giugno 2023 n. 15862 – Fallimento omisso medio dopo risoluzione di concordato preventivo: l’omologazione del concordato non rende intoccabile l’istanza di fallimento presentata in precedenza, che può essere accolta se il concordato viene meno .
La tua azienda che produce, installa o commercializza sistemi di messa a terra, dispersori, cordini in rame, picchetti, trecce, barre equipotenziali, morsetti, collettori e componenti per impianti di protezione elettrica si trova in una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, installa o commercializza sistemi di messa a terra, dispersori, cordini in rame, picchetti, trecce, barre equipotenziali, morsetti, collettori e componenti per impianti di protezione elettrica si trova in una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, fornitori, banche o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il tuo settore richiede materiali costosi come rame, acciaio zincato, ottone, oltre a manodopera qualificata, certificazioni, collaudi e normative restrittive. Basta un rallentamento nei flussi di cassa per generare una crisi finanziaria immediata.
La buona notizia?
La tua azienda può essere difesa e salvata.
Con la strategia giusta puoi bloccare i creditori, ridurre i debiti e mantenere la continuità operativa.
Perché un’Azienda di Sistemi di Messa a Terra Finisce in Debito
Le cause principali includono:
• aumento dei costi delle materie prime (rame, acciai, materiali conduttivi)
• ritardi nei pagamenti da parte di imprese e clienti industriali
• magazzino immobilizzato tra cordini, picchetti, morsetti, barre e accessori
• lavori in appalto o installazioni da pagare in anticipo rispetto agli incassi
• investimenti obbligati in certificazioni e strumenti di misura
• aumento dei costi energetici
• riduzione o revoca di linee di credito bancarie
• cicli di realizzazione lunghi e impegnativi
Il problema non è l’assenza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per una Azienda di Sistemi di Messa a Terra con Debiti
Se non intervieni rapidamente rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti bancari
• sospensione delle forniture di materiali critici
• decreti ingiuntivi e precetti
• sequestro di magazzino, attrezzature e materiale conduttivo
• ritardi nelle installazioni e perdita di contratti
• perdita di clienti strategici
• rischio concreto di fermo operativo
Un debito non gestito può paralizzare la tua attività in pochissimi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1) Bloccare immediatamente i creditori
Con il supporto di un avvocato specializzato puoi:
• sospendere pignoramenti e azioni esecutive
• bloccare richieste di rientro delle banche
• evitare il congelamento dei conti correnti
• gestire i fornitori più pressanti
Prima si ferma l’emergenza, poi si ricostruisce.
2) Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
I debiti spesso contengono:
• interessi illegittimi
• sanzioni e more non corrette
• somme duplicate
• debiti prescritti
• errori di conteggio della Riscossione
• commissioni bancarie abusivamente applicate
Ridurre il debito è spesso possibile e in modo significativo.
3) Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di pagamento con fornitori critici
• rinegoziazione degli affidamenti bancari
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• accesso alle definizioni agevolate, quando disponibili
Obiettivo: ristabilire liquidità e continuare a lavorare.
4) Utilizzare gli strumenti legali che proteggono l’azienda
Per debiti elevati esistono strumenti molto efficaci:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione
• concordato minore
• liquidazione controllata (solo come ultima scelta)
Questi strumenti consentono di:
• bloccare ogni creditore
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte del debito
• continuare la produzione e le installazioni
• proteggere l’imprenditore
Sono soluzioni sicure e riconosciute dal Tribunale.
5) Proteggere produzione, forniture e magazzino
Nel tuo settore è fondamentale:
• tutelare rame, barre, morsetti, cordini e semilavorati
• mantenere attivi i fornitori principali
• evitare sequestri che bloccherebbero la catena di lavoro
• proteggere strumenti di misura e attrezzature tecniche
• garantire continuità nelle installazioni e nei collaudi
La produzione deve continuare per superare la crisi.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco completo dei debiti (commerciali, bancari, fiscali)
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario di magazzino (rame, barre, morsetti, cavetti, semilavorati)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e piani di installazione
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziale: 3–12 mesi
Le tutele possono attivarsi già dai primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione concreta dei debiti
• Protezione di magazzino, materiali e attrezzature
• Trattative efficaci con fornitori, banche e Riscossione
• Continuità produttiva e operativa assicurata
• Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti e atti giudiziari
• Accendere nuovi debiti per pagarne altri
• Scegliere chi pagare senza strategia
• Lasciare avanzare decreti e pignoramenti
• Affidarsi a società “miracolose” o non qualificate
Ogni errore può aggravare la crisi.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato delle azioni esecutive
• Piani di ristrutturazione su misura
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Riscossione
• Protezione totale per azienda e imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di sistemi di messa a terra non significa dover chiudere.
Con una strategia tempestiva puoi:
• bloccare i creditori
• ridurre drasticamente i debiti
• proteggere materiali e produzione
• mantenere continuità operativa
• salvare il tuo futuro imprenditoriale
Agisci ora: ogni giorno conta.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.