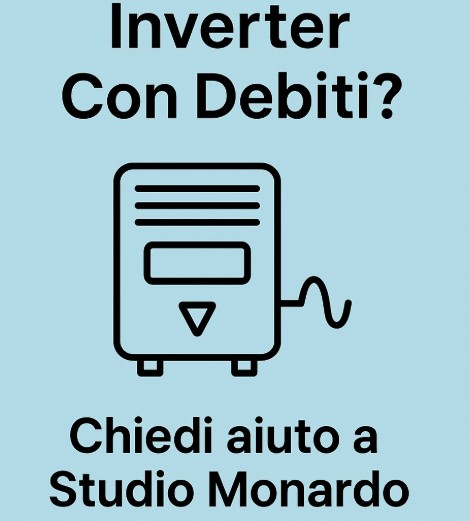Se gestisci un’azienda che produce, importa o distribuisce inverter industriali, inverter per motori, inverter per pompe, inverter per fotovoltaico, sistemi di controllo della velocità, convertitori di frequenza e alimentatori elettronici, e ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente critica.
Il tuo settore dipende da componenti elettronici costosi, approvvigionamenti continui, puntualità nelle consegne e rapporti stabili con industrie, produttori e impiantisti.
Per questo un blocco causato dai debiti può interrompere commesse, fermare installazioni e compromettere rapporti strategici con i clienti.
La buona notizia è che, se agisci subito, puoi bloccare pignoramenti, ristrutturare i debiti e salvare l’azienda.
Perché le aziende di inverter accumulano debiti
Le cause più frequenti sono:
- costi elevati di componenti elettronici, semiconduttori e moduli di potenza
- aumenti dei prezzi della componentistica importata
- tempi di pagamento lunghi da parte di impiantisti e industrie
- magazzini costosi con inverter di varie potenze e configurazioni
- ritardi nei pagamenti di IVA, imposte e contributi
- difficoltà nell’ottenere credito bancario sufficiente
- investimenti necessari per certificazioni, test e aggiornamenti firmware
- fornitori strategici che richiedono pagamenti rapidi
Questi fattori possono facilmente portare a una spirale di debiti e crisi di liquidità.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
La priorità è evitare il peggioramento della situazione. Ecco i passi immediati:
- far analizzare la posizione debitoria da un avvocato specializzato in debiti aziendali
- verificare quali debiti sono corretti, prescritti o contestabili
- evitare accordi improvvisati o piani di rientro insostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti
- attivare rateizzazioni realmente sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
- proteggere fornitori critici e componenti indispensabili
- prevenire il blocco del conto corrente o la riduzione dei fidi bancari
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o eliminare parte dei debiti
Una diagnosi professionale consente di capire quali debiti ridurre, congelare o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non intervieni in tempo, i rischi possono essere molto gravi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo delle attrezzature o dei mezzi
- blocco delle forniture di inverter e componenti elettronici
- impossibilità di completare installazioni o commesse industriali
- perdita di clienti, partner e impiantisti
- danni alla reputazione tecnica dell’azienda
- crisi di liquidità e mancato pagamento del personale
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore degli inverter, anche un piccolo ritardo può bloccare linee produttive dei clienti, aggravando la situazione.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato esperto in debiti aziendali può:
- bloccare immediatamente pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre l’importo complessivo dei debiti con trattative mirate
- ottenere rateizzazioni sostenibili con AE e INPS
- far annullare debiti prescritti, irregolari o mal notificati
- dialogare al posto tuo con fornitori e banche
- proteggere la continuità produttiva e le forniture critiche
- stabilizzare l’azienda mentre viene ristrutturato il debito
- evitare l’insolvenza o la chiusura
Una strategia professionale può salvare l’attività anche nelle fasi più difficili.
Come evitare il blocco dell’attività
Per continuare a operare senza interruzioni, è fondamentale:
- intervenire immediatamente prima che arrivino ulteriori azioni
- non trattare con creditori senza una strategia precisa
- tutelare le componenti essenziali e i fornitori critici
- ristrutturare i debiti prima dell’avvio dei pignoramenti
- individuare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare liquidità per garantire installazioni e consegne
Così puoi evitare fermi, penali e perdita di clienti importanti.
Quando rivolgersi a un avvocato
D dovresti farlo se:
- hai ricevuto intimazioni, solleciti o preavvisi di pignoramento
- hai debiti crescenti con AE Riscossione, INPS o fornitori
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità si sta riducendo rapidamente
- non riesci più a rispettare le scadenze
- vuoi evitare che la crisi sfoci in chiusura
Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e mettere in sicurezza la tua azienda.
Attenzione: molte aziende tecnologiche non falliscono per i debiti, ma per mancanza di una strategia tempestiva. Con il supporto giusto puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare davvero l’attività.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati specializzati in debiti aziendali, riscossione e difesa di imprese elettroniche e industriali – ti aiuta a proteggere la tua azienda di inverter.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare la tua attività.
Introduzione
Un’azienda manifatturiera di inverter fotovoltaici, fortemente indebitata, si trova a dover fronteggiare pressioni da banche, Fisco, fornitori e dipendenti. Cosa può fare l’imprenditore per difendersi e salvare l’impresa o, quantomeno, limitare i danni? Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi avanzata delle soluzioni disponibili nel diritto italiano, con prospettiva dal lato del debitore. Verranno esaminati i strumenti stragiudiziali e giudiziali di gestione della crisi d’impresa, incluse le procedure del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Si illustreranno casi pratici, tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti, il tutto con linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati, consulenti) sia a imprenditori e privati informati.
Dal 2019 in poi la normativa italiana ha subito una profonda riforma: il Codice della Crisi ha sostituito la vecchia legge fallimentare, introducendo obblighi di prevenzione e nuovi strumenti di risanamento. Ad esempio, oggi tutte le società hanno il dovere di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086, co.2 c.c.). Eppure, i dati indicano che solo il 3,5% delle imprese italiane dichiara di aver implementato tali assetti nei bilanci 2023 . Ciò segnala scarsa consapevolezza di questi obblighi e pone molte aziende di fronte a crisi non gestite in tempo. Per farvi fronte, il legislatore ha messo a disposizione procedure come la Composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021): questa è una soluzione volontaria e assistita che consente di negoziare coi creditori con l’aiuto di un esperto indipendente, prima che la situazione diventi irreversibile. Non a caso nel 2024 le richieste di composizione negoziata (1.089 istanze) hanno superato per la prima volta quelle di concordato preventivo (762 istanze), crescendo dell’83% rispetto all’anno precedente . Le imprese mostrano dunque una preferenza per strumenti precoce e flessibili di risanamento, evitando – ove possibile – le procedure concorsuali più invasive.
Tuttavia, non sempre è possibile evitare le soluzioni giudiziarie. I dati Unioncamere indicano che nel 2024 il numero totale di procedure concorsuali è aumentato del 22%, con 11.701 casi, di cui la gran parte (78,7%) liquidazioni giudiziali (nuovo nome del fallimento) . Ciò riflette le persistenti difficoltà delle imprese italiane in un contesto economico difficile e la necessità di conoscere come difendersi di fronte ai debiti aziendali. In questa guida analizzeremo:
- Le tipologie di debiti che un’azienda può avere (fiscali, bancari, verso fornitori, dipendenti, ecc.) e i relativi rischi.
- La differenza tra un’azienda ancora attiva e un’azienda in liquidazione o in concordato, dal punto di vista delle scelte difensive possibili.
- Gli strumenti di difesa stragiudiziali: rinegoziazione dei debiti, accordi con i creditori, piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata.
- Gli strumenti di difesa giudiziali: il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio, compreso il concordato semplificato introdotto di recente), la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e le procedure minori per piccole imprese.
- La responsabilità degli amministratori e degli organi sociali nella gestione della crisi: obblighi legali, rischi di azioni di responsabilità civili e sanzioni (anche penali) in caso di mala gestio.
- Una sezione di Domande e Risposte sulle questioni più frequenti (FAQ) che si pongono imprenditori e professionisti di fronte a debiti aziendali.
- Tabelle riepilogative per confrontare procedure e opzioni, nonché esempi pratici (simulazioni) di come potrebbe evolversi la situazione di un’azienda indebitata a seconda delle scelte fatte.
Importante: questa guida adotta il punto di vista del debitore (l’azienda in difficoltà e i suoi gestori), concentrandosi sugli strumenti di “difesa” volti a contenere le pretese dei creditori e a regolare la crisi. Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati sono aggiornati a ottobre 2025 e saranno indicati in una sezione finale Fonti e riferimenti, per consentire approfondimenti e verifica. Procediamo dunque ad esaminare in dettaglio ogni aspetto, iniziando dalle varie tipologie di debito che possono affliggere un’azienda e dal diverso impatto che ciascuna ha sulla strategia di difesa.
Tipologie di debiti e rischi per l’impresa
Non tutti i debiti sono uguali. Un’azienda può accumulare passività di natura diversa – debiti fiscali, contributivi, bancari, commerciali, verso il personale, ecc. – e ciascuna tipologia comporta rischi specifici e reazioni differenti da parte dei creditori. Prima di scegliere come muoversi, è fondamentale mappare i debiti e comprenderne le implicazioni. Di seguito analizziamo le principali categorie di debito e i relativi rischi per l’impresa debitrice.
Debiti fiscali e contributivi (Erario ed enti previdenziali)
I debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali (Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia, INPS, INAIL, ecc.) sono particolarmente insidiosi. Lo Stato dispone di poteri di riscossione coattiva privilegiati e mezzi di tutela speciali. Ad esempio, l’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteche su immobili aziendali o fermi amministrativi su veicoli per garantire il credito tributario, nonché procedere a pignoramenti su conti correnti e beni aziendali senza passare per un giudice (previa notifica di cartelle esattoriali e atti di precetto) . Inoltre, i crediti tributari e contributivi godono di privilegi nel fallimento (hanno una posizione preferenziale nel riparto) e, se l’impresa ha dipendenti, il mancato versamento di ritenute e contributi può esporre gli amministratori a sanzioni civili e penali.
Rischi specifici: In particolare, l’omesso versamento di IVA superiore a una certa soglia (oggi €250.000 per periodo d’imposta) o di ritenute fiscali sopra €150.000 è sanzionato penalmente (reati tributari) se non viene regolarizzato entro termini di legge. Analogamente, l’omesso versamento delle contribuzioni INPS trattenute ai dipendenti oltre soglie modeste integra fattispecie penali. Ciò significa che il protrarsi di debiti fiscali può comportare, oltre alle azioni esecutive sul patrimonio aziendale, anche responsabilità penale personale per gli amministratori (es. reato di omesso versamento IVA, art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Dal lato civilistico, in caso di procedura concorsuale, lo Stato come creditore tende ad avere voce in capitolo rilevante: per anni la regola è stata che senza accordo (transazione fiscale) con il Fisco non si potesse omologare un concordato preventivo, sebbene la normativa più recente consenta in taluni casi il cram-down fiscale (omologazione forzosa nonostante il dissenso del Fisco, purché la proposta sia non deteriore rispetto alla liquidazione) . Inoltre, se l’azienda viene cancellata senza pagare i debiti tributari, l’Amministrazione finanziaria può in alcuni casi perseguire i soci entro 5 anni dalla cancellazione (ai sensi dell’art. 28, co.4, D.Lgs. 175/2014) o chiedere la revocazione della cancellazione entro 1 anno per aprire comunque il fallimento (art. 10 L.F., oggi art. 33 CCII) .
Strategie difensive: Per difendersi da debiti fiscali, l’impresa può attivarsi su più fronti:
- Rateizzazioni e definizioni agevolate: La legge consente di chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione la dilazione delle cartelle esattoriali. Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore regole più favorevoli (D.Lgs. 110/2024) che permettono piani fino a 120 rate mensili (10 anni) in presenza di temporanea difficoltà, e senza necessità di dare garanzie per debiti sotto €120.000 . Inoltre, se la normativa lo prevede, si può aderire a eventuali “rottamazioni” o definizioni agevolate delle cartelle (strumenti straordinari concessi con leggi finanziarie, che abbattono sanzioni e interessi). Ad esempio, la Rottamazione-quater prevista dalla L. 197/2022 ha consentito nel 2023 di estinguere i carichi affidati a riscossione pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni né interessi. Queste opportunità, quando disponibili, vanno colte per ridurre l’esposizione fiscale.
- Transazione fiscale e contributiva: Nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre al Fisco e agli enti previdenziali una transazione fiscale (art. 63 CCII, ex art. 182-ter L.F.), con pagamento parziale di imposte e contributi e stralcio di sanzioni e interessi. Oggi, grazie alla riforma 2020-2022, il tribunale può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche senza l’adesione formale dell’Erario/INPS, se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria . Ciò toglie al Fisco un potere di veto che aveva in passato, facilitando i piani di risanamento. Anche fuori dalle procedure concorsuali, durante la composizione negoziata della crisi è ora possibile negoziare col Fisco la riduzione di sanzioni e interessi: il D.Lgs. 83/2022 ha esteso l’istituto della transazione fiscale in modo coordinato con la composizione negoziata , incentivando l’Erario a accettare soluzioni transattive precoci.
- Sospensione e ricorsi: Se i debiti sono contestati (ad es. cartelle per avvisi di accertamento impugnati), l’azienda deve valutare ricorsi tributari o previdenziali. In presenza di causa pendente, si può ottenere la sospensione delle azioni esecutive dell’Agente della Riscossione presentando istanza in commissione tributaria o al giudice del lavoro (per contributi) ed eventualmente chiedendo al tribunale un provvedimento d’urgenza. Tuttavia, va ponderato che fare causa al Fisco richiede base giuridica solida e non ferma automaticamente le azioni, se non nei limiti di quanto impugnato e solo con provvedimento ad hoc.
Da ultimo, è essenziale evitare condotte che aggravino la posizione personale: ad esempio, non distrarre liquidità dell’azienda per altri fini quando ci sono imposte non pagate, perché ciò potrebbe configurare reati o comunque mala gestio. Se l’insolvenza appare irreversibile, è preferibile gestire la chiusura con una procedura formale (concordato o liquidazione) piuttosto che accumulare ulteriori debiti fiscali: i crediti erariali infatti non si estinguono con la cancellazione societaria e possono essere fatti valere contro soci e liquidatori colpevoli (art. 2495 c.c. e normative speciali) .
Debiti bancari e finanziari
I debiti bancari (mutui, finanziamenti, scoperti di conto, leasing) e verso altri finanziatori (società di leasing, factor, obbligazionisti) rappresentano spesso l’esposizione più rilevante per un’azienda indebitata. Le banche in genere vantano garanzie a presidio dei crediti: ipoteche su immobili, pegni su macchinari o su azioni, fideiussioni personali di soci o amministratori, cessioni di credito, ecc. Pertanto, quando l’azienda fatica a pagare le rate, l’istituto di credito può reagire rapidamente escutendo le garanzie: ad esempio, escutendo la fideiussione (chiedendo ai garanti il pagamento integrale), avviando l’espropriazione degli immobili ipotecati o dei beni dati in leasing (risolvendo il contratto di leasing con restituzione del bene), o notificando un decreto ingiuntivo e attivando pignoramenti. I creditori bancari, specie se garantiti da pegno o ipoteca, in caso di fallimento hanno privilegi e prelazioni che li pongono ai primi posti nel soddisfo.
Rischi specifici: Un rischio immediato per l’imprenditore è la responsabilità personale da fideiussione. Nella prassi, per erogare credito a PMI, le banche richiedono ai soci o amministratori di firmare garanzie personali o di emettere cambiali. Se l’azienda diventa insolvente, la banca può aggredire il patrimonio personale del garante (ad es. la casa di proprietà) senza attendere oltre. Inoltre, l’apertura di una crisis o procedura concorsuale sull’azienda spesso comporta la segnalazione a centrale rischi e rende le banche meno disponibili a negoziare: il rapporto si deteriora e diventa conflittuale, con rischio di revoca di fidi e rientro immediato di tutte le esposizioni. In caso di concordato preventivo, i crediti bancari chirografari subiranno generalmente falcidie, mentre i crediti garantiti (ipotecari, pignoratizi) dovranno essere soddisfatti almeno in misura pari al valore del bene dato in garanzia (per legge, il concordato non può alterare il diritto di prelazione oltre quella soglia, art. 84 CCII). Va ricordato infine che eventuali finanziamenti soci presenti nel bilancio aziendale diventano postergati: se i soci avevano prestato denaro all’azienda, quel credito è subordinato al pagamento degli altri creditori (art. 2467 c.c. per le s.r.l.), dunque di fatto non verrà pagato finché gli altri non siano soddisfatti integralmente – una tutela per le banche e i terzi.
Strategie difensive: Per gestire i debiti bancari, l’azienda debitrice ha varie opzioni:
- Rinegoziazione del debito e moratorie: Prima di arrivare all’insolvenza conclamata, si può cercare un accordo con la banca per rimodulare i pagamenti. Ad esempio, chiedere una moratoria temporanea (sospensione delle rate per 6-12 mesi) o un allungamento dei piani di ammortamento (spalmando il debito su più anni per ridurre la rata). Negli ultimi anni associazioni di categoria e normative emergenziali (ad es. moratorie Covid-19) hanno talora previsto sospensioni generalizzate. Al di fuori di tali contesti, la banca valuterà caso per caso: è essenziale presentare un piano credibile (es. nuove commesse in arrivo, taglio di costi, ecc.) e magari offrire garanzie aggiuntive o una parziale ricapitalizzazione. L’obiettivo è guadagnare tempo e preservare la continuità aziendale. Attenzione: rinegoziare serve se la crisi è temporanea; se il debito è strutturalmente insostenibile, si rischia solo di posticipare il default.
- Accordo transattivo a saldo e stralcio: Se l’azienda dispone di una somma immediata (propria o apportata da terzi) inferiore al debito ma significativa, può proporre alla banca un saldo e stralcio: pagamento in un’unica soluzione di una parte del dovuto, con stralcio del residuo. Le banche sono disponibili a stralci principalmente quando ritengono che, in caso di fallimento, incasserebbero ancora meno. Ad esempio, se un mutuo ipotecario eccede il valore attuale dell’immobile, la banca potrebbe accettare una cifra pari al valore di mercato per liberare il bene. Tali accordi vanno negoziati con cura (spesso con assistenza di un advisor finanziario) e formalizzati per iscritto, includendo la liberazione dei garanti. Infatti, è cruciale far inserire la liberatoria per le fideiussioni: altrimenti, la banca potrebbe accettare il pagamento ridotto dall’azienda e poi rivalersi sui garanti per la differenza. Un accordo ben fatto prevede che, a fronte del pagamento concordato, la banca rinunci a qualsiasi ulteriore pretesa sia verso l’azienda che verso i garanti.
- Consolidamento o riscadenzamento del debito: Una soluzione di medio termine può essere il refinancing: cercare un nuovo finanziatore (magari un investitore o un’altra banca) disposto a erogare liquidità per rimborsare i debiti esistenti, ma a condizioni più sostenibili. Ciò può assumere la forma di un nuovo mutuo a lungo termine che estingue linee a breve onerose, oppure l’ingresso di un socio finanziatore che apporta capitale (equity) o quasi-equity (strumenti partecipativi) riducendo il leverage. Chiaramente, questa strada è praticabile solo se l’impresa ha ancora prospettive di redditività e se la crisi non è irreversibile. Uno strumento normativo utile in tal senso è il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, v. infra) che consente di eseguire accordi di finanziamento esenti da revocatoria fallimentare, a patto che un esperto li attesti come idonei a risanare l’azienda. Le banche potrebbero essere più propense a partecipare a un piano di risanamento formalmente attestato, magari contribuendo con nuova finanza prededucibile (che verrà rimborsata con priorità in caso di successivo default).
- Strumenti concorsuali protettivi: Se i negoziati privati non approdano a nulla e si rischia l’aggressione da parte delle banche (pignoramenti, escussione garanzie), il debitore può valutare l’accesso a procedure concorsuali che automaticamente congelano le azioni esecutive. Ad esempio, la presentazione di una domanda di concordato preventivo comporta immediatamente il divieto per i creditori di iniziare o proseguire esecuzioni individuali (art. 54 CCII, corrispondente all’art. 168 L.F. ). Ciò può bloccare temporaneamente le revoche di fido e le escussioni, offrendo respiro all’impresa mentre predispone un piano. Anche la composizione negoziata consente, su istanza dell’imprenditore, di ottenere dal tribunale misure protettive del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive fino a 4 mesi, prorogabili) durante le trattative (art. 20 CCII). Occorre però un serio intento di risanamento; l’abuso di tali strumenti solo per ritardare il pagamento è sconsigliabile e potrebbe essere sanzionato (ad esempio con l’inammissibilità della domanda di concordato se proposta in mala fede).
In ogni caso, per difendersi efficacemente dai debiti bancari è fondamentale mantenere un dialogo trasparente con gli istituti finanziatori, mostrare un piano realistico e – dal punto di vista legale – evitare atti preferenziali tra creditori. Pagare una banca lasciando indietro il Fisco o viceversa, in situazione di insolvenza, può esporre gli amministratori all’azione revocatoria successiva (il curatore potrà chiedere la restituzione di quanto pagato a ridosso del fallimento, di regola i pagamenti preferenziali entro 6 mesi sono revocabili, art. 164 CCII) e perfino a responsabilità per violazione della par condicio creditorum. Meglio quindi perseguire soluzioni globali e concordate con l’intero ceto creditorio, se possibile.
Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
Questa categoria include i debiti verso fornitori di beni e servizi, i debiti verso appaltatori, consulenti, locatori (affitti non pagati), utenze e in generale tutti i creditori non finanziari né privilegiati. Sono in maggioranza debiti chirografari (senza garanzie reali), che in caso di fallimento vengono soddisfatti pro-quota solo dopo i privilegiati. Ciò significa che dal punto di vista del debitore, questi creditori sono i più “fragili” nell’azione esecutiva singola (non avendo garanzie speciali se non eventualmente riserva di proprietà su beni forniti, se pattuita), ma sono anche spesso cruciali per la continuità aziendale. Infatti, se i fornitori chiave smettono di rifornire la società per insolvenza, l’attività produttiva o commerciale rischia il collasso.
Rischi specifici: Il rischio principale è la perdita di fiducia da parte dei partner commerciali. Un fornitore non pagato potrebbe interrompere le forniture (facendosi pagare anticipato per le prossime consegne, o rifiutando nuovi ordini) e magari recedere dai contratti in essere se la controparte non onora i pagamenti. Dal punto di vista legale, molto dipende dalle clausole contrattuali: alcuni contratti prevedono espressamente la risoluzione automatica in caso di mancato pagamento o in caso di assoggettamento a procedura concorsuale (clausole risolutive). Occorre sapere che, in caso di concordato preventivo, la legge impedisce ai fornitori di risolvere i contratti di fornitura essenziali solo in base alla presentazione della domanda di concordato (art. 94 CCII, ex art. 186-bis L.F.), e analogamente in composizione negoziata vige un divieto temporaneo di sospensione delle forniture essenziali da parte dei creditori pubblici o privati strategici (come utenze) per il solo motivo dei mancati pagamenti pregressi (art. 19 CCII). Tuttavia, al di fuori di queste tutele temporanee, il rischio di perdita dei rapporti commerciali è concreto. Dal lato delle azioni legali, un fornitore insoluto può ottenere velocemente un decreto ingiuntivo e procedere a pignoramenti di beni o crediti (ad es. pignorare i conti correnti o i crediti verso clienti dell’azienda). Pur essendo un chirografario, in fase esecutiva singolare un fornitore può arrivare a soddisfarsi in via forzata se individua beni liberi. In caso di fallimento, però, se il bene pignorato non era ancora stato assegnato, il suo pignoramento confluisce nel concorso collettivo e il fornitore concorrerà con gli altri. Infine, c’è il rischio reputazionale: avere molti fornitori insoddisfatti nel settore può far scattare un “allarme filiera”, con altri partner che iniziano a pretendere pagamento anticipato, i clienti preoccupati di consegne mancate, ecc.
Strategie difensive: Con i fornitori, la parola d’ordine è negoziare tempestivamente e mantenere la continuità delle forniture essenziali. Ecco alcune possibili azioni:
- Piani di rientro e accordi individuali: Si può proporre a ciascun fornitore un piano di pagamento dilazionato del debito scaduto, magari riconoscendo in parte gli interessi di mora o offrendo qualche garanzia (cambiali agrarie, riconoscimento di debito) per ottenere fiducia. In tal modo il fornitore vede serietà nel voler pagare e potrebbe non intraprendere subito azioni legali. Questi accordi vanno formalizzati per iscritto, indicando le nuove scadenze e prevedendo che il creditore non procederà legalmente se il piano è rispettato. Attenzione: se l’azienda dovesse poi entrare in procedura concorsuale, i pagamenti fatti ai fornitori secondo il piano di rientro potrebbero essere soggetti a revocatoria (se effettuati nei termini di legge); tuttavia, talvolta si tollera il pagamento “in bonis” di fornitori strategici per preservare l’operatività. Conviene comunque consultare un legale per strutturare i piani di rientro in modo da ridurre il rischio di revocatoria (ad esempio, dilazionando oltre 6 mesi i pagamenti meno essenziali).
- Saldo e stralcio fornitori: Per i fornitori meno strategici o laddove vi siano risorse limitate, può essere conveniente negoziare un saldo e stralcio anche qui. Spesso piccoli fornitori preferiscono incassare subito, ad esempio, il 50-60% del credito in un’unica soluzione, piuttosto che intraprendere cause dall’esito incerto e lunghe. L’azienda deve valutare l’equità: un creditore chirografario in fallimento potrebbe prendere molto meno (spesso pochi centesimi per euro), quindi offrire un pagamento ridotto immediato può essere attrattivo. È essenziale però evitare discriminazioni ingiustificate: se si liquidano alcuni fornitori e altri no, chi resta escluso potrebbe sentirsi trattato slealmente e accelerare azioni giudiziarie. Meglio perseguire accordi con quanti più fornitori possibile, presentando la situazione generale e proponendo una percentuale equa per tutti (salvo differenze per importanza strategica). In un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (strumento giudiziale, v. oltre) sarà addirittura necessario trattare in modo omogeneo i creditori di pari grado o suddividerli in classi.
- Proteggere i rapporti essenziali: Identificare i fornitori “critici” (quelli senza cui la produzione si ferma, oppure i clienti chiave) e assicurarsi di non interrompere i pagamenti verso di essi, se possibile. Una strategia comune è “tirare la coperta” spostando risorse: ad esempio, ritardare al massimo chi non è strategico per poter pagare almeno in parte i fornitori vitali. In composizione negoziata, si può anche chiedere al Tribunale di autorizzare pagamenti di crediti pregressi indispensabili a proseguire l’attività (una deroga al principio di par condicio, prevista dall’art. 22 CCII), così che il debitore possa pagare ad esempio un fornitore critico arretrato e continuare a ricevere materie prime. Ciò va pianificato con il supporto dell’esperto nominato.
- Gestire i contratti in corso: Se l’azienda ha contratti a lungo termine (appalti, locazioni, forniture periodiche) e prevede difficoltà, può valutare di rinegoziarli o, se diventati insostenibili, di recedere quando possibile. Ad esempio, se un canone di locazione è troppo alto per le mutate condizioni, si può tentare una rinegoziazione col locatore (anche prospettando che altrimenti l’azienda potrebbe chiudere lasciandolo senza conduttore). In un eventuale concordato preventivo, l’impresa debitrice ha facoltà di sciogliersi da alcuni contratti in corso con autorizzazione del tribunale (art. 95 CCII), il che può aiutare a liberarsi di impegni onerosi – ma genererà crediti per risarcimento in capo alla controparte, da trattare nel concordato stesso come chirografari. Pertanto, vanno pesati costi e benefici.
In sintesi, coi fornitori l’arma principale del debitore è la credibilità: mostrare un piano di risanamento, dimostrare di volerli coinvolgere e non penalizzare oltre il necessario. Spesso la comunicazione trasparente ai fornitori sulla situazione (fin dove possibile senza violare obblighi societari di riservatezza) evita reazioni emotive e cause a catena. Se i fornitori credono nel progetto di rilancio, potrebbero accettare sacrifici temporanei. Viceversa, se si sentono tenuti all’oscuro, sarà più facile che agiscano individualmente per paura di perdere tutto.
Debiti verso dipendenti (retribuzioni e TFR)
I debiti verso i propri dipendenti – stipendi arretrati, ratei di tredicesima, trattamento di fine rapporto (TFR) non accantonati – hanno una valenza delicata: toccano la sfera dei diritti dei lavoratori, tutelati anche costituzionalmente, e possono innescare sia azioni giudiziarie rapide sia meccanismi di protezione sociali. Un’azienda insolvente spesso accumula mensilità non pagate, ma ciò non può protrarsi a lungo senza gravi conseguenze.
Rischi specifici: Innanzitutto il rischio umano e reputazionale: lavoratori non pagati possono legittimamente astenersi dal lavoro (per eccezione di inadempimento) o addirittura rassegnare dimissioni per giusta causa, privando l’azienda di forza lavoro qualificata e aggravando la crisi. Legalmente, i dipendenti possono ottenere decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi per le retribuzioni e, una volta muniti di titolo, iscrivere pignoramenti sui conti aziendali o su beni (spesso i macchinari però sono già gravati da leasing o garanzie bancarie, ma i conti correnti con residui di cassa possono essere aggrediti). In caso di procedura concorsuale, i crediti dei lavoratori per retribuzioni degli ultimi mesi e per TFR godono di privilegio generale mobiliare (art. 2751-bis c.c.) che li colloca al primo posto nel riparto, subito dopo le spese di giustizia. Inoltre, esiste il Fondo di Garanzia INPS che, se l’azienda viene assoggettata a liquidazione giudiziale (fallimento) o altra procedura concorsuale equiparata, interviene a pagare ai dipendenti il TFR maturato e le ultime tre mensilità impagate, entro determinati massimali . In pratica, se l’impresa fallisce, il lavoratore può ottenere dal Fondo pubblico quanto gli era dovuto (nei limiti di legge), subentrando poi l’INPS tra i creditori della procedura. Anche in caso di concordato preventivo liquidatorio omologato, la giurisprudenza ha confermato che il Fondo INPS deve erogare integralmente il TFR ai lavoratori, nonostante la soddisfazione parziale in concordato . Dal lato penale, va segnalato che non è reato il semplice mancato pagamento di retribuzioni (debito civile), ma lo diventa se si configura come appropriazione indebita di trattenute: ad esempio, se l’azienda trattiene in busta paga contributi o quote sindacali e non li versa agli enti competenti, oppure se non versa le ritenute IRPEF operate sulle buste paga (reato di omesso versamento di ritenute, art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, oltre soglia). Anche l’omesso versamento dei contributi previdenziali a carico del datore sopra una certa soglia (circa €10.000 annui) era reato (ora depenalizzato entro certi limiti): resta un illecito amministrativo grave. In sostanza, sul piano giuslavoristico e penale, non pagare i dipendenti è un campanello d’allarme fortissimo per l’ordinamento.
Strategie difensive: La gestione dei debiti verso il personale richiede tatto e pianificazione:
- Coinvolgimento dei dipendenti nel risanamento: In situazioni di crisi, spesso i dipendenti – se correttamente informati – preferiscono accettare soluzioni transitorie piuttosto che vedere l’azienda chiudere. Ad esempio, può essere concordato (anche con l’ausilio sindacale) un slittamento nel pagamento degli stipendi, o la messa in cassa integrazione guadagni per crisi (ove disponibile) in modo da far pagare parte delle retribuzioni all’INPS. Durante la pandemia e oltre, molte imprese hanno utilizzato ammortizzatori sociali straordinari per alleggerire il costo del lavoro nei momenti critici. Se la crisi è settoriale, ci si può informare presso il Ministero del Lavoro per eventuali misure ad hoc (es. per grandi aziende insolventi è prevista l’Amministrazione Straordinaria con continuità, ma per PMI no).
- Transazione con i dipendenti usciti: Se alcuni lavoratori hanno lasciato l’azienda e vantano TFR e stipendi arretrati, si può tentare con loro una conciliazione in sede sindacale o presso l’Ispettorato del Lavoro: offrire il pagamento immediato di una percentuale (es. 80%) in cambio di quietanza saldo e stralcio. Questo è utile perché un ex-dipendente, non avendo più nulla da perdere, potrebbe essere il primo a chiedere il fallimento dell’azienda pur di attivare il Fondo di Garanzia. Mostrando invece volontà di pagare qualcosa subito, magari si evita l’azione istantanea. Si consideri che il deposito di un ricorso per fallimento da parte di un lavoratore (o qualunque creditore) è un evento serio: se il debito è certo e scaduto, il Tribunale può dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’impresa insolvente. A quel punto l’attività passa in mano al curatore. Quindi prevenire iniziative esterne è cruciale.
- Pagamenti autorizzati in concordato: Se l’azienda avvia una procedura di concordato preventivo, la legge impone di pagare regolarmente le retribuzioni correnti dei dipendenti durante la gestione fino all’omologa, se c’è continuità aziendale (art. 86 CCII). Quanto agli arretrati, spesso il piano di concordato prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati dei lavoratori (per soddisfare il privilegio) magari con utilizzo del Fondo INPS per il TFR. Anche nella composizione negoziata, il debitore può chiedere misure protettive purché paghi la parte di retribuzione dovuta ai lavoratori per la prestazione svolta durante le misure (art. 20, co.6 CCII), quindi almeno le paghe correnti vanno garantite. Conclusione: se si entra in procedura, i dipendenti recenti vanno protetti: il successo del risanamento dipende anche dal mantenere la forza lavoro motivata e legalmente tutelata.
- Responsabilità personali: Gli amministratori, per cautelarsi, dovrebbero documentare ogni sforzo fatto per pagare i dipendenti e l’eventuale impossibilità per mancanza di liquidità. Così, se in futuro un giudice dovesse valutare la condotta (ad esempio in un’azione di responsabilità o in sede penale), risulterà che non c’è stata volontà dolosa di arricchirsi a discapito dei lavoratori. Evitare assolutamente situazioni come prelevare cassa per pagare soci o creditori non lavoratori lasciando indietro le paghe: questo sarebbe indizio di possibile bancarotta preferenziale a danno dei lavoratori, passibile di sanzione penale nella successiva procedura fallimentare (artt. 322 e 323 CCII, eredi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale). In sintesi, la difesa migliore è la correttezza: se proprio non si può pagare tutto, pagare almeno parzialmente tutti in modo equilibrato.
Da notare che, in caso di cessazione dell’attività e liquidazione, i debiti verso dipendenti rimasti insoddisfatti saranno in gran parte assorbiti dal Fondo pubblico. Ma questo non significa che il datore di lavoro possa disinteressarsene: una mala gestione del personale in crisi (ad es. non attivare la cassa integrazione disponibile, accumulare mesi su mesi di stipendi non pagati senza prospettive) potrebbe esporre a contestazioni e a sanzioni. Pertanto, la gestione dei debiti verso il personale deve essere ispirata a principi di tempestività, trasparenza e rispetto della dignità dei lavoratori, contemperando le esigenze di cassa con le tutele legali esistenti.
Riepilogo dei rischi per tipo di debito
Di seguito una tabella riepilogativa che confronta le principali tipologie di debito, i rischi che comportano per l’azienda debitrice e alcuni strumenti specifici di difesa:
| Tipo di Debito | Rischi per l’impresa debitrice | Strumenti di difesa (esempi) |
|---|---|---|
| Fiscale (Erario) | – Azioni esecutive rapide (ipoteche, pignoramenti) senza giudice.<br>– Privilegi sui beni in caso di procedura concorsuale.<br>– Sanzioni e interessi elevati in caso di ritardo.<br>– Possibile responsabilità penale amm.re se omessi versamenti rilevanti.<br>– In caso di chiusura società, possibili azioni contro soci/liquidatori. | – Rateizzazione fino a 10 anni (post 2025) .<br>– Definizioni agevolate (rottamazioni) se disponibili.<br>– Transazione fiscale nei piani di ristrutturazione .<br>– Misure protettive in concordato (blocco esecuzioni). |
| Contributivo (INPS) | – Equivalente ai rischi fiscali: esecuzioni coattive, privilegi.<br>– Responsabilità penale per mancato versamento ritenute previdenziali.<br>– Azioni di recupero vs soci/liquidatori post-chiusura (simile a debiti fiscali). | – Rateizzazione contributi (simile a fiscale).<br>– Transazione contributiva in concordato (art. 63 CCII)【45†】.<br>– Utilizzo Cassa Integrazione per evitare nuovi debiti.<br>– Fondo di Garanzia INPS interviene su TFR e ultime retribuzioni in fallimento. |
| Bancario/Finanziario | – Escussione immediata di garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni personali).<br>– Revoca fidi e credito, crisi di liquidità acuta.<br>– Pignoramenti su beni dati in garanzia (leasing risolti ecc.).<br>– In procedura concorsuale: credito privilegiato fino a concorrenza garanzia (meno rischio per banca).<br>– Segnalazioni a Centrale Rischi (danneggiano rating). | – Moratorie e accordi di standstill con le banche.<br>– Rinegoziazione tassi e piani (allungamento durata).<br>– Consolidamento debiti con nuovo finanziatore.<br>– Saldo e stralcio (se fondi disponibili, con liberatoria fideiussioni).<br>– Concordato preventivo o composizione negoziata per sospendere azioni esecutive (stay) . |
| Commerciale (Fornitori) | – Interruzione forniture e servizi essenziali (blocco attività).<br>– Azioni legali individuali (ingiunzioni, pignoramenti) – anche se chirografari possono danneggiare.<br>– Risoluzione contratti in corso per inadempimento (rischio filiera).<br>– Perdita reputazione verso clienti/mercato. | – Accordi di dilazione (piani di rientro) con fornitori chiave.<br>– Saldi e stralci per creditori minori (pagamento % una tantum).<br>– Pagamenti strategici autorizzati dal tribunale (art. 22 CCII) durante composizione negoziata per forniture essenziali.<br>– Clausole contrattuali di salvaguardia (ove possibili) e gestione proattiva dei contratti pendenti (es. scioglimento concordatario di contratti onerosi). |
| Personale (Dipendenti) | – Astensioni dal lavoro, dimissioni in massa per giusta causa (fermo produzione).<br>– Decreti ingiuntivi e pignoramenti su conti aziendali.<br>– Richieste di fallimento da parte di dipendenti licenziati non pagati.<br>– Privilegi nel fallimento (pagati prima degli altri creditori su attivo disponibile).<br>– Intervento del Fondo di Garanzia INPS (ma solo se l’azienda entra in procedura concorsuale liquidatoria).<br>– Potenziali profili di responsabilità penale (omesso versamento ritenute) per gli amministratori. | – Negoziazioni sindacali: cassa integrazione, contratti di solidarietà per ridurre costi.<br>– Piani di pagamento concordati del pregresso (es. pagamento parziale TFR con dilazione, con assenso lavoratore).<br>– Concordato preventivo: pagamento integrale crediti privilegiati lavoratori previsto nel piano (spesso con aiuto Fondo INPS) .<br>– Utilizzo di ammortizzatori sociali straordinari se disponibili (es. Fondo di garanzia salariale).<br>– Condotta trasparente e documentata degli amministratori (a propria tutela in caso di inchieste). |
Nota: La tabella sopra semplifica alcune situazioni complesse; in particolare le “azioni post-chiusura verso soci/liquidatori” si riferiscono alla responsabilità ex art. 2495 c.c., che sarà discussa più avanti.
Stato dell’azienda: impresa attiva vs in liquidazione o concordato
Le strategie di difesa di cui sopra vanno calibrate anche in base allo stato attuale dell’azienda: non è la stessa cosa agire quando l’impresa è ancora in bonis e operativa, rispetto a quando è già in liquidazione o dentro una procedura concorsuale (es. concordato). Vediamo le differenze principali e come incidono sulle possibili mosse del debitore.
Impresa ancora attiva (in bonis o in crisi iniziale)
Un’azienda attiva è quella che, formalmente, non è stata ancora dichiarata insolvente da un tribunale né ha deliberato la propria liquidazione volontaria. Può essere in difficoltà (“stato di crisi”) ma continua l’attività d’impresa sotto la guida degli amministratori in carica. In questo scenario, i gestori conservano pieni poteri di gestione (salvo eventuali limitazioni statutarie o interventi degli organi di controllo) e soprattutto hanno a disposizione tutte le opzioni di risanamento: possono negoziare liberamente con i creditori, attivare strumenti come la composizione negoziata, predisporre piani attestati o accordi, oppure – se necessario – presentare domanda di concordato preventivo o altre procedure concorsuali. L’iniziativa è nelle mani del debitore, il quale dovrebbe agire tempestivamente per evitare l’aggravarsi della situazione.
Dal punto di vista normativo, un’azienda attiva in crisi ha degli obblighi di reazione precoce. Il Codice della Crisi definisce lo stato di crisi come “probabilità di futura insolvenza” e l’insolvenza come l’incapacità già attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni (art. 2 CCII). Gli amministratori devono attivarsi ai primi segnali: l’art. 2086 c.c. (come detto) impone di istituire assetti adeguati per rilevare la crisi e, quando la crisi emerge, di adottare senza indugio le idonee iniziative. Questo può significare, ad esempio, contattare consulenti specializzati, avviare la composizione negoziata, o almeno elaborare internamente un piano di risanamento. La mancata attivazione è fonte di responsabilità per gli amministratori (potranno risponderne ex art. 2486 c.c. per aver aggravato il dissesto – v. infra sulla responsabilità). Dunque, se l’azienda è ancora “padrona del proprio destino”, deve giocare d’anticipo: più la si tira in lungo, meno strumenti resteranno.
In pratica, un’impresa attiva può scegliere tra soluzioni stragiudiziali (accordi volontari con creditori) o giudiziali (attivare procedure concorsuali). Spesso si tenta prima la via stragiudiziale perché più rapida, riservata e meno impattante sulla reputazione; le vie giudiziali entrano in gioco se le trattative falliscono o se servono misure coercitive (come imporre ai dissenzienti un accordo tramite omologazione). Nel capitolo successivo vedremo nel dettaglio questi strumenti. Qui basti ribadire: finché l’azienda è in bonis, gli amministratori conservano l’iniziativa e hanno il dovere di valutare tutte le soluzioni di difesa per evitare il default. Persino decidere un fermo temporaneo dell’attività (es. chiusura per qualche mese per ridurre costi e smaltire debiti) è possibile se utile, purché conforme al dovere di gestione prudente.
Un accenno merita lo stato di “pre-liquidazione”: può capitare che, pur essendo ancora attiva, l’assemblea abbia ridotto il capitale sotto il minimo per perdite, o vi sia una causa di scioglimento (art. 2484 c.c., ad es. impossibilità di conseguire l’oggetto sociale). In tali casi gli amministratori sono tenuti a limitarsi ad atti di ordinaria amministrazione e a convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (art. 2485 c.c.). Se l’assemblea non ricapitalizza, la società si scioglie e va in liquidazione. Questo periodo è critico: gli amministratori non dovrebbero aggravare l’esposizione. La violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio in questa fase può determinare la loro responsabilità personale, quantificata proprio secondo i criteri del novellato art. 2486 c.c. (differenza tra patrimonio netto all’evento di scioglimento e quello alla successiva liquidazione, presumibile come danno) . Quindi, se l’impresa è tecnicamente “sciolta” ma non ancora liquidata formalmente, gli amministratori devono agire con estrema cautela e preferibilmente evitare di contrarre nuovi debiti se non strettamente indispensabili alla conservazione del valore.
Impresa in liquidazione volontaria
Quando la società ha già deliberato lo scioglimento e la liquidazione volontaria, cambia il quadro: gli amministratori decadono (salvo che l’assemblea li nomini anche liquidatori) e il controllo passa ai liquidatori nominati. L’obiettivo primario diventa liquidare l’attivo e pagare i debiti con il ricavato, cessando l’attività d’impresa salvo quanto utile alla liquidazione stessa. Un’azienda in liquidazione cessa di perseguire lo scopo di lucro e quindi, di regola, non può intraprendere nuove operazioni commerciali – a meno che queste non siano finalizzate a miglior realizzazione dell’attivo (es. completare lavori in corso per poterli vendere a prezzo migliore).
Dal punto di vista dei creditori, la liquidazione volontaria non è una procedura concorsuale giudiziale: i creditori non partecipano necessariamente in forma collettiva né c’è un tribunale coinvolto. Tuttavia, i liquidatori hanno obblighi fiduciari verso tutti i creditori: devono rispettare la parità di trattamento (par condicio creditorum), pagando prima i debiti privilegiati e poi, coi residui, i chirografari in proporzione. Se l’attivo non basta a saldare tutti, i liquidatori non possono distribuire nulla ai soci ovviamente. Se addirittura l’attivo è insufficiente a pagare integralmente i privilegiati, la liquidazione volontaria rischia di non poter chiudere senza incorrere in irregolarità – in tal caso spesso scatta l’iniziativa di creditori per far dichiarare il fallimento, oppure gli stessi liquidatori valutano di portare i libri in tribunale (dichiarazione di insolvenza). In generale, i liquidatori rispondono personalmente verso i creditori sociali se, per dolo o colpa, li pregiudicano (art. 2495 c.c.): ad esempio, se pagano in modo preferenziale taluni creditori lasciando altri insoddisfatti quando avrebbero potuto soddisfarli pro quota, possono essere citati in giudizio. La giurisprudenza ha individuato specifici casi di colpa grave del liquidatore (pagamenti preferenziali, bilancio finale falso, svendite di beni sotto costo, omissione di atti dovuti come escutere crediti esigibili) che integrano responsabilità risarcitoria verso i creditori . Si tratta di un’azione di natura extracontrattuale, per cui il creditore deve provare la colpa del liquidatore, il danno e il nesso di causalità – onere non semplice, ma che nei casi di liquidazioni anomale può essere soddisfatto (ad esempio, se dal bilancio finale risultano inspiegabilmente spariti beni o se i liquidatori hanno pagato i soci anziché soddisfare creditori).
Difendersi in liquidazione: se l’azienda è già in fase di liquidazione volontaria, lo scenario di “difesa” cambia natura. Non si tratta più di salvare l’impresa come going concern (che ormai per definizione è destinata a cessare), ma di difendere il patrimonio residuo e la posizione dei responsabili. Dal lato del debitore collettivo (società), si può ancora considerare di accedere ad una procedura concorsuale se questo offre vantaggi – ad esempio un concordato preventivo liquidatorio proposto dai liquidatori per chiudere con stralcio parziale dei debiti col consenso dei creditori, oppure la liquidazione giudiziale se i creditori pressano e si preferisce un ordine gestito dal tribunale. Una figura particolare introdotta dal Codice della Crisi è il “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” (art. 25-sexies CCII), utilizzabile proprio dopo il fallimento di una composizione negoziata senza esito. È un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, che può essere richiesto (anche da liquidatori) per concludere rapidamente la liquidazione sotto controllo del tribunale . Questo strumento, tuttavia, è un’extrema ratio: richiede che un esperto indipendente attesti che nessuna soluzione migliore era praticabile nella negoziazione precedente e serve l’ok del tribunale. In pratica, può capitare se in liquidazione volontaria l’azienda non trova accordi e decide di fare un ultimo tentativo di concordato lampo per evitare il fallimento. I liquidatori potrebbero presentare ricorso ex art.25-sexies CCII se ne ricorrono i presupposti.
Dal lato degli amministratori uscenti, la fase di liquidazione è critica per la loro responsabilità: essi devono assicurarsi di aver passato correttamente consegne ai liquidatori e di non aver nascosto passività o attivi. Se la liquidazione evidenzia insolvenza, gli amministratori potrebbero dover rispondere per aver eventualmente tardato lo scioglimento o aggravato il dissesto prima della liquidazione. Inoltre, rimangono esposti all’azione di responsabilità ordinaria (art. 2476 c.c. per s.r.l. o 2393 c.c. per s.p.a.) che il liquidatore stesso può promuovere contro di loro se emergono irregolarità di gestione pregresse. È quindi nel loro interesse collaborare coi liquidatori e rendere tutte le informazioni sullo stato dei debiti, per evitare accuse di mala fede.
In sintesi, quando l’azienda è in liquidazione volontaria: le opzioni di difesa stragiudiziale si riducono (perché l’azienda non opera più attivamente nel mercato), mentre restano possibili alcuni strumenti giudiziali di chiusura concorsuale (concordato preventivo liquidatorio, concordato semplificato). La priorità è pagare i creditori secondo legge: se il patrimonio basta, la liquidazione onorerà tutti i debiti; se non basta, si dovrebbe valutare la liquidazione giudiziale (fallimento). Una “finta liquidazione” nella speranza di evitare il fallimento ma senza patrimonio sufficiente è pericolosa: i creditori insoddisfatti potranno agire contro soci e liquidatori. Ricordiamo infatti che, a società estinta, i creditori non soddisfatti possono far valere i crediti verso soci e liquidatori: i soci delle s.r.l. rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (se hanno avuto distribuzioni), i liquidatori in caso di colpa . Ad esempio, se i liquidatori distribuiscono attivo ai soci e poi emergono debiti, i creditori potranno chiedere ai soci la restituzione pro-quota fino a concorrenza di quanto incassato (non c’è responsabilità oltre, salvo soci illimitatamente responsabili nelle società di persone) . Questo meccanismo fa sì che chiudere la società “per scappare dai debiti” non funzioni: i debiti sopravvivono nella sfera dei soci (pro quota) e/o liquidatori.
Impresa in concordato preventivo
Se l’azienda ha presentato domanda di concordato preventivo ed è stata ammessa alla procedura, la situazione è peculiare: l’impresa opera sotto la tutela (e vincoli) della procedura concorsuale, finalizzata a un risanamento o liquidazione concordata con i creditori. In questa fase, gli amministratori restano in carica (nel concordato non c’è spossessamento totale dei beni, a differenza del fallimento), ma le loro attività sono affiancate e vigilate da un Commissario Giudiziale nominato dal tribunale. Inoltre, per gli atti di gestione straordinaria devono ottenere autorizzazione del giudice delegato. Dunque, il potere decisionale non è più libero: vi è una cogestione con l’organo concorsuale, nell’interesse della massa dei creditori.
Dal punto di vista delle “mosse difensive”, essere in concordato offre alcuni vantaggi ma anche vincoli:
- I creditori sono temporaneamente bloccati nelle azioni esecutive individuali (come detto, per legge non possono proseguire pignoramenti né iniziarne di nuovi, ex art. 54 CCII), e non possono nemmeno acquisire ipoteche giudiziali dalla data di pubblicazione della domanda di concordato. Questo scudo consente all’impresa di continuare operazioni sotto protezione, in attesa della definizione del piano. Ad esempio, se vi erano decreti ingiuntivi in arrivo, restano congelati. Attenzione: i creditori con diritto di prelazione su beni mobili (es. leasing, trattenuta titoli) potrebbero in certi casi chiedere la separazione dei beni, ma in generale il patrimonio è protetto nella sua integrità.
- L’imprenditore deve però seguire il piano di concordato proposto. Ogni spesa o pagamento deve essere coerente con quanto previsto dal piano depositato e autorizzato dal tribunale. Ciò significa, ad esempio, che non può preferire un creditore non previsto dal piano pagando fuori dal piano: questo verrebbe bloccato dal Commissario e potrebbe far decadere la procedura. Se emergono esigenze di modifica, si può presentare un piano modificato (nei limiti consentiti e prima dell’adunanza creditori).
- Difendersi dalle pretese residuanti: Una volta omologato e adempiuto il concordato, l’azienda si libera dai debiti secondo i termini del piano (i debiti stralciati non sono più dovuti). Tuttavia, se il concordato non viene eseguito regolarmente, i creditori possono chiederne la risoluzione e si rischia il fallimento. Pertanto, la difesa del debitore in questa fase consiste nell’eseguire fedelmente gli impegni. Ad esempio, se il piano prevede il pagamento del 30% ai chirografari entro 12 mesi dall’omologa, l’azienda dovrà attivarsi per reperire le risorse ed effettuare quei pagamenti, altrimenti andrà incontro a risoluzione ex art. 118 CCII e successivo fallimento.
- Durante il concordato, i contratti possono essere gestiti con relativa flessibilità: l’azienda può chiedere di sciogliere contratti pendenti troppo onerosi (art. 95 CCII) o può ottenere di mantenere le forniture essenziali (divieto di sospensione per i fornitori strategici già menzionato). Queste sono leve per stabilizzare l’attività durante la procedura. Ad esempio, un’azienda in concordato in continuità può continuare a ricevere materia prima se paga il corrente, anche se ha debiti pregressi verso quel fornitore, perché il fornitore non può interrompere per i soli debiti pregressi (grazie all’art. 94 CCII).
In pratica, se l’azienda è in concordato, la “difesa” è ormai incanalata nella procedura stessa. Non ha senso, ad esempio, negoziare separatamente con singoli creditori fuori dal piano – si devono convincere nelle sedi della procedura (votazione e omologazione). L’azienda qui si difende seguendo le regole concorsuali: convincendo i creditori della bontà del piano, eventualmente superando le opposizioni in sede di omologa (anche con cram-down se necessario per classi dissenzienti, ai sensi degli artt. 109-110 CCII). Un accenno merita la posizione dei garanti e coobbligati durante il concordato: se un terzo (socio, amministratore) ha garantito un debito dell’azienda, l’apertura del concordato fa decorrere il termine semestrale ex art. 1957 c.c. per l’escussione del fideiussore . Ciò vuol dire che il garante rischia di essere chiamato a pagare durante il concordato. Questa è una difesa indiretta per l’azienda: se il garante paga, libera l’azienda dal debito (surrogandosi poi nella procedura). Ma dal punto di vista del gruppo imprenditoriale, può essere visto come uno spostamento del problema dal patrimonio societario a quello personale del garante.
Riassumendo, un’azienda in concordato preventivo deve agire secondo il piano e sotto vigilanza: non ha la libertà di manovra di prima, ma ha dalla sua la protezione legale dal caos delle esecuzioni. Il focus passa dal “difendersi dai creditori” (che sono congelati) al “convincere i creditori” ad accettare la soluzione proposta: la difesa diventa un esercizio di ragioneria e strategia legale (far risultare il piano conveniente per loro rispetto alla liquidazione giudiziale). Se la procedura va a buon fine, l’impresa potrà proseguire (nel concordato in continuità) o quantomeno i suoi asset saranno liquidati in modo ordinato (concordato liquidatorio) senza il marchio del fallimento.
Impresa in liquidazione giudiziale (fallimento)
In questa sezione distinguiamo l’ipotesi peggiore: se l’impresa è stata dichiarata fallita (oggi si dice aperta la liquidazione giudiziale). A quel punto il debitore – inteso come società – perde completamente la disponibilità dei propri beni e la capacità di gestione, che passa al Curatore Fallimentare nominato dal Tribunale. Non c’è più un “difendersi dai debiti” in senso attivo: ormai i debiti verranno accertati nel passivo e soddisfatti secondo le regole concorsuali sulla base dell’attivo liquidato. Tuttavia, dal punto di vista degli ex-amministratori e dei soci, ci sono ancora aspetti difensivi importanti: evitare responsabilità personali e collaborare per massimizzare l’attivo minimizzando le loro esposizioni.
Se l’azienda è fallita, gli amministratori devono consegnare al curatore i libri e le scritture contabili e collaborare attivamente (art. 291 CCII, ex art. 49 L.F.). Una condotta non collaborativa o l’aver tenuto contabilità irregolare può sfociare in reati di bancarotta semplice o fraudolenta. La difesa personale quindi consiste nella trasparenza: fornire tutte le informazioni, dichiarare eventuali atti compiuti prima del fallimento (ad esempio pagamenti a qualche creditore o vendite di beni nell’ultimo anno) perché tanto emergeranno – meglio riferirli spontaneamente per mostrare buona fede. Il curatore scrutinerà gli atti degli ultimi anni per individuare possibili azioni revocatorie o responsabilità: in particolare, potrebbe promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori se ravvisa che con il loro comportamento hanno aggravato il dissesto o violato i doveri (questa è la c.d. azione ex art. 146 l.fall., ora art. 255 CCII). Ad esempio, se l’amministratore ha continuato a fare impresa in perdita erodendo il patrimonio, il curatore potrà citarlo per rifondere i creditori del danno corrispondente all’aggravio del passivo. La recente modifica dell’art. 2486 c.c. facilita tale azione grazie ai criteri presuntivi di quantificazione del danno: la differenza tra patrimonio netto alla data in cui avrebbero dovuto cessare l’attività e patrimonio netto alla data dell’apertura del fallimento si presume danno risarcibile . In mancanza di scritture affidabili, in via sussidiaria, il danno può essere quantificato nel deficit fallimentare (differenza tra attivo e passivo accertati in procedura). La Cassazione ha confermato l’applicabilità di tali criteri come strumenti per agevolare l’onere probatorio del curatore . In breve, l’amministratore rischia di dover risarcire di tasca propria una somma pari al peggioramento del patrimonio netto causato dalla prosecuzione indebita dell’attività dopo il momento in cui si sarebbe dovuto liquidare. La Sezioni Unite della Cassazione già nel 2015 (sent. 9100/2015) avevano stabilito il principio che fuori dai casi di condotte direttamente causative del dissesto, il danno da prosecuzione abusiva si misura appunto col differenziale di patrimonio netto o, residuale, col deficit . Ora questo principio è normativo. Pertanto, in fallimento, difendersi per l’ex amministratore significa poter provare di aver agito diligentemente e che l’aggravamento del passivo non è dipeso da sue colpe. Se riesce a dimostrare, ad esempio, che la crisi è stata repentina e inevitabile, o che certe scelte erano ragionevoli ex ante, potrà evitare o attenuare la condanna risarcitoria.
Dal punto di vista della società fallita invece, non c’è più un’attività da difendere. Il curatore potrebbe ancora concludere transazioni o concordati fallimentari (ora “piani di ristrutturazione nella liquidazione giudiziale”), ma è il curatore a decidere nell’interesse dei creditori, non l’imprenditore. L’ex imprenditore può proporre al curatore soluzioni come trovare un acquirente per l’azienda o per i beni – è anzi opportuno farlo se si conoscono possibili investitori, così da massimizzare l’attivo e magari prospettare un concordato fallimentare (art. 240 CCII) in cui i creditori prendono più del fallimento ordinario. Ciò può essere utile anche per la riabilitazione: un fallito che soddisfi integralmente i creditori (o almeno il 20% a seguito di concordato) può chiedere la chiusura anticipata e la riabilitazione civile (art. 281 CCII). Inoltre, se parliamo di imprenditore individuale, la vera difesa finale è l’esdebitazione: l’istituto che consente al fallito persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui una volta chiusa la liquidazione e soddisfatti i creditori per quanto possibile. Oggi l’esdebitazione è automatica a certe condizioni (art. 278 CCII), salvo il diniego in caso di frodi o mancanze gravi. Quindi, ad esempio, l’ex titolare di una ditta individuale fallita può chiedere alla fine di essere esdebitato e ricominciare senza strascichi di debiti (restano esclusi però debiti personali non concorsuali, come sanzioni penali o obblighi di mantenimento).
In sintesi, l’azienda in liquidazione giudiziale non ha più strategie da attuare per se stessa: la “difesa” riguarda gli uomini dietro di essa (imprenditore, amministratori, garanti). La collaborazione col curatore, la rettitudine, e l’eventuale utilizzo di strumenti come l’esdebitazione per chi ne ha diritto sono le ultime linee di difesa rimaste. Viceversa, ogni resistenza o occultamento può aggravare la posizione dei responsabili: ad esempio, nascondere beni dalla massa fallimentare è reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; falsificare i libri contabili per mascherare ammanchi è bancarotta fraudolenta documentale – con pene severe e nessun beneficio.
Conclusione della sezione: sapere in che fase del ciclo di vita dell’impresa ci si trova è essenziale per scegliere le mosse adatte. Un proverbio della crisi d’impresa recita: “prima agisci, più scelta avrai; più aspetti, più decideranno altri per te”. Nelle prossime sezioni entreremo nel merito degli strumenti utilizzabili nelle fasi in cui l’impresa è ancora “padrona del proprio destino” (soluzioni stragiudiziali) e poi di quelli concorsuali giudiziari, con i dettagli operativi di ciascuno.
Strumenti di difesa stragiudiziali
Quando un’azienda è gravata dai debiti ma non è ancora in procedura concorsuale, ha a disposizione una serie di strumenti stragiudiziali per cercare un risanamento o quantomeno un accordo con i creditori. “Stragiudiziale” significa senza l’intervento diretto di un giudice nell’immediato – anche se, come vedremo, alcuni di questi strumenti possono prevedere fasi di omologazione giudiziaria eventuale. I vantaggi delle soluzioni stragiudiziali sono la maggiore flessibilità, la riservatezza (non c’è la pubblicità di un fallimento o concordato), il controllo che rimane in capo all’imprenditore, e spesso la possibilità di evitare il “marchio” di insolvenza. Di contro, non essendo coattive, richiedono il consenso dei creditori (o almeno di una parte rilevante di essi). Esaminiamo i principali:
Rinegoziazione privata dei debiti e accordi bilaterali
La forma più semplice (ma spesso la più difficile da coordinare su larga scala) è la trattativa diretta con ciascun creditore o gruppi di creditori per modificare le condizioni del debito. Abbiamo già accennato a varie forme: moratorie, piani di rientro, saldo e stralcio. Qui riepiloghiamo i principi generali:
- Negoziati individuali: L’azienda può contattare singolarmente i creditori per esporre la propria situazione e proporre nuovi termini di pagamento. Non c’è una forma vincolata: può essere una scrittura privata, un semplice scambio di lettere o PEC in cui il creditore accetta di attendere (moratoria) o di ricevere a scadenze diverse. È opportuno formalizzare in modo chiaro l’accordo, includendo clausole di riservatezza (così il creditore non divulga ad altri la difficoltà dell’azienda) e di “standstill” (il creditore non intraprenderà azioni esecutive finché si rispetta l’accordo). Questi accordi non coinvolgono terzi – ad esempio, se la società ha più banche finanziatrici, conviene provare a ottenere che tutte aderiscano a un accordo coordinato, altrimenti lo sforzo di una sarà vanificato dall’azione di un’altra. A tal fine, a volte le imprese convocano riunioni con più banche insieme (cosiddetto accordo “multi-bank”) per concordare collettivamente una moratoria. Ciò richiede attenzione ai profili antitrust (banche che si coordinano tra loro) ma è ormai prassi tollerata nelle ristrutturazioni, purché facilitata da advisor indipendenti e nell’interesse del risanamento.
- Saldo e stralcio e remissione del debito: Qualora un creditore accetti di ridurre l’ammontare dovuto e considerare il resto come stralciato, si configura una remissione parziale del debito (art. 1236 c.c.). È fondamentale ottenere una dichiarazione chiara del creditore che, a fronte del pagamento concordato, nulla più avrà a pretendere. Questo per evitare future rivendicazioni. Tali accordi generano sopravvenienze attive tassabili per l’azienda, salvo che siano parte di procedure concorsuali omologate (in quel caso c’è esenzione fiscale ai sensi dell’art. 88 TUIR). Quindi attenzione: uno stralcio privato del debito può comportare che l’erario tassi il risparmio ottenuto come ricavo straordinario! (A meno che la legge di bilancio non preveda esenzioni, come talvolta avvenuto per accordi omologati). Esempio: se devo 100 a un fornitore e quello accetta 50 in saldo e stralcio, quei 50 risparmiati sono un “utile” tassabile per me. Questo va calcolato nel piano di ristrutturazione, per non creare un nuovo debito fiscale inaspettato.
- Accordi con clausole di maggior favore: Può capitare che l’azienda prometta condizioni migliori a creditori che firmano un accordo presto (per incentivarli). Ad esempio: “se tutti i principali fornitori accettano uno stralcio al 40%, vi daremo un ulteriore 5% a saldo se nessuno fa azioni esecutive nei prossimi 6 mesi”. Sono patti leciti, ma vanno maneggiati con cura perché una disparità eccessiva di trattamenti può esporre a contestazioni di “fraudolenza” in caso di successivo fallimento. Un curatore fallimentare potrebbe sostenere che si è trattato di atti preferenziali. Perciò, trasparenza e uniformità sono preferibili.
In generale, la rinegoziazione informale funziona meglio quando il numero di creditori è limitato e l’ammontare del debito non è abnorme, oppure quando c’è un creditore predominante (es. la banca principale) la cui adesione da sola può risolvere gran parte dei problemi. Se invece i creditori sono molti e di natura diversa, occorre strutturare soluzioni più organiche, come quelle che seguono.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dalla legge che formalizza un tentativo di risanamento totalmente stragiudiziale, ma con alcune tutele. Consiste nella predisposizione, da parte dell’imprenditore in crisi, di un piano di risanamento aziendale (di solito un piano industriale e finanziario pluriennale) volto a portare fuori dalla crisi l’impresa, e nell’attestazione di tale piano da parte di un professionista indipendente nominato (un esperto con requisiti di legge, es. revisore, commercialista, avvocato esperto in crisi) . Il professionista attesta che il piano è fattibile e idoneo a risanare l’esposizione debitoria.
Qual è il vantaggio di tutto ciò? Che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 56, co.3, lett. a, CCII, già art. 67, co.3, lett. d, L.F.). In altre parole, se l’imprenditore paga alcuni creditori o costituisce garanzie secondo un piano di risanamento attestato, questi atti (che normalmente sarebbero sospetti come preferenze) non potranno essere revocati dal curatore se poi l’impresa fallisce, a condizione che il piano era idoneo e veritiero . Ciò crea un incentivo per i creditori a partecipare: sanno che i pagamenti ricevuti sono “blindati” e non dovranno restituirli. Inoltre, il piano attestato viene spesso comunicato alle banche e ai principali creditori come segnale di serietà e trasparenza: pur non essendo reso pubblico ufficialmente, di solito l’azienda comunica ai creditori che ha un “piano attestato ex art. 56” inviandone magari estratti o sintesi (c’è riservatezza industriale da tutelare).
Il piano attestato è particolarmente utile quando l’imprenditore ha bisogno di nuova finanza: ad esempio, convincere una banca a dare un ulteriore finanziamento. Sapendo che quel finanziamento è erogato in esecuzione di un piano attestato, la banca è tranquilla che, se anche la società fallisse poi, il rimborso di quel finanziamento sarà in prededuzione (cioè privilegiato) e l’atto di finanziamento non revocabile, a patto che il piano fosse veritiero. È una misura per favorire la finanza fresca (si pensi alle cosiddette “finanze interinali”).
In pratica, il percorso è: l’azienda con i suoi consulenti redige un piano analitico (di solito triennale o quinquennale) di risanamento, che può includere accordi con creditori (anche stralci, dilazioni, cessione di rami d’azienda, aumenti di capitale, etc.), poi individua un professionista attestatore, il quale esamina i dati, verifica che siano ragionevoli e realistiche le assunzioni, e produce una relazione di attestazione. Questo documento è chiave: deve essere redatto con rigore e buona fede, perché se emergesse poi che l’attestatore ha avallato un piano irrealistico, potrebbe risponderne (anche penalmente, ex art. 341 CCII, per false attestazioni). Una volta ottenuta l’attestazione, il piano si considera efficace al momento della sua sottoscrizione da parte dell’imprenditore. Non va omologato dal tribunale né depositato da nessuna parte (può esser depositato facoltativamente presso il registro imprese per una maggiore data certa, ma non è obbligatorio).
L’azienda quindi esegue il piano: ad esempio, paga certi creditori, ne tiene altri a dilazione, ottiene nuova finanza. Se il piano ha successo, l’insolvenza è evitata e l’azienda torna in bonis. Se invece il piano fallisce (perché le previsioni erano troppo ottimistiche o eventi avversi sopravvengono), si potrebbe comunque accedere ad altre procedure successivamente, ma almeno quanto fatto fino a quel momento sarà protetto da revocatoria.
Va detto che la percentuale di successo dei piani attestati dipende dalla qualità della crisi: funzionano bene per crisi reversibili con interventi chiari (es. ristrutturazione debito bancario con allungamento, cessione di asset per far cassa, riduzione costi e ripartenza), mentre in situazioni di insolvenza grave spesso servono solo a prendere tempo. Prima del Codice della Crisi, c’è stato qualche abuso dello strumento, con attestazioni compiacenti usate solo per evitare revocatorie su pagamenti preferenziali: ma oggi, con la vigilanza anche penale sulle attestazioni, questi abusi sono più rischiosi.
Esempio pratico: una S.r.l. elettrica ha €5 milioni di debiti, di cui 3 con banche e 2 con fornitori, e soffre calo temporaneo di fatturato. Elabora un piano dove i soci apportano €1 milione fresco, le banche accettano di non richiedere rientri per 2 anni e capitalizzano interessi, i fornitori ricevono pagamento del 50% del dovuto in 12 mesi e saldo del 50% in altri 24 mesi. Un professionista attesta che il piano è fattibile sulla base di nuovi contratti acquisiti. Se tutto va come da piano, in 3 anni la società esce dalla crisi; se qualcosa va storto e finisce in concordato o fallimento, comunque i soldi che banche e fornitori hanno incassato non potranno essere revocati dal curatore. Quindi anche i creditori trovano convenienza a rischiare con questo piano piuttosto che precipitare subito nel fallimento dove magari prenderebbero meno.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono un gradino più in alto, in termini di coinvolgimento giudiziale, rispetto ai piani attestati. Si tratta infatti di accordi negoziati con i creditori (almeno il 60% dei crediti in linea capitale, di regola) che però vengono omologati dal Tribunale, acquisendo efficacia legale anche verso terzi (in certi casi) e benefici di protezione. Sono disciplinati dagli artt. 57 e seguenti del Codice e rappresentano l’evoluzione dell’istituto introdotto nel 2005 (art. 182-bis L.F.).
In sostanza, l’impresa debitrice può stipulare un accordo con una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% del totale dei crediti) per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. L’accordo può prevedere di tutto: stralci, dilazioni, conversione di crediti in capitale, ecc., a seconda di ciò che viene accettato. È richiesto un attestatore indipendente anche qui, che certifichi la solvibilità dell’accordo e che l’azienda potrà adempiervi regolarmente . L’accordo, con la relazione dell’attestatore, viene poi sottoposto al Tribunale per l’omologazione. Se il Tribunale omologa, l’accordo diventa vincolante per le parti che l’hanno sottoscritto e l’azienda può godere di alcuni effetti protettivi: ad esempio la sospensione o non applicabilità delle azioni revocatorie sui pagamenti effettuati in esecuzione dell’accordo (simile al piano attestato), e soprattutto la possibilità di ottenere misure protettive già nella fase di trattativa (analoghe a quelle del concordato). Infatti l’impresa può depositare in Tribunale la domanda di omologa accompagnata dalla richiesta di misure protettive (art. 54 CCII richiamato), oppure – come succede spesso – può depositare un ricorso “prenotativo” di accordo di ristrutturazione, riservandosi di presentare l’accordo definitivo entro 120 giorni, ottenendo intanto lo stay delle azioni esecutive (art. 44 CCII in combinato con art. 57 CCII) . Ciò è simile al “concordato in bianco” ma finalizzato ad un accordo.
Un vantaggio degli accordi rispetto al concordato è che solo alcuni creditori devono aderire (il 60% nominativo). Gli altri creditori, quelli dissenzienti o estranei, restano tali e devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa (o dalla scadenza se il debito non è ancora scaduto) per legge. Questo implica che l’accordo di ristrutturazione è utile quando c’è una maggioranza disposta a una manovra e minoranze che si preferisce pagare integralmente ma magari con i fondi liberati dalla manovra. Ad esempio, spesso i debiti bancari rilevanti vengono ristrutturati con adesione delle banche, mentre piccoli fornitori vengono pagati cash integrali perché è più semplice così. Rispetto al piano attestato, l’accordo di ristrutturazione offre maggiore certezza (c’è un decreto di omologa) e la possibilità, introdotta di recente, di estendere gli effetti ai dissenzienti in certi casi: sono i cosiddetti accordi ad efficacia estesa. Ad esempio, se in una certa categoria omogenea di creditori finanziari l’accordo è approvato dal 75% di loro, l’effetto di stralcio si può estendere anche al 25% dissenziente con autorizzazione del tribunale (art. 61 CCII). Questo è un mini-cram-down in accordo, creato per evitare che pochi creditori opportunisti blocchino un buon accordo.
Gli accordi di ristrutturazione possono inoltre includere la transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII): cioè si può coinvolgere il Fisco e l’INPS nell’accordo, tagliando sanzioni e interessi e anche quote di tributi, con l’adesione formale delle Agenzie fiscali. La legge prevede che l’adesione delle Agenzie possa avvenire se l’accordo offre almeno quanto il creditore pubblico otterrebbe in liquidazione e se c’è l’attestazione di convenienza . Se l’Erario non aderisce, l’accordo può comunque essere omologato col meccanismo del cram-down fiscale introdotto nel 2020 (analogamente al concordato) , purché quell’offerta minima sia rispettata.
In sintesi, l’accordo di ristrutturazione è un ibrido: è stragiudiziale nella formazione (si negozia liberamente) ma diventa giudiziale nell’efficacia (serve l’omologazione). È indicato quando l’impresa ha una struttura del debito tale che basti convincere relativamente pochi creditori rilevanti (es. le banche principali) e preferisca pagare gli altri integralmente. Oppure quando, pur coinvolgendo tanti creditori, si riesce a far firmare il 60% e per il restante occorre la protezione temporanea per trovare la finanza necessaria a pagare i dissenzienti. Ad esempio, accordi di ristrutturazione sono spesso usati in operazioni di turnaround di medie imprese dove un investitore entra con capitali freschi a condizione che i debiti bancari vengano rinegoziati: si firma con le banche un accordo, l’investitore mette soldi con cui si pagano gli altri debiti, e l’azienda riparte con bilancio ripulito.
Una variante prevista dal CCII (novità) è l’accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII), dove la soglia di adesione è abbassata al 30% ma l’accordo vincola solo chi aderisce e non dà misure protettive automatiche. È poco utilizzato nella prassi sinora, ma esiste per facilitare accordi parziali (in pratica è un accordo contrattuale che il tribunale prende atto esser stipulato dal 30%, ma i creditori fuori restano fuori e agibili, quindi non risolve la crisi da solo a meno che gli altri siano già pagati o non significativi).
La composizione negoziata per la soluzione della crisi
La composizione negoziata è un istituto innovativo introdotto con D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora disciplinato negli artt. 12-25-octies CCII . È uno strumento volontario e assistito: l’imprenditore in condizioni di squilibrio o crisi può richiederlo attraverso una piattaforma online presso le Camere di Commercio, ottenendo la nomina di un Esperto indipendente. L’Esperto ha il compito di aiutare l’imprenditore a trovare una soluzione di risanamento, facilitando le trattative con i creditori.
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso stretto: è confidenziale (non viene pubblicato il nome dell’impresa a meno che non si chiedano misure protettive) e l’obiettivo è trovare accordi in modo consensuale. Durante la composizione, l’imprenditore rimane al timone dell’azienda, ma si interfaccia con l’esperto e con i creditori in incontri periodici. L’esperto, figura super partes, redige alla fine una relazione conclusiva sull’esito (se c’è accordo, se non c’è, etc.).
Perché usarla? Perché fornisce alcuni vantaggi rispetto al “fai da te”:
- Analisi esperta e piano di risanamento: L’esperto inquadra la situazione, aiuta a stimare la continuità aziendale e la proposta da fare ai creditori. È dotato di poteri di richiesta informazioni anche verso banche e fisco. Insomma, porta struttura e credibilità alle trattative.
- Misure protettive e cautelari: Su istanza dell’imprenditore, il Tribunale può concedere misure protettive (sul modello del concordato) durante le trattative, tipicamente il blocco delle azioni esecutive e delle istanze di fallimento, per un periodo iniziale di 4 mesi prorogabili . Inoltre, se un creditore “gioca sporco” (ad esempio rifiuta senza motivo proposte migliori di quanto otterrebbe in fallimento, o approfitta della situazione per recedere da contratti chiave), l’imprenditore può chiedere al giudice misure cautelari a tutela (per esempio, imporre al fornitore di proseguire il contratto). Questo crea un ambiente negoziale più ordinato, in cui nessuno può sparare il “colpo di grazia” mentre si dialoga.
- Incentivi legali e fiscali: Durante la composizione, per legge gli interessi moratori sui debiti sono sospesi. Alcune norme agevolano i finanziamenti autorizzati dall’esperto (possono ottenere privilegio generale). Inoltre, il Decreto 118/2021 ha previsto esenzioni da alcune responsabilità penali minori per gli atti compiuti con l’assenso dell’esperto (ad esempio, l’amministratore non rischia l’accusa di bancarotta semplice per aver continuato l’attività durante la negoziazione, se autorizzato). Sul piano fiscale, l’adesione a certe misure (transazione fiscale) è stata incentivata dallo Stato con la possibilità di stralciare sanzioni e interessi negli accordi raggiunti in composizione . C’è anche un beneficio di priorità: se la composizione negoziata fallisce e l’impresa chiede un concordato semplificato, non deve passare dal voto dei creditori, come visto.
La composizione negoziata può concludersi in diversi modi: – con un contratto di ristrutturazione vero e proprio tra l’impresa e tutti o alcuni creditori (ad es. accordi transattivi bilaterali o plurilaterali); – con un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (il quale poi viene omologato, la composizione avrà facilitato la firma del 60% dei creditori per quell’accordo); – con un concordato preventivo (la negoziazione può evolvere in un concordato se serve l’intervento del tribunale e la votazione); – oppure, se non c’è soluzione, con l’accesso al concordato semplificato come ultima spiaggia.
Se invece la situazione migliora, la composizione negoziata può anche terminare con l’attestazione di un piano di risanamento o, meglio ancora, con la constatazione che l’impresa è tornata sostenibile (magari grazie a nuovi investimenti). In ogni caso, l’esperto chiude con una relazione finale.
Un elemento peculiare è la differenziazione tra imprese sotto-soglia e sopra-soglia: le piccole imprese (definite dall’art. 2, co.1, lett.d CCII: attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k ) non sono soggettabili a fallimento, ma possono usare la composizione negoziata e hanno procedure “minori” (concordato minore, liquidazione controllata). Per loro esistono semplificazioni: documentazione ridotta da presentare, esperti dedicati, ecc. . Nel nostro contesto, un’azienda di inverter potrebbe essere sopra soglia (se è una medio impresa) oppure sotto soglia (se è una piccola realtà artigiana). In ogni caso, la composizione negoziata è accessibile a entrambe .
Criticità: la composizione negoziata richiede la collaborazione dei creditori: non impone nulla se non c’è accordo. Non c’è voto a maggioranza (a differenza del concordato); ogni creditore deve essere convinto singolarmente. Quindi è utile se i creditori principali sono ragionevoli e intravedono convenienza nel risanamento. Se uno grosso si mette di traverso e non c’è verso di convincerlo, si dovrà passare ad uno strumento concorsuale (concordato o accordo di ristrutturazione con cram-down). C’è anche un aspetto di costi: l’esperto va compensato (secondo tariffe pubbliche approvate), e l’azienda deve predisporre molti documenti (analisi di bilancio, elenco creditori, business plan). Tuttavia, è un investimento che spesso vale la pena per evitare il default. Dal suo avvio a fine 2023, la composizione negoziata è stata avviata in qualche migliaio di casi in Italia, con un tasso di riuscita interessante: secondo l’Osservatorio Unioncamere citato, nel 2024 le richieste di composizione hanno superato i concordati preventivi , segno di successo crescente.
In definitiva, la composizione negoziata è oggi il punto d’incontro tra stragiudiziale e giudiziale: mantiene l’impresa sotto controllo dell’imprenditore, ma con un affiancamento istituzionale. Si potrebbe dire che è la “camera di decompressione” dove l’imprenditore può provare a salvare la nave col supporto di un pilota (l’esperto), prima di decidere se chiamare i rimorchiatori (tribunale) o dichiarare l’affondamento (liquidazione).
Altre soluzioni: piani di allerta interni e accordi di ristrutturazione ad hoc
Oltre ai grandi strumenti citati, meritano menzione:
- Adeguati assetti e piani interni: Una difesa talvolta sottovalutata è quella organizzativa: dotarsi di sistemi di controllo di gestione, analisi di cash flow previsionali e indicatori di crisi (DSCR, indici di bilancio). Questo non è solo un obbligo di legge (lo è, art. 2086 c.c.), ma anche il modo per anticipare il problema. Molte crisi diventano ingestibili perché riconosciute troppo tardi. L’assetto adeguato è come un sistema di allarme antincendio: se suona in tempo, si spegne il fuoco con un estintore; se non c’è, ci si accorge dell’incendio quando è troppo tardi. Secondo i dati Unioncamere, nel 2023 appena il 3,5% delle imprese indicava in bilancio di aver implementato tali assetti di monitoraggio , il che evidenzia quanto sia diffusa la carenza. Dunque, per difendersi dai debiti, la prima linea sarebbe non accumularli oltre soglia critica: questo dipende dall’avere reporting finanziari puntuali, budget e piani di tesoreria. Se nella nostra azienda di inverter avessimo visto 12 mesi prima che il calo di ordini stava generando un buco di liquidità futuro, magari si potevano ridurre costi in tempo o cercare equity nuova prima di diventare insolventi.
- Accordi con sponsor o investitori: Spesso la soluzione stragiudiziale passa dall’ingresso di un soggetto terzo (investitore industriale o finanziario) disposto a salvare l’impresa in cambio di prenderne il controllo o altro. Tali operazioni – fusioni, aumenti di capitale riservati, cessioni d’azienda – possono essere fatte stragiudizialmente se c’è accordo con i soci e creditori. Ad esempio, un competitor potrebbe rilevare l’azienda indebitata accollandosi i debiti (magari rinegoziandoli a sconto con i creditori), oppure un fondo di ristrutturazione potrebbe iniettare capitali se le banche tagliano parte dei crediti. Questi accordi quadro rientrano in genere in un piano attestato o accordo di ristrutturazione, ma talvolta si fanno anche senza quei formalismi, con contratti diretti. Sono però operazioni complesse, di taglio più grande, dove consulenti M&A affiancano quelli legali per definire il perimetro e le condizioni (ad es. l’investitore vuole l’azienda “pulita” da alcuni debiti, quindi i creditori vengono transatti prima in certe percentuali, e così via).
- Soluzioni per micro-imprese non fallibili: Per dovere di completezza, esiste la possibilità per imprenditori individuali e piccoli non fallibili (non soggetti a liquidazione giudiziale) di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012, ora integrate nel CCII, art. 65 e ss.). Queste includono il “piano del consumatore” (se il debitore è persona fisica non imprenditore) e la “ristrutturazione dei debiti del soggetto non fallibile” (simile al concordato ma per piccoli). Nel contesto di un’azienda di inverter, se fosse un artigiano individuale sotto soglie, potrebbe sfruttare tali procedure. Non entriamo nei dettagli perché esulano dall’ambito societario classico, ma è bene sapere che il nostro ordinamento prevede una rete di sicurezza anche per chi non può fallire: la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) e l’esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione debiti di chi proprio non ha nulla). Sono normative di stampo più sociale, rilevanti ad esempio se un piccolo imprenditore chiude e rimane pieno di debiti personali: può chiedere l’esdebitazione di meritevolezza e ripartire.
Abbiamo coperto i principali strumenti stragiudiziali. In pratica, come scegliere? Spesso le scelte non sono alternative secche, ma in sequenza: un imprenditore accorto può iniziare attivando la composizione negoziata; se vede che raggiunge accordi con tutti, potrebbe formalizzarli come piano attestato (non servendo altro), oppure se i numeri lo richiedono li trasformerà in accordo di ristrutturazione omologato per includere il Fisco e avere certezza legale. Se invece in composizione si scontra con troppi dissensi, potrà optare per un concordato preventivo (strumento giudiziale) per imporre una soluzione a maggioranza. Passiamo quindi ora agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi, ovvero le procedure concorsuali vere e proprie, che intervengono quando quelli stragiudiziali o non bastano o non sono praticabili.
Strumenti di difesa giudiziali (procedure concorsuali)
Quando la ristrutturazione privatistica non è possibile o sufficiente, all’imprenditore restano i rimedi concorsuali giudiziali, ossia quelle procedure governate dal tribunale che mirano a regolare la crisi o l’insolvenza tenendo conto dell’interesse collettivo dei creditori. In tali procedure, come visto, il prezzo da pagare è la perdita di autonomia (si opera sotto controllo di organi nominati dal giudice) e la pubblicità (le procedure sono iscritte nel registro imprese e note ai terzi). Il beneficio è che esse consentono di superare i dissensi individuali dei creditori, imponendo soluzioni con la forza della legge una volta ottenute le maggioranze o le condizioni richieste. In ottica difensiva, attivare per tempo la giusta procedura concorsuale può evitare esiti peggiori (pignoramenti disordinati, istanze di fallimento altrui) e anche contenere la responsabilità personale degli amministratori (un tempestivo concordato può impedire l’aggravarsi del dissesto e quindi limitare i danni contestabili). Esaminiamo le principali procedure previste oggi dal Codice della Crisi:
Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale mediante la quale un debitore in stato di crisi o insolvenza propone ai creditori un piano per evitare la liquidazione giudiziale, piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale e/o in forma diversa e – se del caso – la continuazione dell’attività d’impresa (concordato in continuità) oppure la sua cessazione e liquidazione dell’attivo (concordato liquidatorio). Il concordato è “preventivo” perché mira a prevenire il fallimento, e storicamente perché si chiede prima di diventare irreversibilmente insolventi, anche se ormai può accedervi anche il debitore insolvente conclamato (purché non sia già stato dichiarato fallito).
Condizioni di accesso: può proporre concordato l’imprenditore commerciale (non il consumatore o l’ente non profit, ad esempio) che sia fallibile (cioè sopra le soglie dell’art. 2 CCII, se sotto soglia c’è il concordato “minore”), purché non soggetto già a liquidazione giudiziale in corso. Serve la delibera dell’organo competente (es. CdA che convoca assemblea straordinaria per autorizzazione se s.p.a., decisione dei soci se s.r.l., salvo deleghe statutarie agli amministratori). L’azienda predispone un piano dettagliato accompagnato da una proposta ai creditori, e una relazione di un attestatore indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano (simile come ruolo all’attestatore del piano risanamento, ma qui obbligatorio per legge, art. 87 CCII). La domanda va depositata in tribunale; può essere una domanda completa oppure con riserva (cd. “concordato in bianco” ex art. 44 CCII, con pochi elementi e richiesta di termine fino a 60-120 giorni per presentare il piano definitivo) .
Effetti immediati: con la pubblicazione della domanda, scattano le misure protettive di legge: blocco dei pagamenti dei crediti anteriori, divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, sospensione degli interessi (salvo sui crediti ipotecari nei limiti di capienza del valore del bene) . Inoltre, gli eventuali procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti sono sospesi. L’impresa continua a operare ma con dei limiti: non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale (pena nullità). Viene nominato un Commissario Giudiziale che vigila sull’attività sociale nel frattempo.
Classi e proposta: Il debitore deve suddividere i creditori in classi se ci sono posizioni eterogenee (facoltativo se omogenei, obbligatorio se eterogenei per posizione giuridica o interessi). Esempio: spesso si fa classe delle banche chirografarie, classe fornitori, classe creditori privilegiati degradati (per la parte non coperta da garanzia), ecc. La proposta può offrire percentuali diverse a classi diverse, purché rispettando l’ordine delle cause di prelazione salvo consenso specifico degli alterati. Ad esempio, si può proporre ai chirografari il 20%, ai privilegiati il 100% (per legge i privilegiati vanno soddisfatti integralmente salvo che rinuncino o che la garanzia reale si riveli parzialmente scoperta). Nel concordato in continuità, la legge non richiede più una percentuale minima di soddisfo per i chirografari (in passato era 30% in continuità e 20% in liquidatorio); oggi c’è solo il principio che ogni classe di creditori non riceva meno di quanto può ottenere dalla liquidazione giudiziale (criterio di convenienza) e che i creditori prioritari non siano trattati peggio di quelli subordinati (absolute priority rule, salvo deroga se c’è almeno il loro consenso a maggioranza). Nel concordato liquidatorio, invece, c’è un piccolo paletto: se non c’è apporto di finanza esterna almeno del 10% dell’attivo, bisogna garantire almeno il 20% ai chirografari (art. 84, co.4 CCII). Ma se un terzo apporta liquidità nuova pari almeno al 10% dell’attivo, non vi è soglia minima di soddisfo (per incoraggiare offerte di acquisto dell’azienda o dei beni).
Votazione: una volta ammesso il concordato, i creditori sono chiamati a votare (si tiene un’adunanza, ma spesso il voto è espresso per corrispondenza entro un certo termine). Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza in cifra, non per teste) per approvare il concordato. Se ci sono classi, la maggioranza si calcola sul totale crediti e inoltre occorre che la maggioranza delle classi votanti approvi (almeno la metà + una delle classi votanti deve dire sì). I privilegiati possono rinunciare al voto se prendono 100%. Se una classe dissente, ma il concordato è comunque approvato a maggioranza di crediti globali, è possibile il cram-down di quella classe dissenziente in sede di omologa, purché la classe dissenziente venga soddisfatta almeno in misura non inferiore rispetto alle classi pari grado e non migliori di classi inferiori (art. 112 CCII): ciò per evitare che uno sparuto gruppo blocchi la volontà della maggioranza.
Omologazione: se i creditori approvano, il Tribunale procede all’omologazione, verificando legalità e convenienza per eventuali classi dissenzienti. Se nessuno la contesta, emette decreto di omologa; se ci sono opposizioni (creditori che lamentano trattamento iniquo, ecc.), si apre un’udienza e poi il tribunale decide con sentenza (impugnabile in corte d’appello). Una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti (salvo che avessero cause di prelazione specifiche ignorate, ecc.). I creditori perdono la parte di credito falcidiata e devono accontentarsi delle percentuali e tempi del piano.
Esecuzione: il debitore, magari coadiuvato da un liquidatore giudiziale (se nominato per vendere beni) o sotto il controllo del Commissario (che diventa liquidatore nel caso liquidatorio), esegue il piano: paga i creditori secondo le scadenze, eventualmente cede beni, ecc. A esecuzione completata, il tribunale dichiara chiusa la procedura. Se invece non adempie regolarmente, si può chiederne la risoluzione (entro un anno dalla scadenza dei pagamenti previsti): il tribunale la pronuncia e tipicamente contesta il fallimento all’impresa inadempiente. Dunque il concordato, una volta omologato, è la nuova “legge” del debitore e dev’essere rispettata per evitare di tornare a zero (anzi sottozero, perché nel frattempo si è persa la fiducia residua).
Concordato in continuità vs liquidatorio: Nel concordato in continuità, l’azienda prosegue l’attività, sia direttamente dal debitore, sia tramite cessione o conferimento a un terzo che la prosegue (continuità indiretta). La caratteristica è che il piano prevede che il valore per i creditori deriverà anche dal proseguimento dell’attività (utili futuri, mantenimento di contratti, ecc.). Ci sono norme protettive: possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili durante la procedura per esigenze urgenti autorizzate, possibilità di trasferire contratti in corso al soggetto terzo acquirente senza consenso delle controparti (in continuità indiretta, art. 97 CCII), ecc. Il fine è agevolare il salvataggio aziendale come going concern. Esempio: la nostra azienda di inverter presenta un concordato in continuità in cui prevede che un investitore mette soldi per sviluppare un nuovo prodotto, l’attività continua e i creditori verranno pagati al 40% in 5 anni coi flussi di cassa operativi generati, oltre che con qualche dismissione di asset non core. I dipendenti mantengono il posto.
Nel concordato liquidatorio, invece, non c’è prosecuzione oltre quella funzionale alla liquidazione. L’azienda cessa attività (o la continua solo quel tanto per vendere il magazzino, definire commesse in corso) e l’obiettivo è vendere i beni (singoli o in blocco) e distribuire il ricavato. Spesso qui entra un assuntore, cioè un soggetto terzo che si impegna a versare una certa somma (o altra utilità) per rilevare l’azienda o parte dei beni e farsi carico di eseguire il concordato. Ad esempio, un competitor può proporre: prendo tutti i beni, pago 30% ai chirografari, tengo i dipendenti (non è obbligatorio tenerli in un liquidatorio, ma può far parte dell’offerta). In mancanza di assuntore, sarà il liquidatore a vendere pezzo per pezzo secondo stime. Il concordato liquidatorio somiglia molto al fallimento come meccanica, ma è volontario e di solito dà qualcosa in più ai creditori e soprattutto evita le lungaggini e lo stigma del fallimento. Oggi col CCII, come notato, il concordato liquidatorio puro senza apporto esterno deve dare almeno il 20% ai chirografari, il che richiede che l’attivo valga almeno quella percentuale del passivo – se no, va cercato l’assuntore o la finanza esterna del 10%.
Vantaggi del concordato per il debitore (in ottica difensiva): – Impedisce l’iniziativa individuale dei creditori e centralizza la soluzione. – Permette di ridurre il debito complessivo anche senza l’accordo di tutti (basta la maggioranza qualificata). – In continuità, consente di ristrutturare mantenendo in vita l’azienda (conciliando dunque difesa dai creditori con salvaguardia del valore produttivo). – Una volta adempiuto, estingue le obbligazioni pregresse insoddisfatte senza ulteriori strascichi (il debitore “si libera” dai debiti residui per la parte falcidiata). – Gli amministratori non vengono estromessi (a differenza del fallimento): in continuità restano a gestire, seppur con supervisione; in liquidatorio, c’è un liquidatore concordatario di solito, ma spesso coincide con l’assuntore, e comunque l’impresa può scegliere un po’ di più la regia rispetto al fallimento. – L’azienda evita la dichiarazione di insolvenza e relative conseguenze (es. nel concordato non c’è interdizione dagli uffici direttivi per gli amministratori – nel fallimento sì salve riabilitazioni; non c’è stigma penale di bancarotta salvo reati ante concordato; i contratti pubblici possibili, anche se la presenza di un concordato va dichiarata e può rilevare in gare, ma almeno non è un fallimento).
Svantaggi o rischi: – È un procedimento complesso e costoso (spese legali, periti, compenso del commissario, etc. da pagare in prededuzione). – Non è garantito: se i creditori lo bocciano o il tribunale non omologa, si rischia di finire direttamente in fallimento a quel punto (la domanda di concordato rigettata spesso sfocia in dichiarazione di liquidazione giudiziale su istanza di creditori). – Durante la procedura, l’azienda può soffrire reputazionalmente (clienti e fornitori vengono a sapere del concordato, spesso scatta l’obbligo di indicarlo; alcuni partner potranno recedere da contratti se il concordato li pregiudica). – Serve liquidità per gestire l’interim (bisogna pur pagare almeno i fornitori per merci consegnate dopo la domanda, e i dipendenti correnti). Se l’azienda era già a secco, entrare in concordato senza risorse potrebbe condannarla a non riuscire a rispettare la continuità minima e quindi farla fallire comunque. – Gli amministratori durante il concordato sono soggetti a stretta vigilanza: ogni atto è scrutinato; se fanno irregolarità, rischiano anche più che prima (ad esempio, il non rispetto degli obblighi informativi periodici al commissario o atti non autorizzati possono portare alla revoca del concordato e fallimento con possibili accuse di mala gestio aggravata).
In conclusione, il concordato preventivo rimane lo strumento principe per difendersi legalmente dai debiti non risolvibili altrimenti, offrendo una soluzione collettiva. La nostra azienda di inverter potrebbe usarlo se, ad esempio, non riesce a ottenere l’adesione di una banca e di alcuni fornitori a un accordo stragiudiziale: con il concordato li può costringere a subire un taglio, purché la maggioranza di tutti gli altri creditori sia favorevole alla proposta.
Un cenno: esiste come anticipato anche il concordato “minore” (artt. 74-83 CCII) per i piccoli debitori non fallibili, che è una versione semplificata del concordato preventivo (ad esempio, non c’è commissario obbligatorio se non nominato dal giudice, e la percentuale di voto è 50% teste, non valore). È però destinato a imprenditori minori, dunque non lo approfondiamo oltre.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Ne abbiamo parlato prima: il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) è una procedura speciale a cui si può ricorrere solo se si è passati per una composizione negoziata fallita (cioè senza accordo). L’imprenditore può proporre al tribunale la cessione dei propri beni ai creditori senza votazione, chiedendo l’omologazione diretta. È una sorta di “mini-fallimento consensuale”: non c’è voto dei creditori, il tribunale valuta e omologa se il piano di liquidazione dà ai creditori almeno qualcosa in più di quel che avrebbero dal fallimento . I creditori possono solo opporsi all’omologa se contrari.
Il vantaggio dal punto di vista del debitore è che si risparmia tempo (niente adunanza, niente maggioranze da raggiungere) e può scegliersi un liquidatore di fiducia (lo propone nel piano, il tribunale di solito lo nomina come liquidatore giudiziale post omologa). Inoltre, non essendoci voto, non si applicano le percentuali minime (infatti un concordato semplificato può anche pagare <20% ai chirografari, a patto che comunque prendano tutto l’attivo disponibile). Un altro vantaggio: come tutte le procedure concorsuali, blocca le azioni dei creditori e porta alla esdebitazione dell’imprenditore in caso di persona fisica (dopo la chiusura).
Tuttavia, ha mostrato alcuni problemi: per esempio il Fisco ha eccepito che nel concordato semplificato non potendosi esprimere col voto, sarebbe incostituzionale imporgli un taglio forzoso senza dargli almeno il diritto di esprimersi – questione ancora dibattuta . Alcuni tribunali sono diffidenti e tendono a usarlo poco, preferendo spingere i debitori verso il fallimento classico se non c’è accordo.
Ad ogni modo, per il debitore in crisi che ha tentato la composizione negoziata senza successo, rimane come estrema via di uscita. È sicuramente preferibile al fallimento se c’è cooperazione: può essere completato in tempi più rapidi e sotto una regia che il debitore ha almeno in parte predisposto. Ad esempio, la nostra azienda di inverter tenta la composizione negoziata ma non trova investitori né accordi. Ormai l’insolvenza è palese. Piuttosto che attendere i creditori che la portino al fallimento, propone subito un concordato semplificato: cedere in blocco l’inventario e i brevetti a un soggetto interessato che pagherà tot, vendere l’immobile, ecc., con prospetto di pagare forse il 10% ai chirografari. Il tribunale valuta che effettivamente quell’offerta è seria e i creditori in fallimento non prenderebbero di più (forse anche meno perché si perderebbe tempo) – allora può omologare. I creditori, pur arrabbiati magari, non possono cambiare i fatti: almeno incassano subito quel poco e la procedura si chiude. Per l’imprenditore, significherà fine dell’azienda ma almeno rapida liquidazione e possibilità di ripartire pulito dopo (specie se persona fisica con esdebitazione).
Liquidazione giudiziale (il “fallimento”)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che prende il posto del vecchio fallimento. È la meno desiderabile per il debitore, in quanto comporta lo spossessamento e, di regola, la fine dell’impresa come entità operativa. Tuttavia, talvolta presentarsi in tribunale e richiedere il proprio fallimento (o non opporsi ad esso) può essere la scelta meno dannosa rimasta: “far saltare il banco” per evitare ulteriori accumuli di debiti e passare la mano a un curatore che gestisca in modo ordinato la liquidazione.
Quando si arriva al fallimento? Ci si arriva su ricorso di uno o più creditori, o su istanza del debitore stesso, o del PM. Il presupposto è lo stato di insolvenza: ovvero l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (manifesta, come inadempimenti generalizzati, protesti, ecc.). Inoltre l’impresa dev’essere di dimensioni fallibili (sopra soglia). Se un creditore presenta istanza, l’imprenditore può reagire in due modi: o contestare l’insolvenza (oppure pagare il creditore nel frattempo se è uno solo e guadagnare tempo), oppure aderire e magari chiedere i benefici (per esempio, proporre un concordato fallimentare all’udienza). Se non c’è difesa o la difesa è rigettata, il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale e da quel momento l’impresa passa sotto il controllo del Curatore.
Effetti per il debitore: Spossessamento di tutti i beni (che confluiscono nella massa attiva fallimentare). Gli amministratori decadono, i soci perdono ogni potere (nelle società di capitali), e l’azienda è chiusa o gestita temporaneamente dal curatore se serve per venderla meglio. Tutti i creditori chirografari e privilegiati anteriori devono presentare domanda di insinuazione al passivo per partecipare alla distribuzione; gli eventuali creditori che avevano già pignorato beni perdono il privilegio di quell’azione (il bene rientra nella massa). I contratti pendenti possono essere sciolti o proseguiti a scelta del curatore (art. 172 CCII). In pratica, il curatore valuta come massimizzare il valore: se conviene tenere la fabbrica aperta qualche mese per completare ordini in corso e vendere l’azienda come blocco, può chiedere all’autorità di poter esercitare provvisoriamente l’impresa (esercizio provvisorio). Altrimenti, manda lettere a tutti i contraenti dicendo “la società è fallita, i contratti si sciolgono salvo rivalsa in danno”.
Per il debitore persona fisica, scatta l’inabilitazione: non può esercitare impresa per la durata del fallimento e 5 anni dopo (salvo riduzione) e perde diritti come elettorato attivo/passivo finché dura la procedura. Gli amministratori di società fallite possono subire conseguenze reputazionali e di responsabilità come visto.
Procedura: Il curatore fa l’inventario, il giudice delegato verifica le domande di insinuazione e predispone lo stato passivo. Poi il curatore procede a vendere i beni (aste, trattative private autorizzate). Incassa liquidità, e periodicamente propone piani di riparto parziale ai creditori secondo le graduatorie di privilegio, fino al riparto finale. Alla fine, la procedura chiude per ripartizione dell’attivo. Se l’attivo è zero dall’inizio, può chiudersi subito per insufficienza di attivo (art. 233 CCII). Sennò, dura in media qualche anno (dipende da contenziosi, beni difficili da vendere ecc.). Alla fine, se il debitore è persona fisica, può chiedere l’esdebitazione per cancellare i debiti rimasti (art. 278 CCII).
Difendersi in fallimento: Come già detto, qui difesa vuol dire soprattutto comportamento collaborativo per evitare guai peggiori. Ad esempio, se il curatore riscontra distrazioni di beni, farà denuncia per bancarotta fraudolenta. Il debitore può difendersi da accuse penali se dimostra di aver agito senza dolo e di non aver occultato nulla. Nella fase di accertamento del passivo, il debitore può segnalare al curatore se qualche pretesa dei creditori è infondata (il curatore stesso può escludere crediti ingiusti). Può anche proporre un concordato fallimentare: in qualsiasi momento (dopo almeno 1 anno dall’apertura, o prima se offre 100%) il debitore o un terzo possono presentare un piano concordatario ai creditori fallimentari (art. 240 CCII). Se i creditori lo approvano a maggioranza, la procedura fallimentare si chiude anticipatamente con quel concordato. Per il debitore è una chance: magari un familiare o socio decide di mettere soldi per offrire ai creditori una percentuale e riottenere l’azienda libera. Questo è raro ma succede, specie quando l’azienda ha valore speciale per qualcuno (es. impresa familiare).
Responsabilità post-fallimentare: I creditori insoddisfatti, dopo la chiusura del fallimento, non possono comunque agire contro la società estinta (che di solito viene cancellata). Come già spiegato, i crediti residui muoiono con la società per i creditori, salvo agire contro soci e liquidatori ex art. 2495 c.c. se ne hanno titolo . Quindi il fallimento regola in modo definitivo la posizione dei creditori verso la società; resta la responsabilità eventuale degli ex esponenti per atti di mala gestio, ma va esercitata nel fallimento stesso (azione del curatore) o se il curatore non agisce, entro 5 anni dalla chiusura (azione singola dei creditori ex art. 255, co.4 CCII).
Da un’ottica del debitore, la liquidazione giudiziale è l’ultima ratio: non la si cerca, la si subisce di solito. Ma se appare inevitabile, talvolta è meglio autodenunciarsi insolvente piuttosto che lasciar passare tempo in una finta agonia. La legge incoraggia la “sana e prudente gestione”: prima si chiude una situazione irreversibile, più si limita il danno a creditori e terzi. Ad esempio, una società che capisca di essere insolvente irreversibile fa bene a depositare essa stessa ricorso per liquidazione giudiziale (un tempo si diceva “istanza di autofallimento”), perché questo atto le eviterà possibili accuse di aver ritardato la dichiarazione di insolvenza. Inoltre, può scegliere il timing in modo magari da preparare i dipendenti (così possono subito attivare il Fondo di Garanzia), preservare alcuni asset (concordando vendite pre-fallimentari autorizzate), ecc. In certi casi, l’imprenditore deposita ricorso per fallimento con contestuale proposta di concordato fallimentare: segno di proattività che tribunale e creditori guardano positivamente.
Riassumendo in ottica difesa: il fallimento è la resa, ma una resa ordinata è preferibile a una disfatta caotica. Se tutti i tentativi di salvataggio falliscono, consegnare le chiavi al tribunale dignitosamente e collaborare è la scelta consigliabile, anche perché apre la porta alla riabilitazione e all’esdebitazione in tempi più rapidi. L’imprenditore onesto, pur sconfitto, ha diritto di ripartire senza restare schiavo dei debiti a vita: questo è un principio ormai accolto (fresh start). L’ordinamento infatti concede l’esdebitazione una volta chiuse le formalità concorsuali, a patto che non ci sia frode o colpa grave.
Abbiamo così delineato gli strumenti giudiziali più rilevanti: concordato preventivo (e sue varianti) e liquidazione giudiziale. Nella tabella seguente confrontiamo brevemente le caratteristiche chiave:
| Procedura | Chi la controlla | Effetto sui debiti | Continuità aziendale | Coinvolgimento creditori |
|---|---|---|---|---|
| Concordato preventivo | Debitore (gestione) con commissario (vigilanza) ; giudice per autorizzazioni. | Debiti ristrutturati secondo piano omologato: parte stralciata è estinta . | Possibile prosecuzione (concordato in continuità) oppure cessazione (liquidatorio). | Creditori votano proposta (>= majority valore) ; omologa vincola anche dissenzienti. |
| Concordato semplificato | Debitore propone, liquidatore nominato post-omologa gestisce liquidazione . | Debiti soddisfatti col piano senza voto; residuo stralciato dopo omologa definitiva. | No continuità (solo liquidazione rapida dei cespiti) . | Creditori non votano, possono solo fare opposizione in omologa (giudice decide). |
| Liquidazione giudiziale | Curatore nominato dal Tribunale amministra patrimonio; impresa spossessata. | Debiti cristallizzati all’apertura; pagati pro-quota su attivo; insoddisfatti restano ma società poi estinta. | Attività cessa, salvo eventuale esercizio provvisorio breve per vendere meglio. | Creditori partecipano tramite domande di insinuazione; nessun voto, subiscono l’esito (possono formare comitato consultivo). |
| Accordo ristrutturazione | Debitore negozia; omologa tribunale; nessun organo gestorio esterno. | Debiti ristrutturati come da accordo firmato dal >=60% creditori e omologato ; dissenzienti extracontratto vanno pagati al 100% entro 120 gg dall’omologa. | Continuità possibile (l’azienda prosegue normalmente sotto accordo privatistico). | Solo creditori aderenti vincolati dall’accordo (salvo efficacia estesa su intera categoria omogenea con >75% adesione) ; tribunale omologa se condizioni ok. |
| Composizione negoziata | Debitore con Esperto indipendente (facilitatore, non decisionale) . | Non impone riduzione debiti salvo accordi volontari raggiunti; può preludere ad altro (accordo, concordato). | Sì, mira al risanamento con continuità (oppure si sfocia in cessione azienda). | Creditori negoziano volontariamente; nessuna imposizione se non concordano (misure protettive li bloccano temporaneamente). |
(Fonte: elaborazione basata su CCII e prassi giurisprudenziale aggiornati al 2025.)
Responsabilità degli amministratori e degli organi sociali
Un aspetto cruciale, dall’angolo visuale del debitore in crisi, è la responsabilità personale degli amministratori (e, in taluni casi, dei soci o sindaci) per la gestione che ha condotto all’indebitamento e per le scelte compiute durante la crisi. In altre parole, mentre l’azienda “si difende” con gli strumenti di cui abbiamo discusso, gli amministratori devono anche difendere sé stessi dal rischio di azioni di responsabilità civile e di sanzioni (anche penali) che possono emergere in simili contesti. Analizziamo i principali profili di responsabilità:
Doveri di gestione conservativa e tempestiva emersione della crisi
Come già richiamato, l’art. 2086 c.c., comma 2, impone agli amministratori di società il dovere di: (a) istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi; (b) attivarsi senza indugio per adottare gli strumenti di superamento della crisi o dell’insolvenza incipiente . Questo è un obbligo di diligenza professionale elevata, e costituisce un parametro di valutazione della condotta. Se gli amministratori ignorano i segnali di crisi e lasciano che la situazione peggiori, violano tale dovere e possono incorrere in responsabilità.
Il Codice della Crisi ha rafforzato tale aspetto introducendo anche indicatori di allerta (che poi nella forma originaria degli OCRI sono stati accantonati, come accennato , ma i doveri interni rimangono). Inoltre, negli assetti adeguati rientra ad esempio la predisposizione di piani finanziari e report periodici: un amministratore che gestisca “alla cieca” senza contabilità aggiornata, potrebbe essere considerato in colpa grave.
Una conseguenza pratica: se la società poi fallisce, il curatore valuterà da quanto tempo l’insolvenza era manifesta e cosa è stato (o non è stato) fatto. Se riscontra che già due anni prima c’erano perdite enormi e amministratori non hanno né ricapitalizzato né liquidato né chiesto concordato, sicuramente partirà un’azione di responsabilità.
Azione di responsabilità per mala gestio ordinaria e aggravamento del dissesto
Due tipologie di azioni civili possono colpire gli amministratori dopo (o durante) una crisi:
- Azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c. per S.p.A., art. 2476 c.c. per S.r.l.): è l’azione con cui la società (o il curatore fallimentare, nel caso “esercitata dal fallimento” ex art. 255 CCII) chiede risarcimento agli amministratori per danni al patrimonio sociale causati da violazione dei loro doveri. In caso di fallimento, questa si cumula con l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), ma di fatto viene esercitata unitariamente dal curatore ex art. 255 CCII. Tipicamente, nel contesto di crisi, l’inadempimento principale contestato è la violazione dell’obbligo di cui sopra: non aver agito con la dovuta tempestività. Ad esempio, non aver convocato l’assemblea di liquidazione nonostante perdite rilevanti (violazione di artt. 2447 o 2482-ter c.c.), oppure aver continuato a prendere forniture a credito sapendo di non poterle pagare, aggravando il passivo. Questo genera il cosiddetto danno da aggravamento del dissesto. Come discusso, la legge (art. 378 CCII che ha modificato l’art. 2486 c.c.) crea una presunzione sul quantum del danno risarcibile: la differenza tra il patrimonio netto alla data in cui avrebbero dovuto cessare l’attività e il patrimonio netto alla data di apertura della liquidazione è presunta essere il danno causato dagli amministratori . Tale criterio dei “netti patrimoniali” semplifica molto la vita al curatore, che prima doveva provare voce per voce i danni. Ora basta confrontare bilanci o situazioni patrimoniali a due date (o, se non ci sono bilanci affidabili, come spesso avviene perché magari non depositati, si ricorre al deficit finale come seconda presunzione). L’amministratore può liberarsi solo provando che un diverso importo di danno è corretto (onere della prova invertito) .
La giurisprudenza recente ha cominciato ad applicare questo schema. Ad esempio, la Cassazione nel 2023-2024 ha confermato in casi di continuità aziendale abusiva che non serve individuare puntualmente ogni atto dannoso: basta mostrare che il patrimonio si è deteriorato da quando doveva intervenire la liquidazione a quando è intervenuto il fallimento, per attribuire agli amministratori il dovere di risarcire . Le uniche ipotesi in cui l’amministratore può evitare addebiti totali sono se dimostra che il peggioramento non è colpa sua (es. cause esterne imprendibili) o che in realtà mantenere l’attività aperta ha evitato danni peggiori (è raro ma potrebbe succedere: se il patrimonio netto è calato, di solito c’è aggravamento).
- Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.): questa è tecnicamente distinta dall’azione sociale – è il diritto dei creditori di essere risarciti se il patrimonio sociale è insufficiente per i loro crediti a causa di atti di mala gestio degli amministratori. In fallimento confluisce nella medesima azione esercitata dal curatore (lo prevede art. 255 CCII: il curatore esercita sia 2393 che 2394 con un unico giudizio). Se non c’è fallimento (ad esempio la società in liquidazione volontaria viene cancellata con debiti residui), i singoli creditori possono tentare un’azione ex art. 2394 c.c. contro gli ex amministratori, ma devono provare che il deficit patrimoniale è dipeso dalla loro colpa. In assenza di procedura concorsuale, questa prova è in capo al creditore ed è onerosa (bisogna dimostrare ipoteticamente che senza quella mala gestio, i crediti sarebbero stati pagati). Non a caso, tali cause individuali sono meno frequenti; di solito se c’è sostanza l’azione viene fatta dal curatore nel fallimento.
- Azione verso i liquidatori (art. 2495 c.c.): se gli amministratori hanno lasciato la patata bollente ai liquidatori, anche questi ultimi possono essere chiamati in causa se, ad esempio, hanno chiuso male la liquidazione (pagato i soci prima dei creditori, ignorato un creditore noto, svenduto beni). Abbiamo visto i requisiti: colpa nell’inosservanza dei doveri di par condicio e diligenza professionale . Il creditore deve agire entro 2 anni dalla cancellazione, in genere. È extracontrattuale, quindi onere su creditore, e difficile da provare salvo casi eclatanti.
Per un amministratore, quindi, la miglior difesa è l’attacco preventivo: prendere le misure giuste nei momenti chiave. Ad esempio: – se il capitale si riduce sotto zero, convocare subito soci e adottare soluzioni (ricapitalizzazione, riduzione capitale, liquidazione, come richiesto dalla legge); – se vede insolvenza irreversibile, non tardare a decidere per un concordato o fallimento evitando di accumulare ulteriori debiti; – se decide di continuare l’attività sperando in ripresa, documentare bene le ragioni per cui ciò avrebbe potuto ragionevolmente salvare l’azienda (così potrà difendersi dicendo: “era plausibile, non stavo giocando d’azzardo con i soldi dei creditori”).
Un caso particolare su cui la Cassazione si è espressa: l’amministratore che paga solo alcuni creditori a ridosso del fallimento (c.d. pagamenti preferenziali). Questi pagamenti possono essere revocati dal curatore (azione revocatoria) se fatti nell’anno o 6 mesi prima (a seconda se il creditore era consapevole stato insolvenza o meno). Ma oltre alla revocatoria, sul piano dell’azione di responsabilità, tali pagamenti possono costituire violazione della par condicio e quindi danno ai creditori non pagati. Le Sezioni Unite Cassazione 9100/2015 affermarono però che se i pagamenti preferenziali non peggiorano il dissesto (cioè se è solo una diversa distribuzione ma il patrimonio netto resta lo stesso), allora non si può addebitare all’amministratore l’intero importo come danno – è un danno “riflesso” perché un creditore ha avuto di più e un altro di meno, ma nel complesso il buco non è aumentato. Dunque la misura del danno resta l’aggravamento del deficit, non la singola preferenza. Tuttavia, quei pagamenti sono comunque illegittimi e revocabili, e se fatti in frode potrebbero integrare bancarotta preferenziale (penale). In sostanza, pagare alcuni a scapito di altri è sempre pericoloso per l’amministratore: se la società poi fallisce, i creditori esclusi e il curatore punteranno il dito. Meglio inserirli in un contesto di accordo generale o di procedura concorsuale dove quei pagamenti abbiano base legittima (ad esempio, pagamento autorizzato di fornitore strategico in composizione negoziata, come visto, che è giustificato e non contestabile).
Responsabilità verso fisco e terzi
Oltre alla responsabilità verso la società e creditori in generale, gli amministratori possono avere profili di responsabilità specifica verso alcuni enti:
- Responsabilità fiscale personale: In Italia, gli amministratori non sono di regola personalmente debitori delle imposte dovute dalla società (c’è autonomia patrimoniale). Tuttavia, esistono eccezioni: se l’amministratore ha commesso violazioni tributarie, l’Agenzia può notificargli sanzioni amministrative in solido (ad esempio, per omessa presentazione dichiarazioni o infedeltà se imputabile a lui). Ma soprattutto, c’è un fenomeno chiamato “responsabilità per indebita distribuzione dell’attivo” in liquidazione: se la società si scioglie e distribuisce beni ai soci prima di pagare le imposte dovute, l’art. 2495 c.c. e norme tributarie (D.P.R. 602/1973, art. 36) consentono al Fisco di escutere direttamente soci e anche di chiamare in causa gli amministratori/liquidatori per il pagamento delle imposte rimaste. In alcune pronunce si è affermato che l’amministratore che abbia omesso di pagare imposte dovute e chiuso bottega può essere responsabile per aggravio del debito fiscale. Comunque, il terreno fiscale rimane in primis di sanzioni pecuniarie e penali (vedi dopo).
- Rapporti con dipendenti: Gli amministratori potrebbero rispondere di reati come omesso versamento contributi (che può essere anche contravvenzione a carico del legale rappresentante se supera soglie), ma civilmente non pagare i dipendenti genera obblighi non direttamente in capo all’amministratore se non in casi di dolo (ad esempio, se si provasse che l’amministratore ha usato i fondi destinati ai salari per altro, i dipendenti potrebbero chiedergli danni in un’azione aquiliana). Più comune è che il Fondo di garanzia INPS paga e poi surroga nei diritti: ma di solito surroga verso la società, non verso l’organo gestorio (salvo questi abbiano commesso reato e allora si potrebbero rivalere in separato giudizio di danno erariale, ma scenario remoto).
- Responsabilità verso fornitori contrattuale: Raramente il fornitore non pagato può citare l’amministratore per dolo extracontrattuale (es. se sostiene che l’amministratore lo ha fraudolentemente indotto a fornirgli merce sapendo di essere insolvente senza intenzione di pagare, potrebbe configurarsi truffa civilistica). Ma questo è difficile da provare e di solito è materia da tribunale penale (reato di insolvenza fraudolenta, vedi dopo). Dunque non mi soffermo: basti dire che se un amministratore ordina beni quando sa di essere tecnicamente al collasso, rischia denuncia per insolvenza fraudolenta (art. 217 L.F. vecchio, oggi trasfuso negli artt. penal-fallimentari del CCII), e il fornitore potrebbe poi costituirsi parte civile per il danno.
Profili penali: bancarotta e altri reati
La crisi d’impresa è terreno fertile per reati fallimentari e tributari. Gli amministratori devono esserne consapevoli perché la migliore difesa è non oltrepassare la linea della legalità nelle scelte, soprattutto mano a mano che la crisi peggiora.
I reati tipici: – Bancarotta fraudolenta: se l’azienda va in fallimento, qualsiasi distrazione di beni, pagamenti preferenziali, atti dissipativi o esposizione di passività fittizie compiuti prima del fallimento può essere perseguita come bancarotta fraudolenta patrimoniale. Anche le irregolarità nei libri contabili (mancata tenuta, alterazioni) sono bancarotta fraudolenta documentale. Le pene sono pesanti (fino a 6-10 anni di reclusione). Quindi, un amministratore onesto in crisi farà di tutto per tenere le scritture in ordine e non far sparire beni. Ad esempio, non deve assolutamente “regalare” l’auto aziendale al parente per toglierla dal patrimonio, né gonfiare fatture passive all’ultimo per giustificare ammanchi di cassa. Tali atti prima o poi vengono alla luce e portano quasi certamente alla condanna penale.
- Bancarotta semplice: è una forma minore, punisce tra l’altro l’aggravamento del dissesto per imperizia o violazioni come aver aggravato indebitamente la posizione ritardando la dichiarazione di fallimento, oppure aver fatto spese personali eccessive in periodo di crisi, oppure non aver tenuto la contabilità per negligenza. Le pene sono più basse (fino a 2 anni). Ma comunque, l’amministratore non vuole incorrervi. Ad esempio, il solo fatto di non aver tenuto i libri può essere bancarotta semplice documentale, se non si prova il dolo di nasconderli (che sarebbe fraudolenta).
- Ricorso abusivo al credito: un’altra ipotesi di reato (ancora nelle bancarotte) è l’aver continuato a ricorrere al credito aggravando il dissesto pur sapendo di non poter pagare (è un caso di bancarotta semplice, punisce l’assunzione di debiti gravemente imprudente). Quindi amministratori che nel baratro prendono nuovi finanziamenti o ordini a fornitori senza speranza rischiano questa contestazione. Difesa? Dimostrare di avere creduto ragionevolmente di potercela fare, altrimenti è colpa.
- Insolvenza fraudolenta (art. 216 L.F. previgente, ora art. 322 CCII): reato minore rispetto alla bancarotta, si consuma se l’impresa non fallisce ma c’è frode nel contrarre debiti. Ad esempio, un imprenditore che nasconde la sua situazione emettendo assegni a vuoto, e poi chiude l’azienda senza fallire, può essere imputato di insolvenza fraudolenta. Questo reato è perseguibile a querela della parte offesa (es. il fornitore truffato). In contesti di azienda che poi fallisce, di solito subentra la bancarotta, che assorbe l’insolvenza fraudolenta.
- Reati tributari: i più rilevanti sono l’omessa dichiarazione (se l’amministratore non presenta proprio le dichiarazioni fiscali per evadere) o la dichiarazione fraudolenta (falsa contabilità per evadere) – questi avvengono spesso prima della crisi conclamata; e l’omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) e omesso versamento ritenute (art. 10-bis). Se negli ultimi anni l’azienda in crisi non ha versato l’IVA oltre €250k annui o le ritenute oltre €150k, l’amministratore in carica al momento è punibile (salvo che paghi entro la scadenza di presentazione dichiarazione per IVA, o entro 3 mesi da diffida per ritenute). In questi casi, la crisi di liquidità viene vista come non esimente: se hai pagato altri e non il fisco, lo Stato ti ritiene colpevole comunque. A volte, in sede di giudizio, la grave crisi può essere considerata per ridurre la colpevolezza (es. se dimostri che con quei soldi hai pagato stipendi per evitare guai sociali, può incidere sulla valutazione del dolo). Ma formalmente, l’imprenditore rischia fino a 2 anni di reclusione per questi reati (che spesso vengono chiusi con la sospensione condizionale se risarcisce, ma ciò comporta trovare fondi per risarcire il fisco – il cane che si morde la coda). Altri reati: sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (se alieni beni per non fartele pignorare) e autoriciclaggio (se ti intaschi proventi di reati fiscali e li reimpieghi). Insomma, il campo fiscale-penale è una mina. Difesa: l’amministratore deve poter mostrare di aver tentato tutte le soluzioni lecite, e se proprio ha dovuto sacrificare il fisco per pagare altri, farlo comparire come scelta di necessità e non volontà di evadere. Spesso, in sede di concordato o accordo, includere la transazione fiscale e pagare una parte di tributi aiuta: la guardia di finanza e l’agenzia possono poi essere meno inclini a spingere per la via penale se vedono che c’è collaborazione nella crisi.
- Violazioni societarie: se nella crisi gli amministratori falsificano il bilancio (magari per ottenere credito), oltre alle conseguenze civili c’è il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio). E se deliberano distribuzioni ai soci di utili inesistenti per svuotare casse, c’è reato di indebita restituzione conferimenti o illegale ripartizione di utili. In pratica, i comportamenti fraudolenti per frodare creditori sono quasi sempre sanzionati da qualche norma penale.
Questa lunga disamina serve a ribadire: il debitore che voglia difendersi efficacemente dai debiti deve anche difendersi dalla tentazione di gestire la crisi in modo illecito. La compliance legale e contabile è parte integrante della strategia di difesa. Un imprenditore potrà superare la crisi economica o potrà fallire onorevolmente e ripartire, ma se nel frattempo commette reati, le conseguenze personali lo inseguiranno e lo danneggeranno molto di più dei soli debiti economici.
Riassumiamo i principali doveri e potenziali inadempimenti degli amministratori in crisi e relative conseguenze:
- Dovere di patrimonio netto non negativo: se capitale eroso oltre soglie, obbligo riduzione/ricostituzione o liquidazione (artt. 2447, 2482-ter c.c.). Violazione: responsabilità ex art. 2486 c.c. per atti oltre ordinaria amm.ne e potenzialmente bancarotta semplice per continuazione abusiva.
- Dovere di convocare assemblea su fatti rilevanti: es. perdita > 1/3 capitale (art. 2482-bis), o scopo non conseguibile (art. 2484). Violazione: amministratori rispondono per aggravio; liquidatori possono chiamarli in causa.
- Dovere di tenuta regolare contabilità: Violazione: responsabilità civile (difficoltà accertamento danno a creditori) e bancarotta documentale.
- Dovere di par condicio: non favorire alcuni creditori ingiustificatamente. Violazione: atti revocabili e possibili sanzioni (bancarotta preferenziale).
- Dovere di non aggravare il passivo: Violazione: già vista, danno risarcibile con criteri presuntivi di cui a 2486 c.c. e possibili bancarotta per operazioni dolose (se addirittura aggravato intenzionalmente il dissesto).
- Dovere di vigilanza (per sindaci) e controllo (per revisori): gli organi di controllo, se esistenti, devono spronare gli amministratori a rispettare questi doveri. In caso di inerzia colpevole, pure i sindaci possono essere citati in responsabilità solidale con gli amministratori per omessa vigilanza. Esempio: se il collegio sindacale non segnala perdite di capitale o non avverte l’organo amministrativo delle irregolarità, potrà il curatore includere anche loro nell’azione di responsabilità. Idem il revisore se ha certificato bilanci non veritieri coprendo insolvenza.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito proponiamo una sezione domande e risposte per chiarire alcuni dubbi comuni su come difendersi dai debiti aziendali, specialmente dal punto di vista del debitore.
D: La mia S.r.l. ha troppi debiti e non riesco a pagarli tutti. Posso “chiudere” la società per evitare i creditori?
R: Chiudere formalmente una società senza pagare i debiti non fa scomparire le obbligazioni. Se procedi a liquidazione e cancellazione della S.r.l. lasciando creditori insoddisfatti, questi potranno rivalersi sugli ex soci (nei limiti di quanto hanno ricevuto in liquidazione) e sui liquidatori se la mancata soddisfazione è colpa loro . Inoltre, eventuali atti dispositivi pre-liquidazione per sottrarre beni ai creditori potrebbero essere revocati o considerati reato (sottrazione fraudolenta). La strada corretta è affrontare il problema: o trovi un accordo con i creditori (stragiudiziale o concorsuale) o, se non c’è soluzione, si andrà in liquidazione giudiziale (fallimento) con eventuale esdebitazione finale. “Chiudere e scappare” espone a gravi rischi (azioni legali personali, accuse di bancarotta se fallisci entro 1 anno ). Conviene invece chiudere ordinatamente, pagando quel che si può secondo legge.
D: Ho dato garanzie personali (fideiussioni) sui debiti bancari della mia società. Se faccio un concordato preventivo per l’azienda, le banche possono rivalersi su di me garante?
R: Sì, il concordato preventivo produce effetti soltanto sul debitore principale (la società). I fideiussori e coobbligati non sono protetti dalla procedura, a meno che il creditore non rinunci espressamente anche verso di loro. Quindi, salvo accordi diversi, la banca potrà chiedere a te, garante, l’intero importo dovuto dalla società (dedotto magari quanto incassa in concordato). Nota che la presentazione della domanda di concordato fa scattare per il creditore l’obbligo di attivarsi verso il fideiussore entro 6 mesi, altrimenti la fideiussione si può estinguere ex art. 1957 c.c. . Questo per evitare che la banca dorma durante il concordato e poi pretenda da te dopo anni. Quindi, se la tua società entra in concordato, probabilmente la banca ti chiederà di onorare la garanzia abbastanza presto. In fase di trattativa, puoi provare a coinvolgere il garante nelle transazioni (es. offrire un saldo minore con liberazione completa). Tieni presente però che se tu garante paghi la banca, subentri (surroga) nel suo credito verso la società (in concordato verrai trattato come creditore chirografario per quell’importo). Se il concordato prevede di pagare, ad esempio, il 40% ai chirografari, recupererai il 40% di quanto hai pagato. Il concordato in sé però non impedisce l’escussione del garante.
D: Ho debiti fiscali molto alti (IVA e imposte) che non posso pagare subito. Posso chiederne la cancellazione o almeno di pagarli a rate?
R: Non esiste il “condono automatico” dei debiti fiscali salvo specifiche leggi di definizione agevolata (che il Parlamento a volte approva). Al momento, lo strumento ordinario è la rateizzazione: puoi chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione un piano di dilazione (oggi fino a 120 rate in casi ammessi) . Questo ti permette di pagare gradualmente e sospende le azioni esecutive purché rispetti le rate. Se la mole è insostenibile e vuoi ridurre l’importo, devi passare attraverso un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale o un concordato preventivo: in queste procedure puoi proporre all’Erario un pagamento parziale delle imposte (stralcio di parte, esclusi IVA e ritenute che in concordato si possono solo dilazionare, non stralciare oltre il 20% salvo cram-down) . Serve il vaglio del tribunale e che la proposta sia almeno pari a quanto il Fisco otterrebbe in caso di fallimento. Se soddisfi queste condizioni, il giudice può omologare anche senza l’adesione formale del Fisco (cram-down) . In sede puramente amministrativa invece, non puoi ottenere lo stralcio unilaterale del debito fiscale, tranne che con gli istituti di definizione agevolata di legge (es. “rottamazione” che però abbatte sanzioni e interessi, non l’imposta base). Dunque, difenderti dai debiti fiscali significa giocare tra dilazioni e procedure concorsuali. Ignorarli è pericoloso (come visto, genera ipoteche, fermi, possibili denunce per omesso versamento).
D: La crisi è dovuta anche a errori di gestione miei. Rischio che mi tolgano la casa di proprietà per pagare i debiti della società?
R: Se la tua società è di capitali (S.r.l., S.p.A.), vige autonomia patrimoniale: i creditori sociali non possono aggredire direttamente i tuoi beni personali, salvo tu abbia fornito garanzie personali (fideiussioni, pegno su tuo bene, ecc.) o salvo situazioni di abuso di forma societaria. Però, come spiegato, se la società fallisce e i suoi beni non coprono i debiti, il curatore può citarti per responsabilità e in quel caso, in forza di una sentenza di condanna, i creditori indirettamente colpiranno il tuo patrimonio (la casa) per risarcimento . Inoltre, ci sono eccezioni come il Fisco (può chiedere conto a soci/liquidatori per imposte non pagate) . Quindi, non è automatico che perdi la casa, ma è un rischio se hai commesso mala gestio. La casa è al sicuro solo finché i creditori non ottengono un titolo contro di te. Nel caso di imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, invece, la casa è aggredibile eccome dai creditori personali. C’è solo la tutela del “fondo patrimoniale” o “trust” se avevi segregato la casa in quei vincoli prima della crisi (fondo patrimoniale copre debiti non contratti per bisogni d’impresa/famiglia, trust a volte revocabile se fatto in frode ai creditori). Dunque, la miglior difesa per la casa è non esporsi personalmente: se l’hai già fatto, l’unica è negoziare anche a nome tuo (es. esigere liberatoria per fideiussione come condizione di un accordo).
D: Ho scoperto che alcuni ex amministratori hanno commesso irregolarità (hanno fatto uscire soldi prima di dimettersi). Posso non pagare quei debiti?
R: I debiti della società verso terzi restano validi anche se i soldi sono stati distratti dagli ex amministratori. Tuttavia, hai diritto (anzi, dovere, se sei il nuovo amministratore) di valutare azioni contro di loro: un’azione di responsabilità per recuperare i fondi sottratti. Se la società è ora insolvente, questa azione la eserciterà il curatore nel fallimento. Quei fondi potrebbero rientrare tramite revocatorie o se si dimostra che c’erano pagamenti indebiti a parti correlate. Ma di fronte ai creditori esterni la società non può eccepire “non pago perché Tizio amministratore rubò”: i creditori in buona fede sono tutelati, semmai la società (o il curatore) recupererà da Tizio e così potrà pagarli. Se però i creditori erano conniventi (es. un creditore fittizio amico dell’ex amministratore), allora sì, puoi contestare quel “debito” come inesistente e rifiutarti di pagarlo, facendolo accertare in giudizio. È consigliabile in questi casi procedere con audit forense e, se si va in procedura concorsuale, segnalare al commissario/curatore le irregolarità, chiedendo di agire di conseguenza.
D: La banca mi ha revocato il fido e chiesto rientro immediato. Posso oppormi?
R: Dipende dalle condizioni contrattuali e dallo stato di crisi legale. In linea di massima, se il fido è a revoca, la banca può revocarlo discrezionalmente (salvo abuso di diritto da provare in casi estremi). Se invece è un mutuo o apertura di credito con preavviso contrattuale, deve rispettare i termini di preavviso. In ogni caso, se sei in composizione negoziata o concordato, la banca non può alterare i rapporti contrattuali per insoluti pregressi: ad esempio, non può compensare forzosamente il conto se sei protetto da misure (questo perché i crediti anteriori sono congelati). Durante la composizione negoziata, potresti chiedere come misura protettiva che le banche si astengano da revoche ingiustificate di affidamenti (il tribunale può emanare ordini in tal senso, soprattutto se il credito bancario è vitale alla continuità aziendale). Però obbligare una banca a tenere aperto un fido è difficile, a meno che la revoca configuri violazione di regole (ad esempio, se siete in moratoria settoriale o c’è stato accordo di standstill). Una difesa pratica è dialogare: presentare alla banca il piano che stai perseguendo (accordo o concordato in arrivo) e chiedere una moratoria. Spesso le banche, se vedono serietà e magari hanno garanzie, preferiscono negoziare piuttosto che agire aggressivamente (anche perché, se presenti concordato, comunque non potranno incassare subito oltre le garanzie reali). Quindi, opporsi legalmente a una revoca è complicato, ma puoi mitigare l’effetto includendo la banca in un accordo ampio (o, se già depositato concordato, ricordare alla banca che il credito suo è congelato e non può soddisfarsi extra concorso).
D: Quali debiti hanno priorità assoluta?
R: I debiti con privilegio speciale (es. ipoteca su immobile per mutuo) o privilegio generale (stipendi, TFR, debiti fiscali per IVA) vengono soddisfatti con precedenza sui beni o sul ricavato prima dei chirografari. Ciò significa che in qualunque procedura liquidatoria quei creditori vengono pagati per primi fino a copertura del loro credito (se l’attivo basta). Anche negli accordi o concordati, questi crediti vanno trattati meglio degli altri. Un debito garantito da pegno o ipoteca di solito in caso di default porta il creditore ad escutere il bene o ad essere soddisfatto col ricavato della vendita di quel bene (al netto solo delle spese di giustizia). Dunque, i debiti bancari garantiti e i debiti verso dipendenti e Fisco (per la parte privilegiata) sono prioritari. Tuttavia, attenzione: possono degradare in parte a chirografari se il valore del bene non copre tutto il credito garantito. Esempio: mutuo 200 con ipoteca su immobile che frutta 150: la banca ha privilegio su 150, e 50 restano come credito chirografario. Altro debito con “priorità” pratica sono i debiti verso fornitori essenziali (es. fornitura elettricità): non hanno un privilegio legale speciale, ma senza pagarli l’azienda muore. Perciò spesso, di fatto, si danno priorità di pagamento (autorizzata dal tribunale magari) a quei fornitori per continuare l’attività durante la crisi. Formalmente però restano chirografari. Quindi, in termini legali stretti: i debiti privilegiati sono prioritari. In termini strategici: i debiti “critici” per operatività diventano di fatto prioritari nelle scelte di chi paga prima.
D: La mia azienda è in crisi ma vorrei salvarla, magari vendendola. Posso farlo con i debiti?
R: Sì, esistono varie modalità di “passaggio di mano” della tua azienda nonostante i debiti. Nella composizione negoziata, ad esempio, puoi cercare un investitore disposto a intervenire: la norma prevede che l’esperto agevoli anche la ricerca di soluzioni, incluse offerte di terzi (c’è un istituto chiamato “pubblicazione di ricerca di offerte” in cui si mette sul mercato l’azienda durante la composizione). Se trovi un acquirente, potresti realizzare un accordo dove il terzo paga una somma che va ai creditori in cambio dell’azienda “pulita”. Ciò può succedere via concordato preventivo in continuità indiretta: vendi l’azienda al terzo come parte del piano, e con il ricavato paghi i creditori (il tribunale può autorizzare la cessione anche senza consenso individuale di tutti i creditori, che invece partecipano via voto al concordato). Oppure via accordo di ristrutturazione: il terzo può intervenire sottoscrivendo un aumento di capitale e mettendo soldi per pagare i creditori aderenti. Anche in fallimento c’è l’istituto dell’esercizio provvisorio e cessione azienda: l’azienda viene venduta “libera da debiti” e i crediti restano verso la massa fallimentare. La chiave è: vendere l’azienda senza i debiti attaccati, perché i debiti restano nella procedura. Non puoi vendere le quote o l’azienda “così com’è” pretendendo che il compratore si accolli automaticamente tutti i debiti (a meno che lo pattui espressamente, ma non avverrà se è sana logica: vorrà pagar meno per compensare i debiti accollati). Ad esempio, se uno vuole rilevare la tua impresa di inverter, potrebbe dire: “faccio concordato: io verso 1 milione che verrà usato per pagare 30% di tutti i debiti; in cambio mi cedi l’azienda, e la tua società vecchia poi verrà liquidata ma senza più niente”. Oppure: “compro l’azienda dal fallimento per 1 milione”. L’effetto è simile: tu perdi proprietà, i creditori ottengono quel che il terzo offre in percentuale, il terzo prosegue l’attività su una newco o sulla struttura rilevata. Dunque sì, cedere per salvare è possibile. La difesa tua qui consiste nel trovare quel compratore prima che il valore evapori del tutto. Se aspetti troppo, l’azienda perde appeal (know-how, mercato, personale chiave) e nessuno la vorrà, se non a prezzi di liquidazione.
D: Dopo aver superato la crisi, i miei fornitori e banche mi trattano con diffidenza. Posso ottenere che le segnalazioni negative vengano rimosse?
R: Se hai avuto una procedura concorsuale, purtroppo rimarrà traccia nei sistemi di informazione creditizia (Cerved, Centrale Rischi, ecc.) per un certo periodo. Ad esempio, un concordato preventivo omologato è un fatto pubblico che appare nel Registro delle Imprese (cancellabile con annotazione solo dopo completamento e forse neanche del tutto). Non c’è un diritto all’oblio immediato. Tuttavia, una volta che tu adempia al concordato o esca dal fallimento con esdebitazione, sei riabilitato legalmente: potrai richiedere al tribunale un decreto di riabilitazione che dichiara chiuse le pendenze. Questo viene pubblicato ed è utile a dimostrare che hai “pagato il fio”. Alcune segnalazioni (tipo Centrale Rischi Banca d’Italia) riportano per 36 mesi gli insoluti, poi cadono se regolarizzati. Quindi col tempo la situazione migliora. Dal punto di vista pratico, l’unica cosa è ricostruire la fiducia fornendo le prove del tuo risanamento: bilanci tornati positivi, referenze di clienti, e così via. Non c’è un modo legale di imporre ai fornitori di fidarsi, ovviamente; devi convincerli di essere diventato affidabile. Puoi proporre misure come pagamenti anticipati inizialmente, garanzie aggiuntive, per poi chiedere gradualmente normalizzazione dei fidi. La legge punisce eventuali atteggiamenti discriminatori solo in pochi casi: ad esempio, durante la composizione negoziata i creditori essenziali non possono cessare i contratti in essere solo perché hai avviato la procedura (art. 19 CCII prevede questo). Ma dopo, sul mercato libero, sta a te ricostruire la reputazione.
D: Se la mia azienda fallisce, devo aspettarmi di essere denunciato penalmente?
R: Non automaticamente, ma è molto probabile che il curatore e la procura della Repubblica esaminino la tua gestione. Il curatore è obbligato a fare una relazione dettagliata sulle cause del fallimento e sulla condotta degli amministratori, segnalando eventuali fatti di reato (art. 338 CCII). Se emergono anomalie (buchi di inventario, mancanza di libri, pagamenti preferenziali sospetti, vendite sottocosto a parenti, etc.), il curatore le evidenzierà. La relazione va al PM, che valuterà se aprire un’indagine. Inoltre, i creditori a volte autonomamente sporgono denuncia se ritengono di aver subìto frodi. Quindi, se hai operato con correttezza e trasparenza, potresti anche uscire senza incriminazioni; ad esempio, fallimenti per cause esterne (crollo settore, crisi COVID) dove i libri sono in ordine e non ci sono atti distrattivi spesso si concludono con l’archiviazione in sede penale. Viceversa, se ci sono state irregolarità, quasi sicuramente verrà aperto un procedimento per bancarotta. Tieni conto che la bancarotta fraudolenta richiede il dolo, quindi devono trovare intenzionalità di nuocere o frodare. Se non c’è, al limite possono contestare bancarotta semplice (che è contravvenzione). In ogni caso, come amministratore fallito, è prudente farsi assistere da un legale penalista fin da subito per predisporre la tua difesa: spesso è utile collaborare col curatore fornendo chiarimenti già nella fase pre-indagine, in modo da dissipare eventuali sospetti (o ridurre la gravità percepita). In sintesi: non tutti i falliti vanno in galera, ma la possibilità di indagini c’è e dipende molto da come hai gestito le cose. Difenderti dai guai penali, come detto, coincide con aver fatto le cose in regola nel periodo pre-fallimento.
D: La crisi mi ha causato anche debiti personali (es. ho dovuto firmare prestiti personali per mettere soldi in azienda). Posso liberarmi anche di quelli?
R: Questo è un tema spinoso. Se hai debiti personali (non della società) e sei sovraindebitato tu come persona fisica, potresti accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore se prevalentemente personali, o liquidazione del patrimonio personale). Ad esempio, se hai messo casa a garanzia e la banca escute te, e tu non hai altre risorse, puoi valutare la liquidazione controllata del tuo patrimonio come persona sovraindebitata. Questa è una procedura simile al fallimento, ma per soggetti non fallibili (o anche fallibili ma per debiti esclusi dalla concorsualità). Se riesci a completarla correttamente, avrai l’esdebitazione personale, cioè la liberazione dai debiti residui. In alternativa, se i tuoi debiti sono in parte legati a quelli dell’azienda (tipo fideiussioni attivate), e l’azienda fallisce, tu come garante pagherai in parte i creditori e poi diverrai creditore del fallimento – potrai come persona chiedere dopo eventualmente di essere esdebitato in proprio. È complesso quando intrecci persona e società. Ma sappi che oggi c’è la esdebitazione del debitore incapiente: se una persona fisica non fallibile (perché i debiti sono personali o da piccola impresa) è nullatenente, può chiedere di cancellare i suoi debiti una tantum, mantenendo l’obbligo morale di pagare se nei 4 anni successivi migliora la sua condizione (art. 283 CCII). È una norma pensata proprio per chi fallisce come piccolo imprenditore e rimane sommerso di debiti. Quindi sì, in ultima istanza anche tu personalmente puoi avere un “fresh start”, ma devi passare per procedure giudiziarie ad hoc. Non esiste la cancellazione automatica dei tuoi debiti per il fatto che la società ha risolto i suoi: sono entità distinte.
Conclusioni
Affrontare una situazione di azienda fortemente indebitata richiede lucidità, competenza e l’utilizzo combinato di strumenti giuridici e manageriali. Questa guida ha esaminato, con un taglio avanzato, le possibili strade percorribili – dalle trattative private a quelle assistite e alle procedure concorsuali – evidenziando per ciascuna i vantaggi e i limiti. Dal punto di vista del debitore, “difendersi” dai debiti non significa sfuggire alle proprie obbligazioni, ma gestirle in modo da minimizzare le perdite (per l’impresa e per i suoi stakeholder) e da evitare che la crisi travolga definitivamente ogni valore.
Alcuni punti chiave emergono:
- Prevenzione e tempestività: implementare assetti di controllo adeguati non è solo rispetto della legge ma un investimento sul futuro dell’azienda. Rilevare un inizio di crisi e attivarsi per tempo (p.es. ricorrendo alla composizione negoziata) può fare la differenza tra un risanamento riuscito e un fallimento rovinoso. Ricordiamo che solo il 3,5% delle imprese aveva dichiarato assetti adeguati al 2023 , segno che c’è ancora scarsa cultura in proposito – e ciò spesso si traduce in ritardi fatali.
- Trasparenza con i creditori: negoziare in buona fede paga. Molte soluzioni (piani attestati, accordi) richiedono la fiducia dei creditori. Presentare piani realistici con attestazioni indipendenti, coinvolgere i creditori in modo paritario e offrire loro una prospettiva migliore di quella liquidatoria sono passi fondamentali. L’80% di qualcosa è meglio del 100% di niente: far passare questo messaggio ai creditori è centrale.
- Uso corretto delle procedure concorsuali: il concordato preventivo e gli altri istituti non vanno subiti all’ultimo respiro, bensì inseriti in una strategia. Un concordato ben congegnato in continuità può ristrutturare l’impresa salvando posti di lavoro e valore, mentre uno liquidatorio può evitare lungaggini e costi ulteriori di un fallimento. L’importante è scegliere la procedura giusta per tempo e prepararla a dovere, con l’aiuto di professionisti.
- Responsabilità e integrità: l’atteggiamento verso la crisi deve essere responsabile. Ciò significa preservare la par condicio, evitare favoritismi o distrazioni, tenere una condotta onesta e documentata. Così facendo, l’imprenditore riduce al minimo i rischi di conseguenze personali postume (azioni di responsabilità o penali) e potrà beneficiare degli istituti di esdebitazione e rilancio senza strascichi. In altre parole, difendere la propria impresa dai debiti va di pari passo col difendere sé stessi da accuse: entrambe le cose si ottengono agendo secondo legge e nell’interesse del ceto creditorio, per quanto possibile.
In ultima analisi, un’azienda di inverter indebitata (o qualsiasi azienda in crisi) può trovare vie d’uscita dignitose e a volte di successo, ma è fondamentale agire con cognizione di causa e supporto qualificato. La normativa italiana offre oggi un ventaglio di strumenti moderni, in linea anche con le direttive europee, per favorire il risanamento delle imprese viable e, quando ciò non è possibile, per liquidare rapidamente le insolventi con la minor dispersione di valore e offrendo all’imprenditore onesto la possibilità di ripartire.
Come abbiamo visto attraverso tabelle, esempi e Q&A, la strada non è semplice – è fatta di negoziazioni complesse, passaggi giudiziari e sacrifici. Ma conoscere bene i propri diritti e doveri in queste fasi costituisce già metà della difesa. La speranza è che questa guida esaustiva fornisca un orientamento solido a chiunque (avvocato, consulente, imprenditore o studioso) si trovi ad affrontare il tema “azienda indebitata: cosa fare per difendersi e come farlo al meglio”.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali (agg. Ottobre 2025):
- Codice Civile: artt. 2086, 2446-2447 (spa) / 2482-bis, 2482-ter (srl), 2484-2487 (scioglimento e liquidazione), 2485-2486 (doveri amministratori dopo scioglimento) , 2476 (responsabilità amministratori srl), 2392-2394 (responsabilità amm. spa verso società e creditori). Modifiche ex D.Lgs. 14/2019: in particolare art. 2486 c.c. comma 3 introdotto dall’art. 378 CCII (criteri liquidazione danno) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, e successive modifiche D.Lgs. 147/2020, 83/2022, 136/2024): Parti rilevanti – Parte Prima: obblighi di adeguati assetti e doveri di emersione tempestiva ; Titolo II: Composizione negoziata (artt. 12-25-octies) ; Titolo III: Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) , incluso concordato semplificato (art. 25-sexies) ; Titolo IV: Liquidazione giudiziale (artt. 121-270); Titolo V: Disposizioni su liquidazione controllata sovraindebitati (artt. 268-277); Titolo VI: Esdebitazione (artt. 278-283).
- D.L. 118/2021 conv. L.147/2021: norma istitutiva Composizione Negoziata , con decreti dirigenziali 28/09/2021 e D.M. 21/03/2022 (check-list crisi) – integrazioni ora nel CCII dopo D.Lgs. 83/2022.
- D.Lgs. 136/2024 (“correttivo-ter”): ha introdotto miglioramenti alla composizione negoziata (procedure sotto-soglia semplificate, ecc.) .
- Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942): rilevante per giurisprudenza formatasi sotto di essa, in particolare art. 67 (revocatorie, piani attestati) , art. 160-186 (concordato preventivo), art. 182-bis (accordi ristrutturazione) , art. 216-217 (reati di bancarotta e ricorso abusivo credito).
- Legislazione fiscale e societaria: D.P.R. 602/1973 art. 19 (rateazione cartelle, modificato da D.Lgs.110/2024 art.13) ; art. 10 L.F. (fallimento entro 1 anno da cancellazione società) ; D.Lgs. 74/2000 artt. 10-bis, 10-ter (omessi versamenti) e artt. 2-5 (dichiarazione fraudolenta/infedele); Codice Penale art. 641 (insolvenza fraudolenta).
- Giurisprudenza:
- Cassazione Civile:
– Cass. Sez. Un. 9100/2015: principi su criteri liquidazione danno per continuazione attività (deficit vs differenza patrimoni) .
– Cass. Sez. I, 26/04/2024 n. 11324: onere della prova in azione di responsabilità del curatore vs amministratori – spetta a curatore allegare inadempimento, poi agli amm. provare corretto operato . Importante per inversione onere su impiego risorse: curatore può limitarsi a dimostrare che risorse sono sparite in modo ingiustificato, tocca agli amministratori giustificarne l’uso .
– Cass. Sez. I, 02/04/2025 n. 8733: termine di decadenza fideiussore ex art.1957 c.c. decorre da domanda concordato preventivo .
– Cass. Sez. I, 19/08/2024 n. 22914: privilegio fondiario si applica anche in liquidazione controllata sovraindebitamento .
– Cass. Sez. I, 24/10/2025 n. 28313: (in materia di società di comodo in concordato) – conferma irrilevanza cause di scioglimento fittizie nel concordato; [riferimento generico da ratio.it].
– Cass. Sez. Un. 8500/2021: (sul cram-down fiscale nel concordato) – ha affermato la legittimità dell’omologa senza voto Fisco se garantito almeno il dovuto in liquidazione (con riferimento a art. 180, co.4 L.F. introdotto nel 2020). - Cassazione Penale:
– Cass. Pen. Sez. V, 05/07/2023 n. 28064: conferma configurabilità bancarotta fraudolenta per distrazione anche in operazioni di trust prefallimentare se dolose.
– Cass. Pen. Sez. V, 24/05/2019 n. 23098: sulla distinzione bancarotta preferenziale vs semplice pagamento di debiti in buona fede. - Corte Costituzionale:
– Corte Cost. 19/01/2024 n. 6: (sulla durata minima procedure sovraindebitamento e stipendio impignorabile) – cenni su liquidazione controllata .
– Corte Cost. 21/07/2021 n. 147: legittimità cram-down tributario nel concordato (ha dichiarato inammissibile questione sull’art. 180, co.4 L.F.). - Merito e dottrina:
– Tribunale di Bergamo, decreto 06/12/2023 (concordato semplificato): dichiarato inammissibile piano che non attribuiva utilità minima ad alcuni creditori (violazione art. 25-sexies CCII) .
– Tribunale di Firenze, 04/03/2024 n. 428: opinione su natura non retroattiva art. 2486 c.c. comma 3 (citata in dottrina) .
– Tribunale di Milano, 10/01/2023: sulla concessione misure protettive in composizione negoziata e requisiti (prime applicazioni D.Lgs. 83/2022).
- Cassazione Civile:
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce inverter industriali, inverter per motori, drive di controllo, convertitori di frequenza, inverter fotovoltaici e sistemi di elettronica di potenza si trova in una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce inverter industriali, inverter per motori, drive di controllo, convertitori di frequenza, inverter fotovoltaici e sistemi di elettronica di potenza si trova in una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori, finanziarie o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore degli inverter richiede componenti elettronici costosi, schede di potenza, dispositivi di controllo, semiconduttori, hardware di precisione, collaudi e certificazioni. Basta un rallentamento nei pagamenti dei clienti per far crollare la liquidità e generare una crisi improvvisa.
La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata.
Con la giusta strategia puoi bloccare i creditori, ridurre i debiti e continuare a operare senza interrompere la produzione.
Perché un’Azienda di Inverter Finisce in Debito
Le cause più frequenti sono:
• aumento del costo di componenti elettronici, IGBT, MOSFET, microcontrollori
• ritardi nei pagamenti di clienti industriali, integratori e contractor
• importazioni costose con pagamenti anticipati
• magazzino immobilizzato tra schede, moduli di potenza, inverter finiti e ricambi
• investimenti in test, certificazioni CE/EMC, sicurezza elettrica
• rincari energetici e logistici
• riduzione delle linee di credito bancarie
• cicli di produzione e setup hardware molto lunghi
Il problema non è la mancanza di lavoro ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi per una Azienda di Inverter con Debiti
Se non intervieni rapidamente rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti bancari
• stop delle forniture di componenti elettronici critici
• decreti ingiuntivi e azioni esecutive
• sequestro del magazzino, delle schede e dei moduli di potenza
• interruzione della produzione per mancanza di componenti
• ritardi nelle consegne e perdita di clienti chiave
• rischio concreto di fermo totale dell’azienda
Un debito non gestito può paralizzare completamente l’attività.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1) Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
• sospendere pignoramenti in corso
• bloccare richieste aggressive delle banche
• tutelare i conti correnti
• negoziare con i fornitori più urgenti
Prima si ferma l’emergenza, poi si crea il piano di salvataggio.
2) Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
I debiti spesso contengono:
• interessi e more illegittimi
• somme duplicate
• posizioni prescritte
• errori della Riscossione
• costi bancari non dovuti
• conteggi sbagliati
Ridurre il debito è possibile, spesso in modo molto significativo.
3) Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di pagamento con fornitori strategici
• rinegoziazioni bancarie
• sospensione temporanea dei pagamenti
• utilizzo delle definizioni agevolate (se attive)
L’obiettivo è ristabilire liquidità e non fermare la produzione.
4) Attivare strumenti legali che proteggono l’azienda
Per debiti importanti sono disponibili strumenti potentissimi:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione con i creditori
• concordato minore
• liquidazione controllata (solo come ultima scelta)
Questi strumenti consentono di:
• bloccare totalmente i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte dei debiti
• continuare la produzione
• proteggere l’imprenditore da responsabilità personali
Sono procedure sicure, legali e approvate dal Tribunale.
5) Proteggere produzione, magazzino e forniture
Nel settore degli inverter è essenziale:
• tutelare moduli di potenza, schede, trasformatori, dissipatori
• garantire continuità di approvvigionamento
• evitare sequestri che bloccherebbero produzione e collaudi
• proteggere macchinari e banchi prova
• mantenere attivi i rapporti con clienti industriali
La produzione deve continuare, altrimenti il debito peggiora.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco dei debiti commerciali, fiscali e bancari
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documentazione fiscale
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario magazzino (schede, moduli, inverter, componenti)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini in corso e pianificazione delle consegne
Tempistiche di Intervento
• Analisi iniziale: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Procedura giudiziaria (se necessaria): 3–12 mesi
Le tutele possono attivarsi già dai primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione reale dei debiti
• Protezione di magazzino, componentistica e macchinari
• Ristrutturazione efficace con banche e fornitori
• Continuità produttiva e commerciale garantita
• Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti e atti giudiziari
• Fare nuovi debiti per coprire debiti vecchi
• Favorire un creditore a discapito di altri
• Lasciare andare avanti pignoramenti e decreti
• Fidarsi di società “miracolose” non qualificate
Ogni errore peggiora la crisi.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della tua situazione debitoria
• Blocco immediato dei creditori
• Piani di ristrutturazione sostenibili e personalizzati
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Riscossione
• Protezione totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di inverter non significa essere destinati alla chiusura.
Con una strategia tempestiva puoi:
• bloccare subito i creditori
• ridurre il debito in modo significativo
• proteggere magazzino e produzione
• salvare l’azienda e il tuo futuro imprenditoriale
Il momento di agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa e il rilancio della tua azienda possono cominciare oggi stesso.