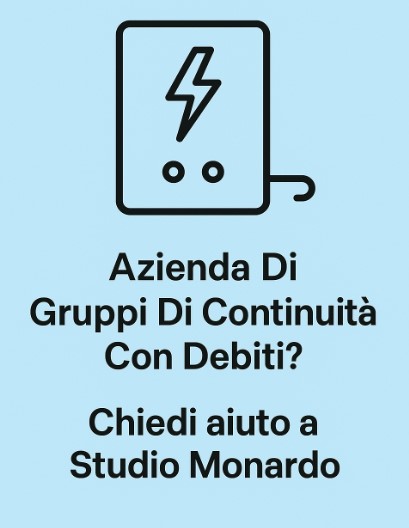Se gestisci un’azienda che produce, distribuisce o installa gruppi di continuità (UPS), sistemi di backup energetico, inverter, batterie industriali, stabilizzatori e soluzioni per la sicurezza elettrica, e ti trovi con debiti fiscali, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente critica.
Gli UPS sono dispositivi fondamentali per data center, industrie, impianti di automazione, strutture sanitarie e aziende che devono garantire continuità elettrica. Un blocco causato dai debiti può fermare le forniture, generare ritardi critici e compromettere rapporti con clienti ad alta esigenza tecnica.
La buona notizia è che puoi bloccare le procedure, ridurre i debiti e salvare l’azienda, se intervieni tempestivamente.
Perché le aziende di UPS accumulano debiti
Le cause più frequenti sono:
- costi elevati di componenti elettronici, batterie, moduli e inverter
- magazzini complessi con ricambi costosi e sensibili
- pagamenti lenti da parte di aziende, enti pubblici e strutture industriali
- aumento dei costi del litio, dei semiconduttori e della logistica
- ritardi nei pagamenti di IVA, imposte e contributi
- investimenti necessari per test, manutenzioni e certificazioni
- difficoltà di accesso a linee di credito bancario
- fornitori strategici che richiedono pagamenti immediati
Questi fattori possono portare rapidamente a crisi di liquidità e indebitamento crescente.
Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata
Il primo passo è intervenire immediatamente. Ecco cosa devi fare:
- far analizzare la situazione da un avvocato esperto in debiti aziendali
- verificare quali debiti sono corretti, prescritti o contestabili
- evitare di firmare accordi affrettati o rateizzazioni insostenibili
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso
- negoziare rateizzazioni realmente sostenibili con AE e INPS
- proteggere forniture essenziali (batterie, inverter, moduli UPS)
- prevenire il blocco del conto corrente o la riduzione dei fidi
- valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o cancellare parte dei debiti
Una diagnosi professionale permette di individuare debiti da ridurre, sospendere o contestare.
I rischi concreti per un’azienda indebitata
Se non agisci in tempo puoi andare incontro a rischi gravi:
- pignoramento del conto corrente aziendale
- fermo di attrezzature e mezzi tecnici
- blocco delle forniture di UPS, batterie ou ricambi
- impossibilità di rispondere a urgenze o richieste di manutenzione
- perdita di clienti industriali, pubblici e strategici
- danneggiamento della reputazione professionale
- crisi di liquidità e impossibilità di pagare personale e fornitori
- rischio reale di chiusura dell’attività
Nel settore degli UPS, anche un ritardo nelle consegne può compromettere contratti importanti.
Come un avvocato può aiutarti concretamente
Un avvocato esperto in debiti aziendali può intervenire in modo efficace:
- bloccare immediatamente pignoramenti e misure esecutive
- ridurre l’importo dei debiti tramite trattative con AE, INPS e banche
- ottenere rateizzazioni davvero sostenibili
- annullare debiti prescritti, irregolari o mal notificati
- negoziare con fornitori e istituti di credito al posto tuo
- proteggere lo stock, le attrezzature e la continuità operativa
- stabilizzare la situazione aziendale durante la ristrutturazione
- prevenire che la crisi degeneri in insolvenza
Una strategia professionale può salvare l’azienda anche in situazioni complesse.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere operativa l’azienda devi:
- intervenire subito, senza attendere ulteriori solleciti
- evitare trattative non strategiche con i creditori
- proteggere fornitori critici e componenti indispensabili
- ristrutturare i debiti prima dell’arrivo di pignoramenti
- individuare debiti contestabili o calcolati in modo errato
- preservare la liquidità per garantire consegne, assistenza e manutenzione
Così puoi evitare fermi, ritardi e perdita di clienti strategici.
Quando rivolgersi a un avvocato
È il momento di farlo se:
- hai ricevuto solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
- i debiti con AE Riscossione, INPS o banche non sono più gestibili
- rischi il blocco del conto corrente aziendale
- la liquidità sta diminuendo rapidamente
- hai difficoltà a pagare fornitori o dipendenti
- vuoi impedire che la crisi sfoci in chiusura o insolvenza
Un avvocato competente può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare la tua attività.
Attenzione: molte aziende tecnologiche non falliscono per i debiti, ma per aver aspettato troppo. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare davvero la tua impresa.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali, riscossione e difesa di imprese tecnologiche e industriali – ti aiuta a proteggere la tua azienda di gruppi di continuità (UPS).
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare subito le procedure, ridurre i debiti e mettere in sicurezza l’attività.
Introduzione
Un’azienda operante nel settore dei gruppi di continuità (UPS, Uninterruptible Power Supply) può trovarsi sovraccarica di debiti per molte ragioni: calo delle vendite, investimenti errati, crisi di liquidità o ritardi nei pagamenti dei clienti. Quando i debiti diventano insostenibili, l’imprenditore deve agire rapidamente e consapevolmente per difendere l’azienda e sé stesso. In Italia esistono strumenti giuridici avanzati per gestire la crisi d’impresa e, quando possibile, evitarne il fallimento. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi dettagliata di tali strumenti (piani di risanamento, accordi con i creditori, concordato preventivo, ecc.), delle tutele legali per il debitore e delle strategie pratiche per affrontare creditori di vario tipo (erariali, bancari, fornitori, dipendenti, enti previdenziali). Il taglio è operativo ma con linguaggio giuridico divulgativo, adatto tanto a consulenti legali quanto a imprenditori e privati.
Seguendo un punto di vista del debitore, esamineremo innanzitutto come distinguere uno stato di crisi da uno stato di insolvenza, i segnali d’allarme e gli obblighi di legge collegati. Analizzeremo poi le diverse categorie di debito e le specifiche criticità (ad esempio, debiti fiscali vs. debiti bancari) e illustreremo i principali strumenti di risanamento previsti dall’ordinamento italiano (dal piano attestato ai vari tipi di accordi e al concordato preventivo, anche alla luce delle ultime riforme del Codice della crisi). Vedremo come tutelarsi dalle azioni esecutive dei creditori, come gestire o evitare l’escussione di garanzie personali, e quali responsabilità può avere l’imprenditore con il proprio patrimonio. Saranno fornite tabelle riepilogative per confrontare soluzioni diverse e casi pratici simulati con domande e risposte per chiarire i dubbi frequenti.
Nota importante: le normative citate sono quelle italiane, in particolare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, detto CCII), aggiornato con le modifiche più recenti (incluso il correttivo del 2024). Le sentenze menzionate sono le più autorevoli e recenti disponibili, con riferimenti puntuali a decisioni di legittimità e merito. Tutte le fonti e i riferimenti normativi e giurisprudenziali utilizzati sono raccolti in una sezione finale della guida.
Crisi d’impresa vs insolvenza: definizioni e segnali
Prima di intraprendere qualsiasi azione, è fondamentale capire in che stato versa l’azienda dal punto di vista finanziario e giuridico. Il diritto italiano distingue tra crisi e insolvenza, concetti simili ma giuridicamente differenti.
- Crisi d’impresa: è una fase di difficoltà economico-finanziaria preliminare rispetto all’insolvenza. Nel CCII la crisi è definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” . In sostanza, l’azienda è in crisi quando, pur riuscendo ancora a operare, mostra segnali di squilibrio (fatturato in calo, perdite, cash flow insufficiente per onorare debiti in scadenza) tali da far prevedere che, senza interventi correttivi, potrebbe diventare insolvente. È un “campanello d’allarme” che impone all’imprenditore di attivarsi tempestivamente: il Codice civile (art. 2086 c.c.) impone infatti agli amministratori di società di “adottare adeguati assetti organizzativi” per rilevare e affrontare la crisi prontamente. Ignorare questi segnali può aggravare la situazione ed esporre gli amministratori a responsabilità.
- Stato di insolvenza: rappresenta la “morte finanziaria” dell’impresa . Giuridicamente, l’insolvenza è “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” . Ciò significa che l’azienda non paga più i debiti alle scadenze e tale incapacità non è passeggera. Non basta un singolo ritardo: l’insolvenza è valutata in modo complessivo e duraturo, come incapacità strutturale di fare fronte agli impegni. Ad esempio, non pagare stipendi, fornitori e rate bancarie per mancanza di liquidità, senza prospettive credibili di recupero a breve, indica insolvenza conclamata. La Cassazione la descrive come insufficienza patrimoniale e finanziaria tale che “gli elementi attivi del patrimonio non sono sufficienti ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori” . In pratica l’azienda ha più debiti che risorse liquidabili, e i creditori perdono fiducia nella sua capacità di adempiere regolarmente.
Tra crisi e insolvenza esistono anche stati intermedi, ad esempio la “illiquidità temporanea”: difficoltà a pagare nell’immediato per mancanza di denaro liquido, pur avendo patrimoni o crediti a medio termine. Un’illiquidità può essere ancora “sanabile” (es. vendendo un immobile si recupera cassa), mentre l’insolvenza è di regola irreversibile senza interventi esterni straordinari . È cruciale distinguere la crisi acuta (ma recuperabile) dall’insolvenza conclamata: le soluzioni giuridiche disponibili e gli obblighi dell’imprenditore cambiano a seconda del caso.
Segnali d’allarme di crisi che un imprenditore dovrebbe monitorare includono: perdite significative su bilancio, erosione del capitale proprio, indici finanziari come il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) inferiore a 1 (indice che segnala incapacità di generare cassa sufficiente a pagare i debiti finanziari) , flussi di cassa negativi, aumento anomalo dei debiti scaduti verso fornitori o fisco, tensioni di liquidità (conto in rosso, necessità continua di scoperti). Con il CCII, alcuni indicatori d’allerta dovevano essere introdotti (patrimoniali, redditività, ecc.), ma la procedura di “allerta esterna” tramite segnalazioni di creditori pubblici è stata ridimensionata nelle riforme. Oggi è lasciata soprattutto all’autovalutazione interna dell’impresa predisporre sistemi di controllo e allerta precoce. Se tali segnali vengono ignorati e si arriva all’insolvenza conclamata, l’intervento diviene drastico e spesso tardivo.
Conseguenze giuridiche dell’insolvenza: quando l’impresa diventa insolvente, si aprono scenari molto seri. Chiunque tra i creditori può chiedere al Tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale (il termine che ha sostituito il “fallimento”) . Il Tribunale, verificati i presupposti (stato d’insolvenza attuale e debiti scaduti per almeno €30.000 ), può dichiarare l’azienda insolvente e nominare un curatore fallimentare (liquidatore giudiziale). Da quel momento l’imprenditore perde la gestione: tutti i beni aziendali entrano nel patrimonio concorsuale vincolato ai creditori, gli amministratori perdono i poteri di amministrazione (sostituiti dal curatore, sotto controllo del giudice) , e l’attività in genere cessa o viene proseguita solo in via temporanea se utile per la liquidazione. Inoltre, l’insolvenza “cristallizza” i rapporti giuridici: scatta il concorso dei creditori sul patrimonio residuo e tutte le azioni esecutive individuali vengono bloccate (nessun creditore può più pignorare beni in via individuale, dovrà partecipare al passivo fallimentare). I contratti in corso possono sciogliersi o proseguire secondo le regole concorsuali; le linee di fido bancarie vengono revocate; l’azienda è segnalata nelle centrali rischi creditizie come default . In sintesi, la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) spossessa l’imprenditore dei beni aziendali e segna la fine dell’autonomia gestionale dell’impresa.
Oltre agli effetti civilistici, insolvenza e fallimento comportano possibili responsabilità per l’imprenditore: si pensi alle azioni di responsabilità civile verso gli amministratori per cattiva gestione e alle possibili conseguenze penali (es. reati di bancarotta, se vi sono distrazioni di beni o frodi). Approfondiremo tali aspetti più avanti; basti qui notare che attendere passivamente il fallimento è l’errore peggiore. La legge incoraggia invece ad agire durante la crisi, quando c’è ancora margine di risanamento . Infatti il CCII ha l’obiettivo primario di prevenire ed evitare l’insolvenza , mettendo a disposizione dell’imprenditore in crisi diversi strumenti di composizione negoziata e giudiziale per ristrutturare i debiti. Solo se questi falliscono si passa alla liquidazione.
Riassumendo:
- Crisi: difficoltà reversibili, obbligo di attivarsi (piani di risanamento interni, ricerca di nuove risorse, utilizzo degli strumenti di allerta/negoziazione) per evitare l’insolvenza.
- Insolvenza: incapacità conclamata di pagare i debiti. Se non si trova immediatamente una soluzione concordata con i creditori (es. concordato preventivo), si rischia l’inizio di una procedura concorsuale liquidatoria d’ufficio, con perdita del controllo dell’azienda.
- Illiquidità temporanea: caso intermedio (crisi di liquidità ma patrimonio solido) in cui l’azienda può salvarsi con misure tempestive (rifinanziamenti, vendita asset, ecc.) .
Esempio: La Gamma Srl (produttrice di piccoli UPS) ha visto calare il fatturato del 30% in due anni, accumulando perdite che riducono il capitale netto. Già emergono difficoltà a pagare fornitori entro i termini e l’IVA di periodo. Questo è uno stato di crisi: la direzione deve attivare un piano di risanamento (riduzione costi, rifinanziamento, dilazione debiti) prima che la cassa si esaurisca. Se nulla viene fatto e Gamma Srl inizia a saltare stipendi, rate di mutuo e altri pagamenti in modo generalizzato, e non ha più risorse liquide né accesso al credito, sarà considerata insolvente. A quel punto un creditore (es. la banca) o l’ufficio fiscale potrebbero presentare istanza di fallimento: il Tribunale verificherà la sussistenza dell’insolvenza e, se confermata, aprirà la liquidazione giudiziale, nominando un curatore che prenderà in mano Gamma Srl per liquidarne i beni a favore dei creditori. Gamma Srl perderebbe la continuità aziendale e l’imprenditore vedrebbe sfumare il valore costruito nell’azienda, subendo per giunta le restrizioni e potenziali azioni di responsabilità tipiche del fallimento.
Morale: appena compaiono i segnali di crisi, un imprenditore prudente deve informarsi sulle soluzioni disponibili e agire proattivamente. Vediamo ora le diverse tipologie di debito che un’azienda può avere, perché ciascuna presenta rischi specifici e può richiedere strumenti differenti di composizione.
Tipologie di debiti e relative criticità
Un’azienda indebitata raramente ha un solo tipo di debito: più spesso vi è un insieme di esposizioni verso diversi creditori. È utile distinguere le principali categorie di debiti perché ognuna segue regole proprie e comporta implicazioni diverse per il debitore. Vediamo i casi tipici: debiti fiscali, debiti bancari, debiti verso fornitori, debiti verso i dipendenti e debiti verso enti previdenziali. Evidenzieremo per ciascuno i rischi che corre l’azienda se non paga e le possibili soluzioni o trattamenti particolari nell’ambito di una ristrutturazione del debito.
Debiti fiscali (Erario)
I debiti tributari includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP), ritenute non pagate, cartelle esattoriali dell’Agenzia Entrate-Riscossione (AER, ex Equitalia) relative a imposte, interessi e sanzioni. Questi debiti sono particolarmente sensibili perché lo Stato dispone di poteri di riscossione coattiva privilegiati. Le criticità principali sono:
- Aggio di interessi e sanzioni: un debito fiscale tende a crescere nel tempo per via di interessi di mora e sanzioni. Rimandare il pagamento peggiora l’esposizione.
- Riscossione esattoriale: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere a fermo amministrativo di beni mobili registrati (es. automezzi), ipoteca su immobili e pignoramenti (su conti correnti, su crediti verso terzi, su beni mobili) senza dover passare per un giudice (le cartelle esattoriali sono già titoli esecutivi). Ad esempio, per imposte non pagate, dopo la notifica della cartella e trascorsi 60 giorni senza adempimento né richiesta di rateazione, AER può iscrivere ipoteca sui beni immobili dell’azienda o dell’imprenditore garante e avviare esecuzioni.
- Soglie per istanza di fallimento: L’Erario (tramite l’Avvocatura dello Stato) può chiedere la liquidazione giudiziale dell’impresa se il debito fiscale è rilevante. In passato vi era una soglia di circa €30.000 di debito IVA non pagato per legittimare l’istanza; oggi la soglia generale di €30.000 di debiti scaduti si applica a qualunque creditore . Dunque, un elevato debito fiscale insoluto può condurre il Fisco a provocare il fallimento dell’azienda.
- Privilegi sui crediti: molti crediti tributari (IVA, ritenute, tributi locali) hanno privilegio generale o speciale sui beni del debitore, il che significa che in caso di concorso vengono soddisfatti con priorità rispetto ai creditori chirografari (e in alcuni casi prima anche di altri privilegiati di grado inferiore). Ciò li rende interlocutori “forti” in qualsiasi trattativa di ristrutturazione: non possono essere trascurati.
- Profili penali: alcuni debiti fiscali derivano da omissioni che costituiscono reato. Ad esempio, omesso versamento di IVA oltre una certa soglia (attualmente €250.000 per periodo d’imposta) o omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 sono reati tributari. Anche l’emissione di fatture false o altri illeciti collegati possono emergere se l’azienda accumula debiti fiscali insoluti. Questo implica che l’imprenditore potrebbe avere conseguenze penali personali, indipendentemente dalle soluzioni concorsuali intraprese, se non regolarizza queste posizioni.
Come gestire i debiti fiscali? Fortunatamente esistono strumenti specifici:
- Rateizzazioni ordinarie: Prima di tutto, la legge consente di chiedere rateizzazioni delle cartelle esattoriali. Dal 2025, grazie al D.Lgs. 110/2024, le possibilità di dilazione sono state ampliate: per debiti fino a €120.000 si può ottenere una dilazione fino a 84 rate mensili (circa 7 anni) se la richiesta è fatta nel 2025-2026, 96 rate nel 2027-2028, e 108 rate dal 2029 in poi . In casi di comprovata temporanea difficoltà, AER può concedere anche 120 rate (10 anni) superando il precedente limite di 72 . Per importi oltre €120.000, è richiesto di dimostrare la situazione di crisi finanziaria (ad esempio con indici di liquidità per le imprese) per accedere al piano lungo . Chiedere una rateazione blocca le azioni esecutive: è fondamentale attivarsi prima che inizi un pignoramento o un fermo . Ad esempio, se l’azienda riceve una cartella per €100.000 di IVA e non può pagarla in unica soluzione, presentando un’istanza di rateazione entro 60 giorni eviterà che AER proceda con il recupero forzoso; iniziando a pagare le rate (minimo €100 ciascuna) mantiene il beneficio del termine e può proseguire l’attività pagando gradualmente il dovuto . Va notato che decadenza dalla rateazione (mancato pagamento di alcune rate) fa perdere questo scudo e a quel punto il debito residuo può essere riscosso immediatamente.
- Definizioni agevolate (rottamazioni): Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali, ossia procedure straordinarie di definizione agevolata dove si pagano le imposte dovute senza sanzioni e con interessi ridotti. Ad esempio, la “Rottamazione-quater” per i carichi 2000-2017 (aperta fino al 2023) consentiva di pagare solo l’imposta e una quota di interessi . In prospettiva, la Legge di Bilancio 2026 potrebbe introdurre una “Rottamazione-quinquies” . Se l’azienda rientra in uno di questi condoni, può ridurre in modo significativo l’esposizione fiscale. È bene tenersi informati sulle normative temporanee vigenti. Tuttavia, queste misure non sono garantite né strutturali: dipendono da scelte politico-legislative. Pertanto, non si può farvi affidamento come strategia certa di risanamento, ma rappresentano un’opportunità da cogliere quando disponibili.
- Transazione fiscale: Nell’ambito delle procedure concorsuali negoziate o giudiziali, esiste la possibilità di proporre al Fisco una transazione fiscale, ossia un accordo che prevede il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari (e contributivi). Questo strumento, inizialmente previsto solo nel concordato preventivo, è stato esteso e reso più flessibile. Oggi, grazie alle riforme attuate entro il 2024, il debitore può proporre un trattamento falcidiato dei crediti fiscali anche negli accordi di ristrutturazione e persino durante la composizione negoziata . Ad esempio, con il decreto correttivo 2024, durante le trattative di composizione negoziata si può sottoporre ad Agenzia delle Entrate e AER una proposta di accordo che stralcia una parte dei tributi dovuti o ne dilaziona il pagamento, allegando la relazione di un professionista che attesti la convenienza della proposta rispetto alla prospettiva liquidatoria . Se gli enti fiscali aderiscono, l’accordo viene depositato in Tribunale e omologato (senza possibilità di cram-down forzoso del dissenso in questa fase stragiudiziale) . Analogamente, nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione omologati, il piano può prevedere di pagare solo una percentuale dei debiti tributari: il tribunale può omologare il piano anche senza l’adesione formale del Fisco, a certe condizioni di legge (si veda oltre la parte sul cram-down fiscale) . La transazione fiscale richiede comunque che l’offerta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (cioè il Fisco deve ricevere almeno quanto otterrebbe in un fallimento dell’azienda) ed è soggetta a termini precisi per l’adesione degli enti. In pratica, tramite transazione fiscale si può ad esempio proporre: “Pagamento del 40% del debito IVA in 5 anni, stralcio totale di sanzioni e interessi”, se ciò dà allo Stato almeno l’equivalente del realizzo in caso di fallimento. Questo strumento è prezioso per ridurre l’onere fiscale e rendere sostenibile un piano di ristrutturazione complessivo.
In caso di debiti IVA, occorre ricordare che l’IVA è un tributo comunitario: non può essere falcidiata al di fuori di una procedura concorsuale omologata, pena violazione delle norme UE. Ma all’interno di concordati e accordi, anche l’IVA può essere parzialmente non pagata se il piano soddisfa i requisiti (ad es., in concordato liquidatorio il cram-down fiscale richiede che la proposta sia “conveniente” rispetto alla liquidazione; in continuità richiede non deteriore e che la classe Erario non sia l’unica consenziente ).
Attenzione: alcuni debiti fiscali non sono negoziabili nemmeno con transazione: ad esempio l’IVA e le ritenute si possono dilazionare o parzialmente stralciare, ma non possono essere esclusi del tutto; inoltre, i tributi costituenti “risorse proprie UE” (come dazi doganali) e i debiti per contributi previdenziali dei lavoratori devono essere trattati con cautele (in genere vanno almeno parzialmente soddisfatti). Le novità 2024 comunque hanno ampliato la possibilità di proporre dilazioni e stralci su contributi previdenziali anche nei piani di ristrutturazione .
Rischio penale: va distinto il piano di risanamento civile dalla posizione penale personale. Se l’imprenditore ha commesso reati tributari (es. non ha versato IVA di importi penalmente rilevanti), la pendenza del debito e persino la sua falcidia in concordato non estinguono il reato (a meno di pagare integralmente il dovuto prima del dibattimento, condizione talvolta prevista per estinguere il reato di omesso versamento). Quindi, la soluzione migliore è prevenire: usare strumenti come la rateazione per rientrare nei parametri ed evitare che il debito fiscale sfoci in un illecito. In un’ottica di risanamento, risolvere i debiti con il Fisco è prioritario sia per motivi legali sia etici, e spesso conviene destinare a questi creditori una quota significativa delle risorse disponibili nei piani di ristrutturazione.
Debiti bancari e finanziari
Questi debiti derivano da mutui, finanziamenti, scoperti di conto, leasing, anticipi su fatture, derivati o altre esposizioni verso banche e società finanziarie. Spesso rappresentano una fetta importante dell’indebitamento di un’azienda (soprattutto se l’impresa ha investito in macchinari o immobili con prestiti bancari, o se usa linee di credito per finanziare il circolante).
Caratteristiche e criticità dei debiti bancari:
- Presenza di garanzie: Molti debiti bancari sono assistiti da garanzie reali (es. ipoteche su immobili aziendali, pegno su macchinari o su magazzino, pegno su quote societarie) o personali (fideiussioni degli imprenditori o di terzi). Ciò significa che, in caso di insolvenza, la banca può rivalersi sul bene dato in garanzia (vendendolo) o sul patrimonio personale del garante. Ad esempio, se un mutuo è garantito da ipoteca sulla sede aziendale, la banca in difetto di pagamento potrà avviare un’esecuzione immobiliare per espropriare e vendere l’immobile ipotecato; oppure, se i soci hanno firmato una fideiussione “omnibus”, la banca potrà chiedere a loro il pagamento integrale del debito residuo, escutendo i loro beni personali.
- Clausole di decadenza/recesso: I contratti bancari prevedono tipicamente clausole di decadenza dal beneficio del termine o di covenant finanziari. Se l’azienda ritarda un pagamento o viola un indice finanziario pattuito, la banca può dichiarare scaduto tutto il debito (c.d. “accelerazione”): ad esempio, basta saltare una rata di mutuo perché la banca, se non si trova un accordo, possa chiedere l’intero importo residuo e attivare la garanzia. Inoltre molte linee di credito sono a revoca o con revisione periodica: all’emergere di segnali di crisi (bilanci in perdita, segnalazioni negative in Centrale Rischi), la banca può ridurre o revocare gli affidamenti, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria dell’impresa.
- Centrale dei Rischi: Il sistema bancario segnala alla Centrale dei Rischi (gestita da Banca d’Italia) gli insoluti e le posizioni deteriorate (inadempienze probabili, sofferenze). Se l’azienda entra in default verso una banca (ad es. oltre 90 giorni di arretrato rilevante su un’esposizione), tutte le banche lo vengono a sapere e spesso reagiscono riducendo esposizioni e pretendendo rientri. Questo effetto domino può portare rapidamente al prosciugamento del credito disponibile per l’impresa.
- Possibili azioni giudiziali rapide: Le banche dispongono di titoli esecutivi (un contratto di mutuo bancario costituisce già titolo per provare l’esistenza del credito, così come un estratto notarile di conto corrente) e possono ottenere decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi in tempi brevi. Ciò significa che, se non si paga, una banca può arrivare al pignoramento di beni (mobili, immobili, crediti presso terzi) in pochi mesi. Inoltre, se vi sono garanzie reali, la banca può attivare la procedura esecutiva sul bene ipotecato/pegno senza bisogno di passare per una causa ordinaria (es. procedura espropriativa immobiliare, vendita di beni mobili pignorati o escussione del pegno con vendita privata se previsto).
- Crediti prededucibili o privilegiati in caso di procedure: Se l’impresa accede a una procedura concorsuale, i crediti bancari chirografari concorreranno con gli altri crediti chirografari, subendo eventuali falcidie. Tuttavia, i crediti bancari garantiti da ipoteca o pegno vengono riconosciuti come privilegiati fino a capienza del valore del pegno/ipoteca (sono crediti privilegiati speciali sui beni dati in garanzia). Dunque la banca può essere soddisfatta in via prioritaria con il ricavato di vendita di quei beni (dopo aver pagato eventuali creditori con garanzie di grado anteriore sullo stesso bene). Ciò influenza le trattative: una banca garantita potrebbe in teoria recuperare di più andando all’esecuzione forzata del bene che accettando un concordato che offre un pagamento parziale. Per questo, nei piani di ristrutturazione spesso alle banche garantite va riconosciuto almeno il valore di realizzo della garanzia.
- Debiti verso società di leasing: sono assimilabili ai debiti bancari. In caso di insolvenza, la società di leasing può risolvere il contratto e recuperare il bene concesso in leasing (ad esempio un macchinario) e poi domandare il pagamento delle rate scadute e del valore residuo. In una procedura concorsuale, i leasing spesso rientrano tra i creditori privilegiati (per i canoni scaduti e il bene come garanzia). Anche questi dovranno essere considerati attentamente in un piano.
Come gestire e ristrutturare i debiti bancari? Alcune strategie e strumenti:
- Moratorie e rinegoziazioni private: In presenza di crisi temporanea, le banche (specialmente se supportate dal quadro normativo, come in occasione di moratorie settoriali o emergenziali) possono concedere moratorie (sospensioni) dei pagamenti per qualche mese, o allungare le scadenze dei mutui (c.d. “rischedulazione”). Ad esempio, l’azienda può negoziare con la banca di congelare il rimborso del capitale per 6-12 mesi, pagando solo interessi, oppure di estendere la durata del finanziamento (riducendo l’importo delle rate). Questo tipo di accordo va cercato prima che la posizione diventi sofferenza conclamata: se l’impresa ha un rapporto di fiducia con la banca e prospetta un piano credibile di rilancio, la banca potrebbe preferire rinegoziare anziché escutere immediatamente le garanzie. In assenza di un quadro concorsuale formale, queste moratorie sono contrattuali e richiedono il consenso della banca; spesso è utile presentare piani di cash flow per convincere la banca che la moratoria aumenterà le chance di recupero integrale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis CCII: Questo strumento (ora disciplinato nel CCII, ex art. 57 e seguenti) è particolarmente adatto per debiti finanziari. Se l’impresa ha la maggior parte del debito verso banche, può mirare a un accordo con almeno il 60% dei creditori (per valore) per ristrutturare i debiti, con omologa del tribunale che rende l’accordo vincolante e protegge da azioni esecutive (lo approfondiremo nella sezione successiva). Un accordo di ristrutturazione consente, ad esempio, di prevedere: “la Banca X rinuncia al 20% del credito e diluisce il resto su 5 anni, la Banca Y converte metà credito in partecipazione al capitale, ecc.”. Se si raggiunge la maggioranza prescritta e l’accordo è equo per i creditori estranei (che vanno normalmente pagati integralmente), il tribunale può omologarlo, impedendo ai dissenzienti di agire individualmente. Questo strumento è spesso usato nei “piani di ristrutturazione del debito bancario” di medio-grandi imprese, a volte con l’assistenza di advisor finanziari, specie dopo la Direttiva UE 2019/1023 che spinge per soluzioni negoziali.
- Garanzie statali o consorziali: In alcuni casi, i crediti bancari sono assistiti da garanzie pubbliche (es. Fondo di Garanzia PMI o SACE). Se l’azienda non paga e il prestito era garantito, la banca può escutere la garanzia statale: ciò non elimina il debito ma lo trasferisce in parte all’ente garante (lo Stato paga la banca fino all’% garantita e poi subentra come creditore verso l’azienda). Nei piani di risanamento, bisogna considerare anche questi attori (lo Stato diventa creditore subentrato). A volte si può negoziare con l’ente garante una ristrutturazione del credito subentrato, o sfruttare normative che facilitano la chiusura della posizione se l’azienda soddisfa certi requisiti.
- Concordato preventivo: In un concordato, l’azienda può imporre una ristrutturazione anche alle banche dissenzienti, suddividendole in classi secondo posizione e garanzie. Ad esempio, può creare una classe di “banche chirografarie” proponendo di pagare il 30% in 2 anni, e una classe di “banche ipotecarie” proponendo di pagare il 100% (fino a concorrenza del valore di stima degli immobili) in 5 anni. Se le classi approvano a maggioranza, il concordato viene omologato e vincola tutte le banche, impedendo azioni esecutive individuali e prevalendo sulle eventuali clausole contrattuali di risoluzione. Questo è uno dei vantaggi del concordato: poter superare l’ostacolo di una singola banca non cooperativa, purché il piano offra a tutti i creditori almeno quanto avrebbero in un fallimento. Nel concordato in continuità, inoltre, si possono mantenere le linee di credito essenziali (magari con l’accordo delle banche) e pagare i debiti finanziari secondo il piano attestato.
- Stralcio per cessione del credito: A volte, se la situazione è molto compromessa, le banche cedono il credito a società specializzate (fondi) che acquistano i crediti a forte sconto. L’azienda debitore potrebbe valutare, con l’aiuto di consulenti, di riscattare il proprio debito finanziario acquistandolo sul mercato (per tramite di terzi) a prezzo scontato, oppure di trattare con il nuovo creditore un saldo e stralcio. Questa è un’operazione complessa e va valutata caso per caso, ma talvolta i crediti bancari vengono venduti a frazioni del valore nominale, il che apre margini per accordi transattivi.
- Nuova finanza: Le banche esistenti potrebbero, in certi casi, fornire nuova finanza all’impresa in crisi, ad esempio convertendo parte del debito in un finanziamento aggiuntivo con garanzie migliori o con prededucibilità (in concordato). La legge consente di prevedere che i finanziamenti iniettati per attuare un piano di salvataggio siano prededucibili in caso di successivo fallimento (artt. 99-101 CCII), purché autorizzati dal tribunale o attestati come funzionali al piano. Questa garanzia ai nuovi finanziatori è pensata per incoraggiare banche o soci a mettere soldi freschi nell’azienda, sapendo che, se il piano fallisce, quei finanziamenti verranno rimborsati con precedenza su altri debiti . Dal lato pratico, convincere una banca ad aggiungere esposizione su un’azienda già in crisi è difficile; più frequente è l’intervento di nuovi investitori o soci. Tuttavia, nei casi in cui la banca creda nel risanamento, potrebbe concordare di erogare liquidità aggiuntiva (es. per pagare fornitori strategici o salari), rendendola prededucibile. Questa è una leva negoziale possibile nel concordato o negli accordi omologati.
In sintesi, i debiti bancari richiedono un approccio equilibrato: da un lato, serve coinvolgere le banche nel processo di risanamento (spesso dalle loro decisioni dipende la sopravvivenza dell’impresa, specie se l’azienda ha necessità di continuo credito per lavorare); dall’altro, bisogna usare la leva delle procedure concorsuali per proteggersi da iniziative aggressive di singole banche e, se necessario, imporre un accordo nell’interesse collettivo di tutti i creditori. La fiducia va mantenuta con trasparenza: fornire piani industriali realistici e perizie sul valore delle garanzie è essenziale nelle trattative con istituti di credito.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
Questi debiti (detti spesso “debiti commerciali”) derivano da merci o servizi acquistati e non ancora pagati. Tipicamente sono chirografari (senza garanzie), salvo eventuali patti di riserva di proprietà su beni mobili forniti (in tal caso il fornitore ha una garanzia reale sul bene venduto fino al completo pagamento). Le caratteristiche di questi debiti:
- Numero elevato e importi variabili: Un’azienda può avere decine o centinaia di fornitori creditori, spesso PMI a loro volta. L’importo per singolo creditore può essere piccolo (es. poche migliaia di euro per materiali di consumo) o grande (es. un fornitore strategico di componenti potrebbe vantare centinaia di migliaia di euro). Ciò rende complessa la gestione: molti soggetti da coordinare, e ognuno potrebbe reagire in modo diverso ai ritardi di pagamento.
- Interesse a preservare i rapporti: I fornitori, a differenza delle banche, hanno spesso un interesse a mantenere in vita il rapporto commerciale (soprattutto se l’azienda è cliente importante). Pertanto, possono essere più disponibili a concordare piani di rientro informali (pagamenti dilazionati) o sconti in cambio della continuità degli ordinativi futuri. D’altro canto, se la fiducia viene meno, possono interrompere le forniture, mettendo in difficoltà operativa l’azienda.
- Azioni legali individuali: Un fornitore impagato può rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo (titolo esecutivo) e poi procedere al pignoramento di beni o crediti dell’azienda. Molti fornitori tuttavia esitano ad agire subito legalmente, specie se sperano di recuperare il cliente; spesso i primi creditori a fare causa sono quelli che hanno capito di non avere più nulla da guadagnare continuando il rapporto. Tuttavia, una volta che uno o più fornitori ottengono un pignoramento (ad esempio bloccano il conto corrente aziendale), l’effetto a catena può precipitare la crisi. Da notare che i fornitori, non avendo garanzie, concorrono in posizione debole rispetto ad altri creditori (banca, Erario, ecc.); perciò in caso di insolvenza vedono concreto il rischio di non recuperare nulla, il che li spinge, se perdono la pazienza, a tentare le vie legali per “prendere qualcosa finché c’è”. Questo spiega perché a volte i fornitori si precipitano a pignorare beni appena avvertono odore di fallimento (temendo la par condicio concorsuale che li penalizzerebbe).
- Possibilità di iniziative estreme: Un gruppo di fornitori può anche presentare istanza di fallimento contro l’azienda debitrice (se il credito di uno di essi supera €30.000, o se si uniscono più creditori per raggiungere la soglia). Nella prassi, spesso è un singolo fornitore rilevante e esasperato a farlo. L’istanza di fallimento può essere usata anche come leva: talvolta il creditore minaccia il fallimento per costringere l’azienda a pagare (sapendo che l’imprenditore teme la procedura concorsuale). Questa è una situazione delicata: se l’azienda ha speranza di recupero, deve assolutamente evitare il fallimento, perciò dovrà rispondere prontamente (magari offrendo un accordo, o reagendo presentando essa stessa un ricorso di concordato preventivo per bloccare la dichiarazione di fallimento – lo vedremo più avanti).
Gestione dei debiti fornitori:
- Comunicazione e dilazioni private: Il primo passo è parlare coi fornitori. Nascondersi o non dare spiegazioni peggiora la fiducia. L’imprenditore in difficoltà dovrebbe spiegare la situazione e proporre un piano di rientro credibile (es: “Vi pagherò il 50% del dovuto entro 60 giorni, il restante in 4 rate mensili, e intanto continuerò ad ordinare da voi”). Molti fornitori preferiranno un accordo di questo tipo piuttosto che perdere il cliente e avviare un contenzioso costoso e incerto. È importante essere trasparenti e, se possibile, dare qualche garanzia: ad esempio, emissione di cambiali per formalizzare il debito dilazionato, oppure coinvolgere un consorzio fidi o un’assicurazione crediti. Bisogna però evitare promesse irrealistiche: meglio offrire meno ma pagare puntualmente quelle scadenze, per ricostruire fiducia.
- Fornitori strategici: Identificare quali sono critici per la continuità produttiva. Questi fornitori (es. l’unico fornitore di una componente essenziale per gli UPS) vanno trattati con priorità. Spesso, nelle procedure come il concordato in continuità, è previsto che i fornitori essenziali vengano pagati regolarmente per assicurare la prosecuzione dell’attività (magari con autorizzazione del tribunale a pagare crediti anteriori di fornitori strategici, in deroga alla par condicio, in quanto funzionali alla continuazione dell’impresa). Anche fuori da procedure formali, l’imprenditore potrebbe scegliere di soddisfare integralmente alcuni fornitori chiave (rischiando però possibili azioni revocatorie successivamente, qualora l’atto sia considerato preferenziale). Su questo tema, va ricordato che pagare alcuni creditori e non altri a ridosso dell’insolvenza può esporre al rischio di revocatoria fallimentare, a meno che rientri in esenzioni (es. pagamenti effettuati nell’ambito di un piano attestato regolarmente pubblicato sono esenti da revocatoria ). In situazioni di crisi profonda, la parità di trattamento dei creditori è un principio da non violare arbitrariamente. È comprensibile voler salvare i partner strategici, ma l’imprenditore deve valutare con il legale se e come fare pagamenti selettivi.
- Procedure di composizione: Se il numero di fornitori è ampio e i debiti grandi, la soluzione privata può diventare ingestibile: non si può ottenere il consenso di tutti e basta un fornitore ostile per rovinare l’accordo. In questi casi, ricorrere a una procedura concorsuale può essere efficace, perché consente di imporre legalmente un certo trattamento a tutti i chirografari. Ad esempio, in un concordato preventivo, i fornitori chirografari verranno raggruppati in una o più classi e chiamati a votare la proposta (che potrebbe prevedere un pagamento parziale, es. 30%, a saldo e stralcio). Se la maggioranza (per crediti) in ciascuna classe approva, la minoranza dissenziente è comunque vincolata dall’omologazione. Questo permette di superare il problema del “free rider” (il fornitore che rifiuta l’accordo sperando di essere pagato per intero). Naturalmente, la proposta concordataria deve essere ragionevole e vantaggiosa per i fornitori rispetto alla prospettiva del fallimento: se si offre troppo poco, rischia di non passare o di non essere omologata (c’è un requisito di soddisfazione minima del 20% per i chirografari nel concordato liquidatorio e comunque il piano deve superare il test di convenienza rispetto alla liquidazione).
- Saldo e stralcio individuali: In alcuni casi si può proporre ai fornitori un saldo a stralcio individuale (fuori da procedure): ad esempio “ti pago subito il 50% e chiudiamo ogni pretesa”. Ciò può riuscire con creditori disposti a incassare qualcosa immediatamente rinunciando al resto. Conviene ottenere da ciascun fornitore una quietanza indicante la natura transattiva (in modo che non possa poi pretendere il saldo). Tali accordi vanno gestiti con attenzione: se poi c’è fallimento entro 6 mesi, quei pagamenti stralcio potrebbero anch’essi essere revocati come preferenziali (perché comunque pagano un creditore in misura maggiore di quanto avrebbe preso in concorso, anche se in forma transattiva). Una difesa è farli rientrare in un piano attestato pubblicato, che li rende non revocabili .
- Forniture future: Per convincere i fornitori a supportare il risanamento, l’azienda può offrire condizioni migliorative sulle commesse future (es. pagamento anticipato all’ordine per i nuovi acquisti, oppure contratti di fornitura che garantiscano volumi futuri se il fornitore accetta la dilazione sul pregresso). In tal modo, il fornitore vede un vantaggio nel continuare il rapporto: recupera il pregresso col tempo e mantiene un cliente.
- Azioni legali difensive: Se un fornitore ha avviato un decreto ingiuntivo, l’azienda può valutare con l’avvocato se ci sono motivi formali o sostanziali per opporsi (es. contestazioni sulla merce, vizi, ecc.) al fine di prendere tempo. Anche proporre un piano di concordato preventivo dopo che un creditore ha depositato istanza di fallimento può bloccare la pronuncia di fallimento: per legge il concordato prevale e l’istanza di fallimento viene sospesa nell’attesa del piano . Questo scenario è frequente: l’azienda minacciata di fallimento da un creditore deposita in tribunale un ricorso di concordato (“in bianco” o con piano) per neutralizzare l’azione del singolo e poi gestire la situazione in sede concorsuale. Ne riparleremo.
In sintesi, i debiti verso fornitori richiedono sensibilità relazionale e strategie diversificate: dialogo e piccoli accordi bilaterali finché possibile; se la situazione degenera, passare a soluzioni collettive (concordato, accordi di ristrutturazione) per evitare che le azioni disordinate dei singoli affossino definitivamente l’azienda.
Debiti verso dipendenti
I debiti verso il personale includono retribuzioni non corrisposte, trattamenti di fine rapporto (TFR) maturati, rimborsi spese e ogni competenza contrattuale dovuta ai lavoratori. Sono debiti delicati per diversi motivi:
- Tutela privilegiata: I crediti dei lavoratori per stipendi, ferie non godute, TFR, ecc., sono protetti dalla legge con privilegi. In caso di procedura concorsuale, hanno un privilegio generale sui mobili dell’azienda, entro certi limiti (es. le retribuzioni degli ultimi 2 anni e il TFR per l’importo di legge) che li fa soddisfare prima dei crediti chirografari . Inoltre, una parte dei crediti salariali (ultimi 3 mesi) gode di un super-privilegio che li pone al vertice delle graduatorie, addirittura prima di alcune garanzie reali. Quindi in un fallimento i dipendenti di norma recuperano almeno in parte i loro crediti privilegiati, e possono accedere al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità.
- Fondo di garanzia INPS: In caso di insolvenza conclamata (fallimento o anche concordato liquidatorio), interviene l’INPS Fondo di garanzia che paga ai lavoratori il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione non pagate, nei limiti di legge, surrogandosi poi nelle loro ragioni di credito verso l’azienda. Questo è un importante paracadute per i lavoratori, ma si attiva solo se c’è un’apertura di procedura concorsuale o un accertamento giudiziale dell’insolvenza (nel concordato preventivo in continuità di solito non interviene perché l’impresa continua).
- Conseguenze sociali e legali: Il mancato pagamento di stipendi ha effetti immediati e dirompenti: i lavoratori possono scioperare o interrompere la prestazione, il che spesso ferma l’attività aziendale. Inoltre, i dipendenti possono dimettersi per giusta causa (mancato pagamento stipendio ≥ una mensilità in genere lo giustifica) chiedendo la disoccupazione NASpI. Giuridicamente, il lavoratore impagato può ottenere decreti ingiuntivi molto rapidamente (i crediti da lavoro sono di solito documentati e incontestabili) e aggredire i conti aziendali. Non ultimo, è reato (contravvenzione) omettere il versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti: se l’azienda trattiene in busta paga i contributi ma non li versa all’INPS oltre una soglia modesta, l’amministratore commette reato. Dunque l’inadempimento verso i dipendenti espone anche a responsabilità penali (omesso versamento contributi) oltre che civili.
- Importanza morale e d’immagine: Un’impresa che non paga i suoi dipendenti subisce un danno reputazionale forte. Inoltre, per l’imprenditore spesso i dipendenti sono persone di fiducia, e il peso morale di questi debiti è alto. Per questo, in molti concordati, i crediti dei dipendenti vengono pagati integralmente (almeno per la parte privilegiata) e magari subito. Anche la legge in materia di concordato imponeva già in passato che i crediti di lavoro con privilegio venissero soddisfatti per intero (ora nel CCII non v’è un obbligo assoluto se il patrimonio è incapiente, ma resta il fatto che non pagarli significherebbe che il piano non è conveniente rispetto al fallimento, visto che in fallimento li pagherebbe il Fondo di garanzia).
- Strumenti come la cassa integrazione: Se l’azienda è in crisi ma vuole proseguire, può accedere agli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS) per temporaneamente non pagare parte degli stipendi (che sono coperti in parte dall’INPS) riducendo l’attività. Ad esempio, attivare una Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi permette di sospendere o ridurre l’orario di lavoro con i lavoratori che ricevono un’indennità dall’INPS. Questo riduce il costo del personale durante la ristrutturazione e tutela in parte i lavoratori. Tuttavia servono requisiti e l’accordo sindacale.
Gestione dei debiti verso dipendenti:
- Priorità di pagamento: Una regola fondamentale è che, per quanto possibile, gli stipendi vanno pagati. Tra pagare un fornitore e pagare i dipendenti, la priorità andrebbe data ai secondi, sia per ragioni legali (contributi, reati) sia per mantenere operativa l’azienda. Se le risorse sono insufficienti, si può provare a scaglionare: ad esempio, pagare subito una parte delle retribuzioni (magari quelle più basse o un acconto a tutti) e concordare con i dipendenti un calendario per il saldo del resto. La comunicazione qui è cruciale: spiegare la situazione e possibilmente coinvolgere le rappresentanze sindacali in un accordo aziendale per gestire l’emergenza (es. posticipare il pagamento di premi o ferie convertendoli in permessi, ecc.).
- Concordati e procedure: Nel caso si acceda a una procedura concorsuale, il trattamento dei dipendenti è generalmente di favore. In un concordato preventivo, i crediti per stipendi e TFR maturati prima del deposito della domanda concorsuale rientrano nel passivo privilegiato. Di solito, il piano di concordato prevede di pagarli integralmente (almeno la parte privilegiata) magari appena omologato il concordato (spesso i giudici chiedono che il piano non pregiudichi i lavoratori rispetto a come starebbero nel fallimento, dove come detto interverrebbe il Fondo INPS). In un concordato in continuità, può essere necessario pagare subito gli stipendi arretrati per poter continuare l’attività con i lavoratori motivati (e anche perché il personale altrimenti potrebbe non collaborare, mettendo a rischio la continuità stessa). La legge consente, in pendenza di domanda di concordato, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare i crediti di lavoro anteriori, in deroga al divieto di pagamenti anteriori, se ciò è funzionale alla continuazione aziendale. Ad esempio, il Tribunale può autorizzare l’azienda in concordato “in bianco” a pagare le mensilità arretrate ai dipendenti, riconoscendone la funzionalità.
- Interventi del Fondo di Garanzia: Se l’azienda prevede che non riuscirà a pagare TFR e ultime mensilità e sta andando verso la liquidazione, può essere interesse degli stessi lavoratori che venga aperta una procedura concorsuale, così attivano l’INPS. Ad esempio, in un fallimento i lavoratori presentano domanda al Fondo di Garanzia e nel giro di qualche mese ricevono dall’INPS il TFR (fino al massimale) e le retribuzioni non pagate degli ultimi 3 mesi di lavoro . Pertanto, paradossalmente, i dipendenti talvolta spingono affinché, se la nave affonda, affondi “ufficialmente” così loro possono incassare dal Fondo. Un imprenditore responsabile, se vede inevitabile la fine, dovrebbe considerare questo aspetto e magari procedere a un concordato liquidatorio o a un’autofallimento, perché lo scenario peggiore per i lavoratori è un’azienda che chiude di fatto senza una procedura formale (in tal caso i lavoratori dovrebbero inseguire l’azienda per vie legali senza garanzia di risultato né accesso al Fondo).
- Riduzione del personale: Come parte del risanamento, può rendersi necessario ridurre i costi del personale, quindi licenziamenti o almeno una cassa integrazione temporanea. Va fatto nel rispetto delle norme (procedure collettive se >5 dipendenti, criteri di scelta, ecc.). Un licenziamento collettivo in costanza di procedura concorsuale segue regole semplificate con autorizzazione del Tribunale. L’uso della Cassa Integrazione Straordinaria per crisi è spesso preferibile per evitare esodi immediati: consente di guadagnare tempo (fino a 12-24 mesi di CIGS) durante il quale l’azienda prova a risollevarsi alleggerita del costo. Nel frattempo i lavoratori percepiscono un’indennità (seppur ridotta) e restano formalmente dipendenti, sperando nella ripresa.
- Relazioni sindacali: È bene coinvolgere eventuali sindacati aziendali o territoriali, specialmente in imprese medio-grandi, per concordare soluzioni (come contratti di solidarietà, temporanea riduzione degli orari, ecc.). Se i dipendenti percepiscono buona fede e sforzi condivisi, potrebbero accettare sacrifici temporanei (come una dilazione del pagamento del premio di risultato) per aiutare l’azienda a riprendersi, specie se intravedono un futuro.
In breve, i debiti verso i dipendenti hanno priorità morale e legale: vanno trattati con la massima serietà. Nelle procedure di ristrutturazione, questi crediti di norma non possono essere falcidiati (se non per la parte eventualmente non privilegiata, rara) e devono essere soddisfatti almeno in misura equivalente a quella garantita dal Fondo di Garanzia INPS, altrimenti la proposta difficilmente supererebbe il vaglio di convenienza del giudice o il voto dei dipendenti (che in un concordato hanno diritto di voto per la parte del loro credito non coperta da privilegio, se c’è). Mantenere il personale coeso durante una crisi d’impresa è spesso decisivo per riuscire nel rilancio.
Debiti verso enti previdenziali e assicurativi
Si tratta soprattutto di contributi INPS (contributi previdenziali dovuti per i dipendenti o per gli stessi soci lavoratori, contributi IVS artigiani/commercianti, gestione separata ecc.) e premi INAIL (assicurazione infortuni), nonché eventuali casse professionali se l’azienda ha professionisti associati. Questi debiti condividono alcune caratteristiche con i debiti fiscali:
- L’INPS e l’INAIL, tramite l’Agenzia Entrate-Riscossione, possono iscrivere a ruolo i contributi non versati ed emettere cartelle esattoriali. Dunque il recupero avviene con strumenti simili a quelli fiscali (fermi, ipoteche, pignoramenti).
- I contributi previdenziali hanno privilegio generale sui beni mobili dell’azienda (sono privilegiati come i tributi, anzi hanno un rango molto alto, insieme ai tributi erariali).
- Sanzioni civili elevate: L’INPS applica sanzioni per omesso versamento contributi che sono percentualmente pesanti (anche oltre il 8-9% annuo come interessi di mora, più sanzioni aggiuntive); questo fa crescere velocemente il debito se non viene regolarizzato o dilazionato.
- Responsabilità personali: Esistono ipotesi di responsabilità degli amministratori se i contributi non vengono versati. Ad esempio, l’art. 2392 c.c. (per gli amministratori di S.p.A.) e analoghe per S.r.l. prevedono responsabilità per inadempimenti anche verso terzi: l’INPS talvolta, in caso di fallimento della società, tenta di escutere gli amministratori per il mancato versamento dei contributi dei dipendenti, soprattutto quando c’è stata mala gestio. Inoltre, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 2 D.Lgs. 8/2016) scatta se non si versano entro il termine le ritenute per un importo annuo superiore a €10.000: l’amministratore rischia una sanzione penale (anche se depenalizzato come reato, comporta sanzioni amministrative elevate).
- Transazione contributiva: Analogamente ai tributi, anche i contributi possono essere oggetto di transazione nei piani di concordato o negli accordi, con parziale pagamento. Le novità del 2024 esplicitamente consentono di proporre nei piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO) e nei concordati di gruppo una trattazione unitaria dei crediti contributivi, e hanno esteso le regole della transazione fiscale anche ai contributi previdenziali . Ciò significa che in un concordato o accordo oggi si può proporre all’INPS ad esempio di pagare solo il 50% dei contributi dovuti, dilazionandoli, se ciò è almeno pari a quanto l’INPS recupererebbe in caso di fallimento. Va però ricordato che l’INPS, al pari del Fisco, non può subire un cram-down forzoso al di fuori delle condizioni di legge: serve o la sua adesione o che ricorrano i requisiti (minimo pagamento 50-60% e certe maggioranze) previsti per l’omologazione forzata dei piani senza consenso degli enti pubblici .
Gestione dei debiti previdenziali:
- Rateizzazioni: Anche per contributi INPS si possono ottenere rateazioni amministrative (in genere fino a 24 rate mensili, estensibili a 36-60 in casi speciali, salvo diverse disposizioni recenti). L’INPS può dilazionare i debiti contributivi dietro richiesta motivata dell’azienda, il che sospende le azioni esecutive. Spesso tali piani richiedono il rispetto puntuale delle rate e il versamento corrente regolare.
- Regolarità contributiva (DURC): Un tema importante per chi lavora con la P.A. o in certi settori è il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Se l’azienda non è in regola coi contributi, non ottiene il DURC e ciò può bloccare pagamenti da clienti pubblici o la partecipazione a gare. Durante una crisi, può essere essenziale ottenere un DURC regolare: attivare una rateazione con INPS e pagarne le prime rate consente di avere DURC positivo (in quanto viene considerato regolare chi ha un piano di rientro in corso). Questo è un incentivo a non trascurare i debiti contributivi: la regolarizzazione, anche rateale, è spesso necessaria per continuare ad operare (es. in edilizia, un’impresa senza DURC non può lavorare negli appalti).
- Concordati: Nel concordato, l’INPS è trattato come creditore privilegiato. Se il piano non prevede il pagamento integrale dei suoi crediti, occorrerà la sua adesione o rispettare i parametri per il cram-down. Di solito, se l’azienda prosegue, l’INPS viene pagato su lungo termine ma integralmente sul dovuto privilegiato (magari con stralcio di sanzioni).
- Rischio di escussione personale: Da segnalare che in linea di principio i contributi non versati dalla società non ricadono direttamente sugli amministratori o sui soci (a differenza dei professionisti, dove ad es. i soci di una s.n.c. rispondono anche di questi). Tuttavia, se la società viene meno, l’INPS per recuperare a volte attiva azioni di responsabilità verso gli amministratori in fallimento, sostenendo che la scelta di non pagare i contributi è stata negligente e ha causato danno ai creditori (all’INPS stesso). Non sempre riescono, ma è un rischio. Inoltre, come detto, le ritenute previdenziali non versate sono penalmente rilevanti: l’amministratore può difendersi dalla sanzione penale solo dimostrando che non aveva le risorse per pagare (causa di forza maggiore), ma se in quel periodo l’azienda ha pagato altri creditori e non l’INPS, difficilmente potrà evitare la condanna.
Come regola generale, i debiti verso gli enti previdenziali vanno considerati insieme a quelli fiscali: rientrano nella categoria di crediti pubblici privilegiati che in un piano di risanamento non possono essere ignorati. Bisognerà prevedere una soluzione, che sia la rateazione amministrativa (se si opera in bonis) o la transazione contributiva nel concordato/accordo.
Conclusione sezione debiti: Abbiamo visto come ciascun tipo di debito ponga sfide specifiche. Una tabella riepilogativa può aiutare:
Tabella 1: Tipologie di debiti, rischi e strumenti di tutela
| Tipo di debito | Rischi per l’azienda (se insolvente) | Strumenti per difendersi o ristrutturare |
|---|---|---|
| Fiscali (Erario) | – Cartelle esattoriali, pignoramenti rapidi (no giudice) <br> – Sanzioni e interessi in aumento <br> – Istanza di fallimento da Fisco (≥ €30k) <br> – Reati tributari (IVA, ritenute) | – Rateazione ordinaria (fino a 10 anni dal 2025) <br> – Definizioni agevolate (rottamazione) se previste <br> – Transazione fiscale in concordato/accordo (stralcio/dilazione) <br> – Concordato preventivo con cram-down fiscale (condizionato) |
| Bancari/Finanziari | – Revoca fidi, richieste rientro immediato (decadenza dal termine) <br> – Escussione garanzie reali (esecuzioni su immobili/beni) <br> – Escussione garanzie personali (fideiussioni soci) <br> – Segnalazione a Centrale Rischi (blocco nuovo credito) | – Moratorie private (sospensione rate, allungamento piani) <br> – Rinegoziazione con banche (riduzione tassi, conversione debito in capitale) <br> – Accordo di ristrutturazione ex 182-bis (coinvolge % banche) <br> – Concordato preventivo (classi banche, cramming delle dissenzienti) <br> – Nuova finanza prededucibile (per supportare piano) |
| Fornitori (chirograf.) | – Azioni legali individuali (decreti ingiuntivi, pignoramenti di beni e crediti) <br> – Interruzione forniture essenziali (blocco produzione) <br> – Possibile istanza di fallimento (se crediti rilevanti) | – Negoziazione individuale (piani di rientro, acconti, saldo stralcio) <br> – Accordi di standstill (moratoria concordata tra più fornitori) <br> – Pagamento fornitori critici (attento a revocatoria) <br> – Concordato preventivo (imposizione di % di pagamento uguale per tutti, con voto a maggioranza) <br> – Composizione negoziata (ricerca accordi assistita da esperto) |
| Dipendenti | – Azioni legali (ingiunzioni, pignoramenti, anche su c/c aziendali) <br> – Dimissioni di massa, scioperi (paralisi attività) <br> – Reati per omessi versamenti contributi <br> – Intervento del Fondo INPS in caso di fallimento (azienda perde controllo su gestione personale) | – Pagamento prioritario stipendi correnti (anche autorizzato in concordato) <br> – Accordi con sindacati (dilazioni temporanee, riduzione orario, cassa integrazione) <br> – Concordato: soddisfacimento integrale crediti privilegiati lavoro (per favore legge e per evitare opposizioni) <br> – Uso ammortizzatori sociali (CIGS) per ridurre costo lavoro durante la crisi <br> – Eventuale concordato/liquidazione per attivare Fondo di Garanzia (se salvataggio impossibile) |
| Enti previdenziali | – Cartelle esattoriali come Fisco (riscossione coattiva) <br> – Aggio di sanzioni civili (costo in aumento) <br> – Irregolarità DURC (blocco lavori/appalti) <br> – Responsabilità penale (omessi contributi > €10k/anno) | – Rateazione debiti INPS (conserva DURC regolare se rispettata) <br> – Transazione contributiva (stralcio/dilazione contributi in concordato/accordo) <br> – Concordato preventivo (pagamento quota contributi con eventuale cram-down se INPS dissente, alle condizioni di legge) <br> – Monitoraggio costante DURC ed eventuale regolarizzazione lampo per evitare blocchi |
(Legenda: “cram-down” = omologazione forzata nonostante dissenso del creditore; “prededucibile” = con diritto di precedenza nel pagamento in caso di procedura concorsuale)
La tabella sopra evidenzia come ogni categoria di credito abbia le proprie leve e come la strategia di difesa del debitore debba modularsi in base ad esse. In genere, i debiti pubblici (fisco, contributi) e quelli verso i lavoratori sono quelli con tutela più forte e con meno margine di sconto (vanno pagati per quanto possibile, salvo remissioni parziali in procedure); i debiti finanziari necessitano di accordi strutturati con soggetti istituzionali (banche) e possono beneficiare di procedure formali; i debiti commerciali richiedono un fine equilibrio tra trattativa umana e ricorso a strumenti concorsuali per evitare iniziative disordinate.
Dopo aver analizzato i tipi di debito, passiamo allo stato dell’azienda e alle opzioni strategiche a seconda che l’impresa sia ancora attiva o già in fase pre-fallimentare.
Stato dell’azienda: operatività, insolvenza o pre-fallimento
Una domanda cruciale per decidere “cosa fare” è: l’azienda è ancora operativa e salvabile o è ormai insolvente e destinata alla liquidazione?. In base a ciò, il debitore potrà scegliere strumenti di risanamento oppure prepararsi a una uscita ordinata attraverso procedure liquidatorie.
Vediamo le diverse situazioni:
Azienda in difficoltà ma ancora operativa (pre-insolvenza)
In questo scenario, l’impresa è in crisi ma non totalmente insolvente: ad esempio paga ancora parte dei debiti, continua la produzione/vendita, ha clienti e ordini, ma fatica a onorare puntualmente tutte le obbligazioni. Potrebbe essere in tensione di liquidità senza aver accumulato troppi arretrati, oppure avere un indebitamento elevato ma con prospettiva di rientro se riorganizzata.
Cosa fare se l’azienda è in crisi ma viva:
- Autodiagnosi e piano interno: L’imprenditore deve fare, preferibilmente con l’aiuto di professionisti (commercialista, consulente aziendale), un’analisi realistica di flussi finanziari, carico di debiti e prospettive di mercato. Questo serve a capire se la crisi è temporanea o strutturale. Ad esempio, se l’azienda UPS ha un picco di debiti perché ha investito in molte scorte che venderà nei prossimi mesi, può essere sufficiente un intervento di liquidità ponte; se invece perde soldi su ogni prodotto venduto (margini negativi), la crisi è strutturale e occorre ripensare il modello di business. Secondo il CCII, l’impresa deve dotarsi di strumenti di allerta interni per cogliere questi segnali. Uno strumento comune è preparare un piano di risanamento interno con budget e business plan a 6-12 mesi per vedere di quanta cassa ha bisogno l’impresa e come reperirla. Questa fase è cruciale per scegliere la strada migliore.
- Evitare l’aggravamento della situazione: In crisi non insolvente, c’è margine di manovra. L’obiettivo è evitare di scivolare nell’insolvenza conclamata. Ciò significa:
- Non contrarre nuovi debiti se non strettamente necessari e comunque solo se funzionali al risanamento (es. evitare di accumulare arretrati fiscali “per pagare i fornitori”: il rimedio peggiorerebbe la malattia).
- Bloccare le perdite: tagliare costi non essenziali, mettere in conservazione l’azienda (niente spese extra, dismettere rami o beni improduttivi per fare cassa).
- Valutare nuove risorse: coinvolgere soci (versamenti o finanziamenti soci), cercare investitori o partners, vendere asset non strategici. Ogni euro raccolto in questa fase può allontanare l’insolvenza.
- Mantenere i ricavi: spesso in crisi la tentazione è ridurre i costi, ma bisogna stare attenti a non compromettere la capacità di generare fatturato. Ad esempio, non tagliare il budget commerciale a zero, se no le vendite crollano ulteriormente. Va trovata una linea di sopravvivenza che permetta all’azienda di continuare ad incassare quel minimo per restare a galla.
- Strumenti di composizione negoziata: Se la crisi non si risolve in poche mosse interne, conviene utilizzare gli strumenti maggiormente “pre-insolvenza” che l’ordinamento offre. Un istituto chiave introdotto di recente è la Composizione Negoziata della Crisi. Dal 2021, l’imprenditore può autonomamente accedere a una piattaforma nazionale e chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a negoziare con i creditori . Questo strumento (detto anche CNC) è confidenziale e su base volontaria: non è una procedura concorsuale pubblica, ma coinvolge un esperto terzo (spesso un commercialista esperto di ristrutturazioni) che analizza la situazione dell’impresa e convoca i creditori chiave per trovare un accordo. Durante la composizione negoziata, l’impresa può chiedere al Tribunale misure protettive (ad es. uno stay delle azioni esecutive per la durata delle trattative, normalmente 4 mesi prorogabili) . Questo consente di avere un “periodo di respiro” senza pignoramenti, per lavorare alla soluzione. La composizione negoziata è indicata quando l’impresa ha possibilità di risanamento ma ha bisogno di tempo e di un mediatore per convincere i creditori. I dati 2024 mostrano che sta iniziando a funzionare: molte PMI l’hanno usata per evitare il fallimento e alcune ne sono uscite risanate . Nel contesto di un’azienda UPS, l’esperto nominato potrebbe aiutare a stilare un piano con banche e fornitori chiave, magari concordando nuove scadenze e tagli su interessi. Se l’accordo riesce (ad esempio, banche che prorogano i mutui, fornitori che accettano il 70% a saldo, Fisco che concede transazione su cartelle), il risultato può essere formalizzato e depositato in tribunale per una sorta di presa d’atto. Se invece non si trova una soluzione, l’imprenditore potrà comunque ripiegare su altre procedure formali (concordato) o persino accedere a un particolare Concordato semplificato di liquidazione (introdotto nel 2021) per chi esce senza esito dalla negoziazione – ne parleremo più avanti. Importante: la mera richiesta di nomina dell’esperto non blocca di per sé i creditori ; occorre ottenere le misure protettive dal giudice e queste non sono automatiche, vanno motivate e il giudice verifica che servano a favorire le trattative, altrimenti i creditori possono ancora spingere per il fallimento (esiste già giurisprudenza: Trib. Modena 2022 ha chiarito che la sola istanza di composizione non ferma il procedimento di fallimento se l’imprenditore non ottiene un provvedimento protettivo) . Pertanto, chi intraprende la CNC deve essere rapido nel chiedere e ottenere lo stay.
- Piano attestato di risanamento: Altro strumento pre-insolvenza è il Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 CCII. È un piano che l’imprenditore predispone unilateralmente, con misure per riequilibrare la situazione finanziaria, e lo fa attestare da un professionista indipendente che ne certifica la fattibilità . Quindi, presenta tale piano ai creditori per trovare accordi individuali coerenti col piano. Se il piano viene eseguito regolarmente, l’impresa esce dalla crisi senza coinvolgere il tribunale. Il vantaggio principale è la riservatezza (non si attiva una procedura pubblica) e la flessibilità (non ci sono soglie di adesione obbligatorie: basta convincere abbastanza creditori chiave da rendere sostenibile la posizione finanziaria). Inoltre, il piano attestato se pubblicato nel registro imprese offre protezioni legali: gli atti compiuti in esecuzione di esso non sono soggetti a revocatoria fallimentare e alcune fattispecie di bancarotta possono essere escluse (ad esempio, pagare un creditore pregresso in esecuzione del piano non è “preferenza fraudolenta” se il piano era idoneo). Tuttavia, il piano attestato non impone il blocco delle azioni dei creditori: è stragiudiziale al 100%, quindi se alcuni creditori non collaborano possono comunque agire per il recupero. Di conseguenza, il piano attestato funziona bene quando l’azienda ha un numero relativamente limitato di creditori consenzienti (es. solo banche, o pochi fornitori principali) e vuole evitare la pubblicità di un concordato. Per un’azienda di media dimensione con molti creditori piccoli, il rischio è che mentre l’imprenditore tratta con alcuni, altri facciano azioni legali; in quel caso spesso al piano attestato si affiancano accordi di moratoria (standstill) con la platea larga di creditori. Un esempio: Alfa Srl (produttrice di UPS) elabora un piano attestato che prevede di cedere un capannone inutilizzato per fare cassa, ottenere nuova finanza dai soci e ristrutturare i debiti bancari con proroga di 3 anni; un esperto giurato attesta che il piano è realistico e sufficiente a risanare la società . Alfa presenta il piano alle banche e ai fornitori maggiori: la maggior parte aderisce (banche allungano i mutui, fornitori accettano di essere pagati al 60% entro 6 mesi dopo la vendita del capannone). Alfa deposita la relazione attestatrice e il piano all’ufficio del registro imprese, ottenendo così l’esenzione da revocatoria sugli atti compiuti secondo piano (vendita capannone, pagamenti ai fornitori) . In 12 mesi Alfa Srl esegue il piano e torna in equilibrio. Questo caso ideale mostra l’efficacia del piano attestato in crisi reversibili. Se però il piano fallisce perché l’azienda era troppo ottimista o perché qualche creditore importante si sfila, bisogna essere consapevoli che un piano attestato non blocca, di per sé, un eventuale successivo fallimento. Tuttavia, giurisprudenza costante (Cass. 13719/2016) afferma che per togliere l’esenzione da revocatoria agli atti fatti in esecuzione del piano, il curatore deve dimostrare che il piano era manifestamente inidoneo fin dall’origine . Ciò per prevenire abusi: non si può usare il piano attestato come “schermo” per fare pagamenti preferenziali sapendo che l’azienda è spacciata . Dunque, se l’impresa è ancora operativa e con chance, il piano attestato è utile; se è già insolvente grave, meglio non usarlo come foglia di fico, perché potrebbe non proteggere certi atti e l’attestatore stesso rischia responsabilità per asseverazioni azzardate .
- Accordi standstill ad hoc: In aggiunta o alternativa a strumenti formali, una società in pre-insolvenza può tentare di ottenere dai principali creditori un accordo di moratoria temporanea (standstill). Tipicamente, se ci sono più banche finanziatrici, si può convocare un tavolo e sottoscrivere un accordo in cui tutte le banche si impegnano a non revocare fidi e non escutere garanzie per X mesi, mentre l’azienda fa certe azioni (vendite asset, presentazione piano, ecc.). Questo è spesso il preludio alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione 182-bis o di un concordato preventivo “in continuità indiretta” (vendita di azienda). Anche con i fornitori si può tentare un accordo collettivo: ad esempio, far firmare a tutti quelli sopra un certo importo un accordo quadro dove accettano un pagamento parziale dilazionato e si impegnano a non agire legalmente nel frattempo. È più difficile con molti soggetti, ma settorialmente (es. un pool di fornitori dietro associazione di categoria) può riuscire.
In sostanza, nella fase di crisi pre-insolvenza, l’imprenditore ha in mano opzioni “morbide” da preferire: negoziazione assistita (CNC), piani attestati, accordi stragiudiziali. L’obiettivo è evitare di entrare in insolvenza conclamata e ripristinare la normalità aziendale con accordi volontari. Oltre a questi, c’è anche l’opzione di un concordato preventivo “in continuità” presentato tempestivamente, anche se l’azienda non è completamente insolvente: nulla vieta di avviare un concordato prima che la cassa sia a zero, come strumento proattivo di ristrutturazione con protezione del tribunale. Tuttavia, in pratica, molti preferiscono provarci su base negoziale finché possibile, perché il concordato è più costoso, pubblico e complesso. Nella prossima sezione vedremo nel dettaglio come funziona il concordato, ma prima esaminiamo il caso opposto: quando l’impresa è già insolvente o sull’orlo del fallimento (“stato di pre-fallimento”) e deve difendersi in extremis.
Azienda in insolvenza o “pre-fallimento”
Qui parliamo di un’azienda che non riesce più a operare regolarmente: non paga fornitori né stipendi, i creditori hanno perso la pazienza, magari c’è già un’istanza di fallimento pendente in tribunale o pignoramenti multipli in atto. È la situazione più critica, dove le opzioni di salvataggio si assottigliano. Il “pre-fallimento” non è un termine giuridico ma rende l’idea di un’impresa che, pur non essendo ancora formalmente fallita, è di fatto già collassata finanziariamente.
Cosa fare se l’azienda è insolvente:
- Non nascondere la testa sotto la sabbia: Se l’insolvenza è conclamata, l’imprenditore ha poco tempo e deve fare scelte rapide. Continuare l’attività in modo caotico, senza pagare nessuno, può aggravare la posizione e integrare condotte di “prosecuzione illegittima dell’attività”. La legge e la giurisprudenza sono chiare: l’amministratore che aggrava il dissesto continuando a contrarre debiti quando non c’è ragionevole prospettiva di recuperarli rischia responsabilità verso i creditori . Ad esempio, il Tribunale di Milano ha condannato gli amministratori per prosecuzione illegittima dell’attività oltre lo stato di insolvenza, ritenendoli responsabili dei nuovi debiti creati in quel periodo . Quindi, appena si prende atto che l’impresa non può più essere risanata come tale, occorre limitare i danni: non fare altri debiti a vuoto e passare in modalità conservativa.
- Valutare se c’è qualche progetto di risanamento attuabile: Anche in insolvenza, potrebbe esistere un’ultima chance di evitare la liquidazione: ad esempio, un investitore esterno interessato a rilevare l’azienda (o i suoi asset) e ripianare i debiti (in tutto o in parte), oppure la possibilità di un concordato in continuità se l’impresa ha ordini e mercato ma solo un grave problema di debiti pregressi. Se c’è un barlume di continuità da salvare, il debitore insolvente può provare un “colpo di reni” tramite gli strumenti concorsuali:
- Un concordato preventivo con continuità aziendale: presentando rapidamente un piano (o almeno un ricorso “con riserva” per bloccare i creditori e poi costruendo il piano entro 120 giorni). Questo concordato punterà a ristrutturare i debiti magari cedendo parte dei beni ma mantenendo il core business in vita. Bisogna avere un attivo e flussi prospettici sufficienti a offrire ai creditori una soddisfazione migliore di quella fallimentare. Ad esempio, l’imprenditore insolvente potrebbe aver negoziato in background la vendita di un ramo d’azienda a un investitore, il cui corrispettivo finanzierà un concordato: la continuità in questo caso è indiretta (l’azienda prosegue in mano al terzo). La legge incentiva la continuità ove possibile, quindi questo tipo di concordato è preferibile al puro liquidatorio se offre esiti simili per i creditori. Cassazione 2025, n.348 ha anche chiarito quando si può parlare di concordato in continuità: se la prosecuzione riguarda una parte significativa dell’azienda e ne conserva l’identità; se invece l’attività viene completamente snaturata o ridotta a brandelli, non è vera continuità . Questa distinzione è importante perché il concordato in continuità gode di alcune flessibilità (es. può prevedere di pagare i creditori privilegiati in modo dilazionato durante la prosecuzione).
- Un accordo di ristrutturazione ex 182-bis: anche se l’impresa è insolvente, può proporre un accordo ai creditori principali (spesso banche) per evitare il fallimento. Ci vuole l’adesione del 60% dei crediti, quindi se c’è la regia di uno o due grossi creditori (es. banche che hanno interesse a non liquidare subito l’azienda per recuperare di più nel tempo), un accordo omologato può tirarla fuori dal fallimento. Va allegata una relazione attestante la fattibilità e conviene richiedere al tribunale di emanare misure protettive (simili a quelle del concordato) per bloccare esecuzioni mentre si formalizza l’accordo.
- La composizione negoziata in fase avanzata: teoricamente si potrebbe ancora tentare la CNC anche se insolventi, ma l’esperto se vede che l’insolvenza è conclamata e non reversibile consiglierà di andare in concorsuale. La CNC è più concepita per la crisi incipiente; in insolvenza conclamata spesso i creditori non hanno tempo/voglia di negoziare senza garanzie forti.
Se nessuna di queste strade appare concretamente percorribile (ad esempio, nessun investitore, attività non più redditizia, patrimonio insufficiente per concordato), si passa alla gestione “liquidatoria” pura.
- Proteggersi dalle iniziative dei creditori nell’immediato: Nello stato di pre-fallimento, l’azienda spesso affronta azioni esecutive multiple e magari l’udienza su un’istanza di fallimento già fissata. In tale situazione, il ricorso al Tribunale è d’obbligo per guadagnare tempo e ordine:
- La mossa tipica è presentare un ricorso per concordato preventivo “con riserva” (detto anche concordato in bianco). Questo consiste nel depositare la domanda di concordato senza allegare subito il piano dettagliato, ma riservandosi di presentarlo entro un termine (fino a 120 giorni) . Il tribunale, alla presentazione di un ricorso in bianco che rispetti i requisiti minimi di legge, dichiara l’azienda ammessa alla procedura e di conseguenza viene inibita qualsiasi azione esecutiva individuale da parte dei creditori (scatta automaticamente la sospensione dei pignoramenti in corso e il divieto di avviarne di nuovi, per l’effetto protettivo del concordato). Inoltre, un concordato presentato prevale sull’istanza di fallimento: quest’ultima viene sospesa in attesa di vedere se il concordato va a buon fine . Ciò è molto importante: consente all’imprenditore di sventare il fallimento last-minute, a patto che poi in quei 2-4 mesi riesca a mettere insieme un piano serio. Naturalmente, il tribunale valuta la buona fede: se appare un trucco solo dilatorio senza prospettiva di piano, può anche dichiarare inammissibile il concordato (oggi i giudici sono un po’ più severi rispetto al passato su queste domande “last second”).
- Oltre al concordato, anche un accordo di ristrutturazione (se c’è base per presentarlo rapidamente con firme di creditori) consente di chiedere al giudice misure protettive analoghe. Ma di solito, un’azienda ormai insolvente e con creditori litigiosi non ha il tempo di raccogliere il 60% di consensi prima di essere travolta, quindi la via concordataria è più agile per bloccare subito tutto.
- Un esempio classico: Beta Srl è insolvente, un fornitore ha chiesto il fallimento e c’è udienza tra 10 giorni; Beta trova un potenziale acquirente interessato a rilevare l’attività senza debiti. Beta allora il giorno prima dell’udienza di fallimento deposita un ricorso di concordato con riserva, dichiarando che ha in corso trattative per la cessione dell’azienda nel contesto di un concordato (con continuità indiretta). Questo deposito di per sé sospende la procedura fallimentare (il tribunale rinvia l’udienza fallimentare e assegna a Beta un termine per presentare il piano definitivo) . In quei mesi Beta formalizza un accordo di cessione d’azienda a Gamma Spa, presenta il piano di concordato che prevede di pagare i creditori con i soldi ricavati dalla cessione, e ottiene l’omologa evitando il fallimento. Questa strategia, perfettamente legittima, realizza il famoso “privilegio del concordato preventivo” nel nostro ordinamento: l’imprenditore, se attiva uno strumento di regolazione, ha priorità nel tentare la via negoziale rispetto alla volontà dei singoli creditori di farlo fallire.
- Liquidazione volontaria e fallimento pilotato: Se l’insolvenza è irreversibile e non ci sono piani di salvataggio credibili, la scelta più corretta potrebbe essere quella di non opporsi alla liquidazione e anzi anticiparla volontariamente in modo ordinato. Ci sono due vie:
- Mettere la società in liquidazione volontaria ex art.2484 c.c. (per le società di capitali) se ancora non ci sono istanze di fallimento. Il liquidatore cercherà di vendere i beni e pagare i creditori. Tuttavia, se l’insolvenza è grave, i creditori potrebbero comunque chiedere il fallimento perché la liquidazione “privata” non li tutela dalla par condicio alterata. Infatti, la legge prevede che se durante la liquidazione volontaria emerge l’insolvenza, il liquidatore deve chiedere la liquidazione giudiziale (è un obbligo).
- Presentare ricorso per liquidazione giudiziale (autofallimento). Può sembrare controintuitivo che l’imprenditore chieda il proprio fallimento, ma ha senso quando si vuole evitare accuse di aggravamento e fare iniziare subito il conteggio per la esdebitazione (la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura del fallimento, concessa all’imprenditore persona fisica onesto). Avviando presto la procedura, i creditori vengono trattati in sede concorsuale tutti paritariamente e l’imprenditore dimostra collaborazione (questo può pesare poi positivamente ad esempio in eventuali richieste di esdebitazione o in evitare inabilitazioni). Inoltre, consente ai dipendenti di attivare subito il Fondo di Garanzia INPS, come detto. Dunque, in certi casi l’autofallimento è responsabilità e trasparenza: si consegna l’azienda al tribunale per liquidarla secondo legge. Un “fallimento pilotato” può anche evitare indagini penali pesanti se fatto con ordine: l’imprenditore consegna libri contabili in regola, il curatore vede che non ci sono atti distrattivi, e l’aspetto criminale si riduce (potrebbero configurarsi solo reati di bancarotta semplice per aver aggravato la crisi, ma la condotta collaborativa attenua il giudizio).
- Salvaguardia degli asset personali e familiari: Nel momento pre-fallimentare, il debitore deve anche pensare alle proprie garanzie personali. Se in passato ha dato ipoteche su beni personali o fideiussioni, probabilmente le banche e i creditori garanti li escuteranno non appena vedranno la società fallire. Ad esempio, se la società va in liquidazione e lascia un debito in banca, la banca chiederà ai fideiussori (soci o amministratori) di pagare. A quel punto, se l’importo è insostenibile per la persona fisica, quest’ultima rischia il proprio dissesto. C’è la possibilità di accedere, per le persone fisiche non fallibili, alle procedure di sovraindebitamento (oggi chiamato “concordato minore” o “liquidazione controllata del sovraindebitato” nel CCII) per gestire i debiti personali, compresi quelli da garanzie. Esempio: Tizio, amministratore di Alfa Srl, aveva garantito con fideiussione €200.000 di debiti bancari di Alfa. Alfa fallisce, la banca ottiene l’importo dal garante Tizio. Tizio non può pagare e quindi potrebbe avviare una liquidazione controllata del suo patrimonio come consumatore (se non è imprenditore in proprio) per chiudere i debiti personali facendo liquidare i beni personali (salve le eventuali esenzioni come la casa di abitazione se non di lusso, che di regola non è pignorabile dall’Agente fiscale se prima casa – ma dalle banche invece sì). Oppure, se Tizio ha un reddito, potrebbe tentare un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti personale con i suoi creditori, magari offrendo il pagamento parziale di quel debito bancario. Questo per dire che l’imprenditore insolvente deve considerare due livelli: la società e sé stesso. Le due insolvenze sono distinte legalmente, ma nella pratica connesse (soprattutto se c’erano garanzie personali). Si approfondirà oltre nella parte sulle garanzie personali.
Riassumendo il punto di vista del debitore insolvente: se c’è ancora un barlume di continuità, usare rapidamente il concordato preventivo o accordi omologati per provare un ultimo salvataggio e per congelare le azioni esecutive (il catenaccio finale per evitare il gol del fallimento immediato); se non c’è più nulla da fare, procedere verso una liquidazione regolata (concordato liquidatorio o fallimento) possibilmente in modo ordinato e concordato, anziché subire passivamente l’iniziativa caotica dei creditori. In entrambe le ipotesi, trasparenza e legalità nelle scelte finali aiutano: mantenere le scritture in ordine, non prelevare indebitamente risorse residue (sarebbe bancarotta fraudolenta), non favorire occultamente qualche creditore a scapito di altri (bancarotta preferenziale) se non nei limiti di piani consentiti. Un debitore che gestisce correttamente anche la fase terminale può spesso evitare o ridurre le proprie responsabilità successive e magari godere dell’esdebitazione, voltando pagina.
Nei capitoli seguenti, affronteremo in modo sistematico gli strumenti giuridici di risanamento citati finora (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata), fornendo i dettagli operativi, i requisiti e le ultime novità legislative. Successivamente vedremo come il debitore può tutelarsi concretamente dalle azioni esecutive durante il percorso scelto e quali sono le responsabilità patrimoniali e personali dell’imprenditore (inclusa la questione delle garanzie personali). Infine, proporremo casi pratici e una sezione Domande & Risposte per chiarire gli ultimi dubbi.
Strumenti di risanamento del debito (soluzioni concorsuali e negoziali)
Il diritto italiano, specialmente con il Codice della Crisi (CCII) entrato in vigore nel 2022 e corretto nel 2024, offre una gamma di strumenti per affrontare formalmente situazioni di crisi o insolvenza. Questi strumenti – talora chiamati “procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” – vanno dal piano attestato di risanamento (strumento privatistico) ai concordati preventivi giudiziali, passando per gli accordi di ristrutturazione e le nuove figure come i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO) e il concordato semplificato. Abbiamo anche la citata composizione negoziata, che è un ibrido stragiudiziale-assistito. Ciascuno ha presupposti, vantaggi e limiti diversi. Di seguito li esamineremo singolarmente, ricordando sempre che la scelta dipende dallo stato dell’impresa e dal consenso che il debitore ritiene di poter ottenere dai creditori. Nel farlo, integreremo le ultime novità normative al ottobre 2025, frutto anche del terzo correttivo (D.Lgs. 13/09/2024 n.136) che ha modificato varie disposizioni del CCII .
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Cos’è: Il piano attestato di risanamento (PAR) è un piano di risanamento aziendale predisposto dall’imprenditore in difficoltà (in stato di crisi o anche di insolvenza reversibile) e asseverato da un professionista indipendente, finalizzato a ristrutturare l’indebitamento e a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa . Non è una procedura concorsuale giudiziaria, ma uno strumento contrattuale e privato: si basa sugli accordi che l’impresa riesce a stringere con i creditori secondo il piano, senza intervento attivo del tribunale . Il piano può riguardare diverse operazioni di risanamento (dilazioni di pagamento, nuove linee di credito, aumento di capitale, dismissione di asset per pagare debiti, transazioni a saldo e stralcio con creditori, etc.), purché nel suo complesso sia idoneo a risanare l’impresa.
Normativa di riferimento: L’istituto affonda le radici nell’art. 67, comma 3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare, che dal 2005 esentava da revocatoria gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato. Il CCII lo disciplina all’art. 56, intitolato “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”. La scelta del legislatore è stata di mantenere la natura flessibile e privatistica del piano attestato, ponendo solo alcuni paletti essenziali : – Il piano deve perseguire il risanamento dell’impresa (non può essere un mero strumento liquidatorio occulto). – Deve contenere un contenuto informativo minimo: l’indicazione dei creditori coinvolti, delle operazioni previste, degli apporti di risorse se necessari, etc. – Deve essere accompagnato da una relazione di attestazione redatta da un professionista terzo (requisiti di indipendenza simili a quelli dell’attestatore di concordato) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . – Può essere pubblicato (depositato) presso il registro delle imprese, a discrezione del debitore (la pubblicazione non è obbligatoria, ma è condizione per alcuni effetti protettivi). – Gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato, se questo è stato pubblicato, sono esenti da azione revocatoria (art. 56 co.3 CCII richiamato da art. 166 e 167 CCII) . Quindi, se poi l’azienda fallisce, il curatore non potrà revocare, ad esempio, i pagamenti fatti secondo il piano attestato, a condizione che il piano fosse idoneo e gli atti esplicitamente indicati in esso. – L’esenzione dalla revocatoria nel CCII è stata ampliata: copre non solo la revocatoria fallimentare ma anche quella ordinaria ex art. 2901 c.c. , per evitare che i creditori tentino vie alternative.
Vantaggi: – Riservatezza e rapidità: Non c’è apertura di procedura pubblica né intervento del tribunale (se non, eventualmente, in sede di omologare specifici accordi transattivi con erario o simili, ma questo è un aspetto marginale). Il piano attestato può restare confidenziale (a meno che si decida di pubblicarlo per la revocatoria) e l’azienda evita la pubblicità negativa di un concorso. Si possono coinvolgere solo i creditori strettamente necessari. – Flessibilità assoluta: Non servono maggioranze legali, non ci sono classi o vincoli di par condicio (salvo poi considerare i rischi di revocatoria se non pubblicato). Il debitore può pagare alcuni creditori e ottenere sconti da altri, come meglio crede, purché arrivi a un equilibrio. – Protezione da revocatoria e bancarotta preferenziale: Se il piano è serio, gli atti esecutivi sono protetti. La Cassazione ha precisato che il giudice fallimentare, per negare la protezione, deve accertare una “manifesta inettitudine” del piano a risanare , altrimenti anche pagamenti di crediti anteriori rientranti nel piano non costituiscono reato di bancarotta preferenziale né sono revocabili . Ciò offre un incentivo forte ai creditori ad aderire: sanno che se l’azienda poi fallisse, i soldi ricevuti nel piano non verranno chiesti indietro se il piano era fatto seriamente. (NB: Dal 2016 Cassazione richiede anche che gli atti da proteggere siano specificamente indicati nel piano e nella attestazione, non vale generico riferimento.) – Nessun coinvolgimento di creditori dissenzienti: Chi non partecipa, in teoria rimane con i suoi diritti intatti. Questo può essere un vantaggio se l’impresa ha molti piccoli creditori gestibili separatamente, e consente ad esempio di escludere dal piano creditori contestati o controversi (che si potranno pagare o far decidere a posteriori). Attenzione però: i creditori estranei non subiscono effetto dal piano, quindi potrebbero agire per conto loro (il piano non li congela).
Svantaggi e limiti: – Nessun automatic stay: Il piano attestato non ferma le azioni esecutive. Se un creditore non è d’accordo, può attaccare l’azienda anche durante la predisposizione o esecuzione del piano. Il debitore può solo provare a convincerlo a non farlo. Non c’è il potere del tribunale di imporre uno standstill come nel concordato/accordo. Questo è il limite maggiore in situazioni tese. – Rischio di insuccesso senza appigli: Se il piano fallisce, non c’è una procedura “di riserva”. Ad esempio, se durante l’esecuzione del piano i flussi non vanno come previsto e salta un pagamento, siamo punto a capo: ciascun creditore può reagire e presumibilmente si aprirà il fallimento, senza alternative se non tentare un concordato dell’ultimo minuto. In pratica, il piano attestato non offre una soluzione definitiva se le cose vanno male, mentre un concordato omologato almeno porta a esdebitazione residua se concluso. – Attestazione impegnativa: Trovare un professionista disposto ad attestare la fattibilità di un piano di risanamento serio può essere complicato. L’attestatore deve essere indipendente e si assume responsabilità civili (verso creditori e debitore) e anche possibili responsabilità penali se omette informazioni o rilascia false attestazioni . Cassazione penale 36401/2023 ha ribadito l’obbligo di diligenza e completezza dell’attestatore, sanzionando chi nasconde dati rilevanti . Quindi il professionista farà verifiche approfondite. Questo comporta tempi e costi (la redazione del piano e la attestazione possono richiedere varie settimane e parcelle non trascurabili, benché minori che in un concordato). – Necessità di ampio consenso di fatto: Anche se non serve una maggioranza formale, in concreto se solo pochi creditori aderissero, il piano non risana nulla. Serve quindi che la gran parte dei crediti rilevanti sia ristrutturata secondo il piano, altrimenti l’azienda rimane insolvente. Il che in taluni casi rende il piano attestato simile, come sforzo di negoziazione, a un accordo ex 182-bis (ma senza l’obbligo formale del 60%). Se però ci si avvicina a quella soglia, spesso è più utile lo strumento ex 182-bis con omologa, che dà il beneficio dell’imposizione ai dissenzienti minori. – Ambito applicativo: Il piano attestato è idoneo se c’è un percorso di recupero credibilità per l’impresa. Ad esempio, un’azienda con squilibrio finanziario ma buon modello di business, cui serve solo riscadenzare debiti e avere nuova finanza: lì il piano attestato può funzionare. Se invece l’azienda è in coma irreversibile, difficilmente un piano attestato (che presuppone accordi privati) sortirà effetti, perché i creditori non avranno fiducia.
Novità 2024: Il correttivo 2024 non ha modificato la sostanza dell’art. 56, ma il contesto è cambiato in quanto nel CCII sono comparsi strumenti nuovi, come i “piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO)”. In pratica il legislatore ha voluto offrire un’alternativa ibrida tra piano attestato e concordato: un piano che se approvato da tutte le classi di creditori può essere omologato dal tribunale con procedura snella . Il PRO consente di non rispettare rigidamente le cause di prelazione (come un accordo libero) però serve consenso integrale per classi . In un certo senso, un PRO riuscito è una formalizzazione giudiziale di un piano negoziato con tutti. Il suo vantaggio sul piano attestato è che, una volta omologato, vincola anche eventuali creditori non aderenti (se hanno ricevuto l’offerta in classe) e produce effetti esdebitativi come un concordato, oltre a proteggere da aggressioni durante il procedimento. Il PRO però richiede l’unanimità per classi, quindi basta un 10% di dissenso in una classe e salta. È un istituto nuovo introdotto col recepimento della Direttiva UE e potrebbe essere usato quando tutti i creditori organizzati trovano un accordo e vogliono metterlo in sicurezza legalmente.
Esempio pratico di piano attestato:
Supponiamo Delta Srl, azienda che commercializza UPS, ha €5 milioni di debiti: €2 mln con banche (ipotecari), €1 mln con fornitori, €0,5 mln fiscali e €1,5 mln con una società di leasing per macchinari. Delta è in crisi ma ha ancora mercato. Prepara un piano in cui: – vende una proprietà immobiliare non strategica ricavando €1 mln; – usa quel ricavato per pagare l’intero debito fiscale (€0,5 mln) e €0,5 mln ai fornitori (offrendo loro il 50% a saldo); – chiede alle banche di non escutere ipoteche e di allungare le scadenze dei mutui, magari riducendo i tassi (in cambio Delta continua a pagare regolarmente interessi e rate ridotte); – restituisce i macchinari in leasing alla società di leasing, la quale rinuncia a ulteriori pretese (perché i macchinari valgono quanto residuo leasing, diciamo), oppure concorda un nuovo piano per le rate pendenti con garanzia aggiuntiva; – i soci di Delta immettono €0,5 mln di nuova finanza per liquidità futura; – con il taglio dei fornitori e la riduzione rata mutui, Delta torna ad avere un cash flow operativo sufficiente a sostenersi.
Un professionista analizza i conti di Delta, verifica che vendendo l’immobile e con il contributo soci Delta può effettivamente fare quei pagamenti, e che con l’alleggerimento del debito la società tornerebbe solvibile. Attesta quindi che i dati sono veritieri e il piano è “realisticamente idoneo” a ristrutturare il debito e riequilibrare Delta . Delta negozia e ottiene adesioni: i fornitori maggiori (che rappresentano l’80% del credito commerciale) accettano il 50% subito; le banche (dopo aver letto la relazione) accettano di allungare mutui di 3 anni rinviando il rimborso capitale; l’INPS e Fisco vengono pagati integralmente appena venduto l’immobile (quindi a loro va bene, non c’è transazione ma pagamento integrale). Delta deposita il piano e la relazione attestata al Registro Imprese per dare data certa. Da quel momento inizia l’esecuzione: vende l’immobile, paga Fisco e fornitori come da accordi (questi atti essendo indicati nel piano e funzionali al risanamento sono protetti ex art. 56 e 167 CCII ), il bilancio successivo evidenzia una forte riduzione del debito e Delta prosegue l’attività su basi più solide. Se poi due anni dopo Delta malauguratamente fallisse, i pagamenti fatti ai fornitori nel piano (50%) non sarebbero revocabili perché il piano era ragionevole e attestato. Se invece il piano fosse stato un bluff (es. Delta sapeva di non incassare abbastanza e il piano era campato in aria), allora quei fornitori avrebbero potuto subire la revocatoria dei loro incassi, poiché il piano sarebbe giudicato manifestamente inidoneo e quindi inefficace ai fini esonerativi .
Conclusione sul piano attestato: È uno strumento di soluzione concordata e discreta della crisi, adatto per PMI o aziende con composizione del debito gestibile in via privata, specialmente quando la fiducia dei creditori chiave è ancora recuperabile. Non risolve situazioni di conflitto aperto, ma può spesso prevenire la degenerazione verso il fallimento con un intervento tempestivo. In pratica, molti piani attestati vengono utilizzati con successo da aziende che vogliono evitare il “marchio” del concordato e che hanno buone chance di cavarsela con accordi bilaterali. Il professionista attestatore gioca un ruolo fondamentale: la sua credibilità e accuratezza danno ai creditori la comfort letter per accettare il piano. Per l’imprenditore, il piano attestato è anche vantaggioso in termini di costi e tempi rispetto a procedure giudiziali.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F., artt. da 57 CCII)
Cosa sono: Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) sono accordi tra il debitore e una percentuale qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti, salvo varianti) volti a ristrutturare l’indebitamento dell’impresa, che vengono sottoposti all’omologazione del Tribunale. A differenza del piano attestato, l’ARD è un ibrido: nasce come accordo negoziale, ma richiede un controllo giudiziale e un decreto di omologa per diventare efficace erga omnes (verso tutti i creditori coinvolti). Fu introdotto nell’art.182-bis della vecchia legge fallimentare e ora è disciplinato nel CCII (Capo II del Titolo IV, artt. 57-64). Lo scopo è di consentire ristrutturazioni in forme più snelle del concordato, con meno coinvolgimento di creditori (non tutti devono aderire, solo una maggioranza qualificata) ma garantendo comunque trasparenza (c’è una relazione attestatrice anche qui) e parità di trattamento dei dissenzienti (che devono essere pagati integralmente se non aderiscono, salvo eccezioni).
Tipologie di accordi di ristrutturazione: Il CCII, recependo anche la direttiva UE, ha diversificato l’istituto: – Accordo di ristrutturazione “puro”: con il 60% dei creditori (per valore) aderenti. I creditori non aderenti rimangono estranei, però devono essere pagati integralmente entro la scadenza dell’accordo, altrimenti l’omologa non può essere concessa (li devi “tirar dentro” pagando cash o comunque soddisfacendoli in pieno) . Questo strumento tipicamente serve quando la stragrande maggioranza del debito è in mano a pochi creditori (es. banche) e i restanti sono spiccioli pagabili per intero. – Accordi di ristrutturazione agevolati (30%) e ad efficacia estesa: La normativa (già pre-CCII con D.L. 118/2021, e ora nel CCII art. 61, 64) prevede alcune varianti. Gli accordi agevolati riducono la soglia di adesione al 30% se però i creditori non aderenti vengono comunque pagati integralmente e tempestivamente (o se sono di modesta entità). Quindi facilitano il raggiungimento della soglia quando pochi creditori rilevanti bastano. Gli accordi ad efficacia estesa (ex art. 64 CCII) permettono di estendere gli effetti dell’accordo anche a creditori dissenzienti appartenenti a determinate categorie omogenee, se l’adesione nella categoria ha raggiunto percentuali elevate e questi creditori dissenzienti sono “finanziari”. Ad esempio, la norma consente che se 75% delle banche aderisce, l’accordo possa essere dichiarato efficace anche verso le banche dissenzienti, a condizione di trattamento non deteriore per queste (è un meccanismo di cram-down settoriale per istituti finanziari, introdotto già nel 2016 e confermato). Il correttivo 2024 ha ulteriormente ritoccato queste soglie e criteri, ma l’impianto rimane: gli accordi di ristrutturazione possono “trascinare” minoranze dissenzienti di finanziatori sotto certe garanzie di equità . – Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari: prima citato, è in pratica l’applicazione più comune dell’accordo ad efficacia estesa. Molto utile per aziende indebitate con consorzi di banche (es. sindacati di credito). Invece di concordato, se convinciono la maggior parte delle banche (>=75%), possono includere tutte. – Accordi nei gruppi di imprese: Il CCII consente accordi di gruppo, e il correttivo 2024 ha introdotto la possibilità di presentare una proposta unitaria di trattamento dei crediti tributari e contributivi per più società in gruppo . Questo per facilitare la ristrutturazione di gruppi societari: possono presentare un accordo con un unico pacchetto per debiti fiscali di tutte, coordinando le competenze degli uffici fiscali. – Accordo di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): Questo in verità è rubricato a parte (Capo III del Titolo IV, se non erro). Già ne abbiamo accennato: è un piano approvato all’unanimità dalle classi e poi portato in tribunale per omologa. Un PRO può essere visto come un accordo con il 100% per classi (non per singolo creditore, ma per classi), quindi molto stringente. Il vantaggio è che nel PRO il codice consente deroghe alle priorità (puoi falcidiare crediti privilegiati anche se dissenzienti, ma tanto c’è unanimità di classe…) e con iter rapido. Onestamente, se si raggiunge quell’unanimità, si poteva anche fare un piano attestato, ma l’impulso di farlo omologare è per blindare eventuali oppositori fuori dal tavolo.
Procedura e requisiti: Per fare un accordo di ristrutturazione standard: – L’imprenditore elabora un piano di risanamento (come contenuto, simile a quello di un concordato, con analisi di fattibilità e di soddisfazione creditori). – Raccoglie l’adesione formale di creditori rappresentanti almeno il 60% (o 30% se agevolato) dell’ammontare complessivo dei crediti. – Predispone una relazione di un esperto indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e che l’accordo è idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza delle singole obbligazioni (o dalla omologa se anteriori) . Questa attestazione serve a tutelare i non aderenti. – Deposita il ricorso in tribunale con l’accordo e documenti. Nel frattempo può chiedere al tribunale le misure protettive (simili a quelle del concordato: blocco delle esecuzioni, ecc. per massimo 4 mesi). – Il tribunale fissa un’udienza, ascolta eventualmente chi si oppone (i creditori estranei o eventuali aderenti dissenzienti su qualcosa). – Se tutto è regolare e non vi sono opposizioni fondate, omologa l’accordo. Da quel momento l’accordo è vincolante tra le parti aderenti. I creditori estranei non sono toccati dall’accordo salvo i casi di accordo ad efficacia estesa. Però l’azienda in virtù dell’accordo ha migliorato la sua posizione e avrà liquidità per pagarli (deve farlo se vuole rispettare i termini di legge – 120 giorni). – Se ci sono creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS) la loro adesione segue regole della transazione fiscale: vanno presentate le proposte e attendere 90 giorni la risposta . Il correttivo 2024 ha ridefinito l’art.63 CCII introducendo condizioni stringenti per il cram-down fiscale negli accordi: ad es., se l’ente pubblico è determinante e il trattamento offerto non è deteriore rispetto al fallimento, il tribunale può omologare forzosamente a due condizioni alternative: i) almeno 25% dei creditori totali aderiscono e Stato prende ≥50% dei suoi crediti; oppure ii) meno del 25% aderiscono ma Stato prende ≥60% e dilazione ≤10 anni . E sono previste cause ostative al cram-down se il debito fiscale è enorme e frutto di frodi seriali (80% debito totale, 1/3 da frodi, ecc.) . Questo per evitare abusi (il legislatore ha reagito a casi in cui aziende con quasi solo debiti erariali usavano il cram-down per tagliarli troppo). Tali parametri raffinati evidenziano che l’accordo con transazione fiscale è possibile ma il tribunale oggi verifica con attenzione convenienza e percentuali prima di imporlo . – Dopo l’omologa, l’accordo viene eseguito: se il debitore non adempie agli impegni, i creditori tornano liberi di agire e l’accordo può essere dichiarato risolto (ma non c’è una procedura automatica tipo fallimento, a meno che il debitore non scivoli comunque in insolvenza e qualcuno lo dichiari).
Vantaggi: – Maggioranze ridotte: serve “solo” il 60% di consenso (o 75% di una classe finanziaria per estenderlo a tutti in quella classe). Questo è molto utile se ci sono pochi grandi creditori collaborativi e tanti piccoli passivi: non devi cercare il voto di ciascuno come in concordato, basta pagare i piccoli per intero e non li coinvolgi. – Meno formalità rispetto al concordato: Non ci sono classi obbligatorie (tranne che per le estensioni per categorie omogenee), non c’è voto in adunanza di tutti i creditori, non c’è un commissario giudiziale salvo in casi particolari. È più rapido: spesso si chiude in 4-6 mesi la pratica di omologa. – Azione esecutiva sospesa: depositata la domanda di omologa, si può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dai creditori (art. 54 CCII). Anche eventuali istanze di fallimento pendenti devono essere sospese nel frattempo, simile al concordato. – Mantenimento gestione: l’imprenditore rimane in carica e non subisce limitazioni come nel concordato (in concordato c’è il commissario e servono autorizzazioni per atti straordinari). Qui c’è più libertà gestionale, dato che si presuppone la negoziazione già avvenuta. – Flessibilità di contenuto: L’accordo può prevedere soluzioni varie: es., conversione di crediti in capitale (una banca può aderire dicendo “mi trasformo in socio per il 30%”), pagamento parziale di chirografari, dilazioni lunghe, vendita di cespiti con accordo su come distribuire il ricavato, ecc. È come un contratto, limitato solo dal fatto che ai non aderenti devi dare almeno ciò che avrebbero con liquidazione o comunque pagarli integralmente se li lasci fuori.
Svantaggi: – Protegge solo dal fallimento, non vincola gli estranei (salvo eccezioni): Un creditore estraneo (che non aderisce e non è finanziatore oggetto di cram-down settoriale) rimane libero di agire. Certo, l’impresa si impegna a pagarlo integralmente entro 120 giorni dall’omologa, ma se non lo fa, costui può attaccare (e potrebbe aver attaccato anche prima se non c’era protezione). In pratica l’accordo funziona bene se il numero di estranei è ridotto e c’è cassa per pagarli presto. Se l’impresa non può pagare i dissenzienti in tempi brevi, l’accordo non è lo strumento adatto. – No effetto esdebitativo generale: Diversamente dal concordato, l’accordo non libera il debitore dai debiti residui verso non aderenti. Nel concordato anche chi non vota (chirografario) è falcidiato secondo il piano. Nell’accordo, chi non firma deve prendere il 100%. Quindi l’accordo non “scarica” tutti i debiti: solo riduce quelli di chi ha accettato uno stralcio. – Necessità di adesione qualificata: Il 60% di consensi non è poco. Soprattutto conta come calcolarlo: 60% di tutti i crediti. Ciò significa che se ci sono tanti piccoli debiti sparsi, difficilmente li fai aderire uno per uno; la soluzione è pagarli out. Ma se la somma dei crediti di estranei supera il 40%, devi pagarli integralmente e avere i soldi per farlo. Non sempre fattibile. Ad esempio, se l’Erario e l’INPS (che di solito non aderiscono facilmente se vuoi stralciare) compongono il 30% del debito totale, e alcune banche rifiutano (poniamo un altro 15%), potresti non arrivare al 60% e l’accordo salta. Il concordato in quel caso poteva passare con 51% in classi. – Opposizioni: Durante l’omologa, un creditore non aderente può fare opposizione (eccependo convenienza, disparità di trattamento, ecc.). Questo può ritardare e complicare l’omologa. Il tribunale però tende a respingere opposizioni se l’esperto ha attestato la convenienza e l’accordo rispetta la legge. Ma c’è rischio di appello (anche se non sospende di solito). – Costo e procedure: Meno costoso del concordato ma comunque richiede un attestatore, avvocati, eventuale coordinamento con creditori vari. Non è proprio a costo zero, quindi serve un’impresa di dimensioni significative per giustificare l’ARD. – No transazione fiscale “imposta”: Fino al correttivo 2024, c’era la possibilità di cram-down fiscale in accordo con requisiti simili al concordato. Ora è stata limitata a precisi casi con soglie (v. sopra). Quindi, se il Fisco non sta al gioco, l’accordo rischia di non poter essere omologato salvo pagarlo in percentuali minime (50-60%). Questo è uno svantaggio se il debito fiscale è ingente. Nel concordato c’è maggiore spazio di cram-down (specie nel liquidatorio: basta convenienza e il tribunale può forzare se il voto Erario ha mandato in minoranza). – Decadenza: Se dopo l’omologa l’impresa non rispetta i patti, l’accordo non ha un giudice che vigila (non c’è commissario né liquidatore). Saranno i creditori, caso per caso, a dover eventualmente agire per risolvere l’accordo e magari chiederne il fallimento. Ciò comporta rischi di incertezza.
Quando usare l’accordo di ristrutturazione: Tipicamente quando l’azienda ha pochi creditori principali disposti a collaborare e vuole evitare il peso di un concordato. Spesso sono banche e qualche fornitore grosso. E l’azienda magari ha risorse (o gliele danno i soci) per pagare i piccoli integralmente. In questi casi, l’accordo è efficace, rapido e meno traumatico (nessun commissario, l’azienda non appare “fallita” sul mercato). È molto usato anche come strumento intermedio: l’impresa deposita un concordato “in bianco”, poi trasforma in accordo 182-bis se vede che riesce a far firmare i creditori. Oppure avvia la composizione negoziata e la conclude con la firma di un accordo di ristrutturazione invece che col concordato.
Novità 2024: Abbiamo visto: – Introduzione di possibilità di parziale falcidia di tributi e contributi direttamente negli accordi e nei PRO, con procedure per l’adesione enti . – Condizioni puntuali per il cram-down fiscale negli accordi in continuità (con soglie 25%/50% o 60%) e per il concordato (simili logiche) . – Possibilità di unificare in proposte di gruppo per tributi (utile se l’azienda UPS fa parte di un gruppo con filiali insolventi). – Allineamento dell’accordo minore liquidatorio (per piccoli debitori) alle regole del concordato liquidatorio (richiesta di risorse esterne≥10%) – ma questo attiene ai sovraindebitati, un campo diverso (privati, piccoli imprenditori non fallibili).
Esempio pratico di accordo di ristrutturazione:
Zeta Srl ha €10 milioni debiti: €6M con 4 banche, €2M con fornitori (100 fornitori vari), €1M debiti fiscali, €1M leasing. È insolvente ma ha ordini e vuole evitare il fallimento. Nella composizione negoziata l’esperto facilita un accordo: – Le 4 banche (che insieme sono il 60% del totale crediti) accettano di ridurre il debito del 20% e di prorogare le scadenze per 5 anni, in cambio di garanzie su immobili e di un interessamento di un investitore. – L’investitore Tizio apporta €1M di nuova finanza prededucibile (che serve a pagare parte fornitori e costi). – I fornitori verranno pagati integralmente ma in 12 mesi dopo l’omologa (usando i flussi della continuità e un pezzetto dell’apporto Tizio). – Il fisco accetta una transazione: Zeta paga il 100% di IVA e contributi in 4 anni, ma ottiene stralcio di sanzioni (questo comporta adesione AE). – Il leasing riprende i macchinari restanti e rinuncia a ulteriori crediti.
Si raccolgono le adesioni scritte: 3 banche su 4 firmano (diciamo 55% crediti) e la quarta banca, un po’ riluttante con €0.5M (5%), viene comunque convinta grazie alla regola dell’accordo finanziario ad efficacia estesa: essendo >75% del credito finanziario d’accordo, in sede di omologa Zeta chiederà di estendere i termini alle banche dissenzienti . Fisco ha aderito formalmente alla transazione. Fornitori non aderiscono formalmente ma non serve perché li paghi integrale (saranno estranei soddisfatti dopo). Il totale adesioni dunque supera il 60% (banca1+2+3+fisco+leasing=supponiamo 80%). Zeta deposita l’accordo con la relazione di un professionista che attesta che i fornitori estranei saranno pagati entro 120 giorni dall’omologa (o piuttosto qui potremmo dire: li paga entro 12 mesi ma anticipa con factoring? Sennò c’è rischio di non rispetto 120 gg – difatti la legge sul 120gg è stringente, ma spesso interpretata con flessibilità se creditori accettano). Il tribunale concede misure protettive (sospendendo un paio di decreti ingiuntivi che fornitori avevano avviato) e fissa udienza. Nessuno si oppone (perché banche e fisco sono dentro, i fornitori attendono fiduciosi dati i rapporti commerciali, e in ogni caso sanno che verranno pagati). L’accordo viene omologato. Post omologa, Zeta esegue: paga man mano i fornitori nei mesi seguenti (attenzione a 120gg: se non li rispetta dovrebbe aver chiesto di essere autorizzata a pagarli oltre? Oppure li paga in 4 mesi con sconto?). Le banche ottengono le garanzie e i piani nuovi, e l’azienda continua attività. Chi non ha firmato (la quarta banca) è comunque obbligato a rispettare l’accordo (perché il tribunale gliel’ha esteso, vedendo equità di trattamento: stesso taglio 20% e stessa dilazione delle altre, non deteriore). In questo modo Zeta ha evitato il fallimento, pur dovendo impegnarsi a fondo per onorare l’accordo. I creditori hanno in teoria ottenuto più di quanto avrebbero visto in una liquidazione immediata (che ipoteticamente avrebbe pagato forse il 50% alle banche e quasi zero ai fornitori).
Questo esempio illustra sia la flessibilità (ciascuno ha un trattamento ad hoc concordato) sia il vincolo (i fornitori piccoli devono esser pagati al 100%). Se invece Zeta non avesse potuto pagare i fornitori integralmente, avrebbe dovuto trascinarli in un concordato offrendo una percentuale anche a loro. In quell’ipotesi, un concordato preventivo sarebbe forse stato più indicato.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Abbiamo già parlato diffusamente della Composizione Negoziata (CNC) nella parte sulle fasi pre-insolvenza. Qui riepiloghiamo i punti chiave come strumento formalizzato dal D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) e ora integrato nel CCII (artt. da 2 a 19 CCII):
- Cos’è: una procedura volontaria, confidenziale e non giudiziale in cui l’imprenditore in crisi (anche in insolvenza reversibile: il requisito è che ci sia “ragionevole perseguibilità del risanamento”, non importa se formalmente insolvente) , chiede a un’apposita commissione di nominare un esperto indipendente. L’esperto affianca l’imprenditore nel tentativo di trovare un accordo con i creditori. Non ha poteri decisionali, ma è un facilitatore/mediatore con competenze aziendali. La procedura è gestita tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) .
- Finalità: agevolare soluzioni extragiudiziali o paraconcorsuali prima che l’impresa collassi. L’esperto aiuta a individuare le opzioni (dall’accordo stragiudiziale, al piano attestato, all’accordo di ristrutturazione, o anche consiglia il concordato se vede che non c’è accordo possibile).
- Durata: in teoria 3 mesi + eventualmente 2 di proroga (5 in totale) per condurre le trattative.
- Misure protettive: su istanza dell’imprenditore, il tribunale può emettere un decreto che fino a 4 mesi proibisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e sospende eventuali istanze di fallimento . Questo è fondamentale sennò i creditori impazienti non starebbero al gioco. Il tribunale può però revocarle su segnalazione dell’esperto se il debitore abusa delle misure (es. non tratta in buona fede). Non c’è automaticità: come menzionato, serve il decreto. Quindi i creditori sanno che è un contesto protetto solo se necessario e con controllo.
- Condotta delle parti: la legge impone doveri di lealtà e riservatezza a debitore e creditori durante la CNC. L’esperto redige alla fine una relazione conclusiva.
- Esiti possibili:
- Raggiungimento di un accordo stragiudiziale (privato, anche senza attestazione se tutte le parti convinte – ma di solito l’esperto consiglia di formalizzare in un piano attestato se è di ampio respiro).
- Conclusione di uno degli strumenti del CCII: l’esperto potrebbe portare le parti a concordare un accordo ex 182-bis (che poi viene omologato) o a elaborare un concordato preventivo da presentare in tribunale (c.d. “concordato semplificato” per chi esce da CNC senza accordo è una opzione; in realtà il concordato semplificato per liquidazione – art. 25-sexies – può essere proposto senza voto dei creditori se le trattative falliscono, ma con cessione di tutti i beni e soddisfazione non inferiore al ricavabile). Questo concordato semplificato liquidatorio è una novità: consente al debitore onesto ma sfortunato di chiudere in tribunale liquidando l’attivo residuo e ottenere comunque l’esdebitazione, pur senza il voto dei creditori (che però possono opporsi in omologa). È stato pensato per evitare che la CNC fallita finisca inevitabilmente in fallimento: c’è una scialuppa per chi vuole evitare il fallimento classico.
- Archiviazione: se non si trova soluzione e l’imprenditore non vuole o non può attivare un concordato, la procedura termina e i creditori tornano liberi (e probabilmente chiederanno il fallimento).
Vantaggi: – E’ volontaria e riservata: non c’è stigma iniziale, l’impresa può dire di essere in “trattativa assistita” senza passare da un tribunale (il tribunale entra in gioco solo per le misure protettive o se serve qualche provvedimento urgente). – Coinvolge tutti i creditori in un tavolo: L’esperto può convocare creditori finanziari, fiscali, fornitori in riunioni congiunte, cosa utile per far capire a ciascuno la situazione e magari far accettare sacrifici coordinati. – Costi relativamente contenuti: l’esperto è pagato secondo tariffe stabilite, spesso con un contributo camerale pubblico. Non c’è tutto l’armamentario di curatore/commissario. Per PMI è sostenibile. – Flessibilità degli esiti: come visto, da questo percorso si può sfociare in qualunque soluzione: accordo privato, piano attestato, accordo 182-bis, concordato, o se non va, concordato semplificato. Quindi è come una porta di accesso a tutti gli strumenti. – Effetto psicologico positivo: Come segnalato dal Report CNC 2025, sta crescendo la fiducia in questo strumento . Le imprese lo iniziano a vedere non come un segnale di morte imminente, ma come una chance di recupero senza troppa pubblicità . Anche le statistiche mostrano un incremento di utilizzo nell’ultimo anno e decine di imprese salvate e posti di lavoro mantenuti grazie alla CNC . – Possibilità di misure specifiche: durante la CNC, il debitore può chiedere al tribunale di autorizzare atti urgenti (es. finanziamenti prededucibili, vendite di beni deteriorabili) o di sospendere/revocare contratti in corso (c’è una norma che consente, con ok dell’esperto, di sospendere per 60 gg o sciogliere alcuni contratti onerosi). Sono mini-poteri ad hoc per stabilizzare la situazione durante le trattative. – Nessuna soglia dimensionale: a differenza delle vecchie “procedure di allerta” pensate per PMI sopra certe soglie, la CNC può essere usata da qualsiasi imprenditore commerciale (anche “minore” non fallibile) e anche agricolo. Anzi, anche grandi imprese la usano. In Lombardia, prevalgono micro e piccole imprese (83%) , ma nulla vieta a una grande azienda di farlo. È un modello di “ristrutturazione assistita” copiato dal sistema francese (mandat ad hoc, conciliation) e sta prendendo piede.
Svantaggi: – Non vincolante senza accordo: Se un creditore importante non collabora, la CNC di per sé non può imporgli nulla. L’esperto può solo registrare il dissenso. Dunque non garantisce esito. Occorre comunque convincere una platea. – Richiede tempo: 3-5 mesi in uno stato di crisi possono essere tanti. Anche se protetti legalmente, l’impresa deve sopravvivere operativamente in quei mesi. Se non ha cassa, deve trovarla (perciò è prevista la facoltà di ottenere finanziamenti in prededuzione con ok del giudice – per esempio per pagare materie prime, stipendi). – Pubblicità limitata ma presente: L’esistenza della CNC non è pubblica (a differenza dell’allerta che fu abolita), a meno che l’impresa chieda misure protettive: in tal caso deve essere iscritta un’apposita comunicazione al registro imprese. Quindi i terzi (banche, partner) potrebbero venirne a conoscenza. È comunque meno noto di un concordato, ma non totalmente invisibile. – Misure protettive non automatiche: come detto, solo su decreto giudice e facilmente revocabili se il debitore sgarra. Ciò mette un po’ di incertezza: un creditore potrebbe provare a opporsi sostenendo che l’impresa non ha chance (il giudice comunque decide in tempi rapidi e tende a concederle se c’è un prospetto di risanamento). – Non adatta a emergenze estreme: se i creditori sono già all’arrembaggio e totalmente ostili, la CNC rischia di essere un passaggio inutile prima del fallimento. In tali casi, spesso l’esperto stesso, alla prima riunione, prenderà atto e chiuderà anticipatamente la procedura, suggerendo al debitore di rivolgersi a un concordato o di portare i libri in tribunale. Infatti, la norma dice che se l’esperto ravvisa “evidente impossibilità di perseguire il risanamento” lo comunica e le parti possono interrompere subito. – Dipende molto dalla qualità dell’esperto: se l’esperto nominato non è molto autorevole o preparato nel settore dell’impresa, potrebbe non riuscire a incidere nelle trattative (anche se per designazione occorre scegliere persone con adeguata esperienza da albi di manager, avvocati, commercialisti formati in crisi). Finora l’esperienza sembra positiva, ma c’è sempre variabilità.
Ruolo del concordato semplificato: Un aspetto peculiare introdotto col CCII (art. 25-sexies) è che se la CNC non porta a risanamento, l’imprenditore può chiedere entro 60 giorni successivi la omologazione di un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Questo concordato non ha voto dei creditori: il debitore propone come liquidare i beni e come distribuire ai creditori, e il tribunale decide se omologare sentiti i creditori. È semplificato perché non c’è commissario né adunanza di voto. Requisito: offrire ai creditori non meno di quanto otterrebbero in liquidazione giudiziale (c’è relazione esperto CNC che lo attesta). Inoltre deve esserci stata CNC conclusa senza altre soluzioni. Questa è una chiusura rapida: di fatto un fallimento consensuale pilotato, con possibilità per il debitore di scegliere il liquidatore. Tuttavia non esonera da possibili reclami creditori. Il correttivo 2024 ha esteso anche a concordato minore semplificato l’obbligo di apporto esterno 10% per i casi liquidatori , quindi per imprenditore minore anche lì serve aggiungere qualcosa. Ciò riflette l’idea che se vuoi il concordato liquido (anche semplificato) devi dare un “premio” rispetto al fallimento, come regola generale, per essere omologato.
Esempio di CNC riuscita:
La Epsilon Srl (30 dipendenti, produzione elettronica) vede un calo e accumula €4M debiti (2M banche, 1M fornitori, 0,5M Fisco, 0,5M altri). Attiva la composizione negoziata. L’esperto, esaminati i conti, vede che l’impresa ha margine di recupero se riduce i costi e ristruttura il debito. Convoca banche e investitori. Durante 3 mesi ottiene: – Le banche (50%) disponibili a tagliare interessi, prorogare mutui e dare nuova finanza di €0,5M (garantita dallo Stato). – Un investitore propone di entrare con €1M in equity fresco se i debiti vengono ridotti. – Fornitori accettano 50% a saldo, se pagati entro 6 mesi. – Fisco accetta transazione su cartelle: paga solo l’imposta, sanzioni out. In pratica si delinea un accordo quasi totale. A questo punto Epsilon potrebbe formalizzare un accordo di ristrutturazione omologato per blindarlo. L’esperto chiude la negoziazione con esito positivo e nella sua relazione finale dice che è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti. Epsilon dunque esce dalla CNC e nel frattempo ha predisposto, con quell’accordo e la relazione già in mano, un ricorso al tribunale per omologa di accordo ex art.182-bis. Il tutto senza mai passare da fallimento e con i creditori soddisfatti di aver partecipato attivamente. 38 imprese lombarde nel 2024 hanno trovato un risanamento così, salvando 2100 posti .
Esempio di CNC fallita con concordato semplificato:
La Omega Srl è troppo indebitata (€10M) e non competitiva. In CNC l’esperto vede che non c’è modo di risanarla come going concern, però c’è un soggetto interessato a comprare macchinari e brevetti per €2M. Non si trova accordo di ristrutturazione perché i debiti sono troppi e nessuno vuole immettere capitali. L’esperto comunica che non c’è soluzione concordata. Omega allora, entro 60 giorni, propone un concordato semplificato liquidatorio: offre di vendere i cespiti a quel soggetto per €2M e distribuire il ricavato ai creditori, stimando un soddisfo del 20% ai chirografari. Dimostra che in un fallimento prenderebbero forse 15%. Il tribunale, verificata regolarità e sentiti i creditori (alcuni protesteranno, ma senza soluzioni alternative), omologa il concordato semplificato. Omega cessa l’attività, il liquidatore nominato vende i beni a €2M come previsto, dopo costi i creditori ricevono il 20%. L’imprenditore ottiene l’esdebitazione residua (non è automatico ma se è persona fisica la può chiedere). Così si chiude la storia senza passare dal classico fallimento, con minor costi e tempi più rapidi.
Chiosa: La Composizione Negoziata essenzialmente rappresenta l’istituzionalizzazione del “fare prevenzione”. Consente all’imprenditore onesto di giocare in anticipo, coinvolgendo tutti i portatori di interesse sotto la guida di un esperto super partes. Non è una bacchetta magica, ma i trend mostrano che sta diventando centrale nel 2025 come strumento per salvare imprese . Il legislatore italiano l’ha preferita al vecchio sistema d’allerta “punitivo” perché qui l’imprenditore è incentivato a venire spontaneamente (anche per evitare responsabilità personali – se non lo fa, rischia poi di essere accusato di tardiva emersione). E i creditori pubblici e banche iniziano a comprenderne l’importanza. In futuro, è probabile che sempre più crisi aziendali passino da questa porta negoziale prima di sfociare in procedure giudiziarie.
Concordato preventivo (in continuità e liquidatorio)
Il concordato preventivo è storicamente la procedura principe per evitare il fallimento, presente nell’ordinamento da prima (R.D. 267/1942) e ora disciplinata dagli artt. 84-120 CCII. Il concordato è una procedura concorsuale giudiziaria a tutti gli effetti: viene aperta con decreto del tribunale, prevede la partecipazione di tutti i creditori (che hanno diritto al voto secondo il loro rango, salvo eccezioni) e si conclude con un’omologazione vincolante per tutti i creditori anteriori. A differenza di tutte le precedenti soluzioni, qui c’è un giudice e un commissario che vigila sull’operato del debitore durante la procedura. Il concordato può avere due anime: – Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): il piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, con i creditori soddisfatti in prevalenza con i proventi generati dalla continuità (o con l’apporto di un terzo che rileva l’azienda e continua l’attività) . Obiettivo: salvare l’azienda come entità economica (o parte di essa) e al contempo ridurre/ristrutturare il debito. Tipico esempio: concordato con continuità diretta = l’azienda resta in mano al debitore e continua a operare durante e dopo la procedura, pagando i creditori col cash flow futuro e/o dismettendo solo asset secondari; concordato con continuità indiretta = l’azienda viene ceduta (o conferita) ad un terzo che la proseguirà, e il prezzo pagato dal terzo va ai creditori. – Concordato liquidatorio: il piano prevede essenzialmente la cessione o liquidazione di tutti i beni del debitore per distribuire il ricavato ai creditori . L’attività non prosegue (se non per quanto funzionale a vendere al meglio). È molto simile, negli esiti, a un fallimento, ma volontario e concordato col ceto creditorio. Il legislatore del CCII, come abbiamo visto, ha reso più difficile l’accesso a concordati meramente liquidatori: richiede soglie di soddisfacimento e apporti esterni per renderli appetibili (per evitare concordati liquidatori “furbi” che davano ai chirografari briciole come in fallimento, ma col vantaggio solo per il debitore di evitare la bancarotta). In particolare, l’art.84 CCII stabilisce che nel concordato liquidatorio puro la proposta è ammissibile solo se i creditori chirografari ricevono almeno il 20% e c’è un apporto di risorse esterne che incrementa di almeno il 10% la soddisfazione rispetto a una liquidazione giudiziale . Tradotto: o garantisci 20% con soldi esterni pari a 10% attivo, oppure niente concordato liquidatorio. Ciò per filtrare i casi e rendere il concordato liquidatorio conveniente per i creditori rispetto al fallimento.
Procedura in sintesi: – Il debitore presenta un ricorso al tribunale con la proposta di concordato, il piano (relazione descrittiva) e la documentazione (bilanci, elenco creditori, inventario, ecc.), più la relazione di un attestatore indipendente che certifica veridicità dei dati e fattibilità del piano. – Se il ricorso è completo e non manifestamente inammissibile, il tribunale ammette alla procedura nominando un commissario giudiziale (figura terza, di solito un commercialista, che sorveglia il debitore e riferisce ai creditori e al giudice). – Da quel momento l’azienda è protetta: non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari individuali (salvo casi particolari, come creditori con pegno su strumenti finanziari possono far valere pegno in borsa, ecc.), e non si possono acquistare diritti di prelazione su crediti concorsuali (divieto di ipoteche giudiziali e simili). I contratti continuano salvo diverse disposizioni (il debitore può chiedere di scioglierne alcuni o sospenderli). – Il debitore rimane in possesso dei beni (“debtor in possession”) ma sotto la vigilanza del commissario e del giudice: per atti fuori ordinaria amministrazione serve autorizzazione del tribunale o parere del commissario (es. vendere immobili prima dell’omologa è possibile solo se autorizzato e se previsto dal piano). – Il commissario redige una relazione per i creditori e convoca l’adunanza dei creditori (entro 120-180 giorni dall’ammissione) dove si discute il piano e i creditori votano (possono anche votare per corrispondenza senza venire). – Classi e votazione: Il debitore deve aver classificato i creditori in classi se opportuno (è obbligatorio separare i creditori con cause di prelazione rispetto ai chirografari; inoltre all’interno di chirografari se interessi economici differenti). Hanno diritto di voto i creditori chirografari e privilegiati se non soddisfatti integralmente. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ogni classe (nel CCII se c’è divisione in classi) oppure, se niente classi, la maggioranza semplice dei crediti votanti. In caso di più classi, bisogna avere la maggioranza delle classi votanti favorevoli. Se non tutte le classi approvano, esiste il meccanismo del cram-down (ristrutturazione trasversale): il tribunale può comunque omologare se certe condizioni di tutela delle classi dissenzienti sono rispettate (in particolare art.112 CCII: il concordato è omologabile lo stesso se almeno una classe di creditori non completamente soddisfatti ha votato sì, i dissenzienti non ricevono meno di quanto spetterebbe in liquidazione e non vengono alterate le priorità in modo illegittimo, salvo accordo interclassista). Il correttivo 2024 ha chiarito dettagli di questo criterio, specie per la continuità: ha precisato il significato di “classe che avrebbe ricevuto qualcosa in liquidazione” ai fini del cram-down , per evitare dubbi. Dunque se c’è un ampio consenso la mancanza di unanimità non blocca (ad es. se 4 classi su 5 approvano, e la contraria comunque prendrebbe più che in fallimento e almeno una classe di pari rango ha detto sì, il giudice può forzare l’approvazione). – Se i creditori approvano (o comunque ci sono i presupposti per cram-down) si passa all’udienza di omologazione: eventuali creditori dissenzienti o esclusi possono fare opposizione (ricordiamo che nel concordato i creditori pubblici Erario/INPS possono essere crammati con quelle percentuali e condizioni illustrate prima ). – Il tribunale (collegio) esamina: se il concordato rispetta la legge (percentuali minime, priorità, etc.), se il voto è stato regolare, e se il piano è attuabile. Non entra nel merito di convenienza (quella è dei creditori, salvo se qualcuno contesta la mancata convenienza rispetto al fallimento, allora il giudice verifica quel parametro). Se tutto okay, emette decreto di omologazione. A quel punto il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori: i loro crediti sono modificati secondo quanto stabilito (es. ridotti del 70%, o trasformati in partecipazioni, ecc. a seconda del piano). – Esecuzione: Il debitore (o un liquidatore se previsto dal piano) esegue le operazioni: paga i creditori secondo le percentuali e tempistiche, vende eventuali beni da liquidare, porta avanti l’azienda se c’è continuità. Il commissario di solito diventa liquidatore giudiziale se è un concordato con cessione di beni. Oppure nel concordato in continuità il debitore stesso esegue e il commissario vigila per tutto il tempo fino a completa esecuzione (ci sarà poi un decreto di chiusura a esecuzione avvenuta). – Esdebitazione: a differenza del fallimento, la società in concordato non prosegue con debiti residui: i creditori, omologato il concordato, possono pretendere solo quanto promesso nel concordato. Se ricevono il 30% secondo piano, il restante 70% è remisso (perdono il diritto). Quindi l’azienda ne esce “pulita” dai debiti pregressi. (Se poi non adempie il concordato, i creditori potrebbero chiederne la risoluzione e farla fallire, ma è un altro capitolo). – Effetti per l’imprenditore: se l’azienda è una società, mantiene la continuità senza fallire e gli amministratori evitano le interdizioni da fallimento (e anche la procedura penale di bancarotta non scatta, salvo reati eventualmente commessi durante, ma non c’è bancarotta se non c’è fallimento; c’è però reato di mancata esecuzione dolosa di concordato se non rispettano apposta). Se è un imprenditore individuale, ottiene esdebitazione di diritto a fine concordato (nuovo CCII prevede esdebitazione per chiunque completi concordato). Ciò è preferibile al fallimento in cui l’esdebitazione è condizionata a tante cose post chiusura.
Concordato in continuità vs liquidatorio – differenze pratiche:
- Nel concordato in continuità l’azienda è un “cantiere aperto” durante la procedura: l’attività continua, i dipendenti restano, i contratti (fornitura, appalti) proseguono. Questo comporta alcune norme ad hoc:
- Il piano deve indicare l’apporto di finanza necessaria e come si finanzia la gestione corrente (spesso con ricavi stessi o finanza interinale).
- Il debitore può ottenere dal tribunale l’autorizzazione a fare debiti prededucibili funzionali alla continuità (es. comprare materie prime a credito, pagare fornitori post domanda: questi crediti di nuova finanza o di forniture essenziali saranno in prededuzione, cioè verranno pagati prima degli altri in caso di successivo fallimento se il concordato non riuscisse, dando sicurezza ai fornitori).
- Il pagamento dei creditori anteriori durante la procedura è di solito vietato, ma in continuità può essere autorizzato se strumentale alla continuazione (es. pagare un fornitore critico o pagare contributi per non perdere DURC e appalti).
- Aspetti come affitto d’azienda o vendite sono possibili ma in continuità diretta di solito l’obiettivo è non smembrare l’impresa.
- Post omologa, l’impresa continua e paga col tempo i creditori secondo il piano (es. 5% subito, poi rate semestrali sui 5 anni, ecc.). I creditori accettano il rischio perché l’alternativa era peggiore. Il commissario poi vigilare l’esecuzione.
- Vantaggio: potenzialmente massimizza il valore rispetto a chiudere bottega, e preserva l’avviamento.
- Rischio: se la gestione in concordato va male (ad es. peggiorano i ricavi), il piano potrebbe non reggere e l’azienda potrebbe poi fallire comunque; però almeno si è tentato e i creditori potevano ottenere più di un immediato realizzo a sconto.
- Per tutelare i creditori, la legge e giurisprudenza implementano l’absolute priority rule mitigata: i creditori dissentienti non possono subire che i soci mantengano valori se ai creditori non è dato almeno l’equivalente valore (nel CCII c’è art. 112 che di fatto incorpora l’idea che se i soci conservano partecipazioni o ottengono distribuzioni, ciò è possibile solo se i creditori sono soddisfatti al 100% o consenzienti). Ad esempio, in un concordato in continuità i soci non possono ricevere utili finché i creditori non siano soddisfatti come da piano, e se i creditori prendono meno del 100%, ai soci non può restare una partecipazione se c’è classe dissenziente, a meno abbiano apportato risorse nuove (questo concetto è riflesso in art.120-quater CCII e normative correlate).
- Esempio tipico: Alfa Srl propone concordato in continuità pagando i chirografari 40% in 4 anni e mantenendo l’azienda. I soci mantengono quote. Una parte di creditori dissente. Il tribunale omologa comunque se i parametri di cram-down sono ok, però se per caso in piano era previsto che i soci restino proprietari, occorre valutare se ciò rispetta la priorità: secondo CCII è ammesso purché quell’esito (soci che non perdono tutto) non riduca il recupero dei creditori rispetto al fallimento e almeno una classe ha detto sì. Questo è un discorso complesso, ma grazie alle regole fissate (tra cui quell’obbligo di contributo esterno 10% per i liquidatori, e l’assoluta/relative priority rule per continuità), c’è un bilanciamento.
- Un aspetto del correttivo 2024: ha chiarito che per omologare in continuità senza maggioranza classi, una delle classi consenzienti deve essere formata da creditori che non sarebbero soddisfatti integralmente in liquidazione e hanno un interesse economico alla proposta (non nulla in scenario alternativo) . Questo per evitare che l’unica classe consenziente fosse magari una classe “fittizia” di creditori postergati o soci, il cui voto era irrilevante economicamente. Serve almeno una classe di veri creditori che guadagnano dal concordato e perciò votano sì.
- Nel concordato liquidatorio l’attività cessa (o viene ridotta al minimo per vendere l’esistente), un liquidatore giudiziale nominato dal tribunale (spesso il commissario stesso) si occupa di vendere beni (anche tramite procedure competitive tra offerte, perché vige il principio di massimizzazione del ricavato) e poi distribuire il ricavato ai creditori secondo le priorità. È molto simile a un fallimento ma con due differenze:
- Avviene su proposta e piano del debitore, quindi può includere apporti di terzi (es. i soci mettono soldi per arrivare al 20% minimo, o un acquirente è già individuato con un prezzo che il fallimento non garantirebbe).
- È approvato dai creditori stessi (quindi in teoria più “consensuale”).
- Richiede come detto: almeno 20% ai chirografari, e risorse esterne ≥10% attivo . Spesso questi 10% esterni li mettono i soci se tengono a evitare il fallimento (magari per evitare azioni di responsabilità, preferiscono pagare qualcosa).
- Non c’è continuità da salvare: i dipendenti saranno licenziati (ma prendono TFR dal fondo), l’azienda di fatto muore. Tuttavia, c’è chi preferisce un concordato liquida a un fallimento per vari motivi (controllo maggiore sui tempi e modi delle vendite, scelta del liquidatore, evitare dichiarazione di fallimento con relativo stigma e potenziali indagini di polizia giudiziaria meno stringenti).
- Esempio: Beta Srl è decotta ma i soci vogliono evitare le responsabilità del fallimento. Propongono concordato dove cedono tutto l’attivo stimato €1M, in cambio i soci aggiungono €100k liquidi (10% esterno), così possono dare 20% sui €5M di debiti chirografari. I creditori valutano e magari preferiscono accettare 20% subito dai soci piuttosto che rischiare un fallimento in cui recupererebbero forse 10% e dopo anni. Votano sì, il tribunale omologa, Beta cessa esistenza con un 20% pagato e il resto stralciato. I soci hanno speso €100k ma evitato doversi confrontare con un curatore (che magari li avrebbe citati per cattiva gestione). Questo capita in realtà medie con soci solvibili che vogliono “chiudere” pulito.
Vantaggi del concordato: – Vincolatività ed esdebitazione universale: è l’unico mezzo per imporre legalmente a tutti i creditori (anche dissenzienti e assenti) una riduzione o dilazione dei crediti. Quindi se la situazione richiede uno sforbicio generalizzato, il concordato è l’arma finale. – Protezione ampia: dal giorno dell’ammissione, l’impresa è protetta da assalti. Ciò permette di respirare e portare avanti soluzioni complesse senza l’incubo di pignoramenti. – Può contemplare mix di soluzioni: ad esempio, parte dell’azienda in continuità e parte da liquidare; accordi con certi creditori e stralci ad altri; conversione di crediti in equity; ecc. È flessibile nel contenuto, a patto di rispettare la par condicio (regole di priorità). – Controllo giudiziario: c’è un organo terzo (commissario + giudice) che assicura trasparenza: per i creditori, sapere che c’è vigilanza indipendente è una garanzia (riduce timori di trucchi da parte del debitore). – Responsabilità ridotte per amministratori: La giurisprudenza dice che la presentazione tempestiva di un concordato poi ammesso, se non è stato fatto in mala fede, esclude la punibilità per fatti di bancarotta preferenziale per pagamenti effettuati nel periodo del tentativo (non c’è fallimento, e se poi fallirà ma i pagamenti erano nel solco del piano presentato, li si possono giustificare meglio). Inoltre l’apertura del concordato segna la cessazione dell’obbligo di chiedere fallimento: l’azione di responsabilità per tardiva richiesta viene meno se si è scelta un’altra procedura concorsuale ragionevole. Quindi l’amministratore che avvia concordato in tempo di solito si copre dal rischio di essere accusato di aver tardato a fare qualcosa. – Possibilità di cram-down fiscale e contributivo: Nel concordato la legge consente al giudice di omologare anche senza voto favorevole di Fisco/INPS, se il piano è conveniente rispetto al fallimento e le condizioni specifiche (ad esempio in concordato liquidatorio il giudice può scavalcare il no del Fisco se la proposta fiscale è comunque più vantaggiosa del fallimento, come confermato nel correttivo 2024 ). Questo è essenziale perché spesso l’Erario è inerte o contrario. Con l’accordo 182-bis ora c’è l’istituto simile ma con paletti come visti (50-60%). Nel concordato in continuità, come da ultime modifiche, il giudice può cramdownare il Fisco salvo il caso che dopo il cramdown esso sarebbe l’unica classe consenziente (non ammesso) . Quindi c’è margine di manovra.
Svantaggi del concordato: – Lungo e costoso: tra preparazione, ammissione, voto e omologa passano facilmente 8-12 mesi, anche di più in casi complessi (il CCII tenta di stringere i tempi, ma con opposizioni ecc. si va per le lunghe). Costi di commissari, attestatore, legali, eventuali consulenti, tribunale. È un onere sostenibile da imprese medio-grandi, meno per piccole (per cui c’è il concordato minore semplificato, ma è un’altra procedura). – Pubblicità negativa: Il concordato è un atto pubblico (registro imprese, comunicati a tutti i creditori, notizia sui media locali…). Ciò può peggiorare i rapporti con clienti e fornitori: ad es., alcuni clienti potrebbero smettere di ordinare sapendo che l’azienda è “in concordato”, fornitori chiederanno pagamento anticipato (anche se i debiti nuovi sono prededucibili, la paura c’è). Spesso l’azienda in concordato subisce un danno reputazionale e fatica durante la procedura. – Rigidità normative: Bisogna rispettare fedelmente le regole su priorità, soglie, classi, ecc. Il giudice può dichiarare inammissibile la proposta se non conforme. Es. presentare un concordato liquidatorio con offerta 5% ai chirografari senza apporto esterno → inammissibile per legge . Oppure proporre di pagare i creditori privilegiati parzialmente senza transazione fiscale approvata → inammissibile. Quindi minor flessibilità rispetto a un accordo privato dove volendo i creditori possono accettare qualunque condizione. – Rischio di esito negativo: Se i creditori non approvano, il concordato viene dichiarato “non approvato” e il tribunale dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale) subito dopo. È un rischio forte: mettersi in concordato e poi fallire è come perdere due volte (si è speso tempo e soldi e in più i ritardi hanno magari eroso valore). Dunque l’impresa deve calibrarsi: conviene tentare il concordato solo se ha ragionevole speranza di farlo approvare. Di solito si testa il terreno con i principali creditori prima di presentarlo. – Perdita di controllo parziale: Gli amministratori restano, ma non sono liberi di fare scelte straordinarie senza permesso. Per alcuni imprenditori questo è vissuto male. Inoltre, in alcuni casi di concordato con continuità il tribunale può imporre la nomina di un ausiliario o “attestatore di performance” per monitorare i flussi (il CCII prevede che in continuità il piano contenga precisi obiettivi di performance e se non li rispetti scattano allerta interne e possibili revoche). Insomma, c’è un occhio costante. – Fenomeno delle classi ostili: Un creditore importante, mettendosi in una classe a sé, può cercare di far fallire il concordato votando no. Questo per far saltare la procedura e magari trattare meglio dopo, o per procedere ad altre soluzioni (es. acquisire l’azienda via fallimento a minor prezzo). Il CCII col cram-down ha mitigato il potere di veto, ma rimane: se la classe dissenziente è di creditori privilegiati integralmene pagati in liquidazione e in concordato vorresti pagarli parziale, non puoi cramdownarli perché la priorità assoluta glielo impedisce. Quindi bisogna comporre con loro o pagarli. – Impatto su eventuali garanzie: Un aspetto spesso sottovalutato: se Tizio ha garantito il debito della società verso una banca, e la società fa concordato pagando 60% a quella banca, la banca può comunque escutere Tizio per il restante 40%? Secondo un orientamento prevalente, sì: il concordato non libera i coobbligati e i fideiussori (salvo patto contrario col creditore). Ciò significa che le garanzie personali non beneficiano dell’esdebitazione ottenuta dalla società. Il creditore può farsi pagare il residuo dal garante. Quindi, a differenza di un accordo stragiudiziale dove magari potevi negoziare liberatoria per i garanti, il concordato li lascia esposti. Questo è uno svantaggio per l’imprenditore se ha firmato fideiussioni: rischia di risolvere il debito in capo all’azienda ma doverlo pagare di tasca propria. Dovrà poi usare le procedure personali per liberarsi. Alcune banche comunque in concordato rinunciano pro quota contro i garanti, ma non c’è obbligo. – Costi post**: Dopo l’omologa, se concordato in continuità, l’azienda continua con un certo indebitamento ridotto ma ancora debiti da pagare per anni secondo piano. Non è facile vivere sotto quel fardello e sotto vigilanza. Serve disciplina ferrea. Non poche aziende, ottenuto il concordato, poi non riescono a rispettarlo, e finiscono in risoluzione/fallimento comunque. Dati storici mostrano tassi di insuccesso abbastanza alti per concordati in continuità soprattutto.
Quando utilizzare il concordato: Quando la situazione è così compromessa che solo una procedura concorsuale può gestirla. Ad esempio: – Troppi creditori per trovare accordi individuali e serve la maggioranza con “cram-down” sui minoritari. – Debiti eccedenti di molto l’attivo, dunque occorre legalmente abbatterli (esdebitazione) per poter proseguire. – Creditori pubblici molto gravosi, dove solo il tribunale può imporre la riduzione. – Necessità di vendere l’azienda “pulita” da debiti: il concordato in continuità indiretta è spesso usato per fare una “soluzione Attila”: un investitore vuole l’azienda senza debiti, allora si fa un concordato: l’investitore crea NewCo che compra l’azienda dal concordato e paga un prezzo che va ai creditori (questo meccanismo, simile all’amministrazione controllata all’americana, in Italia è possibile col concordato). – Evitare fallimento quando i creditori sono ragionevolmente disponibili a una soluzione di soddisfo parziale. – Quando serva protezione robusta da azioni legali: es. cause pendenti con esito potenzialmente dannoso – col concordato si blocca tutto e si convoglia in sede concorsuale.
Novità 2024 sul concordato: Già anticipate: – Dettagli su transazione fiscale e contributiva (art.88 CCII rivisto) e cram-down pubblici: ora codificati parametri (visti prima) . – Chiarimenti su cram-down interclassi in continuità (art.112 interpretato, come sopra) . – Armonizzazione del concordato minore (per debitori non fallibili) alle regole di quello ordinario (richiesta apporto 10% per liquidatorio minore etc.). – Maggiore enfasi su gruppi: possibili concordati di gruppo e proposte unitarie per creditori fiscali di gruppo (utile se la nostra azienda UPS fa parte di un gruppo con altre consociate in crisi: possono presentare un concordato unitario multi-impresa).
Conclusione sezione strumenti: Abbiamo quindi uno spettro: – Strumenti totalmente privati: accordi informali, piani attestati (con minime formalità). – Strumenti ibridi: accordi di ristrutturazione (privati ma con omologa pubblica), PRO. – Strumenti negoziali assistiti: composizione negoziata (che può confluire in accordi, piano attestato, etc.). – Strumenti totalmente giudiziali concorsuali: concordati (continuità o liquidazione) e, se nulla funziona, liquidazione giudiziale (ex fallimento) come ultima ratio.
Il punto di vista del debitore deve essere pragmatico: scegliere lo strumento che massimizza la possibilità di risanare o quantomeno chiudere la situazione col minimo danno, tenendo conto del livello di consenso e fiducia dei creditori. Spesso la via è scalare gradualmente: provare negoziazione stragiudiziale (magari con piano attestato), se non basta passare a composizione negoziata, e se fallisce usare il concordato come ultima spiaggia. L’importante è muoversi tempestivamente: prima si agisce, più chance di evitare la fine disordinata.
Nei prossimi capitoli vedremo ora più specificamente come difendersi dalle azioni esecutive durante questi percorsi (ad es. quali strumenti legali scattano per bloccare i pignoramenti) e come tutelare il patrimonio personale dell’imprenditore, con riferimento alle garanzie personali e responsabilità, argomenti strettamente connessi al tema dei debiti aziendali.
Come fermare (o limitare) le azioni esecutive dei creditori
Uno degli aspetti più critici per un imprenditore indebitato è la tutela contro le azioni esecutive dei creditori: parliamo di pignoramenti, sequestri conservativi, e più in generale di ogni iniziativa con cui un creditore cerca di aggredire i beni dell’azienda (o i crediti verso terzi, come i crediti bancari o le fatture) per soddisfarsi. Queste azioni possono paralizzare l’attività: basti pensare al pignoramento di un conto corrente che blocca tutti i pagamenti, o al pignoramento di un macchinario essenziale. Dunque, “difendersi” dai creditori ha anche e soprattutto il significato di sospendere o prevenire le esecuzioni individuali, incanalando la crisi in un alveo ordinato (che sia ristrutturazione concordata o procedura concorsuale).
Di seguito riepiloghiamo gli strumenti di difesa del debitore contro le esecuzioni e i vincoli sui beni, con indicazione di quando e come si applicano.
Misure protettive nelle procedure di composizione (CNC, accordi, concordato)
Come visto: – Composizione negoziata: L’imprenditore può chiedere misure protettive appena deposita l’istanza di nomina dell’esperto (o anche dopo). Se concesse, esse sospendono per la durata dell’incarico tutte le azioni esecutive e cautelari iniziate dai creditori chirografari e privilegiati chirografari . Restano ferme eventuali esecuzioni sui creditori muniti di prelazione? La legge prevede che anche i creditori privilegiati non possano iniziare o proseguire esecuzioni, ma se il bene su cui hanno prelazione è essenziale per la continuità d’impresa. Inoltre sono sospese le prescrizioni. Quindi di regola blocca quasi tutto. Non blocca però, ad esempio, la decadenza dal termine su eventuali contratti (quelle sono clausole contrattuali). Ma impedisce i pignoramenti di immobili, mobili, conto ecc. Queste misure protettive di CNC hanno efficacia erga omnes e sono pubblicate nel registro imprese (quindi i creditori ne sono informati ufficialmente, e se qualcuno viola – tenta un pignoramento – l’atto è nullo). – Accordo di ristrutturazione (182-bis): Quando il debitore deposita in tribunale la domanda di omologazione, può richiedere un provvedimento del tribunale che impone un “divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari” per max 120 giorni (prorogabili a 180). Tipicamente, si chiede contestualmente al deposito e spesso il tribunale accorda lo stay per proteggere l’accordo in via di definizione o omologazione. Inoltre, anche qui, dal deposito l’eventuale pignoramento su beni aziendali sarebbe inefficace (c’è un concorso nascente). – Concordato preventivo: Dal momento in cui la società deposita il ricorso di concordato e viene ammessa (o anche durante la fase “in bianco”, se la domanda è con riserva, il tribunale di norma emette comunque i provvedimenti per sospendere le azioni fino alla decisione sull’ammissione), scatta l’automatic stay: nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sul patrimonio del debitore . Pignoramenti in corso rimangono sospesi e poi si estingueranno se il concordato va a buon fine. Eccezioni: i creditori con pegno su azioni o altri strumenti finanziari facilmente liquidabili potevano in passato procedere (ma credo che il CCII abbia tolto quell’eccezione); i titolari di crediti estranei al concorso (ad es. crediti verso un coobbligato diverso dalla società) potevano agire su quell’altro soggetto; i titolari di diritto di ritenzione su beni possono continuare a trattenerli. Ma in generale, la stragrande maggioranza dei creditori è congelata. Anche eventuali sequestri conservativi chiesti decadono perché diventano incompatibili col concorso. – Liquidazione giudiziale (fallimento): da quando è dichiarata, tutti i creditori devono fare valere le pretese nel passivo e non possono agire individualmente (le esecuzioni in corso sono interrotte). Il fallimento è la protezione massima, ma con la conseguenza che la gestione passa al curatore.
In pratica, le procedure concorsuali sono l’unico scudo forte e generale contro le esecuzioni. Fuori da esse, un debitore non può unilateralmente impedire ad un creditore di portarlo in tribunale ed eseguire su un bene (fatti salvi i rimedi processuali normali, vedi più avanti). Quindi se un imprenditore vuole protezione totale, la ottiene solo attivando una procedura, sia pure negoziale come CNC. Da notare: le misure protettive di CNC e accordi e concordato non proteggono dall’escussione delle garanzie personali sui terzi: se la banca non può pignorare l’azienda X perché X è protetta, può però pignorare il fideiussore Y (salvo Y entri anch’egli in una procedura protetta per sé). Lo stesso per ipoteche su beni di terzi garanti: quelle non fanno parte del patrimonio del debitore, dunque la protezione non si estende (il CCII art.54 per l’accordo e art.8 per CNC parlano del patrimonio del debitore). Questa asimmetria è rilevante: l’imprenditore che avvia concordato e chiede misure protettive sta sì mettendo al riparo la società, ma se ha dato in pegno la casa personale per un debito sociale, quel creditore potrebbe agire sulla casa comunque (c’è giurisprudenza in merito: la Cassazione ha ritenuto legittimo che un concordato preventivo non ferma l’esecuzione su un bene dato in pegno da un terzo fideiussore). Per ovviare, servirebbe far entrare anche i garanti in procedure analoghe (es. la moglie garante in sovraindebitamento, etc.).
Opposizioni e sospensioni in via giudiziaria
Prima di arrivare a una procedura concorsuale, il debitore può cercare di difendersi nel singolo processo esecutivo o prima:
- Opposizione a decreto ingiuntivo o a precetto: Se il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, l’imprenditore può fare opposizione entro 40 giorni adducendo motivi (anche pretestuosi, volendo, ma con rischio di spese). L’opposizione trasforma il tutto in un giudizio ordinario, ritardando l’esecuzione (a meno che il decreto fosse provvisoriamente esecutivo: in tal caso l’opposizione non sospende, occorre chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva provvisoria provando un grave e fondato motivo). Questa strada è praticabile se esistono reali contestazioni sul credito (merce difettosa, interessi usurari, ecc.) o se si vuole guadagnare tempo. Spesso gli avvocati del debitore fanno opposizioni anche temerarie solo per posticipare, ma va ponderato perché se è chiaramente infondata può peggiorare i costi (interessi e spese legali).
- Conversione del pignoramento in pagamento rateale: Una volta iniziato un pignoramento, l’art. 495 c.p.c. permette al debitore esecutato di evitare l’espropriazione chiedendo di pagare a rate il dovuto. Deve depositare una somma (in genere un quinto del totale) e proporre un piano di rate (massimo 18 mesi). Se il giudice lo concede, sospende l’esecuzione. È un’arma utile specie col Fisco: ad esempio se Equitalia pignora un conto per €100k, il debitore può chiedere conversione depositando €20k e offrendo di pagare i restanti €80k in 12 rate mensili. Se il giudice accetta (sentito il creditore), il pignoramento si ferma e il debitore evita la vendita dei beni. Ovviamente serve liquidità per versare quell’acconto.
- Sospensione dell’esecuzione: Sia in opposizione all’esecuzione (se si contesta il diritto del creditore a procedere) sia in opposizione agli atti esecutivi (se c’è un vizio procedurale), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere il processo esecutivo. È concesso raramente, solo se emergono ragioni gravi (ad es., il debito è stato pagato o c’è un grave vizio di notifica).
- Accordi con il singolo creditore: Anche all’ultimo, il debitore può sempre trattare e trovare un accordo transattivo con il creditore procedente: se questi dichiara al giudice di essersi soddisfatto o di voler rinunciare all’esecuzione, il pignoramento si chiude. Quindi a volte, per bloccare un’asta immobiliare imminente, l’imprenditore può offrire un pagamento parziale immediato all’unico creditore procedente in cambio di ritiro (se ce ne sono più di uno, è più difficile perché andrebbe convinto anche eventuale creditore intervenuto). Una volta partite le aste, convincere i creditori a desistere è complicato (tengono il punto per avere massimo recupero). Ma se il debitore racimola un po’ di soldi e offre un saldo e stralcio efficace, può evitare la vendita di un bene cruciale in extremis.
- Strumenti speciali per il Fisco: Se il pignoramento è dall’Agenzia Riscossione, ottenere una rateazione anche all’ultimo momento fa decadere l’esecuzione (in virtù del DL 193/2016, se non erro, se il debitore entra in un piano di dilazione prima che il bene sia aggiudicato, la procedura esecutiva fiscale è sospesa). Ad esempio, se l’AER sta eseguendo su un immobile, e il contribuente ottiene la dilazione della cartella, l’espropriazione viene congelata (Equitalia non può procedere se c’è un piano in corso e si pagano le rate). Questo è un incentivo normativo a rateizzare piuttosto che far vendere case.
- Prima casa impignorabile dal Fisco: Vale la pena ricordare che l’Agenzia Entrate-Riscossione non può pignorare l’abitazione principale del debitore se questi non ha altri immobili e se non è di lusso (art. 76 DPR 602/1973, modificato). Ciò non difende l’azienda ma l’imprenditore persona fisica: se aveva debiti fiscali personali e quell’immobile è sua prima casa, il Fisco può ipotecarlo ma non metterlo all’asta . Questa norma tutela molte famiglie di imprenditori dal vedere la casa venduta dal Fisco. Attenzione: i creditori privati invece possono pignorare la casa principale (se in garanzia del debito). Quindi non è protezione onnicomprensiva: vale solo contro fisco/agente riscossione.
- Beni strumentali impignorabili: Il codice di procedura ha qualche tutela per i beni d’impresa: in generale, tutti i beni produttivi possono essere pignorati, però l’art. 515 c.p.c. vieta di pignorare ad esempio attrezzi o beni indispensabili all’attività oltre il limite di 1/5 (per il resto deve lasciarne). Questo però si applica all’imprenditore individuale, ed è un concetto un po’ vago (per società in teoria no, si possono pignorare anche i macchinari). Comunque il giudice dell’esecuzione potrebbe escludere dal pignoramento alcuni beni se li considera eccessivi rispetto al credito e pregiudizievoli alla continuazione, ma non c’è certezza.
- Conservare i beni col patto marciano: un’idea preventiva (non proprio difesa in esecuzione, ma rilevante) è utilizzare strumenti come il leasing o il patto marciano sui finanziamenti. La legge 119/2016 ha introdotto la possibilità che, in un contratto di finanziamento, si pattuisca che in caso di insolvenza il bene dato in garanzia (immobile o altro) passi al creditore per stima (patto marciano). Questo evita un’esecuzione giudiziale: se l’imprenditore non paga, la banca attiva il patto, prende il bene, lo fa stimare e se eccede il debito deve restituire differenza. Alcune aziende hanno utilizzato questo strumento con le banche per velocizzare la sistemazione di posizioni in sofferenza (es. consegnare l’immobile invece di subire ipoteca e asta). Non è proprio una difesa, ma una prevenzione di lunghe esecuzioni, riducendo costi e permettendo anche al debitore di chiudere con meno incognite.
- Trust o vincoli di destinazione: Sono strategie di asset protection preventiva. Se l’imprenditore prima della crisi ha costituito un trust o un fondo patrimoniale con beni (specie personali, come immobili di famiglia, o crediti), questi diventano più difficili da aggredire dai creditori aziendali, se i crediti sono successivi e non di natura familiare (nel fondo patrimoniale solo crediti per bisogni familiari possono attaccare i beni del fondo; un debito d’impresa di regola non è per bisogni fam.). Attenzione: queste operazioni se fatte quando la crisi è già in atto sono soggette a revocatoria fallimentare o ordinaria (atto in frode ai creditori). Ma se fatte in tempi non sospetti, possono preservare alcuni asset. Il rovescio della medaglia è che togliere asset dall’impresa la indebolisce (ad es. se un immobile è in trust, l’azienda non può più ipotecarlo per avere credito). Inoltre i creditori possono comunque provare a dimostrare che erano in frode (nel trust il termine di revocatoria è lungo: 2 anni se oneroso, ma se gratuito 5 anni).
- Moratorie legislative: In contesti eccezionali (come il Covid) il legislatore può sospendere i pignoramenti per un periodo. Ad es., nel 2020 si è congelata l’attività di riscossione coattiva per molti mesi. Attualmente (2025) non c’è una moratoria generalizzata, ma è un fattore: il governo può emanare decreti di sospensione per calamità o emergenze economiche che temporaneamente proteggono i debitori.
In sintesi, la difesa attiva contro le esecuzioni si basa su: – Strumenti concorsuali (CNC, concordato ecc.) che offrono stay ampio. – Azioni giudiziarie di dilazione o contestazione (opposizioni, conversione). – Accordi transattivi diretti col creditore esecutante. – Misure preventive di protezione patrimoniale (fondo patrimoniale, trust) – efficaci se fatte molto prima e in contesti leciti. – Sfruttamento delle norme speciali (es. prima casa impignorabile da Fisco, ecc).
L’imprenditore deve valutare il mix: se le esecuzioni sono ancora poche e c’è spazio, tentare opposizioni e accordi può bastare; se stanno per piovere pignoramenti da più fronti, conviene attivare subito una procedura concorsuale per congelare tutto in un colpo ed evitare il “far west” con priorità casuali.
Va ricordato infatti che se diversi creditori pignorano e arrivano a pignorare lo stesso bene (es. casa dell’imprenditore) oppure beni diversi, chi arriva prima prende (nei limiti) e magari altri restano a bocca asciutta o generano caos. La procedura concorsuale risolve con l’unica esecuzione collettiva, più equa per i creditori e di solito più efficiente (evita vendite affrettate o spezzettate). Quindi, per quanto controintuitivo, a volte lo stesso imprenditore preferisce attivare il concordato o far fallire per bloccare quell’anarchia di pignoramenti: in altre parole, “meglio un commissario/curatore che dieci ufficiali giudiziari”.
Dunque la strategia di difesa è strettamente connessa alla scelta degli strumenti di cui al capitolo precedente.
Escussione delle garanzie personali: tutela del garante/debitore
Un capitolo a parte merita il problema delle garanzie personali (fideiussioni, avalli, coobbligazioni) prestate dall’imprenditore o da terzi a favore di creditori dell’azienda.
Quando l’azienda non paga ed è insolvente, i creditori spesso si rivolgono ai garanti per recuperare. Cosa può fare il garante (spesso lo stesso imprenditore) per difendersi?
- Rinegoziare con il creditore la posizione del garante: ad esempio, in sede di accordo di ristrutturazione o di transazione, il garante può chiedere di essere liberato o di vedersi limitata l’escussione. Non tutti i creditori accettano, ma a volte è materia di trattativa. Ad esempio, un imprenditore può dire alla banca: “ti do un’ipoteca sulla casa dell’azienda se liberi la fideiussione personale di mia moglie”. Oppure in un accordo globale può inserire la clausola di rinuncia della banca ad agire contro i fideiussori a fronte di incassare la percentuale concordata. Questo va messo per iscritto e se l’accordo è omologato, vincola la banca (ovviamente verso gli aderenti).
- Sovraindebitamento o concordato personale: Se il garante viene escusso e non può pagare, può a sua volta ricorrere ai procedimenti per persone fisiche e piccoli imprenditori previsti dal CCII (ex legge 3/2012). Tre opzioni:
- Un piano di ristrutturazione del debito del consumatore (se il garante è persona fisica che ha garantito al di fuori dell’attività imprenditoriale propria, può qualificarsi consumatore magari – anche se garantire debiti aziendali non è proprio “consumo”, alcuni tribunali considerano comunque il coniuge o il socio come debitore civile per la fideiussione). In quel caso, può proporre al giudice un piano da far omologare, dove paga ad es. il 50% delle fideiussioni in 5 anni attingendo al suo stipendio, e il resto è esdebitato. Se i creditori non aderiscono serve almeno che il piano dia loro non meno del ricavabile in una sua liquidazione.
- Un concordato minore (se è un piccolo imprenditore o persona non consumatore). Simile, ma con regole un po’ diverse, comunque un accordo concorsuale con eventuali classi di creditori personali.
- La liquidazione controllata del sovraindebitato: se non ha reddito né possibilità di offrire un piano, il garante può far mettere in liquidazione i propri beni nominando un liquidatore e poi chiedere l’esdebitazione integrale. Questo è l’equivalente del fallimento personale.
- Ad esempio, Tizio ha garantito 1 milione, non può pagare, ha solo una casa e un’auto. Può proporre di vendere la casa (se non prima casa impignorabile) e con quel che c’è (diciamo 300k) dare ai creditori e chiedere esdebitazione del resto 700k. Oppure se la casa è protetta (prima casa non ipotecata), può addirittura chiedere esdebitazione senza utilità (prevista per il meritevole che proprio non ha nulla da offrire, come ultima ratio, cancellando i debiti personali residui). Il CCII è più generoso su questo rispetto al passato, per dare una chance anche ai guaranti onesti di ripartire.
- Far valere invalidità o vizi della fideiussione: Spesso le fideiussioni omnibus bancarie standard hanno clausole che Banca d’Italia in passato ha giudicato anticoncorrenziali (clausole di reviviscenza, ecc.). Molti fideiussori hanno fatto cause sostenendo la nullità parziale del contratto (ad es. nullità se plagio di schema ABI), talora ottenendo ragione e quindi vedendosi liberati. Questa è una linea di difesa giudiziaria: contestare la garanzia stessa. Non sempre funziona, ma vale esplorare con un legale specializzato. In più, se la fideiussione è prestata per oltre determinati importi, se ne può eccepire la sproporzione (ex art.1956 c.c., se banca ha aggravato rischio concedendo nuovo credito senza avvisare il fideiussore, questi non è tenuto per quelle nuove esposizioni).
- Eccezioni opponibili dal debitore principale: Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (tranne la mera incapienza o fallimento). Quindi, se l’azienda aveva motivo di contestare parte del debito, può farlo valere anche il garante in giudizio. Ad es., se il debitore principale aveva un credito compensabile con il debito, il fideiussore può eccepirlo riducendo la somma garantita.
- Garanzie reali del garante: Se il garante aveva dato ipoteca su un bene proprio, quell’ipoteca può essere aggredita. Ma se il bene è la casa coniugale in fondo patrimoniale, il creditore deve dimostrare che il debito era per bisogni familiari oppure che il coniuge ha acconsentito se era estraneo. Se era in trust, deve prima far revocare il trust. Quindi certe configurazioni danno uno scudo in più di tempo e arguibilità.
- Coordinamento con la procedura dell’azienda: Purtroppo come detto, se l’azienda fa concordato, il creditore di solito conserva i diritti verso il fideiussore. Alcuni tribunali, però, hanno concesso, in casi di concordato con continuità, la moratoria anche verso i garanti per crediti bancari assistiti da garanzia confidi. In pratica, qualche giudice ha “esteso” la disciplina concorsuale ai coobbligati qualificati, ma è eccezione. In linea generale, il garante deve fare la propria procedura (non esiste come in USA un “co-debtor stay” automatico). Una possibile astuzia: se il creditore vota a favore del concordato, implicitamente accetta la falcidia e alcuni sostengono che ciò libera pro quota il garante (teoria non pacifica, perché la fideiussione tipicamente contiene rinuncia a benefici di escussione e dice che obbligo rimane anche se principale ristruttura il debito, c.d. clausola di “sopravvivenza”). Quindi meglio non farci troppo conto.
- Richiesta di provvedimenti d’urgenza: In alcuni casi, il garante può chiedere al giudice misure cautelari per sospendere la sua escussione, soprattutto se c’è un concordato in corso che prevede il pagamento integrale del creditore e l’escussione sarebbe un abuso (ma difficilmente concessa, il creditore ha diritto).
- Azione di regresso/danni: Se il garante paga, poi ha diritto di regresso verso il debitore principale (che però spesso è in default, quindi rimane con un credito concorsuale magari). Se era un socio garante e l’azienda poi viene risanata, quel socio può farsi rimborsare ciò che ha pagato (spesso però in piani li trattano come postergati). A volte i garanti sono amministratori che possono rifarsi sui soci se c’era patto di manleva, ma queste sono questioni interne.
In definitiva, la miglior tutela del garante è giocare d’anticipo: se sa di aver garantito, può coinvolgersi attivamente nelle trattative col creditore per trovare soluzioni ed evitare di essere chiamato. E se vede che inevitabilmente sarà chiamato, preparare il terreno con una procedura di sovraindebitamento per tempo, così da coordinare i tempi (ad esempio depositare un piano del consumatore il giorno dopo l’omologa del concordato aziendale, in modo da bloccare i creditori residui quando si fionderanno su di lui). Oppure, in sede di concordato aziendale, far includere nel piano una linea di soddisfacimento per i creditori garantiti in misura tale da disincentivare l’escussione (es. se la banca recupera 80% in concordato, può anche non valere la pena inseguire il garante per 20% residuo, e magari con lui chiude con minima somma).
Garanzie personali a favore di creditori pubblici: – Nel caso di debiti tributari, i soci amministratori non sono formalmente garanti del debito fiscale della società, ma ci sono istituti simili: ad esempio la responsabilità solidale per il mancato versamento di ritenute certificate (se societa non versa le ritenute ma amministratore le ha certificate in CU, l’art. 11 D.lgs. 471/97 dice che l’amministratore è obbligato in solido con la società). Simile per l’IVA di gruppo. – L’INPS spesso notifica note di responsabilità ex art. 2394 c.c. a amministratori se il fallimento non paga i contributi e se ravvisa mala gestio. Ma quella è un’azione risarcitoria, non garanzia data prima. Quindi, il concetto di “garante” in contesto pubblico è meno contrattuale e più normativo: l’amministratore risponde in certi casi per legge. Per difendersi, l’unica è dimostrare di non aver commesso inadempimenti (es. in CU non si attestino mai ritenute non pagate!). Se la nota di responsabilità arriva, si può opporre e se ne discute in giudizio; o, se l’azienda fa concordato e paga i contributi in percentuale, vedere se l’INPS considera quell’adempimento sufficiente a non esercitare azione (non c’è certezza: se accetta la transazione contributiva e il piano va a buon fine, in genere non procedono oltre contro gli amministratori).
Tabelle di sintesi: Può aiutare inserire un’ulteriore tabella sui rimedi contro esecuzioni e garanzie:
Tabella 2: Azioni esecutive e garanzie – strumenti di tutela
| Situazione | Strumento di tutela | Note |
|---|---|---|
| Creditori esecutano beni aziendali (pignoramenti, aste) | – Deposito domanda concordato preventivo (sospende tutte le esecuzioni) <br>– Richiesta misure protettive in composizione negoziata (sospende esecuzioni per 4 mesi) <br>– Deposito ricorso omologa accordo 182-bis (istanza sospensiva) <br>– Opposizione al decreto ingiuntivo (se motivi validi) per ritardare <br>– Conversione pignoramento in rate (art.495 cpc) per guadagnare tempo <br>– Transazione singola col creditore (pagamento parziale in cambio di rinuncia all’azione) | Procedura concorsuale = blocco più ampio e garantito. Conversione ex art.495: serve depositare un acconto (≥1/5) entro prima asta. Opposizione solo se vi sono contestazioni non pretestuose (rischio spese). |
| Creditori esecutano beni personali del socio/garante | – Se bene in comunione familiare/fondo patrimoniale: eccepire l’impignorabilità (se il debito non è per bisogni fam.)<br>– Rateizzare cartelle esattoriali per sospendere pignoramento su casa (collegato a norme speciali) <br>– Concordato preventivo del garante o liquidazione controllata per bloccare esecuzioni su di lui (ad es., socio garante usa procedure sovraindebitamento: misure protettive analoghe).<br>– Trust o vincoli costituiti anni prima: resistere all’azione revocatoria eventuale (creditore dovrà provarne la malafede). | La protezione di una procedura di concordato dell’azienda non copre i patrimoni dei terzi garanti. Il garante deve attivare una sua procedura per bloccare le azioni contro di lui. Fondo patrimoniale: utile per debiti non legati all’impresa; trust: se anteriore e noto, argine forte ma revocabile se recente. |
| Fideiussione escussa (garante chiamato a pagare) | – Tentare negoziazione con creditore per definire importo minore in cambio di rinuncia ulteriore (saldo e stralcio del garante). <br>– Contestare la fideiussione (nullità antitrust delle clausole ABI; eccessiva onerosità sopravvenuta; mancato avviso ex art.1956 c.c. se aggravamento rischio).<br>– Accedere a procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione) per ristrutturare quel debito personale. <br>– Se paga: poi insinuarsi al passivo dell’azienda come creditore surrogato (se l’azienda è in concordato/fallimento) | Spesso la banca aspetta l’esito di concordato azienda e poi escute per differenza. Un accordo globale è preferibile (liberare guaranti). Sovraindebitamento: ex legge 3, ora CCII, consente al garante esdebitazione simile al concordato, quindi è la via d’uscita se il danno è troppo grande. Nullità fideiussione ABI spesso riconosciuta dai tribunali , quindi verifica utile. |
| Sequestro conservativo su beni azienda o socio | – Presentare istanza di revoca del sequestro se vengono meno i presupposti (es. offerto adeguata garanzia alternativa). <br>– Conversione in cauzione (se legge lo consente). <br>– Apertura procedura concordataria: con decreto di ammissione, misure cautelari decadono e comunque il sequestro diventa inefficace perché subentra la disciplina concorsuale che destina i beni alla massa. | Il sequestro è preludio a esecuzione, meglio prevenire con concorsuale prima che diventi pignoramento. Sequestro su conto: depositare importo cauzionale in tribunale a garanzia del credito può portare a revoca del sequestro e liberare il conto (ma blocchi comunque liquidità). |
La tavola aiuta a ricordare che l’ombrello delle procedure concorsuali è il metodo più efficiente per fermare in blocco le aggressioni, mentre i rimedi processuali individuali sono pezzetti difensivi utili ma non risolutivi se la crisi è generalizzata.
In conclusione di questa sezione, “difendersi dai creditori” non significa sfuggire illegittimamente alle proprie obbligazioni, ma utilizzare gli strumenti legali per gestire collettivamente il problema del debito, evitando la disgregazione e salvaguardando quanto più valore possibile. Un imprenditore informato non aspetta passivamente i pignoramenti, ma prende l’iniziativa: negozia quando può e, se necessario, porta i creditori al tavolo della legge (che sia un tavolo negoziale assistito o un tribunale) dove la sua situazione viene affrontata in modo ordinato, con pari dignità di tutti e secondo regole chiare.
Responsabilità dell’imprenditore e tutela del patrimonio personale
Quando un’azienda è sommersa dai debiti, inevitabilmente sorge la domanda: fino a che punto ne risponde l’imprenditore con i propri beni personali? E inoltre: l’imprenditore può incorrere in responsabilità civilistiche o addirittura penali per aver condotto l’impresa al dissesto? Questa sezione si concentra sul punto di vista del debitore persona fisica – sia esso titolare di ditta individuale, socio di società di persone, amministratore o socio di società di capitali – e su come proteggere il suo patrimonio personale e la sua libertà da azioni dei creditori e conseguenze di legge.
Affronteremo i casi tipici: – Imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile (SNC, SAS): qui giuridicamente non c’è separazione patrimoniale – i creditori aziendali possono aggredire direttamente i beni personali del debitore. Che fare? – Socio di SRL/SPA o amministratore di società di capitali: qui vige la “responsabilità limitata” della società, ma esistono eccezioni e situazioni in cui il patrimonio personale è comunque a rischio (es. garanzie personali prestate, prelievi indebiti soggetti a revocatoria, azioni di responsabilità per gestione scorretta). – Responsabilità per debiti fiscali e contributivi: specificità per cui i rappresentanti legali possono essere chiamati in causa con obblighi personali o sanzioni (es. sanzioni tributarie, reati). – Conseguenze penali legate al dissesto: i reati fallimentari (bancarotta, preferenziale) e come evitarli con condotte corrette. – Esdebitazione dell’imprenditore una volta finita la crisi o la procedura liquidatoria: come liberarsi dei debiti residui e ripartire pulito (fresh start).
Patrimoni confusi: ditta individuale e soci illimitatamente responsabili
Se l’azienda non ha personalità giuridica distinta (impresa individuale, società di persone), tutti i debiti d’impresa sono debiti personali dell’imprenditore o dei soci. Questo implica: – Un creditore aziendale può indifferentemente pignorare un macchinario dell’officina o il conto corrente personale dell’imprenditore o la sua auto privata. Non c’è distinzione, salvo il già citato fondo patrimoniale per i bisogni di famiglia o simili. – In procedure concorsuali, un imprenditore individuale insolvente viene sottoposto a liquidazione giudiziale (fallimento) e il suo intero patrimonio (azienda + beni privati) va nella massa attiva concorsuale . Per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, la legge prevede il fallimento in estensione dei soci assieme alla società (art. 147 L.F., ora nel CCII all’art.256 e seguenti): quindi se SNC fallisce, falliscono ipso iure anche i soci con il loro patrimonio personale, a meno che i creditori sociali siano già pagati. – Questo scenario è ovviamente drammatico per l’imprenditore perché rischia di perdere anche la casa, i risparmi di famiglia, ecc.
Come può tutelarsi un imprenditore individuale? – Adottare tempestivamente una forma giuridica a responsabilità limitata: Ad esempio, trasformare l’impresa individuale in una SRL unipersonale. Dal momento della trasformazione, i nuovi debiti contratti dalla SRL sono separati. Attenzione però: la trasformazione non libera dai debiti pregressi (quelli restano a carico dell’imprenditore, a meno di accollo da parte della SRL, ma comunque i creditori potrebbero non liberarlo se non pagati). Inoltre, se la trasformazione avviene in stato di insolvenza conclamata, può essere considerata un atto in frode (perché sposta patrimonio e mira a isolare i creditori – in tali casi i creditori possono chiedere la revocatoria dell’atto di conferimento o magari l’amministratore rischia responsabilità per abuso di forma giuridica). Tuttavia, in situazioni ancora salvabili, molti consigliano di “mettere l’ombrello” costituendo una SRL per il proseguo delle attività, isolando i futuri rischi. – Utilizzare il Sovraindebitamento: Oggi l’imprenditore individuale sotto soglia di fallibilità (ricavi sotto €200k, debiti <500k) può accedere alle procedure per sovraindebitati (concordato minore, ecc.). Questo gli consente di ristrutturare o liquidare i debiti personali in maniera simile a una società, ottenendo l’esdebitazione finale. In pratica è un “fallimento di piccola taglia” ma con una visione più di recupero. Un vantaggio: anche un ex imprenditore (che ha chiuso l’attività) può fare un piano del consumatore per i residui debiti rimasti, presentandosi come consumatore se oramai non ha più l’azienda. – Concordato preventivo per imprenditore individuale: Un imprenditore individuale fallibile (sopra soglie) può chiedere il concordato come farebbe una società. In tal caso tutta la massa attiva (compresi beni personali) sono considerati nel piano, e se il concordato va in porto, l’imprenditore si esdebita per legge dai debiti residui . Questo è uno strumento potentissimo: ad esempio un piccolo imprenditore agricolo (non fallibile) è rientrato nelle nuove norme e può chiedere il concordato minore. Insomma, oggi come oggi, nessuno è senza strumenti: o è fallibile e usa concordato classico, o non fallibile e usa concordato minore/sovraind. – Patrimoni destinati: Il codice civile prevede la possibilità (art. 2447-bis e segg.) per le società di capitali di creare patrimoni destinati ad uno specifico affare. Anche un imprenditore individuale commerciale può costituire un patrimonio destinato (art. 2447-decies c.c. prevede per imprenditori individuali la destinazione di beni immobili o mobili registrati a uno specifico finanziamento). Tali strumenti isolano un po’ i rischi, ma sono raramente usati e complessi. Ad esempio, un imprenditore potrebbe destinare un immobile ad un affare con un finanziatore: in caso di default di quell’affare, il creditore può soddisfarsi solo su quell’immobile e non sul resto. Tuttavia, se i debiti sono già sorti, non si può vincolare postumo un bene con efficacia sui creditori esistenti (sarebbe revocabile). – Separazione tra patrimonio familiare e d’impresa: L’uso del fondo patrimoniale (art.167 c.c.) è un istituto tipico: un imprenditore può conferire la casa e altri beni nel fondo per proteggere la famiglia. I creditori per debiti non contratti per bisogni familiari non possono pignorare quei beni . Purtroppo la giurisprudenza in passato spesso ha considerato i debiti d’impresa non per bisogni di famiglia (a meno che i proventi servissero al mantenimento familiare). Quindi la casa in fondo patrimoniale di un imprenditore può essere relativamente al sicuro dai creditori commerciali. Nota: però in un eventuale fallimento del soggetto, la giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. 21963/2013) ha detto che il fondo patrimoniale non esclude i beni dal fallimento, se i creditori concorsuali sono anteriori alla costituzione del fondo e se quei crediti non erano per scopi familiari. Però, un credito commerciale tipicamente non è per scopi familiari, quindi i creditori concorsuali non dovrebbero toccare i beni del fondo. È un’area un po’ grigia; in pratica, se il fondo è stato costituito prima e i crediti sorgono dopo, i creditori non potranno escutere quei beni, e se l’imprenditore fallisce, il curatore potrà cercare di revocare la costituzione del fondo (entro 2 anni se a titolo gratuito) . Insomma, come protezione preventiva per i familiari può aiutare, ma se fatto tardi è contestabile. – Assicurazione del responsabile d’impresa: Esistono polizze di Directors & Officers (D&O) e simili, ma queste di solito coprono i danni derivanti da atti illeciti involontari degli amministratori. Non coprono i debiti aziendali. Possono però intervenire se c’è un’azione di responsabilità e viene accertato un danno civilistico causato dall’amministratore: l’assicurazione indennizza quel danno ai creditori. Non è proprio protezione del patrimonio, ma scarica il rischio su una compagnia. Un imprenditore prudente spesso fa polizze RC professionale, RC prodotto, etc., per mitigare eventuali cause di risarcimento (che sono debiti pecuniari). – Beneficio di escussione: Nelle società di persone c’è una minima protezione: i creditori sociali devono prima escutere il patrimonio sociale, poi se insufficiente passare ai soci (beneficio d’escussione). Tuttavia, se la società è insolvente, quell’azione sul patrimonio sociale c’è già e poi i soci rispondono. In pratica, i soci non possono dire “prima fallite la società e poi me”: in effetti succede proprio così – la società viene dichiarata insolvente (liquidazione concorsuale) e contestualmente anche i soci, se incapiente, vengono dichiarati falliti. Quindi protezione minima.
In conclusione, per chi ha impresa con responsabilità illimitata, l’unica vera barriera è costituire una società di capitali (SRL, SPA) in tempo utile, trasferendovi l’attività e lasciando i debiti nella vecchia struttura, che dovrà poi essere chiusa con un accordo (o portata in fallimento se inevitabile). Spesso si vede: l’imprenditore individuale crea una nuova SRL operativa e tiene la ditta individuale come guscio dove raduna i debiti passati; con i creditori di quest’ultima negozia un saldo o subisce eventuale liquidazione, ma intanto la nuova SRL porta avanti il business senza venire coinvolta giuridicamente. Occhio però alle possibili azioni revocatorie: se l’imprenditore trasferisce asset (macchinari, magazzino, avviamento) dalla ditta individuale alla SRL a fronte di corrispettivo non adeguato o in stato di insolvenza, i creditori potranno cercare di far dichiarare quell’atto inefficace (revocatoria ordinaria entro 5 anni, fallimentare entro 2 anni). La SRL potrebbe essere costretta a restituire i beni o il loro valore. Quindi l’operazione va fatta a valori di mercato e non in frode. Magari vendere asset alla SRL per prezzo congruo (che va a pagare parte dei debiti, mostrando buona fede). O costituire la SRL e poi fare un concordato della ditta cedendo gli asset alla SRL come parte del piano con approvazione creditori (in tal caso blindato da omologa). Insomma, farlo in trasparenza.
Soci e amministratori di SRL/SPA: responsabilità patrimoniale
In società di capitali (SRL, SPA, SAPA), di regola i soci non rispondono delle obbligazioni sociali (art. 2462 cc per SRL: “per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio”, i soci perdono al massimo il capitale investito). Gli amministratori e organi di controllo non rispondono verso i creditori sociali, salvo caso particolare dell’azione di responsabilità (art. 2394 cc, vedi dopo). Questo principio è base ma con importanti eccezioni: – Fideiussioni e coobbligazioni volontarie: come già trattato, spesso le banche o fornitori chiedono ai soci (specie nelle SRL piccole) di garantire personalmente. Oppure i soci firmano cambiali, avalli, etc. In tal caso, limitata o no, il socio diventa obbligato personale. È prassi comune: la SRL è “col responsabile”, ma di fatto i creditori chiave sanno di poter rifarsi sul patrimonio del titolare. Quindi la protezione effettiva di “limitata” viene erosa dall’aver dato garanzie. – Finanziamenti soci postergati: se i soci hanno finanziato la società in modo anomalo (in SRL e SPA, i finanziamenti soci fatti quando la società era sottocapitalizzata o in crisi sono postergati di legge, art. 2467 c.c.), significa che in caso di liquidazione o concordato, i soci saranno pagati solo dopo tutti gli altri creditori . Quindi non possono pretendere indietro i loro crediti fino a soddisfazione integrale degli altri. Questo non è una responsabilità diretta, ma i soci in questi casi perdono i soldi investiti come prestito e non possono neanche competere con gli altri creditori. – Azioni di responsabilità verso amministratori: se la società fallisce o va in liquidazione concorsuale, il curatore o i creditori possono agire contro gli amministratori accusandoli di atti di mala gestio che hanno aggravato il dissesto o depauperato il patrimonio (ex art. 255 CCII, ex art. 146 L.F. unita all’art. 2394 c.c.). Ad esempio, la Cassazione n. 24006/2025 ha visto proprio un caso dove i coeredi di un amministratore defunto sono stati condannati a risarcire i danni ai creditori per l’operato del de cuius . Ciò significa che gli amministratori (anche non soci) possono vedersi aggrediti i beni personali per pagare i creditori, se un giudice accerta che per colpa loro il patrimonio sociale è insufficiente. Tipicamente, i casi sono: continuazione dell’attività in perdita erodendo capitale (danno da wrongful trading), pagamento preferenziale ad alcuni creditori (danno ai creditori rimasti), omessa richiesta tempestiva del fallimento provocando aggravamento del passivo , mancata vigilanza dei sindaci su atti distrattivi (a loro volta sindaci responsabili, Cass. 31753/2024 citata in fonte Unijuris ). Se l’azione ha successo, l’ex amministratore deve risarcire – e quell’importo rientra nella massa fallimentare per pagare creditori. Questo è uno strumento potente per i creditori: ad esempio, se la società ha dissipato risorse, il curatore chiede al tribunale di condannare l’amministratore a rifonderle (quantum = differenza tra deficit effettivo e deficit che ci sarebbe stato con condotta diligente). Spesso questi procedimenti si concludono con transazioni (l’assicurazione D&O paga parte). – Responsabilità fiscale personale: Es. l’omesso versamento IVA oltre soglia è reato penale, ma anche in sede esattoriale, l’amministratore può avere sanzioni amministrative pecuniarie personali. Inoltre, in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate può aggredire i soci se ha elementi di abuso di personalità (è raro: art. 2495 cc prevede che se la società viene cancellata e non paga tributi, i soci sono responsabili pro quota delle imposte non assolte nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Quindi se i soci hanno chiuso la società senza pagare le tasse ma si sono ripresi soldi residui, l’Agenzia li rincorre su quell’importo). – Reati fallimentari: Se c’è fallimento, gli amministratori possono essere incriminati per bancarotta fraudolenta se hanno distratto beni sociali, tenuto conti falsi, aggravato il dissesto in dolo, favorito creditori in pregiudizio di altri. La condanna penale spesso include risarcimento danni e confisca dei beni personali equivalenti all’attivo distratto. Perciò, un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta perché ha fatto sparire €500k di beni, può vedersi confiscare €500k dal suo patrimonio (anche se non li ha più, viene messa ipoteca sui suoi immobili etc.). È un modo indiretto con cui i creditori potrebbero essere ristorati (lo Stato confisca e poi c’è la curatela che chiede quei soldi per la massa, in teoria). In ogni caso, è una conseguenza che impatta sulla sfera personale. La bancarotta preferenziale (pagamenti preferenziali fatti prima del fallimento) è reato minore ma c’è: prevede anche lì pene e possibili confische. E la bancarotta semplice punisce l’imprenditore che per colpa ha aggravato il dissesto (non è penale grave, sanzioni più leggere, ma sempre un record). Va detto che se l’imprenditore evita il fallimento con un concordato, non c’è bancarotta; tuttavia, esiste un reato di “mancata esecuzione dolosa di concordato” se dopo l’omologa non esegue volontariamente gli obblighi (art. 236 L.F. vecchio, oggi art. 344 CCII). Comunque, chi vuole evitare l’onta penale, deve comportarsi correttamente: – Non distrarre beni: se vende auto aziendale, farlo a prezzo di mercato e far entrare i soldi in cassa (altrimenti sembra sottrazione). – Non falsificare bilanci o libri: anzi tenerli in ordine e a disposizione (la bancarotta documentale punisce chi tiene conti in modo da non far capire nulla). – Non pagare “di nascosto” i creditori amici lasciando a zero la cassa per gli altri (preferenziale). – Non aggravare il buco oltre il necessario (es. continuare a ordinare forniture quando sai che non pagherai e finirai male, e intanto vendi sottocosto per fare cassa immediata: può essere bancarotta preferenziale o per dissipazione).
In altre parole, quando sente puzza di insolvenza, l’amministratore dovrebbe cristallizzare la situazione e cercare procedure protette. Il CCII impone all’organo amministrativo di attivarsi con adeguati assetti e reagire ai segnali di crisi . Se non lo fa ed entra in insolvenza, sarà facile imputargli una colpa grave.
Focus: azione di responsabilità vs soci e terzi: – Oltre che amministratori e sindaci, anche i soci di SRL possono eccezionalmente rispondere oltre il capitale: art. 2476 comma 7 c.c. consente ai creditori sociali di agire contro i soci di SRL che abbiano deciso o autorizzato con loro deliberazioni atti di mala gestione causando danno ai creditori (es. i soci impongono agli amministratori distribuzioni indebite di utili o acquisti futili). È norma poco applicata ma esiste. – Il curatore può anche fare causa a terzi complici di bancarotta: es. se un cliente ha simulato un credito o accordo per favorire la distrazione di soldi dall’azienda, può essere corresponsabile (penalmente e civilmente). – Può anche citare la società controllante per abuso di direzione e coordinamento (ex art.2497 c.c. se ha leso la solvibilità della controllata in interesse di gruppo, i creditori possono rivalersi sulla capogruppo). – Esempio: Cassazione 8/01/2025 n.348 (vista prima) delimita la continuità, ma incidentalmente cita temi di direzione e coordinamento: se la capogruppo sacrifica la figlia portandola al collasso, la capogruppo deve risarcire i creditori della figlia.
Dunque come tutela il suo patrimonio l’imprenditore-socio SRL? – Innanzitutto non confondere conti personali e aziendali: i prelievi “alla carlona” di cassa sociale per scopi privati sono facilmente attaccabili come atti di mala gestio (bancarotta per distrazione se fallisce). Meglio prendersi remunerazioni ufficiali (stipendi, dividendi se utili). – Rispettare capitalizzazione minima: se la società ha perso capitale, rifinanziarla come equity (capitale) e non come prestito. Se fai prestito, rischi postergazione e potenziale responsabilità (perché hai fittiziamente aggravato indebitamento invece di ricapitalizzare). – Decidere in modo informato e prudente: se la crisi c’è, far risultare in verbali dei soci e del CDA che ci si sta attivando: ciò può proteggere da accuse di inerzia. – Oculatezza in movimenti patrimoniali: se il socio sa di avere la casa libera e teme la rovina, può valutare passaggi a moglie o figli a titolo oneroso reale (vendita) prima che sia tardi, ma deve farlo molto prima e genuinamente. Altrimenti, revocatoria sicura se entro 2 anni fallimento (atto a titolo gratuito entro 2 anni o oneroso con consapevolezza pregiudizio entro 1 anno) . Va da sé: vendere casa a coniuge per 1 euro un mese prima di fallire è bancarotta fraudolenta (distrazione). Se venduta a prezzo di mercato anni prima e speso soldi per bisogni, forse la fa franca. Insomma, prevenzione remota è chiave. – Assicurarsi: come detto, una polizza D&O è buona prassi. Non salva da tutto, ad es. dolo e mala fede di solito sono esclusi, però per colpa o negligenze copre. Almeno gli avvocati te li paga la compagnia in caso di azione di responsabilità. – Attivare procedure concorsuali all’occorrenza: far da soli con espedienti rischia condanne. Meglio affidarsi al concordato, dove l’organo giudiziario di controllo riduce il rischio di deviare e incorrere in reato. Infatti, se il tribunale autorizza un atto (es. vendere un macchinario durante il concordato) quell’atto non sarà contestato come distrazione. – Esdebitazione personale: se nonostante tutto il socio finisce fallito, ha diritto (se onesto e cooperativo) all’esdebitazione una volta chiusa la procedura (art. 282 CCII: passati 3 anni dalla chiusura liquidazione giudiziale e soddisfatti certi requisiti, ottiene la liberazione dei debiti residui non pagati) . Quindi il fallito persona fisica oggi sa che non rimarrà “ergastolano del debito”: se collabora e non ha commesso irregolarità gravi, uscirà senza debiti. Questa è una tutela importante per il futuro. Anche il sovraindebitato che fa liquidazione del patrimonio ottiene esdebitazione di regola subito dopo riparto finale (anche senza attesa 3 anni, CCII è più rapido per loro). – Reintegrazione del patrimonio per usi familiari: se l’imprenditore ha risorse protette (es. TFR, pensione) in quanto crediti personali impignorabili al di là di un certo minimo, deve saperlo: il TFR è impignorabile per il 50% e la pensione per la parte minima. Quindi non tutto può essergli portato via. Pianificare su questo: ad esempio, nel concordato personale il giudice non può obbligarlo a destinare la pensione minima ai creditori. Così come prima casa non ipotecata resta a lui se fisco non può agire. In base a ciò, ci sono margini di conservazione di beni essenziali.
In sintesi, responsabilità patrimoniale dell’imprenditore varia a seconda della forma giuridica e delle azioni compiute. Il miglior consiglio: – Usare la responsabilità limitata dove opportuno, – non indebolirla con comportamenti contrari (fideiussioni sconsiderate, confusione beni, sottocapitalizzazione deliberata), – adottare condotte diligenti e trasparenti per evitare responsabilità extracontrattuali, – e in caso di crisi irreversibile, seguire le strade offerte dalla legge (concordati, liquidazioni concordate) piuttosto che lasciare un cumulo di debiti che poi inseguono a vita.
Infine, non bisogna dimenticare l’aspetto psicologico e di reputazione: un imprenditore che gestisce attivamente e legalmente la crisi (ad esempio avviando un concordato, trattando con creditori, pagando per quanto può i dipendenti, ecc.) manterrà molta più credibilità e probabilmente potrà in futuro ripartire, magari con una nuova iniziativa, anche coinvolgendo alcuni creditori che hanno apprezzato la correttezza. Al contrario, chi scappa lasciando macerie, o nasconde soldi all’estero mentre fallisce, può subire interdizioni (l’interdizione dall’esercizio d’impresa per anni in caso di bancarotta fraudolenta) e comunque brucia ponti col sistema creditizio e imprenditoriale.
Tabelle e schemi: – Potremmo presentare un schema di responsabilità:
Tabella 3: Tipi di impresa vs responsabilità del debitore
| Forma giuridica | Chi risponde dei debiti? | Strumenti di protezione |
|---|---|---|
| Ditta individuale | Imprenditore con tutti i suoi beni presenti e futuri (illimitatamente) | – Fondo patrimoniale per beni familiari (no debiti impresa) <br>– Trasformazione in SRL/azienda individuale (pre-crisi) <br>– Concordato/sovraindebitamento per limitare importo dovuto (esdebitazione finale) |
| Società SNC, SAS (soci illimitati) | Società con il suo patrimonio <br>+ soci illimitatamente con tutto il loro patrimonio (in solido) | – Beneficio escussione (creditore deve prima aggredire società) <br>– Patti tra soci di compensazione (non opponibili ai creditori) <br>– Come sopra: strumenti concorsuali anche per soci (fallimento in estensione, poi esdebitazione) |
| SRL, SPA | Società con suo patrimonio; soci non responsabili oltre quota conferita. <br>Amministratori: no responsabilità diretta per debiti, MA vedi casi di mala gestio. | – Evitare garanzie personali (limitare fideiussioni) <br>– Adeguata patrimonializzazione (evita azioni 2394 cc) <br>– D&O insurance per organi <br>– Gestione prudente (evita cause di responsabilità e reati) <br>– In caso di insolvenza, concordato vs fallimento (no bancarotta se concordato) |
| SAS (accomandanti) | Accomandatari illimitatamente; accomandanti limitatamente (per quota conferita, salvo abbiano ingerito gestione). | – Accomandanti devono astenersi da atti di gestione per non perdere beneficio di limitazione. <br>– Altrimenti sono trattati come illimitati. |
| Società cooperativa | Come SRL/SPA: soci limitatamente (perdono capitale sottoscritto). Organi secondo regole SRL/SPA. | – (Analogo a SRL/SPA) |
| Gruppo di imprese (holding controllante e controllate) | Ogni società risponde dei propri debiti. Possibile azione verso holding se abusato direzione unitaria (art. 2497 cc). Soci holding di norma limitatamente. | – Holding dovrebbe evitare di drenare risorse da controllate in crisi senza compensarle (per evitare responsabilità). <br>– Procedura di gruppo (concordato/accordo di gruppo) per soluzione unitaria e prevenire cause incrociate. |
- Per i reati di bancarotta si potrebbe fare uno specchietto ma forse è troppo penalistico. Basti averne parlato.
Conclusione sezione responsabilità
Per concludere, il punto di vista del debitore nell’affrontare i debiti non può prescindere da un’analisi franca delle proprie responsabilità. In Italia l’imprenditore ha una serie di obblighi (civilistici e penal-tributari) verso i creditori e la collettività. Difendersi dai debiti non significa eluderli con trucchetti oltre il limite della legalità – quello porta a sanzioni peggiori – ma significa attuare le strategie consentite per ridurre l’impatto (limitare la responsabilità tramite forme societarie, attivare procedure concorsuali per tagliare debiti, negoziare falcidie, e così via) e allo stesso tempo evitare condotte illecite.
Se l’imprenditore agisce con correttezza e trasparenza, le norme stesse gli forniscono opportunità di salvarsi: dalla limitazione di responsabilità patrimoniale, all’esdebitazione finale. Viceversa, chi froda i creditori o dissipa beni sociali troverà la legge molto severa nel colpirlo personalmente .
In particolare, oggi il Codice della Crisi spinge il concetto di “responsabilità anticipata”: l’amministratore deve attivarsi prima che l’insolvenza degeneri, attraverso adeguati assetti interni e l’uso tempestivo degli strumenti di regolazione . Farlo non solo migliora le chance di salvare l’impresa, ma tutela l’organo gestorio dalle accuse di negligenza grave.
Come recita un motto spesso citato nei convegni di diritto fallimentare: “il fallimento punisce chi dorme”. Cioè, l’imprenditore dormiente che lascia accumulare debiti verrà punito – dai creditori, dal mercato e in certi casi dalla legge; quello vigile che affronta la crisi di petto può sperare di uscirne con onore e con il necessario perdono dei debiti residui.
Dopo questo approfondito esame tecnico-giuridico, per concludere la nostra guida proporremo ora alcune domande frequenti e risposte rapide per riepilogare in modo divulgativo i concetti chiave, seguite da esempi pratici integrativi.
Domande frequenti (FAQ)
D1: La mia azienda (SRL) non riesce più a pagare tutti i debiti: rischio il fallimento?
R: Se la tua società è insolvente (incapace di pagare regolarmente debiti scaduti), qualunque creditore con almeno €30.000 di credito scaduto può chiederne la liquidazione giudiziale (ex fallimento) . Per evitare questo scenario, puoi muoverti tu attivando strumenti come il concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione: presentando un piano ai creditori o al tribunale, la procedura fallimentare viene sospesa e hai la possibilità di evitare la chiusura disordinata . Se invece l’azienda non è formalmente insolvente ma in crisi, non rischia il fallimento immediato, ma è meglio agire presto (es. con la Composizione Negoziata della Crisi) per non arrivare al punto di non ritorno.
D2: Ho debiti con il Fisco (IVA, tasse) per la mia SRL: posso trattare un taglio di questi debiti?
R: Sì, attraverso la Transazione Fiscale. Nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato, puoi proporre all’Agenzia delle Entrate di accettare un pagamento parziale e/o dilazionato delle imposte dovute . Ad esempio, potresti offrire di pagare il 50% dell’IVA in 5 anni. L’adesione dell’Erario è soggetta a valutazione, ma se la proposta è conveniente (lo Stato prende almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione fallimentare) può essere approvata . Se l’Erario rifiuta ma la maggioranza degli altri creditori è favorevole, il tribunale può comunque omologare forzosamente il piano (cram-down fiscale) a certe condizioni . Fuori da procedure concorsuali, l’unica via per ridurre carichi fiscali è approfittare di eventuali rottamazioni previste per legge (che però di solito aboliscono sanzioni e interessi, non il tributo base). Puoi anche rateizzare i debiti fiscali ordinariamente (fino a 10 anni dal 2025) , ma quello è solo differimento, non taglio dell’importo.
D3: Le banche mi hanno chiesto la fideiussione personale per i debiti della società: se la società non paga, possono prendersi casa mia?
R: Purtroppo sì, se hai firmato garanzie personali come fideiussioni o ipoteche su beni tuoi a favore della banca, quella è un’obbligazione autonoma: in caso di insolvenza dell’azienda, la banca potrà escutere te e i tuoi beni (es. pignorando la casa, salvo sia prima casa non ipotecata dal Fisco) . Firmare la fideiussione significa mettere in gioco il tuo patrimonio. Tuttavia, se riesci a includere la banca in un piano di ristrutturazione dove la società paga una parte del debito, puoi negoziare che la banca rinunci a rivalersi su di te per la parte stralciata (rinuncia che va espressa). Se invece la società va in concordato o fallimento e la banca recupera solo un pezzetto del suo credito, legalmente potrà chiederti il resto. In tal caso, se non puoi pagare, dovrai valutare le procedure di sovraindebitamento personali (piano del consumatore o liquidazione) per gestire quei debiti residui e proteggere i beni essenziali. Ricorda: la prima casa è impignorabile dall’Agente Riscossione per debiti tributari , ma non dalle banche; però se la banca ha ipoteca, potrà procedere comunque. L’unico limite è se la banca ha una fideiussione “standard ABI” con clausole nulle (ci sono stati casi in cui alcune fideiussioni bancarie sono state dichiarate nulle): consulta un legale per verificare, perché potresti sollevare eccezioni e guadagnare tempo o annullare la garanzia.
D4: Ho fornitori che mi tempestano di decreti ingiuntivi e minacciano pignoramenti: come posso fermarli?
R: La soluzione più efficace è attivare una procedura concorsuale che automaticamente sospende tutte le azioni esecutive. Ad esempio, se presenti domanda di concordato preventivo e vieni ammesso, nessun fornitore potrà avviare o proseguire pignoramenti . Stessa cosa se entri in composizione negoziata della crisi con misure protettive concesse dal tribunale . In alternativa, puoi tentare rimedi processuali: fare opposizione ai decreti ingiuntivi (se hai motivi di contestazione) per allungare i tempi; oppure, se un pignoramento è iniziato, chiedere la conversione (pagando un acconto e rateizzando il resto, l’esecuzione viene sospesa). Ma queste sono tattiche temporanee. Un accordo volontario con i fornitori, se ne convinci la maggior parte, è l’ideale: ad esempio, potresti proporre un piano di rientro in 6-12 mesi, magari assistito da un piano attestato di risanamento per dare loro fiducia sulla fattibilità . Se i fornitori chiave accettano e sospendono le azioni legali, puoi respirare. Ricorda che se uno volesse comunque agire e pignorare, l’unico modo per bloccarlo coattivamente è attraverso un’ordinanza del tribunale in sede concorsuale.
D5: Che differenza c’è tra piano attestato di risanamento e concordato preventivo?
R: Sono entrambi strumenti per gestire la crisi, ma molto diversi: – Il Piano Attestato di Risanamento è un accordo privato con i creditori, basato su un piano di risanamento validato da un esperto indipendente . Non interviene il tribunale (se non per eventuale pubblicazione). Non tutti i creditori devono aderire, ma solo quelli con cui trovi l’intesa; gli altri restano fuori e, attenzione, possono comunque agire per conto loro (il piano non li vincola né li blocca). Il suo vantaggio è la riservatezza e la flessibilità, e se correttamente eseguito gli atti fatti secondo piano non saranno revocabili in caso di fallimento successivo . È indicato se hai un numero limitato di creditori disponibili a collaborare. – Il Concordato Preventivo è una vera procedura concorsuale giudiziale: coinvolge tutti i creditori, va approvato da essi a maggioranza e omologato da un giudice. Una volta omologato, è vincolante per tutti (anche per chi era contrario) e cancella i debiti residui . Offre protezione legale immediata (stay delle azioni esecutive) e consente di imporre anche sacrifici ai privilegiati col loro consenso o via cram-down. Però è pubblico, complesso e richiede il voto dei creditori. In sintesi, il concordato lo usi quando devi per forza coinvolgere tutti i creditori e bloccarli, il piano attestato quando puoi risolvere in modo mirato e hai il consenso spontaneo della gran parte di loro . Spesso si tenta prima la via stragiudiziale (piano attestato) e se fallisce si ripiega sul concordato.
D6: La mia srl è in crisi ma vorrei continuare l’attività se possibile, salvando l’azienda: quale procedura me lo permette?
R: Il Concordato Preventivo in Continuità è pensato proprio per questo: ti consente di ristrutturare i debiti mantenendo in vita l’impresa, sotto la tua gestione o eventualmente trasferendola a un investitore . Nel concordato in continuità diretta, continui a operare durante la procedura e anche dopo, utilizzando i ricavi futuri per pagare i creditori secondo il piano (magari parzialmente e dilazionato). La legge tutela la continuità perché è nell’interesse generale (salvi posti di lavoro, conservi valore d’avviamento). Ci sono anche agevolazioni, ad esempio: puoi chiedere di scioglierti da contratti onerosi che pesano sul bilancio, con l’autorizzazione del tribunale; puoi ottenere nuova finanza prededucibile (che verrà rimborsata con priorità) per sostenere l’attività ; e c’è la possibilità di “forzare” l’approvazione anche se qualche classe di creditori vota contro, purché il piano sia equo . In pratica, presenti un piano industriale di rilancio con taglio del debito e continui l’attività protetto dai creditori. Ovviamente devi dimostrare che l’azienda, alleggerita dai debiti, torna sostenibile. Un’alternativa, se la situazione non richiede il tribunale, è la Composizione Negoziata: anche quella è pro-continuity, perché l’esperto ti aiuta a trovare accordi con creditori senza interrompere l’attività . Molte imprese hanno evitato il fallimento con la composizione negoziata mantenendo la continuità (nel 2024, 38 imprese solo in Lombardia, salvando 2100 posti di lavoro) . Quindi, per salvare l’azienda scegli procedure di ristrutturazione, non quelle liquidatorie: concordato in continuità se necessaria, accordo 182-bis se hai 60% creditori d’accordo, oppure composizione negoziata se vuoi tentare un percorso “morbido”. Al contrario, il concordato liquidatorio o il fallimento significherebbero la fine dell’attività (vendita pezzi e chiusura).
D7: Qual è la soglia di debito per cui un creditore può portare l’azienda al fallimento?
R: La soglia è €30.000 di debiti scaduti e non pagati. Il Codice della Crisi (art. 121 CCII) prevede che il tribunale non dichiari la liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti non pagati risulta inferiore a 30.000€ . Questo per evitare fallimenti “bagatellari”. Attenzione: è il totale dei debiti scaduti non pagati, non per singolo creditore. Quindi se hai 10 fornitori da 5.000€ ciascuno impagati, il totale è 50.000 e sfori la soglia (potenzialmente fallibile). Viceversa, se il debito scaduto è 20.000€, nessun creditore può ottenere il fallimento (dovrebbe aspettare finché superi 30k). Nei concordati minori e procedure di sovraindebitamento per imprenditori minori c’è una soglia diversa? In realtà quella soglia è per il fallimento. Un piccolo imprenditore sotto parametri di legge non è neanche fallibile a prescindere; per quelli fallibili la soglia 30k vale. Tieni presente però: la soglia evita il fallimento su istanza esterna, ma se l’impresa è insolvente e debiti 25k, comunque non paga, i creditori possono fare pignoramenti, e se la situazione è senza sbocco potresti tu stesso decidere di liquidare la società (magari in via stragiudiziale).
D8: In una SRL, posso essere chiamato a rispondere con i miei beni personali per i debiti sociali?
R: Di regola no, i soci non rispondono dei debiti della SRL oltre la quota conferita . Ci sono però tre situazioni da considerare: 1. Garanzie personali prestate: se hai firmato fideiussioni, assegni post-datati, cambiali, o hai fatto da coobbligato, allora ti sei volontariamente impegnato e i creditori potranno aggredire i tuoi beni per quelle obbligazioni (indipendentemente dalla SRL). 2. Azioni di responsabilità per mala gestio: se sei anche amministratore (o lo è un socio di riferimento) e hai gestito la società in modo colposo o doloso causando un danno ai creditori (ad es. hai aggravato il dissesto pagando preferibilmente società collegate, o hai fatto sparire attivi), il curatore o i creditori possono chiedere al giudice di condannarti a risarcire quel danno . In pratica, diventi debitore verso la massa per importi anche ingenti. 3. Debiti tributari o verso dipendenti: in alcuni casi particolari, l’amministratore di SRL risponde in proprio. Ad es., se la SRL non versa le ritenute previdenziali trattenute in busta paga, l’INPS può richiedere il pagamento al legale rappresentante (responsabilità solidale). O se la SRL non versa l’IVA e commette reato, l’amministratore può avere sanzioni penali che comportano confisca di equivalenti beni personali. Fuori da questi casi, i tuoi beni personali sono al sicuro: un fornitore o banca senza tua garanzia non può aggredire direttamente casa tua per un debito della SRL. Nemmeno il tribunale può toccare i patrimoni dei soci in un concordato o fallimento della società (a meno che, ripeto, emerga un illecito). È proprio il vantaggio della SRL. Ma attenzione a non abusare della limitazione: se ad esempio svuoti la SRL e lasci debiti, per poi aprirne un’altra, i creditori della vecchia potrebbero tentare un’azione di abuso di personalità giuridica (non facile, ma in casi estremi la giurisprudenza ha “superato lo schermo sociale” punendo soci scorretti).
D9: Cos’è la Composizione Negoziata della Crisi e conviene usarla?
R: È uno strumento nuovo introdotto a fine 2021, in cui chiedi aiuto a un esperto indipendente per negoziare con i tuoi creditori, in modo riservato e senza aprire una procedura concorsuale formale . In pratica, fai istanza su una piattaforma delle Camere di Commercio, ti assegnano un esperto (commercialista, avvocato o manager esperto di crisi) e insieme a lui analizzi la situazione e convochi i creditori chiave per trovare soluzioni concordate (dilazioni, accordi sul debito, ricerca di nuovi investitori, ecc.). La procedura dura pochi mesi ed è volontaria. Puoi chiedere al tribunale di proteggerti intanto dalle azioni esecutive (misure protettive) . Conviene se la tua crisi è ancora gestibile con il dialogo e vuoi evitare di “far rumore” con un concordato pubblico. I vantaggi: costi contenuti, flessibilità (può finire con un semplice accordo stragiudiziale, con un piano attestato, con un accordo omologato, come preferisci), e l’esperto fa un po’ da mediatore super partes (i creditori tendono a fidarsi di più se c’è un terzo che certifica i dati) . Secondo i dati 2024, molte PMI ne stanno beneficiando e alcune sono state salvate evitando il fallimento grazie a essa . Non conviene invece se i rapporti sono già totalmente deteriorati o se la situazione è talmente grave che serve l’intervento autoritativo di un giudice (ad es. creditori che non vogliono saperne di trattare, oppure rischio di azioni cautelari immediate). In quei casi, forse meglio andare direttamente di concordato. Comunque tentar non nuoce: la CNC è pensata per essere friendly e confidenziale, quindi può valere come primo tentativo di risanamento.
D10: Dopo un fallimento o un concordato andato male, resterò perseguitato dai debiti per sempre?
R: No. L’ordinamento oggi prevede l’Esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui una volta chiusa la procedura liquidatoria. Se sei un imprenditore individuale fallito, puoi ottenere la cancellazione di tutti i debiti rimasti insoddisfatti dopo 3 anni dalla chiusura del fallimento, purché tu abbia cooperato con il curatore e non abbia commesso irregolarità gravi . Se sei un piccolo debitore sovraindebitato (no fallimento), l’esdebitazione può arrivare anche prima, subito dopo la liquidazione del patrimonio o l’esecuzione del piano. Nel caso di concordato preventivo, se lo completi regolarmente, la società viene estinta e i crediti vengono definitivamene annullati secondo quanto stabilito (i creditori non possono chiedere oltre). Se invece il concordato riguarda una persona fisica, l’esdebitazione opera di diritto (es.: concordato minore concluso = i debiti tagliati sono cancellati). Inoltre, c’è una norma speciale che permette addirittura l’esdebitazione senza utilità per il debitore meritevole che proprio non ha niente da dare ai creditori (ad esempio un ex imprenditore nullatenente) – una sorta di “fresh start” compassionevole. Dunque, i debiti non sono più ergastoli a vita: c’è sempre una via d’uscita legale per tornare puliti e ripartire. Bisogna però aver agito senza frode e con trasparenza. Chi ha fatto il furbo (es. nascondendo attivi, o non collaborando con la curatela fallimentare) può vedersi negata l’esdebitazione per indegnità. In sintesi: se affronti la crisi a testa alta e ti metti a disposizione nella liquidazione del tuo patrimonio, avrai diritto a voltare pagina senza debiti.
Casi pratici e simulazioni (Italia)
Per rendere ancora più concreti gli istituti descritti, presentiamo quattro scenari ipotetici ispirati a situazioni reali, mostrando come un’azienda di gruppi di continuità (UPS) con debiti potrebbe muoversi e con quali risultati.
Caso 1: Risanamento tramite Piano Attestato di Risanamento
Scenario: AlfaTech S.r.l., piccola manifattura di UPS in Toscana, ha accumulato €800.000 di debiti: €300k con banca (mutuo per macchinari), €200k con fornitori, €150k di debiti fiscali (IVA e INAIL) e €150k con un fornitore leasing per attrezzature. L’azienda è in crisi di liquidità perché un importante cliente estero è fallito lasciando insoluto un grosso ordine. Tuttavia AlfaTech ha ancora mercato e nuove commesse in arrivo. Gli amministratori vogliono evitare il tribunale e credono di poter risanare se ottengono dilazioni.
Azione intrapresa: AlfaTech si rivolge a un advisor e prepara un piano di risanamento su 3 anni: i punti chiave sono: – I soci apportano €100.000 di nuovo capitale fresco. – Si vende un immobile non strategico (vecchio magazzino) per €200.000. – Con queste risorse, l’azienda pagherà integralmente i debiti fiscali subito (€150k) e offrirà ai fornitori il 50% a saldo entro 3 mesi (€100k su 200k dovuti). – La banca acconsente a rischedulare il mutuo allungandolo di 3 anni (rate più basse nell’immediato); in cambio AlfaTech offre un’ipoteca aggiuntiva sul capannone industriale. – La società di leasing ritira le attrezzature meno utilizzate, cancellando in cambio €50k di debito; il residuo €100k viene spalmato in nuove rate su 5 anni.
Un professionista indipendente (attestatore) esamina il piano e lo certifica come fattibile e basato su dati realistici . Ad esempio, verifica che il magazzino vale davvero ~200k e c’è un acquirente interessato, che con l’allungamento del mutuo la cassa di AlfaTech torna positiva e che le commesse future genereranno margine sufficiente.
Esecuzione: AlfaTech ottiene l’adesione scritta di: – Agenzia delle Entrate e INAIL (che ricevono tutto e dunque sono d’accordo). – L’80% in valore dei fornitori, i quali preferiscono 50% subito piuttosto che rischiare di meno in fallimento (ai piccoli creditori sotto €5k offre il pagamento completo). – La banca firma un accordo privato di rinegoziazione mutuo con garanzia ipotecaria (nessun importo tagliato, solo tempi più lunghi). – Il leasing firma una transazione per ritiro beni e nuovo piano.
Il piano viene pubblicato nel Registro delle Imprese (per dare data certa e protezione legale) . Grazie a ciò, i pagamenti effettuati (ad esempio quei €100k ai fornitori a saldo) saranno esenti da revocatoria futura .
Nei mesi seguenti AlfaTech: – Vende il magazzino, incassa €200k e paga subito il Fisco (€150k) e €50k ai fornitori come prima tranche. – I soci versano i €100k promessi, con cui vengono completati i pagamenti concordati ai fornitori (€50k rimanenti). – La produzione prosegue: i fornitori, rincuorati dall’accordo, continuano a fornire materiali (magari contro pagamento in 60 giorni, disciplinato). – Con l’utile operativo e il minor esborso per mutui (per via dell’allungamento), AlfaTech rispetta le nuove rate leasing e mutuo.
Esito: In un anno AlfaTech riduce il debito complessivo a soli €400k circa (mutuo residuo €250k, leasing €100k, qualche fornitore residuo minoritario €50k) e soprattutto esce dalla crisi di liquidità: paga puntualmente il corrente, e i creditori “stralciati” sono soddisfatti. Nessuna procedura concorsuale è stata necessaria; l’azienda ha conservato reputazione (il piano non è stato pubblico oltre i diretti coinvolti) e anzi i fornitori vedono serietà nella gestione. Tre anni dopo, AlfaTech ottiene un nuovo finanziamento bancario per espandere la gamma di UPS, poiché i bilanci sono tornati positivi e la crisi è superata.
Commento: Questo caso illustra un piano attestato di risanamento riuscito. Era adatto perché: – I debiti non erano eccessivi rispetto agli asset (c’era un immobile vendibile e soci disposti a investire). – Pochi creditori principali, tutti ragionevoli: nessuno ha dovuto subire perdite troppo grandi (fornitori 50%, ma cash immediato; banca solo una dilazione, fisco nulla). – L’attività era sana: il problema era uno shock di liquidità, risolvibile con accordi e un po’ di finanza.
Grazie all’attestazione indipendente, i creditori hanno avuto fiducia che il piano non fosse “fumo negli occhi”. Inoltre, in caso (non avvenuto) di successivo fallimento, AlfaTech avrebbe comunque potuto difendere quei pagamenti straordinari fatti nel piano (protetti dall’art. 56 CCII) . Il piano attestato è stato preferibile al concordato perché meno costoso e più rapido, e soprattutto perché l’azienda poteva pagare integralmente alcune classi di creditori (Fisco) e soddisfare bene altri: non serviva imporre sacrifici oltre il volontariamente concordato.
Caso 2: Accordo di ristrutturazione con le banche (182-bis CCII)
Scenario: BetaPower S.p.A. produce sistemi UPS di grandi dimensioni. Ha debiti per €5 milioni, di cui €3M verso un pool di banche (due banche principali con esposizione garantita da ipoteche e linee di credito), €1M verso fornitori esteri, e €1M di debiti vari (erario, TFR dipendenti arretrati, leasing). L’azienda è sovraindebitata a causa di un investimento andato male e una contrazione di ordini, però ha know-how e un portafoglio clienti ancora buono. Le banche, preoccupate, hanno iniziato a revocare gli affidamenti, causando ulteriore stretta di cassa. BetaPower da sola non riesce a onorare i piani di rientro chiesti dalle banche ed è a rischio insolvenza conclamata.
Azione intrapresa: BetaPower decide di negoziare un Accordo di ristrutturazione dei debiti con il supporto di un legale. Pianifica di coinvolgere soprattutto le banche, che rappresentano il 60% dei debiti totali – soglia minima per l’accordo omologato . Propone loro: – Stralcio del 30% del debito bancario: su €3M di esposizione, pagherà €2,1M come saldo. – Conversione di parte del debito in strumenti partecipativi: una banca accetta di convertire €300k di credito in obbligazioni convertibili BetaPower (scommettendo nella ripresa). – Nuovo finanziamento di €500k da parte di una delle banche, garantito da privilegio, per liquidità immediata (prededucibile se poi l’accordo va in concorso). – I fornitori esteri (che vogliono mantenere la partnership) vengono pagati al 100%, ma diluiti su 12 mesi. – Debiti verso dipendenti (TFR arretrati €200k) saranno saldati per intero entro 3 mesi dall’omologa (grazie anche al nuovo finanziamento). – Il Fisco (IVA €300k) è incluso in una transazione fiscale all’interno dell’accordo: BetaPower offre il pagamento del 50% (€150k) dilazionato in 2 anni, con stralcio di sanzioni e interessi .
Viene redatta la relazione dell’attestatore indipendente che conferma: il piano è fattibile e i creditori estranei (per esempio un piccolo fornitore italiano da €50k che non aderisce formalmente) saranno comunque pagati integralmente entro 120 giorni . La relazione dimostra anche che la soddisfazione offerta al Fisco (50%) è non inferiore a quella ipotizzabile in caso di fallimento (nel quale si stima che il Fisco avrebbe preso circa 20%).
Procedura: Ottenute le firme di adesione: Banca A e Banca B (insieme 75% del debito finanziario), 70% dei fornitori per valore, e l’Agenzia delle Entrate (che formalmente accetta la transazione), BetaPower deposita in tribunale l’accordo con tutta la documentazione. Chiede contestualmente le misure protettive (moratoria delle azioni esecutive) perché una banca minore stava per pignorare dei crediti. Il tribunale concede subito lo stay di 4 mesi .
All’udienza di omologa, i pochi creditori non aderenti (ad esempio l’agente di commercio creditore di €30k di provvigioni) non si oppongono perché verranno pagati al 100% come da piano. L’unica opposizione viene dall’INPS, che non aveva formalmente aderito (crediti contributivi €100k, a cui BetaPower offre 50% come al Fisco). Tuttavia, il giudice rileva che: – Il soddisfacimento proposto a INPS (50%) non è peggiore di quanto avrebbe in caso di fallimento (avrebbe preso forse 20-30%). – L’adesione dei creditori totali supera 60%, e in particolare i creditori “pubblici” (Fisco+INPS) non detengono la maggioranza del debito. – Sono rispettate le condizioni del cram-down fiscale/contributivo: BetaPower ha ottenuto il sì dell’Erario, l’INPS dissenziente rappresenta meno di metà dell’esposizione verso enti pubblici e comunque viene pagato almeno al 50% .
Quindi il tribunale, applicando l’art. 63 CCII come modificato nel 2024, omologa l’accordo anche senza il consenso dell’INPS (cram-down) . L’accordo omologato diventa vincolante ed efficace verso tutti.
Esecuzione: Nei 30 giorni successivi all’omologa: – La banca A eroga i €500k di nuovo finanziamento (prededucibile). – BetaPower paga i TFR arretrati ai dipendenti (€200k) e fornisce la provvista per pagare i fornitori estranei (che come da accordo devono essere saldati entro 60 giorni). – Si perfeziona la conversione di parte del debito Banca B in obbligazioni. – Viene costituito un conto vincolato dove BetaPower versa mensilmente le quote destinate al Fisco e all’INPS secondo i 24 mesi concordati. – Le banche rinunciano formalmente alle ipoteche in eccesso e cancellano le segnalazioni di sofferenza in Centrale Rischi (l’accordo prevede questo a soddisfazione).
Negli anni seguenti BetaPower, liberata da €900k di debiti bancari e dal peso di contenziosi, torna competitiva: con i nuovi progetti finanziati e i fornitori di nuovo collaborativi, incrementa il fatturato e riesce a rispettare le scadenze di pagamento rimaste. Dopo 2 anni, ha pagato integralmente i debiti fiscali/contributivi come da accordo, ottenendo liberatoria, e continua a servire le rate delle banche rifinanziate.
Commento: Questo caso mostra un accordo di ristrutturazione dei debiti con banche e fisco: – BetaPower ha sfruttato il fatto di avere banche esposte al 60%: centrando la soglia di legge, ha potuto omologare l’accordo coinvolgendo forzatamente minoranze dissenzienti (INPS) . – Ha pagato integralmente i creditori strategici (fornitori esteri, dipendenti) mantenendo i rapporti e la continuità. – L’accordo è stato possibile perché le banche hanno convenuto che preferivano un incasso parziale immediato e la continuità del cliente, piuttosto che spingerlo al fallimento (in cui forse avrebbero recuperato meno e perso un cliente). – Il tribunale ha agito come garante, ma senza dover convocare tutti i creditori in voto come in un concordato: la procedura è stata più snella e privata. – BetaPower ha evitato il fallimento e l’azienda è salva. I creditori pubblici hanno comunque incassato metà dei loro crediti in tempi certi, il che è stato giudicato equo. – Punto cruciale: l’accordo aveva già un forte consenso (75% banche, 70% fornitori, AE ok). Se il consenso fosse stato borderline (es. 61%), l’operazione sarebbe stata più rischiosa perché un’opposizione di creditori estranei insoddisfatti avrebbe potuto far saltare l’omologa.
In conclusione, l’accordo 182-bis ha funzionato bene per orchestrare una soluzione “di mercato” ma con il sigillo del giudice che la rende stabile verso tutti i creditori.
Caso 3: Concordato preventivo in continuità aziendale
Scenario: Gamma Energy S.r.l., medio produttore di UPS industriali, è tecnicamente insolvente: ha €10 milioni di debiti a fronte di €6 milioni di attivo di bilancio. In particolare, c’è un debito bancario di €4M (garantito da ipoteche su capannoni per €3M di valore), €3M di debiti verso fornitori, €1M verso l’Erario (IVA arretrata e contributi) e vari debiti minori con leasing e altri. Gamma ha subito una crisi di settore (calo ordini pubblici) ma possiede tecnologie innovative e un portafoglio ordini prospettico buono grazie ad un nuovo prodotto. Tuttavia, la tensione finanziaria è tale che i fornitori hanno smesso di consegnare materiali (crediti scaduti) e due di essi hanno avviato cause. Anche la banca principale ha revocato gli affidamenti e minaccia di escutere le garanzie.
Gli amministratori di Gamma giudicano che l’impresa possa essere salvata con un taglio del debito e nuovi investimenti, ma necessitano di tempo e di bloccare i creditori – ormai non c’è modo di accontentarli a breve. Decidono quindi di preparare un Concordato Preventivo con continuità.
Azione intrapresa: Gamma deposita in tribunale un ricorso “con riserva” (concordato in bianco) per ottenere immediato sollievo. Il tribunale concede la protezione provvisoria e nomina un commissario giudiziale. Entro 120 giorni, Gamma presenta il piano definitivo: – Il piano prevede la continuazione dell’attività aziendale: Gamma riorganizzerà la produzione focalizzandosi sui prodotti nuovi a maggior margine e dismetterà le linee obsolete. – Un investitore terzo, Delta S.p.A., si è impegnato ad apportare nuovo capitale per €2M in cambio del 60% delle quote di Gamma (post concordato). – Con questi €2M e con i flussi generati dall’attività nei prossimi 5 anni, Gamma propone di pagare integralmente i creditori privilegiati (banche fino a valore delle garanzie, Erario per IVA e ritenute). – Ai creditori chirografari (fornitori, leasing scoperto, parte chirografa delle banche oltre garanzie) offre un pagamento pari al 30% del loro credito, dilazionato in 4 rate semestrali, di cui la prima del 10% immediatamente a seguito dell’omologa (grazie ai fondi dell’investitore) . – I dipendenti: le retribuzioni arretrate (privilegi super) saranno pagate subito al 100%. Si prevede però una riduzione di personale di 15 unità su 100 tramite licenziamento collettivo con accesso al Fondo di garanzia INPS per TFR e 3 mensilità (i lavoratori saranno soddisfatti in prededuzione). – Viene richiesta la moratoria di 2 anni per il pagamento delle quote di debito privilegiato non immediatamente coperte dalla cessione investitore (concessa dalla legge per il concordato in continuità). – Il piano include una transazione fiscale: il 100% dell’IVA sarà pagato (anche perché obbligatorio per omologa cram-down), mentre per sanzioni e interessi c’è falcidia.
Il valore liquidatorio (scenario di fallimento) è stimato dal perito in appena 20% per i chirografari (perché se si liquidasse tutto all’asta, beni e magazzino forse darebbero €5M, coprendo a malapena i privilegiati). Il piano al 30% risulta quindi conveniente per loro. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, in particolare confermando che con l’apporto di Delta e la ristrutturazione, Gamma genererà utili sufficienti a pagare quel 30% ai chirografari in 2 anni.
Votazione: Il commissario giudiziale suddivide i creditori in classi: – Classe 1: Banche ipotecarie (hanno garanzie – si prevede soddisfo 100% in 2 anni). – Classe 2: Erario e INPS (creditori privilegiati di rango inferiore – soddisfo proposto ~60% entro 2 anni, la differenza è sanzioni stralciate). – Classe 3: Fornitori chirografari (30% in 2 anni come proposto). – Classe 4: Altri chirografari (leasing scoperto, penali contrattuali, etc., 30% anch’essi).
All’adunanza dei creditori: – La Classe 1 (Banche) approva, perché prendono il 100% (hanno poco da obiettare, ottengono i loro soldi benché un po’ ritardati e preferiscono continuità). – La Classe 2 (Erario/INPS): l’Agenzia Entrate esprime voto favorevole (incassa IVA piena e 50% di altri tributi) mentre l’INPS vota contrario lamentando lo stralcio parziale dei contributi. Questa classe quindi non raggiunge la maggioranza interna (INPS peso maggiore) ed è da considerare dissenziente. – La Classe 3 (Fornitori): inizialmente c’è scetticismo, ma il commissario nella sua relazione spiega che il 30% in continuità vale di più del probabile 0-5% in fallimento. Alcuni grandi fornitori (che se Gamma prosegue, hanno prospettive di future vendite) votano sì. Alla fine si ottiene il 70% di approvazione per importo crediti – classe approva. – Classe 4 (altri chirografari): sono di importo contenuto e diffusi, la maggioranza per numero vota sì e totalizzano il 60% del valore – classe approva.
Abbiamo dunque 4 classi: 3 approvano, 1 (enti pubblici) no. Non c’è unanimità, ma c’è maggioranza delle classi (3 su 4). Inoltre, almeno una classe di creditori chirografari ha approvato (anzi due) e i creditori dissenzienti (INPS) hanno comunque trattamento non deteriore rispetto al fallimento (prendono 50% vs in fallimento forse zero). Il tribunale quindi applica il cram-down interclassi ai sensi dell’art. 112 CCII : – Rileva che è soddisfatta la condizione per l’omologazione forzata: il piano è approvato dalla maggioranza delle classi (3 su 4) e almeno una classe consenziente è di creditori non completamente soddisfatti (i fornitori chirografari lo sono, prendono 30%) . – Verifica anche che la classe Erario/INPS dissenziente non viene trattata peggio che in liquidazione (nel fallimento l’INPS avrebbe preso quasi nulla, qui 50%). – Nota infine che la classe pubblica dissenziente non è l’unica classe a dire sì (se fosse stata l’unica, il cram-down fiscale non si poteva applicare, per legge) .
Superate queste verifiche, il tribunale omologa il concordato preventivo di Gamma Energy.
Esecuzione: Subito dopo l’omologa: – Delta S.p.A. versa i €2M come da accordo di aumento capitale (diventa socio al 60%). Una parte di questi soldi va a pagare: dipendenti (TFR), fornitori strategici con crediti prededucibili per forniture durante concordato, acconto 10% ai chirografari. – Gamma, sotto la nuova gestione in parte affiancata da Delta, implementa il piano industriale: concentra la produzione sul nuovo UPS modulare altamente richiesto, vendendo o dismettendo macchinari delle linee obsolete (ricavato extra che aiuta la cassa). – Col patrimonio ripulito, Gamma rinegozia anche le linee di fido con banche, ottenendo credito per finanziare le commesse (grazie alla presenza di Delta come sponsor). – Nei 24 mesi seguenti, Gamma paga puntualmente le 4 rate semestrali ai fornitori e agli altri creditori chirografari, totalizzando così il 30% promesso. – Ai creditori privilegiati, come convenuto, versa ratealmente il loro dovuto integrale entro al massimo 2 anni (legge consente fino a 2 anni di moratoria interessi legali compresi). – L’INPS, sebbene scontenta, riceve il 50% dei contributi entro i tempi previsti.
A due anni dall’omologa, tutti i pagamenti concordatari sono eseguiti. Il tribunale dichiara il concordato adempiuto e Gamma Energy esce dalla procedura concorsuale. L’azienda continua a operare con successo sotto la guida di Delta S.p.A., che poi rileverà del tutto la società crescendo nel settore.
Commento: Questo caso illustra un concordato in continuità: – La soluzione è stata possibile solo con l’ingresso di un investitore e il sacrificio dei creditori (accettare il 30%). È un caso di ristrutturazione profonda via autorità giudiziaria. Era necessario data l’insolvenza pesante e il gran numero di creditori. – I dipendenti e creditori privilegiati sono stati tutelati quasi completamente (come è prassi in continuità, altrimenti tribunale non omologherebbe facilmente). – I chirografari hanno subito un taglio ma accettabile rispetto allo scenario liquidatorio (30 vs 5%). – La presenza di classi ha permesso di gestire diversamente categorie (banche ipotecarie vs fornitori). La giurisprudenza (Cass. 348/2025) fu citata per definire continuità parziale: qui la continuità c’è sul core business (nuova linea), pur liquidandosi asset marginali – considerata ammissibile perché preserva il nucleo significativo dell’azienda . – Si è visto l’uso del cram-down: il tribunale ha imposto il concordato nonostante la contrarietà di INPS, grazie alle regole di maggioranza e salvaguardie . – Gamma ha evitato il fallimento, ha evitato anche la perdita totale per i soci originari (certo, sono diluiti al 40%, ma meglio del zero post-fallimento). – Il concordato è complesso e costoso (commissario, votazioni, tempi ~1 anno). Ma ha salvato 85 posti di lavoro e permesso a creditori di recuperare qualcosa con la prospettiva di continuare rapporti (fornitori). – Da notare: i garanti personali (se ve ne erano) non sono stati toccati dal concordato – punto di attenzione: se ad esempio un socio avesse garantito un debito bancario, la banca soddisfatta al 100% nel piano non avrebbe motivo di escuterlo; se un fornitore aveva garanzia, per il 70% stralciato tecnicamente potrebbe ancora chiederlo al garante. In pratica però, in concordati spesso i garanti negoziano con i creditori la liberatoria in parallelo (magari pagando una parte). Questo livello di dettaglio esula dal caso, ma resta inteso.
Questo scenario mostra come il concordato preventivo sia uno strumento potente per ristrutturare un’azienda insolvente mantenendola in vita, al prezzo di un intervento terzo e di un sacrificio controllato dei creditori.
Caso 4: Liquidazione giudiziale (fallimento) con esdebitazione dell’imprenditore
Scenario: Delta Impianti S.a.s., azienda familiare (socio accomandatario Mario, socio accomandante suo fratello) attiva nel commercio di UPS di piccole dimensioni, si trova in una crisi irreversibile: il mercato è crollato per l’ingresso di competitor cinesi a basso costo e l’azienda ha accumulato €500.000 di debiti (soprattutto fiscali e bancari) a fronte di un magazzino invenduto e pochi macchinari. Delta ha già licenziato gli operai e cessato l’attività. Non c’è alcuna prospettiva di continuità né investitori interessati. I soci non hanno risorse proprie per proporre un concordato (e i creditori, vista la situazione, non accetterebbero stralci perché c’è poco da stralciare). Inoltre, Equitalia ha già iscritti vari pignoramenti e una banca ha avviato precetto.
Azione intrapresa: Il socio accomandatario Mario, assistito dal legale, opta per non accanirsi oltre e presenta egli stesso istanza di liquidazione giudiziale (fallimento) al tribunale competente, chiedendo la procedura in estensione anche per sé come socio illimitatamente responsabile. L’idea è di avviare subito la liquidazione ordinata dei (pochi) beni rimasti, far intervenire il Fondo di Garanzia per pagare i 3 dipendenti il TFR dovuto, e poi ottenere l’esdebitazione personale per poter ricominciare (probabilmente come dipendente altrove, data la fine dell’impresa).
Procedura: Il tribunale accerta lo stato d’insolvenza (Delta è incapace di pagare da mesi, conti bloccati) e dichiara la liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario. Nomina un curatore. Da quel momento: – Tutte le azioni esecutive in corso (Equitalia, banca) si fermano e vengono assorbite dal concorso . – Il curatore assume la gestione dei beni di Delta e anche di Mario per la parte necessaria. Stila l’inventario: c’è un capannone valutato €200k (ipotecato dalla banca per 150k), un magazzino di prodotti stimato €50k, e pochi crediti verso clienti (20k forse incassabili). – I creditori vengono tutti a fare domanda di ammissione al passivo: banca €160k (150k ipotecati), Agenzia Entrate €100k, Equitalia (ruoli vari) €120k, ex dipendenti €30k (privilegiati), alcuni fornitori €40k. – Viene verificato lo stato dei conti: il curatore riscontra condotte corrette nel senso che Mario non ha sottratto nulla (anzi ha consegnato libri contabili in ordine). Solo nota che forse l’azienda ha tardato di un annetto la cessazione, aggravando debiti – ma come colpa lieve, nulla di fraudolento.
Il curatore procede a vendere il capannone all’asta, ricavando €180k netti. Paga la banca ipotecaria (150k + interessi), il residuo va alla massa. Vende anche il magazzino (i prodotti rimasti) a un concorrente per €30k. Recupera €10k di crediti clienti. Complessivamente crea un attivo di ~€70k per la massa chirografaria dopo spese.
Distribuzione finale: quell’importo consente di pagare integralmente i dipendenti (TFR, stipendi) e dare un 20% circa al Fisco e altri creditori privilegiati di grado inferiore, ma zero ai chirografari (fornitori restano scoperti). Il curatore evidenzia che la causa del dissesto è di mercato, non ci sono illeciti rilevanti: propone quindi la chiusura del fallimento per completamento dell’attivo.
Esdebitazione: Una volta chiuso, Mario – come persona fisica fallita – presenta istanza di esdebitazione ex art. 282 CCII. Dimostra di aver collaborato (ha consegnato libri, non ha nascosto nulla, ha anche trovato acquirente per il magazzino aiutando il curatore, e non è stato condannato per reati). Nessun creditore si oppone. Il tribunale quindi emette decreto di esdebitazione: tutti i debiti residui di Mario verso i creditori concorsuali sono cancellati. Tradotto: Mario non dovrà più pagare in futuro i creditori per la parte rimasta insoddisfatta (che è molta: i fornitori al 100%, il Fisco per l’80% residuo, etc.).
Post-fallimento: Mario, liberato dai debiti, chiude la s.a.s. formalmente. Con i 12 mesi di Naspi e qualche risparmio, apre un piccolo negozio di assistenza di apparecchi elettrici (attività diversa, con la moglie). Gli sarà difficile ottenere credito bancario subito (ha la macchia di un fallimento), ma non avrà azioni esecutive pendenti contro di sé perché i debiti vecchi sono perdonati. I fornitori e il Fisco hanno dovuto incassare la perdita e basta. Anche la banca, pur avendo preso il 100% su ipoteca, su eventuale residuo chirografo nulla potrà più chiedere. L’INPS se aveva sanzioni e interessi pendenti, anche quelli inesigibili. Il caso di Mario finisce qui: la ditta è sparita, i debiti pure, i creditori hanno ricevuto quello che il patrimonio consentiva.
Commento: Questo ultimo caso mostra la gestione “pulita” di una insolvenza terminale: – Invece di attendere i pignoramenti random, l’imprenditore ha attivato la procedura concorsuale liquidatoria. Ciò ha permesso una liquidazione unitaria e un’equa distribuzione (tutelati in primis i dipendenti e i creditori garantiti). – Non c’era spazio per concordati: troppo poco attivo e nessun business da salvare. – Grazie alla collaborazione e all’assenza di atti distrattivi, l’imprenditore ha usufruito del fresh start: l’esdebitazione gli consente di ripartire senza lo “zaino di piombo” dei debiti precedenti . – Certo, ha perso l’azienda e i beni (capannone, ecc.), ma quella era ormai una fine inevitabile. Ha però conservato la dignità (ha pagato tutto ciò che era oggettivamente pagabile col patrimonio rimasto) ed evitato guai peggiori (nessuna bancarotta fraudolenta, nessuna inibizione ai diritti civili se non quelle standard temporanee post-fallimentari). – Anche i creditori, pur insoddisfatti, hanno beneficiato di una procedura ordinata: se qualche fornitore avesse agito da solo, forse il capannone sarebbe stato venduto male o Equitalia avrebbe potuto prendersi quasi tutto con le sue prerogative, lasciando altri a zero. Il fallimento invece garantisce la par condicio e un controllo sulle vendite (il curatore ha venduto a 180k con due aste, magari in esecuzione singola sarebbe stato svenduto a 140k). – Questo scenario capita di frequente per PMI familiari: l’importante è togliere lo stigma del fallimento come “infamia”. Oggi è visto come un evento fisiologico nella vita economica, e l’esdebitazione come uno strumento di politica sociale per reinserire l’ex imprenditore senza condannarlo a debiti perpetui.
Questi casi evidenziano che, a seconda della situazione concreta dell’impresa (salvabile o no, dimensioni, tipologia di debiti, disponibilità di risorse), esistono approcci diversi: – Ristrutturazione leggera privata (caso 1), – Ristrutturazione formale con banche e tribunale (caso 2), – Procedura concorsuale complessa con investitore (caso 3), – Liquidazione concorsuale con “liberazione” finale del debitore (caso 4).
In tutti i casi, la chiave è stata l’uso tempestivo e appropriato degli strumenti legali previsti dal nostro ordinamento, anziché lasciare che la crisi degenerasse fuori controllo.
Conclusione
Abbiamo percorso un lungo itinerario attraverso le possibili vie per difendersi dai debiti di un’azienda italiana nel settore degli UPS (e, per analogia, di qualunque PMI). Di fronte a una situazione debitoria grave, l’imprenditore-debitore ha oggi a disposizione un ventaglio di soluzioni: – negoziali e privatistiche (dalla semplice dilazione concordata, ai piani attestati, agli accordi di ristrutturazione omologati), – assistite e preventive (composizione negoziata), – giudiziali e concorsuali (concordati preventivi, liquidazioni giudiziali).
La scelta dello strumento va calibrata sul caso concreto, valutando grado di insolvenza, natura dei creditori, prospettive di continuità e risorse attivabili. Spesso, un esito positivo richiede la combinazione di più elementi: l’apporto di nuovi finanziamenti (da soci o terzi), il sacrificio parziale dei creditori (stralcio di crediti), e misure di riorganizzazione interna (taglio costi, cessione asset non strategici).
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” significa prima di tutto conoscere i propri diritti e doveri: – ha il diritto di essere protetto da assalti scoordinati dei creditori quando intraprende un percorso di risanamento serio , – ma ha anche il dovere di attivarsi tempestivamente e con trasparenza (i rimedi funzionano se il debitore collabora e agisce in buona fede).
Abbiamo visto come l’ordinamento italiano, aggiornato alle ultime riforme del 2022-2024, tenda a privilegiare la continuità aziendale e il superamento della crisi ove possibile, e solo in ultima istanza la liquidazione. E persino in caso di liquidazione, offre all’imprenditore onesto la chance di ripulirsi dai debiti personali e ripartire (principio della “fresh start” sancito anche a livello europeo) .
In ambito pratico, il debitore d’impresa dovrebbe: 1. Monitorare costantemente la salute economica-finanziaria (indicatori come DSCR, margini, esposizioni) e cogliere subito i segnali di crisi. 2. Distinguere la tipologia dei debiti e le relative priorità legali: non tutti i debiti sono uguali (alcuni – stipendi, contributi – vanno prioritariamente soddisfatti per motivi legali e morali). 3. Coinvolgere consulenti esperti in crisi d’impresa per valutare le opzioni: a volte la soluzione migliore non è intuitiva e richiede competenze interdisciplinari (legali, fiscali, aziendali). 4. Dialogare con i creditori appena possibile: la fiducia si mantiene comunicando. Molti accordi privati falliscono perché il debitore sparisce o nega il problema; al contrario, mettendo le carte in tavola, si possono trovare compromessi accettabili. 5. Non avere timore di usare gli strumenti concorsuali quando necessari: c’è ancora una certa ritrosia culturale a “portare i libri in tribunale”, ma come abbiamo visto spesso è la mossa più saggia per congelare la situazione e progettare la ristrutturazione senza la pistola alla tempia dei pignoramenti. 6. Agire con correttezza: evitare favoritismi illegittimi, non aggravare scientemente l’esposizione, non distogliere beni. Ogni passo scorretto riduce le possibilità di successo di un piano e aumenta il rischio di sanzioni e responsabilità personali. 7. Considerare anche soluzioni ibride o innovative: ad esempio, vendere l’azienda (o parte) a un competitor o fondo e usare il ricavato per pagare i creditori (c.d. concordato con continuità indiretta) – spesso è una via migliore di una liquidazione atomistica. Oppure concordare accordi di standby con tutti i creditori (standstill agreement) extra-giudiziale per guadagnare mesi di respiro: è simile a una moratoria, che se formalizzata in un piano attestato può funzionare senza tribunale.
In sintesi, la difesa del debitore di un’azienda indebitata richiede una strategia proattiva, informata e legale. Non esiste una bacchetta magica per far sparire i debiti, ma esistono procedure per gestirli in modo sostenibile e ridurne l’impatto, coinvolgendo equamente i creditori nella soluzione. L’alternativa – subire passivamente le azioni dei creditori – porta quasi sempre al peggior esito: la dispersione del valore aziendale e il rischio per il debitore di venire spogliato di tutto senza possibilità di rilancio.
Come recita un motto latino in ambito fallimentare, “Ubi debita, ibi remedia” – dove vi sono debiti (problemi), ivi vi sono i rimedi. La normativa italiana della crisi d’impresa, aggiornata al 2025, offre tali rimedi; starà all’imprenditore saggio saperli cogliere per difendere il frutto del proprio lavoro nelle avversità e, se possibile, far rinascere la propria impresa su basi sane.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice Civile e Codice della Crisi (CCII): Articoli citati in materia di insolvenza, concordato e responsabilità (art. 2086 c.c. sugli assetti; art. 2476 c.c. responsabilità soci SRL; D.Lgs. 12/01/2019 n.14, art. 2 (definizioni di crisi e insolvenza) , artt. 56 (piani attestati) , 57-64 (accordi ristrutturazione) , 84-88 (concordato preventivo, transazione fiscale) , 112 (omologazione cram-down) , 121 (soglia €30k fallimento) , 182-185 (esdebitazione imprenditore) ).
- Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/42): Principi poi trasfusi nel CCII, es. art. 67 (protezione piani attestati) , art. 160-186 (concordato preventivo), art. 182-bis (accordi ristrutturazione) , art. 146 L.F. (azione di resp. verso amministratori) , art. 216 e segg. (reati di bancarotta).
- Decr. Leg.vo 13/09/2024 n.136 (Terzo correttivo CCII): ha modificato transazione fiscale e cram-down pubblico (precisando soglie 25%-50% e 60% per omologa forzosa accordi ; nuova formulazione art. 88 CCII per concordato fiscale con riferimento a alternativa liquidatoria ; richiesto apporto esterno ≥10% nei concordati liquidatori ; chiarito art.112 CCII su cross-class cram-down ). Fonte: Lavorosi.it, “D.Lgs. 136/2024… in Gazzetta” , che riassume novità come falcidia fiscale in composizione negoziata e piani di ristrutturazione .
- Decr. Leg.vo 118/2021 conv. L.147/2021: introduttivo della Composizione Negoziata. Art. 2 e seguenti CCII sul percorso CNC (Piattaforma, esperto, misure protettive) . Dato storico: dati Camera Arbitrale Milano 2024 su numero istanze CNC e percentuali (87% crescita in Lombardia) .
- Cassazione Civile:
- Sez. I, 08/01/2025 n. 348 (Pres. Ferro) – Principio: concordato in continuità richiede prosecuzione significativa del core business, non basta attività marginale .
- Sez. Un. 13719/2016 – Piano attestato: atti esecutivi esenti da revocatoria solo se piano non manifestamente inidoneo e atti specificamente indicati . Cass. 9743/2022 ha confermato il principio .
- Cass. 24006/2025 (Pres. M.Ferro) – Azione di responsabilità contro amministratore deceduto: coeredi che si costituiscono in giudizio come eredi ne assumono tacitamente la qualità e vengono condannati .
- Cass. 6866/2022 – (citata da Unijuris) sui motivi di ricorso in cassazione in ambito fallimentare (nota metodologica) .
- Cass. 1521/2013 (SS.UU.) – Attestatore responsabilità: attestatore può rispondere se omette di vigilare su dati non veritieri .
- Cass. 3220/2025 – (cit. da DirittoBancario) su concordato fallimentare e diritto di voto (non trattato estensivamente nel testo).
- Corte Costituzionale n. 87/2023 – ha stabilito che il fallimento può essere dichiarato solo per insolvenza su debiti pre-esistenti la domanda concordataria, non su debiti nuovi post (principio di coerenza); cenno a tutela debitore (menzionato marginalmente: “dichiarazione di fallimento possibile solo se insolvenza attiene a debiti esistenti alla data…” – protezione per chi peggiora dopo concordato?).
- Tribunali di merito:
- Trib. Milano 18/04/2025 – Ha affermato responsabilità amministratori per prosecuzione illegittima attività in perdita e conseguente danno a creditori .
- Trib. Firenze 08/01/2025 – in comparazione concordato vs liquidazione giudiziale, valutare anche azioni di responsabilità recuperabili in fallimento (quindi a piano concordatario conviene tenerne conto) .
- Trib. Venezia 07/07/2025 – su azione vs amministratori e sindaci per pagamenti preferenziali: sindaci responsabili solidalmente se omessa vigilanza .
- Trib. Modena 2022 – (richiamato da iusletter ) ha ritenuto che la sola istanza di nomina esperto CNC non blocca fallimento, serve decreto misure protettive.
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce gruppi di continuità (UPS), sistemi di backup energetico, inverter, batterie industriali, alimentatori stabilizzati e soluzioni di protezione elettrica si trova in una situazione di debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, assembla o distribuisce gruppi di continuità (UPS), sistemi di backup energetico, inverter, batterie industriali, alimentatori stabilizzati e soluzioni di protezione elettrica si trova in una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore degli UPS è complesso e costoso: elettronica di potenza, batterie al piombo o litio, inverter, schede elettroniche, collaudi, certificazioni e fornitori internazionali. Anche una temporanea mancanza di liquidità può generare una crisi immediata e pericolosa.
La buona notizia?
Puoi salvare la tua azienda.
Con una strategia corretta puoi bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e mantenere attiva la produzione.
Perché un’Azienda di UPS Finisce in Debito
Le cause più comuni includono:
• acquisto di componenti costosi: inverter, batterie, schede elettroniche, alimentatori
• rincaro delle materie prime elettriche ed elettroniche
• ritardi di pagamento da parte di clienti pubblici o industriali
• costi elevati per certificazioni, test, collaudi e qualità
• magazzino immobilizzato tra UPS finiti, batterie e componenti
• difficoltà di approvvigionamento da fornitori esteri
• revoche o riduzioni delle linee di credito bancarie
• investimenti obbligati in attrezzature e strumenti tecnici
Il debito raramente nasce per mancanza di lavoro: nasce dal blocco della liquidità.
I Rischi per una Azienda di Gruppi di Continuità con Debiti
Se non intervieni tempestivamente, rischi:
• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti bancari
• interruzione delle forniture di batterie, inverter e componenti critici
• decreti ingiuntivi, precetti e cause civili
• sequestro di magazzino, UPS finiti e attrezzature
• impossibilità di completare ordini e installazioni
• ritardi nelle consegne e perdita di clienti strategici
• rischio concreto di fermo aziendale
Un debito non gestito può paralizzare il tuo business in pochi giorni.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1) Fermare immediatamente i creditori
Un avvocato può ottenere:
• sospensione dei pignoramenti
• blocco delle azioni esecutive
• tutela dei conti aziendali
• stop alle richieste aggressive delle banche
Prima si ferma l’emorragia, poi si organizza la ripartenza.
2) Analizzare i debiti per eliminare ciò che non è dovuto
In molte situazioni i debiti includono:
• interessi e more illegittime
• calcoli errati della Riscossione
• somme prescritte
• importi duplicati
• commissioni bancarie non dovute
Ridurre il debito è spesso possibile e in misura rilevante.
3) Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di pagamento con fornitori strategici
• rinegoziazione delle linee di credito bancarie
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• accesso alle definizioni agevolate quando disponibili
Obiettivo: ripristinare liquidità senza bloccare la produzione.
4) Attivare gli strumenti legali che proteggono l’impresa
Per debiti elevati si possono utilizzare strumenti altamente efficaci:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione
• concordato minore
• liquidazione controllata (solo come ultima opzione)
Questi strumenti permettono di:
• bloccare tutti i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte del debito
• continuare la produzione e le installazioni
• proteggere l’imprenditore
Sono procedure sicure e gestite dal Tribunale.
5) Proteggere produzione, magazzino e forniture
Nel settore degli UPS è vitale:
• tutelare batterie, schede elettroniche, inverter e UPS finiti
• mantenere attivi i fornitori critici di componenti
• evitare sequestri che bloccherebbero produzione e spedizioni
• proteggere macchinari, banchi prova e attrezzature
• garantire continuità nelle consegne e nei contratti di manutenzione
La produzione deve continuare: è la chiave per superare la crisi.
Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
• Elenco completo dei debiti
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presente)
• Bilanci e documenti fiscali
• Lista fornitori strategici e insoluti
• Inventario di magazzino (UPS, batterie, componenti)
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e pianificazione della produzione
Tempistiche di Intervento
• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: entro 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziaria: 3–12 mesi
Le protezioni possono attivarsi già nei primi giorni.
Vantaggi di una Difesa Specializzata
• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione concreta dei debiti
• Protezione di magazzino, componenti e macchinari
• Trattative efficaci con banche e fornitori
• Continuità produttiva e commerciale garantita
• Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
Errori da Evitare
• Ignorare solleciti e atti giudiziari
• Fare nuovi debiti per pagare quelli vecchi
• Favorire un creditore e ignorare gli altri
• Lasciare avanzare decreti e pignoramenti
• Fidarsi di società “miracolose” non qualificate
Ogni errore aumenta i rischi e aggrava la crisi.
Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato delle azioni esecutive
• Ristrutturazione del debito con piani sostenibili
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative mirate con banche, fornitori e Riscossione
• Protezione totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di gruppi di continuità (UPS) non significa dover chiudere.
Con la giusta strategia puoi:
• bloccare subito i creditori
• ridurre significativamente i debiti
• proteggere magazzino e produzione
• mantenere attiva l’azienda
• salvare il tuo futuro imprenditoriale
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.