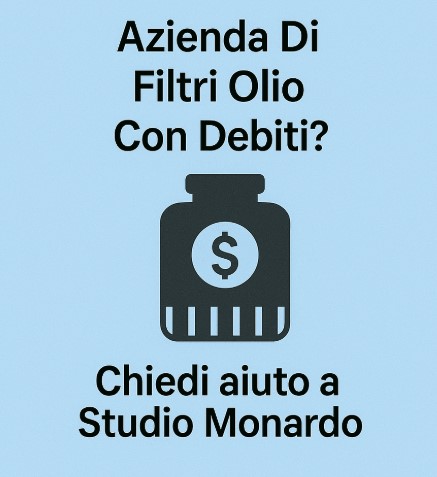Se gestisci un’azienda che produce, distribuisce o vende filtri olio, filtri idraulici, filtri carburante, cartucce filtranti o sistemi di filtrazione industriale, e ti trovi con debiti fiscali, cartelle esattoriali, accertamenti o verifiche dell’Agenzia delle Entrate, sei in una delle situazioni più delicate per un’impresa tecnica del settore meccanico.
Il comparto dei filtri e della filtrazione industriale è tra i più attenzionati dal Fisco: magazzini complessi, componentistica specifica, ricambi variabili, personalizzazioni e margini diversi generano spesso contestazioni basate su presunzioni errate.
La buona notizia è che un debito o un accertamento fiscale non è definitivo: può essere ridotto, sospeso o annullato se ti muovi rapidamente e con la giusta strategia difensiva.
Perché le aziende di filtri olio vengono accertate così spesso
Le verifiche fiscali sono frequenti per diversi motivi tipici del settore:
- magazzino complesso con molti codici (filtri spin-on, cartucce, filtri idraulici, filtri aria-olio, filtri speciali)
- differenze tra DDT, ordini, carichi-scarichi e fatture
- scarti di produzione e componenti difettosi fraintesi dal Fisco
- resi non considerati nella ricostruzione delle rimanenze
- margini variabili tra linee standard e prodotti tecnici
- movimenti bancari interpretati come ricavi non dichiarati
- rimanenze finali giudicate “non congrue”
- vendite a distributori, officine e industrie con pagamenti frazionati
Molte contestazioni derivano dalla mancata comprensione della logistica e della gestione dei ricambi industriali.
Cosa fare subito se hai debiti o un accertamento fiscale
La risposta corretta e tempestiva è fondamentale per proteggere la tua azienda.
Ecco cosa devi fare immediatamente:
- far analizzare l’accertamento da un avvocato tributarista esperto nel settore tecnico-industriale
- raccogliere DDT, fatture, inventario, movimenti bancari, listini, schede tecniche e resi
- non rispondere da solo ai questionari dell’Agenzia delle Entrate
- verificare se puoi ottenere una sospensione urgente della riscossione
- controllare notifiche, calcoli, termini e ricostruzioni del magazzino
- proteggere dati sensibili su fornitori, margini e componenti tecnici
- evitare di consegnare documentazione non richiesta o controproducente
Una risposta sbagliata può trasformare un debito discutibile in una pretesa enorme.
Le contestazioni più comuni alle aziende di filtri olio
Tra le accuse più frequenti troviamo:
- rimanenze ricostruite in modo errato
- movimenti bancari considerati incassi non dichiarati
- scarti di produzione trattati come vendite in nero
- acquisti giudicati non inerenti
- margini troppo bassi secondo i parametri del Fisco
- DDT e fatture non perfettamente allineati
- resi non valorizzati correttamente
- differenze tra articoli tecnici e articoli standard non comprese dagli accertatori
Quasi sempre queste contestazioni sono basate su presunzioni standard e non su verifiche tecniche.
Come un avvocato può difenderti efficacemente
Un avvocato tributarista specializzato può:
- contestare la ricostruzione errata dei magazzini e delle rimanenze
- dimostrare la correttezza di scarti, resi e componentistica
- spiegare tecnicamente i movimenti bancari contestati
- ottenere la sospensione immediata della riscossione
- gestire il contraddittorio con il Fisco senza rischi per la tua azienda
- impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
- ottenere riduzioni importanti o l’annullamento dell’intera pretesa fiscale
- far emergere errori procedurali e vizi di motivazione del Fisco
Una difesa tecnica è indispensabile perché il settore della filtrazione industriale è molto più complesso di quanto immaginano i verificatori.
Quando un accertamento è illegittimo e può essere annullato
Un accertamento può essere dichiarato illegittimo quando:
- si basa su presunzioni senza prove concrete
- il magazzino è stato ricostruito in modo errato
- le motivazioni dell’atto sono generiche o insufficienti
- le notifiche non sono state fatte correttamente
- i movimenti bancari sono stati interpretati senza analisi reale
- scarti e componenti difettosi non sono stati considerati
- i calcoli sono sbagliati o incoerenti
- documenti essenziali forniti dall’azienda non sono stati valutati
Molti accertamenti risultano viziati e possono essere annullati integralmente da un avvocato esperto.
Cosa rischi se non ti difendi
Non intervenire significa rischiare conseguenze molto serie:
- pignoramento dei conti correnti
- fermo dei mezzi aziendali
- blocco degli approvvigionamenti dai fornitori
- perdita di liquidità e difficoltà operative
- ipoteche su beni immobili
- cartelle esattoriali sempre più alte
- sanzioni fino al 240% dell’imposta
- danni alla reputazione con distributori e clienti
Difendersi tempestivamente è essenziale per evitare danni economici e operativi.
Come evitare il blocco dell’attività
Per mantenere attiva e funzionante la tua azienda:
- contestare subito l’accertamento
- richiedere la sospensione della riscossione
- documentare in modo tecnico scarti, rimanenze e specifiche dei filtri
- coordinarsi con commercialista e tecnici del settore
- proteggere dati industriali sensibili
- impugnare l’atto se presenta errori o presunzioni non fondate
Una difesa ben costruita ti permette di continuare a fornire filtri e ricambi senza interruzioni.
Quando rivolgersi a un avvocato
D devi contattare un avvocato tributarista quando:
- hai ricevuto una cartella o un accertamento fiscale
- contestano rimanenze, magazzino, movimenti bancari o margini
- rischi pignoramenti o fermi amministrativi
- vuoi impedire che l’atto diventi definitivo
- devi tutelare rapporti con clienti e fornitori strategici
Un avvocato esperto può ridurre la pretesa fiscale, bloccare la riscossione e difendere davvero la tua azienda di filtri olio.
Attenzione: molte aziende del settore dei filtri pagano debiti non dovuti solo perché non conoscono i propri diritti. Con una strategia corretta puoi ridurre drasticamente o annullare il debito fiscale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti, accertamenti fiscali e difesa di aziende tecniche – ti aiuta a proteggere la tua impresa di filtri olio.
👉 Hai debiti o un accertamento in corso?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per difenderti e bloccare subito la riscossione.
Introduzione
Un’azienda specializzata nella produzione di filtri dell’olio, ad esempio FiltriOlio S.r.l. (una società di capitali italiana), può trovarsi a fronteggiare una situazione di crisi finanziaria con debiti rilevanti verso il Fisco, gli enti previdenziali (INPS), le banche e i fornitori. Quando un’impresa accumula debiti e non riesce più a rispettare regolarmente le proprie obbligazioni, è fondamentale comprendere cosa fare per difendersi dalle azioni dei creditori e quali strumenti legali utilizzare per gestire e risolvere la crisi. In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo in dettaglio le strategie difensive e le procedure disponibili nell’ordinamento italiano per un’azienda indebitata, tenendo conto delle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
La disciplina italiana della crisi d’impresa è stata profondamente innovata dall’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 14/2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022. Il nuovo Codice ha sostituito la vecchia legge fallimentare del 1942, spostando l’enfasi dalla liquidazione ex post (il fallimento, ora denominato liquidazione giudiziale) alla prevenzione e gestione anticipata della crisi attraverso strumenti di allerta e procedure di risanamento. Negli anni successivi, il legislatore ha emanato vari decreti correttivi (da ultimo il D.Lgs. 136/2024, cosiddetto Correttivo-ter) per perfezionare la disciplina, e la giurisprudenza ha iniziato a delineare l’interpretazione delle nuove norme con pronunce importanti. Questa guida approfondirà tali strumenti – dal punto di vista del debitore – con un taglio avanzato ma divulgativo, utile sia a professionisti legali (avvocati, consulenti) sia a imprenditori e privati coinvolti.
Cosa troverete in questa guida: Esamineremo dapprima come riconoscere i segnali della crisi e quali sono gli obblighi legali dell’imprenditore (e degli organi societari) nell’affrontarla tempestivamente. Illustreremo poi le diverse categorie di debiti (erariali, previdenziali, bancari, commerciali) evidenziando i rischi specifici e le possibili strategie di difesa per ciascuna. Successivamente descriveremo in dettaglio gli strumenti di composizione della crisi oggi a disposizione – dalle soluzioni stragiudiziali (come la composizione negoziata, i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) alle procedure concorsuali vere e proprie (come il concordato preventivo – in continuità o liquidatorio – e il concordato semplificato, fino alla liquidazione giudiziale). Verranno forniti riferimenti normativi precisi della normativa italiana vigente (CCII, Codice Civile, leggi speciali) e citate le sentenze più recenti dei tribunali e della Corte di Cassazione in materia, per contestualizzare i principi applicabili. Il tutto verrà esposto con linguaggio giuridico accurato ma accessibile, arricchito da esempi pratici, sessioni di domande e risposte (FAQ) su dubbi frequenti e tabelle riepilogative che riassumono i punti chiave.
L’obiettivo è fornire una guida completa (oltre 10.000 parole) sul da farsi quando un’azienda come FiltriOlio S.r.l. è gravata dai debiti: come difendersi dalle azioni dei creditori e come procedere per cercare di salvare l’impresa (ove possibile) o, nei casi estremi, liquidarla nella maniera meno distruttiva. Saranno affrontati anche temi cruciali come la responsabilità patrimoniale dell’amministratore e degli eventuali soci per i debiti aziendali, alla luce della normativa italiana vigente (aggiornata al 2025) e delle pronunce giurisprudenziali più autorevoli e recenti.
Scenario di riferimento: FiltriOlio S.r.l. è un’azienda manifatturiera di medie dimensioni che produce filtri per impianti oleodinamici. Negli ultimi anni, complice una contrazione del mercato e l’aumento dei costi delle materie prime, l’azienda ha registrato perdite e difficoltà di liquidità. Ha accumulato debiti per €800.000 verso una banca (mutui e scoperti di conto), €200.000 verso fornitori, €150.000 di debiti fiscali (IVA non versata e imposte sui redditi) e €50.000 di contributi previdenziali non pagati all’INPS. I creditori iniziano a fare pressione: la banca minaccia di escutere le garanzie, alcuni fornitori hanno ottenuto decreti ingiuntivi e uno ha già avviato un pignoramento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato cartelle esattoriali e l’INPS ha inviato solleciti per i contributi arretrati. L’azienda è in crisi: rischia di non poter proseguire l’attività se non trova una soluzione. Il titolare e amministratore unico, preoccupato di eventuali responsabilità personali e di perdere l’azienda, si chiede come difendersi da queste azioni e quali passi intraprendere per affrontare la situazione debitoria. Nel prosieguo della guida risponderemo a questi interrogativi, seguendo il filo conduttore di questo scenario esemplificativo.
(NB: Tutte le soluzioni e gli strumenti giuridici discussi saranno riferiti all’ordinamento italiano. Le fonti normative citate – articoli di legge, decreti e sentenze – sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti e Riferimenti.)
Segnali di crisi e obblighi dell’imprenditore debitore
La prima “linea di difesa” per un’azienda indebitata consiste nel riconoscere precocemente lo stato di crisi e attivarsi tempestivamente. Il nuovo Codice della Crisi (CCII) distingue tra crisi e insolvenza: lo stato di crisi è una situazione di difficoltà economico-finanziaria ancora reversibile, in cui l’impresa presenta squilibri patrimoniali o di liquidità che rendono probabile un’insolvenza futura se non si interviene per tempo. In altri termini, la crisi è un “campanello d’allarme” – l’azienda magari sta ancora pagando i debiti, ma mostra segnali di sofferenza (perdite di bilancio, flussi di cassa negativi, patrimonio netto eroso, indici finanziari deteriorati). L’insolvenza, invece, è lo stadio conclamato in cui l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con i mezzi ordinari. Si manifesta con inadempimenti protratti, mancati pagamenti generalizzati, protesti, pignoramenti subiti, ecc.. Questa distinzione non è solo teorica: la maggior parte degli strumenti introdotti dalla riforma mira a gestire la crisi prima che degeneri in insolvenza irreversibile. Ne consegue che l’imprenditore ha il dovere di monitorare costantemente la propria azienda, cogliendo per tempo i segnali di crisi ed evitando di arrivare allo stato di insolvenza senza aver tentato misure correttive.
Doveri di allerta “interna”: assetti adeguati e monitoraggio dei segnali
Il legislatore ha rafforzato i doveri degli amministratori in ottica di prevenzione. L’art. 2086 cod. civ., così come modificato nel 2019, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale. In pratica, ogni impresa deve dotarsi di strumenti di controllo di gestione (contabilità accurata, bilanci periodici, indicatori finanziari come il DSCR – Debt Service Coverage Ratio, ecc.) e procedure interne per individuare squilibri prima che diventino ingestibili. Inoltre, gli amministratori hanno l’obbligo di attivarsi senza indugio nell’adottare rimedi o nell’accedere agli strumenti di regolazione della crisi non appena emergano difficoltà significative. L’inerzia colpevole è ora espressamente sanzionata: l’art. 378 CCII (in combinato con l’art. 2486 c.c.) prevede che la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in situazione di crisi possa dare luogo a responsabilità diretta verso i creditori insoddisfatti. In altre parole, se l’impresa ormai insolvente aggrava il proprio dissesto perché l’organo amministrativo ha colpevolmente procrastinato gli interventi dovuti (ad esempio continuando ad accumulare debiti quando era già evidente l’incapacità di ripagarli), gli amministratori possono essere chiamati a rispondere personalmente di quei maggiori danni verso i creditori. Si tratta, di fatto, di una versione italiana del wrongful trading: il management che “tira a campare” in una situazione di insolvenza manifesta rischia di dover risarcire i creditori per l’aggravamento del passivo. La Cassazione aveva già affermato questo principio prima della riforma – qualificando la responsabilità per il periodo successivo alla perdita del capitale come extracontrattuale sui generis – e la riforma lo ha ulteriormente rafforzato in via normativa.
Oltre agli amministratori, anche gli organi di controllo interni (collegio sindacale, sindaco unico, revisori) sono investiti di nuovi obblighi. Dal 2019 molte S.r.l. di minori dimensioni hanno dovuto nominare un organo di controllo al superamento di determinati parametri (attivo > €4 milioni, ricavi > €4 milioni o > 20 dipendenti). Ciò per estendere la vigilanza anche alle PMI. I sindaci devono verificare che gli amministratori predispongano gli assetti adeguati e devono attivare la procedura di allerta interna se rilevano indizi di crisi: in base all’art. 24 CCII, devono segnalare per iscritto agli amministratori le situazioni allarmanti e le possibili misure da prendere. Se gli amministratori non rispondono entro 30 giorni, il collegio sindacale potrebbe (nel vecchio impianto) informare l’OCRI ovvero, stante l’evoluzione normativa, rivolgersi al tribunale ex art. 2409 c.c. per far emergere le irregolarità. Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha inoltre equiparato il revisore legale ai sindaci quanto all’obbligo di segnalazione. Se sindaci o revisori omettono di vigilare o di segnalare, possono incorrere a loro volta in responsabilità verso la società e i creditori per omessa vigilanza ex art. 2407 c.c.. In sintesi, tutti gli attori interni sono ora “sentinelle” della crisi: l’imprenditore deve gestire attivamente e informare gli organi sociali, e questi ultimi devono pungolare l’imprenditore e intervenire se egli resta inerte.
Allerta “esterna”: segnalazioni da parte di Fisco e INPS (allerta ex art. 25-novies CCII)
Accanto ai doveri di monitoraggio interno, il Codice della Crisi ha introdotto un sistema di allerta esterna affidato a determinati creditori pubblici qualificati: in particolare l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). Questi enti, avendo il polso immediato dei mancati versamenti di imposte e contributi da parte delle imprese, sono tenuti a segnalare formalmente al debitore il superamento di certe soglie di debito scaduto, sollecitandolo a prendere provvedimenti. L’idea è di creare un “campanello d’allarme” ufficiale anche dall’esterno: se un’azienda ha accumulato debiti fiscali o previdenziali oltre una certa entità e non li ha pagati per un certo periodo, ciò è sintomatico di crisi finanziaria; in tal caso il Fisco o l’INPS inviano una comunicazione via PEC all’imprenditore (e per conoscenza all’organo di controllo, se presente) invitandolo ad attivare la composizione negoziata della crisi o comunque a porre rimedio.
Le soglie di debito scaduto che fanno scattare l’obbligo di segnalazione (introdotte dal D.L. 152/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022) sono le seguenti:
- INPS (contributi previdenziali): ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi per un importo > €15.000 per imprese con dipendenti (ed equivalente ad almeno il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente), oppure > €5.000 per imprese senza dipendenti. In sostanza, se l’azienda accumula contributi arretrati oltre queste soglie e per almeno tre mesi, l’INPS deve attivarsi con la segnalazione.
- Agenzia delle Entrate (IVA): esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalle comunicazioni trimestrali IVA (LIPE), superiore a €5.000. Basta dunque il mancato versamento di IVA periodica oltre 5.000 € perché scatti l’allerta fiscale.
- Agente della Riscossione (AER): presenza di crediti affidati all’Agente della Riscossione (cartelle esattoriali) scaduti da oltre 90 giorni, per importi complessivi superiori a: €100.000 per imprese individuali, €200.000 per società di persone, €500.000 per società di capitali. In pratica si tratta di cartelle esattoriali non pagate per importi elevati (a seconda della forma giuridica).
Queste soglie non sono affatto astronomiche, specie per IVA e contributi: €5.000 di IVA non versata può capitare anche a una PMI piccola, e €15.000 di contributi arretrati equivalgono a pochi mesi di stipendi di qualche dipendente. Ciò riflette l’approccio preventivo del sistema di allerta esterna: si vuole suonare l’allarme già nelle fasi iniziali della difficoltà, quando i debiti non sono ancora insostenibili, affinché l’impresa “corra ai ripari” finché è in tempo.
Di seguito una tabella riepilogativa delle soglie di allerta esterna previste:
| Ente segnalante (creditore pubblico) | Soglia di debito scaduto | Condizioni | Tempistiche segnalazione |
|---|---|---|---|
| INPS (contributi) | > €15.000 (imprese con dipendenti, e ≥30% dei contributi dell’anno precedente); <br> > €5.000 (imprese senza dipendenti) | Contributi non versati da > 90 giorni oltre tale soglia. | Trascorsi 60 giorni dal superamento della soglia senza regolarizzazione, invio PEC a debitore e sindaci. |
| Agenzia Entrate (IVA trimestrale) | > €5.000 di IVA risultante da liquidazioni periodiche (LIPE) non versata | Omesso versamento dell’IVA trimestrale per importo eccedente €5.000 (anche per un solo trimestre). | Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo IVA considerato: ad es. per il 1º trimestre (scad. 16/5) avviso entro 60 gg successivi. |
| Agente Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) | > €100.000 (ditte individuali); <br> > €200.000 (società di persone); <br> > €500.000 (società di capitali) | Debiti fiscali o contributivi affidati all’Agente riscossione, scaduti da > 90 giorni, eccedenti tali soglie complessive. | Entro 60 giorni dal riscontro del superamento soglia e persistenza del debito non pagato. |
Come avviene e che effetti ha la segnalazione: Trascorsi 60 giorni dal superamento della soglia senza che il debitore abbia pagato o regolarizzato il debito, l’ente invia via PEC una comunicazione formale all’impresa (e all’organo di controllo). Nella lettera si evidenzia l’ammontare del debito scaduto e si invita espressamente l’imprenditore ad attivare la procedura di composizione negoziata della crisi o comunque a prendere provvedimenti correttivi. Attenzione: la segnalazione non fa scattare automaticamente alcuna procedura concorsuale (non esiste più il vecchio meccanismo di allerta pubblica con attivazione d’ufficio di OCRI). Tuttavia, di fatto, pone l’imprenditore di fronte a una scelta obbligata se vuole evitare guai peggiori. Dal momento della PEC, gli amministratori non possono più ignorare lo stato di crisi: sono stati formalmente avvisati, quindi un successivo immobilismo potrà essere giudicato come grave negligenza. Infatti, se l’azienda non reagisce e poi viene dichiarata insolvente, il curatore o i creditori insoddisfatti avranno facile gioco nel contestare che “già dal tal giorno sapevate di essere in crisi e non avete fatto nulla”. Ciò alimenta sia possibili azioni di responsabilità civile sia possibili addebiti penali (es. bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, ex art. 217 L.F. / art. 322 CCII). Inoltre, il fatto che la PEC sia inviata anche ai sindaci/revisori attiva pure questi ultimi: se gli amministratori ignorano l’avviso, i sindaci dovranno valutare interventi (fino a denunciare le gravi irregolarità in tribunale) per non diventare corresponsabili.
In definitiva, un imprenditore avvisato da Fisco o INPS non è legalmente obbligato ad attivare la composizione negoziata, ma ignorare la segnalazione sarebbe estremamente pericoloso. Il percorso virtuoso è quello di reagire tempestivamente: riconoscere la gravità del segnale e intraprendere subito iniziative per il risanamento o quantomeno per gestire la situazione in modo ordinato. Nel riquadro seguente riassumiamo i consigli operativi:
Promemoria pratico: Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, occorre tenere sempre a mente che: (a) bisogna organizzare l’azienda con adeguati controlli interni per cogliere per tempo i segnali di crisi (questo rientra nei doveri professionali di diligenza); (b) in caso di difficoltà nei pagamenti fiscali o contributivi, c’è un rischio concreto di ricevere avvisi formali da Agenzia Entrate o INPS che non vanno ignorati; (c) il dialogo con sindaci e revisori è fondamentale: gli organi di controllo non sono “nemici” ma alleati nel prevenire il tracollo (se segnalano problemi, ascoltarli può salvarvi da conseguenze peggiori); (d) se ci sono chiari segnali di crisi, conviene attivarsi volontariamente (piani di risanamento, composizione negoziata, ecc.) piuttosto che aspettare le segnalazioni esterne o – peggio – che siano i creditori a portare l’azienda in tribunale.
Conseguenze dell’inerzia: rischio di azioni dei creditori e procedure concorsuali d’ufficio
È importante capire che, se il debitore non prende iniziative e la situazione di insolvenza peggiora, i creditori possono attivarsi essi stessi per tutelare le proprie ragioni, spesso in modo aggressivo. Un creditore impaziente può iniziare procedure esecutive singolari (pignoramenti) contro l’azienda, oppure può presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) in tribunale se ritiene che l’impresa sia insolvente. Nel caso della nostra FiltriOlio S.r.l., ad esempio, un fornitore non pagato potrebbe chiedere al tribunale la liquidazione giudiziale della società. Se in quella sede emergerà che mesi prima l’azienda aveva ricevuto le segnalazioni di allerta da Fisco/INPS e non ha fatto nulla, il tribunale difficilmente concederà attenuanti: è probabile che dichiari l’insolvenza aprendo la liquidazione giudiziale e segnali al pubblico ministero la condotta omissiva degli amministratori. Ciò comporterebbe non solo la perdita della gestione dell’azienda (affidata a un curatore fallimentare), ma possibili azioni di responsabilità personale verso l’amministratore e persino conseguenze penali (per bancarotta semplice o addirittura fraudolenta, se emergessero distrazioni di beni). In sintesi, l’inerzia è il peggior nemico: espone l’imprenditore al rischio di perdere completamente il controllo della situazione e di aggravare le proprie responsabilità.
Al contrario, attivarsi per tempo offre diversi vantaggi difensivi: può consentire di negoziare con i creditori in modo ordinato, di accedere a procedure che congelano temporaneamente le azioni esecutive individuali e di presentarsi (eventualmente davanti al tribunale) con un piano in mano invece che a mani vuote. Anche qualora poi la crisi si rivelasse irrisolvibile, un comportamento proattivo e trasparente dell’imprenditore viene valutato positivamente ai fini, ad esempio, della concessione dell’esdebitazione (la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione) e per evitare contestazioni di mala gestio. Nel prossimo capitolo passeremo in rassegna proprio le possibili azioni dei creditori e i rischi legali legati ai vari tipi di debito, per poi illustrare gli strumenti a disposizione del debitore per fronteggiarli.
Categorie di debiti e strategie di difesa
I debiti contratti da un’azienda non sono tutti uguali: differiscono per natura giuridica, per i diritti e le tutele di cui godono i rispettivi creditori e per gli strumenti con cui possono essere gestiti o ristrutturati. Analizziamo le principali categorie di debiti che una società come FiltriOlio S.r.l. può avere (fiscali, previdenziali, bancari/finanziari, commerciali) evidenziando, per ciascuna, cosa possono fare i creditori per il recupero forzoso e come può difendersi il debitore. Infine, esamineremo le caratteristiche delle azioni esecutive (pignoramenti) che i creditori possono intraprendere e quali rimedi ha l’impresa per contrastarle o sospenderle.
Debiti fiscali (verso Erario e Agenzia Entrate Riscossione)
I debiti fiscali includono imposte dovute allo Stato (o ad altri enti impositori) come IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ritenute su redditi di lavoro, accise, tributi locali, ecc. Nel nostro scenario, FiltriOlio S.r.l. ha circa €150.000 di debiti tributari, prevalentemente IVA non versata e imposte arretrate. Questi debiti sono particolarmente delicati perché il Fisco dispone di poteri di riscossione molto efficaci e privilegi legali sui beni del debitore.
- Titoli e procedure di riscossione: A differenza di un normale creditore commerciale, l’Amministrazione Finanziaria non ha bisogno di una causa civile per accertare il credito: le imposte sono liquidate tramite ruoli/cartelle esattoriali o accertamenti esecutivi. Una volta notificata una cartella esattoriale o un avviso di accertamento esecutivo e decorso il termine per pagare (generalmente 60 giorni), la riscossione passa all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione, ex Equitalia) che può avviare direttamente misure esecutive. Tra gli strumenti a disposizione vi sono: fermo amministrativo di beni mobili (ad es. automezzi aziendali), iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà della società, pignoramento di conti correnti e crediti verso terzi, pignoramento mobiliare presso la sede e, in casi estremi, espropriazione immobiliare. Il tutto senza bisogno di un previo giudizio, in virtù del ruolo esattoriale che costituisce titolo esecutivo. Quindi, un’azienda con debiti fiscali insoluti può trovarsi, dopo le dovute notifiche, con il conto bancario bloccato o i macchinari pignorati dall’Esattore.
- Grado di privilegio: In caso di insolvenza conclamata, i crediti dello Stato e degli enti pubblici godono di privilegi generali sui beni mobili e immobili del debitore. Ad esempio, l’IVA, le ritenute non versate e altre imposte dirette sono assistite da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. (talora anche speciale su beni specifici, come l’ipoteca per imposte su immobili). Ciò significa che, in una distribuzione concorsuale (fallimento o concordato), il Fisco viene soddisfatto prima dei creditori chirografari (non garantiti), fino a concorrenza del valore dei beni su cui insiste il privilegio. Tuttavia, se il patrimonio è insufficiente, anche il Fisco può subire decurtazioni (la parte di credito che non trova capienza sotto il privilegio degrada a chirografo). Storicamente vi erano limiti severi alla possibilità di falcidiare (ridurre) crediti fiscali privilegiati nelle procedure: ad esempio, sotto la vecchia legge fallimentare, l’IVA non poteva essere mai falcidiata nel concordato preventivo (si poteva solo dilazionarne il pagamento), in ossequio a norme UE. Tale divieto assoluto è stato però superato, come vedremo, da interventi normativi e pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale.
- Azioni difensive del debitore: Un’impresa con debiti fiscali ha essenzialmente tre strade per difendersi: (1) trovare un accordo transattivo o una dilazione con il Fisco al di fuori delle procedure concorsuali; (2) includere i debiti tributari in un piano di ristrutturazione o concordatario all’interno di una procedura (avvalendosi degli strumenti offerti dal CCII, come la transazione fiscale); (3) eccepire eventuali vizi formali nelle cartelle/atti per guadagnare tempo (opposizioni in Commissione Tributaria), anche se ciò raramente risolve alla radice il problema.
Dilazione amministrativa: Fuori dalle procedure concorsuali, il debitore può chiedere all’Agente della Riscossione una rateizzazione dei debiti fiscali iscritti a ruolo (fino a 72 rate mensili, ossia 6 anni; in casi di grave difficoltà fino a 120 rate, ossia 10 anni, se l’importo supera determinate soglie). La normativa (DPR 602/1973) consente infatti di diluire il pagamento presentando un’istanza motivata: se accordata, la rateazione sospende le azioni esecutive sull’atto dilazionato, a patto di rispettare le rate. Nel 2023-2024 sono state introdotte anche misure di definizione agevolata (le cosiddette rottamazioni delle cartelle), che permettono di estinguere i ruoli con sanzioni e interessi ridotti. Ad esempio, la “Rottamazione-quater 2023” (D.L. 51/2023 conv. L. 87/2023) ha consentito di pagare le cartelle 2000-2017 senza sanzioni né interessi di mora, in 18 rate. Tali strumenti straordinari, quando disponibili, vanno sfruttati dal debitore per alleggerire il carico fiscale. Nota: Sia la dilazione ordinaria che la rottamazione richiedono comunque il pagamento integrale (al netto di sanzioni condonate) delle imposte dovute – non rappresentano un taglio dell’imposta capitale, ma solo un beneficio sui tempi o sugli accessori.
Transazione fiscale nelle procedure di crisi: Il vero strumento per ridurre l’ammontare dei debiti fiscali è la transazione fiscale, prevista oggi dall’art. 63 CCII (già art. 182-ter l.f.). In sostanza, all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può proporre al Fisco il pagamento parziale (falcidia) e/o dilazionato dei tributi, incluse IVA e ritenute, e delle contribuzioni previdenziali. Questa possibilità – frutto di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale – devia dalla regola generale secondo cui i crediti privilegiati devono essere soddisfatti integralmente salvo incapienza. La transazione fiscale consente al piano di prevedere che il Fisco (e gli enti previdenziali) riceva meno del 100% del dovuto, purché tale proposta sia ritenuta migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale. In altre parole, bisogna dimostrare (con una perizia indipendente) che, accettando quel pagamento parziale, l’Erario ottiene comunque più di quanto ricaverebbe in caso di fallimento dell’azienda. Ad esempio, se da una liquidazione fallimentare l’Erario stimerebbe di recuperare solo il 10% del proprio credito privilegiato (dati i pochi asset liberi dell’azienda), una proposta concordataria di pagargli il 30% dilazionato potrà essere considerata conveniente.
La transazione fiscale richiede l’adesione dell’Amministrazione finanziaria (e dell’INPS per i contributi): in sede di concordato preventivo si traduce in un voto favorevole nella classe dei crediti erariali, oppure nell’accordo di ristrutturazione si traduce in una firma dell’Agenzia Entrate su quella proposta. In passato, se il Fisco non aderiva, la transazione falliva e il concordato non poteva essere omologato con quel taglio (bisognava pagare integralmente i tributi “infalcidiabili”). Novità 2023: il legislatore ha previsto un meccanismo di cram-down fiscale, cioè di omologa forzosa anche senza adesione del Fisco, a certe condizioni. In particolare, con il D.L. 69/2023 convertito (art. 1-bis) e poi con il correttivo 2024, è stato stabilito che il tribunale può omologare ugualmente un accordo di ristrutturazione o un concordato nonostante il voto/pare negativo del Fisco o dell’INPS, se: (a) la proposta non è meramente liquidatoria; (b) il voto dell’Erario era determinante per raggiungere le maggioranze richieste; (c) almeno il 25% degli altri crediti ha aderito; (d) la proposta verso Fisco/INPS è conveniente rispetto al fallimento secondo l’attestatore; (e) viene garantito all’Erario almeno il 30% del suo credito (40% in alcuni casi). Inoltre, l’adesione del Fisco deve eventualmente arrivare entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione. In sostanza, se il debitore offre al Fisco una percentuale significativa (≥30%) che supera di gran lunga quanto otterrebbe in liquidazione, il tribunale può forzare l’omologazione dell’accordo o concordato anche senza il consenso dell’Erario. Questo è un notevole passo avanti per il debitore: rimuove il potere di veto assoluto che il Fisco aveva un tempo, bilanciandolo con la tutela dell’interesse erariale a ottenere almeno una certa soglia.
Difese processuali: Sul piano processuale, un’impresa può guadagnare tempo opponendosi alle cartelle o agli atti dell’Agente di Riscossione per vizi formali (notifica errata, prescrizione, ecc.) davanti alle Commissioni Tributarie o al giudice dell’esecuzione. Tali opposizioni raramente annullano il debito (a meno di errori sostanziali), ma possono ottenere sospensioni temporanee dell’esecuzione. È una strategia che va valutata con attenzione e tipicamente in abbinamento a un piano di ristrutturazione: l’opposizione da sola non risolve il problema, ma può ritardare pignoramenti in attesa che si concretizzi una soluzione concordata (ad esempio, chiedendo la sospensione dell’esecuzione ex art. 62 CCII contestualmente a un ricorso per concordato preventivo).
Ricapitolando per FiltriOlio S.r.l.: con €150.000 di debiti fiscali, inclusa IVA non versata, l’azienda rischia azioni esecutive aggressive (l’Agente Riscossione potrebbe aver già iscritto ipoteca sul capannone o pignorato il conto). Per difendersi, FiltriOlio potrebbe chiedere una rateazione immediata delle cartelle per sospendere le azioni in corso. Nel frattempo, nel quadro di un piano più ampio, potrebbe predisporre una proposta di transazione fiscale da inserire in un accordo di ristrutturazione o concordato: ad esempio offrire all’Erario il pagamento del 30-40% del dovuto in 5 anni, dimostrando che in caso di fallimento il Fisco prenderebbe forse solo il 10%. Se l’Agenzia Entrate aderisce, bene; se no, grazie alle nuove norme, l’azienda potrebbe comunque ottenere l’omologa se rispetta i parametri (offerta ≥30% e attestazione di convenienza). In ogni caso, ignorare il debito fiscale non è un’opzione: oltre alle azioni civili, vanno considerati i profili penali. Infatti, il mancato versamento di IVA oltre soglia €250.000 per anno è reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 (art. 10-bis). Il nostro imprenditore, agendo per tempo con una procedura concordata di ristrutturazione, può evitare anche questi esiti: il pagamento dilazionato concordatario dell’IVA, ad esempio, esclude la punibilità penale se il concordato va a buon fine, in quanto il fatto perde il carattere di illecito (principio di diritto affermato dalla Cassazione). Dunque, inserire i debiti fiscali in una soluzione negoziata serve sia a gestire civilmente il debito sia a mitigare rischi penali.
Debiti contributivi e previdenziali (INPS)
I debiti verso l’INPS (o altri enti previdenziali, come casse professionali) riguardano contributi obbligatori non versati per i lavoratori dipendenti o per i titolari. Nel caso della nostra azienda, vi sono €50.000 di contributi arretrati. Questi debiti condividono molte similitudini con quelli fiscali, ma presentano anche peculiarità:
- Privilegi e tutele: I contributi previdenziali vantano un privilegio generale mobiliare di grado elevato (art. 2753 c.c.) – addirittura prelazione di secondo grado dopo i crediti per retribuzioni. In un fallimento, dunque, i crediti INPS vengono pagati subito dopo gli stipendi non pagati ai lavoratori (che sono di primo grado), e prima di tutti gli altri. Questo significa che, salvo mancanza totale di attivo, l’INPS spesso recupera una parte significativa. Anche per i contributi, storicamente c’era il divieto di falcidia in alcune procedure (nel sovraindebitamento ad esempio, poi rimosso dalla Corte Costituzionale nel 2020). Oggi il CCII consente di includere i contributi in piani di ristrutturazione esattamente come i tributi: la cosiddetta transazione contributiva è parallela a quella fiscale.
- Poteri di riscossione: La riscossione dei contributi INPS avviene tramite Avvisi di Addebito immediatamente esecutivi, affidati poi all’Agente della Riscossione (lo stesso meccanismo delle cartelle). L’INPS inoltre, se il datore omette i versamenti delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, può denunciare penalmente l’amministratore: l’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (conv. L. 638/1983) punisce l’omesso versamento di ritenute previdenziali per importi superiori a €10.000 annui. Sotto €10.000 è illecito amministrativo, sopra è reato (punibile con multa o nei casi gravi con la reclusione fino a 3 anni). Va notato che il reato si estingue se il datore paga integralmente il dovuto (anche tardivamente) prima dell’apertura del dibattimento. Dunque, è essenziale affrontare subito questi debiti per evitare degenerazioni penali.
- Dilazioni e interventi amministrativi: Anche l’INPS consente piani di rateazione per i contributi dovuti (solitamente fino a 24 mesi, estensibili straordinariamente). Inoltre, esiste un Fondo di Garanzia INPS che interviene per pagare ai lavoratori TFR e ultime mensilità in caso di insolvenza del datore: però questo poi surroga l’INPS nei confronti dell’azienda, generando ulteriori crediti INPS.
- Transazione contributiva in piani di crisi: Nell’ambito di un concordato o accordo di ristrutturazione, l’azienda può proporre all’INPS un pagamento parziale dei contributi arretrati analogamente alle imposte. Ad esempio, offrire il 40% dei contributi dovuti dilazionato. L’INPS, come il Fisco, valuterà la proposta in base alla convenienza rispetto a una liquidazione forzata. Se aderisce, la transazione va in porto; se non aderisce ma l’offerta è almeno al 30% ed è sostenuta dalla maggioranza degli altri creditori, il tribunale può comunque omologare secondo le norme sul cram-down fiscale/previdenziale.
Strategie per FiltriOlio S.r.l. sui debiti INPS: l’azienda ha €50.000 di contributi non pagati, di cui una parte riguarda verosimilmente ritenute su stipendi già corrisposti ai dipendenti. La priorità è evitare il reato ex D.L. 463/1983: se il 2024 è stato omesso per €20.000, c’è rischio penale. Dunque, FiltriOlio potrebbe: (a) versare almeno parzialmente le ritenute entro il limite non punibile (€10.000) o comunque prima del dibattimento (ad esempio con un mutuo o anticipo, se riesce, per contenere la propria esposizione penale); (b) includere i contributi in un piano di rientro concordatario. Una volta avviata una procedura concordata (composizione negoziata o concordato), FiltriOlio può anche chiedere all’INPS un DURC provvisorio (Documento Unico Regolarità Contributiva) per poter continuare ad operare con la PA: spesso i tribunali autorizzano il rilascio del DURC durante il concordato in bianco o la composizione negoziata, per evitare che l’azienda perda appalti pubblici a causa di irregolarità contributive. In definitiva, i debiti contributivi vanno integrati nella strategia generale: rateazione + transazione nella procedura formale, assicurandosi di sanare (o garantire) almeno la parte di ritenute che coinvolge la responsabilità penale dell’amministratore.
Debiti bancari e finanziari
I debiti verso banche o altri finanziatori (leasing, società di factoring, ecc.) rappresentano spesso la quota maggiore dell’indebitamento di un’azienda in crisi. Nel nostro esempio, FiltriOlio S.r.l. ha circa €800.000 di esposizione bancaria, di cui una parte garantita da ipoteca sul capannone e una parte in scoperti di conto corrente. Questi creditori hanno caratteristiche specifiche:
- Garanzie e titolo esecutivo: Le banche sovente dispongono di garanzie reali (ipoteche su immobili, pegni su macchinari o su crediti) oppure di fideiussioni personali dei soci/amministratori. Ciò dà loro un vantaggio: il credito ipotecario è privilegiato sul ricavato dei beni dati in garanzia (fino a copertura del valore del bene) e in caso di insolvenza viene soddisfatto con precedenza sui beni ipotecati. Se la banca ha anche la garanzia personale di Tizio (socio), può escutere Tizio per l’intero importo a prescindere dalla procedura sull’azienda. Inoltre, i contratti bancari (mutui, fidi) di solito prevedono clausole risolutive o decadenze dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento, che permettono alla banca di chiedere il rimborso immediato di tutto il credito residuo. Una volta dichiarata la decadenza dal termine o risolto il contratto, la banca ha un titolo esecutivo (per esempio un mutuo fondiario non pagato costituisce titolo per iniziare pignoramento). Può quindi procedere a esecuzione forzata in tempi rapidi sul bene ipotecato o sui conti.
- Rimedi contrattuali della banca: Un segnale di crisi è spesso il comportamento delle banche: se l’azienda ritarda pagamenti o sconfina dai fidi, la banca può revocare gli affidamenti (fidi di cassa, castelletti) e richiedere il rientro immediato, aggravando la crisi di liquidità. Nel 2025, le normative di vigilanza impongono alle banche di classificare come UTP (Unlikely To Pay) o sofferenze certe esposizioni deteriorate, il che spinge l’istituto spesso ad agire o a vendere il credito a società di recupero. Tuttavia, va menzionato che il CCII ha introdotto norme per incoraggiare le banche a sostenere imprese in composizione negoziata o concordato, attenuando il rischio di azioni revocatorie o responsabilità per concessione abusiva di credito. Ad esempio, finanziamenti erogati durante una composizione negoziata con il placet dell’esperto possono ottenere lo status di prededucibili (da restituire con priorità). Inoltre, è stato chiarito che continuare a dare credito a un’impresa in crisi, se avviene nell’ambito di un tentativo ragionevole di risanamento, non espone la banca ad azioni di responsabilità da parte di altri creditori (viene meno il timore della “concessione abusiva di credito” e delle revocatorie per finanziamenti concessi). Questo clima normativo mira a incentivare le banche a negoziare piuttosto che a staccare subito la spina.
- Difesa e negoziazione col ceto bancario: Come può difendersi l’azienda debitrice? Innanzitutto, se vi sono garanzie personali dei soci/amministratori, occorre essere consapevoli che la banca – anche se l’azienda entra in procedura concorsuale – potrà agire contro i garanti senza particolari limitazioni. Una strategia è includere, nelle trattative di ristrutturazione, anche la posizione dei garanti, cercando di ottenere dalle banche una liberatoria o una transazione sull’esposizione personale (spesso i garanti offrono un pagamento parziale pro solvendo per chiudere la posizione). Però legalmente questo richiede l’accordo della banca (le procedure concorsuali dell’azienda non liberano i co-obbligati ex art. 1239 c.c., quindi il concordato dell’azienda non estingue la garanzia del fideiussore se la banca non acconsente).
La leva principale del debitore è mostrare alle banche che conviene ristrutturare invece che liquidare. Se FiltriOlio finisse in liquidazione giudiziale, la banca ipotecaria magari recupererebbe solo il valore d’asta dell’immobile (spesso inferiore al credito) dopo anni, e la parte chirografaria rimarrebbe insoluta. Invece un piano di ristrutturazione potrebbe offrire alla banca un rimborso maggiore e più rapido. Strumenti specifici: l’azienda può proporre alle banche una moratoria temporanea (sospensione dei pagamenti delle rate per 6-12 mesi) mentre cerca investitori o attua un piano – spesso ciò avviene tramite accordi stragiudiziali o all’interno di una composizione negoziata (come accordi di standstill). Può anche proporre una rischedulazione del debito (allungamento delle scadenze, riduzione tasso) o una conversione del debito (ad es. una parte di debito trasformata in strumenti partecipativi o equity). In rari casi, se la banca è disponibile, si può tentare un stralcio (rinuncia a parte del credito): di solito ciò avviene se la banca ha già svalutato il credito e preferisce incassare subito una percentuale piuttosto che rischiare meno in futuro.
Dal punto di vista legale, questi accordi possono essere formalizzati in un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (che richiede almeno il 60% dei crediti finanziari consenzienti e l’omologa del tribunale). Il vantaggio di un accordo omologato è che vincola anche eventuali banche dissenzienti se si raggiunge il 75% di adesioni nel pool bancario (c.d. accordo ad efficacia estesa). Per esempio, se 4 banche su 5 accettano la ristrutturazione e rappresentano l’85% del credito bancario, il tribunale può estendere l’accordo anche alla quinta banca riluttante. Ciò evita che un singolo istituto rovini la ristrutturazione.
Nel frattempo, per bloccare azioni esecutive di singole banche (ad es. l’esecuzione ipotecaria sul capannone), l’impresa può far ricorso a misure protettive offerte dalle procedure: depositando un ricorso per concordato preventivo o per omologazione di un accordo di ristrutturazione, può ottenere la sospensione temporanea delle esecuzioni (stay). Addirittura, in composizione negoziata può chiedere al tribunale misure cautelari/protettive mirate per impedire alle banche di escutere le garanzie durante le trattative (art. 20 CCII).
In concreto, FiltriOlio S.r.l. con la sua banca: poniamo che la banca abbia un’ipoteca sul capannone per un mutuo residuo €500.000, e un’esposizione chirografaria di €300.000 in conto corrente garantita dai fidiussori (i soci). L’immobile vale sui €300.000 sul mercato. La banca quindi, in caso di escussione, recupererebbe quell’importo e resterebbe chirografa per €200.000 (perdendo buona parte, salvo aggredire i soci garanti). FiltriOlio potrebbe proporre nel piano: la vendita controllata del capannone a €300.000 con pagamento immediato alla banca, più il pagamento di un ulteriore 50% del residuo (€100.000) in alcuni anni, forse attingendo a nuovi finanziamenti dei soci, in cambio della liberazione delle fideiussioni. In totale la banca recupererebbe €400.000 su €500.000 (80%) invece del 60% circa stimato in fallimento, e i soci eviterebbero di vedersi pignorare la casa. Questo tipo di accordo win-win può convincere la banca ad aderire. Se la banca invece rifiuta e minaccia l’esecuzione, l’azienda può nel frattempo avviare un concordato preventivo in bianco ottenendo lo stay immediato sui beni (art. 46 CCII: i creditori, inclusa la banca, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive una volta presentata la domanda di concordato). Ciò darebbe a FiltriOlio 4 mesi di tempo (prorogabili a 6) per finalizzare una proposta concordataria o un accordo, durante i quali la banca non può vendere l’immobile all’asta.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
I debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi (e altri crediti non garantiti, come quelli di professionisti, locatori per affitti, ecc.) costituiscono la categoria dei creditori chirografari, ovvero privi di garanzie o privilegi. Nel nostro caso FiltriOlio S.r.l. deve circa €200.000 a vari fornitori di materiali e servizi. Questi creditori, pur non avendo prelazioni, possono mettere in seria difficoltà l’azienda sospendendo le forniture o intraprendendo azioni legali:
- Tutela contrattuale e azioni legali: Un fornitore non pagato può rifiutare ulteriori forniture (facendo valere clausole “solve et repete” se presenti o semplicemente sospendendo la consegna per inadempimento altrui, ex art. 1460 c.c.). Inoltre, può chiedere un decreto ingiuntivo per il credito e, dopo 40 giorni senza opposizione, ottenerne l’esecutorietà e procedere con pignoramenti (spesso su conti correnti o crediti presso terzi, come i crediti del debitore verso i suoi clienti). A differenza delle banche o del Fisco, i fornitori non hanno accesso a titoli immediatamente esecutivi: devono passare da un decreto ingiuntivo o una causa ordinaria. Questo richiede tempo, ma molti creditori agiscono celermente. Un singolo fornitore (o un aggregato di essi) se il credito supera una certa entità può anche presentare istanza di fallimento dell’azienda debitrice. Non esiste più una soglia minima di importo per poter chiedere il fallimento (sotto la vecchia legge fall. erano €30.000 di debiti complessivi, ora l’art. 2 CCII definisce imprenditore minore chi ha un attivo inferiore a €300.000 o debiti sotto €500.000, ma comunque anche un “piccolo” può essere soggetto a liquidazione giudiziale se insolvente, salvo dirottamento nelle procedure di sovraindebitamento se persona fisica). Dunque anche fornitori relativamente piccoli possono innescare la procedura concorsuale.
- Risoluzione dei contratti in corso: Un altro rischio è la risoluzione di contratti di fornitura essenziali: se FiltriOlio ha contratti di fornitura a lungo termine e risulta inadempiente, il fornitore potrebbe risolvere il contratto (artt. 1453 ss. c.c.), lasciando l’azienda priva di materie prime. Nella crisi d’impresa entrano in gioco norme speciali per gestire i contratti pendenti, specie nel concordato: l’art. 94 CCII consente al debitore in concordato di chiedere l’autorizzazione del tribunale a sciogliersi da contratti eccessivamente onerosi o, viceversa, a mantenere attivi contratti essenziali (impedendo la risoluzione per clausole ipso facto). Ma al di fuori delle procedure, la facoltà di recesso dei partner contrattuali può aggravare la crisi.
- Strategie di pagamento e negoziazione: Per difendersi, l’azienda debitrice deve valutare quali fornitori sono critici e assicurarsi la loro collaborazione. Spesso nelle crisi si opera un blocking payment: l’azienda smette di pagare alcuni creditori (quelli ritenuti meno pericolosi o meno essenziali) per destinare la poca cassa ai fornitori strategici, mantenendoli allineati. Ciò però comporta il rischio di azioni legali da parte di quelli non pagati. Una strategia più sostenibile è negoziare accordi transattivi individuali: ad esempio offrire a un fornitore uno sconto a saldo e stralcio (pagamento immediato del 50% del credito in cambio della rinuncia al restante) oppure un piano di rientro rateale (magari garantito da effetti cambiari), facendo leva sul fatto che in caso di fallimento il fornitore rischierebbe di incassare molto meno e molto tardi. Molti fornitori, specie se di piccole dimensioni, preferiscono assicurarsi qualcosa subito piuttosto che affrontare cause costose e dall’esito incerto.
Tuttavia, è importante muoversi con cautela: pagare selettivamente alcuni fornitori e non altri può esporre l’azienda a azioni revocatorie successivamente (se si arriva al fallimento, i pagamenti preferenziali effettuati entro 6 mesi prima possono essere revocati dal curatore). Una soluzione è incanalare queste negoziazioni all’interno di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato, che prevede l’esenzione da revocatoria per i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano omologato. Ad esempio, se in un accordo ex art. 57 CCII si stabilisce di pagare integralmente i piccoli fornitori fino a €5.000 (per non disperdere la rete di forniture), tali pagamenti saranno protetti dall’eventuale revocatoria fallimentare ex post.
Nell’ambito di un concordato preventivo, i fornitori (chirografari) verranno raggruppati in classi e soddisfatti secondo il piano con una certa percentuale. La legge richiede che nel concordato liquidatorio puro i chirografari ottengano almeno il 20%, mentre nel concordato in continuità non c’è una percentuale minima garantita ma il piano deve comunque assicurare loro un trattamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione (principio di migliore soddisfazione). FiltriOlio, ad esempio, potrebbe proporre ai fornitori chirografari un pagamento del 30% in 2 anni: i fornitori voteranno in assemblea dei creditori se accettare. Molti fornitori, specie se mantengono rapporti di business col debitore, sono incentivati ad accettare un concordato che garantisca la prosecuzione dell’attività (così l’azienda resta cliente) anziché spingerla al fallimento dove recupererebbero magari solo il 5-10%.
- Azioni difensive contro esecuzioni dei fornitori: Se un fornitore ha già un decreto ingiuntivo e avvia un pignoramento (ad es. sul conto corrente di FiltriOlio, bloccando liquidità), l’azienda può tentare un’opposizione all’esecuzione per ragioni formali o sostanziali (ad esempio contestare la quantificazione del credito) per guadagnare qualche settimana. Ma la soluzione più efficace, ripetiamo, è mettere in sicurezza l’impresa con una procedura concorsuale o semi-concorsuale: presentare una domanda di concordato (anche con riserva) blocca tutti i pignoramenti in corso (sono inefficaci i pignoramenti non ancora definiti con assegnazione, ex art. 54 CCII) e impedisce nuovi atti esecutivi. Allo stesso modo, avviare la composizione negoziata permette di chiedere al giudice la sospensione di specifiche azioni esecutive per massimo 120 giorni.
In sintesi, per i debiti verso fornitori di FiltriOlio: l’azienda deve fare un’analisi: quali fornitori sono vitali (es. il fornitore di filtri grezzi senza cui non produce)? Quelli vanno preferibilmente pagati regolarmente o inclusi in accordi che ne assicurino la continuità (magari pagandoli per forniture correnti e spalmando il pregresso). Gli altri fornitori, meno critici, possono essere gestiti nel piano con pagamenti parziali differiti. Ad esempio, FiltriOlio potrebbe proporre nel concordato di pagare integralmente i fornitori sotto €5.000 (importi piccoli, per non creare troppi creditori ostili) e pagare al 30% i restanti, in due rate annuali. Questo magari con l’impegno di conservare tali fornitori come partner futuri, così che anche loro abbiano interesse alla sopravvivenza dell’azienda. Fondamentale è comunicare con i fornitori, spiegando la situazione e prospettando la soluzione: un fornitore informato e coinvolto sarà meno propenso ad azioni legali immediate e più disposto ad attendere l’esito della ristrutturazione.
Azioni esecutive dei creditori: pignoramenti e difese del debitore
A prescindere dal tipo di creditore (bancario, fiscale, fornitore), quando il debitore è inadempiente i creditori possono ricorrere alle azioni esecutive individuali per il recupero forzoso. Queste includono:
- Pignoramento mobiliare presso la sede dell’azienda: l’ufficiale giudiziario, su istanza di un creditore munito di titolo esecutivo (es. decreto ingiuntivo esecutivo), può recarsi in azienda e pignorare macchinari, attrezzature, merci in magazzino. Segue poi la vendita all’asta di tali beni. Ciò può paralizzare l’attività se coinvolge beni essenziali.
- Pignoramento immobiliare: il creditore (tipicamente una banca ipotecaria o l’Agente Riscossione) notifica l’atto di pignoramento sull’immobile di proprietà dell’azienda e avvia l’esecuzione immobiliare. L’immobile viene stimato e posto in vendita giudiziaria. Le aste possono protrarsi a lungo e spesso il realizzo è basso (valore d’asta inferiore a mercato).
- Pignoramento presso terzi: molto comune, consiste nel pignorare crediti che l’azienda vanta verso terzi, principalmente i conti correnti bancari (credito verso la banca) e i crediti verso clienti. Ad esempio, un fornitore di FiltriOlio può pignorare il conto corrente aziendale presso la banca Alfa fino a concorrenza del credito: la banca bloccherà le somme e le verserà al creditore dopo l’ordinanza di assegnazione del giudice. Oppure può pignorare il credito di FiltriOlio verso un suo cliente (impedendo a FiltriOlio di incassare le fatture e deviando il pagamento al creditore procedente).
- Sequestro conservativo: prima ancora di avere un titolo definitivo, un creditore può chiedere al tribunale un sequestro conservativo sui beni del debitore se teme di perdere le garanzie del proprio credito (art. 671 c.p.c.). Ciò richiede dimostrare il fumus boni iuris (apparente fondatezza del credito) e il periculum in mora (rischio che il debitore disperda i beni). Il sequestro congela i beni in attesa della sentenza.
Per l’azienda debitrice, subire azioni esecutive significa perdere la gestione ordinata del proprio patrimonio. I singoli creditori agiscono del tutto indifferentemente l’uno dall’altro, spesso in modo disordinato: può accadere che un fornitore blocchi il conto, un altro pignori i crediti commerciali, la banca escuta l’ipoteca, creando un effetto domino che porta rapidamente al collasso operativo. Inoltre, in caso di vendite forzate, il patrimonio aziendale viene disperso a valori spesso sacrificati (le aste fanno realizzare a volte il 50% o meno del valore di mercato). Proprio per evitare questa “corsa al massacro”, il diritto fallimentare prevede che quando si attiva una procedura concorsuale collettiva (come il concordato o la liquidazione giudiziale), scatti il divieto di azioni esecutive individuali (par condicio creditorum): tutti i creditori devono concorrere nella procedura e le esecuzioni pendenti vengono bloccate.
Difese del debitore contro i pignoramenti: Sul piano giudiziario, le opposizioni sono di due tipi: opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), sostenendo che non sussiste il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (es. perché il debito è già pagato o manca il titolo); opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), lamentando vizi formali della procedura. Queste opposizioni, se accolte, possono far sospendere o caducare specifici pignoramenti, ma spesso si risolvono solo in dilazioni perché se il debito è dovuto, il creditore potrà ripresentare l’atto corretto. Sono dunque strumenti tattici, non risolutivi.
La difesa più efficace, come già evidenziato, è far ricorso alle procedure di regolazione della crisi previste dal CCII, che implicano una tutela automatica del patrimonio durante il loro svolgimento. Ad esempio:
- Domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”): dal momento del deposito della domanda di concordato in tribunale, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (art. 54 CCII). I pignoramenti già in corso vengono congelati e, se non è ancora avvenuta l’assegnazione o vendita, non producono effetti definitivi. Inoltre, il debitore rimane “protetto” sino all’omologa (salvo casi di revoca della procedura). Anche le eventuali procedure cautelari (es. sequestro) non possono proseguire. Questo “scudo” consente all’impresa di evitare la frammentazione del patrimonio e di gestire la crisi in modo unitario nel concordato. Va notato che con la riforma del CCII, la protezione può estendersi anche ai soci illimitatamente responsabili e ai coobbligati/fideiussori per i debiti inclusi nel concordato (se il tribunale lo dispone), benché questi ultimi non siano sollevati definitivamente se non pagando (l’efficacia è temporanea per facilitare il risanamento).
- Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: anche in questo caso, dal deposito della domanda di omologa l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive analoghe a quelle del concordato, per 60-120 giorni. Ciò mantiene lo status quo mentre si perfeziona l’accordo.
- Composizione negoziata: durante la composizione negoziata (fase stragiudiziale assistita dall’esperto), il debitore può domandare al tribunale l’applicazione di misure protettive sui propri beni (art. 20 CCII). Tipicamente, il tribunale emette un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari per la durata della composizione (initialmente fino a 4 mesi, prorogabili). Questo consente di condurre le trattative con i creditori “a parità di condizioni”, senza la pressione di pignoramenti isolati. Nel contesto della composizione negoziata, l’imprenditore può anche ottenere autorizzazione per contrarre nuovi finanziamenti prededucibili e per pagare fornitori strategici, col placet dell’esperto e eventualmente del tribunale (questo per stabilizzare la situazione).
In aggiunta alla protezione generale, esistono strumenti per gestire meglio i beni pignorati: ad esempio, nel concordato il debitore può chiedere di sospendere o interrompere una procedura esecutiva per vendere l’attivo nell’ambito concordatario, dove magari può spuntare un prezzo migliore. Se un macchinario è pignorato da un creditore, la vendita forzata lo svenderebbe; nel concordato, il debitore può (con autorizzazione) venderlo privatamente a prezzo di mercato e destinare il ricavato ai creditori, con maggiore efficacia.
Importante: se l’imprenditore prevede di presentare un concordato o accordo, è bene che lo faccia prima che avvengano atti esecutivi definitivi (es. prima che un immobile venga aggiudicato all’asta). Una volta che certi atti si sono perfezionati, non è sempre possibile recuperarli. Il CCII, però, ha introdotto qualche novità: ad esempio, se un immobile aziendale è stato venduto all’asta entro 6 mesi prima del concordato e non ancora trasferito, il CCII consente di includerlo nel patrimonio concordatario pagando prezzo e spese già maturate (art. 55 CCII). Ma queste situazioni sono complesse. Meglio prevenire: anticipare i creditori sul tempo attivando autonomamente uno strumento concorsuale prima che i creditori frammentino il patrimonio.
Nel caso di FiltriOlio S.r.l., supponiamo che un fornitore abbia già pignorato il conto corrente aziendale (dove c’erano €20.000 di liquidità) e che una banca stia per andare all’asta sul magazzino dato in pegno. Depositando una domanda di concordato con riserva, l’azienda ottiene la sospensione: il conto rimane bloccato temporaneamente ma quei €20.000 non vengono assegnati al creditore, bensì rimangono a disposizione della procedura; la banca non può procedere alla vendita del pegno senza autorizzazione del giudice delegato. L’azienda può quindi respirare e proporre ai creditori un piano in cui quelle risorse saranno distribuite par conditio. Va però notato che se poi la procedura concordataria dovesse convertirsi in liquidazione giudiziale, i creditori potrebbero riprendere le azioni (ma a quel punto coordinate dal curatore).
Riassumendo: difendersi dai creditori significa spesso congelare le loro azioni esecutive per guadagnare tempo e gestire la crisi in modo centralizzato. Ciò si ottiene attivando per tempo uno degli strumenti di regolazione della crisi (concordato, accordo omologato, composizione negoziata con misure protettive) prima che le esecuzioni disperdano il patrimonio. Nei paragrafi successivi passeremo in rassegna proprio questi strumenti, spiegando cosa sono, come funzionano e quando utilizzarli.
Strumenti di composizione della crisi d’impresa
Per un’azienda indebitata come FiltriOlio S.r.l. esiste un ventaglio di strumenti giuridici che consentono di gestire e possibilmente superare la crisi, evitando la liquidazione disordinata. Tali strumenti vanno dalle soluzioni stragiudiziali volontarie – in cui il debitore e i creditori trovano accordi senza l’intervento formale del tribunale – fino alle procedure concorsuali vere e proprie, sotto l’egida dell’autorità giudiziaria. Negli ultimi anni (specie a seguito del recepimento della Direttiva UE 2019/1023, detta Insolvency Directive), l’ordinamento italiano ha arricchito il panorama con nuovi istituti come la composizione negoziata e ha aggiornato quelli esistenti (concordato, accordi di ristrutturazione) per favorire soluzioni rapide e, dove possibile, la continuità aziendale. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale scegliere lo strumento più adatto alla propria situazione: ad esempio, se l’azienda ha prospettive di ripresa può puntare a un risanamento in continuità, se invece è decotta dovrà optare per una liquidazione ordinata, eventualmente semplificata. In questa sezione descriveremo i principali strumenti oggi disponibili – composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo (nelle sue varianti) e concordato semplificato, senza tralasciare l’eventualità estrema della liquidazione giudiziale – evidenziandone finalità, procedura, vantaggi e limiti.
Panoramica sintetica degli strumenti di regolazione della crisi: (verrà approfondita ciascuna voce nei paragrafi successivi)
| Strumento | Tipo di procedura | Scopo principale | Coinvolgimento dei creditori |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (artt. 17-25 septies CCII) | Procedura stragiudiziale assistita, volontaria. | Risanare l’impresa tramite accordi volontari con i creditori, con l’aiuto di un esperto indipendente nominato dalla CCIAA. Consente trattative riservate e può attivare tutele provvisorie (stay delle azioni esecutive) per facilitare un accordo. | Nessun voto formale: i creditori partecipano alle trattative e possono concordare moratorie o ristrutturazioni su base volontaria. Non c’è un vincolo legale per chi non aderisce. Se si raggiunge un accordo, va formalizzato (es. accordo stragiudiziale o accordo ex art. 57 CCII se serve omologa). |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Strumento stragiudiziale (accordo privato) con attestazione di esperto indipendente. | Ri-equilibrare l’azienda tramite un piano industriale e finanziario di risanamento, attestato da un professionista circa veridicità dati e fattibilità . Obiettivo: evitare la crisi/insolvenza implementando misure (ricapitalizzazione, dismissioni, rinegoziazioni) prima che sia troppo tardi. Vantaggio: atti e pagamenti compiuti in esecuzione del piano attestato sono protetti da revocatoria fallimentare. | Consenso extragiudiziale: il piano in sé è un atto unilaterale dell’imprenditore, ma spesso si accompagna a accordi bilaterali con alcuni creditori (banche, fornitori) per rinegoziare debiti. Non serve l’adesione di tutti i creditori: quelli che non aderiscono restano estranei (devono essere comunque soddisfatti regolarmente, altrimenti possono agire). Nessun voto o omologa; efficacia fondata sul consenso delle parti coinvolte e sull’attestazione. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) | Procedura concorsuale negoziale con omologazione del tribunale. | Ristrutturare l’indebitamento trovando un accordo con una parte significativa di creditori (≥60% in valore). Scopo: ridurre e/o riscadenzare i debiti garantendo al contempo il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge. Ha effetti protettivi (stay delle azioni esecutive su richiesta) e benefici (esenzione da revocatorie per i pagamenti eseguiti) analoghi al concordato. Varianti: accordo agevolato (soglia ridotta al 30% per certi crediti finanziari) e accordo ad efficacia estesa (possibile estendere ai dissenzienti di una categoria se aderisce ≥75% di quella categoria, ad es. banche). Introdotto di recente anche il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), che permette di derogare ad alcune regole (es. percentuale minima 20%) purché tutte le classi di creditori votino a favore. | Adesione di almeno il 60% dei crediti totali. I creditori aderenti sottoscrivono l’accordo e restano vincolati ai suoi termini dopo l’omologa. I non aderenti rimangono estranei: vanno pagati integralmente fuori dall’accordo nei tempi di legge (massimo 120 gg dalla scadenza o omologa). Eccezione: se scatta l’efficacia estesa su una categoria (es. finanziari al 75%), i dissenzienti di quella categoria vengono anch’essi coinvolti (vincolati alle stesse condizioni degli aderenti). Il tribunale omologa se l’accordo è fattibile e assicura integrale pagamento degli estranei. |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) – in continuità aziendale o liquidatorio | Procedura concorsuale giudiziale con attivo gestito sotto controllo del tribunale. | Regolare la crisi o insolvenza con un accordo imposto erga omnes, evitando il fallimento. Nel concordato in continuità l’obiettivo è salvare l’azienda (o parte di essa) in esercizio, ristrutturando i debiti e eventualmente prevedendo nuovi apporti finanziari o cessione di rami d’azienda. Nel concordato liquidatorio l’attività cessa e si mira a liquidare i beni in modo ordinato distribuendo il ricavato ai creditori secondo un piano, con possibili contributi esterni (es. apporto soci) per migliorarne l’esito. Il concordato offre una esdebitazione implicita all’ente debitore: una volta eseguito, i debiti pregressi sono cancellati secondo quanto previsto (per le società si estinguono con la chiusura, per l’imprenditore individuale l’esdebitazione è pressoché automatica a fine procedura). | Voto dei creditori: i creditori chirografari (e quelli privilegiati degradati/falcidiati) votano la proposta in classi (se previste) o in un’unica classe. Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza in valore; inoltre, se ci sono classi, occorre il sì della maggioranza delle classi o, in caso di dissenso di alcune classi, il tribunale può comunque omologare se ritiene non pregiudicati i dissenzienti – cram down giudiziale). In ogni caso, è richiesta in linea di massima una soddisfazione minima del 20% ai chirografari nel concordato liquidatorio (e almeno il 10% di “finanza esterna” all’attivo liquidabile), mentre in quello in continuità non c’è soglia fissa ma il piano deve essere più conveniente della liquidazione. Effetti: con l’apertura del concordato le azioni esecutive individuali sono sospese; l’impresa opera in regime di autorizzazione (atti straordinari soggetti ad autorizzazione del giudice o del comitato creditori). Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila. A omologa avvenuta, il piano vincola tutti i creditori anteriori, anche i dissenzienti e non votanti. |
| Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) | Procedura concorsuale speciale e residuale, liquidatoria senza votazione. | Liquidare rapidamente il patrimonio dell’impresa in modo concorsuale quando la composizione negoziata è fallita (cioè non ha prodotto accordi né risanamento). È riservato solo a questa circostanza: consente all’imprenditore di evitare il fallimento proponendo al tribunale un piano di liquidazione dei beni con riparto ai creditori. Caratteristiche: niente voto dei creditori (la decisione sull’omologa spetta al tribunale), iter più rapido e snello (non c’è commissario giudiziale né relazione di attestatore, si usa la relazione finale dell’esperto della composizione). Viene nominato un liquidatore giudiziale post-omologa che esegue il piano (vende i beni e distribuisce il ricavato). Scopo: chiudere la partita in pochi mesi, evitando le lungaggini di un fallimento e liberando il debitore dai debiti residui a fine procedura. | Nessun voto dei creditori: i creditori non sono chiamati ad approvare, ma possono eventualmente far pervenire osservazioni al tribunale prima dell’omologazione. La decisione è giudiziale: il tribunale omologa se ritiene che il piano liquidatorio proposto sia il migliore possibile per i creditori date le circostanze (verifica che non vi siano alternative migliori o frodi). Dopo l’omologa, il liquidatore giudiziale attua le vendite secondo il piano e paga i creditori secondo le regole di distribuzione delle prelazioni (privilegi, ipoteche, ecc.). I creditori dunque ricevono quanto previsto (es: x% ciascuno). Effetti: similmente al concordato preventivo, blocca le azioni esecutive dal deposito della domanda; omologato il piano, i creditori sono vincolati e a fine liquidazione l’eventuale passivo insoddisfatto è cancellato (per le società comporta la cancellazione dal registro imprese, per le persone fisiche consente l’esdebitazione). Non essendoci voto, è uno strumento unilaterale del debitore ma ammesso solo se c’è stata una composizione negoziata conclusa senza accordo. |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria giudiziale (artt. 121-270 CCII). | Liquidare il patrimonio dell’impresa insolvente sotto il controllo del tribunale, nominando un curatore che sostituisce gli amministratori. Obiettivo: vendere i beni e distribuire il ricavato ai creditori secondo il loro grado di prelazione. Conseguenza: l’azienda cessa l’attività (salvo esercizio provvisorio breve se utile) e viene spossessata. È la soluzione di ultima istanza quando non vi sono prospettive di risanamento né concordato. Il CCII ha modernizzato alcuni aspetti ma la sostanza è la stessa del vecchio fallimento. Permane tuttavia la possibilità per il debitore persona fisica di ottenere l’esdebitazione a fine procedura, ora quasi automatica se ha cooperato lealmente, per ricominciare senza debiti. | Nessun coinvolgimento propositivo dei creditori: i creditori presentano le domande di insinuazione al passivo e vengono ammessi dallo stato passivo dal giudice delegato. Non c’è un piano votato dai creditori: il curatore liquida i beni (secondo le norme e sotto supervisione del comitato creditori) e poi predispone il piano di riparto. I creditori ricevono le somme in base alle cause di prelazione (prima i privilegiati/ipotecari fino a capienza, poi i chirografari in percentuale). I crediti residui insoddisfatti restano inesigibili verso la società (che si estingue) e verso il debitore individuale (che può chiedere l’esdebitazione). Effetti: dalla sentenza di liquidazione, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive (confluiscono nel fallimento) e perdono la disponibilità individuale dei loro diritti, dovendo partecipare al concorso. L’organo amministrativo perde la gestione che passa al curatore. Questa procedura difensiva per il debitore non lo è affatto: è il peggior scenario, ma a volte inevitabile. |
Come si vede dalla tabella, le opzioni vanno da strumenti completamente volontari (piano attestato) a soluzioni che coinvolgono profondamente l’autorità giudiziaria (concordato, liquidazione). La scelta dipende dal grado di gravità della crisi e dal livello di consenso che l’imprenditore ritiene di poter ottenere dai creditori. Nel prosieguo, approfondiamo i singoli strumenti più nel dettaglio, sempre tenendo a mente il nostro caso pratico FiltriOlio S.r.l. per vedere quale possa essere la strada più adatta.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è uno strumento innovativo introdotto nel 2021 (dal D.L. 118/2021, confluito negli artt. 17-25-septies CCII) e divenuto operativo dal 15 novembre 2021. Si tratta di una procedura di soluzione assistita e volontaria della crisi, caratterizzata dalla riservatezza e dalla flessibilità. Vediamone i punti salienti:
- Accesso e requisiti: Può richiedere la composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far presumere la crisi o l’insolvenza, ma per cui esistono concrete prospettive di risanamento. Non serve essere formalmente insolventi (anzi, meglio muoversi prima). Anche un’impresa già insolvente può accedere, purché l’insolvenza sia reversibile (ad esempio illiquidità temporanea, non decozione totale). È una procedura volontaria: solo l’imprenditore può attivarla (nessun creditore né il tribunale possono imporsela).
- Nomina dell’esperto e ruolo: Una volta presentata l’istanza tramite la piattaforma telematica apposita (gestita da Unioncamere), un’apposita commissione nomina un esperto indipendente (di regola un professionista iscritto in un elenco ad hoc). L’esperto ha il compito di esaminare la situazione aziendale e di facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori, cercando soluzioni concordate. Egli non ha poteri decisori vincolanti, ma fornisce pareri, propone mediazioni e soprattutto certifica l’andamento delle trattative. Tutte le parti devono cooperare in buona fede.
- Svolgimento delle trattative: Le trattative si svolgono in modo riservato (non c’è pubblicità legale iniziale, se non quella eventuale del decreto di misure protettive). L’esperto convoca i creditori chiave insieme al debitore, analizza con loro i dati e le possibili opzioni. Può richiedere al debitore di predisporre piani o offerte e ai creditori di valutare moratorie. Ad esempio, nel Caso FiltriOlio, l’esperto chiamerebbe la banca principale e alcuni fornitori e il consulente del debitore per valutare subito se c’è margine per un accordo – come illustrato da un caso Delta Srl dove l’esperto ottiene subito una moratoria di 6 mesi da banche e fornitori cruciali.
- Misure protettive e autorizzazioni: Su richiesta dell’imprenditore, l’esperto può consigliare di chiedere al tribunale l’emissione di un decreto di misure protettive (art. 20 CCII) che congela le azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative (inizialmente fino a 120 giorni). Nel decreto il giudice può anche sospendere temporaneamente obblighi come l’istanza di fallimento presentata dai creditori. Ciò dà respiro all’impresa. Inoltre, il tribunale può autorizzare l’impresa a contrarre finanziamenti prededucibili (che saranno rimborsati prima degli altri crediti, se la crisi si risolve o anche in concorsuale) o a pagare fornitori essenziali, se l’esperto attesta che ciò è funzionale al miglior esito delle trattative (art. 22 CCII). Ad esempio, FiltriOlio potrebbe ottenere autorizzazione a ottenere un piccolo prestito ponte dai soci con privilegio prededucibile, da usare per completare ordini urgenti, su parere favorevole dell’esperto.
- Esiti possibili: La composizione negoziata non è di per sé una procedura di composizione dei debiti: è una cornice entro cui trovare uno dei possibili accordi. Gli esiti tipici sono: (a) la conclusione di uno o più accordi stragiudiziali con i creditori (ad esempio accordi bilaterali di moratoria, oppure un accordo multilaterale di ristrutturazione non omologato); (b) la predisposizione di un piano attestato di risanamento; (c) la proposta ai creditori di un accordo ex art. 57 da omologare (se serve maggioranza qualificata); (d) la presentazione di un concordato preventivo (se serve coinvolgere tutti i creditori in modo vincolante) – in tal caso la procedura di composizione si chiude e subentra il concordato; (e) in mancanza di accordo, l’imprenditore può optare per il concordato semplificato di cui diremo dopo. L’esperto redige una relazione finale sugli esiti. Va notato che il CCII (come modificato dal correttivo 2024) ha introdotto la possibilità di fare una transazione fiscale anche in composizione negoziata: prima non era chiaro se l’esperto potesse trattare su IVA e contributi, ora si è chiarito che è possibile includere nella proposta ai creditori pubblici anche falcidie (il che agevola accordi completi col Fisco).
- Vantaggi per il debitore: La composizione negoziata è uno strumento molto flessibile e poco stigmatizzante (non c’è dichiarazione formale di insolvenza). Permette di mantenere il controllo dell’impresa durante le trattative (non c’è spossessamento né commissario, l’esperto non gestisce ma solo media). Consente di guadagnare tempo in modo protetto, grazie alle misure protettive, senza tuttavia gli adempimenti formali stringenti di un concordato. Può essere vista come un “ombrello” temporaneo sotto cui l’imprenditore rimane al timone ma con una guida esperta al fianco e la possibilità di stoppare i creditori. Inoltre, se l’imprenditore aderisce con lealtà, il suo attivarsi in composizione viene considerato indice di diligenza: in caso di eventuale fallimento successivo, questo potrebbe evitargli accuse di tardiva aggravazione (è un fatto a suo favore, ex art. 324 CCII).
- Svantaggi e limiti: La composizione negoziata richiede comunque che l’impresa sia “risanabile” – se la situazione è disperata e i creditori non hanno fiducia, potrebbe non sortire accordi utili. Inoltre, non essendo vincolante per i dissenzienti, soffre del problema del free rider: basta che un creditore importante rifiuti ogni accordo per vanificare gli sforzi (ad esempio, se una banca resta ferma nel chiedere il rientro integrale e non accetta moratorie, il debitore dovrà forse passare al concordato). Infine, la composizione non prevede una ristrutturazione forzata dei debiti: se serve imporre un taglio a tutti i creditori, bisogna poi transitare in concordato o accordo omologato.
Applicando alla FiltriOlio S.r.l.: Supponiamo che FiltriOlio, dopo aver ricevuto le segnalazioni di allerta da INPS e Agenzia Entrate, decida a novembre 2024 di attivare la composizione negoziata (questo coincide col consiglio implicito delle PEC ricevute). Presenta istanza sulla piattaforma con i bilanci, la situazione aggiornata e una prima idea di piano. Viene nominato un esperto, che a dicembre convoca la banca principale, l’Agente della Riscossione e due fornitori strategici. Nei primi incontri, l’esperto verifica che l’azienda ha ancora ordini in corso (c’è prospettiva di continuità) ma ha bisogno di alleggerire il debito e rifinanziarsi. Ottiene dalla banca una moratoria di 6 mesi sui pagamenti delle rate mutuo e dagli altri creditori un accordo a non iniziare azioni esecutive (questo in parallelo alle misure protettive ordinate dal tribunale). Nel frattempo, suggerisce all’imprenditore di cercare un investitore o pensare a vendere un ramo non core. Dopo 2 mesi, FiltriOlio trova un investitore interessato a iniettare €200.000 per il 51% delle quote se i debiti finanziari vengono ristrutturati. L’esperto allora formula una proposta ai creditori: la banca accetta di convertire €100.000 di credito in strumenti partecipativi e di prorogare di 5 anni il mutuo residuo; l’Erario accetta una transazione fiscale di pagamento del 30% del suo credito in 4 anni; i fornitori sopra €50k accettano il 50% a stralcio (pagato dall’investitore in parte). Questo pacchetto viene formalizzato come accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, sottoscritto dall’80% dei creditori. Grazie alle nuove norme, l’azienda chiede l’omologa nonostante un fornitore e l’INPS non abbiano firmato: il tribunale omologa perché l’adesione è ampia (>75%) e l’offerta a INPS (30%) è comunque superiore a quanto otterrebbe liquidando. L’accordo viene così chiuso e FiltriOlio esce dalla composizione negoziata avendo evitato il fallimento e con un nuovo socio finanziatore.
Naturalmente, non sempre lo scenario è così positivo: se le trattative fossero fallite, FiltriOlio avrebbe comunque ancora un’opportunità: entro 60 giorni dalla relazione finale negativa dell’esperto, potrebbe proporre il concordato semplificato in tribunale per liquidare i beni residui in modo controllato, evitando il fallimento. Ma questo scenario di default lo descriveremo più avanti.
In conclusione, la composizione negoziata è consigliabile come primo step quando vi è spazio negoziale: per FiltriOlio è stato utile perché c’erano creditori ragionevoli e un business salvabile. Il messaggio per l’imprenditore è: attivalo presto (non aspettare di essere sull’orlo del crac) e usa bene il tempo concessoti, perché la finestra delle trattative è limitata (massimo 6+ mesi).
Piano attestato di risanamento
Il Piano Attestato di Risanamento (PAR) è uno strumento previsto ora all’art. 56 CCII, ma esistente da tempo nella pratica (già contemplato dall’art. 67, co. 3, lett. d) della vecchia legge fallimentare). È un percorso di risanamento strettamente stragiudiziale, basato sulla predisposizione di un piano industriale e finanziario credibile e sulla certificazione di un esperto indipendente. Vediamone le caratteristiche:
- Cos’è e finalità: È sostanzialmente un piano di risanamento aziendale, messo per iscritto e con data certa, che analizza le cause della crisi, delinea le strategie per superarla e prevede gli interventi di ristrutturazione necessari (operazioni sul capitale, riduzione costi, dismissioni di asset, ricerca di finanza fresca, rinegoziazione debiti, ecc.). Il piano deve essere accompagnato da una relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente, che certifichi: la veridicità dei dati aziendali esposti e l’idoneità del piano a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria . In altre parole, l’esperto deve validare che il piano è fattibile e realistico (no fumo negli occhi).
- Procedura e attori: Non vi è un intervento formale del tribunale né un commissario. L’iniziativa e la stesura del piano spettano all’imprenditore (coadiuvato dai suoi consulenti). L’imprenditore individua un professionista terzo (tipicamente un commercialista, advisor finanziario, revisore) da incaricare come attestatore. L’attestatore, svolte le sue verifiche, firma la relazione di attestazione. Il piano completo e l’attestazione vengono poi portati a conoscenza dei creditori con cui si intende attuarlo (spesso le banche). Non c’è obbligo di depositarlo da nessuna parte (se non eventualmente, su scelta, al Registro delle Imprese per data certa).
- Effetti legali: Il beneficio primario del piano attestato è di natura protettiva in sede concorsuale: gli atti e pagamenti compiuti in esecuzione del piano attestato (cioè funzionali al suo adempimento) non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 56 co.3 CCII, ricalca l’ex art. 67 l.f.). Ciò vuol dire che se un domani FiltriOlio dovesse comunque fallire, i pagamenti fatti e le garanzie concesse ai creditori durante l’attuazione del piano non potranno essere contestati dal curatore come preferenziali. Questo dà fiducia ai creditori nel rispettare l’accordo: sanno che l’incasso ricevuto è “blindato” e non andrà restituito. Un altro effetto è esenzione dall’obbligo di ricapitalizzazione immediata per perdite rilevanti (l’art. 56 CCII sospende per la durata del piano l’applicazione degli artt. 2446-2447 c.c. sulle perdite di capitale).
- Rapporto con i creditori: Il piano attestato, di per sé, non vincola i creditori né modifica automaticamente i loro crediti (non essendo una procedura concorsuale). Di solito però il piano è accompagnato da accordi contrattuali con i creditori principali per dare esecuzione alle misure previste. Esempio: se il piano prevede che le banche proroghino le scadenze e riducano i tassi, occorrerà firmare con ciascuna banca un accordo di rinegoziazione del mutuo. Se prevede che i fornitori rinuncino a parte dei crediti, bisognerà sottoscrivere atti transattivi bilaterali con quei fornitori. In pratica il piano funge da quadro di riferimento entro cui poi si stipulano i necessari accordi privati. Tuttavia, a differenza dell’accordo di ristrutturazione ex art. 57, non serve raggiungere il 60% né omologare: anche con alcuni creditori si può attuare un piano attestato, mentre altri creditori (magari minori) continuano a essere pagati regolarmente fuori dal piano. Chiaramente, per essere efficace, deve coinvolgere almeno i creditori maggiori: se i principali non stanno al gioco, il piano attestato resta lettera morta.
- Quando usarlo: Il PAR è ideale nelle situazioni di crisi non troppo grave, dove l’imprenditore ritiene di poter sistemare le cose con misure concordate con i pochi creditori strategici, senza passare per tribunale. È tipico ad esempio per risanare PMI con poche banche esposte: si redige un piano con il consenso delle banche, queste concedono respiro finanziario, l’azienda si risana e nessuno ha avuto bisogno di procedure formali. È utile anche quando si può reperire nuova finanza privata (ad esempio dai soci o investitori) per pagare i creditori parzialmente: quell’input di finanza esterna consente di evitare il default. Anche imprese in bonis ma con squilibri prospettici possono farlo (non serve aspettare il default conclamato).
- Limiti e rischi: Il piano attestato, non avendo la forza di una procedura concorsuale, non blocca per legge le azioni esecutive. Dunque funziona solo se i creditori cooperano spontaneamente. Se un creditore impaziente, durante l’esecuzione del piano, decide comunque di agire legalmente, non c’è uno stay automatico (a meno di accordi contrattuali in cui la banca si impegna a non agire, ma un terzo estraneo potrebbe farlo). Inoltre, non vincola i dissenzienti: basta un creditore importante che rifiuta il piano per dover ripiegare su soluzioni diverse. In sostanza, è uno strumento “morbido” e contrattuale: efficace in contesti relativamente ordinati e con fiducia reciproca, inefficace in presenza di contenziosi accesi o troppi attori eterogenei.
Esempio di piano attestato per FiltriOlio S.r.l.: Immaginiamo che FiltriOlio, nel 2023, avesse avuto squilibri ma non insolvenza: debiti bancari elevati ma ordini e prospettive buone. Avrebbe potuto elaborare con l’aiuto di un advisor un piano di risanamento a 5 anni: ad esempio, i soci si impegnano a conferire €100.000 di nuovi mezzi freschi, l’azienda dismette un ramo non profittevole ricavando €200.000, e le banche accettano di ristrutturare il debito allungando le scadenze e riducendo l’esposizione di €100.000 (con conversione in equity o stralcio). Il piano mostra che così l’azienda tornerebbe in utile dal secondo anno e rientrerebbe nei parametri finanziari. Un professionista indipendente attesta che i dati sono attendibili e che il piano è sostenibile e sufficiente a risanare (pagando integralmente i restanti creditori). Con quell’attestazione, FiltriOlio convince le 3 banche a firmare ciascuna un accordo di modifica dei contratti di finanziamento secondo i termini previsti dal piano. Anche alcuni fornitori maggiori accettano di dilazionare i crediti. FiltriOlio esegue poi il piano: i soci versano i soldi, vende il ramo e paga i fornitori, e prosegue l’attività con minor peso di debiti. Tutto avviene senza clamore né pubblicità, in modo consensuale. Se poi – malauguratamente – nel 2025 FiltriOlio dovesse fallire, i pagamenti fatti nel 2023-24 in attuazione del piano attestato (es. i rimborsi parziali alle banche, i pegni dati a garanzia dei nuovi prestiti) non potrebbero essere revocati dal curatore. Questo tutela le banche che hanno collaborato.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento “ibrido”, a metà tra il piano privatistico e la procedura concorsuale. Introdotti nel 2005 e ora disciplinati agli artt. 57-64 CCII, consentono di dare efficacia legale a un accordo di ristrutturazione stipulato con una parte significativa dei creditori. In pratica, se il debitore riesce a ottenere il consenso di almeno il 60% dei crediti (in valore), può chiedere al tribunale di omologare l’accordo, rendendolo vincolante secondo i suoi termini e attivando alcune protezioni tipiche del concorso. È un’alternativa al concordato più snella, rivolta a situazioni in cui c’è un consenso largo ma non unanime tra i creditori.
Caratteristiche principali:
- Soglia di adesione: Il debitore deve aver raggiunto l’accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali. Questa percentuale è calcolata sul totale passività, e include anche eventuali creditori privilegiati se partecipano all’accordo. Non occorre il 100%: la legge consente di lasciare estranei una parte di creditori minoritari, purché complessivamente si arrivi a 60%. In pratica, l’accordo spesso coinvolge banche e grandi fornitori, mentre piccoli creditori possono restare fuori (e magari verranno pagati a parte, integralmente, come vedremo). Esistono due varianti: l’accordo agevolato (art. 61 CCII) con soglia ridotta al 30% se tutti i creditori coinvolti sono finanziari (banche), pensato per ristrutturazioni finanziarie pure; e l’accordo ad efficacia estesa (art. 62 CCII) che consente, se una certa categoria omogenea di creditori ha aderito al 75%, di estendere gli effetti anche ai creditori di quella categoria che non hanno aderito. Quest’ultimo è un mini “cram down” settoriale: ad es., se 80% delle banche firma, si può vincolare anche il 20% dissenziente imponendo loro lo stesso trattamento degli altri, per evitare opportunismi.
- Contenuto dell’accordo: Ampia libertà negoziale. L’accordo può prevedere qualsiasi ristrutturazione concordata: riduzione dei crediti (stralcio parziale), dilazione dei termini di pagamento, modifiche contrattuali, ecc. Anche qui di solito si accompagna a un piano finanziario e industriale che spiega come l’impresa potrà adempiere all’accordo. Non c’è l’obbligo di rispettare le cause di prelazione come nel concordato, perché è basato sul consenso: ad esempio, una banca ipotecaria può volontariamente accettare di essere pagata al 70% del suo credito ipotecario, rinunciando a parte, senza bisogno di degradare formalmente il privilegio (cosa che nel concordato avverrebbe solo per incapienza). L’unico vincolo legale è che i creditori estranei all’accordo devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dalla scadenza originaria o dall’omologa (art. 58 CCII). Cioè, chi non partecipa non può subire decurtazioni né attese ingiustificate: l’azienda deve prevedere di soddisfarli per intero. Questo spesso significa che nel costruire l’accordo il debitore decide di escludere dall’accordo i piccoli creditori, pianificando di pagarli comunque regolarmente, e di includere invece solo i grandi creditori che faranno sacrifici. In tal modo, chi resta fuori non ha interesse a opporsi perché non viene toccato (prende il 100% fuori accordo).
- Procedimento di omologazione: Una volta raccolte le firme necessarie (60%), il debitore deposita il ricorso di omologazione in tribunale, allegando l’accordo e una attestazione di un esperto circa la veridicità dei dati aziendali e il fatto che l’accordo assicura il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge. Il tribunale, verificati i presupposti e la fattibilità, omologa l’accordo con decreto. In presenza di creditori dissenzienti che potrebbero essere pregiudicati, è previsto il contraddittorio: ad esempio, se un creditore estraneo lamenta che non verrà pagato integralmente, il giudice deve valutare ciò prima di omologare. Oppure, se si invoca l’efficacia estesa su una banca dissenziente, questa può opporsi e il tribunale valuta che abbia ricevuto lo stesso trattamento delle altre e non sia discriminata. Una volta omologato, l’accordo diventa vincolante per i creditori aderenti e per quelli dissenzienti delle categorie soggette a efficacia estesa eventualmente attivate. I creditori estranei rimangono fuori come detto (ma il decreto di omologa certifica l’obbligo di pagarli come promesso).
- Vantaggi dell’omologa: L’omologa conferisce alcuni benefici: (a) L’accordo omologato è pubblicato nel registro delle imprese, acquisendo efficacia erga omnes verso gli aderenti. (b) I creditori aderenti non possono tirarsi indietro successivamente (diventa un titolo esecutivo e giudiziale). (c) L’impresa può richiedere al tribunale, già al deposito dell’accordo, di applicare una moratoria delle azioni esecutive simile a quella del concordato per proteggersi nel frattempo. (d) Gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato e i finanziamenti autorizzati dal tribunale in funzione dell’accordo sono esenti da revocatoria, al pari di quelli in concordato. (e) In caso di inadempimento, l’accordo omologato può costituire base per risoluzione giudiziale o per conversione in fallimento, ma i creditori beneficiano comunque di aver tentato il recupero in misura concordata.
- Quando preferirlo al concordato: L’accordo è preferibile al concordato quando si riesce a coinvolgere la stragrande maggioranza dei creditori, lasciando fuori solo pochi (che verranno soddisfatti integralmente). Il vantaggio è che non c’è votazione né classi: basta convincere uno per uno i necessari creditori. È tipico in situazioni con poche banche: se 4 banche detengono l’80% del debito e tutte e 4 sono d’accordo su un piano di ristrutturazione, l’accordo può formalizzare questo e i piccoli fornitori verranno pagati a parte. L’accordo evita lo stigma del “concordato”, non dichiara insolvenza, e può essere assai rapido. Inoltre l’accordo – a differenza del concordato – non richiede soglie minime di pagamento ai chirografari né contributi esterni obbligatori, consentendo anche soluzioni dove i chirografari prendono <20% (purché consenzienti ovviamente). Esempio: se tutti i chirografari (banche non garantite) accettano 10%, col concordato liquidatorio sarebbe inammissibile (minimo 20%), ma con accordo si può fare perché c’è il loro consenso. Addirittura col PRO (piano di ristrutturazione omologato, che di fatto è un accordo con classi e consenso unanime di classi) si potrebbe omologare un piano liquidatorio pagando i chirografari meno del 20%.
- Limiti: Richiede, ovviamente, che il debitore sia in grado di procurarsi risorse per pagare i creditori estranei per intero (non è uno strumento per coinvolgere tutti i creditori in una decurtazione – quello è il concordato). Se l’impresa ha migliaia di piccoli creditori che non può pagare integralmente, l’accordo non è adatto. Inoltre, i creditori che partecipano devono essere persuasi uno per uno: c’è il rischio di negoziati prolungati. Per questo la legge consente al debitore di pubblicare un avviso in cui dichiara di trattare un accordo: da quell’avviso, entro 60 giorni può depositare l’accordo e nel frattempo chiede lo stay; questo sollecita i creditori a venire a patti, perché sanno che se si arriva all’omologa potranno essere bloccati a certe condizioni anche se dissenzienti (nel frattempo non possono iniziare esecuzioni, cfr. art. 44 CCII). Quindi il debitore può un po’ “forzare la mano” ai creditori indecisi con questa mossa.
Nel caso FiltriOlio S.r.l.: se l’azienda riuscisse a convincere la banca principale, i 5 fornitori più grossi e l’Erario (Agenzia Entrate) a un certo piano di ristrutturazione, e questi rappresentassero ad esempio il 70% del totale debiti, potrebbe formalizzare con loro un accordo di ristrutturazione e poi omologarlo. Poniamo ad esempio: la banca ipotecaria aderisce accettando di incassare solo il ricavato dalla vendita dell’immobile (70% del suo credito) e rinunciando al resto, l’Erario aderisce per un 30% del suo credito (transazione fiscale inclusa nell’accordo), i fornitori grandi accettano il 50%. I piccoli fornitori (30% debiti) vengono tenuti fuori e l’azienda prevede di pagare integralmente questi ultimi con un finanziamento dei soci che entrerà a seguito dell’omologa. L’attestatore certifica che in effetti con le vendite pianificate di asset e l’apporto soci, i piccoli creditori (estranei) saranno pagati al 100%. Il tribunale, visto il 70% di adesioni e la convenienza per i creditori (rispetto al fallimento), omologa l’accordo nonostante l’INPS, ad esempio, non abbia aderito – ma poiché si è offerto il 30% anche a INPS e ciò è >=30%, il tribunale può forzare la sua posizione in analogia al cram-down fiscale (o magari proprio con le norme di DL 69/2023 ha già potuto omologare). Dopo l’omologa, FiltriOlio esegue: vende l’immobile, paga i piccoli fornitori in 120 giorni, distribuisce il 30% concordato al Fisco e INPS, etc., e così chiude la ristrutturazione.
In pratica FiltriOlio avrebbe fatto una sorta di concordato “privato” con i principali creditori, senza dover passare per il voto di tutti. Questo scenario richiede un alto livello di consenso iniziale, che potrebbe derivare ad esempio dal buon esito di una precedente composizione negoziata (spesso i debitori usano la composizione per raccogliere le adesioni e poi cristallizzano il tutto in un accordo ex art. 57).
Concordato preventivo (in continuità e liquidatorio)
Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale di salvaguardia, erede con modifiche della vecchia procedura di concordato della legge fallimentare. Si tratta di una procedura giudiziale vera e propria, che si apre con ricorso al tribunale e, dopo un iter di ammissione, prevede il voto dei creditori su un piano proposto dal debitore, con successiva omologazione da parte del tribunale. È lo strumento da utilizzare quando il debitore intende proporre ai creditori un pagamento parziale e/o dilazionato e vincolante erga omnes, specialmente se ci sono molti creditori e non è possibile ottenerne il consenso individuale come negli accordi.
Principali elementi:
- Finalità: Il concordato può perseguire due finalità: il risanamento dell’impresa in continuità, ossia la prosecuzione (totale o parziale) dell’attività aziendale nell’interesse sia del debitore che dei creditori (che così massimizzano la soddisfazione rispetto a una liquidazione); oppure la liquidazione dei beni in forma ordinata, se la continuazione non è possibile, così comunque offrendo ai creditori una soluzione meno costosa e più rapida del fallimento. Spesso si parla di concordato in continuità vs concordato liquidatorio. La differenza non è banale: il CCII ha introdotto requisiti diversi e incentivi diversi per i due tipi.
- Nel concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII) l’azienda rimane operativa durante e dopo la procedura, i creditori vengono soddisfatti in prevalenza con i flussi generati dalla continuità (utili futuri, vendita di prodotti, apporti legati a contratti in essere) e non solo con la liquidazione dell’esistente. Può essere diretta (la stessa azienda prosegue con il debitore attuale) o indiretta (l’azienda viene affittata o ceduta a un terzo che la prosegue – ad esempio concordato con cessione d’azienda a un investitore). La continuità è incentivata perché preserva il valore produttivo e i posti di lavoro. In questo tipo di concordato non vi è soglia minima di pagamento dei chirografari prevista dalla legge (contrariamente al liquidatorio); tuttavia, il piano deve assicurare che i creditori ricevano non meno di quanto otterrebbero da una liquidazione alternativa (principio di convenienza). Inoltre, i crediti privilegiati possono essere parzialmente soddisfatti nel tempo con i flussi generati (non tutto va venduto subito per pagare i privilegiati: è ammessa la deroga temporanea all’ordine dei privilegi, se prevista dal piano e approvata). Un concordato in continuità ben fatto può offrire ai creditori anche percentuali non alte, ma se dimostra che tenendo in vita l’impresa ottengono ad esempio il 40% contro un 20% in caso di liquidazione, i creditori potrebbero preferirlo.
- Nel concordato liquidatorio (art. 84 co.4 CCII) l’intento è vendere tutti i cespiti dell’azienda e cessare l’attività, distribuendo il ricavato ai creditori. È simile a un fallimento pilotato dal debitore, ma con due importanti differenze: (a) il debitore può apportare risorse esterne (proprie o di terzi) per migliorare la soddisfazione dei creditori; (b) il debitore conserva più controllo (ad es. sceglie lui come liquidare, propone lui il piano di liquidazione). Per evitare concordati liquidatori troppo punitivi per i creditori, la legge impone due requisiti: i chirografari devono ricevere almeno il 20% del loro credito e ci deve essere un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo liquidabile. Ciò per garantire che il concordato offra “qualcosa in più” del semplice ricavato dalla vendita dei beni aziendali (ad esempio, i soci mettono una somma aggiuntiva sul piatto, oppure rinunciano a crediti postergati per quell’importo). Se questi requisiti non sono rispettati, il concordato liquidatorio è inammissibile. Da notare: nel concordato liquidatorio puro la direzione è verso la fine dell’impresa; i lavoratori saranno licenziati (salvo il caso in cui qualcuno rilevi l’azienda in blocco), ecc. Il CCII considera tale opzione residuale, preferendo la liquidazione giudiziale se proprio l’azienda è decotta, salvo quando c’è quell’apporto esterno e comunque il piano è vantaggioso per i creditori (ad esempio evita le lungaggini del fallimento e fa avere il 20% in tempi più rapidi, con un contributo dei soci).
- Procedimento: Il debitore presenta ricorso di concordato al tribunale competente (tribunale delle imprese se spa o >200 dip, sennò sezione fallimentare). Può presentarlo con il piano e la proposta sin dall’inizio, oppure con la sola domanda “con riserva” (detta anche concordato in bianco ex art. 44 CCII) se non ha ancora il piano pronto ma vuole bloccare subito i creditori. In caso di domanda in bianco, il tribunale fissa un termine (30-60 gg prorogabili a 120) per depositare piano e proposta, e nel frattempo nomina un commissario giudiziale e dispone le misure protettive. Quando il piano è presentato, il tribunale valuta l’ammissibilità (requisiti soggettivi, percentuale 20% se liquidatorio, fattibilità giuridica, ecc.) e, se tutto ok, ammette il debitore alla procedura e convoca l’adunanza dei creditori. Intanto un commissario giudiziale (professionista nominato) raccoglie informazioni, sorveglia la gestione e redige una relazione per i creditori sullo stato dell’impresa e sulla proposta.
Nella fase di votazione, i creditori aventi diritto (chirografari e privilegiati degradati per incapienza o falcidiati) votano la proposta in adunanza o per comunicazione scritta entro 20 giorni. Serve la maggioranza in valore dei crediti votanti (il CCII semplifica: non serve più la maggioranza per teste come un tempo). Se ci sono diverse classi di creditori e una classe vota contro, il tribunale può comunque omologare se ritiene la proposta equa verso la classe dissenziente (c.d. cram-down, art. 112 CCII). Ad esempio, se due classi su tre approvano e la terza no, ma i creditori dissenzienti sono trattati non peggio di come sarebbero in caso alternativo e partecipano sufficientemente al valore generato, il giudice può forzare l’omologa. Nell’ambito del concordato, i creditori privilegiati votano solo se il piano prevede per loro una qualche falcidia o modifica (es: li paga parzialmente o in tempi differiti rispetto alla scadenza): se sono pagati integralmente a scadenze normali, non votano perché non toccati.
Dopo il voto, si passa all’omologazione: il tribunale verifica la regolarità della procedura, il raggiungimento delle maggioranze e l’assenza di cause di nullità o fattori che impediscano di ritenere soddisfatti i test di legge (miglior soddisfazione rispetto al fallimento, ecc.). Se tutto a posto, omologa con decreto motivato. Da quel momento la proposta diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato.
- Gestione durante la procedura: Dalla data del deposito del ricorso di concordato, la società debitrice ha una capacità di gestione limitata: non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale (o del giudice delegato e, dopo l’ammissione, del comitato creditori). Può proseguire l’attività ordinaria, ma atti come vendere beni rilevanti, accendere nuovi finanziamenti, pagare crediti pregressi, ecc., richiedono autorizzazione (per evitare spostamenti di asset a danno dei creditori). Durante la procedura, vige la sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di pagamento dai creditori chirografari e privilegiati per crediti anteriori (salvo eccezioni come azioni del lavoro per crediti di lavoro, su cui il tribunale può comunque sospendere l’esecutorietà). Inoltre non maturano interessi sui debiti chirografari. Insomma, si congela la situazione debitoria al momento dell’apertura.
L’impresa continua ad operare sotto la vigilanza del commissario. Se è un concordato con continuità, l’azienda mantiene le commesse, può stipulare nuovi contratti (salvo autorizzazioni se oltre l’ordinario). Sono previste norme per i contratti pendenti: il debitore può richiedere al tribunale di sciogliersi da contratti in corso troppo onerosi per il piano (es. un affitto troppo caro) o di sospenderli fino a 60 giorni (rinnovabili). Questo per agevolare il risanamento (art. 97 CCII). Può anche mantenere i contratti essenziali in essere nonostante ci siano clausole risolutive per il concordato (clausole ipso facto inefficaci ex lege). Quanto ai lavoratori, il concordato in continuità ne prevede la continuazione dei rapporti, mentre nel liquidatorio di solito vengono messi in mobilità con autorizzazione.
- Esito ed effetti: Se tutto va a buon fine e il concordato viene omologato, l’azienda esegue il piano concordatario sotto la sorveglianza di un eventuale liquidatore giudiziale (nominato solo se previsto dal piano, soprattutto nei liquidatori) o del commissario (in continuità spesso il commissario rimane a vigilare fino a completamento). I creditori ricevono i pagamenti o altre utilità secondo i tempi e modi stabiliti nel piano (ad esempio: 30% ai chirografari in 2 rate annuali, oppure conversione dei crediti in partecipazioni, etc.). Eseguito il piano, la società adempiente torna libera da vincoli; i debiti anteriori rimasti insoddisfatti si considerano cancellati (il concordato ha effetto esdebitatorio per l’azienda: i creditori hanno accettato quell’adempimento parziale in luogo del tutto). In caso di inadempimento rilevante del concordato, i creditori o il commissario possono chiedere la risoluzione del concordato e in genere si aprirebbe la liquidazione giudiziale (fallimento) dell’impresa.
Tornando al caso FiltriOlio S.r.l.: immaginiamo che l’azienda ritenga di poter salvare l’attività produttiva se riduce l’indebitamento a un livello sostenibile. Potrebbe presentare un concordato in continuità: ad esempio, tenendo l’azienda in esercizio, propone di pagare integralmente il mutuo alla banca ipotecaria ma a scadenze prorogate, di pagare il 30% ai chirografari (fornitori, crediti Fisco degradati etc.) nell’arco di 5 anni, mantenendo operativa la fabbrica. Mostra che con i flussi di cassa previsti potrà ottenere quelle somme. Prevede anche che i soci apportino €100.000 fresh come finanza esterna a sostegno (questo migliorerebbe le percentuali). I creditori valutano che in un fallimento prenderebbero forse il 10-15%, quindi approvano in numero sufficiente. Il concordato viene omologato; l’azienda prosegue la produzione, paga ratealmente il dovuto secondo il piano e magari nel frattempo un nuovo investitore entra. I creditori riceveranno quell 30% concordato (meglio che zero) e mantengono un cliente (i fornitori) in vita. In più, la legge consente ad es. ai fornitori strategici di continuare a contrattare con FiltriOlio post concordato (non si applica la regola della confusione tra crediti anteriori e nuovi forniture: possono continuare a fornire sapendo di incassare il nuovo per contanti e il vecchio al 30%).
Se invece FiltriOlio fosse in una situazione disperata, senza ordini futuri, potrebbe fare solo un concordato liquidatorio: ad esempio, propone di vendere tutto il magazzino e i macchinari entro 6 mesi e distribuire il ricavato, con i soci che aggiungono una somma per raggiungere il 20%. Se dal realizzo e dall’apporto risulta che i chirografari prendono almeno il 20%, la proposta è ammissibile. I creditori la votano se convinti che ottengono più e più in fretta che nel fallimento. Una volta omologata, un liquidatore nominato venderà i beni e ripartirà ad esempio il 100% ai privilegiati, il 20% ai chirografari, e poi la società verrà cancellata. Questa strada però, come si vede, richiede quell’apporto esterno e comunque porta alla fine dell’impresa. Forse i creditori preferirebbero direttamente un fallimento se non vedono quell’apporto generoso.
In conclusione, il concordato preventivo è lo strumento più strutturato e “forte” per risolvere la crisi, perché consente anche contro la volontà di alcuni creditori di imporre una ristrutturazione, ed è corredato di misure di protezione e discipline specifiche. Tuttavia è anche procedura onerosa e complessa: richiede tempi (di solito qualche mese per arrivare al voto e almeno un anno per completare tutto), costi (compensi al commissario, spese legali, eventuale liquidatore) e un esito incerto (la votazione può anche fallire se i creditori non si convincono). Per questo, se è possibile un accordo più semplice (piano attestato o accordo di ristrutturazione), a parità di condizioni è preferibile quello. Ma se la crisi è profonda e bisogna coinvolgere tutti i creditori in un sacrificio, il concordato è l’unica via per evitare la liquidazione giudiziale.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) è una particolare procedura concorsuale introdotta in via sperimentale dal D.L. 118/2021 e ora recepita stabilmente dal Codice della Crisi. È definito “semplificato” perché non prevede il voto dei creditori ed è molto più rapido e snello nelle forme rispetto al concordato ordinario. Esso è però accessibile solo in un caso specifico: quando un tentativo di composizione negoziata della crisi si è concluso senza raggiungere un accordo.
Il razionale è il seguente: se l’imprenditore ha provato la via negoziata ma non è riuscito a risanare l’azienda, tuttavia emerge che c’è un patrimonio da liquidare e magari una proposta che può comunque essere conveniente per i creditori rispetto al fallimento, gli si dà la chance di presentare un concordato liquidatorio senza il lungo iter del voto, per evitare la dichiarazione di fallimento immediata. In pratica è un “paracadute” post-composizione negoziata.
Caratteristiche principali del concordato semplificato:
- Presupposto di ammissibilità: Occorre la relazione finale dell’esperto nominato nella composizione negoziata, che attesti che le trattative si sono concluse senza un accordo idoneo a risanare l’impresa e che non esistono concrete soluzioni alternative di risanamento. Con quella relazione (che in sostanza certifica che la via del risanamento è fallita e l’impresa è insolvente), entro 60 giorni l’imprenditore può proporre ricorso al tribunale per un concordato semplificato.
- Natura e scopo: È necessariamente un concordato liquidatorio puro (non è ammessa la continuità aziendale in questa procedura). Ciò significa che l’impresa è destinata a cessare l’attività. Il debitore propone semplicemente di liquidare tutto il patrimonio e distribuire il ricavato ai creditori secondo le regole di prelazione. La differenza rispetto a una liquidazione giudiziale è che qui è il debitore a fare una proposta di riparto e di eventuali modalità di liquidazione, e la procedura è concordataria e non fallimentare. Inoltre, il debitore può offrire anche qui apporti esterni per migliorare il risultato (anche se non c’è soglia minima di legge come nel concordato ordinario, l’offerta deve comunque convincere il giudice).
- Niente voto dei creditori: Questa è la peculiarità dirompente: i creditori non votano sul piano. Il tribunale convoca comunque un’udienza in cui i creditori possono comparire ed eventualmente sollevare osservazioni o opposizioni all’omologa, ma non c’è un’assemblea deliberativa. La decisione se approvare il concordato la prende il tribunale stesso, valutando se la proposta è fattibile e non danneggia i creditori (in pratica, che sia più conveniente di una liquidazione fallimentare). È quindi molto importante che nella proposta il debitore dimostri che i creditori verranno soddisfatti nella misura migliore possibile data la situazione – di solito si chiede una relazione di un attestatore su questo. Il tribunale verificherà l’assenza di intenti fraudolenti (che il debitore non stia occultando beni, ecc.) e che la ripartizione proposta rispetti le priorità di legge tra creditori (non è che può dare di più a un chirografo a scapito di un privilegiato).
- Liquidatore giudiziale: Se il concordato viene omologato, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale (di regola lo stesso esperto che aveva seguito la composizione o altra figura professionale). Sarà il liquidatore a prendere in mano l’azienda e procedere alla vendita dei beni secondo le modalità stabilite (ad esempio vendere in blocco l’azienda o l’immobile etc.) e poi distribuire pro-quota ai creditori il ricavato. Il debitore viene quindi spossessato (a omologa avvenuta) e non gestisce la liquidazione – analogamente a quanto avviene in un fallimento, ma con un incaricato scelto ad hoc e con magari regole specifiche di vendita se previste dal piano.
- Tempi rapidi: Non avendo la fase del voto e con meno formalità (non c’è commissario né stato passivo ecc.), il concordato semplificato è molto più veloce. L’idea è di chiuderlo in pochi mesi. Ad esempio, nel caso EcoBuild S.r.l. citato nella nostra guida , in pochi mesi il liquidatore aveva venduto l’unico cantiere e distribuito il 30% ai chirografari. Questo serve a evitare quell’effetto di trascinamento e costi che un fallimento tradizionale può avere.
- Effetti per il debitore: Una volta eseguito il concordato semplificato (ossia liquidati i beni e fatte le ripartizioni), l’impresa viene cancellata dal registro imprese. I debiti residui non soddisfatti restano inesigibili verso di essa (se era società, si estingue; se imprenditore individuo, potrà chiedere esdebitazione). Di fatto il debitore chiude la sua vicenda debitoria, analogamente a quanto accade dopo un fallimento ma spesso in modo più ordinato e con minori strascichi.
- Confronto con fallimento: Il concordato semplificato è pensato per essere una sorta di fallimento concordato dal debitore: quest’ultimo evita il “marchio” di fallito e mantiene qualche margine di proposta (ad esempio, può proporre di vendere a un certo soggetto o di destinare i beni in un certo modo se ciò massimizza il valore). Per i creditori, la differenza è che non votano ma devono confidare nel controllo del tribunale che la proposta sia la migliore possibile. In effetti la legge ha voluto evitare possibili abusi: per questo limita l’accesso solo a chi ha tentato la composizione negoziata (non si può bypassare il voto dei creditori andando direttamente a semplificato senza quell’esperienza). Inoltre, il debitore nel semplificato non può richiedere di mantenere l’azienda in esercizio (niente continuità), per evitare che uno lo usi per liberarsi dei debiti e tenere l’azienda: se vuole la continuità, doveva convincere i creditori in un concordato ordinario. Insomma, è riservato a casi dove l’impresa va chiusa ma conviene farlo in concordato per risparmiare tempo/costi rispetto al fallimento.
Nel nostro esempio FiltriOlio S.r.l.: supponiamo che la composizione negoziata di FiltriOlio sia fallita: l’esperto ha constatato che le banche e i creditori non trovano accordo per risanare e l’azienda è insolvente. FiltriOlio allora propone subito un concordato semplificato. Nella proposta indica: vendere il capannone e i macchinari a un acquirente interessato per €1,2 milioni (già individuato nella trattativa), con cui pagare tutti i creditori privilegiati (la banca ipotecaria e i dipendenti) e il restante distribuire pro quota ai chirografari, stimando un realizzo del 30% per loro. I creditori vengono informati e magari qualcuno si oppone dicendo che quell’acquirente offre troppo poco; il tribunale valuta e ritiene che invece sia un buon prezzo (supportato da stime). Omologa il concordato. Viene nominato liquidatore il medesimo esperto indipendente che conosce la situazione. Questi entro pochi mesi conclude la vendita al terzo al prezzo pattuito e incassa €1,2M; soddisfa la banca ipotecaria (poniamo €600k), paga qualche creditore privilegiato minore (INPS per €50k) e gli rimangono €550k per i chirografari che avevano crediti per €1,8M – ne deriva circa il 30% pagato. Il liquidatore stende il rendiconto, il giudice chiude la procedura. FiltriOlio S.r.l. viene cancellata dal registro imprese. I creditori non soddisfatti (ad es. un fornitore che ha ricevuto 30% invece di 100%) non possono più pretendere nulla (la società è estinta; se avevano fideiussioni dei soci, potranno rifarsi su di quelle, ma questa è altra partita). L’amministratore, avendo cooperato sin dall’inizio (comp negoziata e poi semplificato), potrà anche difendersi da eventuali azioni per responsabilità: dirà “ho fatto tutto il possibile seguendo la legge”. Inoltre, se l’amministratore avesse posizioni debitorie personali verso quei fornitori, potrà valutare procedure di sovraindebitamento ma esula dal nostro tema.
In pratica, con il concordato semplificato FiltriOlio è riuscita a evitare il fallimento, anche se comunque ha chiuso i battenti. Per i creditori, hanno ottenuto il 30% in pochi mesi, mentre in un fallimento ordinario magari dopo 5 anni avrebbero ottenuto percentuale simile o inferiore (erosa da spese). Certo, loro non hanno potuto votare, ma realisticamente se la composizione era fallita significava che non c’era accordo: molti avrebbero preferito rischiare il fallimento – qui il legislatore ha deciso per loro che un esito concordato, se ben supervisionato, è preferibile.
Nota bene: Il concordato semplificato è una procedura nuova, su cui la giurisprudenza sta ancora formando orientamenti. Le sentenze più recenti confermano l’utilizzabilità dello strumento e sottolineano il rigore nel controllare l’assenza di abusi. Ad esempio, tribunali hanno rifiutato omologhe dove sembrava che il debitore avesse maliziosamente saltato i creditori scontenti. Ma laddove il debitore dimostra trasparenza e la proposta obiettivamente avvantaggia i creditori, viene approvata.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Se nessuno degli strumenti sopra descritti viene intrapreso o va a buon fine, rimane l’eventualità residuale ma drastica: la liquidazione giudiziale, ossia la dichiarazione giudiziale di insolvenza dell’impresa e l’apertura di una procedura concorsuale liquidatoria d’ufficio. In base al CCII, la liquidazione giudiziale (che sostituisce il termine “fallimento”) può essere aperta su istanza di uno o più creditori, su istanza del debitore stesso (che rinuncia a tentativi di concordato e chiede la propria liquidazione) o d’ufficio dal tribunale in casi particolari (ad es. conversione di un concordato non omologato).
Le caratteristiche principali di questa procedura (disciplina compresa tra art. 121 e 270 CCII) sono note e solo brevemente richiamate:
- Presupposti: Lo stato di insolvenza attuale del debitore (incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) accertato dal tribunale. Non occorre il requisito dimensionale minimo di fallibilità di cui si discuteva in passato: sostanzialmente quasi tutte le imprese commerciali insolventi possono essere soggette, eccetto micro-imprese sottosoglia che potrebbero ricadere nel sovraindebitamento (ma società come FiltriOlio con centinaia di migliaia di debiti sono soggette).
- Effetti: Con la sentenza di apertura, il debitore perde la gestione dell’impresa e la disponibilità dei beni: viene nominato un curatore che amministra il patrimonio; i creditori devono far valere i loro crediti nelle sede concorsuale (insinuazione al passivo); scattano i divieti di azioni esecutive individuali; gli amministratori (in caso di società) decadono dalla carica. Il curatore compie un programma di liquidazione: inventaria i beni, prosegue se del caso temporaneamente l’esercizio dell’impresa (ma solo se autorizzato e se serve a salvaguardare valore), e poi liquida gli asset mediante vendite all’asta o procedure competitive. I fondi raccolti vengono distribuiti secondo l’ordine dei privilegi: prima i creditori con garanzie reali sui singoli beni, poi i creditori privilegiati generali in ordine di grado, infine i chirografari con eventuale riparto residuo. La procedura può durare anni, specie se vi sono cause legali in corso (revocatorie per atti prefallimentari, azioni di responsabilità contro amministratori, ecc. che il curatore può intraprendere).
- Responsabilità e sanzioni: L’apertura di una liquidazione giudiziale porta con sé possibili conseguenze negative per l’imprenditore: gli amministratori possono subire l’interdizione da attività commerciali, vi è l’eventuale segnalazione al PM di condotte rilevate (apertura di indagini per bancarotta fraudolenta o semplice se emergono atti distrattivi o mala gestio). I creditori possono promuovere azioni di responsabilità contro gli amministratori per danni (il curatore stesso esercita tipicamente l’azione sociale o quella dei creditori ex art. 378 CCII, già menzionata). Insomma, il fallimento è un terreno “punitivo” in cui vengono anche sanzionate le condotte antecedenti scorrette.
- Chiusura ed esdebitazione: Terminata la liquidazione e fatti i riparti, la procedura si chiude. Se il debitore è una società, con il decreto di chiusura viene cancellata (dopo avere eventualmente completato i riparti). Se il debitore è una persona fisica o socio illimitatamente responsabile, può chiedere l’esdebitazione: il CCII ha reso l’esdebitazione pressoché automatica dopo 3 anni dalla chiusura, salvo che il debitore sia stato poco cooperativo o scorretto. Quindi la persona fisica può ottenere di essere liberata dai debiti residui, come misura di “fresh start”. Questo è un notevole incentivo alla cooperazione con il curatore (si vuole favorire il debitore onesto ma sfortunato, non punirlo a vita per debiti che non può pagare).
Nel contesto di FiltriOlio S.r.l.: se nessuna delle opzioni di concordato o accordo avesse avuto successo, un creditore (ad es. la banca) avrebbe certamente chiesto la liquidazione giudiziale. Il tribunale, constatata l’insolvenza, l’avrebbe aperta. A quel punto un curatore avrebbe venduto i beni: magari avrebbe venduto il capannone a prezzo d’asta (forse più basso di quanto un concordato poteva spuntare con vendita privata concordata), incassato crediti, ecc. Avrebbe distribuito (dopo anni) il ricavato: ipotizziamo che i chirografari avrebbero preso solo un 10%. Gli amministratori di FiltriOlio probabilmente sarebbero stati citati in giudizio dal curatore per aver tardato la dichiarazione di insolvenza e aggravato il dissesto (a meno che possano difendersi mostrando di aver in realtà tentato la composizione; se l’hanno fatto, come abbiamo visto, la segnalazione e i tentativi compiuti li aiutano a difendersi da accuse di colpa grave). Dunque, comparando al concordato semplificato, i creditori hanno preso meno e l’imprenditore è finito in guai peggiori – di qui l’importanza di attivarsi prima con uno strumento di composizione assistita.
Riassumendo: la liquidazione giudiziale è l’esito che si vuole evitare quando si parla di “difendersi dai debiti”, a meno che non sia inevitabile. Il sistema attuale incentiva il debitore a usare gli strumenti anticipati (allerta, composizione, concordati) per evitare il fallimento. Solo se proprio non vi sono alternative si arriva lì.
Come ultima nota, segnaliamo che la legge prevede anche per il fallimento la possibilità di proposte concordatarie dopo l’apertura (il cd. concordato fallimentare, art. 240 CCII, dove i creditori o terzi possono proporre un concordato ai creditori per chiudere anticipatamente la liquidazione). Ma entrare in queste ulteriori opzioni esula dal nostro ambito, perché la guida si concentra sul punto di vista del debitore prima di fallire.
Abbiamo così passato in rassegna tutti gli strumenti rilevanti per un’azienda in crisi come la nostra ipotetica FiltriOlio S.r.l. A questo punto, per fissare le idee, presentiamo due possibili simulazioni pratiche sul caso concreto: una in cui l’azienda riesce a risanarsi e continuare, e un’altra in cui deve arrendersi e liquidare, evidenziando come si applicherebbero in concreto le procedure discusse.
Simulazioni pratiche: il caso FiltriOlio S.r.l.
Di seguito proponiamo due scenari “verosimili” riguardanti FiltriOlio S.r.l., per capire come – nella pratica – un’azienda con debiti può muoversi difensivamente a seconda della gravità della situazione. Caso A ipotizza che l’impresa riesca a trovare un accordo e proseguire l’attività (risanamento con continuità aziendale). Caso B ipotizza invece che l’impresa non sia salvabile come going concern e debba optare per una liquidazione controllata, evitando comunque il fallimento grazie agli strumenti descritti.
Caso A: Risanamento e continuità aziendale tramite accordo di ristrutturazione
Situazione iniziale: FiltriOlio S.r.l. ha debiti totali per €1,2 milioni, ma ha anche un portafoglio ordini per il prossimo anno del valore di €800.000 e una base clienti fidelizzata. I suoi prodotti hanno mercato, il problema è l’eccessivo indebitamento pregresso dovuto a investimenti errati e ritardi di incasso. L’azienda è in crisi di liquidità ma non insolvente irreversibile: se riuscisse a ridurre l’onere del debito e a dilazionare i pagamenti, potrebbe generare flussi di cassa sufficienti a ripagare almeno in parte i creditori col tempo, continuando l’attività.
Passo 1 – Allerta e attivazione: Nel 2024 FiltriOlio riceve dall’INPS e dall’Agenzia Entrate le lettere di allerta (ha €20.000 di contributi arretrati e €50.000 di IVA non pagata, oltre soglia). L’organo amministrativo prende atto della gravità e, consigliato dal proprio commercialista (e consapevole delle possibili responsabilità se ignora i segnali), decide di attivare subito la composizione negoziata. Presenta istanza sulla piattaforma ad ottobre 2024, fornendo i dati richiesti e indicando di avere prospettive di recupero (ordini futuri e business plan indicativo). Nel frattempo chiede al tribunale misure protettive per sospendere un pignoramento appena avviato da un fornitore sul conto corrente.
Passo 2 – Composizione negoziata con esperto: Viene nominato un esperto a novembre 2024. FiltriOlio espone all’esperto che, se potesse ottenere una riduzione del debito del 30% e tempi di pagamento di 5 anni sul restante, riuscirebbe a sostenere la produzione e ripagare tutti col margine operativo previsto. L’esperto convoca i creditori principali: la banca Alfa (esposta per €500k, con ipoteca), la banca Beta (esposta €150k chirografo), l’Agenzia Entrate (IVA e tributi €50k) e tre fornitori principali (crediti totali €200k). Dopo aver esaminato conti e prospettive, l’esperto concorda che l’azienda è risanabile se alleggerita. Ottiene intanto un accordo di standstill: tutti i presenti accettano di non intraprendere azioni esecutive per 3 mesi mentre si tratta (anche supportati dal decreto protettivo del tribunale). Inoltre la banca Alfa acconsente informalmente a congelare le rate di mutuo fino a fine trattative.
Passo 3 – Proposta di ristrutturazione: L’esperto suggerisce una bozza di manovra: – La banca Alfa (ipotecaria) rinuncia a €100k di credito e accetta di riscadenzare il residuo €400k su 8 anni a tasso ridotto. – La banca Beta (chirografa) accetta un pagamento del 60% (€90k) in 5 anni, con rinuncia al 40%. – I fornitori accettano di ridursi i crediti del 50% e di ricevere il 50% residuo in 2 anni (due tranche annuali). – L’Erario (Agenzia Entrate) tramite transazione fiscale accetta il pagamento del 30% dei €50k in 3 anni (quindi €15k dilazionato). – I contributi INPS (€20k) l’azienda propone di pagarli integralmente ma in 2 anni, sfruttando una dilazione amministrativa (che l’INPS ha concesso). – I soci di FiltriOlio si impegnano a apportare €100k di nuovi fondi (ottenuti da un investitore privato coinvolto durante le trattative) da destinare interamente ai pagamenti iniziali dell’accordo (questo convince maggiormente i creditori della fattibilità).
Tutti questi termini vengono discussi in meeting con l’esperto: ciascun creditore fa le sue richieste, ma l’esperto media evidenziando che ognuno deve cedere qualcosa per evitare esito peggiore. Dopo vari aggiustamenti (la banca Alfa inizialmente voleva rientrare al 100% in 5 anni, ma l’esperto le mostra che così l’azienda non regge e finirebbe per non pagare nulla a Beta e fornitori, portando a fallimento – scenario peggiore per Alfa stessa), si raggiunge un accordo di massima su quei termini.
Passo 4 – Formalizzazione dell’accordo ex art. 57 CCII: FiltriOlio, con l’assistenza legale, redige un accordo di ristrutturazione dei debiti che riflette i termini concordati. L’accordo viene firmato entro febbraio 2025 da creditori che rappresentano l’80% del totale crediti (Alfa 42%, Beta 12%, fornitori 17%, Erario 4% – totale ~75%, e in più INPS è estranea perché viene pagata full). L’accordo contiene anche clausole di salvaguardia: ad esempio, se FiltriOlio non paga due rate consecutive a un creditore, l’intero accordo decade (insistenza dei creditori). L’attestatore indipendente predispone la relazione ex art. 56 CCII confermando che i dati aziendali sono veritieri e che l’accordo permetterà di pagare integralmente i creditori estranei (nel caso, l’INPS e qualche piccolo fornitore da €10k che verrà pagato per intero con i fondi soci). Ad esempio, attesta che con l’apporto dei soci i piccoli verranno soddisfatti subito, e i flussi futuri bastano a onorare le rate di Alfa, Beta, etc.
Passo 5 – Omologazione in tribunale: A marzo 2025 FiltriOlio deposita il ricorso per omologare l’accordo di ristrutturazione. Chiede contestualmente, a scanso di equivoci, la conferma delle misure protettive fino all’omologa (vengono concesse per altri 60 giorni). Un piccolo fornitore estraneo (che sarà pagato al 100%) non fa opposizione. L’INPS, estranea ma pagata integralmente a parte, non si oppone. Il tribunale tiene udienza, verifica che tutte le formalità sono rispettate: percentuale 80% aderenti > 60%, relazione attestatore positiva, creditori estranei pagati integralmente. Inoltre rileva che l’Erario ha aderito formalmente alla transazione fiscale di cui all’accordo (quindi niente problema di cram-down). Omologa dunque l’accordo ad aprile 2025. Da quel momento l’accordo è efficace e vincola tutti i firmatari, acquistando efficacia di cosa giudicata.
Passo 6 – Esecuzione e uscita dalla crisi: Subito dopo l’omologa, grazie al decreto, FiltriOlio può ottenere dalla banca un finanziamento in conto corrente (piccolo) per riprendere respiro: sbloccate le pendenze, i creditori riaprono linee di fido commerciali. I soci versano i €100k promessi – con tali fondi FiltriOlio paga immediatamente i debiti verso fornitori estranei (€30k) e la prima rata dovuta ai fornitori aderenti (es. paga 25% subito ai fornitori aderenti, come concordato). Versa anche una prima quota di €5k all’Agenzia Entrate e €5k all’INPS secondo i piani di dilazione. L’azienda continua l’attività: con i ricavi delle vendite in corso, a fine 2025 paga la seconda rata ai fornitori (ulteriore 25%) e così via. La banca Alfa e Beta iniziano a incassare le rate semestrali dei loro nuovi piani di rientro.
Dopo qualche tempo, l’accordo viene interamente eseguito: entro il 2029 FiltriOlio avrà finito di pagare i debiti ristrutturati. I creditori hanno ottenuto quanto pattuito: Alfa, pur rinunciando a €100k, ha evitato di dover svalutare forse €300k in fallimento e ha mantenuto come cliente un’azienda risanata; Beta ha recuperato 60% invece di quasi zero; i fornitori hanno preso 50% del loro ma FiltriOlio è rimasta sul mercato e continua a fare ordini da loro, quindi hanno anche interesse commerciale; il Fisco e l’INPS hanno recuperato parte e non hanno dovuto aprire procedure lunghe. L’azienda, dal canto suo, è salva: ha dimezzato il debito e grazie alla crescita di fatturato sta nuovamente generando utili. Gli amministratori hanno evitato azioni di responsabilità perché, anzi, hanno gestito attivamente la crisi con successo. Questo scenario virtuoso è l’obiettivo di tutte le riforme recenti.
Caso B: Liquidazione concordataria semplificata dell’azienda
Situazione iniziale: FiltriOlio S.r.l. questa volta è messa peggio: i suoi principali clienti hanno delocalizzato, gli ordini sono crollati. L’azienda lavora al 30% della capacità, accumulando perdite. I debiti (€1,2M come prima) superano di gran lunga le prospettive di ricavo. Non c’è investitore disposto a metter soldi se non per rilevare i pochi asset a prezzo di saldo. Insomma, l’impresa appare decotta, senza ragionevoli prospettive di risanamento in continuità. Tuttavia, possiede ancora alcuni beni di valore: un capannone stimato €400k, macchinari rivendibili per €200k e scorte per €100k. Se venduti ordinatamente si stimano ricavi totali ~€700k. In caso di fallimento, tra spese e aste ribassate, i creditori temono si ricaverebbe molto meno (forse €400k netti). Dunque c’è interesse a evitare dispersione.
Passo 1 – Composizione negoziata senza esito positivo: Gli amministratori, pur consapevoli del quadro nero, attivano comunque la composizione negoziata (obbligatoria per poter accedere poi al concordato semplificato). Da ottobre a dicembre 2024 l’esperto prova a trovare soluzioni: convoca creditori, ipotizza la cessione dell’azienda in blocco ad eventuali concorrenti. Purtroppo nessuno è interessato a continuare l’attività – appare anti-economica. L’unica offerta sul tavolo è da parte di un’impresa immobiliare Delta S.p.A., che sarebbe disposta a comprare il capannone e i terreni di FiltriOlio per €350.000, e un rivenditore di macchinari offrirebbe €150.000 per tutti i macchinari. Totale €500k. L’esperto valuta che vendendo tutto così e liquidando le scorte, probabilmente si arriverebbe a circa €600k da distribuire. Presenta quest’ipotesi ai creditori: la banca ipotecaria su capannone (credito €400k) prenderebbe tutto il ricavato dell’immobile (€350k, rimanendo con scoperto di €50k chirografo), i privilegiati (INPS €20k, dipendenti €30k) prenderebbero il resto del ricavato di beni mobili prioritariamente (dipendenti e INPS per €50k), e gli altri chirografari (circa €700k residui) si dividerebbero il rimanente (supponiamo €200k), prendendo circa il 28%. I creditori, seppur perdendo molto, riconoscono che in un fallimento con aste, spese e tempi lunghi potrebbero prendere anche meno del 20%. Tuttavia, non c’è unanimità: un paio di fornitori e la banca Beta (chirografa €150k) sono scontenti e preferirebbero tentare il fallimento (magari nella speranza di azioni verso i soci). Le trattative si chiudono senza un accordo consensuale formalizzato – si redige solo un verbale con l’offerta Delta S.p.A. e i motivi del mancato accordo.
L’esperto nella sua relazione finale (gennaio 2025) attesta che: (a) sono state esperite trattative senza successo; (b) non esistono soluzioni alternative per salvare l’impresa (ha tentato vendite in blocco, affitto d’azienda, investitori – nulla); (c) la proposta Delta è l’unica via di realizzo dignitoso e appare più conveniente di un fallimento, ma non tutti i creditori hanno aderito. Suggerisce dunque al debitore di valutare la strada del concordato semplificato per realizzare quell’operazione nell’interesse della massa.
Passo 2 – Proposta di concordato semplificato: Forte di questa relazione, FiltriOlio S.r.l. in febbraio 2025 deposita al tribunale un ricorso per concordato semplificato liquidatorio. Nel ricorso descrive: – Il patrimonio è composto da immobile, macchinari, scorte, cassa minima. – Propone di vendere il capannone a Delta S.p.A. per €350k entro 3 mesi dall’omologa (c’è già una bozza di contratto vincolata all’approvazione del concordato) e di vendere i macchinari al rivenditore Gamma srl per €150k (anche questo con impegno scritto). – Le scorte verranno liquidate tramite un commissionario con stima di incasso €100k entro 6 mesi. – Il ricavato totale stimato €600k sarà così distribuito: prima €350k andranno alla banca Alfa ipotecaria (che soddisfa quindi ~87% del suo credito garantito; il residuo del suo credito €50k diventerà chirografario parte della massa chirografa), poi dei restanti €250k una parte andrà a dipendenti (€30k, saldandoli 100%) e INPS (€20k, 100%), restano circa €200k che saranno ripartiti pro quota tra tutti i creditori chirografari (inclusa la banca Alfa per la parte €50k rimasta chirografa, la banca Beta €150k, i fornitori €500k circa, Erario €30k chirografo post privilegio ecc.). FiltriOlio stima una percentuale del 25-30% per ciascun chirografario. – Specifica che non vi sono garanzie prestate da terzi (nessuno rimane obbligato all’infuori della società). – Richiede la nomina come liquidatore del sig. Rossi (lo stesso esperto che conosce la situazione).
Il tribunale fissa un’udienza a marzo 2025 e dispone che il ricorso venga comunicato ai creditori. Nelle more, su istanza di FiltriOlio, emette un decreto di misure protettive per vietare iniziative esecutive (alcuni creditori volevano intanto fare istanza di fallimento, il decreto sospende queste iniziative).
Passo 3 – Valutazione del tribunale e delle parti: All’udienza si presentano alcuni creditori: la banca Beta contesta che €350k per il capannone è un po’ basso, secondo lei si poteva ottenere di più. Il tribunale ascolta il parere del costituendo liquidatore Rossi, il quale riferisce di aver sondato il mercato durante la composizione e che quell’offerta è la migliore ottenibile in tempi rapidi, anzi se si andasse a fallimento è probabile che all’asta si realizzerebbe meno. I fornitori chirografari, pur scontenti di prendere solo ~25%, non negano che in fallimento forse prenderebbero zero e dopo anni. Il giudice verifica la regolarità formale: la relazione finale dell’esperto c’è (presupposto rispettato), la proposta rispetta le cause di prelazione (privilegiati presi prima, chirografi concorrono dopo sul residuo). Chiama anche il commissario della composizione (che era l’esperto stesso in questo caso) a confermare l’assenza di atti distrattivi: conferma che il debitore non ha nascosto nulla e ha agito correttamente.
Passo 4 – Omologazione senza voto: Alla luce di ciò, il tribunale ritiene la proposta meritevole: è nell’interesse dei creditori, che nel complesso ottengono ~25% invece del <15% stimato in fallimento, ed evita lungaggini. Non rileva frodi o penalizzazioni indebite di qualche creditore (tutti i chirografi hanno pari trattamento pro quota; i privilegiati sono soddisfatti al meglio delle risorse). Pertanto, a aprile 2025, emette decreto di omologa del concordato semplificato. I creditori dissenzienti non hanno potere di opporsi oltre (salvo reclamo per motivi legali, ma qui non ci sono evidenti violazioni di legge).
Passo 5 – Liquidazione dei beni: Viene nominato liquidatore il dott. Rossi come richiesto. Egli entro maggio 2025 stipula il rogito col Delta S.p.A. per il capannone a €350.000, e conclude il contratto con Gamma srl per i macchinari a €150.000. Mette inoltre all’asta le scorte, realizzando €100.000 da un acquirente settore ricambi. Incassa in totale €600.000 (poniamo arrotondato). Trattiene una quota per spese procedurali (minime, diciamo €20k per compensi e oneri vari, molto inferiori a un fallimento). Restano €580.000 netti per i creditori. Esegue quindi il riparto: – Paga alla banca Alfa €350.000 (soddisfacendola quasi interamente sul garantito). – Versa €30.000 ai dipendenti (tfr e stipendi arretrati) e €20.000 all’INPS – questi creditori privilegiati ricevono il 100%. – Rimangono €180.000 circa da distribuire ai creditori chirografari. Sommiamo i crediti chirografari: banca Alfa €50k (residuo), banca Beta €150k, fornitori €500k, Erario €30k (IVA residua perché il privilegio IVA si copre solo in parte), altri €20k vari – circa €750k totale chirografo ammesso. Distribuendo €180k su €750k, la percentuale finale risulta ~24%. – Ogni chirografario riceve dunque il 24% del proprio credito: la banca Beta incassa ~€36k, fornitori con €100k credito prendono €24k, e così via.
Il liquidatore prepara i conteggi finali e riferisce al giudice. Nessun creditore contesta il riparto perché è matematico.
Passo 6 – Chiusura della procedura: A settembre 2025 il tribunale dichiara compiuto il concordato semplificato e dispone la cancellazione di FiltriOlio S.r.l. dal registro imprese. La società viene estinta. I debiti residui dei creditori rimangono insoddisfatti ma non più esigibili (i creditori non hanno più un soggetto giuridico contro cui agire: FiltriOlio non esiste, e per legge il concordato ha effetto esdebitatorio analogo al fallimento). L’ex amministratore di FiltriOlio, avendo gestito tutto con correttezza, non subisce azioni di responsabilità (anzi, i creditori riconoscono di aver ottenuto il possibile). Anche eventuali profili di reato di bancarotta sono esclusi, perché non vi sono state distrazioni e la procedura concordataria di per sé non comporta dichiarazione di fallimento (quindi niente bancarotta semplice). In sostanza l’imprenditore chiude la vicenda senza strascichi penali e con minori strascichi civilistici (certo ha perso l’azienda, ma evita di persona ulteriori esposizioni, salvo fideiussioni personali che però nel caso non vi erano).
I creditori chirografari, pur non soddisfatti integralmente, hanno ottenuto qualcosa in tempi brevi, e possono dedurre fiscalmente il resto a perdita. È un epilogo doloroso ma ordinato: rispetto al fallimento, c’è stata meno spesa e più ritorno percentuale.
Questi due scenari mostrano come, a seconda delle circostanze, un’impresa indebitata possa:
- Nel caso A: difendersi efficacemente salvando l’azienda, grazie a una trattativa e un accordo sostenibile (grazie anche all’intervento normativo che permette di superare le resistenze di minoranze con l’omologazione forzosa). Ciò richiede che esista un nucleo economico valido (continuità) e la buona volontà di principali creditori.
- Nel caso B: difendersi evitando il peggio (il fallimento giudiziario), pur dovendo liquidare tutto, sfruttando il nuovo strumento del concordato semplificato che consente di chiudere la partita rapidamente e con esiti meno penalizzanti per tutti rispetto alla liquidazione fallimentare standard .
In entrambe le situazioni, il filo conduttore è la tempestività e la trasparenza dell’imprenditore: appena chiaro di essere in crisi/insolvenza, ha attivato le procedure previste (allerta, composizione) e coinvolto i creditori in un percorso legale, invece di subire passivamente i pignoramenti o farsi dichiarare fallito. Questa proattività è la migliore difesa: non a caso, il nuovo Codice insiste molto su doveri di attivazione e premia il debitore diligente (anche con l’esdebitazione “facile” se va male).
Passiamo ora a rispondere sinteticamente ad alcune domande frequenti (FAQ) che un imprenditore o debitore potrebbe porsi trovandosi in queste situazioni, e a presentare infine un quadro riepilogativo delle varie soluzioni e responsabilità, completando la guida.
Domande frequenti (FAQ)
D: La mia azienda rischia il fallimento a causa dei debiti. Posso evitarlo in qualche modo?
R: Sì. Il fallimento (ora liquidazione giudiziale) può essere evitato se si adotta per tempo uno degli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge. Ad esempio, presentando un concordato preventivo prima che i creditori ottengano sentenze o facciano istanza di fallimento, potrai beneficiare di una sospensione automatica delle azioni esecutive e proporre tu un piano ai creditori, invece di subire la liquidazione forzata. Anche un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale blocca le istanze di fallimento. Inoltre, durante la nuova composizione negoziata puoi ottenere misure protettive (stay) che congelano i fallimenti su richiesta dei creditori. In estrema ipotesi, se la composizione negoziata fallisce ma hai un piano di liquidazione, puoi proporre un concordato semplificato: se omologato, il tribunale dichiara inammissibili eventuali istanze di fallimento e si procede in concordato. In breve, sì, è possibile evitare il fallimento adottando iniziative di regolazione prima che il tribunale dichiari l’insolvenza d’ufficio. La chiave è muoversi in anticipo: se lasci che i creditori ottengano un fallimento senza aver proposto alternative, sarà troppo tardi.
D: Come posso fermare i pignoramenti dei creditori che stanno bloccando i conti e i beni?
R: Gli strumenti per sospendere o impedire i pignoramenti esistono e sono efficaci se attivati correttamente: – Presentando una domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”) al tribunale, scatta automaticamente il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’azienda (art. 54 CCII). I pignoramenti in corso vengono congelati (se non c’è ancora stato assegnazione o vendita) e nessun nuovo pignoramento può essere effettuato durante la procedura. Questo ti dà respiro per elaborare e proporre il piano di concordato. – Se intraprendi una composizione negoziata, puoi chiedere al tribunale misure protettive simili: con decreto, il giudice inibisce ai creditori qualsiasi azione esecutiva o cautelare per la durata delle trattative. Ciò include bloccare pignoramenti su conti, atti di sequestro etc. (già pendenti o minacciati). – Durante la pendenza di un accordo di ristrutturazione depositato per l’omologa, puoi ottenere la sospensione delle esecuzioni per 60 giorni (prorogabili), analogamente (il tribunale estende la protezione che aveva nel concordato). – Per singoli atti esecutivi, potresti presentare un’opposizione all’esecuzione (se contesti il titolo o l’entità del debito) o un’opposizione agli atti (per vizi formali) per bloccare temporaneamente l’iter presso il giudice dell’esecuzione. Ma questa è più che altro una tattica dilatoria: la vera protezione ampia la ottieni con le procedure concorsuali sopra dette.
In sostanza, se l’azienda è oggetto di pignoramenti su conti, immobili o merci, il metodo migliore per fermarli è depositare un ricorso di concordato preventivo o un’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Così tutti i creditori vengono forzosamente fermati e dovranno attendere il negoziato o la votazione del piano. Al di fuori di ciò, cercare di fermare ciascun pignoramento con opposizioni è incerto e frammentario. Meglio agire in modo unitario con gli strumenti di legge.
D: Cos’è la composizione negoziata della crisi e mi conviene usarla?
R: La composizione negoziata è una procedura stragiudiziale introdotta nel 2021 che consente all’imprenditore in crisi (ma con possibilità di risanamento) di farsi affiancare da un esperto indipendente per condurre trattative riservate con i creditori e trovare una soluzione concordata. È volontaria: la attivi tu imprenditore tramite piattaforma online presso la Camera di Commercio. Ti verrà assegnato un esperto (commercialista/avvocato esperto di crisi) che ti aiuterà a valutare la situazione e a negoziare con i creditori chiave. Durante la composizione puoi continuare a gestire l’azienda e, se necessario, chiedere al tribunale di proteggere i tuoi beni dalle azioni esecutive (con un “ombrello” temporaneo). Conviene usarla se la tua impresa ha ancora prospettive di salvataggio ma ha bisogno di tempo o di ristrutturare debiti: è uno strumento snello e confidenziale, senza lo stigma di un fallimento o concordato. Ti dà accesso a competenze (l’esperto) e crea uno spazio di dialogo con i creditori, incentivandoli (perché se si trova un accordo tutti perdono meno). In più, è un segnale di buona fede: se poi la crisi peggiora, aver tentato la composizione negoziata giocherà a tuo favore (ad esempio per esdebitazione o per evitare accuse di inerzia). Naturalmente, se la situazione è già compromessa al punto che i creditori non credono più nel risanamento, la composizione potrebbe concludersi senza accordo – ma anche in tal caso non è tempo sprecato, perché ti apre la via al concordato semplificato e dimostra ai giudici che hai fatto il possibile.
D: La mia società è una S.r.l.: in caso di fallimento o concordato, io come amministratore rischio di dover pagare i debiti di tasca mia?
R: Di regola, no: se la società è una S.r.l. (a responsabilità limitata), i debiti sociali non ricadono sugli amministratori o soci personalmente. Essi rispondono solo se viene accertata una loro responsabilità per condotte illecite o negligenti nella gestione. In pratica, l’amministratore non è automaticamente garante dei debiti; però può essere chiamato a risponderne a posteriori se ha violato i doveri gestionali, causando danno ai creditori. Ad esempio, il nuovo art. 378 CCII prevede che l’amministratore che, violando l’obbligo di preservare il patrimonio sociale, abbia aggravato il dissesto, risponde verso i creditori insoddisfatti con patrimonio personale. In sede fallimentare, spesso il curatore promuove l’azione di responsabilità contro gli amministratori chiedendo loro i danni pari al deficit fallimentare (specie se hanno continuato l’attività quando l’insolvenza era manifesta). Se però tu hai agito diligentemente – ad esempio attivando per tempo gli strumenti di allerta, provando un concordato – difficilmente potranno imputarti colpe gravi. La giurisprudenza riconosce che non tutti i fallimenti sono colpa degli amministratori, solo quelli aggravati da inerzia o mala gestio. Quindi, salvo tu abbia compiuto atti distrattivi (es. sottrazione di beni, pagamenti preferenziali dolosi), personalmente non dovresti pagare i debiti sociali. Attenzione però: se hai firmato fideiussioni personali per debiti della società (molti amministratori garantiscono coi propri beni i mutui bancari, leasing, ecc.), in quel caso la banca o il creditore garantito potrà escutere te a prescindere dalla società. La procedura concorsuale non libera i garanti (a meno che il creditore consenta). Quindi il rischio è indiretto: come amministratore di S.r.l. la legge non ti rende debitore sociale, ma tramite garanzie accessorie volontarie potresti esserlo. In conclusione: nessun rischio di responsabilità patrimoniale diretta per i debiti sociali, a meno di mala gestio (da provare) o garanzie personali prestate (contrattuali).
D: Quali comportamenti dell’amministratore possono portare a responsabilità personale verso i creditori?
R: Oltre ai casi evidenti di illecito (frodi, distrazioni di beni sociali – in tal caso si parla anche di reati di bancarotta fraudolenta, con obbligo di risarcimento), la situazione tipica è l’omessa reazione alla crisi. Se un amministratore, quando la società ha perso il capitale o è insolvente, continua l’attività aggravando il buco invece di attivare le procedure o liquidare, viene considerato responsabile dell’aggravamento. Il codice civile (art. 2486 c.c.) fissa che dalla causa di scioglimento (es. perdita di capitale) gli amministratori devono operare solo per conservare il patrimonio, non per fare nuove operazioni rischiose; la violazione comporta responsabilità. Il CCII ha rafforzato questo aspetto introducendo una presunzione di danno: la differenza tra patrimonio netto alla data in cui avresti dovuto attivarti e patrimonio netto poi al fallimento può essere chiesta come danno. In pratica, continuare a fare impresa “a tutti i costi” in stato di insolvenza è fonte di responsabilità (cosiddetto wrongful trading all’italiana). Altri comportamenti: non tenere le scritture contabili regolarmente (che impedisce di accertare la situazione), pagare preferenzialmente alcuni creditori a scapito di altri in prossimità del fallimento (oltre a essere revocabile, può integrare bancarotta preferenziale), non collaborare col curatore consegnando documenti (rischio di sanzioni). Viceversa, se l’amministratore predispone assetti adeguati e interviene tempestivamente attivando gli strumenti di allerta o di composizione appena percepisce la crisi, adempie ai suoi doveri. In quel caso, anche se la società poi fallisse, sarebbe più difficile imputargli una colpa grave. Infatti, la legge valorizza la tempestiva iniziativa come esimente (ad esempio per la bancarotta semplice, l’aver chiesto il concordato o composizione viene considerato positivamente). Quindi, in sintesi, i comportamenti che portano responsabilità sono: inerzia colpevole di fronte alla crisi (continuare a indebitarsi senza prospettive), violazione degli obblighi gestori (non convocare assemblea per perdita di capitale, non tenere conti, atti in conflitto di interessi) e atti distrattivi o preferenziali in pre-fallimento. Tutto ciò va evitato; al contrario, attivismo e correttezza sono la miglior protezione.
D: I soci di una S.r.l. (non amministratori) rischiano qualcosa con i debiti della società?
R: Normalmente, no. I soci di capitale di una S.r.l. o S.p.A. godono del beneficio della responsabilità limitata: possono perdere il capitale investito (quote/azioni che si azzerano), ma i creditori sociali non possono chiedere ai soci di ripianare i debiti con patrimonio personale. Fanno eccezione i soci che abbiano assunto obbligazioni personali (ad esempio, un socio spesso è anche amministratore e magari ha dato fideiussione bancaria come persona; oppure soci che hanno garantito con pegno su beni propri un debito sociale – casi particolari). Inoltre, se un socio ha percepito utili illegalmente (ad esempio distribuzioni di dividendi in violazione dell’art. 2476 c.c. su utili fittizi), può essergli chiesto di restituirli per pagare i creditori. Ma parliamo di situazioni anomale. In genere, i soci non amministratori non rispondono dei debiti e nemmeno di illeciti, salvo abbiano concorso in essi (es: socio che di fatto dirige la società – amministratore di fatto – potrebbe essere chiamato in causa). Un caso importante: se la società è di persone (S.n.c. o S.a.s.), allora i soci illimitatamente responsabili rispondono personalmente dei debiti sociali (art. 2291 c.c.): in tal caso i creditori, escussa la società, possono colpire i beni personali dei soci. Ma la domanda menzionava S.r.l., quindi no, i soci di S.r.l. di regola non pagano oltre il capitale perso. Attenzione comunque al caso in cui i soci abbiano finanziato la società in crisi con prestiti dei soci: in base all’art. 2467 c.c., tali finanziamenti sono postergati (vengono rimborsati dopo tutti gli altri crediti). In fallimento, spesso i crediti dei soci verso la società non vengono pagati affatto. Quindi il socio rischia di non recuperare i soldi che ha prestato alla società. D’altra parte, se il socio ha prelevato fondi indebiti (es. rimborsi spese esagerati, utili anticipati), potrebbe essere costretto a restituirli. In conclusione, i soci investitori puri non rischiano il proprio patrimonio personale verso i creditori sociali (nessun “piercing the corporate veil” facile in Italia), a meno di abusi gravi (come confusione dei patrimoni società-socio, sotto-capitalizzazione dolosa, frode attraverso la società – ipotesi estreme in cui la giurisprudenza può far rispondere i soci usando concetti di abuso della personalità giuridica, ma sono rari e complessi da provare). Per un privato socio di S.r.l., l’importante è che non firmi garanzie personali se vuole restare davvero protetto.
D: Cosa succede ai dipendenti e ai contratti durante una procedura di concordato o simili?
R: Nel concordato preventivo in continuità, l’azienda prosegue l’attività, quindi normalmente i dipendenti continuano a lavorare e percepiscono le retribuzioni correnti come crediti prededucibili (vengono pagati regolarmente, queste paghe maturate durante la procedura hanno priorità di pagamento assoluta). I crediti dei dipendenti per stipendi arretrati e TFR maturati prima del concordato sono crediti privilegiati che saranno soddisfatti nel piano (di solito integralmente, perché i dipendenti hanno privilegio di altissimo grado – di solito vengono pagati 100% o quasi). Se il concordato è liquidatorio e prevede la cessazione, i dipendenti vengono licenziati (con autorizzazione del tribunale). Essi possono accedere alla NASpI (disoccupazione) e i loro crediti per TFR e ultime 3 mensilità sono garantiti dal Fondo di Garanzia INPS, che li paga subito e poi si surroga nel fallimento/concordato. Quindi, i lavoratori in genere non restano senza tutela: o l’azienda continua e loro mantengono il posto, oppure se cessa l’attività possono far valere i loro crediti tramite il Fondo di garanzia e insinuarsi per eventuali differenze. Quanto ai contratti commerciali in corso: nel concordato in continuità non si risolvono automaticamente (anzi, la legge invalida clausole di risoluzione automatica tipo “se vai in concordato, il contratto si scioglie”). Se però qualche contratto è molto oneroso, il debitore può chiedere al giudice di scioglierlo o sospenderlo (es. un contratto di affitto troppo caro – art. 97 CCII). Nel concordato liquidatorio, di solito tutti i contratti vengono sciolti perché la società cessa: forniture, locazioni, appalti ecc. vengono chiusi con autorizzazione e eventuali indennizzi per la controparte sono crediti da far valere nel concordato come chirografari. Nella composizione negoziata, invece, nulla è imposto: i contratti proseguono, salvo tu negozi diversamente con i contraenti (puoi chiedere di rinegoziare i termini). Durante la composizione, i fornitori essenziali devono continuare a fornire se sei in regola con i pagamenti correnti, non possono usare la crisi come motivo di recesso (la legge 118/2021 lo vieta per evitare interruzioni di forniture vitali). In un eventuale fallimento, i contratti pendenti si sciolgono (il curatore decide se subentrare o sciogliere) e i dipendenti vengono licenziati subito con accesso al Fondo di Garanzia per TFR/stipendi e alla disoccupazione. Quindi, in sintesi: nelle procedure “morbide” (concordato in continuità, accordi) l’obiettivo è mantenere il business vivo, quindi dipendenti e contratti per lo più continuano; nelle procedure liquidatorie (concordato liquido, fallimento) si chiude tutto, ma i lavoratori hanno tutele (Fondo INPS) e i partner contrattuali riceveranno eventualmente un indennizzo come creditori.
D: I debiti fiscali (IVA, tasse) e contributivi si possono tagliare o vanno pagati per forza al 100%?
R: Oggi è possibile ridurre anche i debiti fiscali e contributivi in certi casi, grazie alla transazione fiscale e contributiva. Storicamente, l’IVA e i contributi erano “intoccabili” (dovevi pagarli per intero anche nel concordato) ma la legge è cambiata. In un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione puoi proporre al Fisco e all’INPS di accettare un pagamento parziale del dovuto (ad esempio il 30%) e/o una dilazione lunga. Questa proposta sarà valutata da Agenzia Entrate e INPS: la accetteranno se risulta conveniente rispetto all’alternativa (es: se nel fallimento prenderebbero 5%, una proposta del 30% può essere accolta). Se la accettano, il giudice omologa il tutto. Se non accettano, oggi la legge consente comunque al tribunale di omologare la tua proposta contro il parere del Fisco, a patto che tu garantisca almeno il 30% al Fisco e che quell’importo sia ritenuto equo rispetto alla liquidazione. Questo è il cosiddetto cram-down fiscale: il tribunale può “forzare” la transazione se il Fisco fa il difficile ma la tua offerta gli dà più di quanto ricaverebbe liquidandoti. Dunque, sì, puoi “stralciare” IVA, imposte e contributi in ambito concorsuale, seguendo le regole. Fuori dalle procedure, invece, il Fisco non accetta stralci (a parte le rottamazioni periodiche che tagliano sanzioni e interessi, ma l’imposta la vogliono intera). Una via di mezzo è la rateazione: puoi ottenere fino a 6 anni (72 rate) dilazionando cartelle senza riduzione. Ma il taglio vero e proprio lo ottieni solo con transazione fiscale nel concordato/accordo. Nota: l’IVA è stata a lungo considerata immodificabile per vincoli UE, ma ora è ammesso stralciarla purché all’interno di “procedure rigoriose” come il concordato – la Corte di Giustizia UE ha detto che non è rinuncia indiscriminata se avviene sotto controllo e con convenienza superiore alla liquidazione (sentenza “Degano Trasporti” citata in Corte Cost. n.245/2019). Infatti, dal 2017 la Cassazione ha consentito falcidia IVA in concordato senza transazione, e ora il CCII la consente con transazione. Per i contributi INPS, stesso discorso: transazione contributiva. Quindi, anche i debiti verso Erario e INPS oggi si possono trattare, non vanno necessariamente pagati al 100% se l’azienda è insolvente. Bisogna però rispettare la forma (inserirli in un piano omologato) e dare evidenza che stai offrendo il massimo possibile (almeno quanto avrebbero dal fallimento). Fuori da piani concorsuali, l’unico sconto è se ogni tanto esce una legge di “saldo e stralcio” per piccoli importi o per interessi/multe (come quella del 2023 per cartelle < €1.000). Ma non puoi contarci, sono occasionali e limitate. Dunque, includere Fisco e INPS in un piano concordatario è la strada per ridurre il peso fiscale.
D: Ci sono rischi penali se la mia azienda non paga tasse o contributi?
R: Sì, ci sono alcuni reati tributari e previdenziali a carico dell’amministratore se l’azienda omette determinati pagamenti oltre soglie di importo: – Omesso versamento di IVA: se la tua società non versa l’IVA dovuta annualmente per un importo superiore a €250.000, scatta il reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 (punibile con reclusione 6 mesi–2 anni). Sotto €250k non è reato (solo sanzione amministrativa). La soglia va riferita all’anno d’imposta. Quindi, ad es., IVA 2024 evasa €300k = reato; €240k = no reato. – Omesso versamento di ritenute certificate (IRPEF trattenuta ai dipendenti): soglia €150.000 annui, art. 10-bis D.Lgs.74/2000 (reclusione fino a 3 anni). Anche qui, se la società non versa le ritenute operate (che risultano nelle CU) oltre €150k, è reato; sotto soglia, illecito amministrativo. – Omesso versamento di contributi previdenziali: tecnicamente, se trattasi di solo contributi datori di lavoro, oggi è depenalizzato (sanzione amministrativa). Ma se includi le ritenute previdenziali a carico del dipendente non versate, c’è il reato ex art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 se l’importo supera €10.000 annui. Questo è contravvenzione penale (arresto/fine) ma si estingue se paghi prima del giudizio. – Reati fallimentari: se poi l’azienda fallisce, l’omesso versamento di imposte non è reato di per sé, ma se hai dissipato risorse che potevano servire a pagarle, potresti incorrere in bancarotta fraudolenta (ad es. se hai usato quei fondi per altro scopo). Quindi, il rischio penale c’è per IVA e ritenute. Come difendersi? Intanto saperlo e calcolare: se vedi che la tua società rischia di non pagare IVA oltre soglia, valuta soluzioni – un concordato che includa quell’IVA, ad esempio. Nota positiva: se riesci poi a pagare (anche tardivamente) il dovuto prima che inizi il dibattimento penale, l’omesso versamento IVA/ritenute non è punibile (causa di non punibilità introdotta di recente). E in caso di concordato, la Cassazione ha detto che il concordato che prevede il pagamento parziale dell’IVA esclude la punibilità perché quell’obbligo viene meno parzialmente per legge. Cioè, se il giudice omologa un concordato dove al Fisco dai il 30% dell’IVA, stai di fatto regolarizzando la posizione secondo la legge, quindi non dovresti essere punito per il 70% non versato. Sui contributi, se li inserisci in transazione contributiva e poi li paghi come concordato prevede, anche lì dimostri di aver adempiuto almeno in parte. In conclusione: il rischio penale esiste per amministratori che lasciano l’IVA o le ritenute non pagate; la soluzione migliore è evitare di accumulare quegli arretrati oltre soglia (magari pagando almeno in parte in extremis) e, se già esistono, risolvere via un piano concorsuale (che evita la procedibilità penale se approvato). Per contributi dipendenti, la soglia €10k è bassa: cercare sempre di versare almeno le ritenute employee (che sono poche, il 9% stipendio) per non incorrere nel reato, e semmai lasciare indietro la quota azienda (che non è penalmente sanzionata se non versi). Insomma, attenzione alle soglie penali e, in caso di crisi, affrontare quelle voci per prime.
D: Dopo un concordato o fallimento, i debiti residui della società che fine fanno?
R: Se parliamo di società (S.r.l., S.p.A.), al termine di un concordato la società resta in vita (salvo concordato liquidatorio dove magari viene poi estinta) ma i crediti anteriori sono definiti secondo la proposta: ciò significa che il creditore ha diritto solo a quanto previsto dal piano e niente di più. Ad esempio, se in concordato ha preso 30%, il restante 70% è perduto e non potrà più pretenderlo (è remissibile per legge). La società risanata riparte “pulita” dai vecchi debiti (tecnicamente non c’è un’“esdebitazione” formale come per le persone fisiche, ma di fatto i debiti sono stati falcidiati e nessuno potrà reclamarli ulteriormente – il decreto di omologa fa stato). Nel caso di liquidazione giudiziale (fallimento), la società viene di norma cancellata dal registro imprese a fine procedura, quindi i debiti residui si estinguono con lei. Giuridicamente non c’è un soggetto contro cui farli valere, e i creditori non soddisfatti restano tali ma senza più azione. Per l’imprenditore persona fisica, invece, esiste l’esdebitazione: dopo la chiusura del fallimento, il debitore individuo può chiedere al tribunale di essere esdebitato, cioè liberato da tutti i debiti non pagati nella procedura, così da poter ricominciare. Oggi l’esdebitazione è quasi automatica se il fallito ha collaborato (CCII la concede salvo casi di frode o simili). Quindi, in un certo senso, c’è un “perdono” sui debiti residui. Anche nel concordato per persona fisica, dopo che esegue la percentuale dovuta, il resto non può più esigerlo nessuno (analogo all’esdebitazione). Dunque, tanto per società quanto per persone, un concorso chiude la partita debitoria: il creditore ha avuto quello che ha avuto e non può inseguire oltre il debitore. Fa eccezione ovviamente un coobbligato o garante terzo: se Tizio aveva garantito la società, il creditore può rifarsi su Tizio anche dopo, perché il concordato non libera i terzi garanti (salvo questi fossero anch’essi parte di accordo). Ma per il debitore principale, i debiti pregressi sono considerati estinti nei limiti della falcidia subita. In sintesi, il concordato/fallimento consente al debitore onesto di chiudere con il passato: la società fallita viene cancellata, l’imprenditore persona fisica ottiene l’esdebitazione e nessun debitore “a vita”. Naturalmente, questo vale se la procedura è andata regolare; se emergeranno attività occulte, potrebbero revocare l’esdebitazione etc., ma parliamo di casi di frode. Per la generalità, c’è vita oltre i debiti: la legge consente di ripartire senza quei fardelli.
Tabelle riepilogative
Di seguito forniamo due tabelle di riepilogo che sintetizzano le informazioni chiave discusse nella guida, utili per un confronto immediato.
Tabella 1 – Principali strumenti di gestione della crisi d’impresa (concordati e accordi)
| Strumento (norma di riferimento) | Finalità | Attivazione & Presupposti | Coinvolgimento dei creditori | Esito per l’impresa |
|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (D.L. 118/21 conv. L.147/21, ora artt. 17-25 septies CCII) | Risanamento in via stragiudiziale assistita (continuità aziendale ove possibile). | Volontaria, avviata dall’imprenditore in crisi reversibile (anche se già insolvente ma recuperabile). Si richiede istanza via piattaforma; nominato un esperto. | Nessun voto. Trattative riservate con creditori. Possibili accordi stragiudiziali o preparazione di piani/accordi concorsuali. Misure protettive disponibili (su istanza, stop ai pignoramenti). | Se accordo raggiunto: l’azienda prosegue secondo i nuovi accordi. Se fallisce: l’imprenditore può accedere al concordato semplificato. In ogni caso, ha mostrato diligenza (utile per evitare azioni di responsabilità). |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Risanamento stragiudiziale con protezione da revocatorie. Obiettivo: riequilibrio economico-finanziario senza procedure formali. | Unilaterale (piano redatto dall’imprenditore). Richiede attestazione da parte di esperto indipendente su veridicità dati e fattibilità del piano . Presuppone squilibrio gestibile: usato se crisi non troppo grave o con pochi creditori chiave. | Accordi su base contrattuale con i creditori che aderiscono. Nessuna omologazione. I creditori estranei restano con diritti integri (devono essere pagati integralmente a scadenze ordinarie). Atti esecutivi del piano non revocabili in caso di fallimento. | Se il piano ha successo: evitata l’insolvenza, l’azienda continua sotto nuovi termini concordati privatamente. Se insuccesso: possibilità di virare su accordo ex art.57 o concordato. Comunque, atti compiuti nel frattempo restano protetti. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) | Ristrutturazione debiti con efficacia legale (vincolante) ma senza procedura complessa. Permette cram-down sui pochi dissenzienti (per categorie). | Volontaria: iniziativa del debitore con consenso ≥60% dei crediti. Richiede omologazione del tribunale. Impresa può essere in crisi o insolvente (purché accordo assicuri pagamento integrale estranei). | Nessun voto collettivo, ma adesione individuale di ≥60% crediti. Omologazione rende l’accordo vincolante per gli aderenti e settorialmente per eventuali finanziatori dissenzienti (≥75% categoria). Creditori estranei: vanno pagati integralmente entro 120 gg (o nei termini pattuiti). Possibile sospensione azioni esecutive su richiesta durante omologa. | Se omologato, l’impresa esegue l’accordo e prosegue (di solito in continuità). I creditori ottengono le riduzioni/dilazioni pattuite e non possono più agire oltre i termini concordati. Se non omologato (es. adesioni insufficienti): il debitore può ripiegare su un concordato preventivo. |
| Concordato preventivo in continuità (artt. 84-94 CCII) | Salvaguardia dell’impresa in crisi mediante soddisfazione parziale dei creditori e prosecuzione dell’attività. Obiettivo: evitare la dispersione del valore aziendale. | Volontaria: domanda dell’imprenditore (anche in proprio). Presuppone stato di crisi o insolvenza. Piano deve prevedere continuità (diretta o tramite cessione/affitto d’azienda) e convenienza per creditori > liquidazione. Nessuna soglia minima di pagamento chirografi imposta per legge (≠ liquidatorio 20%). | Voto dei creditori su proposta: maggioranza >50% crediti (per valore). Eventuale suddivisione in classi omogenee; possibile cram-down di classi dissenzienti se il piano è equo (art. 112). Creditori privilegiati pagati secondo par condicio salvo consenso a diversa scadenza/riduzione; possibili parziali falcidie se incapienza o contributo “esterna” (surplus). Commissario giudiziale nominato. Azioni esecutive sospese durante la procedura. | Se omologato, l’impresa continua l’attività sotto il piano di risanamento. Debiti pregressi risolti secondo piano (falcidiati/dilazionati); a fine esecuzione i creditori non possono avanzare pretese extra. La società esce dalla procedura ristrutturata (eventualmente con nuovi investitori o diversa struttura). Se non omologato (esito negativo del voto o revoca): probabile conversione in liquidazione giudiziale (fallimento). |
| Concordato preventivo liquidatorio (art. 84 co.4 CCII) | Liquidazione ordinata dell’attivo sotto controllo del debitore, con parziale soddisfacimento dei creditori. Alternativa “concordata” al fallimento (quando non c’è possibilità di continuità). | Domanda dell’imprenditore in stato di insolvenza conclamata. Piano prevede cessione di tutti i beni. Requisiti obbligatori: pagamento ≥20% ai chirografari + apporto di risorse esterne ≥10% attivo (per migliorare soddisfazione rispetto a fallimento). Se requisiti non rispettati, proposta inammissibile. | Voto dei creditori come per concordato in continuità. Di solito un’unica classe chirografi, privilegiati votano se non pagati al 100%. Maggioranza valore >50%. Nessuna continuazione d’azienda: rapporti contrattuali risolti. Nominato liquidatore giudiziale per attuare le vendite post-omologa. Creditori privilegiati soddisfatti prioritariamente col ricavato, chirografari ≥20%. Soci perdiamo capitale e di norma escono senza nulla. | Se omologato, la società viene spossessata: un liquidatore (spesso il commissario) vende i beni secondo il piano e distribuisce ai creditori le percentuali promesse. Eseguito il piano, la società viene cancellata (cessa). I creditori non soddisfatti integralmente non possono agire oltre (debiti estinti nei limiti della falcidia subita). Se non omologato (mancanza di voto o fattibilità), si apre la liquidazione giudiziale. |
| Concordato semplificato post-composizione negoziata (art. 25-sexies CCII) | Liquidazione concorsuale rapida senza voto dei creditori. Obiettivo: evitare il fallimento quando la composizione negoziata non ha salvato l’azienda ma c’è un piano liquidatorio vantaggioso. | Accessibile solo se è stata svolta la composizione negoziata e l’esperto nella relazione finale ha attestato l’assenza di soluzioni di continuità percorribili. Domanda entro 60 gg da tale relazione. Insolvenza presente. Piano unicamente liquidatorio (no continuità). | Nessun voto dei creditori. Creditori e parti possono presentare osservazioni/opposizioni in udienza. Decide il tribunale se omologare, valutando la convenienza per creditori e la regolarità. Una volta aperta la procedura, nominato un liquidatore giudiziale (il debitore propone un nome). Azioni esecutive sospese come in concordato ordinario durante la procedura. | Se omologato, il liquidatore realizza i beni secondo il piano e paga i creditori in ordine di prelazione. La procedura è veloce (pochi mesi). Poi la società viene cancellata. Debiti residui insoddisfatti non più esigibili (società estinta; per persona fisica c’è esdebitazione). Se il tribunale non omologa (ritiene la proposta iniqua o in frode), di norma dichiara contestualmente la liquidazione giudiziale (fallimento). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento, artt. 121-270 CCII) | Liquidazione forzata con spossessamento dell’impresa insolvente, per soddisfare i creditori secondo par condicio. Soluzione giudiziale “classica” se risanamento impossibile o non richiesto dal debitore. | Procedimento d’ufficio su ricorso di creditore, debitore o PM. Presuppone insolvenza conclamata. Competenza del tribunale. Non richiede cooperazione del debitore (può essere dichiarata anche contro la volontà). Organi: giudice delegato e curatore nominato. | Nessun voto di creditori su piano (non c’è un piano proposto dal debitore). I creditori partecipano insinuando i loro crediti nel passivo entro termini. Assemblea di creditori ha poteri limitati (nomina comitato, approva progetto di riparto finale). Curatore liquida i beni con autorizzazioni del GD e parere comitato. Creditori soddisfatti secondo prelazioni (privilegi, ipoteche; i chirografari solo su eventuale residuo). Durata spesso lunga (anni). | Impresa spossessata e solitamente cessazione attività (salvo brevi esercizi provvisori se conviene). Al termine, la società è cancellata d’ufficio dal RI; i debiti residui restano inesigibili (società estinta). L’imprenditore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti) quasi di diritto a fine procedura. Procedura può comportare azioni di responsabilità vs amministratori e conseguenze penali (bancarotta). |
Tabella 2 – Responsabilità patrimoniali e obblighi delle figure chiave nell’impresa debitrice
| Soggetto | Responsabilità per i debiti sociali | Obblighi e condotte virtuose | Rischi in caso di condotta scorretta |
|---|---|---|---|
| Amministratore di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) | In linea generale non risponde personalmente dei debiti della società (principio di autonomia patrimoniale perfetta). Eccezioni solo se presta garanzie personali (es. fideiussione) o in caso di azione di responsabilità per mala gestio. | – Dovere di gestire con diligenza e attivare assetti adeguati per rilevare la crisi (art. 2086 c.c.).<br>– Obbligo di reagire tempestivamente alla crisi: adottare misure di risanamento o attivare procedure concorsuali appena emergono segnali gravi.<br>– In caso di perdita rilevante di capitale, convocare soci per provvedimenti (artt. 2446/2447, 2482-bis c.c.).<br>– Durante trattative (composizione negoziata) o procedure concorsuali, cooperare lealmente con esperto/commissario/curatore, fornendo informazioni veritiere e non aggravare il passivo.<br>– Predisporre un piano di pagamento dei creditori o di liquidazione ordinata se vede insolvenza inevitabile (meglio domandare concordato che attendere il fallimento). | – Azione di responsabilità: se viola i doveri, l’amministratore può essere chiamato a risarcire danni verso società (azione sociale) e verso creditori (azione dei creditori ex art. 2394 c.c. o art. 378 CCII). Tipico: se ha continuato ad indebitare l’azienda in insolvenza aggravando i debiti, i creditori insoddisfatti possono ottenere da lui il risarcimento del maggior deficit (stabilito con criteri presuntivi ex art. 2486 c.c.).<br>– Responsabilità penale: amministratore può incorrere in reati fallimentari (bancarotta fraudolenta se ha distratto beni, falsificato conti, pagato preferenzialmente taluni creditori in danno di altri; bancarotta semplice se ha aggravato per negligenza il dissesto). Inoltre: omesso versamento di IVA o ritenute (reati tributari) se oltre soglie; omesso versamento contributi dipendenti (oltre soglia 10k) reato contravvenzionale.<br>– Fideiussioni personali: se ha garantito debiti sociali, al di là del suo ruolo, il patrimonio personale è aggredibile dal creditore garantito. Nei concordati, la liberazione del garante richiede accordo specifico del creditore (non è automatica). |
| Socio di S.r.l./S.p.A. (non amministratore) | Non risponde dei debiti sociali oltre la perdita della propria partecipazione (responsabilità limitata). Il creditore sociale non può pretendere pagamento dal socio. | – Conferire per intero il capitale sottoscritto; non percepire utili se non da bilanci regolarmente approvati e in presenza di utili distribuibili (art. 2433 c.c.).<br>– Se la società perde il capitale, in assemblea approvare ricapitalizzazione o liquidazione (nel caso S.r.l., i soci devono attivarsi se amministratori omessi).<br>– In situazione di crisi, eventualmente finanziare la società per sostenerla, ma tenendo presente che i finanziamenti soci in fase di undercapitalization sono postergati (art. 2467 c.c.). | – Perdita del conferimento: se la società fallisce o va in concordato liquidatorio, il socio normalmente perde il valore delle quote (il che è il rischio d’impresa accettato).<br>– Restituzione utili illeciti: se ha incassato dividendi o rimborsi contrari alla legge (ad es. utili inesistenti), il curatore o commissario può chiederne la restituzione ai sensi di legge per soddisfare i creditori.<br>– Azione di responsabilità del curatore verso soci “dominus”: se un socio (di maggioranza) ha di fatto diretto la società causando danni (amministratore di fatto), può risponderne al pari di un amministratore formalmente investito. Ma il socio puro, non ingerente, non ha tali obblighi gestori.<br>– Escussione garanzie personali: se il socio (anche non amministratore) ha garantito debiti sociali con patrimonio personale (es. ha ipotecato immobile proprio a garanzia di mutuo sociale, o firma di avallo), i creditori possono escutere quelle garanzie indipendentemente dalla procedura concorsuale (i garanti non sono protetti dal concordato, salvo liberatoria contrattuale). |
| Imprenditore individuale / Socio illimitatamente responsabile (S.n.c., S.a.s.) | Non c’è distinzione tra patrimonio aziendale e personale: risponde con tutti i propri beni dei debiti d’impresa (art. 2740 c.c.). Nel caso di società di persone, i creditori sociali, dopo escussa la società, possono aggredire beni personali dei soci (art. 2267 c.c.). | – Doveri analoghi a quelli dell’amministratore di società: tenere contabilità regolare, attivarsi tempestivamente nella crisi (anche per l’imprenditore individuale la legge suggerisce di utilizzare gli strumenti come composizione o concordato).<br>– Nelle società di persone, i soci illimitatamente responsabili devono concordare le decisioni di gestione, ma anche vigilare: se un socio accomandatario o socio S.n.c. dissipa patrimonio, ne risponderanno comunque anche gli altri con i propri beni. Dunque obbligo di correttezza e controllo reciproco. | – Patrimonio personale escusso: in fallimento, l’imprenditore individuale viene dichiarato fallito con effetti su tutti i suoi beni (presenti e futuri). Nelle S.n.c., il fallimento dei soci segue quello della società. Il curatore può liquidare sia i beni aziendali sia quelli personali del titolare/socio, a beneficio dei creditori.<br>– Esdebitazione: però l’imprenditore individuo ha diritto, al termine, all’esdebitazione (liberazione debiti residui) se ha collaborato. Ciò significa che, dopo aver subito l’escussione del suo patrimonio, può ripartire senza strascichi di debiti a vita (cosa che un socio di S.r.l., se avesse garantito, non avrebbe; ma un socio di S.r.l. non subisce nemmeno il sequestro dei suoi beni inizialmente).<br>– Rischio penale: l’imprenditore individuale può incorrere in reati fallimentari allo stesso modo (bancarotta) e tributari (omesso versamento IVA, ecc.) come un amministratore. Inoltre, il socio illimitato che sottrae beni sociali commette reato di bancarotta patrimoniale proprio.<br>– Difficoltà di accesso a concordati risanatori: il piccolo imprenditore sottosoglia in crisi può usare le procedure di sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore/professionista), ma se è “fallibile” allora può anche proporre concordato. In generale, la legge ora parifica sul piano strumenti, ma l’imprenditore individuale rischia di perdere la casa, ecc., se garanzie personali coinvolte (non c’è schermo societario). |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; c.c. = Codice Civile; OCRI = Organismi di Composizione delle Crisi, la cui entrata in vigore è stata sospesa in favore della composizione negoziata.)
Considerazione finale: La gestione di un’azienda indebitata richiede sangue freddo, conoscenza degli strumenti legali e soprattutto tempestività. Dal punto di vista del debitore, “difendersi” non significa fare ostruzionismo, ma anzi prendere l’iniziativa: riconoscere la crisi, comunicare con i creditori e sfruttare i canali normativi per evitare soluzioni distruttive come l’esecuzione forzata o il fallimento giudiziario. L’ordinamento attuale offre molteplici vie d’uscita, in un’ottica di salvaguardia sia dell’impresa quando possibile, sia della dignità del debitore in caso di liquidazione. Abbiamo visto come un imprenditore diligente può salvare l’azienda tramite accordi o, se ciò non è fattibile, almeno chiudere la partita debitoria in modo ordinato e con conseguenze personali limitate. Viceversa, l’inazione o i comportamenti scorretti restringono le opzioni di difesa e amplificano i rischi (fino a coinvolgere il patrimonio personale e la sfera penale). In conclusione, “cosa fare” per un’azienda con debiti è: affrontare la crisi di petto, con l’aiuto di professionisti, scegliendo lo strumento adatto (dal piano attestato al concordato) e coinvolgendo proattivamente creditori e autorità. “Come difendersi” significa usare le tutele offerte da quelle procedure (sospensioni di pignoramenti, transazioni fiscali, esdebitazione) per proteggere il valore aziendale residuo e il proprio futuro post-crisi. Così facendo, si possono spesso trasformare situazioni che sembravano disperate in soluzioni gestibili e, dove c’è un nucleo sano, in veri e propri rilanci aziendali.
Fonti e Riferimenti
- Codice Civile, artt. 2086, 2446-2447, 2482-bis, 2484-2487, 2486, 2394, 2407, etc. – Doveri di amministratori e organi di controllo; cause scioglimento società; responsabilità verso società e creditori.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n.83 (Correttivo-bis) e D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (Correttivo-ter). In particolare: artt. 3-4 (adeguati assetti), 24-25 (allerta esterna creditori pubblici); artt. 17-25-sexies (Composizione negoziata); art. 56 (Piani attestati); artt. 57-64 (Accordi di ristrutturazione); art. 63 (Transazione fiscale); artt. 84-88 (Concordato preventivo: requisiti, continuità vs liquidatorio); art. 94 (Effetti concordato: sospensione azioni); artt. 112-114 (Omologazione concordato e cram-down classi); art. 120 (Concordato semplificato, rinvio a art.25-sexies); art. 25-sexies (Concordato semplificato post composizione); artt. 121-270 (Liquidazione giudiziale; effetti, esdebitazione); art. 322 (Bancarotta semplice: aggravamento dissesto). – (Gazzetta Ufficiale vari anni; testo consolidato su Normattiva).
- Cass., Sez. I, 8 marzo 2023 n. 6893 – Principio di diritto: l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. contro gli amministratori in caso di prosecuzione abusiva dell’attività dopo perdita capitale/insolvenza è di natura extracontrattuale “sui generis”, fondata sulla violazione di obblighi di conservazione del patrimonio (art. 2486 c.c.). Conferma che l’amministratore risponde verso i creditori per atti di mala gestio successivi al verificarsi di causa di scioglimento (insolvenza), non riconducibili a 2043 c.c. (tutela aquiliana ordinaria) ma a disciplina speciale. (Massimata in Diritto della Crisi).
- Cass., Sez. I, 8 marzo 2023 n. 6893 (massima su Eutekne) – “L’amministratore è responsabile verso il creditore sociale se non prova che l’operazione nuova era funzionale alla liquidazione”: onus probandi sull’amministratore che compie nuove operazioni dopo scioglimento.
- Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016 n. 26988 e 13 gennaio 2017 n. 760 – Hanno mutato orientamento in tema di IVA falcidiabile nel concordato: consentito il pagamento parziale dell’IVA in concordato in assenza di transazione fiscale, superando il precedente divieto assoluto, in ossequio ai principi UE (CJUE caso Degano).
- Corte Costituzionale, sentenza 3 dicembre 2019 n. 245 – Ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia IVA nelle procedure di sovraindebitamento (L.3/2012), richiamando la giurisprudenza UE: lo Stato può accettare pagamento parziale IVA in un quadro procedurale serio come il concordato, senza violare obblighi UE. Il contesto argomentativo spiega che il precedente “divieto in ogni caso” costituiva disparità di trattamento irragionevole.
- D.L. 13 agosto 2011 n. 138, art. 6 (conv. L.148/2011) – Inserito art. 2467 c.c. sui finanziamenti soci postergati. E art. 2497 c.c. – Responsabilità di chi esercita direzione e coordinamento (holding) verso creditori società etero-diretta. – (Possibili riferimenti in caso di responsabilità soci di fatto).
- Cass., 20 novembre 2024 n. 29844 – (Vicenda omessa vigilanza amministratori non esecutivi in banca). Ha affermato la responsabilità solidale anche degli amministratori non esecutivi che omettono di attivarsi davanti a segnali di cattiva gestione, in particolare in contesti bancari.
- Cass., Sez. V pen., 31 gennaio 2019 n. 4943 – (Caso omesso versamento IVA e concordato): ha ritenuto che l’integrale pagamento del debito IVA nel concordato non è condizione per escludere il reato se la proposta non rispetta transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. (precedente prima della riforma CCII). Oggi superato, in quanto l’art. 88 CCII consente di includere IVA in concordato.
- Cass. pen., Sez. III, 11 aprile 2019 n. 16010 – Conferma la non punibilità ex art. 131-bis c.p. per omesso versamento IVA se il debito IVA viene soddisfatto parzialmente in concordato su autorizzazione giudice (principio di causa di giustificazione economico-legale in caso di concordato autorizzato). – (giurisprudenza di merito e legittimità in evoluzione, vedere anche Cass. 12/2020 n. 13203).
- Tribunale di Milano, 10 ottobre 2022 – Prima applicazione concordato semplificato: omologato concordato semplificato proposto da società edilizia (EcoBuild, citato) nonostante opposizione di alcuni creditori, ritenendo soddisfatto il requisito di convenienza rispetto al fallimento . – (Fonte: IlCaso.it, massima) .
- Tribunale di Roma, 15 dicembre 2022 – Ha negato omologa di concordato semplificato per mancanza effettiva di trattative serie in composizione negoziata (debitore non aveva coinvolto davvero i creditori), a riprova che i giudici vigilano su possibili abusi. – (Fonte: Diritto della Crisi, Focus).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 (Riforma Cartabia) – Ha modificato le procedure di sovraindebitamento (Codice della crisi, artt. 65-91) allineandole ai concordati. Rilevante perché piccoli imprenditori non fallibili possono accedere a esdebitazione più facilmente.
- Documentazione normativa e dottrinale:
- Relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019 – Principi ispiratori del Codice (enfasi su emersione tempestiva crisi, continuità aziendale).
- Relazione ministeriale al D.L. 118/2021 – Ratio introduzione composizione negoziata (superare inefficienze allerta obbligatoria, privilegiare negozialità).
- Massimario Corte di Cassazione (Relazione 2021 sul punto concordati – “Il punto sul concordato preventivo” Corte Cass.) – evidenzia orientamenti su falcidia IVA e necessità di transazione fiscale.
- Linee guida CNDCEC sulla composizione negoziata – Suggeriscono best practices per esperti e imprese (check-list autodiagnosi, indicazioni su misure protettive).
La tua azienda che produce, assembla o commercializza filtri olio (automotive, industriali, idraulici) ha ricevuto un accertamento fiscale da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza oppure ha debiti con INPS e Agenzia Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, assembla o commercializza filtri olio (automotive, industriali, idraulici) ha ricevuto un accertamento fiscale da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza oppure ha debiti con INPS e Agenzia Entrate-Riscossione?
Ti hanno chiesto documenti su forniture, materiali filtranti, componentistica, cicli produttivi, magazzino, lavorazioni esterne o movimenti bancari?
👉 Sei in un settore molto controllato: materiale filtrante, componentistica importata, margini variabili e produzioni su larga scala rendono il comparto dei filtri particolarmente esposto agli accertamenti.
La buona notizia? Puoi difendere l’azienda, bloccare il Fisco e ridurre i debiti, se agisci con una strategia precisa e professionale.
Questa guida ti mostra cosa fare subito, quali errori evitare e come un avvocato specializzato può tutelarti in modo efficace.
💥 Perché le Aziende di Filtri Olio Finiscono Sotto Accertamento
Il settore è sotto osservazione per molte ragioni:
- materiali filtranti difficili da tracciare (carta, fibra, resine, elementi metallici);
- componentistica acquistata anche dall’estero (corpi, valvole, tappi, guarnizioni);
- differenze tra magazzino, scarti e prodotti finiti;
- subforniture e lavorazioni esterne difficili da documentare;
- elevate quantità prodotte → sospetti su margini e ricarichi;
- contestazioni su forniture a officine, industrie e rivenditori;
- movimenti bancari considerati incoerenti con i ricavi dichiarati;
- percezione di settore a rischio evasione in base ai volumi.
📌 Molte di queste contestazioni nascono da presunzioni tecniche errate o ricostruzioni contabili incomplete.
⚠️ I Rischi per una Azienda di Filtri Olio con Debiti
Se non intervieni subito rischi:
🧾 accertamenti pesanti su imposte e sanzioni;
🏦 pignoramento del conto aziendale;
🚚 fermo amministrativo dei mezzi;
🧱 ipoteca su magazzini, officine o capannoni;
⚙️ verifiche su fornitori, componenti e lavorazioni;
📉 perdita di credibilità verso banche e fornitori strategici;
🛑 blocco di produzioni, consegne e approvvigionamenti.
📌 Un accertamento mal gestito può fermare produzione, vendite e catena di fornitura.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ NON rispondere da soli al Fisco
Ogni parola può essere male interpretata.
Ogni documento consegnato senza strategia può peggiorare la posizione dell’azienda.
📌 Prima di parlare con il Fisco serve un’analisi professionale.
2️⃣ Far analizzare l’accertamento da un avvocato specializzato
Un avvocato esperto verifica:
- vizi di notifica;
- decadenza dei termini;
- errori nella ricostruzione del magazzino;
- contestazioni infondate su materiali filtranti o componenti;
- presunzioni tecniche errate su costi e margini;
- irregolarità negli accertamenti bancari;
- incoerenze tra documenti e ricostruzione dell’Agenzia.
📌 Molti accertamenti sono illegittimi e possono essere annullati o ridotti di oltre il 70%.
3️⃣ Presentare Memorie Difensive o Attivare il Contraddittorio
In questa fase puoi:
- chiarire i costi reali dei materiali e della componentistica;
- spiegare differenze di magazzino, scarti e cicli produttivi;
- giustificare subforniture e lavorazioni esterne;
- correggere errori dell’Agenzia;
- evitare la chiusura dell’accertamento.
📌 Una difesa tecnica forte può bloccare tutto prima dell’avviso definitivo.
4️⃣ Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni)
Con il ricorso puoi ottenere:
- sospensione immediata dell’accertamento;
- annullamento totale o parziale delle imposte;
- cancellazione delle sanzioni;
- blocco dei pignoramenti e delle azioni esecutive.
📌 In casi urgenti il giudice può sospendere la riscossione in 48 ore.
5️⃣ Contestare gli Accertamenti Bancari
Il Fisco presume:
- versamenti = ricavi non dichiarati
- prelievi = costi non giustificati
- bonifici = operazioni non registrate
Ma la giurisprudenza è chiara:
📌 I movimenti bancari non sono automaticamente ricavi: vanno spiegati e documentati correttamente.
6️⃣ Ristrutturare i Debiti (se una parte è reale)
Dopo la difesa, puoi:
- rateizzare fino a 120 rate;
- aderire alle rottamazioni;
- ottenere saldo e stralcio;
- attivare strumenti di crisi d’impresa (PRO, accordo di ristrutturazione, concordato minore).
📌 Prima si contesta. Solo dopo — se serve — si paga.
🧩 Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Avviso di accertamento o PVC
- Estratto di ruolo (se presenti cartelle)
- Inventari e giacenze di magazzino
- Distinte base dei filtri olio
- Fatture di acquisto e vendita
- Documentazione di fornitori e subfornitori
- Estratti conto bancari
- DDT e documenti di trasporto
- Certificazioni, test e controlli qualità
- Cicli produttivi, scarti e resi
⏱️ Tempistiche
- Analisi del caso: 24–72 ore
- Sospensione cautelare: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Durata complessiva: 6–18 mesi
📌 La sospensione può bloccare immediatamente riscossione, pignoramenti e fermi.
⚖️ Vantaggi di una Difesa Specializzata
✔️ Riduzione o annullamento dell’accertamento
✔️ Blocco di pignoramenti e ipoteche
✔️ Contestazione tecnica dei costi e dei cicli produttivi
✔️ Protezione di magazzino, macchinari e mezzi
✔️ Difesa contro contestazioni su fornitori e subforniture
✔️ Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
🚫 Errori da Evitare
❌ Rispondere da soli al Fisco
❌ Consegnare documenti senza una strategia precisa
❌ Lasciar scadere i 60 giorni per il ricorso
❌ Ignorare gli accertamenti bancari
❌ Affidarsi a consulenti non esperti in contenzioso tributario
📌 Un singolo errore può costare decine di migliaia di euro e mettere a rischio l’attività.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analisi tecnica dell’accertamento
📌 Individuazione dei vizi e delle contestazioni più efficaci
✍️ Presentazione di memorie difensive e ricorsi tecnici
⚖️ Difesa in Corte Tributaria
🔁 Trattative per rateizzazioni e riduzioni del debito
🛡️ Protezione totale dell’azienda e dell’imprenditore
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in accertamenti fiscali
✔️ Specializzato nella difesa di aziende meccaniche e produttive
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Riscossione
Conclusione
Un accertamento fiscale alla tua azienda di filtri olio non significa dover pagare tutto quello che il Fisco richiede.
Con una difesa tempestiva puoi:
- bloccare l’accertamento,
- contestare ricostruzioni errate,
- ridurre debiti e sanzioni,
- proteggere la produzione, il magazzino e il patrimonio.
⏱️ Agisci subito: ogni giorno è decisivo.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa della tua azienda può iniziare oggi stesso.