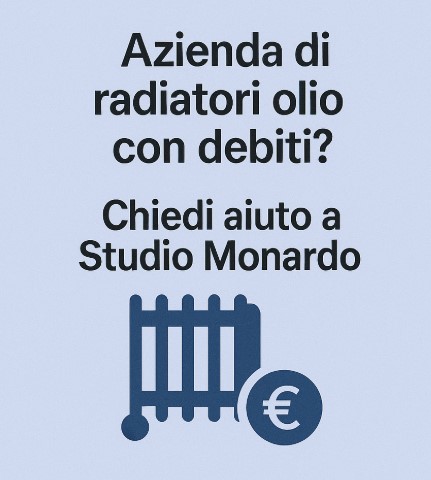Se gestisci un’azienda che produce, distribuisce o vende radiatori a olio – sia per il settore domestico che professionale – e hai ricevuto un accertamento fiscale, debiti, cartelle esattoriali o verifiche dell’Agenzia delle Entrate, sei in una fase molto delicata per il tuo business.
Il settore dei radiatori a olio comporta cicli produttivi specifici, costi variabili, componentistica tecnica, forniture continuative e un magazzino complesso che il Fisco spesso interpreta in modo errato.
La buona notizia è che un accertamento non è definitivo: può essere bloccato, contestato o ridotto, se intervieni subito con il supporto di un avvocato tributarista esperto nel settore industriale.
Perché le aziende di radiatori a olio vengono accertate così spesso
Le aziende che operano nella produzione e vendita di apparecchi elettrici e termici vengono controllate frequentemente per diversi motivi:
- magazzino tecnico complesso (resistenze, gusci, oli termici, componentistica)
- scarti di produzione facilmente fraintendibili
- differenze tra DDT, fatture e inventari
- cicli produttivi interpretati dal Fisco come “anomalie”
- acquisti frequenti di componenti da fornitori diversi
- margini variabili tra linee di prodotto
- contestazioni su movimentazioni bancarie non lineari
- vendite stagionali con picchi anomali
- ricostruzioni errate delle rimanenze
La maggior parte delle contestazioni nasce da una scarsa comprensione dei processi produttivi e logistici del settore.
Cosa fare subito quando arriva un accertamento fiscale
Un accertamento fiscale richiede risposte rapide ed esatte. Qualunque ritardo può aggravare la situazione.
Ecco cosa fare subito:
- fai analizzare l’atto da un avvocato tributarista esperto in aziende manifatturiere
- raccogli fatture, DDT, inventari, documenti di produzione, resi, scarti e movimenti bancari
- non rispondere da solo ai questionari o all’invito al contraddittorio
- verifica la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione
- controlla eventuali errori nella notifica o nei calcoli
- tutelati nel fornire dati su fornitori, margini e processi produttivi
- non presentare documenti inutili o non richiesti
Una risposta non supportata da analisi tecniche può aggravare l’accertamento e aumentare il debito.
Le contestazioni più comuni alle aziende di radiatori a olio
Le accuse principali riguardano:
- scarti di produzione interpretati come vendite non registrate
- differenze tra inventari e rimanenze contabili
- movimenti bancari considerati ricavi non dichiarati
- costi per componenti ritenuti non inerenti o non documentati
- acquisti frequenti interpretati come “anomalie”
- contestazioni sulla reale quantità di materiali utilizzati
- applicazione errata di margini medi di settore
- vendite stagionali interpretate come irregolari
- resi e sostituzioni non adeguatamente riconosciuti
Molte di queste sono presunzioni generate da una valutazione superficiale della filiera produttiva.
Come un avvocato può difenderti efficacemente
Un avvocato tributarista competente nel settore industriale può:
- contestare la ricostruzione errata del ciclo produttivo
- dimostrare la correttezza degli scarti e delle rimanenze
- giustificare i movimenti bancari contestati
- bloccare la riscossione con una sospensione tempestiva
- gestire il contraddittorio tecnico con l’Agenzia delle Entrate
- impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
- ottenere una forte riduzione o annullamento della pretesa fiscale
- evidenziare errori procedurali, tecnici o di valutazione del Fisco
Una difesa specializzata è fondamentale per aziende che lavorano con processi produttivi e componenti tecnici.
Quando un accertamento è illegittimo e può essere annullato
L’accertamento può essere illegittimo quando:
- si basa su presunzioni senza prove concrete
- la ricostruzione del magazzino o degli scarti è errata
- le motivazioni dell’atto sono troppo generiche
- sono stati ignorati documenti tecnici e contabili rilevanti
- i movimenti bancari sono stati interpretati senza analisi adeguata
- le spese sono considerate “non inerenti” senza reale valutazione
- ci sono errori nella notifica o nella ricostruzione dei calcoli
Molti accertamenti cadono semplicemente perché l’Agenzia applica schemi standard a un settore altamente tecnico.
Cosa rischi se non ti difendi
Non intervenire significa esporsi a conseguenze gravi:
- cartelle esattoriali elevate
- pignoramenti dei conti correnti
- blocco delle forniture di componentistica
- fermo amministrativo dei mezzi aziendali
- perdita di liquidità e difficoltà di produzione
- ipoteche su immobili
- sanzioni fino al 240% dell’imposta contestata
- danni alla reputazione commerciale
Una difesa tempestiva è essenziale per proteggere stabilimento, clienti e continuità produttiva.
Come evitare il blocco dell’attività
Per tutelare l’operatività della tua azienda:
- contesta immediatamente l’accertamento
- richiedi la sospensione della riscossione
- dimostra con documenti tecnici la correttezza dei processi produttivi
- coordina la difesa con commercialista e tecnici interni
- proteggi informazioni sensibili su fornitori, margini e volumi
- impugna l’atto se presenta errori o presunzioni non realistiche
Una difesa ben articolata permette di continuare la produzione e mantenere rapporti commerciali senza rischi di blocco.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti farlo se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento, un PVC o un invito al contraddittorio
- contestano scarti, rimanenze, costi o movimenti bancari
- hai debiti fiscali e temi pignoramenti o fermi amministrativi
- vuoi evitare che l’atto diventi definitivo
- il controllo coinvolge fornitori strategici o clienti importanti
Un avvocato esperto può impugnare l’atto, ridurre l’importo richiesto, bloccare la riscossione e tutelare davvero la tua azienda.
Attenzione: molte aziende del settore termotecnico pagano accertamenti infondati solo perché non conoscono i propri diritti. Con una strategia corretta puoi ridurre drasticamente o annullare la pretesa fiscale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in accertamenti fiscali, contenzioso tributario e difesa delle aziende tecniche – ti mostra come reagire nel modo più efficace.
👉 Hai ricevuto un accertamento fiscale o hai debiti con il Fisco?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per difenderti, bloccare la riscossione e proteggere la tua azienda di radiatori a olio.
Introduzione
Un’azienda che produce o commercia radiatori ad olio e che si trova in difficoltà finanziarie può affrontare una situazione complessa, con creditori di vario tipo (Fisco, banche, fornitori, enti previdenziali) che avanzano pretese. In Italia esiste un quadro normativo avanzato pensato per gestire la crisi d’impresa in modo equilibrato, tutelando sia i diritti dei creditori sia la continuità dell’attività aziendale ove possibile. In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo in dettaglio cosa può fare il debitore (l’azienda indebitata e i suoi titolari) per difendersi dalle azioni esecutive, risanare la propria impresa o, nei casi estremi, gestire un’uscita ordinata dal mercato minimizzando le conseguenze negative. L’analisi sarà svolta con un taglio giuridico-divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati interessati, fornendo riferimenti normativi puntuali e richiami a sentenze aggiornate.
Affronteremo innanzitutto le differenze legate alla forma giuridica dell’impresa (ad esempio una S.r.l. rispetto a una S.n.c. o a una ditta individuale) e alla natura dei debiti principali (debiti fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi, ecc.). Proseguiremo illustrando i doveri legali degli imprenditori in crisi e i rischi di inattività, per poi analizzare i vari strumenti di gestione della crisi e del sovraindebitamento previsti dall’ordinamento italiano – dal piano attestato di risanamento agli accordi di ristrutturazione, dal concordato preventivo alla nuova composizione negoziata della crisi, fino alle procedure di sovraindebitamento come il concordato minore o la liquidazione controllata per i soggetti non fallibili. Saranno inclusi casi pratici (simulazioni) in cui, ad esempio, la nostra Radiatori Oli S.r.l. affronta scenari diversi a seconda delle soluzioni adottate. Inoltre, una sezione di Domande e Risposte (FAQ) riassumerà i quesiti più comuni (ad es. “Un socio di S.n.c. risponde dei debiti con il proprio patrimonio?” oppure “Cos’è la composizione negoziata e come si attiva?”), fornendo risposte chiare e riferimenti utili. Tabelle riepilogative aiuteranno a confrontare opzioni e situazioni in modo sintetico.
Nota sul linguaggio e le fonti: useremo un linguaggio piano ma tecnicamente accurato, spiegando i concetti giuridici in modo comprensibile senza rinunciare al rigore. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali saranno citate nel testo con riferimenti in stile Harvard (es. sentenze della Corte di Cassazione, articoli di legge) e raccolte in fondo alla guida nella sezione Fonti e Riferimenti Normativi, per consentire approfondimenti. Questa guida è aggiornata alle ultime novità legislative – incluso il Terzo Decreto Correttivo al Codice della crisi d’impresa del settembre 2024 – e alle più recenti pronunce dei tribunali. Emblematica, ad esempio, la sentenza della Cassazione n. 30109/2025 (depositata il 2 settembre 2025) che ha riconosciuto nella composizione negoziata un efficace strumento di tutela del debitore: la sola pendenza di tale procedura, se supportata da un piano serio e dall’intervento di un esperto indipendente, può giustificare la sospensione di misure cautelari come sequestri preventivi sui beni aziendali. Si tratta di un importante segnale di fiducia verso i nuovi strumenti di risanamento introdotti dal legislatore, che conferma come un imprenditore in difficoltà, se agisce con trasparenza e tempestività, possa “difendersi” legalmente dalle azioni più invasive dei creditori mentre lavora al risanamento dell’impresa.
Iniziamo dunque l’analisi esaminando le diverse tipologie di imprese e come la forma giuridica influisce sulle responsabilità per i debiti, per poi addentrarci nelle possibili strategie di difesa e risanamento dal punto di vista del debitore.
Forma giuridica dell’impresa e responsabilità per i debiti
Uno dei primi aspetti da considerare, quando un’azienda indebitata cerca di capire “cosa fare per difendersi”, è la forma giuridica dell’impresa. In base alla struttura societaria infatti variano sia la responsabilità patrimoniale per i debiti, sia gli strumenti giuridici a disposizione. Di seguito distinguiamo i casi tipici:
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) – È una società di capitali con personalità giuridica e patrimonio separato. In una S.r.l., i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale della società e non anche direttamente sui beni personali dei soci. In altre parole vige la “responsabilità limitata”: i soci rischiano al massimo il capitale conferito. Ad esempio, la nostra ipotetica Radiatori Oli S.r.l. se accumula debiti non pagati verso fornitori o banche, vede come soggetto obbligato al pagamento la società in sé; i soci non sono debitori personali di quelle somme. Questo consente di proteggere il patrimonio personale dell’imprenditore, ma comporta al contempo che l’eventuale insolvenza della società resti confinata all’ambito aziendale (senza coinvolgere automaticamente i soci). Fanno eccezione casi particolari: ad esempio se un socio ha rilasciato garanzie personali (fideiussioni) per debiti sociali – evenienza comune con le banche – quel socio sarà comunque tenuto a pagare il creditore garantito in caso di inadempienza della società, nonostante la responsabilità limitata. Un altro caso di deroga è la S.r.l. unipersonale: se l’unico socio non ha versato interamente i conferimenti o ha violato gli obblighi di pubblicità della sua unicità, può decadere dal beneficio della responsabilità limitata e rispondere personalmente dei debiti (art. 2462 c.c.). In generale, però, nella S.r.l. correttamente costituita e gestita, i soci non rischiano i propri beni per le obbligazioni sociali. Nota: la responsabilità limitata non protegge gli amministratori da eventuali profili di responsabilità personale per condotte illecite: ad esempio, l’amministratore che ometta il versamento di IVA o di ritenute previdenziali può incorrere in sanzioni e conseguenze penali a titolo personale, così come l’amministratore/liquidatore che, in fase di scioglimento, paghi alcuni creditori lasciando insolute le imposte potrebbe essere chiamato a risponderne verso l’Erario (si veda ad es. l’art. 2495 c.c. e l’art. 36 D.P.R. 602/1973 sulla responsabilità dei liquidatori per il pagamento delle imposte). Queste sono responsabilità specifiche, diverse dalla responsabilità generale per i debiti contratti dalla società, la quale rimane limitata al patrimonio sociale.
- Società di persone (S.n.c. e S.a.s.) – Nelle società di persone la situazione cambia radicalmente. Prendiamo la Società in nome collettivo (S.n.c.): qui tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti sociali. In pratica, se la Radiatori Oli S.n.c. non paga un fornitore o una banca, questi creditori – dopo aver escusso il patrimonio della società – possono pretendere l’intero pagamento da qualunque socio sul proprio patrimonio personale. Il creditore deve prima agire sulla società e sui suoi beni (beneficio di escussione), ma se il patrimonio sociale è insufficiente, i soci rispondono con i loro beni senza limiti di importo. Ciò significa che l’intero patrimonio personale del socio (es. casa, conto corrente, auto) può essere aggredito dai creditori sociali per soddisfare debiti dell’azienda. Analoga responsabilità illimitata riguarda i soci accomandatari della S.a.s. (Società in accomandita semplice), mentre i soci accomandanti di una S.a.s. rispondono limitatamente al conferimento (similmente ai soci di capitali) a condizione di non ingerirsi nella gestione. La conseguenza pratica per un imprenditore in forma di S.n.c. è che la linea di difesa dal debito non può basarsi sulla separazione patrimoniale (che non c’è): il punto di vista del debitore coincide qui con quello dei soci stessi, i quali dovranno valutare strumenti non solo per l’azienda ma anche per proteggere il proprio patrimonio personale. In caso di grave insolvenza di una S.n.c., il fallimento (o liquidazione giudiziale, secondo la nuova terminologia) colpirà sia la società sia in estensione tutti i soci illimitatamente responsabili (art. 147 R.D. 267/1942, ora sostanzialmente confluito negli artt. 256 e ss. del Codice della crisi): la dichiarazione di fallimento della società comporta automaticamente anche quella dei soci, salvo che siano usciti dalla società da oltre un anno. Pertanto i soci di società di persone, per “difendersi” dai debiti, dovranno spesso ricorrere agli stessi strumenti applicabili alla società (concordato preventivo, accordi, ecc.), tenendo presente che una eventuale procedura concorsuale coinvolgerà il loro patrimonio. Una notazione importante: se in una società di persone i soci hanno garantito personalmente un debito sociale (ad esempio firmando cambiali o fideiussioni), tali garanzie talvolta aggiungono poco rispetto alla responsabilità illimitata che già hanno verso quei debiti (fatta salva l’escussione preventiva del patrimonio sociale). Viceversa, in una S.r.l. un socio/familiare che presti fideiussione per un debito della società non amministrata da lui si espone in modo aggiuntivo rispetto al regime ordinario di limitata responsabilità.
- Ditta individuale / Impresa individuale – La ditta individuale non ha personalità giuridica separata dall’imprenditore: impresa e persona fisica coincidono. Ciò significa che tutti i debiti contratti nell’attività (così come i debiti personali dell’imprenditore) vengono giuridicamente ad essere a carico della medesima persona. Il titolare della ditta individuale risponde con tutto il proprio patrimonio personale dei debiti di impresa (non esiste un “patrimonio sociale” distinto). Per fare un esempio, se Mario Rossi opera come ditta individuale “Radiatori Olio di Mario Rossi” e accumula €100.000 di debiti verso fornitori e Fisco, quei creditori possono aggredire direttamente i beni di Mario Rossi (casa, denaro, ecc.) senza formalità ulteriori, poiché Mario Rossi è il debitore in prima persona. La mancanza di autonomia patrimoniale comporta anche che, tecnicamente, la ditta individuale non è soggetta alle ordinarie procedure concorsuali (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo), a meno che l’imprenditore individuale abbia dimensioni economiche tali da rientrare tra i soggetti “fallibili”. La legge infatti stabilisce delle soglie dimensionali al di sotto delle quali un imprenditore (commerciale) viene considerato piccolo imprenditore e non può essere assoggettato a fallimento. Attualmente, i limiti per la non fallibilità (ereditati dall’art. 1 della vecchia legge fallimentare) sono avere, contemporaneamente: ricavi lordi annui non superiori a €200.000, attivo patrimoniale non oltre €300.000 e debiti totali non oltre €500.000. Se l’imprenditore individuale rimane sotto questi parametri, egli non può essere dichiarato fallito (né può accedere al concordato preventivo); in caso di insolvenza potrà però accedere alle procedure di sovraindebitamento (di cui diremo più avanti), come il concordato minore o la liquidazione controllata. Se invece la ditta individuale supera anche solo una di tali soglie, è considerata fallibile al pari di una società: questo implica che i creditori possono chiederne il fallimento e che l’imprenditore può attivare strumenti come il concordato preventivo, esattamente come una società commerciale. Riassumendo: nella ditta individuale non c’è distinzione tra debiti dell’impresa e debiti personali dell’imprenditore; la difesa dal debito va quindi pianificata sapendo che l’intero patrimonio personale è in gioco, e che gli strumenti di composizione della crisi disponibili dipendono dalla qualifica di piccolo o grande imprenditore.
Di seguito una tabella riepilogativa delle principali differenze legate alla forma giuridica, dal punto di vista della responsabilità per i debiti e delle procedure applicabili:
| Forma giuridica | Responsabilità per i debiti | Soggetto a fallimento? | Strumenti di gestione crisi |
|---|---|---|---|
| S.r.l. (società di capitali) | Limitata al patrimonio sociale (soci non rispondono con beni propri). Eccezioni: garanzie personali prestate dai soci, casi di responsabilità specifica di amministratori. | Sì, se esercita attività commerciale (in pratica tutte le S.r.l. lo sono). Non ci sono soglie di non fallibilità per le società di capitali (anche piccole S.r.l. possono fallire). | Concordato preventivo; Accordi di ristrutturazione; Composizione negoziata; Liquidazione giudiziale (fallimento); Piano attestato di risanamento; (Sovraindebitamento non applicabile perché fallibile). |
| S.n.c. (società di persone) | Illimitata e solidale: i soci rispondono con tutto il loro patrimonio, previa escussione della società. Soci parificati a co-obbligati verso i creditori sociali. | Sì, se attività commerciale e oltre soglie (tipicamente S.n.c. è considerata sempre non piccola, salvo eccezioni). Il fallimento della società si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili. | Concordato preventivo (coinvolge anche i soci); Accordi di ristrutturazione; Composizione negoziata; Liquidazione giudiziale (fallimento) con estensione ai soci; Piano attestato; Procedure di sovraindebitamento solo se esente da fallimento (raro). |
| Ditta individuale | Illimitata: imprenditore e impresa coincidono, tutti i beni personali sono aggredibili dai creditori. | Dipende dalle dimensioni: se supera soglie di cui sopra (attivo >€300k, ricavi >€200k o debiti >€500k) viene considerato soggetto fallibile. Se sotto soglie (piccolo imprenditore) è non fallibile. | Fallibile: Concordato preventivo; Accordi di ristrutturazione; Composizione negoziata; Liquidazione giudiziale, ecc. Non fallibile: Procedure da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, piano del consumatore se persona fisica con debiti personali). Sempre accesso a piano attestato; composizione negoziata (anche se piccola impresa, su base volontaria). |
| S.a.s. (soc. accomandita) | Accomandatari: illimitatamente responsabili (come soci Snc). Accomandanti: responsabilità limitata alla quota conferita (perdono il beneficio se ingeriscono nella gestione). | Sì, se commerciale e oltre soglie (la società fallisce; fallimento esteso solo agli accomandatari illimitatamente responsabili; accomandanti no). | Simile a S.n.c.: concordato preventivo (vincola accomandatari), accordi, composizione negoziata, fallimento, ecc. Accomandanti non coinvolti personalmente salvo garanzie date. |
(Legenda: per “fallimento” qui si intende la liquidazione giudiziale ai sensi del D.lgs. 14/2019; per semplicità utilizzeremo talvolta il termine tradizionale.)
Come si evince, chi opera tramite società di capitali dispone di uno “scudo” patrimoniale (che però non è assoluto: comportamenti illegittimi o garanzie prestate possono perforarlo), mentre chi opera tramite società di persone o ditta individuale è esposto personalmente. Ciò influirà sulle strategie: ad esempio, un imprenditore individuale dovrà considerare anche strumenti per la propria esdebitazione personale, mentre il socio di S.r.l. si focalizzerà sul risanamento della società.
Natura dei debiti: tipologie di creditori e implicazioni
Non tutti i debiti aziendali sono uguali dal punto di vista legale. La natura del credito (fiscale, bancario, commerciale, previdenziale, ecc.) incide sulle facoltà del creditore e sulle possibili difese del debitore. Esaminiamo le categorie più comuni di debiti che una azienda di radiatori olio (o qualsiasi impresa) potrebbe aver accumulato, e vediamo cosa comportano e come gestirli.
Debiti fiscali e tributari
I debiti verso il Fisco includono imposte non pagate (IVA, IRPEF/IRES, IRAP), ritenute fiscali non versate, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, ecc. Questi debiti hanno alcune caratteristiche particolari:
- Privilegi: nello scenario di una procedura concorsuale (fallimento, concordato, liquidazione), i crediti dello Stato per imposte godono di privilegio generale sui beni mobili e immobili (ad esempio l’IVA ha privilegio sui mobili ex art. 2752 c.c.). Ciò significa che, in caso di liquidazione, il Fisco verrà soddisfatto prima dei crediti chirografari (come fornitori non garantiti), e in alcuni casi anche prima delle banche se queste non hanno garanzie reali.
- Agenzia di riscossione: la riscossione dei tributi iscritti a ruolo è affidata all’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER), l’ente pubblico che ha sostituito Equitalia. AER procede tramite la notifica di cartelle esattoriali (o avvisi di addebito per contributi) e ha poteri di esecuzione amministrativa senza dover passare dal giudice (può iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali o personali se il debitore è una persona fisica, disporre il fermo amministrativo dei veicoli, pignorare conti correnti, ecc., il tutto in base alla cartella non pagata che costituisce titolo esecutivo).
- Limiti e procedure: Ci sono regole specifiche sulla riscossione. Ad esempio, per importi sotto €60.000 non può essere iscritta ipoteca sugli immobili prima di aver offerto un piano di rateizzazione; il fermo di beni mobili registrati è preceduto da preavviso. Inoltre, l’Agenzia Riscossione non può iniziare o proseguire azioni esecutive se il debitore ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa o se è in corso una procedura concorsuale che prevede una moratoria.
- Possibilità di dilazione (“rateizzazione”): Uno strumento fondamentale di difesa del debitore fiscale è la rateizzazione dei debiti tributari. Entro certi limiti, l’agente della riscossione concede piani di pagamento dilazionato: attualmente per importi fino a €120.000 è prevista la concessione automatica di rate fino a 84 mesi (7 anni) su semplice richiesta, senza dover fornire prova di difficoltà. Per importi superiori, o per ottenere piani più lunghi (fino a 120 rate mensili, cioè 10 anni), occorre documentare una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica. Queste soglie sono state aggiornate di recente (nel 2023/2024, innalzate rispetto ai vecchi €60.000) per ampliare l’accesso alle dilazioni. Ad esempio, se la Radiatori Oli S.r.l. ha una cartella per €100.000 di IVA non versata, può chiedere un piano in 72–84 rate senza troppi ostacoli; se il debito fosse €300.000, può comunque ottenere un piano (sino a 10 anni) presentando i bilanci e gli indici di liquidità che attestino l’impossibilità di pagare subito. Attenzione: la rateizzazione blocca le azioni esecutive di AER a patto che il debitore sia in regola con i pagamenti delle rate. Se invece si decade dalla rateizzazione (ad esempio saltando alcune rate), l’intero debito residuo diviene immediatamente riscuotibile e l’agente può riprendere pignoramenti, fermi ecc., con aggravio di interessi di mora.
- Rottamazioni e definizioni agevolate: Negli ultimi anni il legislatore ha spesso introdotto misure straordinarie di definizione agevolata dei carichi affidati ad AER (le cosiddette “rottamazioni delle cartelle”). Tali misure (ad es. rottamazione-quater 2023) consentono di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora, oppure in forma ridotta (saldo e stralcio per soggetti in disagio economico) in un certo numero di rate. Queste opportunità, quando aperte, rappresentano un modo per ridurre il debito fiscale complessivo. Al momento (ottobre 2025) non risulta attiva una nuova rottamazione generalizzata oltre a quelle già scadute nel 2023, ma è possibile che in futuro vengano riproposte. Vale la pena per il debitore monitorare la normativa fiscale corrente e valutare, con assistenza professionale, l’adesione a tali sanatorie se disponibili, perché possono alleggerire notevolmente il carico debitorio.
- Transazione fiscale: All’interno di procedure concorsuali negoziate o giudiziali (es. concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata), la legge prevede la possibilità di proporre al Fisco una transazione fiscale, cioè un trattamento dei crediti tributari che comporti dilazioni o anche rinunce parziali (stralcio) di imposta e sanzioni. La transazione fiscale, disciplinata oggi dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi (già art. 182-ter L.F.), permette di includere i debiti tributari in un piano concordatario offrendo il pagamento di una parte delle imposte dovute. È necessaria l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le norme sono state innovate per renderla più efficace: il Decreto Legge 125/2020 e poi la Legge 159/2020 hanno introdotto il cosiddetto cram-down fiscale, ora recepito a regime, che consente al tribunale di omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche senza il voto favorevole dell’Erario, purché la proposta del debitore assicuri allo Stato almeno quello che otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare. Il terzo correttivo 2024 ha ulteriormente chiarito limiti e meccanismi della transazione fiscale e contributiva, consolidando il principio che il tribunale può superare l’eventuale dissenso del Fisco se il piano è conveniente per quest’ultimo. Dunque, dal punto di vista del debitore, oggi è più concretamente possibile tagliare o dilazionare il debito fiscale all’interno di una procedura di risanamento, ottenendo un sollievo che in passato era di fatto rimesso alla totale discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria.
- Conseguenze del debito fiscale: se l’azienda non paga le imposte, oltre alle azioni esecutive di riscossione coattiva sopra descritte, vanno considerate possibili conseguenze collaterali: (a) dal punto di vista amministrativo, l’irregolarità fiscale e contributiva porta al rilascio di un DURC negativo (Documento Unico Regolarità Contributiva), che impedisce all’azienda di partecipare ad appalti pubblici e talvolta anche di ottenere certi bonus o agevolazioni; (b) dal punto di vista penale, l’omesso versamento di IVA superiore a una certa soglia (€250.000 annui) o di ritenute oltre soglia (€150.000) è reato (punito col carcere, D.lgs. 74/2000). In tali casi, difendersi significa attuare tempestivamente strategie per ridurre il debito sotto soglia (es. tramite rateazione: il versamento anche parziale prima della scadenza delle rate può evitare la punibilità) o ricorrere agli strumenti concorsuali prima che maturino gli estremi del reato. Un caso concreto: la nostra Radiatori Oli S.r.l. ha €300.000 di IVA non versata nell’anno fiscale; prima della scadenza del termine di versamento, potrebbe attivarsi per dilazionare o includere quel debito in un concordato preventivo. Se riesce a ottenere un provvedimento di ammissione, le procedure penali per omesso versamento possono essere sospese o evitate se il debito viene poi soddisfatto almeno nel minimo concordatario.
In sintesi sui debiti fiscali: il debitore deve considerarli “sensibili”, perché il Fisco ha armi affilate (privilegi, riscossione esattoriale, influenza penale) ma al contempo la legge offre strumenti specifici (rateazioni molto lunghe, transazioni fiscali nei piani di risanamento) per gestirli. Ignorare il debito fiscale è estremamente pericoloso; affrontarlo attivamente, invece, può portare anche a soluzioni di compromesso col fisco (pagamento parziale dilazionato) salvando l’azienda. Più avanti vedremo come questi debiti vengono trattati nelle diverse procedure (ad esempio, in composizione negoziata è ora possibile coinvolgere l’Erario in accordi transattivi grazie alle modifiche del 2024).
Debiti verso banche e istituti di credito
Molte aziende indebitate presentano esposizioni bancarie, tipicamente sotto forma di mutui, finanziamenti a medio termine, anticipazioni di credito (fidi di conto corrente), leasing finanziari, ecc. Le caratteristiche salienti di questi debiti sono:
- Garanzie: la prassi è che i finanziamenti bancari siano assistiti da garanzie reali (es. ipoteche su immobili aziendali, pegno su macchinari, su magazzino o su beni mobili registrati) oppure da garanzie personali (fideiussioni di soci, di società collegate, o dal Fondo Centrale di Garanzia dello Stato per le PMI). Questo implica che la banca, in caso di inadempimento, può far valere la garanzia: es. escutere la fideiussione (colpendo il patrimonio del garante, spesso il titolare dell’azienda o i suoi familiari) o avviare esecuzione forzata sul bene ipotecato/pegno. Un creditore ipotecario ha un forte privilegio: potrà soddisfarsi con precedenza sul ricavato dell’immobile ipotecato in caso di vendita forzata o di liquidazione concorsuale.
- Decadenza dal beneficio del termine e rientro: se l’impresa è in difficoltà e salta una o più rate del mutuo, la banca di norma invoca la decadenza dal termine, chiedendo immediatamente il pagamento dell’intero importo residuo del finanziamento. Lo stesso accade per gli scoperti di conto: la banca può revocare gli affidamenti (fidi) e pretendere il rientro immediato delle somme utilizzate. Questa dinamica è spesso micidiale perché l’azienda già in crisi si trova richieste di pagamento integrale di importi ingenti, che non può onorare. Cosa fare? Difendersi da queste situazioni significa, in prima battuta, negoziare con la banca per ottenere una moratoria o una ristrutturazione del debito. A volte istituti e imprese trovano accordi di riscadenzamento (ad esempio sospensione di 6-12 mesi delle quote capitale delle rate, o consolidamento delle esposizioni di conto corrente in un finanziamento a medio termine). È bene ricordare che esistono anche normative di sostegno: negli ultimi anni diverse moratorie legislative o pattizie (accordi ABI) hanno permesso alle PMI di sospendere temporaneamente i pagamenti dei mutui, specie in periodi di crisi generalizzata (come l’era Covid). Al 2025 non sono attive moratorie generalizzate, ma vale la pena per il debitore verificare eventuali bandi di ristrutturazione assistita (es. tramite MCC, Mediocredito Centrale).
- Iniziative legali della banca: la banca può agire giudizialmente presentando un ricorso per decreto ingiuntivo per il credito dovuto, e dopo 40 giorni (in assenza di opposizione o se l’opposizione viene rigettata) procedere con pignoramenti. In alternativa, se c’è ipoteca, può attivare direttamente un’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato; se c’è pegno su macchinari, può chiedere al giudice di vendere quei beni. Inoltre, se il credito supera certe soglie, la banca può presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) contro l’impresa debitrice insolvente.
- Priorità e trattamenti in concorsuale: in caso di procedura concorsuale dell’azienda, i crediti bancari chirografari (non garantiti) concorreranno alla pari con altri chirografari (fornitori, ecc.), mentre i crediti ipotecari/pegno sono privilegiati fino a concorrenza del valore del bene (sono considerati crediti preferenziali). Ciò significa che, ad esempio, se la Radiatori Oli ha un mutuo garantito da ipoteca su un capannone, la banca ipotecaria è prelazionaria: avrà diritto a essere soddisfatta sul ricavato della vendita del capannone prima degli altri. Se però dalla vendita non si ricava abbastanza da coprire tutto il debito, la parte scoperta del credito diventa chirografaria (come credito residuo non garantito).
- Strumenti di ristrutturazione: un imprenditore indebitato con le banche può utilizzare vari strumenti per ristrutturare tali debiti. Fuori dalle procedure concorsuali vere e proprie, c’è il piano attestato di risanamento (ex art. 56 CCII, già art. 67 L.F.) in cui la banca può accordare nuove condizioni (ad esempio rinuncia a parte del credito, conversione di debito in capitale, allungamento dei termini) nell’ambito di un piano che un professionista indipendente attesta come idoneo a risanare l’impresa – come vantaggio, tali accordi se attuati in conformità al piano godono di esenzione da revocatoria fallimentare. Dentro procedure concorsuali, le banche partecipano come creditori: si possono prevedere classi dedicate (ad esempio una classe di banche distinta dai fornitori, data la diversa posizione). Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII, ex art. 182-bis L.F.) spesso il 60-75% dei creditori finanziari aderisce e l’accordo viene esteso ai dissenzienti della stessa categoria (cram down omogeneo previsto dalla normativa); questo strumento è stato affinato recependo la Direttiva UE 2019/1023, introducendo ad esempio gli accordi ad efficacia estesa per i creditori finanziari. In un concordato preventivo o concordato minore, i crediti bancari ipotecari devono essere soddisfatti almeno per il valore di stima del bene dato in garanzia (salvo diverse pattuizioni); i crediti chirografari delle banche possono essere falcidiati in percentuale come gli altri. Da notare che dal 2021 è esplicitamente ammessa la moratoria annuale per i creditori privilegiati nel concordato in continuità (art. 86 CCII, ex art. 182-quinquies L.F.), quindi è possibile proporre di iniziare a pagare le banche ipotecarie fino a 12 mesi dopo l’omologazione, per favorire la cassa aziendale immediata.
- Garanti e coobbligati: Un aspetto delicato riguarda i garanti personali del debito bancario (tipicamente soci o amministratori che abbiano firmato fideiussioni). Il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione non vincola i terzi garanti, a meno che questi siano essi stessi parte della procedura. Ciò significa che se Radiatori Oli S.r.l. va in concordato e prevede di pagare alle banche il 40% del dovuto, il piano non impedisce alla banca di escutere il restante 60% direttamente dal fideiussore (es. il socio che aveva garantito) – salvo il caso particolare di soci illimitatamente responsabili, come visto, in cui la procedura coinvolge automaticamente anche loro e quindi li “protegge” dai creditori sociali (art. 184 L.F. prevedeva l’estinzione delle fideiussioni dei soci illimitatamente responsabili a seguito del concordato, principio confermato anche nella normativa attuale per analogia). Dal punto di vista del debitore-garante, quindi, fare un concordato della società non risolve il suo obbligo personale: dovrà eventualmente attivare una procedura personale (es. sovraindebitamento) o cercare un accordo extra per liberarsi dalla garanzia. Alcuni concordati includono clausole per cui il soddisfacimento del credito sociale libera i garanti (ma serve il consenso espresso del creditore in sede di voto). In sede negoziale, un imprenditore può cercare di ottenere dalla banca, contestualmente alla ristrutturazione del debito principale, anche la liberazione o attenuazione delle garanzie prestate (ma è una concessione volontaria della banca).
In sintesi per debiti bancari: il debitore dovrà valutare se vi sono margini per rinegoziare privatamente con gli istituti (molto dipende dalla fiducia che la banca ripone in un recupero aziendale e dalle eventuali garanzie disponibili), altrimenti considerare l’accesso a strumenti concorsuali che gli diano respiro (nel concordato ad esempio scatta un blocco delle azioni esecutive durante la procedura, impedendo alle banche di agire individualmente). È fondamentale non attendere la revoca dei fidi o l’insolvenza conclamata: coinvolgere le banche in un dialogo preventivo – magari tramite la composizione negoziata con l’ausilio di un esperto indipendente – può evitare reazioni aggressive e portare a soluzioni concordate (come riduzione dei tassi, allungamento dei piani di ammortamento, concessione di nuova finanza protetta da privilegio ex art. 99 CCII, ecc.). Nel prosieguo, vedremo come strumenti come l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata sono pensati proprio per facilitare l’intesa con i creditori finanziari, spesso decisivi per superare la crisi.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
La categoria residuale ma frequentemente rilevante è quella dei debiti commerciali verso fornitori, subfornitori, consulenti e altri creditori non garantiti. Caratteristiche:
- Crediti chirografari: i fornitori (così come eventuali professionisti, affittuari dell’immobile sede dell’azienda, ecc.) di regola non hanno garanzie reali né privilegi (a meno che non si tratti di crediti particolari come quello del venditore per riserva di proprietà, o del locatore per canoni, che godono di alcuni privilegi limitati). Sono quindi creditori chirografari, il che in gergo fallimentare significa “ultimi in fila” in un’eventuale liquidazione: in media, in caso di fallimento, recuperano poco o nulla poiché prima vengono soddisfatti creditori con privilegio o garanzia.
- Azioni legali individuali: il singolo fornitore ha come arma la causa civile (ingiunzione di pagamento) e successiva esecuzione forzata. Diversamente dal fisco, deve passare dal giudice per ottenere un titolo esecutivo (a meno di fattispecie come assegni protestati). Spesso, per importi modesti, molti fornitori esitano ad affrontare le spese legali; tuttavia se il credito è consistente o se intravedono il rischio concreto di insolvenza, anche un fornitore può depositare un’istanza di fallimento. In passato, la legge richiedeva un importo minimo di €30.000 di debito scaduto per accogliere un’istanza di fallimento; il Codice della crisi ha eliminato una soglia fissa, lasciando al giudice valutare la rilevanza dello stato di insolvenza. Dunque anche un gruppo di piccoli fornitori potrebbe provocare l’apertura della liquidazione giudiziale se dimostrano che l’impresa non paga i debiti in modo generalizzato.
- Negoziazione: dal punto di vista dell’azienda debitrice, i fornitori sono spesso i creditori con cui è più facile negoziare spontaneamente: un fornitore commerciale può avere interesse a mantenere in vita il rapporto di fornitura, quindi potrebbe accettare dilazioni, piani di rientro o addirittura stralci del credito (ad esempio rinunciare al 20% del dovuto se ciò aumenta le chance di ottenere il restante 80% e di conservare il cliente). Queste intese possono essere raggiunte in via privata, magari con l’aiuto di consulenti o, in maniera più strutturata, nell’ambito di una composizione negoziata o di un accordo di ristrutturazione. È importante formalizzare bene eventuali accordi transattivi (ad esempio scrivere che il creditore rinuncia a procedere legalmente in cambio del piano di pagamento concordato, e prevedere cosa succede in caso di inadempimento del piano).
- Fornitori strategici: Alcuni fornitori possono avere un ruolo strategico per l’impresa (es: il fornitore di materie prime essenziali, o il distributore monopolista di un componente), quindi il debitore deve gestire con attenzione quel rapporto. Il Codice della crisi prevede strumenti per tutelare la continuità operativa: ad esempio l’art. 99 CCII consente di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare fornitori essenziali anche prima del concordato, per evitare l’interruzione di servizi vitali (pagamenti in prededuzione). Inoltre, durante la composizione negoziata, è stato previsto il divieto per i contratti pendenti essenziali di essere risolti dal fornitore per il solo fatto dei mancati pagamenti pregressi, se l’impresa accede alle misure protettive (art. 18 CCII). Questo protegge l’azienda dal cosiddetto “effetto domino” in cui i fornitori sospendono le forniture aggravando la crisi.
- Trattamento concorsuale: in un concordato o nel fallimento, i fornitori (chirografari) avranno un soddisfo in percentuale del loro credito, dipendente dalle disponibilità. Il Codice della crisi impone per il concordato preventivo liquidatorio un soddisfacimento minimo del 20% dei chirografari (salvo apporti esterni che possano ridurre tale soglia), mentre per il concordato in continuità non c’è una percentuale minima prefissata, ma occorre dimostrare che i creditori ricevono almeno quanto otterrebbero da una liquidazione e comunque che il piano è fattibile. Nel concordato minore (per sovraindebitati) similmente è richiesto il 20% minimo ai chirografari se si liquida il patrimonio, percentuale riducibile a 10% se approvato dai creditori (art. 74 CCII, come modificato dal correttivo 2024) . In pratica quindi, in sede di concordato, i fornitori possono aspettarsi di subire un taglio del credito variabile (spesso significativo, es. pagamenti del 30% in 5 anni, etc.), ma concordato significa anche che essi – se la maggioranza approva – sono obbligati al trattamento proposto e non possono agire individualmente, il che per il debitore è un vantaggio in quanto “ingabbia” le pretese e le diluisce.
- Strumenti di tutela del fornitore: invertendo la prospettiva (giusto per capire possibili mosse dei creditori), ricordiamo che un fornitore non pagato può chiedere misure conservative come il sequestro giudiziario di beni del debitore se teme di perdere le garanzie del credito, oppure – se ci sono presupposti – può agire con azione revocatoria per rendere inefficaci atti del debitore che hanno diminuito la garanzia patrimoniale (ad es. se l’impresa ha ceduto beni a terzi prima di fallire, i creditori possono farli revocare in fallo). Tuttavia, nel nostro scenario dove l’imprenditore vuole difendersi e risanare, l’obiettivo sarà semmai prevenire queste azioni con strumenti generali (ad es. ottenendo le misure protettive in composizione negoziata che sospendono i sequestri e le ipoteche giudiziali).
- Debiti verso professionisti e consulenti: Assimilabili ai fornitori come chirografari, ma con una particolarità: alcuni crediti professionali (es. avvocati per spese di giustizia) possono godere di privilegio. In genere gli onorari no, e vengono trattati come chirografari. Dal punto di vista umano, molti consulenti continuano a lavorare per l’azienda anche se pagati a fatica, in vista di un eventuale risanamento: è importante, per difendersi, mantenere un dialogo franco con questi creditori e magari inserirli anch’essi tra quelli “essenziali” da soddisfare appena possibile, perché sono proprio coloro che aiutano l’imprenditore a venire fuori dalla crisi (si pensi al commercialista che prepara il piano, all’avvocato che lo assiste nelle trattative…).
In sintesi sui debiti commerciali: il debitore ha un maggior margine di manovra negoziale informale con essi, rispetto a quanto avviene con il Fisco o con le banche. Spesso conviene contattare i principali fornitori creditori, spiegare la situazione e proporre soluzioni graduali (pagamenti parziali, magari offrendo in garanzia effetti cambiari o altro per rassicurare). È fondamentale però evitare di accordarsi con uno penalizzando troppo un altro: occorre muoversi sapendo che eventuali accordi preferenziali potrebbero essere sindacati in sede fallimentare (pagare un fornitore e non altri a ridosso dell’insolvenza potrebbe configurare una preferenza potenzialmente revocabile se la crisi degenera in fallimento entro 6 mesi). Questo non vuol dire che non si possano pagare fornitori strategici, ma è bene farlo all’interno di una strategia generale, magari con il “paracadute” di un piano attestato (che esenta da revocatoria i pagamenti eseguiti in adempimento del piano) o di una composizione negoziata. Nel contesto di una procedura concorsuale, il debitore dovrà prepararsi a proporre ai fornitori un sacrificio (che è quasi inevitabile) bilanciato e motivato: fornire proiezioni su quanto otterrebbero in caso di fallimento (di solito zero o pochi centesimi) li aiuta a capire che accettare un concordato con pagamento parziale è nel loro interesse.
Debiti verso i dipendenti e gli enti previdenziali (INPS)
Un’azienda con dipendenti può accumulare debiti da lavoro: stipendi arretrati, TFR non versato, contributi previdenziali dovuti all’INPS (o a Casse professionali) e premi assicurativi INAIL. Questi debiti presentano particolarità:
- Crediti privilegiati: I crediti dei lavoratori per retribuzioni degli ultimi mesi e per TFR godono di privilegio generale di primo grado (ex art. 2751-bis c.c.) nelle procedure concorsuali: vengono soddisfatti subito dopo le spese di giustizia, al pari – anzi prima – di molti crediti fiscali. Inoltre, i crediti per contributi INPS hanno privilegio generale e in parte anche privilegi speciali (ad es. contributi da lavoro subordinato stessi beni del privilegio lavorativo). Ciò significa che in un fallimento o concordato liquidatorio, i dipendenti sono tra i primi a essere pagati con le somme ricavate, e l’INPS pure beneficia di prelazione.
- Fondo di Garanzia INPS: I lavoratori dipendenti hanno la tutela del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, che interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro per pagare il TFR e le ultime mensilità di retribuzione (fino a un massimo di 3 mensilità) ai lavoratori rimasti insoddisfatti. Il Fondo interviene di solito dopo che sia stata aperta una procedura concorsuale (fallimento o anche concordato liquidatorio) o, in caso di semplice cessazione azienda non fallibile, dopo una infruttuosa esecuzione. Dopo aver pagato, il Fondo si surroga nelle posizioni dei lavoratori come creditore privilegiato nella procedura. Dal punto di vista dell’imprenditore, ciò significa che i lavoratori trovano comunque soddisfazione e potrebbero avere minore conflittualità una volta attivato il Fondo; però l’INPS subentrante potrebbe poi perseguire il datore (in sede concorsuale o eventualmente anche personale se ne ricorrono i presupposti).
- Debiti contributivi INPS: Sono assimilabili ai debiti fiscali come tipologia: l’INPS (tramite AER per i contributi in gestione separata ruolo, o direttamente per crediti contributivi) può emettere avvisi di addebito, iscrivere ipoteche, avviare pignoramenti. Ci sono soglie oltre cui l’INPS deve segnalare la situazione di indebitamento contributivo (anche questo rientra nel sistema di allerta anticipata previsto dal Codice della crisi: ad esempio debiti INPS superiori a €50.000 per alcune durate, etc., generano obbligo di comunicazione al debitore perché corra ai ripari). I debiti contributivi possono essere oggetto di transazione nelle procedure di concordato/accordi, insieme ai debiti fiscali (si parla appunto di transazione fiscale e contributiva).
- Impatti penali: L’omesso versamento di ritenute previdenziali (trattenute sulle buste paga dei dipendenti e non versate all’INPS) oltre la soglia di €10.000 annui costituisce reato (art. 2 D.lgs. 8/2016 ha depenalizzato sotto 10k trasformando in sanzione amministrativa, sopra rimane reato). Quindi, un’azienda che non versa i contributi dei dipendenti per cifre rilevanti espone l’amministratore a responsabilità penale. Per difendersi, è fondamentale attuare piani di rientro con l’INPS o includere i contributi in una transazione, oppure versare almeno parzialmente entro termini di legge per non incorrere nella soglia di punibilità.
- Gestione dei dipendenti in crisi: Se l’azienda è in difficoltà temporanea, può ricorrere a ammortizzatori sociali (es. Cassa Integrazione Guadagni) per ridurre il costo del lavoro, evitando di accumulare mensilità non pagate. È meglio cercare di evitare di far lavorare i dipendenti senza pagarli, sia per ragioni etiche sia perché poi il debito cresce (il TFR continua a maturare, i contributi pure) e i lavoratori potrebbero agire giudizialmente (un decreto ingiuntivo per salari è esecutivo quasi immediatamente). Nei concordati preventivi in continuità spesso si prevede il pagamento integrale di questi crediti (essendo privilegiati, vanno soddisfatti almeno al 100% salvo diverse classi e consenso se in eccedenza rispetto a valore beni).
- Licenziamenti e costi: Se l’azienda deve ridurre personale, attenzione che eventuali indennità di fine rapporto e indennizzi vari possono creare ulteriori crediti privilegiati. Tuttavia, alleggerire la struttura dei costi può essere indispensabile per il risanamento. Gli eventuali costi dei licenziamenti collettivi (NASpI, ticket licenziamento da versare all’INPS) diventano anch’essi debiti contributivi se non pagati.
Sintesi debiti lavoro/INPS: dal punto di vista del debitore, questi sono crediti “sensibili” sia legalmente che socialmente. È difficile “stralciare” il dovuto ai lavoratori: in qualsiasi piano, gli stipendi e TFR maturati vanno pagati integralmente o quasi (in concordato si tende a pagare i privilegiati per intero, eventualmente solo la parte eccedente il privilegio – ad esempio la parte di TFR maturato oltre il limite garantito dal Fondo – può subire decurtazioni). I contributi possono essere trattati come gli altri crediti erariali, quindi potenzialmente ridotti in sede di transazione contributiva, ma l’INPS ha storicamente avuto un atteggiamento rigido simile all’Erario (oggi, col cram-down contributivo previsto, il tribunale può comunque omologare anche senza il loro consenso). Difendersi su questo fronte vuol dire: cercare di non accumulare troppi arretrati (usare ammortizzatori, riduzioni del personale se inevitabili, ecc.), tutelarsi penalmente versando almeno le ritenute entro i limiti di legge, e in caso di procedura concorsuale, prevedere il pagamento dei lavoratori tra le priorità. Anche perché, a livello pratico, una forza lavoro non pagata difficilmente sosterrà un piano di risanamento: conflitti sindacali, dimissioni in massa di operai qualificati, possono “affondare” l’impresa più dei debiti finanziari. Quindi nell’affrontare la crisi l’imprenditore deve curare molto la gestione delle risorse umane: comunicare, spiegare eventuali ritardi, magari coinvolgere i dipendenti in sforzi condivisi (es. riduzioni orarie temporanee) se vede prospettiva di salvezza.
Altre tipologie di debiti
Potrebbero esserci ulteriori tipologie, come:
- Debiti verso soci o parti correlate: ad esempio finanziamenti soci non restituiti. Questi in insolvenza sono postergati (i soci vengono dopo tutti gli altri creditori, ex art. 2467 c.c. per S.r.l.), quindi di fatto non hanno tutele particolari e spesso vengono sacrificati integralmente nei piani.
- Debiti verso il fisco locale (es. IMU, TARI): sono anch’essi crediti privilegiati (Comuni) e vengono riscossi a volte tramite ingiunzione fiscale comunale. Da gestire analogamente agli altri fiscali (possibile includerli in transazioni, etc.).
- Sanzioni amministrative: es. multe, sanzioni da enti. In fallimento sono chirografarie subordinate (vengono soddisfatte solo dopo i chirografari comuni). In concordato spesso non vengono pagate integralmente. Nulla vieta comunque di trattarle con l’ente per riduzioni.
- Debiti da sentenze o risarcimenti: se l’azienda ha cause civili perse con condanne al risarcimento, questi crediti seguono la natura (di solito chirografari se non inerenti lavoro). Se sono risarcimenti di danni da fatto illecito, in fallimento hanno collocazione chirografaria ma con interessi anche post-concorsuali fino al riparto (non subordinati come le sanzioni). Poco cambia per la strategia: vanno considerati tra i creditori concorrenti, potenzialmente negoziabili (il creditore può accettare una transazione).
- Debiti verso fornitori di energia o affini: talvolta considerabili “fornitori strategici” (luce, gas indispensabili). Si può chiedere che non interrompano forniture e di spalmare gli arretrati nelle future bollette. La legge 3/2012 già prevedeva qualcosa a tutela della continuità di forniture essenziali in procedure di sovraindebitamento; anche il CCII ha norme simili (nessuna sospensione di forniture essenziali ai sensi dell’art. 55 per il concordato, in composizione negoziata misure protettive come detto).
- Debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione per cartelle diverse da tributi, ad esempio cartelle per multe stradali o per contributi previdenziali Cassa Geometri ecc.: queste seguono le regole generali di AER (quindi possibilità di rateazione, misure cautelari analoghe).
Doveri dell’imprenditore in crisi e rischi dell’inerzia
Prima di passare agli strumenti di soluzione, è cruciale capire che la legge impone all’imprenditore (specie se societario) alcuni doveri di attivazione quando l’azienda è in crisi. Il legislatore, con la riforma sfociata nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, in vigore dal 2022), ha voluto responsabilizzare gli amministratori affinché affrontino tempestivamente la crisi, invece di aggravare i debiti sperando in improbabili miglioramenti.
Adeguati assetti e obbligo di emergenza della crisi
L’art. 2086 c.c., comma 2 (introdotto dal D.lgs. 14/2019), recita che l’imprenditore collettivo (società) «ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale». Questo significa che una S.r.l. o S.p.A. deve dotarsi di strumenti interni (contabilità aggiornata, sistemi di controllo di gestione, indicatori di liquidità) tali da cogliere i segnali di crisi per tempo. Non solo: gli amministratori, una volta individuati segnali di squilibrio, devono attivarsi per prendere le iniziative appropriate (ad esempio rinegoziare i debiti, cercare nuovi finanziamenti, oppure attivare le procedure di allerta o composizione negoziata). La mancata istituzione di assetti adeguati e la mancata reazione alla crisi può configurare una responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori. Infatti, se poi l’impresa fallisce, il curatore potrà avviare un’azione di responsabilità per malagestio: l’inerzia colpevole che ha aggravato il dissesto può comportare che gli amministratori siano condannati a risarcire i danni (tipicamente il deficit fallimentare incrementale).
In termini pratici, questo obbligo si traduce in misure come: tenere d’occhio indicatori finanziari (indici di liquidità, DSCR – debt service coverage ratio – per capire se si riuscirà a pagare i debiti a 6-12 mesi, ecc.), predisporre piani di tesoreria, e se emergono segnali come patrimonio netto azzerato o negativo, incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni, etc., non rimanere passivi. La normativa ha introdotto anche strumenti di allerta esterna: per esempio, gli organi di controllo interni (collegio sindacale o revisore), se esistenti, devono segnalare agli amministratori gli indizi di crisi e, se questi non reagiscono, possono informare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI, per il sistema di allerta). Questo sistema di allerta è entrato in vigore nel 2022-2023 con alcune modifiche: il terzo correttivo 2024 ha implementato le “segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi”. In particolare, oggi alcuni creditori pubblici qualificati – Agenzia Entrate, INPS, Agenzia Riscossione – devono comunicare all’imprenditore (e all’eventuale organo di controllo) il superamento di soglie rilevanti di debito scaduto (es. debiti fiscali oltre €100.000 per ditte individuali, €200.000 per società di persone, €500.000 per s.r.l.). Ricevuta questa segnalazione, l’imprenditore ha l’obbligo di rispondere entro 90 giorni, avviando la composizione negoziata o altra misura di regolazione della crisi, pena la possibilità che tali creditori notifichino l’allerta all’OCRI (istituito presso le Camere di Commercio). Questo meccanismo di allerta serve a impedire l’aggravarsi delle crisi: se il debito fiscale è alto, meglio affrontarlo subito con una procedura, piuttosto che lasciarlo crescere con sanzioni e interessi.
Dal punto di vista del debitore, questi obblighi significano che l’inerzia non è più un’opzione priva di conseguenze: aspettare che i creditori facciano la prima mossa può esporre l’amministratore a sanzioni (ad esempio sanzioni interdittive post-fallimento per gestione imprudente) e responsabilità risarcitorie. Invece, la legge premia chi agisce per tempo: ad esempio, se un amministratore attiva la composizione negoziata appena vede la crisi, potrà documentare di aver agito con diligenza e questo potrà proteggerlo da accuse future di aver aggravato il dissesto. Persino in ambito penale, la tempestività può fare la differenza: la Cassazione penale ha affermato che anche il mero aggravamento del dissesto di una società poi fallita, causato dalla prosecuzione dell’attività nonostante la situazione compromessa, può integrare gli estremi della bancarotta semplice o impropria (art. 217 e 224 L.F.) . Ciò vuol dire che l’amministratore che testardamente va avanti accumulando perdite ulteriori rischia sanzioni penali per bancarotta semplice da irragionevole perseveranza. All’opposto, se egli prende atto della situazione e adotta gli strumenti offerti dalla legge per gestire la crisi, difficilmente potrà essergli imputata una condotta colposa.
Responsabilità civili e penali degli amministratori e dei soci
Approfondiamo brevemente le possibili responsabilità che l’imprenditore (amministratore o socio) può subire se la gestione del debito non è corretta:
- Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.): se il patrimonio della società risulta insufficiente a soddisfare i creditori (insufficienza attiva), i creditori possono (tramite il curatore fallimentare, o anche singolarmente se non c’è fallimento ma insolvenza conclamata) fare causa agli amministratori sostenendo che il danno deriva dalla violazione dei doveri di conservazione del patrimonio. Tipico caso: amministratori che hanno continuato ad accumulare debiti quando la società era già sottocapitalizzata o in perdita grave, erodendo attivo a discapito dei creditori. Questa azione di responsabilità tende a imputare agli amministratori l’aggravamento del passivo. Cassazione e giurisprudenza recenti sono concordi: non occorre provare una condotta dolosa, basta anche la colpa grave nel non aver attivato strumenti di salvataggio o liquidazione tempestivi. Quindi, per ridurre il rischio, il manager deve poter dimostrare di aver fatto il possibile (es. aver tentato un concordato, aver messo in liquidazione volontaria la società appena capito che non c’erano prospettive, ecc.).
- Responsabilità per pagamenti preferenziali o postergazione: i soci o parti correlate che ricevono pagamenti a scapito di altri creditori in fase di insolvenza possono dover restituire le somme (es. revocatoria fallimentare di rimborsi di finanziamenti soci eseguiti nell’anno anteriore). I soci finanziatori inoltre, come accennato, per legge sono postergati: se si sono fatti rimborsare prestiti in tempi di crisi, devono restituire le somme alla massa (art. 2467 c.c.). Un avvocato che assiste l’azienda insolvente deve quindi consigliare di evitare atti di questo genere o di farli rientrare in un quadro legale (un pagamento autorizzato in concordato non è revocabile, ad esempio).
- Reati fallimentari: in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) della società, gli amministratori e in alcuni casi i soci possono essere imputati per bancarotta, che può essere fraudolenta (se hanno distratto beni, falsificato scritture, sottratto attivo, favorito taluni creditori occultando altri, ecc.) o semplice (se per imperizia o negligenza hanno aggravato il dissesto, come nel caso della prosecuzione abusiva dell’attività sopra menzionato). Se l’impresa tenta un risanamento trasparente e lo documenta, difficilmente scatteranno ipotesi di bancarotta fraudolenta; se invece l’imprenditore dissipa risorse o le trasferisce a parenti, o nasconde contabilità, ciò configura reati seri. Inoltre, i già citati reati tributari (omesso versamento) e societari (false comunicazioni sociali se si falsificano bilanci per mascherare debiti) possono derivare dalla gestione della crisi. Quindi, difendersi dai debiti significa anche non sconfinare nell’illegalità nel tentativo di tamponare: ad esempio, mai pensare di salvarsi vendendo sottoprezzo macchinari a un’impresa amica lasciando i creditori all’asciutto, perché quella è distrazione di beni punibile come bancarotta fraudolenta patrimoniale. Invece, seguire i canali predisposti (come la composizione negoziata, il concordato) consente di vendere asset eventualmente, ma con trasparenza e autorizzazioni, evitando di incorrere in tali reati.
- Responsabilità del liquidatore per il pagamento dei debiti tributari: segnaliamo uno specifico obbligo, spesso ignorato: se la società viene messa in liquidazione volontaria, il liquidatore è tenuto a pagare prima i crediti privilegiati, tra cui i tributi. L’art. 2495 c.c. e il D.Lgs. 175/2014 prevedono che, dopo la cancellazione della società, se risultano debiti tributari non soddisfatti e il liquidatore ha ripartito attivo ai soci senza pagare il Fisco, l’Erario può rivalersi personalmente sul liquidatore fino a concorrenza delle somme distribuite ai soci. Ciò per dire: anche sciogliere la società senza un’adeguata pianificazione non mette al sicuro l’organo amministrativo. Bisogna liquidare seguendo la legge, altrimenti alcuni debiti (fisco, lavoro) “inseguiranno” il liquidatore o i soci.
In definitiva, il punto di vista del debitore deve cambiare dall’idea “non pago nessuno e vediamo che succede” (strategia suicida) all’idea “utilizzo gli strumenti legali per gestire chi pagare, quando e quanto, in modo da minimizzare la mia esposizione a responsabilità”. La legge italiana oggi, specie dopo la riforma, incoraggia fortemente il debitore a prendere l’iniziativa. Come vedremo subito, esistono vari strumenti – sia negoziali stragiudiziali sia giudiziali – per affrontare i debiti. La scelta dipende dalla gravità della situazione e dalla risolvibilità della crisi.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo questi strumenti di risanamento o composizione della crisi: la composizione negoziata, il piano attestato, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo, nonché le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata) per chi non può accedere alle soluzioni ordinarie. Per ciascuno vedremo come funzionano, quando convengono, e come possono aiutare il debitore a “difendersi” (sospendendo le azioni dei creditori, riducendo l’ammontare dei debiti, ecc.).
Strumenti di gestione e soluzione della crisi d’impresa
Di fronte a una situazione di indebitamento grave, l’imprenditore ha a disposizione diverse procedure o strumenti legali con cui può ristrutturare i debiti, ottenere protezione dai creditori e tentare il risanamento dell’azienda (o, se il risanamento non è possibile, almeno liquidare il patrimonio in modo ordinato limitando le conseguenze personali). Tali strumenti si differenziano per natura (stragiudiziale o giudiziale), per requisiti di accesso e per effetti. È fondamentale scegliere quello più appropriato al caso concreto. Di seguito presentiamo i principali, con un occhio di riguardo alle novità normative fino al 2025.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è uno strumento nuovo, introdotto con il D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora disciplinato negli artt. 12-25-quinquies del Codice della crisi. Si tratta di una procedura volontaria e riservata attraverso la quale l’imprenditore in condizioni di squilibrio o crisi può tentare di raggiungere un accordo con i creditori, con l’ausilio di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. Vediamone i punti salienti dal punto di vista del debitore:
- Presupposti: Può accedere alla composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione (quindi anche PMI sotto soglia, che non potevano accedere al concordato). Occorre trovarsi in uno stato di crisi o pre-crisi (squilibrio patrimoniale o economico-finanziario) reversibile, cioè tale che esistano prospettive di risanamento. Non serve essere formalmente insolventi – anzi se si è già insolventi conclamati forse è tardi, ma la norma consente comunque l’accesso se c’è possibilità di risanamento. È un procedimento volontario avviato dall’imprenditore (nessuno glielo può imporre).
- Nomina dell’esperto: L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) e fornisce informazioni su azienda, debiti, tentativi di risanamento, un piano che intende proporre, ecc. Una commissione nomina un esperto negoziatore, scelto tra professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti di rilevata esperienza in ristrutturazioni) iscritti in un apposito albo. L’esperto è terzo, imparziale e indipendente.
- Procedura informale: La composizione negoziata non è pubblica (non c’è automatica iscrizione al registro imprese, salvo che l’imprenditore chieda misure protettive o altre autorizzazioni). L’obiettivo è creare un tavolo negoziale tra l’imprenditore e i creditori principali, facilitato dall’esperto, per giungere a una soluzione concordata: che può essere un accordo stragiudiziale semplice, un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato preventivo (in continuità o anche liquidatorio semplificato) o altre soluzioni (anche ad esempio la cessione dell’azienda a terzi).
- Poteri e ruolo dell’esperto: L’esperto non ha poteri di imporre accordi, ma guida le trattative. Può convocare le parti, esaminare dati, suggerire soluzioni. Redige inizialmente una relazione sulla situazione dell’impresa e sulle prospettive di risanamento e, man mano che la negoziazione procede, verifica la fattibilità delle proposte. Se il debitore ha comportamenti ostruzionistici o non collabora, l’esperto può dichiarare chiusa la procedura. Se invece intravede soluzioni, cerca di farle emergere e di farle accettare ai creditori. La presenza dell’esperto serve anche a dare credibilità all’imprenditore: un piano visto con sospetto dai creditori, se accompagnato dal parere favorevole di un esperto terzo, può acquisire ben altro peso.
- Misure protettive: Uno strumento fondamentale per difendersi dalle azioni esecutive mentre si tratta è la possibilità, per l’imprenditore, di chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive (art. 18 CCII) dal giorno della pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata. Tali misure consistono nel blocco (automatic stay) delle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa, per la durata di iniziali 120 giorni prorogabili (fino a max 240). In pratica, se il tribunale le concede, nessun creditore potrà pignorare conti, né iscrivere ipoteche giudiziali, né iniziare procedure di sequestro o simili durante la negoziazione. Nota: i crediti dei lavoratori per retribuzioni e i nuovi crediti sorti durante la composizione non sono soggetti a questo blocco (per garantire fornitori correnti). Le misure protettive vengono annotate nel Registro imprese, quindi in quel caso la procedura diventa conoscibile da terzi (ma l’azienda può spiegare che sta adottando misure di risanamento). La Cassazione nel 2025 ha attribuito grande importanza alle misure protettive concesse nella composizione negoziata: ha stabilito che la loro presenza è indice del serio intento di risanare e giustifica il rigetto di misure cautelari penali (sequestri) sui beni dell’impresa, in assenza di pericolo concreto di distrazione. Questo approccio della Suprema Corte (sent. 30109/2025) evidenzia come la composizione negoziata sia considerata uno “scudo” attivo: se l’imprenditore la intraprende seriamente, gode di un favore dell’ordinamento, vedendo ridotto il rischio di aggressioni sul patrimonio durante i tentativi di risanamento.
- Continuità aziendale: Durante la composizione negoziata, l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa (non c’è spossessamento come nel fallimento). Deve però astenersi da atti di straordinaria amministrazione non coerenti con la conduzione ordinaria senza informare l’esperto, e in caso chiedere autorizzazione del tribunale per alcuni atti (es. finanziamenti prededucibili, scioglimento di contratti onerosi, vendita di immobili, a norma dell’art. 20 CCII). Ciò consente di proseguire l’attività, salvaguardando la continuità produttiva e i rapporti con clienti e fornitori, cosa cruciale per poter poi risanare. A differenza del concordato preventivo, qui non c’è la figura del commissario giudiziale a controllare: l’esperto vigila ma non ha poteri di amministrazione, dunque la responsabilità resta all’imprenditore (che però agisce sotto la “guida morale” dell’esperto).
- Esito della procedura: Può essere molteplice:
- Se le trattative hanno successo, si può formalizzare un accordo con tutti o parte dei creditori. Ad esempio l’impresa ottiene un accordo stragiudiziale con ciascuna banca e con i fornitori principali, magari con l’intervento di un investitore che apporta liquidità; l’accordo può restare riservato oppure, se coinvolge la ristrutturazione dei debiti finanziari oltre il 60% o si vuole estenderlo ai dissenzienti, si può chiedere l’omologazione come accordo di ristrutturazione. In alternativa, se le intese raggiunte configurano un soddisfacimento non integrale dei creditori e serve una moratoria generale, l’imprenditore può “convertire” il negoziato in un vero e proprio concordato preventivo (presentando ricorso in tribunale, spesso con il beneficio di aver già l’assenso di molti creditori raccolto in sede negoziale).
- Se le trattative falliscono, l’esperto lo dichiara nelle conclusioni. In tal caso l’imprenditore ha comunque alcune opzioni residue: una è accedere al “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” (art. 25-sexies CCII). Questo concordato semplificato è una procedura introdotta come valvola di sicurezza: se la composizione negoziata non arriva a un risanamento, ma c’è comunque la necessità di evitare il collasso disordinato, l’imprenditore – solo all’esito negativo della composizione negoziata – può proporre un concordato liquidatorio senza passare per il voto dei creditori (sarà il tribunale a valutare e omologare sentite le parti). In questo concordato semplificato, l’attivo dell’azienda viene liquidato sotto controllo giudiziario e il ricavato ripartito tra i creditori secondo le regole di legge, con possibile falcidia dei debiti; non essendoci voto, i creditori possono solo opporsi in sede di omologa, ma non decidono essi l’esito. Importante: il concordato semplificato non consente la continuità aziendale (serve solo a liquidare), e per questo è utilizzabile appunto come extrema ratio. Un’altra opzione se la negoziazione fallisce è che l’imprenditore decida di accedere comunque al concordato preventivo ordinario (se ritiene di avere chance di farlo approvare dai creditori nonostante l’insuccesso delle trattative informali) oppure che si rassegni a portare i libri in tribunale (istanza di liquidazione giudiziale).
- Vantaggi per il debitore: la composizione negoziata è flessibile, riservata e relativamente rapida. Permette di provare a trovare soluzioni creative (dilazioni, nuove garanzie, conversione debiti in quote) senza i formalismi di un processo. La presenza di un esperto dà autorevolezza e struttura al dialogo. Inoltre offre protezioni legali: misure protettive, possibilità di chiedere finanziamenti prededucibili autorizzati (per avere cassa fresca), deroga alla disciplina delle cause di scioglimento societario (una S.r.l. in perdita significativa può rinviare la ricapitalizzazione finché dura la procedura negoziata, ex art. 20 co.3 CCII), nonché il bonus menzionato prima sul fronte cautelare/penale (un’azienda in composizione negoziata è percepita come in via di risanamento, dunque meno soggetta a provvedimenti restrittivi). Un ulteriore vantaggio: l’art. 23 CCII prevede che le transazioni stipulate durante la composizione negoziata con alcuni creditori (accordi stragiudiziali) possono, su richiesta del debitore, essere omologate dal tribunale e rese vincolanti anche per eventuali creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria (ad es. se il debitore raggiunge accordo con l’75% delle banche per riscadenzare il debito, può chiedere che sia esteso anche alle banche dissenzienti – questo è un riflesso delle nuove norme sugli accordi ad efficacia estesa).
- Svantaggi e limiti: innanzitutto, la composizione negoziata non garantisce il risultato: se i creditori non vogliono accordarsi, non c’è modo di imporre un sacrificio a maggioranza (come invece avviene nel concordato). Dipende molto dalla buona fede e apertura delle parti. Inoltre richiede che l’impresa abbia ancora prospettive di recupero: se la situazione è troppo compromessa, l’esperto stesso potrà constatare l’impossibilità di risanare e suggerire la liquidazione. È uno strumento giuridicamente “leggero”, quindi in certe situazioni può essere insufficiente. Non ultimo, richiede all’imprenditore collaborazione totale e trasparenza: se emergeranno comportamenti in malafede (dati falsi forniti all’esperto, atti distrattivi nel frattempo), la procedura cesserà e i creditori saranno probabilmente ancora più esasperati.
In sintesi, la composizione negoziata è la prima linea di difesa legale che un imprenditore debitore dovrebbe considerare appena percepisce che la situazione dei debiti è divenuta critica. La sua introduzione risponde proprio alla necessità di intervenire presto. Come notato in dottrina, essa incarna un approccio di “soluzione negoziale anticipata” che l’ordinamento italiano, in attuazione delle indicazioni europee (Direttiva UE 2019/1023), ha adottato per privilegiare il salvataggio rispetto alla liquidazione.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento già previsto dalla vecchia legge fallimentare (art. 67, co. 3, lett. d) L.F.) e confermato nel Codice della crisi (art. 56). Si tratta di un percorso totalmente stragiudiziale: l’imprenditore elabora, con l’ausilio di consulenti, un piano di risanamento aziendale, cioè un insieme di operazioni (ristrutturazione debiti, aumento di capitale, dismissione di asset, riorganizzazione produttiva, ecc.) volte a riequilibrare la situazione economico-patrimoniale e a garantire la continuità aziendale. Questo piano viene sottoposto a un professionista indipendente (revisore, commercialista, esperto di crisi iscritto negli albi) il quale redige una attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano (in termini di ragionevole probabilità di successo).
Caratteristiche principali:
- Finalità: Il piano attestato non è di per sé un accordo con i creditori, ma serve a dare un quadro organico e credibile alle trattative. Spesso il debitore utilizza il piano attestato come base per convincere banche e altri creditori a ristrutturare i propri crediti volontariamente. Ad esempio, la Radiatori Oli S.r.l. potrebbe fare un piano attestato in cui prevede che le banche proroghino le scadenze dei mutui di 5 anni e rinuncino a 1/3 degli interessi futuri, i fornitori accettino un pagamento al 80% a 12 mesi, i soci immettano nuovi fondi e l’azienda venda un capannone inutilizzato per fare cassa. Se un professionista indipendente attesta che con queste azioni l’impresa tornerà redditizia e solvente, le banche e fornitori hanno un documento oggettivo su cui fare affidamento.
- Vantaggi legali (protezione da revocatoria): Il vero “scudo” che la legge attribuisce al piano attestato è in materia fallimentare: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 67, c.3 L.F., ora art. 166, c.3 CCII mantiene analoga esenzione). Questo significa che un creditore che aderisca al piano (ad esempio accettando un pagamento parziale immediato) non dovrà temere che, se l’azienda poi fallisce, il curatore gli chieda di restituire i soldi per “pagamento preferenziale”. Ciò incentiva i creditori ad aderire, perché rimuove il rischio di dover restituire in futuro. Dal lato del debitore, ciò permette di pagare alcuni creditori e fare operazioni di risanamento senza il timore che vengano invalidati ex post.
- Assenza di coinvolgimento del tribunale: il piano attestato non richiede omologazione né deposito in tribunale (può essere facoltativamente pubblicato nel Registro delle Imprese per dare pubblicità ai terzi). Quindi è rapido e confidenziale. Tuttavia, proprio perché non c’è omologazione, non vincola i creditori dissenzienti: chi non ha aderito al piano resta libero di agire. Dunque il piano attestato funziona bene se l’impresa riesce a portare spontaneamente tutti i principali creditori a cooperare.
- Meritevolezza e buona fede: L’attestatore deve essere indipendente e scrupoloso. Se un piano viene attestato in maniera compiacente senza basi solide, i benefici decadono: ad esempio, un creditore che si ritenga frodato da un piano “fasullo” potrebbe contestare l’efficacia protettiva in revocatoria, oppure gli amministratori potrebbero incorrere in responsabilità per aver falsamente rappresentato la situazione all’attestatore. In sostanza, il piano attestato richiede una due diligence profonda e onesta.
- Evoluzioni normative: Il Codice della crisi all’art. 56 ha introdotto l’obbligo che il piano indichi specificamente come assicura l’integrale soddisfacimento di eventuali creditori che non aderiscono (per evitare che questi restino pregiudicati). Inoltre, il terzo correttivo 2024 ha dettagliato il contenuto minimo del piano, richiedendo di esplicitare se e quanto i creditori otterranno in esecuzione del piano. Questo per elevare la qualità e la trasparenza di tali piani.
- Quando usarlo: Il piano attestato è indicato quando la crisi è ancora moderata e circoscritta a pochi grandi creditori, oppure quando l’impresa ha bisogno solo di regolare temporaneamente alcune posizioni e reperire finanza fresca senza passare per un tribunale. Ad esempio, può essere preferibile a un concordato se l’azienda ha principalmente debiti verso banche con cui è possibile trovare un accordo e magari un socio disponibile a investire: con il piano attestato si risparmia tempo e pubblicità negativa. Al contrario, se il numero di creditori è ampio e c’è bisogno di vincolare anche i dissenzienti, questo strumento rischia di essere inadeguato.
- Esempio pratico: Radiatori Oli S.r.l. ha 3 banche esposte e 5 fornitori grossi, total debiti €2 milioni. Prepara un piano di risanamento dove un esperto attesta che, se le banche allungano le scadenze di 5 anni e i fornitori accettano un piano di rientro a 12 mesi per il 70% dei crediti, con l’apporto di €200k nuovi dei soci e la vendita di un immobile non strategico per €500k, l’azienda tornerà in utile e liquida. Le banche e fornitori, vedendo il piano e la relazione di un professionista stimato, decidono di aderire per evitare di perdere tutto in un fallimento. L’azienda esegue in pochi mesi questi atti: vende l’immobile, paga parzialmente i creditori come da accordi, ottiene nuove linee. Tra 2 anni però, per circostanze imprevedibili, va comunque in default e fallisce. Ebbene, i pagamenti fatti e le garanzie date in attuazione del piano (es. la banca aveva ottenuto pegno su un magazzino a fronte dell’allungamento) non potranno essere revocati dal curatore, perché coperti dalla safe harbour del piano attestato.
Sintesi piano attestato: è uno strumento contrattuale basato sulla fiducia generata da un’attestazione professionale. Non offre “scudi” contro le azioni esecutive (nessun automatic stay) né consente di imporre tagli a chi non li accetta, ma offre un ambiente protetto ex post (no revoche) per concretizzare un workout privato. Dal punto di vista del debitore, si può dire che è ottimo in situazioni di crisi non ancora irreversibile, dove si vuole evitare la pubblicità di un concordato, e se si ha la ragionevole aspettativa di coinvolgere cooperativamente i creditori principali. È spesso usato insieme ad altri strumenti: ad esempio, un piano attestato può sfociare in un accordo di ristrutturazione omologato (vedi infra), qualora si decida di dare forza esecutiva a quell’accordo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
L’accordo di ristrutturazione (già art. 182-bis L.F.) è una procedura concorsuale “mista”: nasce dall’accordo tra l’impresa debitrice e una parte dei suoi creditori, ma viene poi sottoposto all’omologazione del tribunale per acquisire efficacia legale generale. In breve, l’impresa negozia con i creditori un accordo che può prevedere qualunque modifica delle obbligazioni (dilazioni, stralci, conversione debiti in equity, ecc.), a condizione di raggiungere l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (percentuale che il correttivo 2020 aveva ridotto a 30% per i soli accordi con intermediari finanziari, ma poi riallineato in recepimento direttiva UE) – attualmente è 60% per accordo ordinario, ma esistono varianti: accordo “ad efficacia estesa” ai sensi dell’art. 61 CCII che consente di estendere ai creditori finanziari dissenzienti se aderisce il 75% di tali crediti, e accordi agevolati con riduzione di maggioranze se non ci sono determinate classi di creditori. Una volta raggiunta la soglia, l’accordo (che di solito è formalizzato in un unico documento firmato dai creditori aderenti e dal debitore) viene sottoposto al tribunale con un ricorso per omologazione. Il tribunale verifica che siano rispettate le norme (in particolare che i creditori estranei possano essere pagati per intero nei 120 giorni dall’omologa o dalle scadenze), e se tutto è a posto omologa l’accordo, rendendolo efficace erga omnes.
Punti chiave e differenze rispetto al piano attestato/concordato:
- Adesione di una maggioranza qualificata: Serve il sì (formale) di un numero di creditori sufficiente a coprire 60% dei crediti. Non si tratta di un voto assembleare per teste e capitali come nel concordato; è proprio un calcolo sul totale crediti. Ad esempio, se l’azienda ha debiti totali €1M, e creditori per €600k firmano l’accordo, si presenta il tutto al giudice. I creditori non aderenti, pari al 40% residuo in valore, rimangono estranei all’accordo: il che significa che non subiscono tagli o modifiche forzate alle loro pretese (devono venir pagati integralmente, fuori accordo, entro 120 giorni dall’omologa se già scaduti o entro 120 giorni dalla scadenza se a termine – art. 61 CCII). Questo è un limite importante: non è come nel concordato dove la minoranza dissenziente è vincolata a quanto deciso a maggioranza, qui i non aderenti devono essere comunque soddisfatti in pieno (salvo quelle eccezioni del “cram down fiscale” e di efficacia estesa per finanziari, dove il giudice può forzare anche se Erario dissente o se un 25% di banche dissente). Dunque la convenienza dell’accordo di ristrutturazione sta nell’evitare di coinvolgere troppi creditori piccoli: spesso si cerca l’accordo con banche e grandi fornitori, mentre i piccoli vengono pagati integralmente a parte.
- Attestazione di un esperto: Anche l’accordo di ristrutturazione dev’essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e l’idoneità dell’accordo a assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Attesta in sostanza che chi non firma non verrà danneggiato (perché li paghiamo per intero) e che l’accordo è sostenibile.
- Procedimento e misure protettive: Quando il debitore deposita il ricorso per omologa dell’accordo già concluso (o anche prima, in veste di pre-accordo per ottenere protezione), può chiedere al tribunale le stesse misure protettive del concordato: sospensione delle azioni esecutive dei creditori, sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 2446-2447 c.c., ecc. Queste protezioni durano fino all’omologa e servono a evitare che qualche creditori estraneo “rovini” tutto pignorando l’azienda. Inoltre, una volta depositato il ricorso, si ha uno stay anche rispetto alle istanze di fallimento (il tribunale di solito le sospende in attesa dell’omologa). Quindi l’accordo di ristrutturazione, pur volontario, ha un’importante efficacia difensiva per il debitore: consente di paralizzare le aggressioni mentre finalizza la soluzione.
- Cram-down fiscale e per banche: Come accennato, la legge oggi consente di omologare l’accordo di ristrutturazione anche senza il voto dell’Erario/INPS sulla transazione fiscale o contributiva, purché l’adesione dei creditori sia comunque oltre 60% e il trattamento proposto al Fisco sia conveniente (questo è il “cram-down fiscale” introdotto dal 2020 e ora confermato: art. 63 CCII). Inoltre, l’art. 61 CCII prevede che se l’accordo è concluso con almeno il 75% dei crediti finanziari, possa essere esteso ai creditori finanziari dissenzienti (di pari grado) su istanza del debitore, previa omologa del tribunale, a condizione che siano stati informati e abbiano possibilità di aderire alle stesse condizioni (accordo ad efficacia estesa). Queste previsioni permettono di superare l’ostacolo di poche banche dissenzienti o dell’eventuale silenzio/diniego del Fisco.
- Esecuzione e risoluzione: Una volta omologato, l’accordo è contratto obbligatorio per chi l’ha firmato e vincolante nella sua efficacia per quei casi di estensione. Se il debitore poi non rispetta i pagamenti come da accordo, i creditori possono chiederne la risoluzione (davanti al tribunale) e a quel punto niente vieta il fallimento. L’accordo di ristrutturazione non prevede una esdebitazione automatica: i crediti dei firmatari si considerano soddisfatti secondo l’accordo (e per la parte eventualmente stralciata non c’è più pretesa), mentre i creditori estranei, essendo pagati integralmente, escono soddisfatti. Non c’è un effetto “liquidatorio” generale come nel concordato.
- Quando è adatto: È molto utile se l’impresa ha pochi creditori rilevanti con cui può mediare e molti creditori minori che può pagare regolarmente. Ad esempio tipico: grandi esposizioni con banche e fisco, e poi tanti fornitori piccoli. Si fa un accordo con banche e Fisco (transazione fiscale inclusa) per pagare magari una percentuale o diluire molto il debito, e i piccoli fornitori invece vengono pagati cash (magari grazie al risparmio ottenuto con banche). Così quell’azienda si libera del grosso del fardello e riprende ossigeno.
- Costi e tempi: L’accordo di ristrutturazione è generalmente più veloce del concordato perché non ha la fase di voto e adunanza: presentato l’accordo già firmato, il tribunale verifica e se nessuno si oppone in 30-60 giorni può omologarlo. Anche i costi procedurali (compenso dell’attestatore, spese legali) sono inferiori di solito a quelli di un concordato lungo.
- Esempio: Radiatori Oli S.r.l. ha €5 milioni di debiti: 3 banche (€3M), 50 fornitori (€1M), Fisco e INPS (€1M). Trovandosi in crisi di liquidità, propone: alle banche conversione di metà credito in strumenti partecipativi (o una riduzione con pagamento del 50% in 5 anni), ai fornitori piccoli paga cash il 100% grazie a nuova finanza, al Fisco chiede stralcio di sanzioni e interessi e dilazione imposte in 5 anni. Banche (che hanno il 60% del credito totale sommando anche Fisco e fornitori) accettano, l’Erario aderisce alla transazione, i fornitori li paga e dunque non c’è problema. Raggiunto ~65% di consensi, l’azienda deposita l’accordo. Il tribunale attesta che i dissenzienti (pochissimi, magari 2 fornitori su 50 che volevano subito i soldi ma li hanno già avuti) sono pagati comunque e che l’accordo è fattibile e conveniente rispetto al fallimento. Viene omologato. L’impresa esce dalla procedura senza più spada di Damocle: i creditori aderenti non potranno pretendere più di quanto accordato, e l’azienda ha evitato il fallimento.
Sintesi accordo di ristrutturazione: è uno strumento concorsuale flessibile, adatto al debtor che mantiene la fiducia di un nucleo di creditori disposto a trattare. Dal punto di vista del debitore, offre protezione giudiziaria (stay) e un risultato vincolante, ma richiede di disporre di risorse sufficienti per non penalizzare gli estranei. Se la massa di creditori è ampia e molti non possono essere pagati integralmente, allora serve il concordato. L’accordo è anche utile come esito di una composizione negoziata: in quella sede il debitore può raccogliere informali adesioni e poi formalizzarle in un accordo da omologare (beneficiando anche di norme speciali come l’estensione ai dissenzienti). Le riforme 2020-2022-2024 lo hanno reso ancora più efficiente, introducendo possibilità di omologa semplificata (accordo “agevolato” ex art. 60-bis CCII, senza classi né quorum se tutti i creditori sono banca/fisco e aderisce almeno il 30%, poi elevato) e di accordi su crediti tributari previdenziali con omologa anche se c’è opposizione (cram-down). Quindi al 2025, l’accordo di ristrutturazione è un pilastro delle soluzioni negoziali d’impresa.
Di seguito una tabella comparativa, per chiarezza, tra i principali strumenti concordatari/negoziali di cui abbiamo discusso:
| Strumento | Natura | Adesione creditori | Omologazione tribunale | Effetti sui creditori | Misure protettive | Continuità aziendale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Stragiudiziale assistito (procedura volontaria con esperto) | Nessuna maggioranza prestabilita: accordi consensuali con chi si riesce (non vincola dissenzienti) | No omologa (solo eventuali provvedimenti su misure protettive) | Vincola solo chi sottoscrive accordi durante la negoziazione. Possibile poi convertire in concordato o accordo di ristrutturazione per effetti erga omnes. | Sì, se richieste al tribunale (sospensione azioni esecutive max 240 gg) | Sì, impresa continua sotto la guida dell’imprenditore, coadiuvato da esperto (nessuno spossessamento). |
| Piano attestato di risanamento | Stragiudiziale puro (contratto) | Nessuna soglia legale; dipende da accordi individuali (di solito con banche principali). Non vincola chi non partecipa. | No (può essere pubblicato registro imprese, ma niente udienza) | Chi aderisce è vincolato contrattualmente; i non aderenti restano liberi e vanno soddisfatti secondo termini originari. Protezione da revocatoria per atti eseguiti in piano. | No misure automatiche; però possibile chiedere a tribunale sospensione singole azioni esecutive ex art. 56 co. 3 se pendono procedure concorsuali? (In generale no stay globale). | Sì, il piano è finalizzato a risanare in continuità di solito (può includere cessioni asset ma impresa rimane in piedi). |
| Accordo di ristrutturazione | Misto (accordo privato + omologazione) | 60% dei crediti (in valore). Possibile efficacia estesa per banche 75% e cram-down fiscale. | Sì, il tribunale omologa se condizioni rispettate e attesta pagamento integrale estranei. | Vincola solo aderenti (ma con omologa, anche il Fisco dissenziente può essere obbligato a transazione se tutela rispettata). I non aderenti devono essere pagati al 100% entro 120 gg (salvo dilazioni già a termine). Dopo omologa, i creditori aderenti subiscono gli stralci/dilazioni concordati. | Sì, dal deposito ricorso fino a omologa; impedite azioni cautelari/esecutive. | Sì, usualmente l’azienda prosegue; se accordo implica cessione beni può comunque avvenire in continuità parziale. Nessun organo nominato, amministrazione resta al debitore. |
| Concordato preventivo | Giudiziale a maggioranza (procedura concorsuale) | Doppia maggioranza: maggioranza di crediti ammessi al voto e maggioranza di votanti favorevoli (>50%). Classi se eterogeneità. | Sì, omologa dopo voto (può anche cramdown classi dissenzienti se alcune approvano e trattamenti equi). | Vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti) al soddisfo secondo il piano omologato (purché abbiano diritto almeno al valore di liquidazione). Creditori post-apertura fuori dal concorso. | Sì, automatico dalla pubblicazione ricorso (blocco azioni esecutive). | Due tipologie: Concordato in continuità (azienda continua, debitore mantiene gestione sotto osservazione di un commissario, salvo casi di continuità indiretta), oppure concordato liquidatorio (cessione beni, di solito nominato un liquidatore giudiziale post-omologa). In entrambi i casi durante la procedura c’è un commissario che vigila. |
(NB: Esistono anche “concordato semplificato” post-composizione negoziata, qui non inserito in tabella, che è un concordato liquidatorio speciale senza voto; e le procedure di sovraindebitamento per non fallibili, trattate a parte.)
Come si vede, l’accordo di ristrutturazione è un po’ a metà tra il piano attestato (negoziale, flessibile) e il concordato (giudiziale, vincolante erga omnes), con requisiti intermedi. Spesso è preferibile quando si vuole evitare un concordato (che può essere lungo e stigmatizzante) ma serve qualcosa in più del semplice accordo informale.
Concordato preventivo (artt. 84-118 CCII)
Il concordato preventivo è forse lo strumento più noto di regolazione della crisi d’impresa in Italia, presente da decenni e rivisitato dalla riforma. Si tratta di una procedura concorsuale giudiziale in cui l’imprenditore propone ai creditori un piano per il soddisfacimento parziale dei loro crediti, in alternativa al fallimento. Se i creditori approvano a maggioranza e il tribunale omologa ritenendo che siano rispettate le norme, il concordato si perfeziona ed evita la liquidazione giudiziale.
Dal punto di vista del debitore, il concordato preventivo è uno strumento più strutturato e impegnativo rispetto a quelli visti sopra, ma è anche quello che offre le maggiori tutele e la possibilità di imporre la soluzione anche ai creditori contrari (potere coercitivo a maggioranza). È in sostanza l’ultimo baluardo per cercare di evitare il fallimento, quando non è stato possibile trovare accordo in via più semplice.
Principali aspetti:
- Requisiti di accesso: Possono proporre concordato tutti i debitori “fallibili” (soggetti a liquidazione giudiziale) in stato di crisi o di insolvenza (anche prospettica). Quindi un’impresa sopra soglie, o comunque non un consumatore o piccolo imprenditore (per questi ultimi c’è il concordato minore di cui diremo). Di norma, la domanda di concordato la presenta lo stesso debitore (concordato volontario); i creditori non possono “imporre” un concordato, al massimo durante un fallimento possono suggerire un concordato fallimentare ma è altra fattispecie. Dunque è uno strumento a iniziativa del debitore.
- Classi e voto: Il debitore presenta un piano e una proposta. Nel piano descrive come intende soddisfare i creditori (es: vendendo certi asset, incassando crediti, continuando l’attività per X anni e pagando col flusso, ecc.). Può suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei (ed è obbligatorio farlo per i creditori con garanzie reali e per quelli con trattamento differenziato). Questo consente, ad esempio, di mettere le banche ipotecarie in una classe, i fornitori chirografari in un’altra, ecc., e offrire percentuali diverse a classi diverse. I creditori votano per classi (ogni classe approva se raggiunge la maggioranza in valore dei crediti in quella classe). Serve anche la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto (50%+1). Se vi sono classi dissenzienti ma almeno una classe ha votato sì, il tribunale può omologare il concordato anche senza il consenso delle classi minoritarie (cram-down interclassi) purché ritenga che i dissenzienti non ricevano meno di quanto riceverebbero in una liquidazione fallimentare e che la proposta verso di loro sia equa e non li discrimini ingiustamente (art. 112 CCII). Dunque, a differenza di tutti gli altri strumenti, il concordato consente di trascinare anche chi è contrario, sotto controllo del giudice.
- Tipologie di concordato: La riforma distingue nettamente:
- Concordato in continuità aziendale: quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia in forma diretta (la stessa società continua operare) sia indiretta (es. affitto o cessione dell’azienda a un terzo che continua l’attività). Il fine è preservare l’avviamento, i posti di lavoro e generare risorse per pagare i creditori col ricavato della continuità (utile futuro). Il concordato in continuità è incentivato dalla legge: ad esempio, non ha soglie minime di pagamento ai chirografari, può prevedere una moratoria fino a 2 anni per pagare i privilegiati (se autorizzata), i contratti pendenti non si sciolgono automaticamente (l’impresa può chiederne la sospensione o mantenimento a seconda utilità), e, novità del CCII, è possibile proporre di pagare i creditori in forma non monetaria (equity, strumenti partecipativi) se accettano.
- Concordato liquidatorio: quando il piano prevede cessione dei beni e sostanzialmente la fine dell’attività. Tradizionalmente malvisto perché simile a un fallimento ma volontario, oggi è ammesso ma con condizioni più severe: è necessario garantire ai creditori un pagamento minimo del 20% dell’ammontare dei crediti chirografari (soglia ridotta rispetto al 30% della vecchia legge, e per i sovraindebitati ancora minore). Inoltre, di regola, nel concordato liquidatorio classico l’imprenditore deve cedere tutto il patrimonio, nominare un liquidatore e uscire di scena. Non c’è più continuità salvo quella minima per miglior realizzo (ad es. vendere l’azienda funzionante invece che spezzettata).
- Concordato misto: piani che combinano aspetti di continuità e liquidazione (es. vendi alcuni asset non strategici, ma continui l’attività core). La legge li assimila alla continuità se la parte prevalente è la continuità.
- Concordato semplificato per liquidazione: come visto, è il nuovo istituto riservato al caso di composizione negoziata fallita, senza voto dei creditori. Lo citiamo ma è speciale.
- Trattamento dei creditori: Nel concordato, l’obbligo fondamentale è che nessun creditore (in classe o fuori) riceva meno di quanto otterrebbe in un fallimento (principio del best interest test). Inoltre, i creditori muniti di privilegio/garanzia possono essere soddisfatti in percentuale ridotta solo se la parte insoddisfatta è comunque pari o superiore a quanto otterrebbero dalla vendita del bene vincolato in concordato liquidatorio (in pratica, non li puoi decurtare oltre il sacrificio che subirebbero comunque dalle spese e ritardi della liquidazione giudiziale). I creditori chirografari possono prendere anche percentuali basse, purché la soglia 20% (liquidatorio) sia rispettata e comunque il piano sia votato dalla maggioranza – se accettano 10%, pace, ma la legge vuole almeno 20% se liquidazione pura a tutela minima. Nel concordato in continuità, come detto, non c’è soglia fissa di legge, quindi se la stima di fallimento dice che i chirografari prenderebbero zero, teoricamente anche 5% in concordato potrebbe passare se i creditori lo preferiscono. L’importante è la convenienza comparativa.
- Procedura: L’imprenditore presenta il ricorso, il tribunale dichiara aperta la procedura se la domanda è completa o fissa un termine se è “concordato con riserva” (cioè domanda prenotativa senza piano completo, entro 60-120 giorni va depositato il piano). Viene nominato un Commissario Giudiziale, che sorveglia la gestione e redige una relazione per i creditori. Si indice l’adunanza dei creditori dove questi votano (oggi possono votare anche per PEC senza presenza fisica). Dopo il voto, se raggiunte le maggioranze, il tribunale passa all’omologazione: omologa se non ci sono opposizioni fondate, verifica legalità e meritevolezza. Una volta omologato, il piano diventa vincolante e la società ne esce mantenendo i beni che erano destinati a continuità e liberandosi dai debiti eccedenti con le percentuali offerte.
- Vantaggi per il debitore: la procedura di concordato offre la protezione massima: dal giorno della pubblicazione del ricorso in registro imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti (né acquisire privilegi se non concordati). Sono anche sospese le prescrizioni, ecc. C’è poi la moratoria dei debiti pregressi: il debitore non paga nulla ai vecchi creditori finché la procedura è in corso (salvo eventuali acconti autorizzati). Questo congelamento può durare anche parecchi mesi, permettendo all’impresa di respirare. Inoltre, il concordato consente di sciogliersi da contratti onerosi (previa autorizzazione, art. 97 CCII) o di sospenderli se conviene, e prevede che eventuali clausole di decadenza anticipata dei contratti per il concordato non abbiano effetto. Ad esempio, una clausola di un contratto di fornitura che dice “se la parte chiede il concordato, il contratto si risolve” non è valida (patti ipso facto nulli). Questo tutela la continuità: i fornitori cruciali non possono interrompere solo perché c’è il concordato in corso, se il debitore adempie alla fornitura corrente.
- Sacrifici per il debitore: Ovviamente c’è un rovescio della medaglia: il debitore in concordato perde l’autonomia completa. Pur restando in possesso dei beni in continuità, ogni atto di straordinaria amministrazione dev’essere autorizzato dal giudice delegato; il commissario vigila e riferisce, quindi eventuali malversazioni saranno subito notate. In caso di gestione scorretta o peggioramento, il tribunale può revocare il concordato e aprire il fallimento. Inoltre, l’imprenditore deve esporre pubblicamente la crisi: la notizia del concordato diventa di dominio pubblico (Registro imprese, potenziali clienti e fornitori lo sapranno, con possibili effetti reputazionali negativi). Per questo di solito il concordato è l’ultima spiaggia, quando si è già in situazione molto compromessa.
- Esdebitazione: La logica del concordato è liberatoria: una volta eseguito il piano, il debitore è liberato dai debiti residui come stabilito dall’omologa. Ad esempio, se un creditore aveva €100 e il piano prevede pagamento 30, incassato 30 egli non potrà più reclamare i 70 residui: sono estinti per effetto dell’omologa e del pagamento conforme. Ciò consente al debitore un vero fresh start se il concordato ha successo. (Viceversa, se il concordato fallisce e viene risolto, tornano attivi i crediti originari, salvo detrarre acconti eventualmente ricevuti).
- Concordato nei gruppi di imprese: Novità del CCII, per completezza, è la possibilità di presentare concordati di gruppo coordinati, con un unico piano o piani collegati, dinanzi allo stesso tribunale, se più società del medesimo gruppo sono in crisi. Questo semplifica la gestione di crisi di gruppi complessi (es. holding + controllate in crisi).
- Esempio: Radiatori Oli S.r.l. capisce di non poter più salvare l’azienda se non riducendo fortemente il debito, e che gli accordi bonari non hanno funzionato. Presenta un piano di concordato con continuità: l’azienda rimane attiva, ma i creditori chirografari riceveranno il 30% in 5 anni con risorse derivanti dall’attività più l’ingresso di un investitore. I privilegiati (banche ipotecarie) ricevono il 100% ma a partire dal secondo anno (moratoria 1 anno). Il piano viene approvato dal 75% dei crediti (le banche e alcuni fornitori importanti votano sì, altri non votano ma non importa). Il tribunale omologa: i creditori dissenzienti (anche quelli che magari preferivano il fallimento) sono obbligati a stare nei termini del piano: non potranno agire oltre e riceveranno ad es. 30%. L’azienda è salva, esce dal concordato e negli anni paga regolarmente quel 30%. Al termine, i debiti vecchi sono considerati estinti. L’alternativa sarebbe stata il fallimento con probabilmente chiusura azienda e creditori chirografari a zero.
Sintesi concordato preventivo: per il debitore è lo strumento più potente ma anche più gravoso. Permette di imporre una ristrutturazione anche a chi non la vuole, e offre un’ampia gamma di opzioni (salvataggio, cessione, misto). In compenso, richiede trasparenza totale, il rispetto di regole formali, la maggior intrusione del tribunale negli affari aziendali. In generale, va considerato quando: – Il risanamento richiede un taglio consistente dei debiti che non si potrebbe ottenere consensualmente da tutti creditori. – La platea dei creditori è ampia e eterogenea, rendendo difficile un accordo con maggioranze qualificate come nel 182-bis. – Oppure quando un creditore/blocco di creditori rilevanti è ostile e non c’è modo di superarlo se non con la forza del cram-down (es. l’Erario rifiuta la transazione ma il concordato può essere omologato comunque, oppure una banca dissenziente ma i fornitori e altre banche sono pro-concordato). – Serve protezione immediata e prolungata dalle esecuzioni, che solo il concordato può dare a lungo termine (il piano attestato e la composizione negoziata non hanno uno stay così robusto e automatico).
Il punto di vista del debitore dev’essere pragmatico: a volte, dichiarare concordato per tempo può evitare che uno o due creditori facciano istanza di fallimento precipitosa. Infatti l’art. 40 CCII (già art. 161 L.F.) consente al debitore di depositare anche una domanda di concordato in bianco (prenotativo) all’ultimo momento, ottenendo lo stop delle azioni e poi guadagnando tempo per preparare il piano. Questo è spesso utilizzato come difesa d’urgenza: se l’azienda riceve convocazione in tribunale su istanza di fallimento di un creditore, presentare la domanda di concordato sospende la declaratoria finché non si vede se il piano è fattibile. Naturalmente, abusare di questa facoltà senza poi presentare un piano serio può ritorcersi contro (il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda se era solo dilatoria). Però è un segnale di come il concordato sia inteso come strumento di composizione preferibile al fallimento, e il sistema concede chance al debitore per perseguirlo.
Strumenti per la crisi da sovraindebitamento (piccoli imprenditori e privati)
Accenniamo ora, separatamente, alle procedure destinate ai debitori non fallibili (o comunque non soggetti alle procedure sopra). Questo può rilevare in due situazioni nel contesto “azienda radiatori olio”: 1. L’impresa indebitata è una ditta individuale o società sotto soglia non fallibile. In tal caso, non potrà accedere a concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, ma dovrà usare questi strumenti speciali. 2. Soci e garanti persone fisiche indebitati a titolo personale, a causa di garanzie escusse o mischiati con debiti aziendali (ad es. il socio di Snc, essendo fallito con la società, potrebbe poi chiedere esdebitazione; oppure un ex imprenditore individuale finito con patrimonio insufficiente).
La legge n. 3/2012 istituì le procedure di sovraindebitamento per il debitore civile e piccolo imprenditore. Dal 15 luglio 2022 queste sono confluite nel Codice della crisi (artt. 65-91 CCII) con alcune modifiche terminologiche e sostanziali. Oggi abbiamo:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): è l’evoluzione del “piano del consumatore”. Riservato alle persone fisiche che hanno debiti principalmente di natura personale (non legati ad attività di impresa). Permette al consumatore sovraindebitato di proporre un piano di pagamento, anche senza l’accordo dei creditori (basta l’omologa del giudice, se ritiene che il piano sia fattibile e che il debitore sia meritevole, cioè che non abbia colpa grave nel suo indebitamento). Ad es. una persona che ha debiti per carte di credito, bollette, ecc., può proporre di pagarne il 50% in 4 anni usando il suo stipendio, e ottenere dal giudice l’omologa anche se i creditori (banche, finanziarie) non sono d’accordo. Va nominato un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che aiuta a predisporre il piano e gestisce la procedura.
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII): sostituisce il vecchio “accordo di composizione della crisi” della L.3/2012. Destinato ai debitori non consumatori che non possono fallire (piccoli imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, ecc., e anche ex imprenditori fallibili ma non più tali). Funziona in modo simile al concordato preventivo ma semplificato: si presenta un piano, i creditori votano (qui basta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza classi rigide), e il tribunale omologa. Se i creditori non approvano ma il debitore offre almeno il 20% ai chirografari, il giudice può omologare lo stesso (cram-down anche qui). Il concordato minore consente anche la continuità aziendale per salvare piccole imprese. Il correttivo 2024 ha introdotto la soglia del 20% minimo per omologa forzata e ha chiarito che nel concordato minore se c’è apporto di risorse esterne rilevanti si può scendere sotto, analogamente al concordato preventivo ordinario. In generale, è uno strumento calibrato sulle piccole crisi: c’è comunque l’OCC che fa relazione e controlla la procedura (funge un po’ da commissario).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): è l’equivalente del fallimento (liquidazione giudiziale) per i soggetti non fallibili. Viene nominato un liquidatore che vende i beni del debitore (persona fisica o impresa minore), e poi il ricavato è ripartito tra i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Può essere volontaria (il debitore stesso chiede di liquidare tutto per liberarsi dei debiti) o chiesta dai creditori/occ se altre soluzioni non vanno. Al termine della liquidazione, se il debitore è persona fisica, può chiedere l’esdebitazione.
- Esdebitazione: Importante concetto: la liberazione dai debiti residui. Nel vecchio sistema fallimentare, l’imprenditore persona fisica fallito poteva ottenere l’esdebitazione dopo il fallimento (art. 142 L.F.) se aveva cooperato. Nel CCII c’è analoga previsione (art. 278 CCII) per la liquidazione controllata e per il fallimento delle persone fisiche e soci illimitatamente responsabili: il debitore meritevole, che ha soddisfatto almeno parzialmente i creditori con la liquidazione del suo patrimonio, viene liberato dai debiti residui insoddisfatti (tranne quelli espressamente esclusi come alimenti, risarcimenti da illecito extra contrattuale, debiti erariali per sanzioni – questi ultimi in parte, salvo modifiche eventuali). Ma la vera novità è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): se una persona fisica sovraindebitata non ha alcun patrimonio liquidabile (o è irrisorio) e non può offrire niente ai creditori, può comunque chiedere al tribunale di essere esdebitata senza dare nulla, una volta ogni vita, purché dimostri di aver agito con correttezza e di non aver arricchito terzi volontariamente. È una sorta di fresh start puro per i casi di disperazione economica. Il tribunale concede l’esdebitazione di tutti i debiti (tranne alcuni come sanzioni penali e obblighi di mantenimento), tuttavia per i 4 anni successivi se il debitore trova un lavoro redditizio o un’eredità, dovrà pagare i creditori in misura pari alla soddisfazione che avrebbero avuto nella liquidazione (se ad esempio comparisse il 10% di quanto dovuto, quell’importo va destinato ai vecchi creditori).
Applicando queste nozioni al nostro caso: – Se la “azienda radiatori olio” fosse un imprenditore individuale piccolo, e non riesce a risanare l’attività, può tentare un concordato minore per continuare (se i creditori accettano) o direttamente una liquidazione controllata per chiudere l’attività e farsi esdebitare. Ad esempio, Mario Rossi ditta individuale Radiatori con €500k debiti, casa di proprietà: chiede la liquidazione, la casa viene venduta, i creditori prendono il 30% e poi Mario ottiene esdebitazione del restante 70%. Oppure se non ha nulla, potrebbe addirittura ottenere esdebitazione incapiente (quest’ultima però non disponibile per debiti aziendali contratti con colpa grave o frode: c’è un concetto di meritevolezza da valutare). – Se i soci di Radiatori Oli S.n.c. falliscono con la società, dopo la procedura potranno chiedere l’esdebitazione secondo le regole ordinarie (nel fallimento dei soci). – Se l’amministratore di Radiatori Oli S.r.l. aveva prestato fideiussioni personali e la società va in concordato ma lui rimane esposto a banche come privato, lui come persona fisica (non essendo fallibile perché la S.r.l. non comporta il suo fallimento personale) potrebbe ricorrere al piano del consumatore o concordato minore personale se i debiti sono professionali, per sistemare la propria situazione.
In generale, il legislatore ha voluto offrire una soluzione di esdebitazione anche a chi non può accedere al fallimento e concordato, per evitare i cosiddetti “debiti perpetui”. Ciò risponde a esigenze sociali: l’imprenditore onesto ma sfortunato deve avere la chance di ripartire da zero (principio del fresh start, affermato anche in ambito UE).
Strategie pratiche: come muoversi (Simulazioni)
Dopo aver passato in rassegna gli strumenti, proviamo a calarli in situazioni concrete ispirate al caso di una “azienda di radiatori olio” (un’impresa produttiva manifatturiera di dimensioni PMI). Esploreremo alcuni scenari tipo e le possibili scelte dal lato del debitore:
Caso A: S.r.l. in temporanea difficoltà (debiti gestibili con accordi)
Radiatori Oli S.r.l. (società di capitali, 20 dipendenti) subisce un calo di fatturato dovuto all’aumento dei costi energetici. Accumula €150.000 di debiti con fornitori, €100.000 di arretrati IVA e ritenute, e la banca ha segnalato sconfinamenti su un fido di €50.000. L’azienda ha però ordini in ripresa e un buon portafoglio clienti. In questo scenario i debiti, sebbene significativi, non superano il valore dell’attivo e la crisi sembra reversibile. Dal nostro ventaglio di strumenti, la strategia del debitore potrebbe essere: – Attivare immediatamente un confronto con i creditori principali: fornitori e banca. Poiché la situazione è ancora trattabile, magari coinvolgendo un consulente finanziario che redige un mini-piano di rientro, l’azienda può proporre ai fornitori dilazioni di pagamento (es: saldo 50% subito e 50% a 6 mesi) in cambio di assicurazioni di proseguire i rapporti. Contestualmente, chiederà alla banca una moratoria di 6-12 mesi sul rientro del fido (magari aderendo a protocolli ABI se esistenti, o offrendo garanzie aggiuntive). Per i debiti IVA, valuterà la richiesta di rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione (72 rate) per evitare ulteriori sanzioni. Questo approccio rientra nell’ambito stragiudiziale. All’occorrenza, se i creditori fossero titubanti, la S.r.l. potrebbe formalizzare un piano attestato di risanamento per dare loro fiducia: un professionista attesta che con quelle dilazioni e con un modesto aumento di capitale dei soci la crisi si risolve. I creditori vedendo l’attestazione aderiscono. In tal modo, Radiatori Oli S.r.l. evita procedure concorsuali, mantiene la reputazione intatta e in pochi mesi torna regolare nei pagamenti.
Esito atteso: l’azienda esce dalla crisi pagando tutti (seppur in modo dilazionato) – non c’è stralcio, ma solo tempo. I creditori ottengono soddisfazione completa anche se un po’ tardiva (preferibile al rischio di perdere tutto in un fallimento). Il punto chiave è stata la tempestività e la trasparenza del debitore, che ha agito prima di accumulare troppo arretrato, sfruttando strumenti come la rateazione fiscale e la negoziazione privata.
Caso B: S.r.l. in crisi più grave (rischio insolvenza, necessità di riduzione debiti)
Supponiamo che Radiatori Oli S.r.l. abbia indebitamento più pesante: €1,5 milioni con banche (mutui e leasing su impianti), €500.000 di debiti fornitori, €300.000 di debiti fiscali (IVA di due anni, contributi dipendenti non versati) e cassa ormai quasi esaurita. L’azienda però ha un prodotto valido e potrebbe risanarsi se liberata da una parte del debito e se trovasse investitori. In questo scenario, siamo in zona di insolvenza (incapacità di pagare integralmente tutti). Il punto di vista del debitore sarà difensivo ma proattivo: – Una scelta possibile è attivare la composizione negoziata: il titolare si rivolge alla Camera di Commercio e ottiene la nomina di un esperto. Con l’esperto, redige un piano di risanamento che prevede di attirare un socio finanziatore disposto a investire €500.000, vendere un ramo d’azienda non core per €200.000, e usare i fondi per pagare in parte i debiti. Ai creditori si propone questo: le banche convertono metà credito in partecipazioni (diventando socie) e posticipano il rimborso del resto a 7-8 anni; i fornitori accettano un pagamento al 40% del dovuto, ma subito alla conclusione dell’accordo (grazie ai soldi del nuovo investitore); il Fisco accetta una transazione fiscale: stralcio del 50% delle sanzioni/interessi e dilazione del resto. Durante la negoziazione, l’azienda chiede al tribunale misure protettive: le banche non possono nel frattempo revocare i fidi né agire, i fornitori non possono pignorare i macchinari. L’esperto coordina riunioni: dopo trattative, si raggiunge un accordo di massima su questi termini. A questo punto, il debitore può formalizzare un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, raccogliendo le firme delle banche (che detengono, poniamo, il 60% del credito totale) e dei principali fornitori (un altro 20%). Con l’80% di adesioni, presenta l’accordo in tribunale chiedendone l’omologa. I pochi creditori estranei (es. uno fornitore che si è rifiutato e un paio di piccoli creditori) saranno comunque pagati integralmente (sono coperti dal nuovo investitore). Il tribunale omologa l’accordo: Radiatori Oli S.r.l. dimezza il proprio indebitamento (le banche hanno rinunciato a una parte trasformandola in equity, i fornitori han preso 40% liberatorio, l’Erario dilazionato e ridotto) e ottiene nuova finanza per ripartire. In alternativa, se non tutti fosssero saliti a bordo, l’azienda potrebbe optare per un concordato preventivo in continuità con un’offerta simile: dove però impone la falcidia con il voto a maggioranza. Ad esempio se qualche banca non volesse convertire, in concordato potrebbe classe per classe decidere.
Esito atteso: l’impresa continua l’attività depurata da gran parte del debito. I creditori hanno subito decurtazioni ma valutano che in caso di fallimento avrebbero preso molto meno (forse zero). L’accordo omologato garantisce loro almeno una parziale soddisfazione immediata e la prospettiva di mantenere un cliente in vita (specialmente i fornitori possono continuare a vendere prodotti in futuro). Il debitore ha “vinto” difendendosi dall’insolvenza grazie a strumenti legali e a un sacrificio condiviso tra tutte le parti.
Caso C: S.n.c. artigiana fortemente indebitata (liquidazione e debiti personali)
Immaginiamo Radiatori Oli S.n.c. (due soci) che accumula debiti insostenibili e l’attività non è più redditizia. Debiti: €300k banca (garantito da ipoteca su laboratorio di proprietà dei soci), €200k fornitori, €100k fisco. Mercato in declino, macchinari obsoleti. I soci decidono che non c’è modo di risanare e preferiscono cessare. Come difendersi in questo caso? – Essendo una Snc, se la situazione è insolvente, qualunque creditore potrebbe chiedere il fallimento della società e di riflesso dei soci. I soci però possono cercare di pilotare la cosa in modo più vantaggioso: potrebbero presentare essi stessi un concordato preventivo liquidatorio: proponendo di vendere tutti i beni (immobile, macchinari) e distribuire il ricavato, magari offrendo ai chirografari un 20% minimo (sfruttando la casa ipotecata, che però serve prima a pagare banca). Se il concordato appare meno conveniente per i creditori rispetto al fallimento (perché c’è poca differenza), può non passare. Allora altra via: come non fallibili (se magari i parametri li escludono, ma Snc è fallibile di solito), o come persone fisiche post-fallimento, i soci potranno usare il sovraindebitamento. Ad esempio, potrebbero optare per la liquidazione controllata dei loro beni personali e sociali con l’ausilio di un OCC: i beni vengono liquidati, i creditori ricevono qualche pagamento (forse la banca prende quasi tutto dall’immobile, i fornitori poco-nulla). Dopodiché, chiedono l’esdebitazione: i soci persone fisiche, avendo cooperato in buona fede, otterranno la cancellazione dei debiti rimasti . Questo è fondamentale per “difendersi” nel senso di poter ripartire da zero senza debiti a vita. I soci dovranno probabilmente chiudere l’attività, ma potranno cercarsi altro lavoro senza quell’enorme fardello.
Esito atteso: i creditori ipotecari prendono il possibile, i chirografari purtroppo realizzano poco (ma non avrebbero avuto comunque di più da un fallimento); però c’è un risparmio di costi e tempo, magari vendendo l’immobile con calma tramite l’OCC si ottiene miglior prezzo. I debitori-soci perdono i beni ma salvano future entrate. Il fallimento li avrebbe anch’esso spogliati e poi esdebitati, qui hanno usato la procedura adatta alla dimensione per evitare lo stigma del fallimento.
Caso D: Ditta individuale “Radiatori” sommersa dai debiti personali e aziendali
Mario Rossi, artigiano individuale, ha chiuso l’attività Radiatori Oli. Ha debiti verso fornitori €80k, verso banca €50k (fido scoperto con sue garanzie personali ovviamente), verso Agenzia Entrate €30k (tasse non pagate). Non possiede casa, solo un furgone e pochi risparmi. Come difendersi? Egli può rivolgersi all’OCC locale e presentare un piano di ristrutturazione del consumatore o un concordato minore (a seconda se i debiti sono in prevalenza personali o di impresa, qui di impresa: userà concordato minore). Propone ad esempio di pagare €20k totali in 4 anni (rate mensili di circa €400 frutto di un suo nuovo stipendio se trova occupazione, oppure di aiuti familiari), cioè circa il 15% del totale debiti, suddiviso pro-rata tra i creditori, offrendo quindi ai chirografari qualcosa. Siccome 15% è sotto il 20%, avrebbe bisogno di adesione dei creditori o di apporto esterno per arrivare a soglia; se non possibile, opta per la liquidazione controllata: consegna all’OCC il furgone e i risparmi (pochi). I creditori ricevono magari 5% e poi la procedura si chiude. Mario chiede ed ottiene l’esdebitazione del debitore incapiente, dimostrando di essere nullatenente e meritevole (ha chiuso per motivi di salute, ad esempio). In pochi mesi il tribunale cancella i suoi debiti. Mario può così cercare un nuovo impiego senza che stipendio gli venga pignorato per vecchi debiti. Ha “perso” il patrimonio (poco) ma ha salvato sé stesso dall’indebitamento a vita.
Esito atteso: creditori delusi (prendono quasi nulla) ma era l’unica via (un creditore potrebbe opporsi per abuso, ma se Mario è onesto e proprio non ha risorse, il giudice privilegia il fresh start). Questa è la situazione in cui la difesa del debitore è massimamente garantita a scapito però dei creditori – scelta di politica legislativa per dare una seconda chance agli indebitati onesti.
Questi casi evidenziano alcuni principi pratici: – Tempestività: prima l’imprenditore affronta la crisi, più strumenti “morbidi” ha (accordi, composizione negoziata). Aspettare troppo porta a opzioni più drastiche (concordato o fallimento). – Collaborazione: un debitore cooperativo, trasparente con consulenti, OCC e tribunale, avrà maggiore favore (v. esdebitazione concessa se meritevole). Chi tenta di nascondere asset o di fare il furbo rischia preclusioni (diniego di omologa, azioni per bancarotta). – Scelte ponderate: non c’è un one-size-fits-all. Un bravo consulente legale deve consigliare la procedura adatta: ad es. non imporrebbe un costoso concordato a una micro-ditta, né un semplice piano attestato a un’azienda con centinaia di creditori arrabbiati. – Tutele legali: usando le procedure si attivano tutele: ad es. una volta depositato un concordato, i decreti ingiuntivi dei fornitori perdono mordente perché comunque non possono pignorare; depositato un accordo 182-bis, si può sospendere un’asta immobiliare su bene aziendale in extremis. Ciò fa parte del “difendersi” in senso tecnico: se un creditore agisce aggressivamente, il debitore può contrattaccare con lo strumento concorsuale, che congela tutto e costringe il creditore a venire a patti nella sede collettiva.
Domande Frequenti (FAQ)
D: I soci di una S.r.l. rispondono dei debiti aziendali con il proprio patrimonio?
R: No, in linea generale i soci di una S.r.l. o S.p.A. hanno responsabilità limitata: i creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio della società, non su quello personale dei soci. Questo è un vantaggio chiave delle società di capitali. Fanno eccezione poche situazioni: ad esempio, se un socio ha prestato fideiussione personale per un debito della società (molto comune con le banche), allora quel socio/garante è obbligato direttamente verso la banca in caso di insolvenza della società. Un’altra eccezione: i soci di S.r.l. unipersonale che non abbiano versato integralmente il capitale sociale o non abbiano pubblicizzato l’unipersonalità, possono perdere la limitazione di responsabilità sino a concorrenza delle somme non versate. Infine, va citata la possibile azione di responsabilità verso amministratori o soci: se questi hanno tenuto comportamenti illeciti (es. distratto beni, occultato attivo, continuato ad aggravare i debiti in malafede), i creditori insoddisfatti attraverso il curatore fallimentare possono agire per danni contro di loro, ottenendo risarcimenti sul loro patrimonio personale. Ma questa è una responsabilità per atto illecito, non per il debito in sé. In sintesi: se la S.r.l. fallisce, i creditori non possono automaticamente pignorare beni dei soci; se però i soci hanno garantito i debiti o commesso abusi, allora sì, possono subirne le conseguenze.
D: Nella società in nome collettivo (S.n.c.) chi paga i debiti?
R: Nella S.n.c. tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per i debiti sociali. Ciò significa che se la società non paga un debito, i creditori – dopo aver escusso infruttuosamente la società – possono richiedere l’intero importo a qualunque socio, il quale dovrà pagare con i propri beni personali. Quindi, per i creditori è come avere più debitori coobbligati (la società + i soci). Tra soci vale il diritto di regresso: il socio che ha pagato più della sua quota può chiedere agli altri di contribuire. Ma verso il creditore esterno, ognuno risponde per il tutto. Esempio: Radiatori Snc ha due soci, debito €100k. Se la Snc non ha fondi, il creditore può pignorare la casa di uno dei soci per l’intero. Questo regime rende le società di persone rischiose patrimonialmente per i soci. Inoltre, se la S.n.c. viene dichiarata fallita, falliscono in estensione anche i soci illimitatamente responsabili, con conseguente liquidazione dei patrimoni personali. Perciò i soci Snc debitori “si difendono” solo salvando la società o utilizzando procedure di sovraindebitamento/esdebitazione dopo la liquidazione. Da notare: il socio accomandante di una S.a.s. invece ha responsabilità limitata alla quota conferita (se resta nei limiti di legge, cioè non partecipa alla gestione). In una S.a.s. quindi pagheranno i debiti sociali in ultima istanza solo gli accomandatari (come nella Snc), mentre gli accomandanti rischiano al più di perdere il capitale investito.
D: Cos’è la composizione negoziata e come differisce dal concordato preventivo?
R: La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale introdotta nel 2021 per aiutare l’imprenditore in crisi a trovare un accordo con i creditori con l’ausilio di un esperto indipendente. Differisce dal concordato preventivo in vari modi: (a) non c’è spossessamento né intervento diretto del tribunale (se non per eventuali misure protettive e omologa di accordi specifici), (b) è riservata e confidenziale (il pubblico viene a conoscenza solo se si chiedono protezioni via tribunale), (c) non vincola i creditori dissenzienti – l’accordo deve essere raggiunto con il consenso di ciascun creditore coinvolto; se qualcuno non ci sta, resta escluso e può essere pagato a parte o portare all’impossibilità di concludere la negoziazione. Il concordato preventivo invece è una procedura concorsuale giudiziale: prevede il deposito in tribunale di un piano da sottoporre al voto dei creditori e successiva omologazione. Nel concordato la maggioranza approva e diventa vincolante anche per i contrari, con decreto del giudice; nella composizione negoziata nulla può essere imposto, è tutto basato su accordi volontari. Ancora: nel concordato c’è un commissario nominato dal tribunale, nella comp. negoziata c’è un esperto nominato dalla Camera di Commercio che però non gestisce l’azienda, solo facilita. Entrambe le procedure permettono di ottenere una sospensione delle azioni esecutive (nel concordato automaticamente, nella comp. negoziata chiedendo le misure protettive), ma la differenza è che nel concordato la protezione è per arrivare a un esito vincolante a maggioranza (quindi più “forte”), nella comp. negoziata è per dare respiro alle trattative (più “morbida”). In sintesi: la composizione negoziata è una sorta di negoziazione assistita per la crisi d’impresa, flessibile e informale; il concordato è una procedura formale in tribunale con poteri coercitivi ma più onerosa. Spesso si tenta prima la via negoziata e, se fallisce, si ripiega sul concordato (magari “semplificato” se siamo dopo la comp. negoziata fallita).
D: Ho debiti tributari (IVA, tasse) molto alti: posso ridurli con un concordato o devo pagarli per forza al 100%?
R: Fino a qualche anno fa, la regola era che in un concordato il debitore poteva falcidiare l’IVA solo pagando integralmente il capitale (lo vietava il diritto UE), mentre poteva proporre stralci su interessi e sanzioni. Oggi però, grazie alla Direttiva UE 1023/2019 e alle modifiche normative italiane, è possibile includere debiti fiscali e contributivi in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione con trattamento dilazionato o anche parzialmente falcidiato, attraverso lo strumento della transazione fiscale. La transazione fiscale (art. 63 CCII) permette di proporre il pagamento parziale o in forma dilazionata di imposte e contributi, a patto di garantire allo Stato almeno quanto otterrebbe in una liquidazione. In sede di voto, l’Erario si esprime come un creditore (ha diritto di voto se chirografo per la parte falcidiata). Se l’Erario rifiuta la proposta ma la maggioranza dei creditori approva il concordato, il tribunale può ugualmente omologare (cram-down fiscale) dichiarando che il trattamento proposto al Fisco è equo e non inferiore al ricavabile in caso di fallimento. Quindi sì, in un concordato oggi puoi prevedere, ad esempio, di pagare solo il 50% dell’IVA dovuta e in 5 anni, se dimostri che in un fallimento il Fisco prenderebbe meno del 50%. È una grossa novità pro-debitore perché fino al 2020 l’IVA non poteva essere falcidiata affatto (ora lo è, ma serve la procedura concorsuale). Negli accordi di ristrutturazione analogamente si può inserire una transazione fiscale: se l’Agenzia Entrate non firma, il tribunale può omologare lo stesso purché il 60% degli altri crediti sia raggiunto e il Fisco ottenga il “fair value”. Al di fuori di queste procedure, l’unico modo di ridurre debiti fiscali è attendere eventuali definizioni agevolate (rottamazioni) legislative o contenziosi vittoriosi. Ma durante la normale vita, le imposte restano dovute integralmente e si può solo dilazionare (72-120 rate). Dunque il concordato/accordo diventano in pratica l’unico strumento per tagliare strutturalmente il carico fiscale pregresso in ottica di risanamento. Bisogna comunque tener presente che il Fisco ha credito privilegiato per imposte (capitale) quindi in un concordato liquidatorio va pagato almeno in misura pari al realizzo sui beni (che spesso copre una buona parte del capitale). Però, specie nei concordati in continuità, si può offrire di pagare anche meno del 100% del capitale se la liquidazione alternativa darebbe zero (ad es. se l’IVA è priva di garanzie e l’azienda senza concordato fallirebbe, l’Erario in realtà prenderebbe poco come chirografo residuo – su tale base puoi proporre stralcio). Insomma, è complesso ma non è più tabù tagliare debiti fiscali in sede concorsuale.
D: Cosa succede ai contratti in corso se la mia azienda chiede il concordato preventivo? Ad esempio, posso continuare a fornire ai clienti e questi a loro volta sono tenuti a rispettare i contratti?
R: Nel concordato preventivo l’impresa di solito prosegue la gestione sotto vigilanza, specie se è un concordato in continuità. I contratti pendenti (di forniture, appalti, leasing, etc.) non si sciolgono automaticamente. Anzi, la legge vieta ai contraenti di interrompere rapporti essenziali solo perché c’è il concordato (clausole ipso facto). L’azienda in concordato però può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sciogliersi da alcuni contratti onerosi o non più utili (art. 97 CCII), o a sospenderli per un certo periodo, nell’ottica di agevolare il risanamento. Esempio: se aveva un contratto di affitto di ramo d’azienda troppo costoso, può domandare lo scioglimento pagando eventualmente un indennizzo al controparte come credito concorsuale (danno equamente valutato). I contratti essenziali invece (fornitura elettricità, acqua, telecomunicazioni) non possono essere risolti dal fornitore per i mancati pagamenti pre-concordato, se l’azienda continua a pagare il consumo corrente. Il tribunale di Milano ad esempio ha chiarito che anche il DURC irregolare durante la composizione negoziata non legittima la rescissione di appalti pubblici in corso , proprio per tutelare la continuità. Nel concordato, la controparte contrattuale può chiedere garanzie per le forniture future, ma non può tirarsi indietro unilateralmente se il contratto è ancora pendente e l’azienda intende eseguirlo (salvo diverse previsioni contrattuali lecite). Dunque, dal punto di vista del debitore, il concordato offre un quadro protetto: si possono cestinare i contratti sfavorevoli (con autorizzazione, pagando semmai un indennizzo ridotto ai contratti) e mantenere i contratti favorevoli, imponendo ai partner di continuare, almeno finché l’azienda onora le obbligazioni correnti. Ovviamente, ogni caso va analizzato singolarmente: in contratti complessi (es. appalti pubblici) interviene anche la normativa di settore che spesso prevede la possibile risoluzione se l’appaltatore entra in concordato salvo continuità autorizzata. Ma in generale la filosofia del Codice della crisi è dare strumenti per conservare i rapporti profittevoli e liberarsi di quelli dannosi. Questo è distinto dalla liquidazione fallimentare, dove i contratti pendenti si sciolgono di default salvo interesse del curatore a subentrare. Nel concordato c’è più flessibilità: l’imprenditore elabora la strategia contrattuale come parte del piano (indicando quali contratti intende continuare e quali no).
D: La mia azienda ha troppi debiti e penso di chiuderla: se fallisco, poi dovrò comunque pagare i debiti residui in futuro?
R: Dipende se sei una persona fisica o una società. Se a fallire (oggi liquidazione giudiziale) è una società di capitali, la società viene liquidata e poi cessa di esistere: i creditori insoddisfatti non possono più nulla perché il soggetto debitore è estinto. I soci rimangono indenni (salvo versamenti non effettuati o garanzie prestate come detto). Se invece fallisce un imprenditore individuale o una società di persone con soci illimitatamente responsabili, dopo la chiusura del fallimento il debitore fisico rimane teoricamente obbligato per gli eventuali debiti non soddisfatti. Tuttavia, la legge prevede l’esdebitazione: l’imprenditore persona fisica (o i soci illimitati) possono chiedere al tribunale di essere liberati dai debiti residui non pagati nel fallimento . È una sorta di “discharge”: se hanno collaborato e non ci sono circostanze ostative (tipo condanne per bancarotta fraudolenta), il giudice concede l’esdebitazione e quei debiti non possono più essere reclamati sui suoi redditi futuri. Quindi di fatto, dopo il fallimento, il debitore onesto riparte pulito. Nel nuovo CCII l’esdebitazione è quasi di diritto se ricorrono i requisiti, e può ottenersi anche immediatamente nel caso del debitore incapiente senza liquidazione (una volta per persona). Se invece non si chiede o non si ottiene l’esdebitazione, allora sì: i creditori potrebbero sulla carta aggredire futuri redditi. Ma oggi è raro negare l’esdebitazione salvo frodi o gravi scorrettezze. Nel caso di sovraindebitamento (procedura per non fallibili), analogamente dopo la liquidazione controllata si ha l’esdebitazione. Nei concordati preventivi, invece, l’esdebitazione è “interna”: la percentuale non pagata è già giuridicamente cancellata dall’omologa (quindi il debitore concordatario adempiente è già libero residualmente). Riassumendo: il nostro ordinamento tende a non condannare a vita l’ex imprenditore per i debiti passati, purché questi abbia utilizzato correttamente gli strumenti di legge per liquidare ciò che aveva in modo equo. Un caso particolare: se il debitore persona fisica avesse garanti terzi sui suoi debiti, l’esdebitazione libera solo lui, non i garanti (che restano obbligati per intero, salvo anche loro poi chiedano esdebitazione).
D: Quali sono le conseguenze per l’imprenditore (amministratore) che non reagisce alla crisi e lascia aggravare i debiti?
R: Sono potenzialmente molto serie. Sul piano civile, l’amministratore di società che non adotta misure per contenere la crisi può essere ritenuto responsabile verso la società e i creditori. In particolare, all’apertura di un fallimento, il curatore quasi sempre valuta un’azione di responsabilità per mala gestio: se riscontra che i debiti sono aumentati nel periodo in cui l’impresa era già decotta, imputa agli amministratori l’aggravamento del dissesto. La Cassazione ha più volte affermato che anche la semplice omissione di chiedere tempestivamente il fallimento o di interrompere l’attività può costituire colpa grave sufficiente per la responsabilità . Questo può portare a una condanna a risarcire una somma pari al maggior deficit creato. Ad esempio, se l’azienda a un certo punto aveva €100k di patrimonio netto negativo e poi arriva a -€500k perché in 2 anni di inerzia accumula perdite, l’amministratore potrebbe dover risarcire quei €400k di differenza ai creditori. Sul piano penale, l’inerzia può configurare reati fallimentari: l’amministratore che “tira a campare” indebitandosi ulteriormente pur sapendo di essere insolvente, spesso commette fatti come pagare preferenzialmente qualche creditore strategico lasciando indietro altri, oppure tenere la contabilità in modo confuso – tutte condotte che, valutate ex post, integrano la bancarotta semplice (art. 217 L.F., ripreso negli artt. 322-323 CCII) o perfino la bancarotta fraudolenta se c’è dolo di favorire qualcuno o nascondere la situazione. La Cassazione penale ha detto chiaramente: proseguire l’attività aggravando il dissesto rientra nell’elemento materiale della bancarotta impropria da false comunicazioni se accompagnato da bilanci falsati per occultare le perdite . Anche senza falsi, la bancarotta semplice punisce l’imprenditore che ha aggravato la crisi per grave imprudenza. Quindi l’amministratore indolente rischia anche fino a 2 anni di arresto per bancarotta semplice, oltre ad eventuali sanzioni per aver violato l’obbligo di tenere assetti adeguati. Un altro rischio: se non paga stipendi e contributi, incappa in reati tributari (omesso versamento contributi >€10k l’anno è reato) e può subire denunce dai dipendenti per appropriazione indebita di trattenute. Sul piano professionale, poi, la riforma ha introdotto obblighi per l’organo di controllo (sindaci) di segnalare la crisi: la mancata attivazione tempestiva può portare anche a responsabilità del collegio sindacale e del revisore per omissione. In sommo grado, se il dissesto coinvolge interessi pubblici, l’amministratore negligente può essere soggetto ad un divieto di esercitare imprese per qualche tempo (misura interdittiva post-fallimento). Insomma, il messaggio normativo è: meglio cercare una soluzione (concordato, accordo) che nascondere la testa sotto la sabbia. L’imprenditore che attiva i rimedi di composizione mostra di adempiere ai suoi doveri di diligente gestione (2086 c.c.), quindi sarà difficilmente attaccabile su quel fronte. Quello che tarda senza giustificazione plausibile, invece, non solo peggiora la situazione ma espone sé stesso a queste conseguenze legali. Quindi la “difesa” migliore è prevenire: monitorare costantemente la propria situazione economica e muoversi ai primi segnali di insolvenza incipiente (per questo la legge parla di “anticipata emersione della crisi”).
D: I debiti con fornitori e banche sono cancellati dal concordato anche se i creditori votano contro?
R: Sì, se il concordato viene comunque approvato a maggioranza e omologato, tutti i crediti anteriori restano vincolati dalle condizioni del concordato. Anche i creditori che non hanno approvato (o addirittura non si sono presentati al voto) sono obbligati dagli effetti del concordato omologato (art. 114 CCII, ex art. 184 L.F.). Ciò significa che la parte di debito chirografario che non sarà pagata secondo il piano concordatario viene giuridicamente cancellata, e il creditore non potrà più pretenderla. Ad esempio: banca Alfa aveva credito €100k chirografario, non vota a favore del concordato (magari vota contro), ma il concordato passa lo stesso perché la maggioranza di altri crediti c’è. Il piano approvato prevede di pagare ai chirografari il 30%. Una volta omologato, la banca Alfa ha diritto solo a €30k e li riceverà come previsto. Il residuo €70k è estinto: la banca deve rinunciarvi contabilmente, non può agire verso garanti? (se c’era un fideiussore estraneo, lui rimane obbligato; ma verso il debitore principale, finisce lì). Nel concordato minore per sovraindebitati vale simile regola: se omologato (anche senza voto unanime, essendoci il cram-down minorile) i creditori sono obbligati al piano. Quindi sì, il concordato esdebità il debitore per la quota falcidiata dei debiti chirografari, indifferentemente dal consenso individuale di ciascun creditore dissenziente. L’unico limite: i crediti privilegiati se non soddisfatti integralmente non si estinguono per la parte eccedente? In realtà, in concordato anche il privilegio se c’è falcidia viene meno per la parte non pagata, perché la legge subordina quell’importo al pagamento integrale dei chirografari (art. 112 CCII) e se non viene pagato, rimane insoddisfatto ma non azionabile, salvo la condizione di miglior fortuna a volte prevista. Spiegazione: un creditore privilegiato se accetta una percentuale minore (o gliela impongono col voto), la parte di credito che supera quanto ottenuto degrada a chirografo. Se quel chirografo non è pagato (perché ai chirografari si dava 0 o 10%), lui formalmente conserva un credito residuo chirografario che dopo il concordato però è come se fosse cancellato (non può agire post omologa perché il debito è concorsuale ed è stato trattato come da piano). Ci sono alcune eccezioni: crediti erariali per sanzioni pecuniarie, multe etc., se non pagati integralmente non si estinguono (restano esclusi dall’esdebitazione concorsuale per legge), ma sono casi limitati. In generale, il concordato una volta omologato è vincolante erga omnes e produce effetti novativi sui debiti: li ridetermina secondo il piano e li estingue per la parte eccedente. Questo ovviamente è possibile perché la procedura concorsuale è collettiva e approvata a maggioranza. Non succede invece con un accordo fuori concorso: se un creditore non aderisce a un accordo stragiudiziale, mantiene integro il suo diritto. Ecco perché se serve imporre perdite a qualcuno, bisogna passare dal concordato (o dall’accordo omologato col meccanismo ad efficacia estesa).
D: In conclusione, quali consigli per un imprenditore debitore in crisi?
R: Riassumendo i punti di vista di questa guida in forma di consigli: – Non isolarsi né negare la realtà: Appena emergono segnali di stress finanziario (ritardi pagamenti, casse vuote), analizzare la situazione con lucidità. Se necessario, farsi aiutare da un professionista per valutare la profondità della crisi. – Comunicare con i creditori: Il silenzio alimenta sfiducia e azioni aggressive. Meglio affrontare i discorsi difficili: proporre piani di rientro, spiegare le cause dei ritardi. Spesso i creditori preferiscono una transazione ragionevole che dover agire legalmente incerto. – Sfruttare gli strumenti bonari: Rateizzazioni fiscali, moratorie bancarie (se disponibili), rinegoziazioni. Queste soluzioni “private” sono meno costose e meno traumatiche. – Monitorare la meritevolezza: Chi vuole difendersi efficacemente deve mantenere la credibilità: evitare atti in frode (vendere beni a parenti a 1 euro – poi verrà revocato e peggiora la posizione), evitare di preferire un creditore a scapito di altri in extremis (può essere revocato e genera cause). Meglio agire sotto il perimetro di una procedura che rende tutto più ordinato. – Usare le procedure al momento giusto: Se la crisi è seria e generalizzata, non esitare a utilizzare la composizione negoziata o, se necessario, il concordato. Rinviarli peggiora la recovery. Anche considerare l’accordo di ristrutturazione come ottimo compromesso se hai banche disponibili. Se sei troppo piccolo per il concordato, ricorri per tempo all’OCC per un concordato minore o piano del consumatore: la procedura non è infamante, anzi ti tutela (ad es. sospende interessi, blocca pignoramenti). – Proteggere la continuità se c’è valore: Se l’azienda ha prospettive (un prodotto valido, know-how, avviamento), vale la pena tentare procedure di continuità (comp. negoziata, concordato in continuità). Liquidare precipitosamente può distruggere quel valore di avviamento lasciando tutti più poveri. Vedi il caso Cassazione 2025: il tribunale ha preferito evitare il sequestro di beni in un’azienda che stava provando a risanarsi, proprio per non comprometterne la continuità. – Accettare la liquidazione se inevitabile: Se invece il business è senza futuro, prolungare l’agonia brucia solo cassa che magari poteva andare ai creditori. In tal caso, meglio optare per una liquidazione ordinata (un concordato liquidatorio o liquidazione controllata) e puntare all’esdebitazione. Inutile accumulare altri debiti (tasse, contributi) se sai che comunque dovrai chiudere. Meglio staccare la spina con dignità e ripartire pulito, che trascinarsi finendo magari anche in guai penali.
– Consiglio legale esperto: Le normative di crisi d’impresa sono complesse e in evoluzione. Un avvocato specializzato o un commercialista esperto di crisi sono essenziali per usare al meglio questi strumenti. Difendersi significa anche conoscere i propri diritti nella procedura: ad esempio, saper che si può chiedere la sospensione di un pignoramento presentando un ricorso di concordato, o che l’apertura di una composizione negoziata impedisce al PM di chiedere d’ufficio il fallimento. Queste finezze fanno differenza tra subire passivamente gli eventi e prendere il controllo attivo della situazione.
D: Quali sono le fonti normative principali che disciplinano questi argomenti, per approfondire?
R: La materia è vasta, ma i riferimenti chiave includono: il Codice Civile (art. 2086 c.c. sul dovere di assetti adeguati; art. 2446-2447 c.c. su riduzione capitale; art. 2476 c.c. su responsabilità amministratori Srl; art. 2257 e segg. per Snc; art. 2304 c.c. sul beneficio di escussione soci Snc); il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, 83/2022, 136/2024), che disciplina composizione negoziata (art. 12 e segg.), concordato preventivo (artt. 84 e segg.), accordi di ristrutturazione (artt. 57 e segg.), procedure di sovraindebitamento (artt. 65 e segg.), liquidazione giudiziale (artt. 121 e segg.), ecc. Sul fronte fiscale, il D.P.R. 602/1973 (art. 19 su rateazioni, art. 48 su fermo amministrativo), e il D.Lgs. 74/2000 per reati tributari. Importanti anche le sentenze: la Cassazione n. 118/2020 e n. 8500/2021 (S.U.) sulla responsabilità degli amministratori per tardiva richiesta liquidazione; Cass. pen. sez. V n. 9958/2023 su aggravamento dissesto come bancarotta impropria ; Cass. pen. n. 33042/2022 (sulla punibilità omesso versamento IVA e concordato preventivo); Cass. civ. n. 29742/2019 (sulla prededucibilità di crediti in composizione negoziata, se applicabile analogia con pre-concordato); Tribunale di Milano 2022 su contratti energetici essenziali in comp. negoziata (DURC). In fondo a questa guida troverai un elenco di fonti e riferimenti precisi, incluse circolari e linee guida ministeriali (ad es. la Circolare Mise sulla piattaforma composizione negoziata, le Linee guida OCC per sovraindebitamento). Un’ultima notazione: essendo la normativa in continuo aggiornamento (specie con il recepimento della direttiva UE e i correttivi del 2024), è opportuno verificare eventuali modifiche intervenute nel 2025-2026 in fase di consultazione delle fonti.
Fonti e Riferimenti Normativi
- Codice Civile, art. 2086 comma 2 – Dovere di assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e perdita continuità (introdotto dall’art. 375 D.lgs. 14/2019).
- Codice Civile, art. 2251, 2267, 2291 e 2304 – Responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle società di persone; beneficio di escussione preventiva sul patrimonio sociale.
- Codice Civile, art. 2462 – Regime di responsabilità limitata nelle S.r.l. (estensione al socio unico in caso di mancata effettiva liberazione dei conferimenti o omessa pubblicità).
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza – CCII), in vigore dal 15/07/2022, e successive modifiche (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 169/2020 cd. “correttivo bis”, D.Lgs. 136/2024 “terzo correttivo”). Disposizioni rilevanti:
- Artt. 12-25-quinquies CCII – Composizione negoziata della crisi: presupposti, nomina esperto, misure protettive (art. 18: sospensione azioni esecutive), facilitazioni contrattuali (divieto contratti ipso facto, ecc.), concordato semplificato (art. 25-sexies). Introdotti dal D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, integrati nel CCII dal 15/11/2021; correttivo 2024 ha inciso su transazione fiscale in comp. negoziata e obblighi segnalazione.
- Artt. 57-64 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti: percentuale di adesione minima (60%), esenzione da revocatoria per atti eseguiti in accordo omologato (art. 59), transazione fiscale (art. 63) con cram-down (L. 159/2020, art. 3, co.1, convertito Decreto Ristori), accordi agevolati (art. 60-bis, introdotto da D.Lgs. 83/2022) e ad efficacia estesa (art. 61).
- Artt. 84-120 CCII – Concordato preventivo: requisiti (stato di crisi o insolvenza), finalità (continuità vs liquidazione), contenuto del piano (art. 87), classi e trattamento creditori (obbligo classi per garantiti, art. 85; pagamento min. 20% chirografi in liquidatorio salvo risorse esterne; priorità assoluta salvo deroghe consenso), voto (maggioranze art. 109), omologazione anche in caso di classi dissenzienti (cram-down art. 112).
- Art. 94 CCII – Concordato con riserva (in bianco): possibilità di presentare ricorso prenotativo con documenti minimi e termine fino a 60+60 giorni per presentare piano definitivo, misure protettive nel frattempo.
- Art. 97 CCII – Scioglimento o sospensione di contratti pendenti nel concordato su autorizzazione del Tribunale (salvo contratti di lavoro).
- Artt. 63 e 88 CCII – Transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione: possibilità di falcidie e dilazioni tributi e contributi, con necessità di attestazione convenienza e voto espresso della PA creditrice. Legge 159/2020 ha introdotto comma su cram-down fiscale (ora trasfuso).
- Art. 115 CCII (già art. 186-bis L.F.) – Concordato in continuità: definizione e disciplina particolare (mantenimento contratti pendenti, pagamento debiti privilegiati anche oltre un anno se autorizzato, salvaguardia livelli occupazionali, ecc.).
- Artt. 121-270 CCII – Liquidazione giudiziale (fallimento): soggetti assoggettabili (art. 121 rimanda a requisiti imprenditore commerciale non piccolo analoghi art. 1 L.F., soglie ricavi 200k, attivo 300k, debiti 500k; esclusi imprenditori sotto soglia e agricoli), iniziativa (possibile istanza anche d’ufficio da Pubblico Ministero, art. 38; nel correttivo 2024 specificato non obbligo se pendenza comp. negoziata), effetti personali (sospensione amministratori, divieto azioni individuali creditori art. 150), ecc.
- Artt. 277-281 CCII – Esdebitazione del debitore fallito: condizioni per persona fisica, estensione a soci illimitati, preclusioni (es. condanne penali gravi, mancata collaborazione, atti in frode) ; debiti esclusi (alimentari, risarcimenti da fatto illecito, multe).
- Artt. 282-283 CCII – Esdebitazione del debitore incapiente: possibilità, una volta ogni 4 anni, per persona fisica sovraindebitata meritevole che non abbia nessun patrimonio da liquidare, di ottenere cancellazione integrale debiti senza pagamento. Obbligo di pagamento sopravvenienze rilevanti entro 4 anni dalla concessione pena revoca. (Introdotto dal D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020).
- Artt. 65-73 CCII – Disposizioni generali procedure da sovraindebitamento (definizione sovraindebitato, requisiti meritevolezza, ruolo Organismo Composizione Crisi – OCC).
- Art. 67 CCII – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: requisiti (persona fisica, debiti prevalentemente estranei attività imprenditoriale), meritevolezza (no colpa grave, dolo, frode), approvazione senza voto creditori (decisione rimessa a giudice su convenienza e sostenibilità).
- Art. 74-83 CCII – Concordato minore: soggetti (debitore sovraindebitato escluso consumatore), contenuto proposta (può prevedere continuità o liquidazione), classi non obbligatorie salvo garantiti, maggioranza voti richiesta (50% crediti), omologa anche in mancanza di voto unanime se rispettata soglia soddisfacimento minimo creditori (20%). Correttivo 2024 (D.Lgs 136/2024) ha modificato art. 74 sui requisiti risorse esterne e classamento.
- Art. 268-277 CCII – Liquidazione controllata del sovraindebitato: disciplina analoga liquidazione giudiziale ma semplificata, nomina liquidatore da parte tribunale, partecipazione OCC. Previsione richiamo art. 144 TUB per beni impignorabili e crediti alimentari. Sentenza Corte Cost. 15/2022 ha reso incostituzionale art. 14-quinquies L.3/2012 per esclusione debitore incapiente, poi integrato nel CCII.
- D.L. 118/2021 convertito con modifiche dalla L. 147/2021 – Introduzione urgente della Composizione Negoziata e misure collegate (posticipazione allerta). Relazione Illustrativa ministeriale (settembre 2021) spiega ratio: strumento volontario confidenziale vs regime allerta obbligatorio rinviato.
- Decreto Dirigenziale Mise 28 settembre 2021 – Istituzione piattaforma telematica composizionenegoziata.camcom.it e checklist auto-diagnosi azienda (art. 13 CCII).
- Linee Guida del CNDCEC (Cons. Naz. Dott. Commercialisti) sulla Composizione Negoziata (ottobre 2021, aggiorn. 2022): forniscono indicazioni operative per esperti e imprese (es. come predisporre piano, gestione incontri).
- Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 30109 del 09/07/2025 (dep. 02/09/2025) – Ha affermato principio di diritto: la pendenza di una procedura di composizione negoziata con misure protettive in corso, supportata da un piano attestato dall’esperto e iniziali riscontri positivi, può escludere il periculum in mora necessario per convalidare un sequestro preventivo penale sui beni dell’impresa. Confermato annullamento di un sequestro disposto per reati tributari, in quanto l’impresa in comp. negoziata stava seguendo un percorso di risanamento tale da assicurare la conservazione del patrimonio a garanzia dei creditori. (Fonte: Cass. pen. sez. III – massima: “la composizione negoziata attivata in modo serio e con misure protettive riduce il pericolo di dispersione dei beni, legittimando la non applicazione del sequestro”).
- Tribunale di Modena, ordinanza riesame 2025 (richiamata in Cass. 30109/2025) – Ha ritenuto insussistente periculum in mora e annullato sequestro di €500k su conti di società in composizione negoziata ben avviata.
- Cassazione Penale, sez. V, sent. n. 9958 del 09/03/2023 – In tema di bancarotta impropria ex art. 223 co.2 n.1 L.F., ha sancito che non solo la causazione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto tramite condotte gestionali dolosamente dissimulate (esposizione in bilancio di dati falsi per occultare perdite e continuare l’attività) costituisce l’evento del reato . Nella specie, amministratore che aveva nascosto perdite ed aggravato dissesto condannato. (Fonte: Unijuris massima ).
- Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16411 del 04/08/2016 – (principio consolidato, richiamato anche in Cass. SS.UU. 2019 n. 34447) – Responsabilità ex art. 2486 c.c.: il liquidatore o amministratore che ritarda il fallimento risponde delle perdite incrementali. Occorre valutazione comparativa patrimonio netto alla data in cui doveva cessare attività vs data effettiva, la differenza è danno risarcibile.
- Corte Costituzionale, sent. n. 18 del 24/01/2022 – Ha dichiarato illegittimo art. 14-quinquies L.3/2012 nella parte in cui non consentiva esdebitazione del sovraindebitato persona fisica incapiente che abbia adempiuto con correttezza (ha anticipato norma CCII art. 283).
- Unione Europea – Direttiva (UE) 2019/1023 del 20/06/2019 – Ristrutturazione preventiva e insolvenza: stabilisce principi di early warning, protezioni temporanee, facilitazioni per ristrutturazioni (fresh start per imprenditore onesto entro 3 anni). Recepita in Italia col CCII e D.Lgs. 83/2022.
- Agenzia Entrate-Riscossione – Sito ufficiale, sezione Rateizzazione (agg. 2025): spiega nuove soglie introdotte da riforma riscossione (D.Lgs. 119/2022 e D.Lgs. 110/2024 attuativi PNRR) – fino €120.000 senza documenti 72-84 rate, oltre con prova difficoltà fino 120 rate. (V. anche Circolare MEF 19/2023 su attuazione estensione piani rate).
- Legge 3/2012 (abrogata dal CCII ma rilevante per casi pre-2022) – Disciplina vecchie procedure sovraindebitamento: accordo composizione, piano consumatore, liquidazione patrimonio. Cita perché giurisprudenza precedente (es. meritevolezza, interpretazioni) resta utile. Ad es. Tribunale di Udine ord. 29/12/2020 sollevò questione costituzionale su esclusione esdebitazione incapiente poi accolta da Corte Cost..
- Massimario Cassazione Civile 2022 – Varie massime su concordato: Cass. SS.UU. n. 8500/2021 (azione di responsabilità contro amministratori in concordato, potere del commissario di esercitarla), Cass. n. 33852/2022 (su prededuzione crediti fornitori post omologa concordato in continuità), Cass. n. 9231/2022 (su riparto a creditori privilegiati degradati in concordato).
- Documentazione Ministero della Giustizia: Relazioni illustrative ai decreti correttivi CCII (Relazione D.Lgs. 83/2022 e Relazione D.Lgs. 136/2024) – evidenziano: introduzione “segnalazioni anticipata emersione” (art. 25-octies CCII, nuove soglie: debiti >€100k ditte individuali, >€200k società di persone, >€500k società capitali) con obbligo avviso al debitore e organo controllo; miglioramenti transazione fiscale (remissione parziale IVA ammessa subordinatamente a direttiva).
- CNDCEC, “Linee guida OCC” ed. 2023 – prassi su istruttoria meritevolezza piano consumatore, parametri reddito disponibile, ecc.
Accertamento Fiscale a Azienda di Radiatori a Olio con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come Agire Subito
La tua azienda che produce o commercializza radiatori a olio ha ricevuto un accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza?
Hai debiti tributari, cartelle esattoriali, richieste di chiarimenti su fatture, magazzino, componentistica, costi di produzione, sicurezza, test di qualità o movimenti bancari?
👉 Il settore termotecnico ed elettrico è considerato ad alto rischio fiscale per margini variabili, costi energetici elevati, importazioni frequenti e controlli serrati sulla produzione.
Ma puoi difenderti e proteggere l’azienda se agisci con un piano preciso.
In questa guida scoprirai cosa fare immediatamente, quali errori evitare e come costruire una difesa vincente con un avvocato specializzato in accertamenti fiscali e crisi d’impresa.
💥 Perché le Aziende che Producono o Vendono Radiatori a Olio Sono Sotto Accertamento
Le autorità fiscali controllano attentamente questo settore per diversi motivi:
- costi di produzione elevati e spesso contestati;
- acquisto di componenti elettriche e meccaniche dall’estero;
- differenze tra carichi di magazzino e prodotti finiti;
- subforniture o assemblaggi esterni non documentati correttamente;
- margini variabili considerati “antieconomici”;
- fatture emesse verso privati difficili da verificare;
- pagamenti misti (bonifici/contanti) considerati irregolari;
- movimentazioni bancarie considerate incoerenti con i ricavi dichiarati.
📌 Molti accertamenti derivano da errori nelle ricostruzioni o da semplici presunzioni del Fisco.
⚠️ I Rischi per una Azienda di Radiatori a Olio con Debiti
Se non intervieni subito rischi:
🧾 avvisi di accertamento con imposte e sanzioni molto elevate;
🏦 pignoramento dei conti aziendali;
🚚 fermo amministrativo dei mezzi utilizzati per distribuzione e trasporto;
🧱 ipoteche su capannoni, terreni o magazzini;
⚖️ ulteriori controlli su fornitori e componentistica;
📉 perdita di affidabilità verso banche, fornitori e grandi clienti;
🔥 blocchi alla produzione o difficoltà nel reperimento dei materiali.
📌 Un accertamento non gestito può mettere in crisi catena produttiva, vendite e consegne in pochi giorni.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ NON rispondere da solo all’Agenzia delle Entrate
Ogni parola, documento o dato consegnato senza strategia può peggiorare la situazione.
📌 Prima di agire serve una valutazione tecnica e legale.
2️⃣ Far analizzare l’accertamento da un avvocato specializzato
L’avvocato verifica:
- vizi di notifica;
- decadenza dei termini dell’accertamento;
- errori nella ricostruzione di magazzino;
- contestazioni infondate sui costi dei componenti;
- ricostruzioni induttive eccessive o illegittime;
- presunzioni fiscali non supportate da documenti;
- irregolarità nei controlli bancari.
📌 Una grande parte degli accertamenti è illegittima e può essere annullata.
3️⃣ Presentare Memorie Difensive o Attivare il Contraddittorio
In questa fase è possibile:
- documentare correttamente costi e cicli di produzione;
- spiegare variazioni di magazzino e componentistica;
- giustificare assemblaggi, test qualità e subforniture;
- correggere errori dell’Agenzia delle Entrate;
- evitare l’emissione dell’avviso definitivo.
📌 Una difesa solida può bloccare tutto prima dell’avviso definitivo.
4️⃣ Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni)
Il ricorso consente di ottenere:
- sospensione immediata dell’accertamento;
- annullamento totale/parziale delle imposte;
- cancellazione delle sanzioni;
- blocco di pignoramenti, fermi e ipoteche.
📌 In situazioni urgenti, il giudice può sospendere tutto in 48 ore.
5️⃣ Contestare gli Accertamenti Bancari
Il Fisco può considerare:
- versamenti → ricavi in nero
- prelievi → costi non giustificati
- bonifici → forniture non fatturate
Ma la giurisprudenza conferma:
📌 Non tutto ciò che transita nei conti è reddito: occorre dimostrare finalità e tracciabilità.
6️⃣ Ristrutturare i Debiti se una parte risulta reale
Se dopo la difesa emergono importi dovuti, puoi:
- rateizzare fino a 120 rate;
- utilizzare rottamazioni e definizioni agevolate;
- richiedere saldo e stralcio;
- attivare procedure di crisi d’impresa (PRO, ristrutturazione, concordato minore).
📌 Prima di pagare bisogna verificare la legittimità dell’accertamento.
🧩 Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Avviso di accertamento o PVC
- Estratto di ruolo (se ci sono cartelle)
- Inventari, carichi di magazzino e prodotti finiti
- Distinte base dei radiatori a olio
- Fatture di acquisto e vendita
- Contratti con fornitori esteri o nazionali
- Documentazione sui test di qualità e certificazioni
- Estratti conto bancari aziendali
- DDT, bolle e documenti di trasporto
- Documentazione su manodopera interna ed esterna
⏱️ Tempistiche
- Analisi dell’atto: 24–72 ore
- Sospensione cautelare: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Durata del giudizio: 6–18 mesi
📌 La sospensione può bloccare immediatamente la riscossione.
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata
✔️ Riduzione o annullamento dell’accertamento
✔️ Blocco immediato di pignoramenti, ipoteche e fermi
✔️ Contestazione delle ricostruzioni su magazzino e componenti
✔️ Protezione di macchinari, capannoni e beni aziendali
✔️ Difesa contro contestazioni su forniture, assemblaggi e test qualità
✔️ Tutela del patrimonio dell’amministratore e della società
🚫 Errori da Evitare
❌ Rispondere da soli al Fisco
❌ Consegnare documenti senza una strategia difensiva
❌ Ignorare l’accertamento sperando si risolva da sé
❌ Superare i 60 giorni del ricorso
❌ Affidarsi a consulenti non esperti in contenzioso tributario
📌 Un singolo errore può costare decine di migliaia di euro.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analisi completa dell’accertamento
📌 Individuazione dei punti attaccabili
✍️ Memorie difensive e ricorsi efficaci
⚖️ Rappresentanza davanti alla Corte Tributaria
🔁 Trattative per definizioni agevolate e rateizzazioni
🛡️ Tutela totale dell’azienda e dell’amministratore
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in accertamenti fiscali
✔️ Specialista nella difesa di aziende termotecniche, elettriche e produttive
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia Entrate e Guardia di Finanza
Conclusione
Un accertamento fiscale alla tua azienda di radiatori a olio non significa pagare tutto ciò che il Fisco richiede.
Con una difesa immediata puoi:
- bloccare l’accertamento,
- contestare ricostruzioni errate,
- ridurre drasticamente i debiti,
- proteggere magazzino, macchinari e patrimonio aziendale.
⏱️ Agisci ora: il tempo è fondamentale.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
La difesa della tua azienda può iniziare subito.