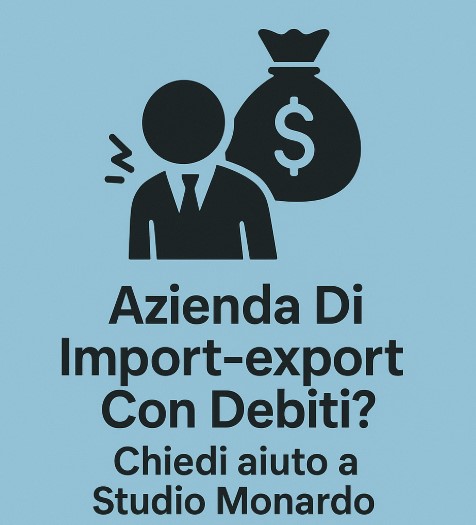Gestire un’azienda di import-export significa affrontare sfide continue: dogane, dazi, IVA all’importazione, pagamenti anticipati ai fornitori esteri, ritardi nei pagamenti dei clienti, oscillazioni dei costi di trasporto e rischio cambio.
Per questo le imprese del settore sono tra le più esposte ad accumulare debiti fiscali, bancari, doganali e commerciali, oltre a cartelle esattoriali difficili da sostenere.
La buona notizia è che puoi difenderti subito, bloccare la riscossione e ristrutturare i debiti grazie a una strategia legale mirata. Un avvocato tributarista esperto in imprese internazionali può aiutarti a risolvere la situazione in tempi rapidi e in modo sicuro.
Perché un’azienda di import-export arriva ai debiti
Nel settore import-export le criticità finanziarie nascono quasi sempre da dinamiche esterne all’azienda:
ritardi nei pagamenti da parte di clienti stranieri
costi doganali imprevisti o mal calcolati
IVA all’importazione anticipata e difficile da recuperare
fluttuazioni dei prezzi dei container e dei trasporti
ritardi nelle consegne che bloccano gli incassi
dazi, accise e tributi gestiti in modo complesso
revoca degli affidamenti bancari
cartelle esattoriali accumulate negli anni
Una sola operazione contestata dalle dogane o un ritardo di pagamento può creare un effetto domino pericoloso per la liquidità aziendale.
Cosa fare subito per difenderti e bloccare i danni
Il primo obiettivo è impedire pignoramenti, fermi o blocchi operativi.
Ecco cosa fare immediatamente:
far esaminare tutte le cartelle, avvisi e atti da un avvocato
verificare la presenza di cartelle prescritte o irregolari
richiedere la sospensione della riscossione per bloccare pignoramenti
mettere al sicuro beni, conti aziendali e merci in transito
non trattare direttamente con Agenzia delle Entrate o Dogane senza assistenza legale
controllare eventuali contestazioni doganali non ancora definite
Una reazione tempestiva può evitare danni enormi.
Le soluzioni legali più efficaci per un’azienda di import-export indebitata
A seconda della posizione, un avvocato può attivare diverse strategie:
rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 120 rate
saldo e stralcio dei debiti con banche o fornitori esteri
composizione negoziata della crisi, che blocca tutti i creditori
impugnazione di cartelle, accertamenti fiscali e atti doganali
opposizione a pignoramenti, fermi e ipoteche
rinegoziazione dei finanziamenti, fidi e anticipo export
contestazione delle rettifiche doganali errate
procedure di sovraindebitamento per ditte individuali o piccole imprese
Il settore doganale è complesso e spesso pieno di errori: molte richieste di pagamento non sono dovute.
Quando i debiti possono essere ridotti o cancellati
Un controllo legale accurato permette spesso di eliminare una quota importante dei debiti. È possibile annullare o ridurre le somme quando:
le cartelle sono prescritte
le notifiche non sono state fatte correttamente
le Dogane hanno commesso errori nelle rettifiche
ci sono calcoli sbagliati su IVA all’importazione, dazi o accise
le banche hanno applicato interessi illegittimi
l’Agenzia delle Entrate ha usato dati incompleti o non attendibili
i debiti sono stati ceduti a società di recupero senza documenti
Molte richieste italiane ed europee vengono annullate perché prive di fondamento.
Le strategie difensive migliori per proteggere l’azienda
Per una realtà di import-export, è fondamentale proteggere liquidità, merci e flussi internazionali. Ecco le azioni più efficaci:
contestare subito gli atti viziati
bloccare i pignoramenti dei conti e dei crediti esteri
evitare fermi amministrativi su mezzi e container
impugnare rettifiche doganali errate
richiedere la sospensione della riscossione durante il ricorso
negoziare con banche e fornitori per evitare blocchi delle spedizioni
attivare una ristrutturazione del debito prima che l’azienda perda operatività
Agire rapidamente è essenziale per non bloccare le operazioni internazionali.
Perché affidarsi a un avvocato specializzato
Un avvocato tributarista con esperienza in aziende internazionali può:
analizzare cartelle, accertamenti fiscali e atti doganali
bloccare rapidamente esecuzioni e fermi
impugnare richieste illegittime
proteggere beni, merci e conti bancari
negoziare saldo e stralcio o rateizzazioni sostenibili
dialogare con Dogane, Agenzia delle Entrate e banche
costruire un piano per riportare l’azienda in equilibrio
Senza una difesa competente, il rischio è di perdere merci, clienti o crediti all’estero.
Cosa succede se non agisci
Ignorare la situazione può portare a conseguenze molto pesanti:
pignoramento dei conti aziendali
fermo dei mezzi e blocco delle spedizioni
sequestro di merci da parte delle Dogane
revoca dei fidi bancari e impossibilità di anticipare le fatture
interruzione delle forniture internazionali
perdita di clienti e reputazione
rischio concreto di chiusura dell’azienda
Agire subito significa mettere al riparo l’attività e recuperare controllo e liquidità.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti farlo se:
sei in difficoltà con IVA all’importazione, dazi o accise
hai ricevuto cartelle, accertamenti o rettifiche doganali
temi un blocco dei conti o delle merci
le banche stanno chiedendo rientri immediati
vuoi ristrutturare i debiti e salvare l’azienda
Un avvocato esperto può:
impugnare gli atti
ottenere la sospensione della riscossione
ridurre o cancellare il debito
proteggere merci, mezzi, conti e operatività
trattare con creditori e autorità
Attenzione: molte aziende di import-export pagano debiti non dovuti o subiscono blocchi doganali evitabili. Una difesa competente può salvare merce, liquidità e rapporti commerciali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, doganale e crisi d’impresa ti spiega cosa fare subito per proteggere la tua azienda.
👉 Hai un’azienda di import-export con debiti o cartelle esattoriali?
Richiedi adesso una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare la riscossione, ridurre i debiti e mettere al sicuro la tua attività.
Introduzione
Un’azienda che opera nell’import-export può accumulare vari tipi di debiti – fiscali, doganali, bancari, verso fornitori o contributivi – che mettono a rischio la propria continuità. In caso di squilibrio economico-finanziario o insolvenza, è fondamentale che l’impresa agisca tempestivamente: ignorare le richieste di pagamento può portare a pignoramenti, ipoteche o addirittura confisca delle merci, nonché alla perdita di licenze e operatività. Fortunatamente l’ordinamento italiano prevede strumenti sia stragiudiziali (es. composizione negoziata, piani di risanamento stragiudiziali) sia giudiziali (concordato preventivo, liquidazione) per risolvere la crisi aziendale.
Questa guida approfondisce tutte le strade praticabili dal punto di vista del debitore, illustrando normative e orientamenti giurisprudenziali recenti, corredati da tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di FAQ (domande e risposte). L’approccio è giuridico-divulgativo e ad elevato dettaglio, rivolto ad avvocati, imprenditori e professionisti, con particolare attenzione alle novità legislative più recenti (es. D.Lgs. 136/2024, L.197/2022, riforma della crisi) e alle più autorevoli sentenze (es. Cass. n.27782/2024, Cass. ord. n.18185/2025, Corte Cost. n.93/2025).
1. Contesto normativo e definizioni preliminari
In Italia, l’impresa in difficoltà è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, aggiornato con il correttivo-ter D.Lgs. 136/2024). Il CCII definisce l’impresa in crisi come quella che risulta “squilibrata” (rapporto negativo tra esposizioni e disponibilità) o con prospettiva di insolvenza, e l’impresa insolvente come quella che non è più in grado di onorare regolarmente le obbligazioni. Le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) godono di autonomia patrimoniale perfetta: i creditori sociali possono rivalersi soltanto sul patrimonio della società e, in linea di principio, non sui beni personali dei soci (ai sensi dell’art. 2740 c.c.). Ciò significa che, di norma, il socio non risponde delle passività sociali se non nel limite del capitale conferito; la funzione del capitale sociale è proprio quella di costituire una garanzia per i creditori. Tuttavia, gli amministratori hanno l’obbligo di sorvegliare lo stato di salute della società e di adottare tempestivamente misure di ristrutturazione in caso di perdite significative (artt. 2446, 2447 c.c. per S.p.A.; art. 2482-bis, 2482-ter c.c. per S.r.l.). In caso di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge, gli amministratori devono convocare l’assemblea per la ricostituzione, pena la scioglimento della società.
Debito fiscale, contributivo o bancario? Le obbligazioni verso Fisco (imposte, I.V.A., dazi doganali), Enti previdenziali (INPS, INAIL) e istituti di credito presentano peculiarità e tutele diverse, descritte più avanti. In ogni caso, la nascita del debito avviene normalmente per mancati o ritardati versamenti (dichiarazioni fiscali, pagamenti contributivi, rate di finanziamento) o per contenziosi accertativi che confluiscono in riscossione coattiva. Va distinto tra Agenzia delle Entrate, che accerta le imposte, e Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), che incassa le somme non versate. Per i tributi doganali esistono procedure analoghe gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (oggi ADM).
Obbligo di allerta: Ai sensi degli artt. 379-380 CCII, amministratori e sindaci hanno l’onere di segnalare gli squilibri economici-finanziari alle autorità (Registro Imprese) nel momento in cui emergono i presupposti di crisi, pena responsabilità civile e penale in caso di tardiva o mancata attivazione delle procedure di risanamento. In sintesi, il legislatore italiano incentiva la gestione precoce della crisi e prevede strumenti per salvare l’impresa o massimizzare il soddisfacimento dei creditori, sempre con attenzione alla continuità aziendale.
2. Tipologie di debiti e rischi specifici
Un’azienda di import-export può accumulare debiti di natura diversa. Qui analizziamo i principali, dal punto di vista del debitore, con indicazione dei rischi immediati e degli strumenti di gestione più comuni.
2.1 Debiti fiscali (imposte e I.V.A.)
- Origine del debito: L’impresa può trovarsi indebitata con il Fisco per IRPEF/IRES, IRAP, addizionali, IVA non versata o dazi doganali non pagati all’importazione. Il mancato versamento entro i termini di legge genera automaticamente un credito d’imposta iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Anche le sanzioni tributarie (ad esempio il 30% per mancato versamento) e gli interessi di mora aumentano il debito. In caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (controlli formali o sostanziali), la mancata impugnazione del provvedimento nel termine di 60 giorni determina l’iscrizione a ruolo del debito contestato. Di regola, Agenzia delle Entrate e Riscossione seguono le cartelle esattoriali con un preavviso di 60 giorni di pagamento, trascorsi i quali sono possibili misure esecutive.
- Rischi immediati: Se l’impresa non paga il debito tributario entro i termini (o non impugna gli atti entro 60 giorni), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può eseguire subito attività coattive: iscrivere ipoteche su beni immobili aziendali, pignorare i conti correnti, i crediti verso terzi (pignoramento presso terzi), i mezzi aziendali, e in casi estremi disporre il fermo amministrativo o la confisca delle merci doganali in giacenza. La Corte Costituzionale, con sent. n.93/2025, ha recentemente ribadito che l’IVA all’importazione non è un “diritto di confine” equiparabile ai dazi, ed ha escluso l’applicabilità della confisca delle merci se l’operatore provvede a saldare l’IVA dovuta e la sanzione. In sostanza, il Fisco non può confiscare le merci se il debito (IVA+accessori) viene pagato: applicare la confisca oltre alla sanzione, infatti, violerebbe il principio di proporzionalità. Resta però il rischio di ingiunzioni esecutive fino al saldo del debito residuo (la Cassazione n.18185/2025 ha confermato che gli atti doganali non subiscono nullità per carenza di firma del funzionario, art.42 DPR 600/1973 non si estende ai tributi doganali).
- Possibili soluzioni: Subito dopo la notifica degli atti tributari, il debitore può attivare vari strumenti. Innanzitutto conviene verificare la legittimità delle pretese: un avvocato specializzato può impugnare avvisi di accertamento o cartelle palesemente illegittimi. Se il debito è dovuto, l’impresa può negoziare pagamenti rateali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ad esempio, la legge prevede fino a 72 rate (6 anni) per importi fiscali fino a €120.000 (per debiti derivanti da dichiarazioni o atti rescindibili in autotutela). Negli ultimi anni sono state inoltre varate «rottamazioni» (definizioni agevolate) per saldare i carichi erariali accumulati senza sanzioni o con sconti sugli interessi. Ad esempio, la L.197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha reintrodotto una definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”) che riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2020. Anche la transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione (art.63 CCII) consente di proporre un pagamento dilazionato o parziale di tributi e contributi fino alla data di domanda, negoziandolo con le agenzie fiscali o previdenziali. In sostanza, anche un debito erariale può essere incluso in un piano di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, e come chiarito dalla Cassazione (sent. 27782/2024), il tribunale può omologare un piano concordatario anche se l’Amministrazione finanziaria ha espresso voto contrario (“cram-down fiscale”) . Ciò rende possibile, sotto certi presupposti, l’omologazione di un concordato “forzato” nonostante il dissenso del Fisco.
- Aspetti doganali e IVA intra-UE: Per le merci importate da paesi extra-UE, oltre all’IVA può sorgere un debito di dazi. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Dogane può procedere al sequestro o confisca delle merci secondo il Testo Unico Doganale. Come detto, la Corte Cost. 3 luglio 2025 n.93 ha stabilito che se l’Iva doganale viene pagata integrale, non può essere disposta anche la confisca. Inoltre, il Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) all’art.124 stabilisce che la confisca della merce estingue l’obbligazione doganale, il che non avviene però per l’IVA import, contrariamente a quanto avviene per i dazi. In definitiva, dal punto di vista del debitore: regolarizzare subito i pagamenti doganali scongiura il rischio di confisca. Quanto all’IVA intra-UE, occorre distinguere: per le cessioni intracomunitarie di beni effettuate a condizioni corrette (fatturazione con numero di partita IVA UE valido) l’Iva è “non imponibile” in uscita e l’acquirente UE assolve l’imposta nel proprio Paese. Tuttavia, errori nella documentazione o nella scelta del regime (reverse charge) possono generare contestazioni, da gestire anch’esse tramite ricorsi fiscali o strumenti di ristrutturazione.
2.2 Debiti contributivi (INPS, INAIL, ecc.)
- Origine del debito: L’impresa di import-export ha dipendenti e collaboratori? Allora deve versare puntualmente i contributi previdenziali e assistenziali (INPS), oltre alle assicurazioni obbligatorie (INAIL). Il mancato versamento delle ritenute IRPEF dei dipendenti o dei contributi INPS (per es. versamenti trimestrali) genera crediti contributivi iscritti a ruolo. AdER (ex Equitalia) è incaricata anche della riscossione dei contributi insoluti e delle eventuali sanzioni e interessi.
- Rischi immediati: I debiti contributivi sono equiparati ai debiti tributari in termini di azioni esecutive. L’INPS può iscrivere ipoteche su immobili aziendali o rivolgersi alle banche per pignorare crediti. Anche le ritenute IRPEF non versate possono tradursi in ruoli di riscossione. In un concordato preventivo, i crediti previdenziali godono di uno status particolarmente protetto: la normativa (art. 278 cod. fall. e art. 88 CCII) dà il privilegio sui beni ceduti o sulle azioni societarie, superiore a quello dei debiti chirografari. Ciò significa che, in un fallimento o liquidazione, l’INPS verrà soddisfatto prima dei fornitori comuni. Tuttavia, in pendenza di composizione della crisi, l’amministrazione previdenziale può comunque opporsi a piani di ristrutturazione che ritenga non idonei a garantirle un trattamento equo (anche se come detto, il tribunale può impiegare il cram-down ).
- Possibili soluzioni: Analogamente ai tributi, i contributi insoluti possono essere oggetto di transazione nell’accordo di ristrutturazione (art.63 CCII, che annovera sia tributi che contributi). Inoltre, l’adozione di una procedura di crisi (ad esempio concordato preventivo) sospende le azioni esecutive e consente di rinegoziare tutti i debiti, ivi compresi quelli previdenziali. In assenza di procedure concorsuali, è spesso possibile concordare una rateizzazione straordinaria con l’INPS (fino a 120 rate, 10 anni) per saldare il pregresso, anche sulla base di protocolli INPS-Governo (es. Legge 92/2012, art. 10). In ogni caso, l’INPS è tenuto a valutare in buona fede le proposte di dilazione e per legge non può agire coattivamente durante lo svolgimento di una composizione della crisi (v. art. 17 CCII).
2.3 Debiti bancari e finanziari
- Origine del debito: Le banche finanziatrici possono essere fonte di debito per fidi, mutui, leasing, linee di credito rotative, bond e altre obbligazioni. In attività di import-export, si usano spesso aperture di credito (crediti a scadenza per importazioni) o sconto di effetti (cambiali). Le scadenze dei finanziamenti vanno gestite con diligenza per evitare insolvenze.
- Rischi immediati: In caso di mancato pagamento delle rate bancarie, la banca può accelerare le linee di credito e richiedere immediatamente il rimborso. Può iniettare protesti bancari (cambiali insolute), costringendo la società all’immediato pagamento di tutta la scadenza in anticipo. In presenza di garanzie (ipoteca immobiliare, pegno, fideiussioni), la banca può avviare pignoramenti su immobili o beni aziendali, nonché escutere le fideiussioni dei soci. Inoltre, in caso di intervento in un concordato o in procedure concorsuali, i rapporti bancari acquisiscono la qualifica di credito privilegiato (secondo il tipo di garanzia).
- Possibili soluzioni: In fase di crisi, le banche possono essere negoziate come gli altri creditori. L’impresa può chiedere una ristrutturazione del debito bancario: ad esempio, la modifica delle scadenze, la proroga del piano di ammortamento o la riduzione degli interessi (in genere solo in accordo stragiudiziale). Spesso è richiesto un piano industriale o una nuova garanzia per ottenere nuove erogazioni. Nei casi più gravi, la procedura di concordato preventivo permette di includere i debiti bancari in un piano di ristrutturazione complessivo. Ad esempio, se l’azienda propone di corrispondere un importo inferiore e dilazionato rispetto al valore nominale del debito bancario, i creditori privati (banche incluse) si considerano ristrutturati. Come visto, il tribunale può forzare l’accordo in deroga al dissenso delle banche (cram-down) se la proposta è meglio dell’alternativa liquidatoria . Gli accordi di ristrutturazione ex art.57 CCII (c.d. stralci bancari) possono invece essere utilizzati per pattuire novazioni contrattuali con le banche al di fuori del concordato (ma richiedono l’omologazione del tribunale e il consenso delle classi di creditori). In sintesi, il debitore bancario dispone di strumenti negoziali (compresi il nuovo Accordo ABI per le PMI o il piano di rientro ABI-ABI) per rinegoziare in via volontaria, e – se del caso – di strumenti concorsuali per ottenere, anche coattivamente, l’adeguamento del debito.
2.4 Debiti verso fornitori
- Origine del debito: I fornitori di merci, servizi o materie prime diventano creditori dell’impresa per i beni consegnati o le prestazioni rese. Gli import-export devono spesso acquistare beni o servizi senza pagare immediatamente, generando un rapporto creditizio commerciale (tipicamente 30/60/90 giorni).
- Rischi immediati: I fornitori insoddisfatti possono interrompere le forniture o intraprendere azioni legali per ottenere pagamenti (decreto ingiuntivo). Tuttavia, l’impresa gode del principio della par condicio creditorum solo se si apre una procedura concorsuale: senza concordato o fallimento, i fornitori più solleciti potrebbero ottenere sentenza e pignoramenti anche parziali. Spesso la pressione dei fornitori è altissima: bloccare forniture essenziali può fermare l’attività produttiva.
- Possibili soluzioni: Il debitore può cercare la solidarietà dei fornitori negoziando dilazioni o sconti (per esempio compromessi stragiudiziali, clausole risolutive non immediate). In fase di crisi conclamata, i fornitori possono essere formalmente compresi nel piano di ristrutturazione del concordato o della composizione negoziata. Nel concordato, i creditori fallimentari (fra cui i fornitori) approvano la proposta con una maggioranza di cui alla legge: almeno il 60% in valore dei crediti ammessi e due terzi in valore dei crediti non privilegiati . Se l’accordo è omologato, anche i fornitori dissenzienti sono vincolati. Va comunque tenuto presente che i creditori privilegiati (erario, INPS, dipendenti) vanno soddisfatti prima; i fornitori rientrano tra i creditori chirografari. Può convenire all’impresa compensare debiti e crediti commerciali con partner affidabili, oppure cedere i crediti in sofferenza a società di factoring per migliorare la liquidità.
2.5 Debiti doganali e IVA intra-UE (aspetti transfrontalieri)
- Dogane (dazi e IVA import): L’import/export comporta l’interazione con le procedure doganali. Se l’azienda importa merci extra-UE, deve versare dazi all’importazione (doganali) e l’IVA doganale. Il mancato pagamento di tali dazi e IVA può portare all’applicazione di sanzioni penali/doganali (contrabbando) e all’esecuzione di confisca. Tuttavia, come detto, la Giurisprudenza più recente limita tali rischi per chi regolarizzi il debito: la Cassazione penale ha già affermato che un atto imputabile al “rappresentante doganale” non può avere conseguenze sul committente (il c.d. trasporto merce pulito, v. Cass. sez. V, 30/1/2020 n.2139), e la Consulta (sent. n.93/2025) ha escluso la confisca se l’imposta doganale è stata saldata. È comunque vitale tenersi regolari nelle dichiarazioni doganali e comunicare con l’operatore doganale per evitare contestazioni. La Cassazione (ordinanza n.18185/2025) ha chiarito che nelle procedure doganali gli atti impositivi non vengono annullati per un mero difetto di sottoscrizione (non si applica per analogia l’art.42 del DPR 600/1973 sulle nullità tributaria); in pratica, la validità formale della notifica doganale rimane presunta.
- I.V.A. intra-UE: Il commercio con i Paesi UE è regolato dal sistema dell’IVA intra-comunitaria. In uscita, la cessione intracomunitaria di beni è esente da IVA (reverse charge) purché si siano rispettate le regole formali (fattura senza IVA, annotazioni, possesso del numero di partita IVA del cliente UE). Se l’impresa omette le comunicazioni o fattura con IVA erroneamente, rischia accertamenti che possono generare debiti d’imposta. In entrata, l’acquisto intracomunitario (con fattura senza IVA) genera un debito IVA da autofatturare secondo il meccanismo della inversione contabile. Tali debiti IVA intracomunitari non implicano confisca di merci, ma l’azienda resta responsabile del versamento (magari rateale o transattivo in sede di concordato). Va segnalato che la Corte di Cassazione (Sez. Trib., ord. 21/7/2023) si era già occupata del rapporto IVA-import tra esportatore italiano e dogane, rimettendo la questione alle Sezioni Unite; e la Corte Costituzionale, come detto, ha sottolineato che l’IVA all’importazione deve essere trattata secondo la natura di imposta indiretta, non come un dazio doganale. In sintesi: l’azienda estero-esportatrice deve prestare massima attenzione alla corretta applicazione dell’IVA intracomunitaria per evitare recuperi coattivi; ma se inserisce i debiti IVA in un piano di ristrutturazione, le stesse regole della transazione fiscale CCII (art.63) valgono anche per l’IVA, sia essa nazionale o all’import.
2.6 Altri debiti (contributivi, leasing, ecc.)
Oltre a quelli sopra, vanno considerati anche i debiti verso enti pubblici (ad es. multe, IVA d’ufficio, accertamenti su IRES) e i debiti contrattuali (es. leasing di beni strumentali per l’export, affitti di capannoni). Anche questi crediti possono essere inclusi in negoziazioni o procedure concorsuali. Ad esempio, le multe doganali amministrative possono essere rinegoziate in sede di composizione della crisi, oppure contestate con ricorsi tributari. In generale, ogni obbligazione esigibile dell’impresa deve essere valutata caso per caso con l’aiuto di un professionista.
<div style=”page-break-after: always;”></div>
3. Strumenti di gestione e composizione della crisi
Quando l’azienda è in stato di crisi o di insolvenza, il debitore ha a disposizione diversi strumenti normativi per ristrutturare l’esposizione debitoria, dilazionare i pagamenti o concordare modifiche contrattuali. Questi strumenti si distinguono in stragiudiziali (volontari, extra-giudizio) e giudiziali (con ricorso al tribunale). La scelta dipende dalla gravità della crisi, dalle esigenze di riservatezza e rapidità, e dalla volontà di ottenere protezioni legali (consolidamento del debito, blocco dei pignoramenti, ecc.).
3.1 Strumenti stragiudiziali (negoziazione e piani autonomi)
- Composizione negoziata della crisi: Introdotta dal D.L. 118/2021 (ora art. 10-25 ter CCII), è un processo volontario gestito dal Sistema Camerale che aiuta l’imprenditore in grave squilibrio a definire una soluzione concertata con i creditori. L’iter coinvolge un “esperto indipendente” (iscritto agli albi camerali) che assiste l’impresa e i creditori nelle trattative. La composizione negoziata è caratterizzata da alcune misure di protezione automatiche: dall’accesso all’istanza sospende gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale e le cause di scioglimento (art.17 CCII), inoltre il debitore conserva i poteri gestori. Ad oggi (nov. 2024) l’osservatorio Unioncamere segnala che su 1.860 istanze presentate, circa il 59% (1.097) è stato archiviato, di cui il 19% con esito favorevole, cioè con accordi sottoscritti tra debito e creditori. In pratica, in media una composizione su cinque ottiene un’intesa risanante (tasso di successo ~20,5%). Le trattative possono sfociare in diverse forme di accordo: transazioni finanziarie con credito di terzi, rinegoziazioni parziali di debiti (art. 23 CCII), prospetti di piano, o addirittura in una richiesta di concordato preventivo con riserva. Se la composizione negoziata fallisce, nulla impedisce all’impresa di ricorrere successivamente al tribunale (concordato o altro). Per il debitore è uno strumento utile perché garantisce confidenzialità (non è pubblicato un piano), rapidità e permette di approcciare creditori pubblici (fisco, INPS) senza i formalismi di un giudizio, negoziando condizioni di pagamento realistiche. Tuttavia richiede che gli organi sociali individuino un esperto iscritto e attivino l’iter tramite la piattaforma camerale. L’accesso alla composizione negoziata non impedisce per legge l’avvio di altre procedure, ma le misure cautelari (art.17) ne scoraggiano l’aggressione da parte dei creditori (es. si abbassano gli oneri del debitore).
- Piano attestato di risanamento: In base all’art. 56 CCII, il debitore in crisi può redigere un piano di risanamento sottoposto all’attestazione di un professionista indipendente. Questo strumento permette all’impresa di presentare autonomamente (senza intervento del tribunale) un programma dettagliato di ristrutturazione del debito, corredato da una relazione di un esperto che ne attesti la fattibilità economica e la veridicità dei dati. Il piano attestato contiene elementi simili al piano di concordato (illustrazione causa della crisi, lista dei creditori, strategie di intervento, piano industriale). Pur non essendo di per sé vincolante per i creditori, il piano attestato funge da base negoziale: i creditori possono aderire agli accordi (favorendo il contratto di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt.57-61 CCII) oppure l’assenza di adesione può legittimare l’impresa a rivolgersi al tribunale. Il grande vantaggio di questo strumento è la riservatezza (non è un atto pubblico) e la possibilità di preservare l’autonomia gestionale senza costi procedurali elevati. Molti istituti di credito richiedono un piano attestato in casi di ristrutturazione bilaterale. Importante è che il professionista certificatore controlli anche che il trattamento dei creditori (fiscali, previdenziali e gli altri) sia “non deteriorativo” rispetto alla liquidazione fallimentare; questo requisito serve a tutelare i creditori in caso di successive procedure concorsuali.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: Se l’impresa ha debiti complessivi notevoli, può ricorrere a un accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57-58 CCII, eredi dell’art.182-bis l.fall.). In sostanza, il debitore negozia con le categorie di creditori (fisco, banche, fornitori, altri) un accordo che preveda modifiche contrattuali (dilazioni, sconti, conversione di debito in equity). L’accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% in valore dei crediti ammessi e due terzi di quelli non garantiti . Se il giudice ritenesse che l’accordo sia più conveniente rispetto a un’ipotetica liquidazione e il quorum di credito è raggiunto, può omologare l’intesa, rendendola vincolante anche per i dissenzienti (“effetto cram-down” generale). In particolare, ai sensi dell’art. 180 l.fall. (attuativo anche oggi nel CCII), è possibile forzare l’omologazione anche senza l’accordo di un ente pubblico dissenziente . Questi accordi – utili specie in assenza di soluzioni consensuali complete – devono essere depositati in Tribunale e sottoposti a verifica di affidabilità da parte del tribunale stesso (che può bloccare l’esecuzione di pignoramenti nel frattempo).
- Strumenti di distresso finanziario: Oltre a quanto sopra, esistono meccanismi più semplici. Ad esempio la conciliazione bancaria (accordi ABI) o la ristrutturazione del debito presso Associazioni di categoria, che sono modalità bonarie per discutere con gli istituti. In alcuni casi specifici, accordi di settore possono prevedere facilitazioni per pagamenti contributivi o fiscali in via amministrativa.
3.2 Strumenti giudiziali (procedimenti giudiziali di crisi)
- Concordato preventivo: È la procedura giudiziaria ordinaria di ristrutturazione/risanamento (ex art. 50 ss. CCII). Si articola in due fasi principali: presentazione della domanda con ricorso al Tribunale competente (di solito quello della sede legale, art.63 CCII), e omologazione della proposta. Il concordato può prevedere la continuazione dell’attività (conservativa/ in continuità) o la liquidazione del patrimonio (liquidatorio). Nella versione in continuità, l’imprenditore progetta di perseguire la gestione aziendale e prevede risorse nuove per il risanamento, continuando l’attività (ad es. sfruttando nuova finanza esterna, cessione di asset non strategici, ecc.). Nel concordato liquidatorio, l’azienda cessa l’attività e il tribunale nomina un liquidatore per vendere i beni. In entrambi i casi, la proposta di concordato deve essere approvata dai creditori: servono la maggioranza in valore di ciascuna classe (crediti privilegiati, chirografari, etc.) come stabilito dagli artt. 109-110 CCII. Il tribunale convalida il concordato (omologa) se la ristrutturazione è più conveniente rispetto all’alternativa fallimentare, tenendo conto anche del giudizio di un commissario giudiziale nominato (se del caso).
Il concordato dispone effetti forti in favore del debitore: dall’apertura del procedimento tutti i creditori (pubblici e privati) subiscono il divieto di nuove azioni esecutive (possono continuare solo quelle già iscritte a ruolo), e l’impresa può pagare solo quanto previsto dal piano senza subire pignoramenti collettivi (c.d. “cram-down” del giudice, come visto). Inoltre, l’eventuale ritardo nel versamento delle rate concordatarie non porta di regola alla denuncia di reato (ex art. 194 CCII, se pagate entro 6 mesi dalla scadenza con interessi). Tuttavia, lo svantaggio di questa procedura è l’iter lungo (decine di mesi), i costi giudiziali e il controllo dell’organo giudiziario e del commissario che vigilano sulla correttezza del piano. In casi di concordato «in bianco» (senza allegato piano iniziale) è possibile ottenere termini brevi (massimo 90 giorni) per depositare il progetto.
- Concordato semplificato post-composizione: Il CCII ha previsto specifiche norme (art. 25 sexies e segg.) per passare dalla composizione negoziata al concordato. Se l’impresa ha avviato la composizione negoziata ma non ha raggiunto un accordo, può trasformare quella procedura in un concordato semplificato: il medesimo esperto che seguiva la composizione diventa commissario liquidatore, e si procede a liquidare i beni con modalità accelerate, vincolando anche i creditori dissentanti come in un concordato normale. Questo permette di avviare una liquidazione organizzata in continuità (cioè vendendo l’azienda come complesso aziendale anziché frazionare i singoli beni) senza dover ricominciare da capo.
- Liquidazione giudiziale (fallimento): Se le altre soluzioni falliscono o il debitore è già in evidente insolvenza, l’ultimo sbocco è la liquidazione giudiziale (ex art. 33 CCII, corrispondente al vecchio fallimento). Qui il tribunale dichiara cessata l’attività e procede alla liquidazione coatta del patrimonio sociale. Un curatore nominato ripartisce il ricavato tra i creditori secondo le quote di legge (prima i privilegi, poi i chirografari). Dal punto di vista del debitore, è l’ipotesi da evitare in ogni caso, perché implica la perdita di controllo (l’organo di amministrazione viene sostituito dal curatore) e quasi sempre la fine dell’attività. Tabelle riepilogative sulla struttura del concordato sono riportate in seguito.
- Procedura di allerta e accordi protettivi: Il CCII (Titolo III) prevede strumenti di allerta (obblighi di segnalazione in banca dati, studio redditività, ecc.) che possono far emergere anticipatamente la crisi. In aggiunta, il tribunale può concedere misure protettive cautelari su domanda del debitore o dei creditori: ad esempio iscrivere ipoteche giudiziali sospensive (che bloccano le azioni esecutive), oppure anticipare all’avvio del concordato la destinazione di un bilancio (art. 38 CCII).
4. Strategie pratiche e consigli
Nell’affrontare una crisi aziendale, l’imprenditore deve innanzitutto analizzare le cause della difficoltà: calo di fatturato, marginalità insufficiente, crisi di un cliente estero, eventi avversi (pandemia, sanzioni), e determinare se esistono margini di ripresa con interventi mirati. In seconda battuta, è necessario coordinare finanza e piano d’azione: redigere un budget aggiornato, tagliare i costi non strategici, cercare nuovi finanziatori o partnership. Spesso conviene attivare subito un professionista (avvocato fallimentare o commercialista) che possa valutare la fattibilità di soluzioni concorsuali o transazioni.
È fondamentale portare “in bonis” i debiti nei limiti del possibile: ad esempio, aderire alle rateizzazioni tributarie (anche dilazioni di 10 anni per contributi) e cercare di negoziare piani di rientro con le banche prima di aggravare la posizione. Se l’azienda ha scadenze fiscali imminenti, può valutare di fare subito una domanda di definizione agevolata (rottamazione) entro la deadline stabilita da legge.
Esempio pratico (simulazione): Immaginiamo una S.r.l. di spedizioni marittime con fatturato annuo di €2M, in grave ritardo sui pagamenti di €100k all’Agenzia delle Entrate (IVA import), €150k verso banche (mutuo e scoperti), €50k di contributi previdenziali, e €50k verso fornitori. L’impresa può innanzitutto chiedere proroghe all’INPS e rateizzare i debiti contributivi (fino a 120 rate), e valutare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la possibilità di aderire alla rottamazione-quater per saldare l’IVA rimasta con sanzioni ridotte. Contemporaneamente, gli amministratori potrebbero preparare una richiesta di accesso alla composizione negoziata presso la Camera di Commercio competente, individuando un esperto specializzato in crisi d’impresa. Nel frattempo, potrebbero negoziare con la banca una sospensione del piano di ammortamento o un consolidamento dei fidi, presentando eventuali garanzie aggiuntive. Se la composizione negoziata dovesse andare avanti, l’esperto potrebbe aiutare a redigere un piano di risanamento dell’impresa: magari vendendo un ramo non strategico o coinvolgendo un nuovo socio per iniettare liquidità. Se il credito della banca viene riammesso al 60% e quello del Fisco al 40% con dilazione in 5 anni, si potrebbe raggiungere un’intesa. Se invece la composizione fallisce, l’impresa potrebbe convertire l’istanza in un concordato semplificato per liquidazione, garantendo comunque ai creditori un piano di riparto pluriennale.
In ogni strategia, occorre ricordare che la regia dev’essere sempre del debitore: spetta cioè agli organi amministrativi della società valutare le possibili opzioni (in assemblea o con il consiglio dei soci), deliberarle e attuarle, supportati da consulenti. Ad esempio, per accedere al concordato è necessario un verbale di assemblea straordinaria che approvi la domanda (art. 43 CCII). Gli amministratori devono altresì verificare il corretto aggiornamento contabile (es. bilancio infrannuale) e redigere eventuali relazioni sulla continuità aziendale. In caso di sforamento del capitale, va inoltre costituita apposita riserva o reintegrato il capitale (ma il Codice della crisi sospende tali obblighi in attesa di soluzione, art. 15 CCII).
5. Tabelle riepilogative
- Tabella 1. Differenze tra S.r.l. e S.p.A. (nel contesto della crisi aziendale):
| Caratteristica | Società a responsabilità limitata (S.r.l.) | Società per azioni (S.p.A.) |
|---|---|---|
| Capitale sociale minimo | Anche €1 (neopatentata, ma raccomandato > €10k) | €50.000 (con sottoscrizione integrale versata) |
| Responsabilità soci | Limitata al conferimento (autonomia perfetta) | Limitata al conferimento (autonomia perfetta) |
| Organi sociali | Assemblea soci; amministratore unico o consiglio; sindaci facoltativi | Assemblea soci; consiglio di amministrazione (o consiglio unico) e sindaci obbligatori |
| Transferabilità partecipazioni | Più rigida, spesso mediante atto notarile | Libera, con circolazione di azioni |
| Quote societarie vs azioni | Quote (diritti socio proporzionali ai conferimenti) | Azioni (quote nominali/divisibili, allineate al capitale) |
| Gestione della crisi | Medesime procedure CCII; S.r.l. semplificata può costituire un “patrimonio destinato” | Medesime procedure CCII e formalità più stringenti (es. convocazioni assemblee) |
| Scioglimento per perdita | Il capitale non può scendere oltre 1/3 senza ricapitalizzare (art. 2482-bis c.c.) | Simile disciplina (art. 2446-2447 c.c. e 2482-bis c.c.) |
| Liquidazione giudiziale | Gli amministratori versano residuale (art. 2484 c.c.) | Viceversa; diritti dei soci anteriori tutelati (art. 2484-ter c.c.) |
- Tabella 2. Strumenti di composizione della crisi:
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche principali | Effetti principali |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Qualunque impresa in crisi (anche in esposizione grave) | Istituto volontario (D.L.118/2021). Esperto nominato dalle Camere di Commercio assiste debitore e creditori; uso riservato dei dati. | Non sospende le azioni esecutive, ma prevede misure protettive (art.17 CCII: es. sospensione obblighi statutarî). Risolvere senza tribunale; esito non garantito (tasso di successo ~20%). |
| Piano attestato di risanamento | Qualunque impresa in crisi o insolvenza | L’impresa redige un piano (art.56 CCII) certificato da professionista indipendente. Strumento stragiudiziale. | Permette di negoziare transazioni con creditori (anche fisco/INPS) mostrando convenienza rispetto a liquidazione. No efficacia vincolante senza accordi. |
| Accordi di ristrutturazione (art.57 CCII) | Imprese in crisi con debiti rilevanti | Trattative con le classi di creditori su riduzioni/dilazioni di debito; accordo privato sottoposto a omologazione del tribunale con quorum (60% valore e 2/3 creditori non privilegiati) . | Omologa giudiziale rende vincolanti anche i dissenzienti (forse con “cram-down”). Sospende esecuzioni solo dopo l’omologa. |
| Concordato preventivo (art.43 ss. CCII) | Imprese in stato di insolvenza o crisi profonda | Domanda al Tribunale con piano di continuità o liquidazione. Necessita di deliberazione assembleare e deposito di piani. Prevede omologazione se maggioranze crediti valide (artt.109-110 CCII). | Sospende tutte le esecuzioni (art. 52 CCII). Blocca pignoramenti e insolvenze penali se pagamenti dilazionati. Permette cram-down pubblico . Attuazione lunga (anni), ma vincola tutti i creditori. |
| Concordato semplificato | Imprese in crisi coinvolte in composizione | Liquidazione “accelerata” dopo trattativa negoziata fallita (art.25-sexies CCII). | Permette liquidazione in continuità (vendita azienda) con vincolo dei creditori partecipanti. Alcuni obblighi procedure semplificati. |
| Liquidazione giudiziale | Imprese manifestamente insolventi | Procedimento “ultima ratio”: nomina di un liquidatore/curatore. Valuta crediti e patrimonio con occhio giudiziario (previlegi di legge). | Mette fine all’attività, soddisfa i creditori secondo l’ordine di legge (privilegi e chirografari). Rischio fallimento pieno. |
- Tabella 3. Debiti comuni e opzioni del debitore (esempi):
| Tipo di debito | Principali rischi e azioni creditori | Opzioni di tutela del debitore |
|---|---|---|
| Tributi diretti (IRPEF, IRES, IRAP) | Cartelle esattoriali, riscossione coattiva, ipoteche, pignoramenti. | Verifica legittimità (ricorsi), rateizzazioni (fino a 72 rate se accessibile), definizioni agevolate (rottamazioni), inclusione in piani di concordato (transazione fiscale) . |
| IVA e dazi all’import | Iscrizione a ruolo, sequestro/confisca merci. | Regolarizzazione immediata dell’imposta e della sanzione (niente confisca, Corte Cost. 93/2025), definizioni agevolate, transazione fiscale o concordato con cram-down per differenze residue. |
| Contributi INPS/INAIL | Iscrizioni a ruolo, ipoteche, fermo auto aziendale. | Proroghe e rateizzazioni agevolate INPS (fino a 120 rate), conciliazioni, inclusione in concordato (privilegio garantito, transazione contributiva). |
| Fornitori commerciali | Sospensione forniture, decreto ingiuntivo, azioni esecutive. | Rinegoziazione volontaria, dilazione dei termini, piani industriali (costi prioritizzati), accordo di ristrutturazione con classi di creditori. |
| Banca / finanziarie | Protesti cambiali, revoca linee di credito, pignoramenti/ipoteche. | Proposte di ristrutturazione del debito, rifinanziamento, Accordo ABI, piano di concordato con cram-down bancario . |
| Altri debiti (es. mutui soci, leasing) | Imposizione di garanzie aggiuntive, azioni giudiziali degli enti. | Valutazione insieme ad altri debiti in un piano globale; in concordato possono essere riscritti; in casi, cessione del contratto (leasing) con obbligo di comunicazione. |
<div style=”page-break-after: always;”></div>
6. Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa devo fare appena ricevo una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
R: È essenziale non ignorarla. Innanzitutto, verificare con un consulente la correttezza formale e sostanziale del ruolo. Se il debito è legittimo, si possono immediatamente attivare misure di tutela: impugnare in autotutela o ricorso (se vi sono vizi), chiedere una dilazione del pagamento (pagamento rateale o accesso alla definizione agevolata previgente, come la “rottamazione”). Se vi è un ampio ritardo fiscale, valutare parallelamente la strategia di composizione della crisi: per esempio, in un concordato preventivo i debiti fiscali possono essere inclusi e potenzialmente ridotti o dilazionati mediante i meccanismi di transazione fiscale. Ricordiamo che, come afferma la Cassazione (sent. 27782/2024), il tribunale può omologare un concordato anche contro il dissenso espresso del fisco, rendendo legittimo il cosiddetto cram-down fiscale .
D: In quali casi conviene la composizione negoziata e cosa ottengo?
R: La composizione negoziata conviene a un’impresa in crisi grave ma non ancora fallita. È uno strumento veloce e riservato (non pubblico): un esperto indipendente aiuta imprenditore e creditori a trovare un accordo globale. Se l’accordo riesce, l’azienda può continuare l’attività con un piano di rientro concertato. L’Osservatorio Unioncamere evidenzia che il tasso di successo di questo istituto è attualmente attorno al 20%: un’impresa su cinque ottiene un’intesa positiva (per es. ristrutturazione concordata di parte dei debiti). Vantaggi concreti: il debitore resta in controllo e non subisce pignoramenti nelle more, e può estendere l’accordo a tutti i creditori coinvolti (banche, Fisco, fornitori). In caso contrario, può passare in qualsiasi momento a procedure giudiziali (ad es. concordato) senza conseguenze particolari.
D: Che differenza c’è tra piano attestato di risanamento e concordato preventivo?
R: Il piano attestato è uno strumento stragiudiziale previsto dall’art.56 CCII. L’impresa in crisi lo redige e un professionista ne attesta la fattibilità. In pratica è un documento contrattuale che illustra come risanare i debiti e viene usato per sollecitare trattative con i creditori. Non serve l’intervento del tribunale, ma tantomeno vincola i creditori: essi devono comunque sottoscrivere eventuali accordi (art.57 CCII) affinché i piani abbiano effetto. Il concordato preventivo, invece, è una procedura giudiziaria formale (art.43 ss. CCII) in cui il giudice verifica e omologa il piano proposto dalla società; ha efficacia coattiva su tutti i creditori (anche quelli dissenzienti) se raggiunge le maggioranze di legge. In sintesi: il piano attestato è più snello e confidenziale, ma non garantisce l’adesione dei creditori; il concordato è impegnativo ma può bindere tutti in forza di legge.
D: I soci di una S.r.l. perdono i loro averi se la società ha debiti?
R: No, la regola generale (art.2740 c.c.) prevede l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali. Ciò significa che, salvo casi di illecito (ad es. distrazione di beni sociali) o malafede, i creditori sociali possono aggredire solo il patrimonio della società stessa. I soci rispondono solo con il capitale conferito (il capitale sociale). Ovviamente, se il capitale sociale viene a ridursi oltre 1/3 a causa di perdite, gli amministratori devono convocare l’assemblea per ricostituirlo o sciogliere la società (artt. 2446-2447 c.c., artt. 2482-bis-ter c.c.). Il Codice della crisi, però, sospende tali obblighi in attesa di soluzioni (per agevolare la continuità). In definitiva, una S.r.l. o S.p.A. non fa “rispondere” i soci personalmente dei debiti sociali, ma la perdita totale del capitale può portarli alla perdita degli investimenti effettuati.
D: In che modo i debiti doganali possono essere regolarizzati in un concordato?
R: I tributi doganali (dazi e IVA all’import) vengono amministrati dall’Agenzia delle Dogane (ADM). Per includerli in un concordato o in accordi di ristrutturazione, si applica in linea di principio la stessa disciplina prevista per i tributi erariali. In pratica, la proposta di concordato può prevedere un pagamento parziale rateale dell’IVA doganale dovuta, sottoposta all’approvazione delle direzioni territoriali ADM (Art.63, comma 2 CCII). L’Agenzia Dogane può esprimere parere: ad esempio, se la proposta prevede una forte “falcidia” (taglio) del debito IVA, serve il benestare degli uffici centrali (art.63 CCII, ultimo comma). Se il piano di concordato ottiene l’omologazione, anche i creditori (ADM inclusa) devono attenersi ai termini del piano. La recente Cassazione ha sottolineato che in materia doganale non operano per analogia le nullità previste per altri tributi (art.42 DPR 600/1973), ma ciò non ostacola la possibilità di negoziare i debiti doganali nell’ambito di un piano di crisi. Infine, occorre sempre considerare che, come detto, se l’IVA doganale è integralmente saldata, l’Agenzia non può confiscare le merci (Cass. cost. 3/7/2025 n.93). Quindi, un concordato che preveda il pagamento totale dell’imposta (anche se rateizzata) esclude ulteriori sanzioni in termini di confisca.
D: Il trattato intra-UE si applica anche al nostro debito IVA?
R: Il commercio intracomunitario rientra nel sistema IVA a “border zero” dell’Unione Europea. Ciò significa che, per le cessioni intracomunitarie di beni, non si applica IVA italiana (viene fatturato senza IVA a condizione che l’acquirente sia un soggetto passivo UE), e l’acquirente UE addebita l’IVA nel suo Paese (reverse charge). Se l’azienda italiana ha sbagliato a gestire questi flussi (ad es. emettendo fatture con IVA interna per vendite intra-UE), il Fisco può recuperare l’imposta omessa come se fosse un debito nazionale. Anche questo debito IVA comunitario può essere oggetto di transazione o ristrutturazione (art.63 CCII) come qualsiasi altro tributo. Non esistono “sanzioni doganali” vere e proprie per l’IVA intra-UE, in quanto non si tratta di un atto di confine: tuttavia, persistono sanzioni e interessi per omessi versamenti.
D: Cosa succede ai debiti tributari e contributivi in un concordato?
R: Nel concordato preventivo, i debiti tributari e previdenziali si collocano a prefefolios (i tributi erariali e i contributi hanno diritto di prelazione su determinati beni, art. 88 CCII). Tuttavia, come ammesso dalla legge fallimentare modificata dalla riforma, il tribunale può applicare il cram-down anche a questi crediti pubblici. In altre parole, un piano concordatario può essere omologato senza l’accordo formale del Fisco o dell’INPS, purché sia dimostrato che il trattamento proposto è conveniente rispetto alla liquidazione (Cass. 27782/2024 ). Nell’ambito del piano, il debitore dovrà precisare quanti soldi destina al saldo integrale dei crediti privilegiati (erario, previdenza) e quanto offre ai crediti chirografari; tipicamente, si garantisce il soddisfacimento totale dei crediti di fonte pubblica, oppure comunque un valore equivalente al 100% dei beni ceduti in garanzia (art.88 CCII). Grazie all’intervento della Corte di Cassazione, oggi il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate non blocca l’omologazione del concordato se esistono le condizioni per il cram-down . Ciò rappresenta una netta svolta: in passato l’assenza di “aumenti di capitale” era un ostacolo. Oggi, in sintesi, l’impresa in concordato può trattare anche i debiti fiscali senza subire il rifiuto invalicabile delle autorità, usando i meccanismi di ristrutturazione previsti.
D: La causa del mio debito può influenzare la crisi (es. impresa travolta da sanzioni o da contrabbando)?
R: Se le ragioni del debito derivano da errori formali (ad es. vizi nelle dichiarazioni doganali), il debitore può contestare le contestazioni di condotta (ad es. tramite il giudizio di impugnativa tributaria) e persino ottenere l’annullamento degli atti. Se invece il debito è fondato ma dovuto a situazioni di mercato avverse (clienti insolventi, perdite ingenti, crisi settore), la trattativa di ristrutturazione dovrà focalizzarsi sul piano di risanamento e sui contributi esterni (finanza ex novo, supporto bancario). Ad esempio, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 31/10/2023 n.30140) ha addirittura ammissso la revoca di un atto di cessione d’azienda simulato per frodare i creditori, sottolineando che l’alternativa del concordato in continuità deve essere valutata con attenzione alla preservazione del valore d’impresa (Cass. 30140/2024, non citata sopra). Il punto chiave: il debitore non può mai dimettersi passivamente di fronte alle contestazioni; può impugnare gli atti irregolari e, parallelamente, attivare percorsi di risanamento sugli altri fronti.
D: È importante chiudere i rapporti con i fornitori insolventi?
R: Non necessariamente. Se i crediti verso l’impresa sono dubbia esigibilità, spesso il fornitore può aver ceduto o scontato il proprio credito a factor o banca. In tal caso l’impresa dovrà pagare all’ente terzo. D’altra parte, lasciare insoluti i fornitori può significare interrompere forniture essenziali (ad es. visti consolari, polizze di carico, certificazioni di origine), bloccando l’attività. Spesso è utile mantenere un dialogo: in alcuni concordati i fornitori firmano piani di rientro (anche con sconti sul dovuto) per non perdere completamente il cliente. In alternativa, si può ricorrere agli strumenti di transazione su crediti commerciali (art.63 CCII, comma 2, riferito alle ristrutturazioni), offrendo un piano di rientro rateale per i fornitori terzi.
D: Esistono limiti al pignoramento in caso di piano di rientro?
R: Sì. Una volta depositata una domanda di concordato preventivo (o di accordo di ristrutturazione omologato), tutte le azioni esecutive coattive in corso sono sospese (art.52 CCII). Analogamente, il pignoramento conservativo a tutela del credito può essere annullato dal tribunale del concordato se ritiene che la pretesa debitoria sia risolta nel piano. In una composizione negoziata, invece, non vi è una norma assoluta di sospensione automatica (solitamente non impedisce il pignoramento, sebbene l’esperto e i creditori tendenzialmente convengano di non procedere fino al termine del negoziato). È però prassi che, su richiesta, il tribunale o l’autorità giudiziaria applichino misure protettive al debitore in crisi per evitare spossessamenti e permettere l’esito delle trattative (art.17 CCII). In sintesi: se si è in concordato, i creditori non possono pignorare ulteriori beni aziendali né il debitore può essere dichiarato fallito (a meno di grave irregolarità). Questo garantisce al debitore un “paracadute” da cui ripartire al termine delle trattative.
D: Come coinvolgere i crediti esteri (clienti in EU o extra-EU) nella soluzione dei debiti?
R: I crediti commerciali vantati nei confronti di clienti esteri fanno parte dell’attivo aziendale e possono essere utilizzati come garanzia o moneta di scambio. In un concordato, è importante includere i crediti nei conteggi del piano (per dimostrare capacità di rientro). Ad esempio, in un concordato in continuità si può prevedere che parte dei pagamenti dei fornitori sia destinata a ripagare questi crediti (garantendo di fatto le disponibilità future). Se il cliente estero è particolarmente inadempiente, si può considerare la cessione del credito a una società italiana o estera (cedente responsabilità solidale all’estero) per accelerare l’incasso. In ogni caso, dal punto di vista giuridico il recupero crediti in UE segue la direttiva europea, ma in concordato prevale la prassi italiana che tratta i creditori esteri alla pari.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n.14, in attuazione L.155/2017), con modifiche (correttivi D.Lgs. 83/2015, D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 136/2024); Capo I, Titolo IV (artt.10-25) sui rimedi stragiudiziali; Titolo II (artt.43-64) sul concordato; art.56 CCII (piano attestato di risanamento); art.63 CCII (transazione tributi); art.17 CCII (misure protettive). Codice Civile: artt. 2740 (autonomia patrimoniale perfetta); art.2462 c.c. e segg. (capitale sociale); art.2482-bis c.c. (perdite di capitale e scioglimento).
- Legge 3/2012 (sovraindebitamento, soluzioni esdebitazione per imprese non fallibili). Legge 27/2022 di conversione del D.L. 118/2021 (“Milleproroghe”), che ha espressamente prorogato e modificato le norme sulla composizione negoziata. Legge 197/2022 (Stabilità 2023), che ha introdotto la nuova definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi (c.d. “definizione agevolata – rottamazione-quater”). Decreto Legge 36/2022 (conversione di operazioni bancarie in contabilità, c.d. “lex price”), modifiche al CCII.
- Regolamenti UE: Regolamento (UE) 2015/848 (insolvenze transfrontaliere); Reg. (UE) 1215/2012 (civile comunitario – non previsto per esecuzioni dirette intra-UE senza sentenza in materia fiscale, ma relativo alla libera circolazione di decisioni). Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione, art.124 su estinzione dell’obbligazione da dazi). Direttiva (UE) 2019/1023 sul quadro europeo di ristrutturazione e insolvenza.
- Giurisprudenza italiana recente: Corte Costituzionale, sent. 3 luglio 2025 n.93 (principio di proporzionalità sanzioni IVA doganale, confisca esclusa in caso di pagamento dell’Iva evasa). Corte di Cassazione: Sez. I Civ., 28 ott. 2024 n.27782 (concordato preventivo – confermato il cram-down fiscale previsto dall’art.180 l.fall. anche in caso di espresso dissenso dell’amministrazione finanziaria) . Cass. Sez. trib., ord. 15 ott. 2025 n.18185 (nullità per difetto firma negli atti doganali: le nullità tributare ex art.42 DPR 600/73 non si estendono agli atti doganali; principio di tassatività delle nullità). Tribunali: Tribunale di Bologna (21/3/2023, ord. istanza concordato “ristoro Covid”), Trib. Milano (9/9/2025, concordato liquidatorio in continuità con apporto esterno) – citati in fonti.
- Altre fonti istituzionali: Rapporto Unioncamere (Osservatorio semestrale, VI ed. nov.2024) sulla composizione negoziata. Circolari Ministero Economia e Finanze (es. circolare 4/2015 su piani attestati – superata in gran parte dal CCII). Documenti AGEA e INPS (guide alle rateizzazioni contributive). Leggi di stabilità (2023, 2024) e decreti attuativi del Ministero Economia per la pace fiscale. Testi citati in Web-Gazzetta Ufficiale: ad es. D.Lgs. 14/2019 (GU n.38/2019).
Hai un’azienda di import-export che sta affrontando debiti, cartelle esattoriali, richieste dei fornitori esteri, problemi con banche o pignoramenti in arrivo? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai un’azienda di import-export che sta affrontando debiti, cartelle esattoriali, richieste dei fornitori esteri, problemi con banche o pignoramenti in arrivo?
Hai notato un calo dei margini, ritardi nei pagamenti dei clienti, blocchi in dogana o difficoltà a mantenere i flussi di cassa?
👉 Non sei solo: moltissime aziende del commercio internazionale sono in crisi. Ma puoi difenderti e salvare l’attività, se agisci subito e in modo mirato.
In questa guida ti spiego cosa fare immediatamente, quali strumenti legali esistono e come proteggere la tua azienda di import-export prima che sia troppo tardi.
💥 Perché le Aziende di Import-Export Entrano in Crisi
Le imprese del settore sono tra le più esposte a rischi globali e finanziari:
- aumento dei prezzi delle materie prime e dei noli internazionali;
- variazioni repentine di cambio e dazi;
- ritardi nei pagamenti tra partner internazionali;
- blocchi in dogana o problemi con certificazioni;
- esposizioni bancarie elevate;
- ricarichi minimi su grandi volumi;
- debiti con fornitori esteri e italiani;
- crollo improvviso della domanda.
📌 In questo settore, basta un container bloccato o un pagamento mancato per creare una crisi immediata di liquidità.
⚠️ I Rischi per un’Azienda di Import-Export Indebitata
Se non intervieni subito, rischi:
- 🏦 pignoramento dei conti correnti aziendali;
- 📦 pignoramento o blocco del magazzino (merci in arrivo, stoccate o in attesa di sdoganamento);
- 🚚 fermi amministrativi sui mezzi utilizzati per la logistica;
- 🧾 cartelle esattoriali, intimazioni e nuove iscrizioni a ruolo;
- 🏠 ipoteche su immobili aziendali;
- 💥 revoca dei fidi bancari e degli affidamenti commerciali;
- 🌍 perdita di credibilità con fornitori esteri.
📌 Una singola azione (pignoramento del conto o blocco della merce) può paralizzare l’azienda.
💠 Come Difendersi Subito: Le Azioni Fondamentali
1️⃣ Analisi completa dei debiti
Serve esaminare:
- cartelle esattoriali e debiti fiscali;
- importi in dogana (IVA, dazi, sanzioni);
- debiti verso fornitori esteri e italiani;
- crediti da incassare;
- esposizioni bancarie e garanzie;
- eventuali decreti ingiuntivi o pignoramenti.
📌 Solo una visione globale permette una strategia efficace.
2️⃣ Blocco Immediato di Cartelle e Pignoramenti
L’avvocato può chiedere:
- sospensione urgente delle cartelle esattoriali;
- blocco pignoramenti su conti o magazzini;
- opposizione a decreti ingiuntivi;
- sospensione di fermi amministrativi.
📌 In molti casi, la sospensione può arrivare in 48 ore.
3️⃣ Ristrutturazione del Debito Aziendale
Le aziende di import-export possono accedere a strumenti potentissimi:
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO);
- Accordo di ristrutturazione dei debiti;
- Composizione negoziata della crisi;
- Concordato minore;
- Liquidazione controllata (solo se inevitabile).
Queste procedure offrono:
- riduzione del debito fino al 70–90%;
- blocco totale delle azioni in corso;
- tutela del patrimonio aziendale;
- continuità del business internazionale.
📌 Sono le soluzioni più efficaci per salvare l’impresa.
4️⃣ Trattare con Fornitori e Banche
Con una trattativa professionale puoi ottenere:
- dilazioni di pagamento sostenibili;
- rinegoziazione dei debiti contrattuali;
- saldo e stralcio con fornitori esteri;
- revisione di tassi e condizioni bancarie;
- sospensione delle rate di finanziamenti e leasing.
📌 I fornitori stranieri preferiscono un accordo piuttosto che perdere un cliente.
5️⃣ Contestare Debiti Fiscali e Doganali
Le aziende di import-export sono spesso colpite da:
- dazi doganali contestati;
- IVA all’importazione non allineata;
- sanzioni per presunte irregolarità;
- cartelle esattoriali basate su errori.
📌 Con una difesa legale tecnica, moltissimi debiti fiscali/doganali sono annullabili.
🧩 Checklist Pratica: Cosa Fare Subito
- Raccogli cartelle, solleciti, fatture, estratti conto.
- Non firmare piani di rientro senza analisi legale.
- Blocca pignoramenti e cartelle immediatamente.
- Proteggi magazzino e flussi di merce.
- Attiva una procedura di ristrutturazione prima che i debiti diventino ingestibili.
- Lavora sul recupero crediti e sulle trattative con fornitori e banche.
📌 Ogni giorno perso aumenta il rischio operativo.
🧾 Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Estratto di ruolo aggiornato;
- Estratti conto bancari;
- DDT, documenti doganali, fatture import/export;
- Contratti con fornitori esteri;
- Bilanci e dichiarazioni fiscali;
- Atti giudiziari (cartelle, pignoramenti, decreti).
⏱️ Tempistiche realistiche
- Blocco pignoramenti/cartelle: 48 ore – 7 giorni
- Elaborazione del piano di ristrutturazione: 30–60 giorni
- Protezione totale dai creditori: immediata dal deposito della procedura
- Chiusura definitiva della crisi: 6–18 mesi
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✔️ Blocco immediato delle azioni dei creditori
✔️ Possibile riduzione del debito fino al 90%
✔️ Protezione delle merci e dei flussi commerciali
✔️ Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
✔️ Continuità dell’attività internazionale
✔️ Difesa contro Fisco, Dogane, banche e fornitori esteri
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare cartelle, avvisi o solleciti doganali
❌ Fare nuovi debiti per coprire debiti vecchi
❌ Firmare piani di rientro impossibili da sostenere
❌ Attendere che “si sistemi da solo”
❌ Fidarsi di chi non è esperto di crisi aziendali e doganali
📌 Una crisi di import-export può esplodere rapidamente. Va gestita subito.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analisi completa della situazione debitoria e doganale
📌 Blocco immediato di cartelle, pignoramenti e fermi
✍️ Elaborazione del miglior piano di ristrutturazione
⚖️ Difesa contro Fisco, Dogane, banche e fornitori esteri
🔁 Assistenza continua fino alla risoluzione totale della crisi
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in crisi d’impresa, debiti fiscali e doganali
✔️ Specializzato nella difesa di aziende di import-export e commercio internazionale
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia Entrate, Dogane e istituti finanziari
Conclusione
Una azienda di import-export con debiti può essere salvata.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, proteggere le merci, annullare cartelle irregolari, ridurre drasticamente i debiti e salvare l’operatività internazionale.
⏱️ Non aspettare: ogni giorno perso può costarti un cliente o un container.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua strategia di difesa può partire oggi stesso.