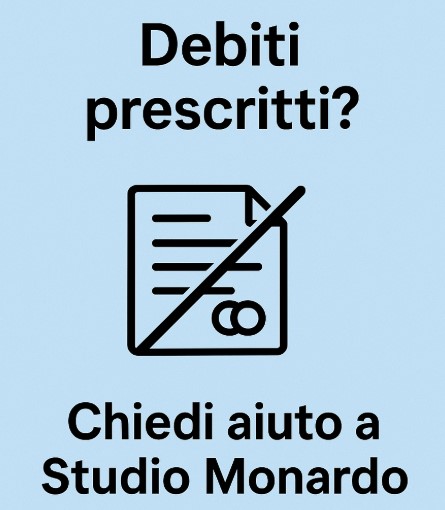Hai scoperto di avere vecchi debiti o cartelle esattoriali che pensavi fossero ormai prescritti, ma hai ricevuto una nuova richiesta di pagamento o un sollecito da parte dell’Agenzia delle Entrate o di una società di recupero crediti?
In Italia, la prescrizione è il limite di tempo entro cui un creditore può richiedere legalmente un debito. Tuttavia, in alcuni casi, debiti prescritti possono essere “riattivati” se non si reagisce nel modo corretto.
Questa Guida 2025 ti spiega quando un debito prescritto può tornare esigibile, quali sono i rischi e come difenderti legalmente per evitare di pagare somme ormai non dovute.
Cosa significa che un debito è prescritto
La prescrizione è il termine di legge entro il quale un creditore (pubblico o privato) può chiedere il pagamento di un debito.
Trascorso questo periodo, il diritto di riscuotere si estingue automaticamente, e il debito non può più essere richiesto legalmente.
In pratica, un debito prescritto esiste solo “sulla carta”, ma non è più esigibile davanti al giudice.
Tempi di prescrizione aggiornati al 2025
I termini di prescrizione cambiano a seconda del tipo di debito:
- Imposte statali (IRPEF, IVA, IRES, IRAP): 10 anni;
- Tributi locali (IMU, TARI, bollo auto): 5 anni;
- Contributi INPS e INAIL: 5 anni;
- Multe stradali: 5 anni;
- Utenze domestiche (gas, luce, telefono, acqua): 5 anni;
- Prestiti bancari e finanziamenti: 10 anni (in alcuni casi 5 per rapporti contrattuali specifici);
- Canone RAI: 5 anni;
- Fatture commerciali e tra privati: 5 anni.
Attenzione: ogni notifica valida o atto interruttivo (come un avviso, una raccomandata o una cartella) fa ripartire da zero il termine di prescrizione.
Quando un debito prescritto può tornare esigibile
Un debito prescritto può “riattivarsi” o tornare esigibile in tre casi principali:
- Riconoscimento del debito da parte del debitore: se rispondi a una lettera, firmi un accordo o paghi anche una sola rata, il debito si considera “riconosciuto” e la prescrizione riparte da zero.
- Nuova notifica o atto interruttivo: se il creditore (o l’Agenzia delle Entrate) riesce a dimostrare di aver inviato una comunicazione valida, la prescrizione viene interrotta e ricomincia a decorrere.
- Errore del contribuente: molte persone, non sapendo che il debito era prescritto, pagano spontaneamente, riattivando così l’obbligo o rinunciando implicitamente alla prescrizione.
In nessun caso, però, il debito può tornare esigibile senza un atto formale valido o un riconoscimento diretto da parte tua.
Cosa fare se ti chiedono di pagare un debito prescritto
- Non pagare subito. Prima di effettuare qualsiasi pagamento, è fondamentale verificare se il debito è davvero ancora valido o se è prescritto.
- Controlla le date. Recupera tutti i documenti (cartelle, avvisi, lettere, notifiche) e verifica l’ultimo atto formale ricevuto: se sono trascorsi più di 5 o 10 anni, il debito è estinto.
- Richiedi la prova della notifica. Il creditore deve dimostrare di averti inviato un atto interruttivo regolare. Se non lo fa, non può riscuotere.
- Evita di riconoscere il debito. Non firmare lettere, piani di rientro o proposte di saldo finché un avvocato non ha verificato la prescrizione.
- Chiedi assistenza legale. Un avvocato esperto può analizzare il fascicolo e presentare opposizione o ricorso per far dichiarare il debito prescritto.
Come difendersi legalmente da un debito prescritto
Un avvocato tributarista o bancario può aiutarti a bloccare ogni tentativo di riscossione illegittima attraverso:
- istanza di sospensione per fermare subito eventuali azioni di pignoramento o cartelle;
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, se il debito è di natura fiscale;
- contestazione della prescrizione tramite eccezione formale, chiedendo l’annullamento dell’atto;
- richiesta di accesso agli atti per verificare la regolarità delle notifiche;
- azione legale per danno o indebito pagamento, se hai pagato somme non più dovute.
Esempi pratici di riattivazione dei debiti prescritti
- Caso 1 – Agenzia delle Entrate: hai ricevuto una cartella per IRPEF del 2012, ma nessuna notifica negli ultimi 10 anni. Se nel 2025 ti arriva un sollecito, puoi opporre la prescrizione decennale.
- Caso 2 – Recupero crediti: una società ti chiede il pagamento di un vecchio finanziamento bancario del 2013. Se non esiste un decreto ingiuntivo o una notifica recente, il debito è prescritto e non devi pagare.
- Caso 3 – Riconoscimento involontario: firmi un accordo di saldo e stralcio per un debito prescritto del 2010. Con quella firma, hai riattivato il debito e rinunciato alla prescrizione.
Come sapere se il debito è davvero prescritto
Per capire se il tuo debito è prescritto, serve verificare:
- la data dell’ultimo atto notificato (accertamento, cartella, intimazione di pagamento);
- se ci sono atti interruttivi documentati;
- se la notifica è valida (inviata al giusto indirizzo e con firma legale);
- il tipo di debito (perché ogni categoria ha tempi diversi).
Un avvocato può controllare la tua situazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i tribunali o le banche dati per stabilire con certezza se il debito è ancora esigibile o no.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un debito prescritto può portare a conseguenze spiacevoli:
- il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo se non opponi la prescrizione;
- potresti pagare somme non dovute per paura o disinformazione;
- in mancanza di opposizione, il debito diventa giudizialmente valido, anche se era prescritto.
Agire subito è fondamentale per impedire che un debito estinto torni a perseguitarti.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta un avvocato se:
- hai ricevuto una richiesta di pagamento per un vecchio debito o cartella;
- vuoi verificare se i tuoi debiti sono prescritti;
- hai pagato per errore un debito che doveva essere cancellato;
- vuoi bloccare una procedura di pignoramento o recupero crediti.
Un avvocato esperto può:
- accertare la prescrizione;
- impugnare gli atti illegittimi;
- ottenere la sospensione immediata della riscossione;
- chiedere la cancellazione del debito dai registri;
- far valere i tuoi diritti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria o al Tribunale civile.
⚠️ Attenzione: molti creditori e società di recupero approfittano della disinformazione per richiedere il pagamento di debiti ormai prescritti. Non firmare nulla e non pagare senza prima un controllo legale: potresti evitare di riattivare un debito estinto da anni.
Questa Guida 2025 dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, bancario e difesa contro il recupero crediti spiega quando un debito prescritto può tornare esigibile, come riconoscerlo e come reagire legalmente per bloccare richieste illegittime e cancellare definitivamente i debiti non più dovuti.
👉 Hai ricevuto una richiesta per un vecchio debito o una cartella ormai prescritta?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo gli atti, verificheremo la prescrizione e costruiremo una strategia legale per bloccare la riscossione, annullare i debiti prescritti e proteggere il tuo patrimonio.
Introduzione
La prescrizione dei debiti è un meccanismo fondamentale del diritto civile italiano, volto a garantire certezza nei rapporti giuridici. Quando un debito è “prescritto”, significa che il creditore ha lasciato trascorrere troppo tempo senza esigerlo, perdendo così il diritto di pretenderne il pagamento in via giudiziale. In altre parole, il decorso del tempo – determinato dalla legge – estingue il diritto del creditore . Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, offre un livello di approfondimento avanzato sull’istituto della prescrizione, con particolare riguardo ai debitori (siano essi privati cittadini, imprenditori o professionisti) e su come possano difendersi legalmente di fronte a richieste di pagamento di debiti ormai prescritti.
Affronteremo quando un debito prescritto può tornare esigibile – ossia in quali circostanze un’obbligazione ormai estinta per decorso del tempo può di nuovo essere pretesa dal creditore – e come reagire legalmente in tali casi. La trattazione coprirà vari tipi di debiti (fiscali, bancari, condominiali, commerciali, verso privati, ecc.), indicando i termini di prescrizione previsti dalla normativa e fornendo esempi pratici, tabelle riepilogative, oltre a un format Q&A (domande e risposte) per chiarire i dubbi più comuni. Saranno citate le norme pertinenti e le sentenze più aggiornate (fino al 2025) di Corte di Cassazione e altre autorità, così da fornire riferimenti istituzionali autorevoli. Il linguaggio sarà giuridico ma divulgativo, per essere utile sia agli avvocati che necessitano di un quadro completo e aggiornato, sia ai debitori privati o imprenditori che vogliono comprendere i propri diritti e strategie di difesa.
Prima di entrare nel dettaglio, è importante chiarire alcuni concetti chiave: cos’è esattamente la prescrizione e come funziona in generale, qual è la differenza tra prescrizione e decadenza, e quali sono i termini ordinari e quelli brevi di prescrizione a seconda delle varie tipologie di debito. Successivamente, analizzeremo quando un debito prescritto può “tornare in vita”, esaminando circostanze particolari (come il comportamento del debitore o del creditore, atti interruttivi, sentenze, ecc.) e le più recenti pronunce giurisprudenziali al riguardo. Infine, delineeremo come il debitore dovrebbe reagire qualora gli venga richiesto un pagamento prescritto: dagli strumenti stragiudiziali (lettere di contestazione, segnalazioni alle autorità) alle difese processuali (l’eccezione di prescrizione da sollevare in giudizio), con strategie di difesa in caso di tentativi indebiti di “riattivazione” del debito.
Ricordiamo sin da ora due principi fondamentali che guideranno molte delle considerazioni seguenti:
- La prescrizione non opera automaticamente in giudizio: è una difesa (eccezione) che deve essere espressamente invocata dal debitore. Il giudice infatti non può rilevarla d’ufficio se il debitore non la oppone . Dunque, un debito prescritto torna di fatto esigibile se il debitore non solleva per tempo l’eccezione di prescrizione.
- Un debito estinto per prescrizione non scompare nel mondo fattuale: rimane un’obbligazione naturale. Se il debitore la adempie spontaneamente (ad esempio paga comunque una somma prescritta), non può poi pretendere la restituzione di quanto pagato . La legge considera infatti valido il pagamento spontaneo di un debito prescritto, pur non essendo più esigibile coattivamente.
Nei capitoli seguenti, esploreremo dettagliatamente i diversi aspetti di questa materia, con l’obiettivo di fornire una guida completa nel 2025 su come i debiti prescritti funzionano e come tutelarsi nel migliore dei modi.
Cos’è la prescrizione di un debito? Differenza tra prescrizione e decadenza
La prescrizione estintiva è l’istituto giuridico in base al quale ogni diritto si estingue se non viene esercitato dal titolare entro il tempo stabilito dalla legge . È uno strumento di tutela della certezza dei rapporti: il creditore ha un periodo di tempo determinato per far valere il proprio diritto, decorso il quale il debitore può legittimamente rifiutarsi di adempiere. In termini pratici, se un creditore rimane inattivo per un lungo periodo (diverso a seconda del tipo di credito) senza compiere atti di esercizio del diritto (come richieste formali di pagamento, atti legali, ecc.), il debito “cade in prescrizione” e il debitore acquisisce un diritto a rifiutare la prestazione.
La prescrizione è disciplinata dal Codice Civile agli artt. 2934 e seguenti. L’art. 2934 c.c. recita: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Sono esclusi dalla prescrizione solo i diritti indisponibili e altri diritti particolari espressamente previsti (ad esempio alcuni diritti di stato e della persona) . Il principio cardine è quindi l’inattività del titolare del diritto per un certo periodo.
È fondamentale distinguere la prescrizione dalla decadenza. Entrambi gli istituti attengono al fattore tempo, ma con differenze sostanziali:
- La prescrizione estintiva incide sul diritto in sé: estingue il diritto soggettivo se non esercitato entro un certo termine. È una difesa che va eccepita dal debitore; se non eccepita, il giudice non può applicarla d’ufficio (salvo eccezioni di legge) . Inoltre, la prescrizione può essere interrotta o sospesa da determinati eventi (come vedremo) che fanno ripartire o congelano il decorso del tempo.
- La decadenza invece attiene all’esercizio di poteri o facoltà entro termini perentori stabiliti dalla legge, spesso di natura pubblicistica o procedurale. Se il titolare non compie l’atto entro quel termine, perde definitivamente la possibilità di farlo (ad esempio il termine per impugnare un atto amministrativo, o il termine per esercitare un’opzione contrattuale). La decadenza di solito non è soggetta a sospensione o interruzione, salvo diversa previsione, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (in quanto spesso inderogabile). Un esempio tipico in ambito di debiti è il termine di decadenza per notificare un atto impositivo (come un avviso di accertamento tributario): trascorso tale termine, il tributo non può più essere richiesto perché l’ente impositore è decaduto dal potere di accertarlo.
In ambito di riscossione dei tributi, ad esempio, opera sia la decadenza (per l’accertamento o la notifica delle cartelle) sia la prescrizione (per la successiva attività di riscossione coattiva). Spesso i contribuenti confondono i due concetti: un’imposta potrebbe essere decaduta perché l’ente non l’ha notificata in tempo, oppure prescritta perché, pur validamente accertata, sono passati troppi anni senza che l’ente la riscuotesse. La differenza pratica è che la decadenza viene rilevata normalmente nel ricorso contro l’atto (ed è spesso rilevabile d’ufficio), mentre la prescrizione va eccepita dal contribuente e può maturare anche successivamente all’emissione dell’atto, durante la fase di riscossione.
In sintesi: la prescrizione estingue il diritto per inattività prolungata del creditore; la decadenza estingue il potere di compiere un atto per mancato esercizio entro un termine perentorio più breve. Nel prosieguo di questa guida ci concentreremo principalmente sulla prescrizione, ossia sul limite massimo di tempo entro il quale un credito può essere fatto valere, e sulle sue cause interruttive/sospensive.
Interruzione e sospensione della prescrizione
Prima di analizzare i termini specifici per i vari tipi di debiti, occorre comprendere due concetti tecnici che spesso determinano se un debito sia o meno prescritto in concreto: l’interruzione e la sospensione della prescrizione.
- Interruzione della prescrizione: consiste in un atto o fatto che azzera il tempo già trascorso e fa ripartire da capo il termine di prescrizione. Secondo l’art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da ogni atto con cui il creditore compie una costituzione in mora del debitore, oppure dall’atto con cui il creditore esercita il diritto in giudizio (citazione, ricorso, atto di precetto, ecc.), o ancora da un riconoscimento del diritto da parte del debitore (art. 2944 c.c.). Ad esempio, se un creditore invia una raccomandata di messa in mora o notifica un decreto ingiuntivo, interrompe la prescrizione; parimenti, se il debitore riconosce il debito (magari con una lettera in cui chiede una dilazione o effettua un pagamento parziale), l’effetto è interruttivo. Dopo l’interruzione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere per intero da capo. È importante notare che un atto interruttivo, per essere valido, deve provenire dal titolare del diritto (o dal suo rappresentante) oppure – nel caso del riconoscimento – dal debitore. Inoltre deve intervenire prima che la prescrizione si sia già compiuta; se arriva dopo, avrà eventualmente valore di “rinuncia” alla prescrizione già maturata (vedremo oltre). Nella pratica, l’onere di provare un’eventuale interruzione spetta al creditore: se il debitore eccepisce la prescrizione affermando che è trascorso il termine, sarà il creditore a dover esibire documenti che dimostrino l’invio o la notifica di atti interruttivi in quel periodo . Anche la presentazione di una domanda di mediazione o negoziazione assistita può avere efficacia interruttiva/sospensiva, a certe condizioni: la Cassazione ha chiarito ad esempio che l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione solo se dalla documentazione risulta chiaramente la pretesa fatta valere, non bastando la mera comunicazione informale .
- Sospensione della prescrizione: è un istituto per cui il decorso del tempo si ferma temporaneamente a causa di particolari rapporti tra le parti o per specifiche situazioni previste dalla legge, e poi riprende a decorrere per il residuo una volta cessata la causa sospensiva (il tempo già maturato non viene azzerato, a differenza dell’interruzione, ma semplicemente congelato per un certo periodo). Gli esempi classici sono: il rapporto tra coniugi o tra genitore e figlio minore, durante il quale la prescrizione di diritti reciproci è sospesa (art. 2941 c.c.); oppure la sospensione per forza maggiore (riconosciuta da alcune normative emergenziali, come durante la pandemia da Covid-19, in cui il legislatore ha sospeso i termini di prescrizione per alcuni mesi). Un altro caso pratico di sospensione è contemplato in materia di procedure: ad esempio, se il debitore chiede la rateizzazione di un debito tributario già iscritto a ruolo, la legge prevede la sospensione del termine di prescrizione per la durata del piano di rate (come da sentenza Cass. n. 1227/2024 in ambito tributario ).
In sintesi, interruzione = il “cronometro” riparte da zero; sospensione = il “cronometro” si mette in pausa e poi riprende da dove si era fermato. Questi meccanismi fanno sì che il momento di compimento della prescrizione possa spostarsi in avanti se vi sono stati atti o eventi durante il periodo. Ad esempio, per un debito che di regola si prescrive in 5 anni, se dopo 2 anni il creditore invia una diffida (interruzione), i 5 anni ricominciano da capo da quella data (quindi il nuovo termine scadrà 5 anni dopo la diffida). È quindi fondamentale, nel valutare se un debito è prescritto, ricostruire la cronologia: data di nascita del credito, eventuali atti interruttivi (richieste scritte, pagamenti, citazioni) o periodi di sospensione.
Prescrizione come eccezione di parte (non rilevata d’ufficio)
Un principio decisivo da comprendere è che la prescrizione opera come eccezione di parte. Ciò significa che, se il creditore agisce legalmente per recuperare un credito, il debitore deve espressamente dichiarare che il credito è prescritto nelle sue difese, altrimenti il giudice non può dichiararlo da sé. L’art. 2938 c.c. stabilisce infatti che “il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”. La Cassazione ha più volte ribadito che l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso proprio e stretto: non è rilevabile d’ufficio ed è nella disponibilità esclusiva del debitore . In un processo civile di cognizione ordinaria, ad esempio, il convenuto debitore deve sollevare l’eccezione nella comparsa di risposta tempestiva (art. 167 c.p.c.), pena la decadenza. Se non lo fa (o non si costituisce affatto), il giudice non potrà che ritenere il diritto non prescritto, anche se dal punto di vista sostanziale i termini fossero trascorsi. Analogamente, nel procedimento per decreto ingiuntivo, se il debitore non propone opposizione entro 40 giorni (o il termine previsto) eccependo la prescrizione, il decreto diverrà definitivo e quel debito, a quel punto consacrato in un titolo esecutivo, potrà essere legittimamente eseguito.
Questo aspetto pratico è cruciale: un debito prescrittibile può “tornare esigibile” se il debitore non fa valere la prescrizione in giudizio. Si consideri ad esempio un decreto ingiuntivo notificato su un credito vecchio di 10 anni: se il debitore, pur avendo motivo per opporsi (in quanto il credito è presumibilmente prescritto), lascia decorrere i termini senza fare opposizione, quel decreto diventerà esecutivo e il debito sarà in pratica dovuto. Non potrà più eccepire la prescrizione successivamente, perché avrebbe dovuto farlo nell’opposizione al decreto.
Riassumendo: la prescrizione è una difesa del debitore, che va attivata tempestivamente. Un debito prescritto non è automaticamente inesigibile in assoluto, ma lo diventa se e solo se il debitore solleva l’eccezione nella sede opportuna. Tenere presente ciò è fondamentale per la strategia di difesa: ignorare una citazione o un sollecito legale pensando che “tanto è prescritto” può portare a spiacevoli sorprese, perché l’assenza di reazione può “rianimare” il credito in sede giudiziaria.
Dopo questa panoramica generale, passiamo ora a dettagliare i termini di prescrizione per le varie categorie di debiti e obbligazioni, con tabelle riepilogative e riferimenti normativi, per poi affrontare le situazioni in cui un debito prescritto può essere indebitamente rivitalizzato e come reagire.
Termini di prescrizione dei debiti: ordinari e particolari
La legge fissa diversi termini di prescrizione a seconda della natura del diritto di credito. Il termine ordinario di prescrizione per i diritti patrimoniali, salvo eccezioni, è di 10 anni . Tuttavia, molte tipologie di crediti sono soggette a termini più brevi (quinquennali, biennali, annuali, ecc.), in ragione della loro specificità. In questa sezione elenchiamo i principali termini di prescrizione per i debiti più comuni, distinguendo per categoria, e forniamo una tabella riepilogativa per orientarsi rapidamente.
Termine ordinario decennale (10 anni)
L’art. 2946 c.c. prevede che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” . Dunque, ogni credito per il quale non sia stabilito un termine diverso rientra nella prescrizione decennale. Rientrano nei 10 anni in via generale:
- Crediti derivanti da contratti ordinari e da obbligazioni civilistiche non soggette a termini brevi. Esempi: restituzione di un mutuo (capitale), saldo di un prezzo di vendita, restituzione di un prestito tra privati documentato in forma scritta, pagamenti dovuti in base a un contratto di appalto, risarcimento del danno contrattuale, ecc. (salvo quanto diremo su crediti con prestazioni periodiche).
- Debiti bancari in genere (finanziamenti, scoperti di conto corrente, fidi, ecc., fatta salva l’eventuale natura periodica di interessi e rate, di cui sotto).
- Debiti derivanti da sentenze o provvedimenti giudiziari di condanna passati in giudicato: in tal caso opera l’art. 2953 c.c., che converte il termine breve in decennale (il cosiddetto termine di prescrizione del giudicato, v. infra). Un decreto ingiuntivo non opposto, ad esempio, diventa definitivo e il credito in esso consacrato si prescrive in 10 anni dal passaggio in giudicato del decreto .
- Imposte, tasse e contributi previdenziali per i quali non sia espressamente previsto un termine più breve: come regola generale, i crediti erariali (tributi erariali quali IRPEF, IVA, IRAP, ecc.) dovrebbero prescriversi in 10 anni, salvo interpretazioni differenti della giurisprudenza in certi casi (si vedano dettagli nella parte sui debiti fiscali). Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto spesso la prescrizione decennale delle imposte statali iscritte a ruolo; oggi la Cassazione, pur ammettendo casi particolari, conferma che in assenza di norma specifica vale il decennio . Anche il canone RAI è soggetto a 10 anni .
- Altri crediti non altrove classificati: ad esempio, indennizzi una tantum o crediti di lavoro non rientranti in termini brevi (come le differenze retributive non soggette a prescrizione presuntiva, che comunque hanno regole proprie sul dies a quo in costanza di rapporto di lavoro).
In sostanza, quando non c’è una specifica previsione di legge che accorci il termine, il decennio è la regola di default.
Termini brevi di prescrizione (5 anni e altri termini ridotti)
Molte categorie di crediti invece si prescrivono in un termine inferiore a 10 anni, tipicamente 5 anni. L’art. 2948 c.c. elenca varie ipotesi di prescrizione quinquennale. In particolare, “si prescrivono in cinque anni”:
- Le annualità di rendite perpetue o vitalizie (canoni di rendite, ecc.) – (n.1)
- Il capitale dei titoli di Stato al portatore – (n.1 bis, introdotto successivamente)
- Le annualità delle pensioni alimentari (gli assegni periodici dovuti come alimenti) – (n.2)
- Le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazione**** – (n.3)
- Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi – (n.4)
- Le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (es.: trattamento di fine rapporto TFR, indennità di mancato preavviso, ecc.) – (n.5)
La categoria di cui al numero 4) è molto ampia e importante: include qualsiasi obbligazione a carattere periodico con scadenza annuale o inferiore. In questa fattispecie rientrano ad esempio: i canoni di locazione (già menzionati al n.3), le bollette e utenze con cadenza regolare, le rate di contratti continuativi, le spese condominiali ordinarie, gli interessi su somme dovute, le rate assicurative, e così via. Si tratta di prestazioni che maturano periodicamente e la legge presuppone che dopo 5 anni il creditore debba averle richieste se intendeva farle valere. È bene chiarire che il decorso per le prestazioni periodiche si computa separatamente per ciascuna di esse: ad esempio, il canone di locazione di gennaio 2020 si prescriverà a gennaio 2025 se non sono intervenuti atti interruttivi su quella mensilità; la pigione di febbraio 2020 a febbraio 2025, e così via.
Oltre alle ipotesi tipiche dell’art. 2948 c.c., varie leggi speciali prevedono termini brevi per specifici crediti. Ecco un elenco delle prescrizioni brevi più rilevanti in materia di debiti:
- Bollette di luce, gas, acqua*: attualmente *2 anni. In passato erano quinquennali per via del carattere periodico (art. 2948 n.4 c.c.), ma la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto la prescrizione biennale per i consumi di energia e gas (attuata da ARERA a partire dal 2018) e successivamente per il servizio idrico. Dal 1° marzo 2018 la prescrizione delle fatture elettriche è 2 anni, dal 1° gennaio 2019 quella delle fatture gas è 2 anni, e dal 1° gennaio 2020 quella del servizio idrico è 2 anni . Ciò significa che le compagnie di fornitura non possono più richiedere conguagli o pagamenti per consumi risalenti a oltre 2 anni rispetto alla data di fatturazione (salvo il caso in cui il ritardo sia dovuto a comportamento del cliente, ad esempio mancate letture per inaccessibilità del contatore). Questa è una tutela introdotta a favore di consumatori e piccole imprese per evitare le cosiddette “maxi-bollette” arretrate. Il cliente ha il diritto di eccepire la prescrizione breve e pagare solo gli ultimi 24 mesi fatturati . (Nota: eventuali importi di canone RAI addebitati in bolletta seguono invece la disciplina propria del canone, che è decennale come tributo erariale.)
- Bolletta telefonica (telefonia fissa e mobile) e abbonamenti internet: 5 anni. Questo rientra nella prescrizione quinquennale generale per servizi periodici. Non vi è (ad oggi) una norma che le riduca a 2 anni come per le utenze energetiche. Quindi una bolletta telefonica non pagata si prescrive in 5 anni dalla scadenza. Alcune normative degli anni ‘90 avevano previsto termini brevi (ad es. 3 anni per servizi radiomobili) ma sono state superate; il quadro attuale per telecomunicazioni è normalmente il quinquennio, salvo normative speciali per indennità o rimborsi.
- Spese condominiali: occorre distinguere. Le quote condominiali ordinarie (quelle dovute periodicamente, es. mensilmente o annualmente, per le spese di manutenzione ordinaria, pulizie, utenze condominiali, compenso amministratore, ecc.) si prescrivono in 5 anni, in quanto “debiti periodici” ai sensi dell’art. 2948 c.c. . Le quote condominiali straordinarie (contributi una tantum o di durata limitata, destinati a lavori straordinari, es. rifacimento facciata, installazione ascensore, ecc.), invece, essendo dovute in base a una delibera e non aventi carattere periodico annuo, seguono il termine ordinario di 10 anni . La Cassazione ha confermato tale distinzione: dal momento in cui l’assemblea approva lo stato di riparto o la delibera di spesa, l’amministratore ha 5 anni per riscuotere le quote ordinarie, e 10 anni per quelle straordinarie . Importante: il dies a quo (giorno iniziale) per la prescrizione delle quote condominiali decorre dall’approvazione del bilancio consuntivo in cui quelle spese sono ricomprese (per le ordinarie) , oppure dalla delibera che approva i lavori straordinari e il relativo piano di riparto (per le straordinarie) . Dunque, fino a che i conti non sono approvati dall’assemblea, formalmente il credito del condominio verso i condomini non è esigibile e la prescrizione non inizia. Una volta approvato, parte il quinquennio o decennio. Se l’amministratore notifica un decreto ingiuntivo per morosità e questo diventa definitivo (per mancata opposizione entro 40 giorni), il debito resterà esigibile anche oltre il termine, perché il condomino ha perso la chance di eccepire la prescrizione .
- Canoni di locazione (affitti): 5 anni. Rientrano nell’art. 2948 n.3 c.c. come “pigioni delle case” o “fitti dei beni rustici”. Ogni rata di affitto si prescrive in cinque anni dalla scadenza. Anche qui, se il locatore ha ottenuto sfratto e decreto ingiuntivo per canoni, una volta passato in giudicato tale titolo si applicherà il decennio (2953 c.c.), ma i canoni non domandati in giudizio entro 5 anni cadono prescritti.
- Rate di mutuo o finanziamento: la questione è complessa. In genere, per i mutui bancari le rate scadute non pagate sono composte di quota capitale e quota interessi. La quota interessi si prescrive in 5 anni (essendo interesse periodico) . La quota capitale invece si prescrive in 10 anni dal momento in cui è esigibile. Se la banca non risolve il contratto e mantiene il piano di ammortamento, ciascuna rata capitale è esigibile alla sua scadenza, quindi si potrebbe ragionare che ogni rata capitale isolatamente si prescriva in 10 anni da quando scade. Tuttavia, nelle prassi, in caso di inadempimento, la banca spesso esercita la decadenza dal beneficio del termine (dichiarando tutto il debito residuo immediatamente dovuto) oppure ottiene un decreto ingiuntivo per l’intero, il che unifica il credito in un titolo. In assenza di ciò, la giurisprudenza ha avuto orientamenti: c’è chi sostiene che il termine decennale per le rate decorra dalla scadenza dell’ultima rata (poiché il mutuo è obbligazione unica rateizzata) – il che porterebbe scenari di oltre 10 anni; ma l’orientamento prevalente è che ogni rata sia autonoma. Di certo, un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria consente alla banca di agire esecutivamente entro 20 anni sull’ipoteca (rinnovabile), ma il diritto personale di credito resta decennale. Dunque in pratica: debiti bancari (prestiti, finanziamenti) → capitale 10 anni, interessi 5 anni, rate soggette a possibili complicazioni se non accelerate. Un punto importante: per i conti correnti con affidamento (fido), dove il cliente ha un saldo passivo entro i limiti fido, la Cassazione ha chiarito che gli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese non si prescrivono singolarmente finché il conto rimane aperto e operante entro fido. Solo quando il conto viene chiuso o il fido revocato, il saldo diventa esigibile e inizia la prescrizione . Questo perché le rimesse su conto affidato che rientrano nell’oscillazione entro il fido non sono pagamenti definitivi ma movimentazioni interne: finché c’è fido attivo, la banca non può esigere il rientro immediato dello scoperto intrafido, quindi gli addebiti periodici non sono “dovuti” singolarmente. La Cass. civ. sez. I n. 15684/2025 ha ribadito che i costi addebitati su un conto in essere entro il fido non sono soggetti a prescrizione finché il rapporto prosegue . Solo gli eventuali versamenti che eccedono il fido (rimesse solutorie extrafido) possono costituire pagamenti soggetti a prescrizione decennale da quel momento. Questa regola è tecnica ma rilevante per chi analizza contenziosi bancari (ad es. ripetizione di interessi anatocistici decorsi oltre 10 anni).
- Stipendi, salari e altre retribuzioni: il diritto del lavoratore alle retribuzioni si prescrive in 5 anni (art. 2948 n.4 c.c. – periodico). Tuttavia, esiste la particolarità che la prescrizione inizia a decorrere, durante il rapporto di lavoro, solo quando il lavoratore ha stabilità di impiego (art. 2948 e 2949 c.c. interpretati dalla giurisprudenza): ad esempio, per i dipendenti privati a tempo indeterminato fino alle riforme degli anni ‘90 si diceva decorresse anche in costanza di rapporto, oggi tendenzialmente decorre dalla cessazione se il rapporto non era garantito da tutela reale. In ogni caso, una volta finito il rapporto, gli arretrati si prescrivono in 5 anni. Le indennità di fine rapporto (TFR), come detto, sono 5 anni dal momento in cui sono esigibili (cessazione del rapporto).
- Trattamenti pensionistici e previdenziali: le rate di pensione e simili si prescrivono in 5 anni (art. 2948 n.2 per pensioni alimentari, applicato estensivamente). I contributi previdenziali dovuti a enti (INPS, casse professionali) hanno un discorso a parte: fino al 1995 era 10 anni, poi la L. 335/1995 ha portato a 5 anni la prescrizione dei contributi (salvo atti interruttivi; anche qui però, se c’è sentenza, ritorna decennale). La Cassazione SS.UU. n. 23397/2016 ha risolto un lungo contrasto stabilendo che le cartelle per contributi previdenziali non opposte restano soggette al termine quinquennale proprio del credito, e non si trasformano in decennali . Oggi dunque i contributi INPS e INAIL si prescrivono in 5 anni, anche se la cartella è divenuta definitiva, salvo il caso in cui intervenga un giudicato giudiziario sul credito.
- Multe stradali (sanzioni per violazioni del Codice della Strada): attenzione, qui si parla impropriamente di prescrizione, ma tecnicamente il termine di 5 anni (art. 209 CdS richiamando L. 689/81) è una prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione. Quindi, dopo la notifica del verbale, l’ente ha 5 anni per riscuotere la multa, decorso cui la sanzione amministrativa pecuniaria si estingue. Anche le sanzioni amministrative in generale seguono il termine quinquennale (salvo sia stabilito diversamente). Se però la sanzione viene confermata da un giudice con sentenza passata in giudicato, torna ad applicarsi l’art. 2953 c.c. e si passa a 10 anni (vedi oltre, riguardo a sanzioni tributarie). Per i tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, ecc.), come vedremo, la giurisprudenza ha stabilito che il termine è 5 anni in quanto non c’è giudicato ma solo decadenze e poi prescrizione breve di natura tributaria.
- Titoli di credito: i titoli esecutivi di credito come cambiali e assegni hanno termini di prescrizione propri, molto brevi. Una cambiale si prescrive in 3 anni dalla scadenza (azione cambiaria), un assegno bancario in 6 mesi (azione cartolare). Tuttavia, se si perde l’azione sul titolo (perché prescritta), resta possibile agire in via causale (cioè far valere il rapporto sottostante, ad esempio la restituzione del prestito per cui la cambiale era stata emessa) entro il termine ordinario decennale, purché tale rapporto non sia anch’esso prescritto. Sono tecnicismi che riguardano più l’ambito creditizio-commerciale. Dal punto di vista del debitore, significa che se ha firmato una cambiale a garanzia di un debito, il creditore può agire rapidamente col titolo entro 3 anni; se lo perde, potrà citarlo per il debito originario ma qui potrà eccepirsi la prescrizione a seconda del caso (spesso l’emissione della cambiale interrompe la prescrizione del debito sottostante). In ogni caso, questi termini brevissimi non rientrano nell’elenco del codice civile ma in leggi speciali (Legge Cambiaria R.D. 1669/33). Vanno citati per completezza, benché i debiti da titoli cambiari siano meno comuni nella vita quotidiana odierna.
- Altri crediti con prescrizioni ultrabrevi (prescrizioni presuntive): il codice prevede all’art. 2954-2961 c.c. alcune prescrizioni di 6 mesi o 1 anno per pagamenti dovuti a determinate categorie (albergatori, commercianti al minuto, artigiani, insegnanti, prestazioni di professionisti ecc.). Questi termini brevissimi in realtà sono presunzioni di pagamento: si presumono pagati se decorre quel termine e il debitore afferma di aver pagato, a meno che il creditore non provi per iscritto il contrario. Non sono di grande rilievo pratico oggigiorno se non in casi peculiari, ma per esempio: il credito dell’albergatore per il soggiorno si prescrive in 6 mesi, quello del ristoratore in 6 mesi, del commerciante in 1 anno, dell’avvocato per le proprie parcelle in 3 anni (prescrizione presuntiva, diversa dalla sostanziale di 5 o 10 se c’è contratto scritto). Dal punto di vista del debitore, queste ipotesi significano che dopo breve tempo il debitore può semplicemente dire “ti ho pagato”, e il creditore che non ha ricevuto nulla difficilmente potrà vincere la causa se non ha ricevute firmate dal debitore (è un favor per il debitore per evitare vecchie pretese dove usualmente si paga a vista). Non approfondiamo oltre tali casi particolari, citati solo per completezza.
Di seguito, una tabella riassuntiva dei principali termini di prescrizione per tipologia di debito (situazione aggiornata al 2025):
| Tipo di debito | Termine di prescrizione | Norma di riferimento / Note |
|---|---|---|
| Obbligazione civile generica (nessuna specificità) | 10 anni (ordinario) | Art. 2946 c.c. |
| Debito da contratto (pagamento una tantum) | 10 anni | Art. 2946 c.c. (es: saldo prezzo, prestito tra privati documentato) |
| Debiti bancari – capitale di mutui, prestiti | 10 anni (capitale)<br>5 anni (interessi) | Art. 2946 e 2948 c.c. (interessi periodici)<br>Rate: prescrizione decorre dalla scadenza ultima se non accelerate (opinioni), ma ogni rata interessi è 5 anni. |
| Scoperti di c/c entro fido (interessi, commissioni) | Non decorre finché conto aperto entro fido | Cass. 15684/2025 (interessi intrafido non esigibili finché fido attivo) |
| Debiti per canoni di affitto (locazione) | 5 anni | Art. 2948 n.3 c.c. (pigioni case, fitti) |
| Spese condominiali ordinarie | 5 anni | Art. 2948 n.4 c.c. (pagamenti periodici)<br>Cass. 2046/1968 (principio consolidato), confermato da giurisprudenza attuale |
| Spese condominiali straordinarie | 10 anni | Art. 2946 c.c. (prestazione non periodica) |
| Bollette utenze domestiche – telefono | 5 anni | Art. 2948 n.4 c.c. (utenze periodiche non ricomprese nella riduzione biennale) |
| Bollette luce, gas (consumi post-2018) | 2 anni | L. 205/2017 (Bilancio 2018) e succ. – prescrizione biennale introdotta, ARERA Delib. 97/2018 |
| Bollette acqua (consumi post-2020) | 2 anni | L. 205/2017 come mod., in vigore dal 2020 (Arera) |
| Multe stradali e altre sanzioni amm.ve (non giudiz.) | 5 anni (dalla data notifica verbale o da evento interr.) | L. 689/1981 art.28, CdS art.209 – prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie.<br>Se confermate da sentenza passata in giudicato: 10 anni (2953 c.c.) |
| Tributi erariali (es. IRPEF, IVA) – non da giudicato | Controverso: orient. prevalente 10 anni | Cass. SS.UU. 23397/2016: cartella non impugnata non diventa giudicato → termine resta quello del tributo.<br>In mancanza disposizione specifica, spesso 10 anni . (Alcune Cass. minori hanno ritenuto 5 anni per omessa impugnazione, ma SU contrarie) |
| Tributi locali (IMU, TARI, ecc.) | 5 anni | Previsto da leggi (es. 296/2006 per ICI) o da giurisprudenza: Cass. SU 23397/2016 applicata analogicamente ai tributi locali come principio generale . |
| Contributi previdenziali (INPS, INAIL) | 5 anni (dal 1996 in avanti) | L. 335/1995 art.3 co.9. Confermato da Cass. SS.UU. 23397/2016 anche per cartelle non impugnate . (Prima del 1996 era 10 anni, oggi tutti i contributi cadono in 5) |
| Interessi (legali o convenzionali) su qualunque debito | 5 anni | Art. 2948 n.4 c.c. – qualsiasi interesse periodico, compresi interessi moratori, si prescrive in cinque anni via via che maturano. |
| Stipendi, salari, mensilità di lavoro | 5 anni (dalla cessazione o dalle singole scadenze) | Art. 2948 n.4 c.c. – credito periodico.<br>(Decorrenza: se rapporto di lavoro in corso, particolarità giurisprudenziali sulla decorrenza in costanza rapporto, v. supra) |
| Trattamento di fine rapporto (TFR) | 5 anni (dal termine rapporto) | Art. 2948 n.5 c.c. |
| Assegno di mantenimento (es. divorzile, per figli) | 5 anni per rate periodiche | Art. 2948 n.4 c.c. – equiparabile ad alimenti periodici. (Gli arretrati maturati si prescrivono in 5 anni ciascuno) |
| Risarcimento danni da fatto illecito (es. torti) | 5 anni (regola generale)<br>2 anni (danni da circolazione veicoli) | Art. 2947 c.c. – 5 anni dal fatto illecito ; eccezione: 2 anni per danni da incidenti stradali . <br>Se il fatto è reato con prescrizione penale più lunga: termine penale (azione civile) . |
| Titoli di credito: Cambiale | 3 anni (azione cambiaria diretta) | R.D. 1669/33 (Legge Cambiaria) art. 49. (Azione di regresso: 1 anno da protesto) |
| Titoli di credito: Assegno bancario | 6 mesi (azione cartolare) | R.D. 1736/33 art. 75. (Dalla scadenza termine presentazione) |
| Debito riconosciuto con sentenza passata in giudicato | 10 anni | Art. 2953 c.c. – conversione dei termini brevi in decennale actio iudicati. |
(La tabella sopra non è esaustiva di tutte le ipotesi, ma copre le più comuni in ambito civile, commerciale e tributario. I termini indicati decorrono salvo cause di sospensione o interruzione come detto in premessa. “Passata in giudicato” indica sentenza o altro provvedimento definitivo equiparabile a giudicato.)
Osserviamo che, quando un debito ha origine da un titolo giudiziale definitivo (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo non opposto, lodo arbitrale reso esecutivo, ecc.), il termine di prescrizione diviene sempre di 10 anni per effetto dell’art. 2953 c.c. , chiamato anche actio iudicati. Questo articolo stabilisce che se la legge prevede un termine breve (es. 5 anni) per un certo diritto, ma intanto su di esso interviene una sentenza di condanna passata in giudicato, da quel momento il diritto si prescrive in 10 anni (decorrenti dal passaggio in giudicato) . Attenzione: la Cassazione ha però chiarito che questa conversione si applica solo se c’è una pronuncia giurisdizionale sostanziale sul merito del diritto. Se invece il credito diventa definitivo per ragioni diverse da una condanna in giudizio – ad esempio, una cartella esattoriale non impugnata entro i termini – non c’è vero e proprio “giudicato” sul merito, quindi non scatta automaticamente l’art. 2953 c.c.. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la mancata impugnazione di un atto amministrativo di riscossione (cartella, avviso) comporta irretrattabilità del credito ma non la conversione della prescrizione breve in decennale . Pertanto, un tributo locale che di base ha 5 anni di prescrizione rimane 5 anni anche se la cartella è divenuta definitiva per mancata opposizione (non essendo intervenuta alcuna sentenza di condanna, ma solo la decadenza dall’opposizione) . Su questo torneremo parlando dei debiti fiscali.
Riassumendo, ogni tipologia di debito ha un suo “orologio” di prescrizione. Un buon avvocato o un debitore informato, di fronte a una richiesta di pagamento, dovrà innanzitutto qualificare il tipo di credito e individuare il termine applicabile, poi verificare quando è iniziato a decorrere (dies a quo) e se è stato interrotto o sospeso. Solo così potrà stabilire se il debito è effettivamente prescritto al momento presente. Nel prossimo capitolo esamineremo più da vicino singole categorie di debiti (fiscali, bancari, condominiali, ecc.), evidenziando le particolarità di ciascuna e le più recenti novità normative o giurisprudenziali rilevanti.
Analisi per categoria di debito: fiscale, bancario, condominiale, commerciale, privati
In questa sezione approfondiremo le diverse categorie di debiti, mettendo in luce per ognuna: il termine di prescrizione applicabile, la normativa di riferimento, eventuali pronunce giurisprudenziali importanti e le peculiarità (ad esempio eventi che possono allungarne o accorciarne il termine, differenze tra sottocategorie, strategie tipiche dei creditori e possibili difese per il debitore).
Debiti fiscali e tributari
I debiti fiscali comprendono imposte, tasse, tributi sia erariali (dovuti allo Stato, come IRPEF, IVA, imposta di registro, ecc.) sia locali (IMU, TARI, bollo auto, multe stradali comunali, ecc.), nonché i contributi previdenziali dovuti a enti come INPS, INAIL, casse professionali. La materia è complessa perché intreccia termini di decadenza (per l’accertamento) e termini di prescrizione (per la riscossione). Qui ci focalizziamo sui termini di prescrizione dei crediti tributari, cioè entro quando l’ente può esigere il pagamento una volta validamente formato il titolo impositivo, e sulle problematiche connesse alla “reviviscenza” di debiti tributari prescritti in seguito a determinate circostanze.
Termini di prescrizione dei tributi principali: La regola generale, come già indicato, è che se la legge non prevede un termine speciale, il credito tributario si prescrive in 10 anni. Ad esempio, per imposte come IRPEF, IVA, IRAP, il Codice Civile non prevede termini ad hoc, e molti giudici applicano il decennio ordinario . Tuttavia, su questo c’è stato dibattito: alcuni hanno sostenuto che anche i tributi erariali dovessero prescriversi in 5 anni per analogia ai tributi locali, ma la giurisprudenza di legittimità più recente propende per la tesi che, in mancanza di specifica disposizione, vale il decennio (perché la cartella esattoriale non è equiparabile a un giudicato, ma ciò non impone per forza la prescrizione quinquennale – semplicemente rimane il termine proprio del tributo, che se non definito altrove è 10).
Diverso è il caso di tributi per cui esiste una normativa specifica: ad esempio il bollo auto è per legge triennale (3 anni) – il DPR 43/73 e poi confermato da normative regionali; i tributi locali come ICI/IMU, TARI, TASI sono stati oggetto di pronunce oscillanti ma ormai assestati su 5 anni, spesso perché equiparati a prestazioni periodiche (IMU ogni anno dovuta, etc.) o perché norme come la Finanziaria 2007 li indicavano in prescrizione breve. La Cass. SU 23397/2016 ha testualmente affermato che “i tributi locali si prescrivono nel termine di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo” , affermando un principio generale di breve termine per imposte locali. Quindi oggi: IMU, TARI, Tosap/Canone Unico, Tassa Auto (bollo) – 5 anni. Questo vale anche se il contribuente non ha impugnato la cartella: non scatta il 2953 c.c. perché non c’è stata sentenza, e il termine rimane quello quinquennale tipico .
Per quanto riguarda i contributi previdenziali (INPS, INAIL): la L. 335/1995 art. 3 ha stabilito che i contributi si prescrivono in 5 anni (salvo atti interruttivi validi che potevano mantenere 10 per periodi transitori). Oggi, tutti i contributi obbligatori sono 5 anni, ad eccezione di quelli per cui vi sia stato accertamento giudiziario. La Cassazione SU 23397/2016 ha confermato che la mancata opposizione a cartella per contributi non trasforma la prescrizione in 10 anni . Quindi, se un’azienda riceve una cartella INPS per contributi e non fa opposizione, dopo 5 anni dalla notifica la pretesa contributiva si estingue comunque (sempre che nel frattempo l’INPS/Agente Riscossione non abbia compiuto atti interruttivi).
Sanzioni tributarie: le sanzioni amministrative per violazioni tributarie seguono una regola propria (D.Lgs. 472/1997). L’art. 20 di tale decreto stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in 5 anni. La Cassazione ha consolidato che una sanzione fiscale non impugnata in giudizio si prescrive in 5 anni . Solo se la sanzione viene confermata da una sentenza passata in giudicato (es: ricorso in CTP e CTR respinti e sentenza definitiva), allora si applica l’art. 2953 c.c. e diventa 10 anni dal giudicato . In pratica: se prendo una multa dall’Agenzia delle Entrate per omesso versamento IVA e non faccio ricorso, la sanzione rimane con prescrizione 5 anni. Se faccio ricorso e arrivo a sentenza definitiva sfavorevole, quella sanzione dal passaggio in giudicato si prescriverà in 10 anni (actio iudicati). Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo su imposte o sanzioni hanno natura autonoma e anch’essi quinquennale , essendo obbligazioni periodiche (art. 2948 n.4 c.c.). Ad esempio, la Cass. ord. n. 4969/2024 ha cassato una decisione che applicava 10 anni anche agli interessi su sanzioni: ha ribadito che interessi e sanzioni tributarie sono 5 anni, salvo giudicato per le sanzioni .
Atti interruttivi e momenti di decorso nei tributi: In ambito fiscale, bisogna tener conto che spesso i crediti tributari vengono prima accertati con un atto (avviso di accertamento, liquidazione, cartella ecc.) e poi, se non pagati, vengono riscolti con atti successivi (intimazioni, pignoramenti). L’inizio del decorso della prescrizione di un tributo generalmente si individua dalla scadenza del termine entro cui doveva essere pagato volontariamente o dall’ultimo atto valido. Ad esempio: per un accertamento IRPEF notificato il 10/10/2020 (dovuto in 60 gg.), se il contribuente non paga né ricorre, dal 60° giorno decorre il termine di prescrizione (probabilmente 10 anni, quindi dal 10/12/2020 al 10/12/2030, salvo interruzioni). La notifica della successiva cartella esattoriale è un atto interruttivo che sposta in avanti la prescrizione (oltre a essere soggetta a un termine di decadenza per la notifica stessa). Ogni intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, ogni sollecito o ogni azione esecutiva (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca) notificata interrompe la prescrizione, che riparte da zero. Ad esempio, per un tributo locale IMU con prescrizione 5 anni: la notifica di una cartella nel 2018 interrompe, poi magari la notifica di un’intimazione nel 2021 interrompe di nuovo, e così via.
Il caso della “cristallizzazione” dopo intimazione non impugnata: È recente (2025) un importante sviluppo giurisprudenziale riguardo ai debiti tributari prescritti e intimazioni di pagamento. La Cassazione, Sez. Trib., sent. 21 luglio 2025 n. 21240 ha stabilito un principio di grande rilievo: l’intimazione di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione (ex art. 50 DPR 602/1973, atto che viene dopo la cartella, per sollecitare il pagamento prima di esecuzione) costituisce atto impugnabile in Commissione Tributaria. Se il contribuente non la impugna tempestivamente (entro 60 giorni), l’intimazione “cristallizza” la pretesa tributaria e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione . In altri termini, se il fisco notifica un’intimazione su un credito in realtà già prescritto, il contribuente ha l’onere di fare ricorso in Commissione Tributaria e sollevare lì la prescrizione. Se non lo fa, passati i 60 giorni l’intimazione diventa definitiva e la possibilità di far valere la prescrizione è persa. Il debito viene “consolidato” e potrà essere riscosso. La Cassazione usa il termine “cristallizzazione della pretesa” . Questo non significa che la prescrizione sparisce per sempre, ma che non si può più eccepire quella già maturata fino alla notifica dell’intimazione. Da quel momento in poi, il termine di prescrizione (quinquennale o decennale a seconda del caso) riparte, ma il debitore non può far valere il fatto che fosse già scaduto prima. È come se l’intimazione, se non opposta, sanasse retroattivamente la decadenza da prescrizione. Questo è un cambio di prospettiva significativo e potenzialmente dirompente, perché impone al contribuente di non trascurare mai un’intimazione, neppure se convinto che il debito sia prescritto. Deve comunque impugnarla. La notizia di questa sentenza ha fatto scalpore, al punto che alcuni media hanno titolato “Debiti prescritti: ora tornano in vita se non impugni l’intimazione”. In realtà, la Cassazione non ha “resuscitato” un diritto già estinto – ha semplicemente detto: se non difendi il tuo diritto all’estinzione in sede processuale tributaria entro i termini, poi non potrai più farlo . Questo principio era in nuce già presente: l’intimazione è atto impugnabile come la cartella, e se non impugni atti impugnabili perdi le eccezioni opponibili. Ma è la prima volta che viene affermato in modo così esplicito per la prescrizione sopravvenuta di cartelle esattoriali. Dunque, per il debitore-contribuente, la lezione è: occhio alle intimazioni di pagamento. Se ricevi un’intimazione per vecchi debiti, verifica subito la prescrizione e, se ritieni che il credito fosse prescritto prima dell’intimazione, devi presentare ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni, eccependo la prescrizione. In mancanza, quell’intimazione diverrà incontestabile e il debito potrà essere riscosso, anche se in origine era prescritto .
A conferma, la Cassazione stessa parla di “preclusione”: il contribuente viene precluso dall’eccepire la prescrizione maturata prima della scadenza del termine di impugnazione . Questo concetto di preclusione è analogo a quanto avviene nel processo civile con le preclusioni processuali: c’è un “tempo” per ogni difesa, scaduto quel tempo, la difesa non è più ammissibile.
Strategie difensive del debitore in ambito fiscale: Per riassumere il punto di vista del debitore:
- Conoscere i termini: sapere quanti anni devono passare perché quel tributo cada in prescrizione. Ad esempio, se so che la TARI è 5 anni, e l’ultima cartella che ho ricevuto è del 2016 e poi più nulla, nel 2022 inizio a stare tranquillo (salvo interruzioni).
- Conservare la documentazione: le notifiche delle cartelle, avvisi, intimazioni, perché servono per calcolare le interruzioni. In caso di dubbio, è possibile richiedere all’Agente della Riscossione l’estratto di ruolo e la situazione dei carichi, dove figurano le date di notifica. Il debitore può così vedere se magari ci sono atti che lui non ricorda (es. una intimazione notificata via PEC).
- Eccepire tempestivamente la prescrizione: se arriva una cartella o un altro atto entro 60 giorni occorre fare ricorso alla Commissione Tributaria. Se l’atto è chiaramente notificato dopo che il debito è prescritto, il ricorso avrà ottime chance (giudici tributari riconoscono la prescrizione se eccepita). Se ci si lascia scappare i 60 giorni, quell’atto diventa definitivo.
- Attenzione ai provvedimenti di sgravio o sospensioni: in certi casi normative particolari (es. rottamazioni, sospensioni Covid) hanno previsto congelamenti dei termini o rinunce. Questi vanno considerati. Per esempio, l’adesione a una “rottamazione cartelle” interrompe la prescrizione e la sospende finché sei in regola con i pagamenti delle rate.
- Non dare per scontato nulla: come si vede dal caso intimazione, il fisco ha strumenti per consolidare le pretese. Anche in materia di crediti erariali, spesso l’Agenzia contesta la prescrizione quinquennale e invoca il decennio. Ci sono state pronunce non univoche (alcune sezioni ordinarie pro-5 anni, altre pro-10). La Cass. 25222/2024 ad esempio ha ritenuto decennale la prescrizione di un’imposta fondata su accertamento definitivo da sentenza . E la Cass. 35907/2023 ha ribadito che, se non c’è sentenza di merito, resta la prescrizione propria (non il decennio) , quindi orientamento confermato per i casi di estinzione del giudizio senza decisione. Il quadro quindi è: se c’è stato un giudice a decidere sul tributo, decennio; altrimenti, se l’accertamento è solo amministrativo e non impugnato, si cerca la norma specifica (per locali e contributi c’è, per erariali no quindi decennio).
In conclusione per i debiti fiscali: la prescrizione è un’arma potente in mano al debitore, perché i tempi della riscossione spesso sono lunghi e costellati di vizi. Ma va usata con competenza e tempestività. Gli enti creditori, d’altro canto, hanno a disposizione meccanismi come la “cristallizzazione” tramite atti non impugnati, perciò il debitore non deve mai restare inerte se riceve comunicazioni relative a vecchi debiti. Nei prossimi capitoli, vedremo nello specifico come reagire legalmente a richieste di debiti prescritti, ma ora proseguiamo l’analisi per le altre categorie di debiti.
Debiti bancari (prestiti, mutui, conti correnti)
I debiti verso banche o finanziarie includono mutui ipotecari, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente, scoperti di conto, carte di credito revolving, leasing, ecc. La prescrizione di questi debiti segue le regole generali viste sopra, ma con alcune peculiarità legate alla natura dei rapporti bancari e alle clausole contrattuali.
- Mutui e finanziamenti con rate: Come accennato, le singole rate scadute di un mutuo contengono interessi (quinquennale) e capitale (decennale). Spesso però in caso di inadempimento si verifica la decadenza dal beneficio del termine: la banca, dopo un certo numero di rate non pagate (di solito 7 nel mutuo fondiario o secondo contratto), può esigere l’intero residuo immediatamente. Se la banca dichiara la decadenza e comunica al debitore la richiesta di pagamento dell’intero, da quel momento tutto il debito residuo diviene esigibile in blocco e la prescrizione di 10 anni decorre da tale comunicazione (o dalla risoluzione del contratto). Se invece la banca non comunica formalmente la risoluzione e decadenza, si può discutere se le rate non pagate oltre un certo tempo siano prescritte una ad una. Per prudenza, le banche tendono a inviare formali atti di messa in mora che interrompono continuamente la prescrizione. Ad esempio, se un mutuo ha ultima rata nel 2030 ma il debitore smette di pagare nel 2025, la banca nel 2026 gli intima il pagamento integrale: la prescrizione dell’intero (capitale) scadrà nel 2036 (10 anni dall’intimazione), mentre gli interessi di mora comunque cadono a 5 anni via via. C’è un orientamento minoritario (talvolta citato) secondo cui in caso di mutuo non risolto, la rata omessa si prescriverebbe 10 anni dopo la scadenza contrattuale dell’ultima rata (argomentando che finché dura il piano non c’è inadempimento definitivo). Tuttavia è una costruzione forzata; più corretto dire: ogni rata dà luogo a inadempimento e da lì la banca può agire, quindi la prescrizione di quella prestazione decorre.
- Crediti da conto corrente: se un conto corrente è scoperto senza fido (ovvero con saldo negativo che la banca potrebbe chiedere in ogni momento), il debito del correntista è esigibile a vista e dunque la prescrizione decorre dal momento in cui lo scoperto si è verificato (salvo riconoscimenti, pagamenti parziali, ecc.). Se invece c’è un affidamento (fido), come detto, la situazione cambia: finché il conto resta aperto e l’affidamento non è revocato, le voci annotate “entro fido” non sono considerate obbligazioni esigibili singolarmente. Quindi la prescrizione del credito della banca inizia a decorrere quando il rapporto si chiude o quando il fido viene revocato e la banca intima il rientro. È frequente nei contenziosi di anatocismo e competenze bancarie che la banca eccepisca la prescrizione decennale di versamenti fatti dal cliente oltre 10 anni prima della citazione, sostenendo che erano pagamenti solutori di interessi indebiti. E il correntista replica che quei versamenti erano entro fido e quindi non pagamenti ma semplici rimesse. La Cassazione in varie sentenze (es. Cass. 9479/2022, Cass. 9141/2020, fino alla citata Cass. 15684/2025) ha abbracciato il criterio del saldo disponibile rettificato: solo i versamenti che riducono un saldo passivo oltre il fido (o su conto senza fido) sono considerati pagamenti soggetti a prescrizione, mentre quelli su conto in affidamento fino a concorrenza fido sono semplici ripristini di disponibilità e non fanno decorrere alcuna prescrizione per eventuali ripetizioni . Questo è un aspetto tecnico, ma da debitore può essere utile sapere che: se la banca, dopo 15 anni, mi chiede scoperto di conto, non posso eccepire prescrizione per il periodo in cui il conto era in funzione con affidamento salvo capire quando è stato chiuso. Di solito però, una volta chiuso il conto o revocato il fido, la banca in tempi rapidi (entro 1-2 anni) agisce, quindi raramente si porrà problema prescrizione decennale su ciò (a meno di inerzie lunghe).
- Debiti da carte di credito revolving o cessione del quinto: Questi sono finanziamenti con rate mensili. Analoghi a prestiti personali; quindi regola 10 anni per il capitale dall’ultima rata prevista o dalla risoluzione, e 5 per interessi. Le finanziarie in genere sollecitano e interrompono spesso.
- Debiti da garanzie (fideiussioni, avalli): Se il soggetto era garante per debito altrui e paga, poi avrà regresso; se non paga e la banca gli chiede il pagamento in via di escussione di garanzia, la prescrizione dipende dal rapporto garantito. Una fideiussione segue la sorte dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c. pone un termine breve per escutere il fideiussore dopo scadenza obbligazione principale, ma se il creditore agisce entro quel termine la prescrizione è la medesima del debito). Ad esempio, se Tizio era fideiussore di un mutuo, la banca deve escuterlo entro i tempi previsti (entro 6 mesi dalla scadenza ultima rata se non ricordo male, altrimenti la fideiussione si estingue per decadenza); se lo escute, il fideiussore può eccepire prescrizione del debito come farebbe il debitore principale. Ci sono anche sentenze su aspetti particolari (ad es. Cass. 27691/2018 sul diritto di regresso tra fideiussori in solido – 10 anni).
- Assegni scoperti, sconfinamenti, penali bancarie: se la banca applica delle penali o commissioni per sconfinamenti, quelle sono dovute subito e quinquennali perché periodiche. Ma se il conto era affidato, come detto, finché entro fido non scattano.
- Decreti ingiuntivi bancari: In moltissimi casi, le banche appena il cliente non paga emettono un decreto ingiuntivo (ad esempio per saldo di conto, o rate insolute). Se il decreto diventa definitivo (non opposto), il credito va in actio iudicati decennale da quel momento. Quindi un debito bancario originariamente soggetto a 10 anni magari non ancora maturati, con un decreto, avrà altri 10 anni dal 2025 (se il decreto passa in giudicato nel 2025, fino al 2035 se nessuna interruzione). Tuttavia, attenzione: la banca deve comunque compiere atti interruttivi anche dopo il decreto, altrimenti il titolo esecutivo si prescrive (ex art. 2953 c.c.) dopo 10 anni. Ad esempio, un decreto ingiuntivo del 2010 non eseguito né rinnovato, nel 2020 non è più azionabile. Ma le banche di solito notificano un atto di precetto o un pignoramento entro quel decennio, interrompendo e rinnovando per altri 10. Infatti, i titoli esecutivi giudiziari hanno la caratteristica di essere rinnovabili indefinitamente con atti interruttivi (precetto, atto di esecuzione): ogni atto esecutivo notificato interrompe la prescrizione decennale del diritto di procedere esecutivamente e fa decorrere un nuovo termine decennale (non confondere con efficacia del precetto che è 90 giorni, qui parliamo di prescrizione). Così a volte accade che la banca, pur con decreto vecchio, riesca a mantenere in vita il credito notificando periodicamente (prima che scada il decennio) un precetto o un atto esecutivo, impedendo la prescrizione. Il debitore deve quindi vigilare anche su questo: se sono passati quasi 10 anni da un titolo senza che la banca si faccia viva, scaduto il decennio potrà opporsi ad eventuale esecuzione tardiva eccependo la prescrizione del titolo; ma se la banca nel frattempo ha inviato un precetto (anche se poi non ha pignorato), quel precetto vale come interruzione (purché regolarmente notificato).
- Riconoscimento del debito: Nelle relazioni bancarie a volte il debitore firma ricognizioni di debito o piani di rientro. Tali atti costituiscono un riconoscimento che interrompe la prescrizione (art. 2944 c.c.) e, se il debito era già prescritto, valgono come rinuncia tacita alla prescrizione (art. 2937 c.c.). Ad esempio, se un debitore aveva un vecchio scoperto del 2010 mai sollecitato e nel 2021 firma una dichiarazione “riconosco di dovere €10.000 e pagherò a rate”, egli sta di fatto rinunciando alla prescrizione compiuta e non potrà più opporla. Spesso le banche o società di recupero cercano questo: far firmare al debitore un acknowledgment. Suggerimento dal lato debitore: non firmare mai accordi, piani di rientro o bollettini se si ha anche solo il dubbio che il debito sia già prescritto, senza prima aver consultato un legale; quella firma farebbe rivivere il debito definitivamente.
In sintesi per i debiti bancari: La prescrizione è generalmente 10 anni, ma i crediti bancari raramente restano “in sonno” così a lungo senza azioni. Inoltre, per spezzare la difesa della prescrizione, banche e recuperatori fanno spesso leva su atti del debitore (pagamenti minimi, promesse di pagamento, comunicazioni registrate) da cui desumere riconoscimenti. Il debitore deve essere cauto e calcolare bene i tempi, magari con l’ausilio di un legale che ricostruisca la cronistoria del rapporto e individui eventuali interruzioni.
Debiti condominiali
I debiti condominiali sono i crediti che il condominio (ossia la collettività dei condomini, rappresentata dall’amministratore) vanta verso i singoli proprietari per la loro quota di spese comuni. Come visto, qui bisogna distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie:
- Quote ordinarie: riguardano manutenzione ordinaria, servizi ricorrenti (luce scale, pulizia, giardinaggio), assicurazione stabile, compenso annuale dell’amministratore, piccolo fondo cassa, ecc. Sono importi tendenzialmente fissi o comunque periodici, dovuti di solito con cadenza mensile/trimestrale. Prescrizione: 5 anni . La giurisprudenza (tra cui Cass. n. 4489/2014 e altre) conferma che rientrano nell’art. 2948 c.c. come “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
- Quote straordinarie: contributi deliberati una tantum o per un numero limitato di rate, volti a coprire spese straordinarie (rifacimento tetto, installazione ascensore, ristrutturazioni importanti). Prescrizione: 10 anni , perché non sono pagamenti dovuti “ad anno o meno”, bensì derivano da una deliberazione specifica che genera un’obbligazione unica (anche se rateizzata).
Decorrenza della prescrizione: come anticipato, non decorre da quando la spesa è effettuata, ma da quando l’assemblea approva il rendiconto (per le ordinarie) o la delibera straordinaria (per le straordinarie) . Esempio: spese ordinarie 2021 approvate in assemblea ad aprile 2022 → prescrizione inizia da aprile 2022 per 5 anni, quindi fino aprile 2027 l’amministratore può agire per riscuoterle (salvo interruzioni); trascorso quel termine, il condomino può eccepire prescrizione. Per spese straordinarie, se delibera di lavori è del 1° giugno 2023 con riparto quote, il condominio ha fino al 1° giugno 2033 (10 anni) per esigere.
Atti interruttivi: l’amministratore, per interrompere la prescrizione, può inviare un sollecito di pagamento scritto (meglio se raccomandata A/R o PEC). Atti informali come avvisi lasciati nella cassetta delle lettere o comunicazioni verbali non interrompono . Neppure una e-mail semplice (non PEC) interrompe, a meno che il condomino risponda ammettendo di aver ricevuto e di dovere (il che varrebbe come riconoscimento) . Quindi, il condominio per tutelarsi deve usare strumenti formali. Naturalmente, l’atto giudiziario come il decreto ingiuntivo è un fortissimo atto interruttivo.
Decreto ingiuntivo e giudicato: se l’amministratore ottiene un decreto ingiuntivo verso il condomino moroso e questo non viene opposto, il decreto diventa definitivo (giudicato) e il debito, a prescindere dalla prescrizione originaria, si consolida. Anche se al momento della notifica del decreto alcune quote erano più vecchie di 5 anni, il condomino che non si oppone nei 40 giorni perde l’occasione di eccepirlo . Il decreto acquista efficacia di cosa giudicata e, secondo l’art. 2953 c.c., il credito risultante si prescriverà in 10 anni da allora. Dunque, come regola pratica: le eccezioni di prescrizione sulle spese condominiali vanno sollevate presentando opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, altrimenti quelle spese saranno dovute anche se erano datate. Ci sono casi giurisprudenziali di decreti ingiuntivi a cui il condomino non si è opposto credendo che il giudice “vedrà che erano vecchie e non le concede”: errore, perché vale lo stesso discorso di eccezione in senso stretto.
Uso strumentale della prescrizione nei condomini: talvolta, condomini morosi cercano di “tirare in lungo” per far prescrivere le spese. Ad esempio, confidano nell’inerzia di amministratori. C’è da dire che la legge (art. 1129 c.c.) impone all’amministratore di agire per la riscossione coattiva entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo, salvo autorizzazione assembleare a soprassedere. Quindi un amministratore diligente non lascerebbe passare 5 anni. Però in condomini litigiosi, può succedere che l’amministratore temporeggi. Comunque, il condomino che voglia invocare la prescrizione deve contare i 5 o 10 anni dalla delibera, verificare che in quel frattempo non abbia ricevuto raccomandate o ingiunzioni, e nel caso in cui il condominio, trascorso il termine, tenti ancora di esigere (magari portando in approvazione un vecchio credito in un consuntivo successivo), opporsi per iscritto.
Difesa del debitore-condomino: se ritiene di essere al riparo per prescrizione, può inviare all’amministratore una lettera formale in cui contesta il debito perché riferito a esercizi caduti in prescrizione, citando l’art. 2948 c.c. e l’anno di approvazione del rendiconto. Se il condominio ha già fatto decreto ingiuntivo, deve fare opposizione eccependo la prescrizione nel primo atto difensivo. Se il termine è abbondantemente scaduto e l’amministratore persevera, il condomino potrà far valere la prescrizione come eccezione anche in sede di esecuzione eventualmente (opposizione a precetto es. art. 615 c.p.c.), ma meglio non arrivare a quel punto: conviene agire prima in via giudiziale per l’accertamento negativo se necessario.
Infine, un cenno: anche nel microcosmo condominiale valgono i principi generali di rinuncia alla prescrizione. Quindi, se il condomino in assemblea (o tramite corrispondenza) riconosce di dovere quelle somme vecchie e magari chiede tempo, potrebbe aver implicitamente rinunciato alla prescrizione maturata. Occorre prudenza: ad esempio, firmare un piano di rientro col condominio su spese arretrate prescritte costituirebbe certamente rinuncia.
Debiti commerciali e tra privati
Questa categoria è un po’ generica: include tutti i debiti derivanti da rapporti commerciali tra imprenditori (fornitore-cliente, contratti di impresa, ecc.) e debiti tra soggetti privati non rientranti nelle altre categorie (ad esempio un prestito tra amici non formalizzato, la restituzione di una caparra in un contratto tra privati, i compensi di professionisti, etc.). I principi di prescrizione qui sono essenzialmente quelli generali: ordinario 10 anni, salvo rientrare in qualche ipotesi di termine breve (5 anni in primis).
Fatture commerciali tra imprese: La fornitura di beni o servizi da un’impresa a un’altra genera un credito che, se è una tantum (es. vendita di un macchinario), è 10 anni. Se invece è una fornitura periodica continuativa, alcune giurisprudenze hanno talvolta fatto analogie con l’art. 2948 n.4 c.c. (prestazioni periodiche) stabilendo 5 anni; ma in realtà la vendita di beni dietro fattura non è “periodica ad anno” se è puntuale. Spesso comunque i creditori agiscono prima di 5 anni. Un caso tipico: fatture di utenze aziendali (telefono business, energia per azienda) – già coperto dalle regole viste (spesso 5 anni o 2 anni per energia).
Compensi di professionisti (avvocati, notai, ingegneri): qui c’è la particolarità delle prescrizioni presuntive triennali per il compenso di professionisti (art. 2956 c.c.). Significa che se un avvocato non chiede il pagamento entro 3 anni dalla prestazione, e poi ci prova, il cliente può dire “presumo di averti pagato” e sta all’avvocato dimostrare di non essere stato pagato con qualcosa di scritto (e se non ce l’ha, la legge presuppone che ha ricevuto il pagamento). Quindi, dal lato debitore, il cliente dopo 3 anni potrebbe opporre quella presunzione. Questa però è un’eccezione particolare e non attiene all’estinzione del diritto in senso sostanziale, ma a una finzione giuridica probatoria. Se il cliente ammette di non aver pagato, anche dopo 10 anni, il debito rimane. Quindi è un’eccezione che va usata con cautela: il cliente dovrebbe, in giudizio, dichiarare di aver pagato il professionista e la legge gli evita di dover mostrare ricevute per fatti molto antichi (perché si presume li abbia persi). Lo menzioniamo per completezza perché può capitare a privati.
Debiti riconducibili a atti scritti vs verbali: Un’altra distinzione codicistica è la seguente: l’art. 2944 c.c. (interruzione da riconoscimento) e l’art. 2720 c.c. influenzano la prova. Ma non c’è in Italia, a differenza di altri Paesi, una regola che contratti scritti hanno prescrizione diversa da contratti orali (in Francia per esempio c’è differenza). In Italia non importa se il contratto era scritto o orale: la prescrizione è la stessa. Ciò che cambia è la prova. Un prestito tra amici non messo per iscritto: in teoria prescrizione 10 anni perché è un mutuo semplice; però dopo 10 anni oltre a prescriversi, il creditore non avrebbe nemmeno prova scritta e sarebbe difficile in giudizio (ma questo è un profilo probatorio, non di prescrizione).
Obbligazioni alimentari e di mantenimento: Vale la regola delle prestazioni periodiche: 5 anni per ogni rata (es. l’assegno di mantenimento mensile per ex coniuge, come già detto). Debiti di natura familiare (restituzione di prestiti in famiglia) – 10 anni se qualificabili come mutuo, oppure se erano più donazione non sarebbero proprio dovuti.
Debiti derivanti da arricchimento senza causa o ripetizione indebito: Se Tizio ha pagato per sbaglio Caio e vuole indietro i soldi, quel diritto (azione di indebito arricchimento) si prescrive in 10 anni dal giorno del pagamento. Non è un “debito” iniziale ma un credito di rimborso – rientra comunque nel 10 anni (giurisprudenza consolidata).
Debiti per danni: Se Tizio deve risarcire Caio per un danno extracontrattuale (es. lo ha diffamato, o ha causato danni), Caio aveva 5 anni per agire come da art. 2947, trascorsi i quali Tizio può rifiutare di pagare perché prescritto. Diverso se c’è stata condanna penale come detto. Dal punto di vista del debitore (il danneggiante): se passano 5 anni e la vittima non ha chiesto danni, può considerarsi al sicuro salvo eccezioni.
Debiti tra soci in affari, conti tra contitolari: Spesso sono rapporti di durata dove finché c’è la società di fatto aperta non decorrono termini, poi si conteggiano e decennio.
In generale, per i debiti tra privati e commerciali, le strategie difensive contro la prescrizione dei creditori possono essere: l’invio di costanti solleciti scritti (ogni tot mesi o anni, raccomandate) per interrompere; l’utilizzo di società di recupero crediti che telefonano (le telefonate non interrompono, ma spesso a seguito di esse i debitori fanno una promessa via e-mail o un piccolo pagamento, che invece vale); e naturalmente l’azione legale (ingiunzione). Mentre dal lato debitore la strategia, se vuole far decorrere la prescrizione, è non dare mai segno di riconoscimento, non pagare neanche parzialmente, e possibilmente non farsi trovare – ma attenzione: se una raccomandata non viene ritirata ed è inviata correttamente, per la legge è comunque notificata (dopo 10 giorni in giacenza). Quindi ignorare non sempre è utile: il silenzio del debitore non ferma l’interruzione se l’atto è notificato secondo regole. Diverso è se il creditore manda solo solleciti ordinari via posta semplice o e-mail: quelli non bastano legalmente. Dunque un debitore smaliziato potrebbe sperare che il creditore non invii mai raccomandate o atti giudiziari, lasciando passare il tempo.
Esempio pratico: un commerciante (creditore) ha emesso fattura nel 2018 verso una ditta, ma poi non la sollecita formalmente mai; nel 2024 prova a incaricare un recupero crediti che chiama la ditta debitrice. La ditta può, a quel punto, se viene eventualmente citata in causa nel 2025, eccepire che il credito (2018→2025) è prescritto (7 anni). Il creditore in giudizio proverà magari ad allegare che ci fu un’e-mail del 2020 del debitore che “chiedeva più tempo” – quella e-mail, se provata, potrebbe costituire riconoscimento del debito e quindi aver interrotto la prescrizione nel 2020, spostando la scadenza al 2030. Sarà battaglia probatoria: quell’e-mail era firmata? Il contenuto era chiaro? ecc.
Questo scenario illustra come nei rapporti privati e commerciali la linea tra riconoscimento e semplici trattative può essere sottile. Ad esempio, una risposta “Sto verificando le fatture, le farò sapere” non è un riconoscimento; mentre “So di doverla pagare, ma ho problemi, pago tra due mesi” è sicuramente riconoscimento.
Nota sulle pratiche scorrette dei recupero crediti: Molte società di recupero, specie su crediti tra privati/commerciali o bancari acquistati, inviano lettere genericamente (anche dopo anni) e citano cause se non paghi. Spesso con crediti prescritti provano ugualmente. Qui c’è da considerare anche la tutela del Codice del Consumo: l’AGCM (Autorità Antitrust) è intervenuta più volte sanzionando società di recupero che minacciavano azioni legali su crediti presumibilmente prescritti, giudicando ciò come pratica commerciale aggressiva e scorretta . Ad esempio, nel 2013 sanzionò un’impresa per aver inviato in tutta Italia atti di citazione falsi presso giudici di pace incompetenti per crediti prescritti, al solo scopo di intimidire i consumatori e indurli a pagare . Anche nel 2014 l’AGCM multò alcune società (Elliot, Ge.Ri.) per aver inviato richieste di pagamento di crediti molto vecchi minacciando cause immediate . Quindi, se un privato riceve insistenti pressioni su un debito che sa essere ormai prescritto, può segnalarlo all’Antitrust (se rientra in ambito consumer) o rivolgersi a un’associazione di consumatori. Le imprese di recupero rischiano multe salate se usano l’espediente della minaccia temeraria di cause su debiti non esigibili . Ad ogni modo, il debitore rimane tenuto a eccepire la prescrizione in giudizio se la controparte deposita effettivamente un ricorso o una citazione. La rilevanza dell’intervento AGCM è soprattutto inibitoria: può far cessare telefonate e lettere moleste e sanzionare l’operatore scorretto, ma non estingue il debito (che era già estinto di suo per legge, semmai).
In definitiva, per privati e imprenditori debitori in rapporti non regolati da normative specifiche, vale il mantra: tenere traccia delle date, non riconoscere debiti vecchi e far valere la prescrizione alla prima occasione utile. Nei prossimi paragrafi, passeremo a trattare proprio quando e come far valere questa eccezione, ossia come reagire se vi viene chiesto un pagamento che ritenete prescrtitto.
Quando un debito prescritto può tornare esigibile
Alla luce di quanto esposto, parrebbe che una volta che un debito è prescritto – ossia decorso il termine senza atti interruttivi – il debitore sia definitivamente al sicuro. Ma non è sempre così semplice. Ci sono situazioni in cui, in maniera indiretta o surrettizia, un debito “prescritto” può tornare a essere esigibile. Analizziamo le principali ipotesi:
1. Mancata eccezione di prescrizione in giudizio
Questo è il caso più comune e già richiamato più volte: se il creditore, pur dopo la maturazione della prescrizione, avvia un’azione legale (ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione, ecc.), il giudice non dichiarerà d’ufficio che il debito è prescritto. Sarà compito del debitore eccepirlo tempestivamente. Se ciò non avviene, si rischia che il giudice pronunci una sentenza di condanna o emetta un provvedimento esecutivo in favore del creditore. Una volta formatosi un titolo giudiziale, il debito diventa esigibile in base a quel titolo, anche se originariamente il diritto era prescritto. In pratica, come visto, il debitore che resta inerte di fronte a un’azione legale su un credito prescritto rinuncia implicitamente al beneficio della prescrizione. Ad esempio, ricevere un decreto ingiuntivo su un vecchio debito e ignorarlo (o costituirsi in ritardo, o dimenticare di eccepire la prescrizione) equivale a perdere per sempre la possibilità di far valere la prescrizione, e il debito “risorge” con veste di titolo esecutivo giudiziario. L’unico rimedio sarebbe cercare di impugnare quel provvedimento per altri motivi (es. opposizione tardiva se c’è vizio di notifica). Ma se la notifica è regolare e i termini scaduti, non c’è più scampo: bisognerà pagare.
Quando questo accade? Spesso con debiti di persone poco informate: ad esempio, vecchi debiti di prestito o di bollette per cui la finanziaria avvia causa in tribunale e il convenuto non si presenta – il giudice, non avendo l’eccezione, emette sentenza di condanna (magari nemmeno menziona la prescrizione). Oppure con cartelle esattoriali non impugnate in Commissione Tributaria (come nel caso Cass. 21240/2025: il contribuente che non ricorre avalla di fatto la riscossione anche di un credito prima prescritto) .
Dunque, prima regola: un debito prescritto non torna esigibile di per sé, ma torna esigibile se il debitore si lascia sfuggire l’eccezione nei modi e tempi dovuti. È una “ri-esigibilità” per inerzia processuale del debitore.
2. Riconoscimento o pagamento volontario del debitore
L’altra grande ipotesi è quando è il debitore stesso a compiere atti che “rivitalizzano” il debito. La legge, come visto, prevede all’art. 2937 c.c. che la prescrizione compiuta possa essere rinunciata dal debitore. La rinuncia può essere espressa (una dichiarazione esplicita: “rinuncio alla prescrizione e pagherò il debito”) oppure tacita, desumibile da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Quali comportamenti? Il più evidente è pagare (anche parzialmente) il debito prescritto. Se pago, ad esempio, la metà di un debito già prescritto, sto mostrando di considerarlo ancora dovuto – sto perciò rinunciando al diritto di non pagarlo. Oppure promettere di pagare: ad esempio firmare un accordo transattivo per dilazionare un debito ormai prescritto, oppure semplicemente scrivere una lettera/e-mail ammettendo il debito e chiedendo tempo. Tutti questi costituiscono riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.) o comunque atto incompatibile con la volontà di opporre la prescrizione. L’effetto è duplice: se il termine di prescrizione era in corso, l’atto lo interrompe e lo fa ripartire; se il termine era già scaduto, l’atto vale come rinuncia alla prescrizione già maturata, quindi il debito “rivive” ed è come se ripartisse un nuovo periodo di prescrizione ex novo da quell’atto.
Esempi concreti:
– Un privato ha un debito verso banca per una carta di credito non pagata dal 2015; nel 2023 la società di recupero lo contatta e lui, intimorito, versa 100 € “a titolo di acconto”. Quel versamento, anche se minimo, costituisce riconoscimento del debito e riapre i termini: la prescrizione (che sarebbe maturata nel 2020, quinquennale, se non ci fossero stati atti) viene considerata rinunciata e da quel pagamento nel 2023 decorre un nuovo termine di 10 anni per il resto . La società potrà così, entro il 2033, agire per l’intero (meno i 100€).
– Un’azienda creditrice rinuncia a far causa per vecchie fatture del 2017 (ormai quasi 6 anni); nel 2024 il debitore le scrive “riconosciamo il nostro debito di €50.000, stiamo attraversando difficoltà, proporremo un piano”. Questa lettera mette il creditore al sicuro: la prescrizione che sarebbe scattata dopo pochi mesi viene interrotta e il debitore non potrà più cambiar idea dicendo che era prescritto, perché ha riconosciuto per iscritto.
– Un inquilino moroso per affitti 2016-2017 (prescritti nel 2022) lascia l’alloggio e firma, nel 2023, un accordo con il proprietario dove si impegna a restituire un certo importo a saldo di tutti i debiti pregressi. Anche qui, l’inquilino ha implicitamente rinunciato a eccepire la prescrizione su quelle mensilità, che viceversa avrebbe potuto non pagare. Se poi non paga secondo l’accordo, il proprietario potrà citarlo e l’inquilino non potrà dire “ma quelle erano 2016 quindi prescritte”, perché il giudice considererà l’accordo una novazione/riconoscimento successivo.
Attenzione, c’è anche un limite: la rinuncia alla prescrizione, per essere valida, deve avvenire dopo che la prescrizione è compiuta. Non si può rinunciare anticipatamente a prescrivere (art. 2937 vieta patti preventivi di non prescrizione). Quindi, una clausola contrattuale tipo “il debitore rinuncia sin d’ora alla prescrizione” non ha effetto. Però spesso i creditori non hanno bisogno di tali clausole: contano sul fatto che il debitore, ignorando di avere un’obbligazione ormai “non più azionabile”, la riconosca comunque, soprattutto per motivi morali o di rapporti continuativi.
Un caso particolare: pagamento spontaneo di debito prescritto. Se il debitore, senza nemmeno essere sollecitato, paga un debito vecchio, poi si pente e chiede indietro i soldi, la legge (art. 2940 c.c.) glielo impedisce: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.” . Questo significa che il pagamento di un debito prescritto è valido come adempimento di un’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.). Quindi, il debitore che versa non può invocare l’ingiustificato arricchimento o l’indebito per farsi restituire la somma: il creditore potrà legalmente trattenerla. Pertanto, pagare tacitamente equivale a rinunciare alla prescrizione. Molti debitori non lo sanno: magari saldano vecchi bollettini convinti di doverlo fare, e poi qualcuno dice loro “ma era prescritto!”. Purtroppo, non c’è rimedio: quel denaro è perso.
Riassumendo, un debito prescritto “torna esigibile” (o meglio, rimane esigibile nonostante la prescrizione) se il debitore stesso lo fa rivivere, pagando o riconoscendolo dopo la prescrizione. Da quel momento, il creditore può pretendere il residuo e agire giudizialmente come se fosse un nuovo debito.
3. Condotte ingannevoli o inducenti in errore il debitore
Questa non è una categoria giuridica a sé, ma vale la pena menzionare: a volte i creditori cercano di far ripartire un debito prescritto attraverso condotte al limite della correttezza, ad esempio:
- Invio di richieste vaghe: Lettere di sollecito di pagamento che non menzionano la data del credito o la possibile prescrizione, sperando che il debitore paghi non sapendo di poter opporre la prescrizione. Se il debitore paga, come detto, amen. Queste pratiche sono contestabili come scorrette sul piano amministrativo (Antitrust).
- Cause temerarie: Citare comunque in giudizio per un credito prescritto, confidando che il debitore non si difenda. È azzardato (il giudice se il debitore resiste rigetta la domanda e può condannare per lite temeraria), ma succede specialmente con decreti ingiuntivi su crediti di massa: magari su 100 ingiunzioni di piccoli importi prescritti, 90 non vengono opposte e la società incassa. È un comportamento biasimato dall’Antitrust e dai tribunali, ma avviene. Il debitore deve essere vigile e opporsi.
- Richieste transattive con saldo e stralcio: Il creditore propone “lo stralcio del debito” con forte sconto, ad es. “il tuo debito di €1000 lo chiudiamo con €200 se paghi entro 10 giorni”. Il debitore allettato paga 200 credendo di risparmiare 800, ma magari quei 1000 non erano più esigibili affatto. E con 200 euro ha appunto riconosciuto tutto (oltre a regalare 200 per nulla dovuto). Queste offerte sono comuni nel recupero crediti. Un debitore informato, davanti a un’offerta così vantaggiosa per un debito molto vecchio, dovrebbe insospettirsi e chiedersi se per caso non sia prescritto, perché spesso i creditori consapevoli della prescrizione accettano qualsiasi cifra pur di chiudere.
In tutte queste situazioni, il debito “torna in vita” solo perché il debitore è stato indotto a comportarsi in un certo modo. La lezione è: non assumere iniziative sfavorevoli (pagamenti, ammissioni) senza verificare i propri diritti. Se c’è dubbio, consultare un legale o informarsi.
4. Novità legislative straordinarie
In teoria, il legislatore potrebbe emanare leggi che incidono sulla prescrizione già maturata. Ad esempio, in passato durante emergenze sono stati sospesi i termini di prescrizione, ex post allungando un po’ i tempi. Oppure potrebbe (ma sarebbe costituzionalmente dubbio) dire “riapriamo la possibilità di riscuotere crediti tributari prescritti nel tal periodo”. Finora non si è mai vista una legge che faccia rivivere crediti prescritti in via generale – perché violerebbe la tutela del debitore (principio di affidamento e di certezza del diritto). Si sono avuti casi di proroghe dei termini non ancora scaduti (ad esempio, per il Covid, il DL 18/2020 ha prorogato di alcuni mesi i termini di prescrizione e decadenza tributaria che sarebbero scaduti nel 2020). Quindi più che “tornare esigibili” debiti prescritti, abbiamo visto “slittare in avanti” la maturazione della prescrizione. Questo è legittimo se fatto prima che il diritto si sia estinto; farlo dopo solleverebbe problemi di costituzionalità (sarebbe come togliere un diritto acquisito del debitore).
Un esempio storico: quando fu introdotta la legge 335/1995 (riforma pensionistica) che ridusse a 5 anni la prescrizione contributiva, per i periodi antecedenti c’era stato un regime transitorio (contribuzioni anteriori rimanevano decennali ma in parte condonabili). All’opposto, se domani una legge portasse la prescrizione ordinaria a 5 anni (ipotesi talvolta discussa per “modernizzare” il sistema), prevederebbe di certo che i termini in corso si riducono (magari dando un tempo di adeguamento). Ciò non farebbe tornare esigibile un credito già prescritto, semmai ne accorcerebbe altri non prescritti.
Possiamo dunque dire che nessuna legge può far risorgere un debito già prescritto senza violare la Costituzione (principio di irretroattività sfavorevole delle norme sostanziali, protezione dell’affidamento). Dunque, i casi da temere sono essenzialmente quelli comportamentali e processuali discussi sopra.
5. Vizi della notifica e decorso dei termini
Un cenno va fatto a una situazione particolare: se un creditore notifica un atto interruttivo (es. una citazione) ma la notifica è nulla o inesistente, il debitore magari non ne viene a conoscenza. Se poi il creditore non reitera l’atto in modo valido, potrebbe credere di aver interrotto mentre non è così. Questo è favorevole al debitore, perché in realtà la prescrizione sarebbe decorosa. Tuttavia, può succedere l’inverso: un debitore pensa di essere a posto perché sono passati molti anni senza ricevere nulla, ma scopre che il creditore aveva notificato qualcosa ad un vecchio indirizzo con compiuta giacenza (lui non era lì e non l’ha saputo, ma legalmente la notifica c’è). Risultato: la prescrizione è stata interrotta senza che lui lo sapesse. Questo non fa “tornare esigibile” un debito prescritto – in realtà impedisce che lo fosse, perché non era mai maturata prescrizione. Ma dal punto di vista pratico per il debitore è come se un debito che credeva estinto in realtà è ancora vivo per un atto che lui ignorava. La regola è: la notifica per compiuta giacenza (quando il postino lascia l’avviso e decorrono i giorni in posta) vale come notifica anche se il destinatario non ritira, ed è interruttiva . Quindi non è un modo per fregare la prescrizione, è proprio così di sistema.
Per concludere, un debito già prescritto può “tornare esigibile” solo se il debitore glielo consente: o perché non reagisce in giudizio, o perché compie atti di riconoscimento/pagamento. Il creditore da solo non ha il potere di resuscitare un diritto estinto (non c’è un rito voodoo legale!). Ciò detto, l’esperienza insegna che molti debitori inconsapevoli pagano debiti prescritti – il che sul piano pratico significa che quei crediti vengono incassati come se fossero esigibili, benché giuridicamente non lo fossero più. In questa luce, l’informazione e la tempestività sono le armi del debitore per evitare di onorare obbligazioni che il diritto gli consente di non pagare. Nel prossimo capitolo vedremo proprio come reagire se un creditore cerca di farsi pagare un debito che riteniamo prescritto: cosa fare fuori dal processo e dentro il processo, quali strumenti attivare e con quali tempistiche.
Come reagire legalmente a una richiesta di pagamento di un debito prescritto
Vediamo ora in modo operativo cosa dovrebbe fare un debitore quando riceve una richiesta di pagamento per un debito che egli ritiene (o sa) essere già prescritto. Distinguere innanzitutto se la richiesta è stragiudiziale (una lettera, telefonata, mail, diffida) oppure se è un atto giudiziario (ingiunzione, atto di citazione, precetto, ecc.), perché le modalità e i tempi di reazione differiscono.
A. Richiesta stragiudiziale (lettera di sollecito, diffida di pagamento)
Spesso il primo contatto arriva in forma di lettera da parte del creditore o di una società di recupero crediti. Può essere una raccomandata, una PEC, o perfino una semplice lettera ordinaria (o mail non PEC). In questi casi, il debitore non ha un obbligo legale di rispondere, ma è fortemente consigliato farlo per chiarire la propria posizione e prevenire escalation.
Cosa fare:
- Verificare bene la situazione: Identificare chi è il creditore e di che debito parla la richiesta. Spesso queste lettere contengono riferimenti (numero contratto, data fattura, ecc.). Bisogna risalire alla data di origine del debito e agli eventuali atti successivi. Se si hanno archiviati documenti (es. vecchie fatture, vecchie intimazioni), cercarli. In mancanza, si può anche contattare (con prudenza) il soggetto mittente per chiedere dettagli, oppure consultare uno storico (ad es., per cartelle esattoriali, accedere al cassetto fiscale o chiedere estratto a Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione).
- Calcolare il termine di prescrizione pertinente (secondo la categoria di debito) e vedere se, dalla data di esigibilità, sono trascorsi tot anni senza atti interruttivi. Gli atti interruttivi certi di solito il debitore li ricorda (una raccomandata ricevuta, una citazione in tribunale). Per scrupolo, se il debitore non è sicuro di aver ricevuto qualcosa perché magari ha cambiato indirizzo negli anni, può recarsi in anagrafe a controllare se esistono notifiche depositate (ma di solito se erano depositate, dopo la compiuta giacenza l’ente ha l’obbligo di inviare una raccomandata informativa all’indirizzo risultante). Insomma, se non si è mai ricevuto nulla, nella maggior parte dei casi significa che nulla è stato notificato (non sempre però, come detto sopra sulla giacenza).
- Se dal calcolo risulta che il debito è effettivamente prescritto, la mossa opportuna è inviare una risposta scritta formale al mittente, preferibilmente tramite mezzo tracciabile (PEC o raccomandata A/R). Nella risposta occorre:
- Contestare espressamente la richiesta di pagamento in quanto il debito è prescritto. Conviene usare proprio questa parola: “eccepisco l’intervenuta prescrizione del credito ai sensi degli artt. 2934 e segg. c.c.”.
- Fare riferimento, se noti, agli estremi del debito e spiegare perché è prescritto: es. “trattasi di fattura del dd/mm/aaaa, per la quale non ricevo comunicazioni da oltre 5 anni, quindi prescritta ex art. 2948 c.c.”, oppure “ultimo pagamento risale al mese X dell’anno Y, sono trascorsi più di 10 anni”.
- Dichiarare che non si intende pertanto pagare e invitare il creditore a desistere da ulteriori pretese.
- Facoltativamente, si può aggiungere che ogni eventuale azione giudiziaria sarà tempestivamente contrastata e che l’insistenza nella richiesta potrebbe costituire abuso (se vi sono estremi, citare magari il fatto che pretendere il pagamento di crediti prescritti può integrare pratica commerciale scorretta – questo se il debitore è un consumatore verso un professionista, giusto per far capire che si conoscono i propri diritti).
- Non ammettere mai nel merito il debito nella lettera. Evitare frasi tipo “so di dovervi questi soldi ma…”, perché sarebbe autolesionista (un riconoscimento!). Mantenere un tono fermo ma neutro: ad esempio “Vostro asserito credito di €… relativo a …, ormai estinto per prescrizione”.
- Se il debitore non è affatto certo dell’esistenza del debito (a volte chiedono soldi per cose mai ricevute o già pagate), può contestare anche nel merito (“non riconosco il credito e comunque, anche ammesso in ipotesi, sarebbe prescritto”).
Una tale lettera di risposta ha diversi effetti: – Interrompe l’eventuale “gioco” del recuperatore: se contavano sull’ignoranza del debitore, capiranno che invece conosce la prescrizione e difficilmente pagherà spontaneamente. – Mette agli atti l’eccezione di prescrizione: se poi, nonostante tutto, il creditore facesse causa, quella lettera può essere prodotta per dimostrare la mala fede del creditore (sapeva già dell’eccezione, e magari rafforzare una richiesta di spese legali a carico loro). – Spesso induce il creditore a desistere, specialmente se la prescrizione è lampante. Aziende serie, ricevuta la contestazione fondata, archiviano. Altre meno serie magari continuano a tartassare: in tal caso, aver già eccepito la prescrizione vi mette al riparo da futuri “riconoscimenti involontari” – cioè avete chiarito che per voi è chiuso. Qualsiasi ulteriore loro richiesta potrebbe configurare molestia.
- Non effettuare pagamenti o firmare impegni: fino a che non è chiarito il quadro, non pagare nulla. A volte i recuperatori al telefono dicono “intanto versi qualcosa, poi vediamo” – è un trucco per avere riconoscimento. Mai farlo. La cosa giusta è prima accertare se si deve pagare ancora legalmente. La lettera di contestazione di cui sopra serve anche a guadagnare tempo. In alcuni casi, il debitore può anche prendere l’iniziativa di farsi assistere da un legale per rispondere: una lettera di un avvocato che eccepisce prescrizione con citazione di norme e magari allegando la Cassazione pertinente può spaventare ancor di più il creditore. Certo c’è un costo, quindi va valutato l’interesse economico.
- Segnalazione autorità (in caso di pratiche scorrette): Se il soggetto che richiede è un professionista o società e il debitore è un consumatore e ravvisa modalità aggressive (minacce infondate di azioni penali, contatti sul lavoro, alla famiglia, atti di citazione fasulli, etc.), si può segnalare il fatto all’AGCM (Antitrust) o all’Autorità per la Protezione dei Dati (se vengono usati dati impropriamente per fare pressing, come telefonate insistenza). L’AGCM nelle FAQ sulle pratiche scorrette indica proprio l’attività di recupero crediti su somme non dovute o prescritte come potenzialmente illecita . Anche un esposto alla Guardia di Finanza o all’AGCOM (se è operatore telefonico) in certi casi può servire. Queste mosse non risolvono nell’immediato il caso specifico, ma possono portare a provvedimenti generali e far cessare molestie, e far sentire il debitore meno isolato. Federconsumatori e altre associazioni hanno sportelli per queste situazioni .
In sintesi per la fase stragiudiziale: rispondere per iscritto, eccepire la prescrizione, non fare atti di riconoscimento, segnalare eventuali abusi. Spesso questo basta a chiudere la vicenda.
B. Atto di precetto o minaccia di esecuzione
Un caso particolare: se la prima notizia arriva sotto forma di atto di precetto (cioè l’ultimo avviso prima di pignoramento, basato su un titolo che il debitore magari ignorava), si è in una fase tecnica diversa. Il precetto è un atto giudiziario vero e proprio, anche se stragiudiziale (non c’è ancora il giudice coinvolto). Indica che c’è già un titolo esecutivo (sentenza, decreto, cartella esattoriale) e si intima di pagare entro X giorni.
Se il debitore non conosceva l’esistenza di quel titolo, c’è da capire perché: o gli era sfuggito (ad es. decreto ingiuntivo notificato per posta e non ritirato), o fu notificato viziato, o altro. In ogni caso, non bisogna aspettare: agire subito. Ci sono due strade parallele non mutualmente esclusive: – Fare opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) davanti al giudice competente, eccependo la prescrizione del titolo esecutivo. Ad esempio, se c’è un decreto ingiuntivo del 2010 mai eseguito e arriva un precetto nel 2023, si oppone che il diritto di procedere esecutivamente si è prescritto (10 anni) perché dal 2010 nessun atto interruttivo fu compiuto. Oppure, se è una cartella esattoriale notificata 8 anni fa per contributi (5 anni), si oppone che il credito sottostante è prescritto e l’agente non poteva iniziare esecuzione. L’opposizione va fatta entro 20 giorni dalla notifica del precetto (termine non perentorio, ma se non la fai e intanto ti pignorano è peggio). Nel frattempo potresti chiedere al giudice anche la sospensione dell’esecuzione. È un procedimento ordinario (ricorso se prima del pignoramento, o citazione se dopo, dettagli tecnici). – Verificare se c’è appiglio per opposizione tardiva al titolo stesso (es.: scopri che la notifica del decreto fu nulla, allora fai opposizione tardiva ex art. 650 cpc se rientri nei termini di 10 giorni da quando hai avuto conoscenza effettiva con precetto). Questo è un rimedio straordinario: utile se la prescrizione originaria non è chiarissima ma c’è un vizio di notifica. Ad esempio, se quell’ingiunzione era notificata a un indirizzo errato e tu non l’hai mai saputo, l’opposizione tardiva (entro 40 giorni da quando hai conoscenza, quindi dal precetto direi) può portare a far riaprire il caso e in quell’opposizione tirerai dentro anche la prescrizione originaria.
Se arriva direttamente un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), senza precetto noto (il precetto magari è stato notificato con le stesse problematiche, o l’Agente Riscossione su cartella a volte notifica intimazione e atti insieme): bisogna reagire con opposizione all’esecuzione (sempre art. 615 cpc) al più presto, chiedendo magari sospensione al giudice. I tempi qui stringono, perché se c’è udienza vendite ecc., conviene subito presentare ricorso in caso di esecuzione immobiliare, o atto di citazione per bloccare mobiliare. Serve l’avvocato. Si eccepisce la prescrizione come motivo per cui l’esecuzione è impropria (il titolo è inesistente perché credito estinto). Spesso i giudici dell’esecuzione sospendono se vedono chiara la prescrizione.
Riassumendo in forma chiara: se ormai siamo alla fase esecutiva, la prescrizione può essere ancora invocata ma con atti formali di opposizione, e conviene farsi assistere da un legale. Non esitare, perché una volta avvenuto il pignoramento e magari distribuito il ricavato, recuperare è arduo.
C. Atto di citazione o ricorso in tribunale (causa di merito)
Se il creditore ha avviato una causa di merito ordinaria (citazione per una somma) o un procedimento monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo), il debitore riceverà l’atto a casa tramite ufficiale giudiziario o posta. Cosa fare immediatamente:
- Segnare la data di notifica e calcolare la scadenza per costituirsi o per fare opposizione. Ad esempio, per un decreto ingiuntivo, 40 giorni dalla notifica (se in Italia). Per una citazione, comparsa di risposta 10 giorni prima dell’udienza se Tribunale, il che grosso modo significa 80-90 giorni dal momento della citazione a udienza (ma leggete l’atto!).
- Rivolgersi preferibilmente ad un avvocato subito, portando tutta la documentazione. La prescrizione è un’eccezione di merito, il che richiede conoscenze processuali su come eccepirla correttamente e tempestivamente.
- Nell’atto difensivo (comparsa di risposta o atto di opposizione a decreto) va inserita in modo chiaro l’eccezione di prescrizione. Non basta dire “il credito è vecchio”: bisogna indicare le norme (es. “eccepisce la prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c. in relazione all’intercorso decorso decennale…”, specificare i conteggi: “il diritto sarebbe sorto nel ____ e da allora sono decorsi ___ anni senza validi atti interruttivi”). Meglio puntigliosi che vaghi. L’onere di provare eventuali interruzioni sarà del creditore, una volta che il debitore ha sollevato l’eccezione e indicato che è trascorso il tempo .
- Attenzione: come detto, l’eccezione va sollevata nel primo scritto difensivo utile, altrimenti è irricevibile. Dunque guai a presentare per esempio una comparsa priva dell’eccezione pensando di aggiungerla in corso di causa: sarebbe tardiva. Vincola il giudice: se l’eccezione è formulata, il giudice dovrà pronunciarsi su di essa; se manca, il giudice considererà il diritto non prescritto anche se magari lo era.
Il difensore, oltre a eccepire la prescrizione, controllerà se ci sono altri motivi di opposizione (magari il debito non è dovuto nel merito, ecc.). Ma l’eccezione di prescrizione, se fondata, è assorbente: fa rigettare la domanda senza entrare nel merito (o revocare il decreto ingiuntivo ingiusto).
E se uno volesse difendersi da solo (sconsigliato)? In teoria, davanti al Giudice di Pace per cause fino a €5.000, il debitore potrebbe costituirsi senza avvocato e scrivere di proprio pugno l’eccezione di prescrizione. È valido purché la scriva chiaramente. Esempio: “Il convenuto eccepisce che nulla è dovuto all’attore perché il credito di cui è causa si è estinto per intervenuta prescrizione, essendo trascorsi più di X anni dall’epoca in cui il diritto poteva essere fatto valere (individuabile nella data ____) senza atti interruttivi”. Anche a voce a udienza si può eccepire, ma meglio consegnare uno scritto. Comunque, date le complessità, meglio farsi assistere.
Dopo aver eccepito, che succede? Il giudizio seguirà il suo corso. Il creditore attore, a quel punto, dovrà replicare cercando di dimostrare che la prescrizione in realtà è stata interrotta o non è maturata. Produrrà magari le raccomandate inviate, i pagamenti fatti dal debitore, ecc. Il giudice valuterà:
- Se riscontra che effettivamente dal momento esatto in cui il diritto è divenuto esigibile al momento di notificazione dell’atto introduttivo (es. citazione) è trascorso più tempo del previsto e che nessun atto interruttivo valido è intervenuto in mezzo, allora accoglierà l’eccezione e respingerà la domanda del creditore, dichiarando il diritto prescritto. (Tecnicamente la sentenza non “dichiara la prescrizione” se non eccepita, ma se eccepita la accerta).
- Se invece il creditore prova una o più interruzioni e convince che conti alla mano non è trascorso il periodo richiesto, la domanda del creditore verrà esaminata nel merito e l’eccezione respinta. Ad esempio, se la prescrizione è decennale e c’è stata un’interruzione al 5° anno, poi un’altra al 9°, e infine la causa è partita al 12° dal sorgere ma contandole quell’ultimo periodo era ripartito 9→19, il giudice dirà “non è prescritto perché interrotto, entriamo nel merito”.
- Se ci sono dubbi sul decorso (per esempio la data in cui il diritto poteva esser fatto valere è contestata), li risolverà. A volte c’è diatriba su quando inizia la prescrizione: es. nelle polizze assicurative, dal sinistro o dal rifiuto di indennizzo? (due possibili dies a quo), ecc. Il giudice deciderà caso per caso. Ad esempio, Cass. 11067/2025 (massima citata prima) discute quando decorre la prescrizione del credito di interessi su rimborsi fiscali: considerato un’obbligazione autonoma quindi 5 anni da quando il credito principale fu compensato .
Se il debitore vince per prescrizione, avrà diritto anche alle spese legali (di solito) a carico del creditore, perché è vittorioso. Nel caso di decreti ingiuntivi, la sentenza di opposizione che accolga la prescrizione revoca il decreto e può condannare l’ingiungente alle spese.
Un aspetto psicologico: Spesso, se un creditore vede un’eccezione di prescrizione ben fondata, desiste prima che si arrivi a sentenza – magari chiede al giudice di rinunciare alla domanda (soprattutto se nel merito avrebbe anche ragione ma non ha armi contro l’eccezione). A volte propone un accordo, ma il debitore in questa fase non ha molto da guadagnare a transare, a meno che non ci siano incertezze.
D. Contro-attacco legale del debitore?
Ci si può chiedere: un debitore potrebbe agire lui per primo, ad esempio per far dichiarare in giudizio che il debito è prescritto (azione di accertamento negativo) o per farsi restituire quanto pagato erroneamente?
- Azione di accertamento negativo della prescrizione: In teoria possibile: ad esempio, se uno riceve continuamente richieste, potrebbe citare in giudizio il creditore chiedendo al giudice di dichiarare che nulla è dovuto perché il credito è prescritto. È un’azione di accertamento (art. 100 cpc, serve interesse concreto). Si può fare se il creditore tiene il punto. Serve però un interesse: cioè che il creditore stia effettivamente insistendo tanto da generare incertezza nei rapporti. Se è solo una lettera isolata, conviene rispondere come sopra e basta. Ma se, poniamo caso, un’ex moglie pretende arretrati di 15 anni fa di mantenimento e minaccia cause, il marito può stancarsi e far causa lui chiedendo si dichiari la prescrizione. Il rischio di queste azioni è che poi si va in giudizio e magari emergono fatti (es. riconoscimenti) che fanno perdere la causa, con spese a proprio carico. Quindi vanno valutate caso per caso. Solitamente, è preferibile attendere che sia il creditore eventualmente a muoversi, limitandosi nella fase stragiudiziale a eccepire.
- Azione di ripetizione di indebito per pagamento di debito prescritto: Come detto, l’art. 2940 c.c. nega la ripetizione. Quindi se volontariamente ho pagato quando già era prescritto, non posso ottenere rimborso. Uniche eccezioni: se ho pagato per errore ritenendo di doverlo ancora ma ignorando la prescrizione, l’orientamento costante è comunque l’irripetibilità, trattandosi di obbligazione naturale. Alcuni hanno provato a configurare l’errore come vizio del volere (art. 2033 e 1427 c.c.), ma la giurisprudenza esclude la ripetibilità anche se il pagatore ignorava la prescrizione . Diverso se il pagamento non era spontaneo ma forzoso: es. subisco un pignoramento per un credito prescritto e pago, lì posso fare opposizione all’esecuzione e chiedere la restituzione, perché non è “spontaneo” ma coattivo (non ricade nell’art. 2940). O se pago per evitare guai credendo erroneamente che il debito fosse ancora dovuto, ma su forte minaccia – anche lì però è complicato qualificare il pagamento come non spontaneo. Quindi difficilmente recupererò.
- Denunce o reclami: Un debitore arrabbiato per le continue richieste illecite potrebbe presentare una denuncia per tentata estorsione se le minacce sono gravi (ad es. “se non paghi vengo a casa tua” – ci sono stati casi di recuperatori denunciati). Oppure un reclamo al Garante della privacy se vengono contattati terzi (datore di lavoro, parenti) divulgando il debito. Queste possono affiancare la difesa civile.
In genere però, la strategia più efficiente è quella difensiva, non offensiva: attendere eventuali mosse legali altrui e eccepire la prescrizione. L’onere economico di fare causa (anticipare spese legali) è meglio lasciarlo al creditore. La prescrizione è come uno scudo: il debitore lo alza quando l’altro attacca.
E. Sintesi step-by-step dal punto di vista del debitore
Se pensi che un tuo debito sia prescritto, ecco un decalogo:
- Non pagare nulla immediatamente, nemmeno parzialmente.
- Raccogli le informazioni: qual è l’origine del debito, quanti anni sono passati, ci sono stati solleciti/atti in mezzo?
- Confronta con i termini di legge: è passato oltre il termine (5, 10 anni, etc.)? Se sì, di quanto?
- Se ricevi un sollecito scritto: rispondi formalmente eccependo la prescrizione e rifiutando il pagamento. Conserva copia della tua risposta.
- Non riconoscere mai per iscritto il debito nelle comunicazioni, neanche per “negoziare”: parlane sempre ipoteticamente (“asserito debito”, “presunto credito che contestiamo”).
- Informa gli eventuali coobbligati (es. altri garanti, altri debitori solidali) della situazione: se uno di loro paga o riconosce, può avere effetti anche su di te (nell’obbligazione solidale, l’interruzione per uno vale per tutti, art. 1310 c.c.). Quindi allineatevi sul da farsi.
- Se arriva un atto giudiziario: non perdere tempo, rivolgiti a un avvocato e predisponi l’eccezione di prescrizione nella comparsa di risposta/opposizione. Rispetta i termini procedurali.
- Raccogli le prove a sostegno dell’eccezione: se hai la copia di una lettera con cui il creditore ammetteva di essere stato inattivo per anni, o calcoli precisi delle date. Se il creditore contesta l’epoca da cui decorre la prescrizione (es. sostiene che c’era un pagamento rateale e quindi la prescrizione parte dall’ultima rata), preparati a controbattere.
- Partecipa al processo (direttamente o tramite avvocato) e insisti sull’eccezione.
- Dopo la sentenza: se ti dà ragione (prescrizione accolta), il debito è morto e sepolto giuridicamente. Se malauguratamente la sentenza ritenesse non prescritta la somma (perché magari ha riconosciuto un atto interruttivo valido che tu contestavi), valuta con l’avvocato se appellare, ma potrebbe significare che effettivamente non era prescritta. In tal caso, si torna al merito o alla trattativa su importo.
Ricorda: la prescrizione può sempre essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, purché dal principio sia stata sollevata. Se in primo grado per assurdo il giudice la ignorasse pur essendo eccepita e rigettasse la tua eccezione erroneamente, puoi riproporla in appello (anzi devi, come motivo di appello). Non è mai coperta da giudicato implicito se non affrontata e se era eccepita opportunamente.
Simulazioni pratiche
Per concretizzare quanto discusso, esaminiamo tre casi pratici ipotetici, dal punto di vista rispettivamente di un privato cittadino debitore, di un imprenditore debitore, e di un avvocato che deve consigliare un cliente su un debito prescritto. Queste simulazioni mostrano come applicare le regole e strategie illustrate, tenendo conto delle diverse prospettive e interessi in gioco.
Caso pratico 1: Privato e bollette telefoniche prescritte
Scenario: Mario, un privato cittadino, riceve nel 2025 una lettera da una società di recupero crediti XY S.p.A., la quale gli intima di pagare €300 per “bollette telefoniche insolute Telecom 2018”. Mario ricorda vagamente di aver avuto un contenzioso con il gestore telefonico nel 2018, di aver cambiato operatore, e di non aver più ricevuto nulla in merito. La lettera minaccia azioni legali se non paga entro 10 giorni. Mario è preoccupato ma sa, per aver letto guide di consumatori, che le bollette telefoniche cadono in prescrizione in 5 anni (essendo servizi periodici) . Sono passati più di 5 anni dal 2018, e Mario non ha ricevuto alcun sollecito scritto nel frattempo. Solo qualche email spam da Telecom nel 2019 che ha ignorato.
Cosa fa Mario:
1. Verifica l’ultima fattura in questione: era di giugno 2018. La prescrizione per quella bolletta sarebbe scattata a luglio 2023 (5 anni dopo). Siamo a gennaio 2025, quindi ben oltre.
2. Si assicura di non aver firmato nulla o pagato nulla nel frattempo. Non l’ha fatto.
3. Redige una raccomandata A/R indirizzata a XY S.p.A. (o via PEC se trova un indirizzo). Nella lettera indica: “Oggetto: Vostro sollecito del __ relativo a presunte fatture Telecom 2018 intestate a Mario Rossi. Con la presente contesto integralmente il preteso credito. Eccepisco l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 1 n.4 c.c., atteso che eventuali addebiti telefonici risalirebbero al 2018 e da allora non ho ricevuto atti interruttivi validi. Pertanto nulla è dovuto. Diffido codesta società dal proseguire in richieste infondate; ogni eventuale azione giudiziaria sarà da me ritualmente contrastata. Distinti saluti…”.
4. Spedisce la raccomandata/PEC e conserva la ricevuta.
5. Non effettua alcun pagamento, ignorando completamente la richiesta di “pagare entro 10 giorni”.
6. XY S.p.A., ricevuta la lettera di Mario, potrebbe reagire in modi diversi: – Opzione A: archivia il caso, ritenendo fondata l’eccezione. Magari invia una comunicazione di riscontro in cui dice “abbiamo chiuso la pratica”. Se così, Mario ha risolto con quella lettera. – Opzione B: XY risponde contestando (es. “ci risulta che Telecom inviò lettera nel 2020, quindi non è prescritto”). A quel punto Mario valuterebbe la fondatezza: se davvero ci fu una raccomandata 2020 (che Mario non ricorda), Mario potrebbe chiedere prova (ad es. copia ricevuta) o restare sulla sua posizione. – Opzione C: XY ignora la contestazione di Mario e, nel tentativo di spaventarlo, gli invia dopo un mese un atto di citazione al Giudice di Pace per quei €300, confidando che Mario magari non si presenti. Mario però è all’erta: ricevuta la citazione, entro i termini si costituisce (può farlo da solo essendo GdP e somma bassa, o con avvocato se preferisce). Nel suo scritto difensivo indica: “Il convenuto eccepisce che il diritto di credito è estinto per prescrizione quinquennale maturata prima della notifica dell’atto di citazione. Infatti trattasi di bollette 2018 e nessun atto interruttivo è intervenuto fino alla presente citazione notificata nel 2025. Pertanto ai sensi dell’art. 2948 c.c. n.4 il credito è prescritto e la domanda attrice va rigettata”. Aggiunge magari: “Si produce la lettera raccomandata inviata dal convenuto in data… che attesta l’eccezione già sollevata stragiudizialmente”.
Il giorno dell’udienza, Mario (o il suo legale) insiste sulla prescrizione. Se la società XY non ha prove di interruzioni (e con buona probabilità Telecom non aveva fatto nulla), il Giudice darà ragione a Mario e respingerà la domanda, condannando XY alle spese. 7. A questo punto Mario ha vinto. Poniamo invece che, ipotesi remota, salti fuori che Telecom inviò nel 2021 una raccomandata (ad un vecchio indirizzo di Mario) e XY la porta come prova. Il giudice potrebbe ritenere che quell’atto ha interrotto e quindi prescrizione decorreva di nuovo dal 2021 al 2026, per cui nel 2025 il credito è ancora vivo. Allora Mario perderebbe l’eccezione e dovrà pagare i €300 (magari senza interessi per i periodi non dovuti). In quel caso, Mario avrebbe comunque beneficiato per anni del “non pagamento” e avrebbe tentato legittimamente la difesa. Sarebbe sfortunato, ma almeno non avrebbe aggravato la sua posizione con riconoscimenti.
Esito della simulazione: Nel probabile scenario in cui XY soprassiede, Mario non paga nulla e il debito rimane estinto. Ha evitato di buttare €300 semplicemente conoscendo i suoi diritti. Il suo caso mostra l’importanza di rispondere per iscritto e di non lasciarsi intimidire da toni perentori.
Caso pratico 2: Imprenditore e cartella esattoriale prescritta “resuscitata” da intimazione
Scenario: La ditta individuale di Luigi, un artigiano, aveva un debito verso l’INPS per contributi 2014 non versati, importo €5.000. L’INPS gli notificò nel giugno 2016 una cartella esattoriale tramite Agenzia Entrate Riscossione (AER). Luigi non fece ricorso, ma nemmeno pagò. Da allora non ha più sentito nulla – sono passati oltre 9 anni. I contributi, essendo 5 anni la prescrizione, sarebbero prescritti dal giugno 2021 . Tuttavia, a gennaio 2025 Luigi riceve dall’Agenzia Riscossione un’intimazione di pagamento ai sensi art. 50 DPR 602/73, che intima di saldare quei €5.000 entro 5 giorni, preannunciando in difetto l’avvio di esecuzione forzata. L’intimazione fa riferimento alla cartella del 2016. Luigi rimane sorpreso: sapeva (da internet o consulenti) che i contributi prescrivono in 5 anni, e pensava di essere ormai salvo. Si informa e scopre la recente Cassazione 21240/2025 che abbiamo discusso: se non impugna l’intimazione entro 60 giorni, perde la possibilità di far valere la prescrizione . Deve quindi attivarsi subito.
Cosa fa Luigi:
1. Si reca immediatamente dal suo commercialista o avvocato tributarista con l’intimazione.
2. Il consulente conferma: sì, il debito era prescritto al 2021, ma adesso occorre impugnare l’intimazione alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 gg. (In realtà, per cartelle INPS l’impugnazione può essere anche al giudice del lavoro – questione di giurisdizione – ma facciamo finta segua la prassi unitaria tributaria come spesso accade con AER). 3. L’avvocato predispone un ricorso tributario contro l’intimazione, indicando: “il credito per contributi è estinto per prescrizione quinquennale ex L.335/95, maturata prima della notificazione dell’intimazione; pertanto si chiede l’annullamento dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito sotteso”. Argomenta anche citando Cass. SU 23397/2016 e altre, evidenzia che dalla notifica cartella (2016) alla intimazione (2025) sono passati 8,5 anni senza atti interruptivi (ipotesi). Magari AER proverà a eccepire che la cartella non impugnata sarebbe titolo decennale (tesi minoritaria rigettata da SU), ma Luigi è in buon diritto. 4. La presentazione del ricorso entro 60 giorni sospende l’efficacia dell’intimazione (in quanto atto impugnabile del D.Lgs. 546/92). Luigi tramite avvocato può anche chiedere una sospensione cautelare se AER minacciasse di procedere subito, ma in genere se c’è ricorso si attende. 5. In giudizio, l’Avvocato di Luigi evidenzia che il credito contributivo è soggetto a 5 anni e la mancata impugnazione della cartella non ha creato giudicato, ergo atti successivi dovevano avvenire entro 5 anni. L’Avvocatura dello Stato (difensore di AER/INPS) magari richiama Cass. 21240/25 dicendo “l’intimazione cristallizza”. Ma qui la differenza è: Luigi ha impugnato nei termini, quindi non scatta la preclusione. 6. La Commissione Tributaria, valutate le date, con ogni probabilità darà ragione a Luigi: dichiarerà che il credito era prescritto al momento dell’intimazione e annullerà l’intimazione . Quindi Luigi non dovrà pagare e l’AER non potrà procedere oltre. Se anche la CTP sbagliasse e desse torto, Luigi potrebbe appellare (CTR) e fin su, forte della legge. Dato che Cass. e SU su contributi sono chiare, alla fine vincerebbe. 7. Importante: se Luigi fosse stato inattivo e non avesse impugnato l’intimazione entro 60 giorni, quell’atto sarebbe divenuto definitivo, e poi se AER avesse avviato pignoramento Luigi non avrebbe più potuto eccepire la prescrizione pregressa . Avrebbe potuto solo lamentare l’eventuale prescrizione sopravvenuta dell’intimazione stessa (che è 180 giorni la sua efficacia, ma irrilevante perché agiscono prima). Insomma, sarebbe stato costretto a pagare, pur avendo un diritto alla prescrizione. Questa simulazione evidenzia come le regole processuali (impugnare in tempo) siano determinanti nel preservare i propri diritti. 8. Luigi, anche grazie alla consulenza aggiornata ricevuta, ha potuto reagire correttamente.
Esito della simulazione: Luigi riesce a far valere la prescrizione e blocca la riscossione indebita. Ha dovuto però attivarsi legalmente (con costi di avvocato, ma in tali casi spesso le spese sono compensate o liquidate a favore del contribuente se vince). Questo caso insegna: nel campo tributario, mai ignorare un atto pensando “tanto è prescritto”, perché come la Cassazione ha sancito, quell’inerzia può essere fatale.
Caso pratico 3: Avvocato e difesa in giudizio su crediti prescritti
Scenario: L’avvocato Maria è contattata da un nuovo cliente, il sig. Antonio, il quale ha ricevuto una citazione davanti al Tribunale da parte di una banca che gli chiede €20.000 per saldo di un vecchio conto corrente chiuso. Antonio spiega all’avvocato: il conto era stato chiuso nel 2013 con un saldo passivo di €15.000; la banca non si è fatta viva per anni, poi ha ceduto il credito a una società di recupero, la quale lo ha citato nel 2025 per €20.000 (15k capitale + interessi vari). Antonio aggiunge di non aver mai ricevuto richieste ufficiali in quei 12 anni; solo qualche telefonata di società di recupero anni fa che lui ha ignorato. Non ha mai riconosciuto il debito, anzi lo contestava in origine perché secondo lui c’erano addebiti illegittimi sul conto (commissioni). Ora però vuole principalmente non pagare, e chiede se è possibile far valere la prescrizione.
Cosa fa l’avvocato Maria:
1. Analizza il caso alla luce di giurisprudenza: trattandosi di saldo conto corrente bancario, prescrizione ordinaria 10 anni dal momento in cui il conto è chiuso e il saldo dovuto . Chiusura 2013 → prescrizione sarebbe 2023. La citazione è del 2025, quindi in teoria oltre 10 anni. Sembrerebbe prescritto. 2. Maria però vuole essere scrupolosa: chiede ad Antonio se ha ricevuto per caso raccomandate dalla banca nel frattempo (la banca cedente o il cessionario). Antonio ribadisce di no. Verifica la documentazione allegata alla citazione: spesso il creditore allega un estratto conto certificato, e a volte menziona di aver inviato raccomandata di messa in mora nel tal anno. In questo caso, supponiamo il creditore cessionario non abbia menzionato alcuna interruzione. Forse confidano che Antonio manco si presenti. 3. Maria prepara la comparsa di risposta per Antonio. In essa, solleva come prima difesa l’eccezione di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., calcolando: saldo esigibile da chiusura rapporto il 31/12/2013, nessun atto interruttivo sino alla notifica citazione del 2025 → oltre 11 anni. Richiama magari Cass. civ. 24418/2019 che conferma decennale per azioni di banca su scoperti di conto (ce ne sono tante). Afferma che pertanto il diritto è estinto e la domanda va respinta . 4. Maria inoltre, come seconda linea, contesta nel merito il quantum: “in ogni caso, senza rinunciare all’eccezione, si contesta il credito anche nel merito perché il saldo è gonfiato da interessi ultralegali non pattuiti e da anatocismo, ecc.”. Questo perché, se per qualche ragione la prescrizione venisse ritenuta non maturata, ha un paracadute per ridurre l’importo (magari alcune rimesse erano solutorie e lei vuole far valere parzialmente prescrizione di quelle – discorso tecnico). 5. In udienza, la controparte (società cessionaria) magari non si costituisce nemmeno (pensando di vincere facile in contumacia). Se non si costituiscono, Maria chiede al giudice di accogliere l’eccezione. Il giudice verifica l’atto: in effetti vede che la citazione è del 2025 e la chiusura conto risulta da allegati 2013 – ergo accoglie. Sentenza: rigetta la domanda per intervenuta prescrizione, condannando parte attrice contumace alle spese. 6. Se invece la controparte si costituisce e – sorpresa – produce una lettera AR del 2016 inviata da banca al vecchio indirizzo di Antonio (risulta “compiuta giacenza”) e sostiene che ha interrotto la prescrizione. Maria dovrà replicare: magari l’eccezione l’aveva già sollevata, ora quell’atto del 2016 (7 anni dopo chiusura) se valido, sposta la scadenza a 2026. In tal caso nel 2025 il credito non sarebbe prescritto (perché interrotto al 3° anno e poi la causa al 12° dall’origine, cioè 9 anni dopo l’interr., ancora dentro i 10 ripartiti). Maria potrebbe controbattere sulla validità di quell’interruzione: “l’attrice non ha provato la ricezione da parte del convenuto” – ma se c’è ricevuta di Poste per compiuta giacenza, è considerata notifica valida . Potrebbe eccepire che la banca non allega il contenuto di quella raccomandata (magari non c’è copia lettera) – in effetti, servirebbe dimostrare che era un atto interruttivo (costituzione in mora). Se la controparte non lo prova, quell’atto è irrilevante. Diciamo che Maria con abilità riesce a far sì che il giudice non consideri provata l’efficacia interruttiva (perché manca testo lettera). Il giudice allora può ritenere la prescrizione maturata. Se invece la considerasse provata, respingerebbe l’eccezione e passerebbe al merito. 7. Supponiamo comunque che l’esito sia favorevole: prescrizione accolta, domanda respinta. Antonio non paga nulla.
8. Maria inoltre, siccome è brava, aveva pure evidenziato che la società cessionaria ha agito in giudizio nonostante fosse chiaro che il credito era prescritto, chiedendo al giudice di valutare la temerarietà ex art. 96 c.p.c. Magari in sentenza il giudice, vista la contumacia o la superficialità del recuperatore, condanna la società a un risarcimento simbolico per lite temeraria (non raro in casi di azioni su crediti palesemente prescritti). Antonio così potrebbe perfino ottenere un piccolo ristoro (es. €500) oltre alle spese legali. Questo sarebbe un forte deterrente per il creditore a rifare cause simili.
9. Antonio e Maria vincono; Maria pubblica un articolo sulla vicenda (senza nomi) per far conoscere ai debitori i loro diritti su crediti bancari datati.
Esito della simulazione: Dal lato avvocato, si vede come la prescrizione vada gestita in giudizio: eccepita per iscritto, provata nel suo decorso, e come possano emergere questioni (interruzioni) su cui dibattere. L’avvocato deve padroneggiare oneri di prova: una recente Cass. 5364/2024 ad esempio ha ribadito che se il debitore eccepisce prescrizione, spetta al creditore provare la domanda di mediazione presentata in una certa data per dire che ha interrotto – qui l’onere è sul creditore di provare l’effetto interruttivo. Allo stesso modo Maria punta sul fatto che il creditore non ha provato interruzioni efficaci.
Questa simulazione evidenzia la necessità, per il legale, di condurre un’istruttoria accurata: chiedere al cliente tutti i dettagli, non dare per scontato nulla (ad es. chiedere: “sei sicuro di non aver cambiato residenza? Di non aver ricevuto PEC?”). Spesso i creditori spediscono anche PEC se hanno indirizzo, e il debitore magari non la controllava – quell’email PEC è valida come raccomandata. L’avvocato deve sondare tutti questi aspetti per non trovarsi sorprese.
In conclusione, attraverso questi casi pratici abbiamo visto il punto di vista del debitore applicato: dal privato che con una lettera risolve, all’imprenditore che deve attivare un ricorso, all’avvocato che usa la prescrizione come scudo in causa.
Domande frequenti (FAQ) sui debiti prescritti
D1: Cosa significa esattamente che un debito è “prescritto”?
R: Significa che è trascorso il tempo previsto dalla legge senza che il creditore abbia esercitato il suo diritto, provocandone l’estinzione sul piano giuridico . In pratica, un debito prescritto non può più essere legalmente preteso dal creditore: il debitore ha il diritto di rifiutare il pagamento. Ad esempio, dire “quel debito è prescritto” equivale a dire “è passato troppo tempo, non sei più tenuto a pagarlo perché la legge ti tutela se il creditore è rimasto inerte oltre il termine fissato”. Va ricordato che la prescrizione è una eccezione, quindi se il creditore agisce legalmente, il debitore deve dichiarare che è prescritta per farla valere . Se il debitore paga spontaneamente un debito ormai prescritto, non può poi chiedere rimborso .
D2: Quali sono i termini di prescrizione per i vari tipi di debiti?
R: Dipende dalla natura del debito. Il termine ordinario generale è 10 anni . Molti debiti comuni però hanno termini più brevi: 5 anni per quasi tutte le prestazioni periodiche (affitti, bollette, interessi, stipendi, rate condominiali ordinarie) , 3 anni per alcuni compensi (es. parcelle professionali, ma si tratta di prescrizione presuntiva), 2 anni per i danni da circolazione auto , 5 anni per sanzioni amministrative e tributi locali , 5 anni per contributi previdenziali , 2 anni (dal 2018-2020) per bollette di luce/gas/acqua , 3 anni per cambiali, 6 mesi per assegni, ecc. (Vedi la tabella riepilogativa sopra per un elenco dettagliato). In mancanza di indicazione specifica, si applica il decennale. Alcune situazioni particolari: diritti personali (non patrimoniali) sono imprescrittibili; i diritti di credito verso lo Stato (tributi) variano, ma in genere 10 anni salvo previsione di 5. È importante determinare il dies a quo (inizio) e se ci sono state interruzioni che fanno ripartire da capo il termine .
D3: La decadenza è la stessa cosa della prescrizione?
R: No, sono istituti diversi. La prescrizione attiene al diritto e si matura con l’inerzia prolungata del titolare; la decadenza attiene al potere/atto da compiere entro un termine perentorio stabilito di solito dalla legge (o contratto) e opera di diritto, spesso rilevabile d’ufficio. Ad esempio, l’Amministrazione finanziaria ha decadenze (es. 5 anni per notificare un accertamento IRPEF); trascorso quel termine l’atto è nullo. Ma una volta notificato, ha prescrizioni per riscuotere (ad es. 5 o 10 anni). Un altro esempio: il diritto del consumatore alla garanzia legale è soggetto a decadenza di 2 mesi per denunciare il difetto, e prescrizione di 26 mesi per agire. In sintesi: la prescrizione estingue il diritto per inerzia prolungata; la decadenza preclude l’esercizio di un diritto o potere oltre un certo termine, anche breve. Inoltre, la prescrizione può essere interrotta o sospesa, la decadenza di norma no (salvo eccezioni). Infine, la prescrizione va eccepita dal debitore , la decadenza spesso il giudice la rileva d’ufficio (quando riguarda poteri autoritativi o termini procedurali).
D4: Il giudice o l’ente considererà d’ufficio la prescrizione di un debito?
R: No, a meno che si tratti di materie speciali in cui è diversamente previsto. Nel diritto civile ordinario, la prescrizione è un’“eccezione in senso stretto”: ciò significa che il giudice non può dichiararla se il debitore non la invoca . Questo è stabilito espressamente dall’art. 2938 c.c. (“il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”) e confermato dalla Cassazione . Dunque, se sei convenuto in una causa di pagamento, devi tu affermare che il credito è prescritto; se non lo fai, anche un credito vecchissimo potrà essere posto a base di condanna. Fanno eccezione alcuni casi: ad esempio in materia di lavoro, la prescrizione di certi crediti decorre anche durante il rapporto ma il giudice talvolta la considera d’ufficio se il datore non l’ha eccepita (questo però perché lì l’inerzia è discussa), oppure in materia di disciplina antitrust (le sanzioni penali prescritte devono escludere risarcimenti; ma è contorto). In generale, non fare affidamento su interventi d’ufficio: la prescrizione è una tua difesa, esercitala.
D5: Come si calcola esattamente il termine di prescrizione?
R: In genere in anni (10, 5, etc.) decorrenti dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.). Questo giorno spesso coincide con la scadenza dell’obbligazione o il momento del fatto dannoso. Ad esempio: un pagamento doveva avvenire il 10 gennaio 2015; da 11 gennaio 2015 inizia il conteggio – se è decennale, sarà prescritto alla fine del 10 gennaio 2025 (quindi dal 11 gennaio 2025 il debitore può rifiutare). Per i crediti periodici: ciascuna prestazione ha propria decorrenza. Per i danni: dalla data del danno o da quando se ne ha conoscenza, salvo il caso reato (art. 2947). Bisogna stare attenti alle cause di sospensione (che fermano il conteggio per un certo periodo) e alle cause di interruzione (che azzerano il tempo trascorso e, dal fatto interruttivo, il termine ricomincia da capo per intero ). Ad esempio, se a metà del decorso decennale c’è una lettera raccomandata di messa in mora, il tempo passato prima si perde e riparte 10 anni da quella lettera . Altro esempio: se per legge il termine è sospeso (es. durante trattative di mediazione per 3 mesi + 20 gg, oppure tra coniugi finché sposati per certi crediti), quel periodo non conta. In pratica si calcola “a ritroso”: dal momento in cui il creditore intraprende azione, si guarda indietro se c’è un periodo continuo senza atti maggiore del termine. Se sì, la prescrizione è compiuta.
D6: Una raccomandata semplice (non A/R) interrompe la prescrizione? E una PEC? E un sollecito via email?
R: Per interrompere la prescrizione serve un “atto che valga a costituire in mora il debitore” (art. 2943 c.c.), ossia una richiesta formale dal creditore che manifesti la volontà di ottenere la prestazione . Non richiede formule sacramentali ma dev’essere portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei a provarne la ricezione. La raccomandata A/R è il mezzo tipico: la giurisprudenza dice che la prescrizione è interrotta anche se il debitore rifiuta il ritiro o non la ritira entro i termini (compiuta giacenza), purché l’indirizzo fosse corretto . Una PEC (Posta Elettronica Certificata) ha valore legale pari a raccomandata: se il creditore la invia all’indirizzo PEC del debitore (iscritto in registri ufficiali o comunicato validamente), la ricevuta di consegna fa prova e interrompe. Una lettera ordinaria o una email normale, invece, non fanno piena prova di ricezione. Potrebbero interrompere solo se il debitore ne ammette il ricevimento o risponde. Se il creditore ha solo prova d’invio non certificato, quell’atto difficilmente sarà riconosciuto come interruttivo in giudizio (perché potrebbe non essere mai giunto). Dunque: raccomandata A/R (o atto giudiziario, o notifica via ufficiale giudiziario) – SÌ interrompe; PEC inviata correttamente – SÌ; email semplice o fax senza ricevuta firmata – NO, a meno di riconoscimento del debitore. Il telefono certamente no, trattandosi di comunicazione orale non documentabile (a meno di registrazioni, ma comunque l’onere di provare il contenuto e la ricezione è problematico). Quindi i solleciti telefonici delle società di recupero non hanno valore interruttivo – e la Cassazione conferma che diffide verbali non bastano . Attenzione: se il debitore, in risposta a un sollecito non formale, invia egli stesso qualcosa di scritto riconoscendo il debito, paradossalmente quello può valere come ricognizione e quindi come interruzione (o rinuncia alla prescrizione se compiuta).
D7: Ho un debito vecchio di 6 anni con un privato, non mi ha mai chiesto nulla finora. Devo fare qualcosa per farlo prescrivere ufficialmente?
R: No, non c’è bisogno di nessuna formalità: la prescrizione matura automaticamente col decorso del tempo previsto, senza necessità di atti. Quindi se davvero per 6 anni il creditore è stato totalmente inattivo e il termine applicabile era 5 anni, il diritto è già prescritto. Non esiste un certificato o una dichiarazione d’ufficio che attesti ciò. Semplicemente, se in futuro il creditore dovesse chiederti il pagamento, tu potrai opporre la prescrizione come difesa. Puoi però consolidare la tua posizione mantenendo l’inerzia: ad esempio, non ammettere di doverlo ancora (perché un eventuale riconoscimento orale, pur non scrivendo, almeno interrompe moralmente – anche se non prova, meglio non fare ammissioni nemmeno verbali, potrebbero testimoniare). Alcuni debitori preferiscono inviare al creditore una comunicazione, dopo il termine, dicendo “ti informo che il tuo credito è prescritto, dunque non lo pagherò”. Non è strettamente necessario e, se il creditore magari nemmeno ci pensava più, può risvegliarlo. Quindi spesso è meglio non fare nulla e sperare che nemmeno il creditore faccia più nulla. In sintesi: una volta trascorso il tempo, il debito è prescritto per legge. Starà al debitore farlo valere se necessario. Non c’è un registro pubblico delle prescrizioni.
D8: Ho ricevuto una diffida di pagamento per un vecchio debito. Posso ignorarla?
R: Se sei certo che il debito sia prescritto, in teoria anche ignorandola il creditore non potrebbe (legalmente) farti nulla. Tuttavia, ignorare è sconsigliato per due motivi: 1) Il creditore potrebbe comunque tentare un’azione legale, contando sul fatto che tu possa non difenderti, e se tu la ignori anche quella, finisci con un provvedimento esecutivo a tuo carico (pur potendo eccepire la prescrizione). 2) Tacere potrebbe essere interpretato dal creditore come un segnale di debolezza o di disinteresse: potrebbe intensificare gli sforzi (es. chiamate, visite di esattore, ecc.). È invece opportuno replicare formalmente contestando la pretesa per prescrizione . Così metti subito in chiaro che sei consapevole dei tuoi diritti e, verosimilmente, il creditore penserà due volte prima di avviare una causa che sa già che perderà. Ci sono però delle eccezioni: se la diffida proviene da soggetti poco seri o anonimi (es. non si capisce chi sia, importi non dettagliati), bisogna prima accertare che non sia una truffa. Ma in genere rispondere via raccomandata/PEC è la strategia difensiva migliore. Diverso è l’atto giudiziario: quello non devi MAI ignorare, nemmeno se credi al 100% che sia prescritto, perché come detto va eccepito in giudizio attivamente.
D9: Cosa succede se pago volontariamente un debito già prescritto? Posso riavere indietro i soldi?
R: No, il pagamento volontario di un debito prescritto non è ripetibile. L’art. 2940 c.c. parla chiaro: ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto non può essere richiesto indietro . La logica è che la prescrizione tutela chi vuole opporla, ma se uno decide di adempiere comunque, significa che riconosce un dovere morale o naturale, quindi il pagamento è definitivo (si configura come adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.). Quindi, se hai scoperto dopo di aver pagato un credito prescritto, purtroppo non hai azioni legali efficaci per recuperarlo. L’unica eccezione sarebbe se il pagamento non era “spontaneo” ma estorto con violenza o altre cause di annullamento del contratto (ma sono casi limite e complessi da provare: es. minaccia di denuncia infondata, errore essenziale su qualcosa di diverso dalla prescrizione…). In generale, consideralo perso. Meglio quindi accertare prima di pagare se era dovuto o no. Se hai dubbi sulla prescrizione di un debito, consulta un esperto prima di effettuare transazioni.
D10: Il creditore continua a chiedermi soldi per un debito prescritto, tartassandomi di telefonate e lettere. Posso denunciarlo o farlo smettere?
R: Sì, hai diversi strumenti. Innanzitutto, come detto, rispondi con lettera formale eccependo la prescrizione e diffidandolo dal proseguire . Questo spesso basta. Se continua con metodi molesti (telefonate reiterate, magari al lavoro, a parenti, toni minacciosi), puoi: – Inviare un reclamo scritto alla società stessa (se è una società di recupero crediti). Le serie hanno uffici reclami e ompliance. – Segnalare la condotta all’AGCM (Autorità Garante Concorrenza e Mercato) che vigila sulle pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust ha più volte sanzionato operatori finanziari e di recupero crediti per aver insistito su crediti palesemente prescritti, giudicandolo un comportamento aggressivo ai sensi del Codice del Consumo . La tua segnalazione può contribuire a far aprire un’istruttoria. In genere l’AGCM richiede copia delle comunicazioni ricevute. – Valutare se ci sono estremi per una denuncia alle autorità: se, ad esempio, ti minacciano penalmente (“ti facciamo pignorare tutto, ti mandiamo in galera” – quest’ultima è una minaccia infondata, i debiti civili non portano al carcere; questo potrebbe configurare il reato di minaccia o estorsione tentata). Oppure se divulgano la tua situazione a terzi (violazione privacy). La Polizia Postale o i Carabinieri possono raccogliere denunce di questo tipo, se c’è un illecito. – Coinvolgere un’associazione di consumatori. Federconsumatori, Adusbef ecc. hanno assistito persone molestate da recuperatori: a volte una lettera dell’associazione intimorisce la società di recupero (c’è il precedente di multe AGCM e cattiva pubblicità). – Se la società di recupero è iscritta ad Unirec (un’associazione di categoria), c’è un codice deontologico: si può segnalare la violazione all’associazione. In ogni caso, hai pieno diritto di pretendere che non ti si disturbi per un’obbligazione estinta. Qualsiasi richiesta di denaro deve specificare la causale e, se tu replichi che è prescritta, insistere può costituire pratica scorretta. Nel 2014 l’AGCM ha proprio vietato a una società di recupero di continuare richieste su crediti annullati o prescritti , imponendo una sanzione. Quindi sappi che la legge è dalla tua parte: fai valere i tuoi diritti anche segnalando l’abuso.
D11: Se un debito viene riconosciuto dal debitore dopo la prescrizione, che succede?
R: Se il debitore rinuncia alla prescrizione una volta maturata (esplicitamente o implicitamente), il debito “rivive” e il creditore può esigerlo. La rinuncia può avvenire con un atto formale (una dichiarazione scritta che di solito il creditore fa firmare ingenuamente al debitore) oppure tacita, attraverso un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione . Il tipico comportamento è il pagamento (anche parziale) o la promessa di pagare. L’art. 2944 c.c. stabilisce che un riconoscimento del diritto da parte del debitore ha effetto interruttivo (se la prescrizione non è ancora compiuta) e possiamo dire anche di rinuncia (se era già compiuta). Ad esempio: avevi un debito prescritto, ma firmi una lettera in cui riconosci di dovere quella somma – hai rinunciato alla prescrizione e da quella data il credito è nuovamente efficace e comincerà un nuovo periodo di prescrizione ex novo. Attenzione: la legge vieta di pattuire anticipatamente la rinuncia (non puoi in anticipo rinunciare a futuri effetti di prescrizione, art. 2937), ma puoi farlo dopo che la prescrizione è maturata. In pratica, non firmare mai nulla relativo a un vecchio debito senza consultare un legale. Anche una mail in cui scrivi “riconosco il mio debito, datemi tempo” è sufficiente a far perdere il beneficio della prescrizione. Se invece, ad esempio, stai trattando una transazione e vuoi che la tua disponibilità non valga come rinuncia finché non si chiude l’accordo, assicurati di inserire diciture tipo “questa proposta è formulata in via transattiva e senza riconoscimento del debito, riservando ogni eccezione, ivi compresa la prescrizione”. Così cerchi di prevenire fraintendimenti. In sostanza, dopo la prescrizione il potere è nelle mani del debitore: se vuole può spontaneamente pagare o riconoscere (e allora il creditore torna a poterlo esigere); se non vuole, nulla può costringerlo (purché eccepisca a dovere).
D12: La prescrizione può essere sospesa? In quali casi?
R: Sì, la prescrizione può subire sospensioni, ovvero periodi durante i quali il “conteggio del tempo” si ferma temporaneamente per cause specifiche. Alcune cause previste dal Codice Civile (art. 2941 e seguenti) includono: rapporti particolari fra le parti (ad es. tra coniugi, finché un figlio è minorenne verso i genitori, tra persone sottoposte a tutela o amministrazione di sostegno e tutore, eredi con eredità giacente, etc.), oppure il caso di forza maggiore che impedisce al titolare di agire (non codificato espressamente, ma la giurisprudenza lo ammette in situazioni estreme). Un esempio classico: i termini di prescrizione tra coniugi sono sospesi per tutta la durata del matrimonio per i crediti che derivano da obblighi tra coniugi (non decorre finché sono sposati). Altro esempio: durante la pandemia Covid, con i tribunali chiusi, una legge ha sospeso per alcuni mesi (da febbraio a maggio 2020) i termini di prescrizione e decadenza in materia civile. Quindi quel periodo non contava. Altro caso: la presentazione di una domanda di mediazione o conciliazione prevista come obbligatoria per alcune controversie sospende la prescrizione per la durata del procedimento di mediazione e per un certo periodo (4 mesi + eventualmente 3 mesi in caso di mediazione demandata dal giudice – v. D.Lgs. 28/2010). Idem per la negoziazione assistita in certe materie. Anche il fallimento del debitore sospende le azioni dei creditori, ma sulla prescrizione incide parzialmente (dopo il fallimento c’è una disciplina particolare). Comunque, le sospensioni sono eccezionali e previste tassativamente. Quando cessa la causa di sospensione, il tempo riprende da dove si era fermato. Esempio pratico: Tizio ha un credito verso Caio; Caio e Tizio si sposano – da quel momento la prescrizione del credito di Tizio è sospesa, rimane così magari per 10 anni, poi divorziano: da lì ricomincia a decorrere il residuo di tempo che mancava, e se ne era già passata metà prima del matrimonio, riprende da metà. Per un debitore, le sospensioni sono vantaggiose perché impediscono al credito di prescriversi finché c’è quella situazione (cioè prolungano la vita del credito). Per il debitore, invece, significano che non può “far conto” che il tempo passi in quel periodo. In pratica, verificate sempre se tra voi e il creditore c’era qualcuno di questi rapporti protetti. Nella maggior parte dei casi commerciali e di consumo, no.
D13: La prescrizione si applica anche ai debiti con lo Stato, tipo multe o tasse?
R: Sì, anche i crediti dello Stato o di enti pubblici non possono restare esigibili all’infinito: se l’ente non agisce entro certi termini, decadono o prescrivono. Nello specifico, le multe stradali (sanzioni amministrative) si prescrivono in 5 anni dopo che sono divenute definitive (es. dal momento in cui avresti dovuto pagarle se non hai fatto ricorso) . Le tasse e imposte hanno un sistema misto: per l’accertamento ci sono termini di decadenza (di solito 5 anni dall’anno d’imposta per notifica dell’avviso, 7 anni se omessa dichiarazione, etc.), mentre una volta formato l’accertamento (o la cartella) e scaduti i termini di impugnazione, si passa alla fase di riscossione, regolata dalla prescrizione. Le regole non sono sempre uniformi: – Le imposte erariali (es. IRPEF, IVA) formalmente non hanno un termine di prescrizione definito dal legislatore, ma la Cassazione tende ad applicare il decennale salvo eccezioni . – I tributi locali (IMU, Tari, Bollo auto) la legge o la giurisprudenza li considerano quinquennali . – I contributi previdenziali e le relative sanzioni sono quinquennali (dopo le riforme) . – Le sanzioni tributarie amministrative: quinquennali se non c’è giudizio , se confermate da giudice diventano decennali . Comunque, sì: se hai una cartella esattoriale vecchia, controlla quando risale l’ultimo atto notificatoti; se sono passati più di 5 anni (per multe, contributi, tributi locali) o 10 anni (per imposte erariali, sanzioni giudiziali), potresti eccepirne la prescrizione. Occhio: come visto, devi impugnarle ai sensi di Cass. 21240/25 , non basta aspettare. Esempio: hai una cartella del 2010 per IRPEF, mai seguita da null’altro, oggi 2025: se l’Agenzia Entrate Riscossione ti fa un pignoramento, puoi opporti per prescrizione (10 anni passati) e vincerai. Però se ignorassi l’atto di pignoramento, il giudice non lo vedrebbe da solo. Quindi sì, anche i debiti verso PA si prescrivono.
D14: Se ho garantito il debito di un altro (fideiussione), la prescrizione come funziona?
R: La prescrizione del credito principale ha effetto anche per il garante. Il fideiussore può eccepire la prescrizione maturata sul debito principale (art. 1957 c.c. pone anche una decadenza specifica per escutere il fideiussore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale se quella è a termine; se il creditore se la fa scappare, il fideiussore è libero). In generale, se il debitore principale rinuncia alla prescrizione, ciò non toglie al fideiussore di opporla per sé, salvo la rinuncia sia fatta con il suo consenso. In pratica: se c’è un fideiussore, il creditore spesso interrompe con atti separati per entrambi per sicurezza; altrimenti, attenzione, il codice dice che l’interruzione verso il debitore principale vale anche verso il fideiussore (art. 1310 c.c.) . Quindi il garante non può sperare che il creditore si dimentichi di lui se ha sollecitato il debitore: se notifica una diffida al debitore principale, interrompe pure per il garante. E viceversa: un atto contro il fideiussore interrompe anche per il debitore. Quindi c’è solidarietà e unico destino in termini di prescrizione, però la prescrizione continua a decorrere separatamente: spesso se il debitore non paga, fanno decreto contro entrambi e amen. Se lasciassero passare anni, il garante può eccepire come il principale.
D15: Dopo quanti anni un pignoramento o una sentenza di condanna non sono più eseguibili?
R: Un titolo esecutivo (es. una sentenza di condanna definitiva o un decreto ingiuntivo non opposto) si prescrive in 10 anni dal passaggio in giudicato . È la cosiddetta actio iudicati. Ciò significa che se il creditore munito di sentenza favorevole rimane fermo per 10 anni senza fare atti esecutivi, trascorso quel periodo il debitore può opporsi ad un eventuale pignoramento tardivo per intervenuta prescrizione del diritto a eseguire . Tuttavia, quasi sempre i creditori non aspettano 10 anni senza far nulla. Basta che entro quel decennio compiano un atto di esecuzione (notifica precetto, o meglio ancora un pignoramento, o un atto di riattivazione della procedura esecutiva) per interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo decennio . Molti creditori per tenere “in vita” i titoli notificano un precetto ogni 9 anni, ad esempio. O iscrivono ipoteca giudiziale e poi procedono. Quindi attenzione: se hai una vecchia sentenza contro, non pensare di esserne fuori passati 10 anni se il creditore, magari a tua insaputa, ha fatto qualcosa nel frattempo (tipo rinnovato un pignoramento infruttuoso). Devi verificare eventuali atti. Se davvero per oltre 10 anni non hai ricevuto alcun atto esecutivo, puoi rifiutarti di pagare, ma comunque se ti arriva un precetto devi fare opposizione subito eccependo la prescrizione del titolo. Per i pignoramenti in corso: se un pignoramento è avviato ma resta pendente senza sviluppi (es. pignoramento presso terzi senza udienza da anni), c’è una norma che dopo 2 anni di stasi si estingue la procedura esecutiva. Ma il creditore può notificarne uno nuovo finché il titolo è valido (10 anni come sopra, rinnovabili).
D16: Qual è la differenza tra “prescrizione presuntiva” e prescrizione normale?
R: Le prescrizioni presuntive (artt. 2954-2956 c.c.) sono termini brevissimi (6 mesi, 1 anno, 3 anni) applicabili a taluni rapporti (debiti di albergatori, ristoratori, commercianti al minuto; debiti per spese di professionisti, insegnanti, prestazioni periodiche sanitari, ecc.). Non significano che dopo quel termine il diritto si estingue sicuramente, ma che si presume pagato se il debitore, citato in giudizio, dichiara di aver pagato senza prova scritta da parte del creditore. Sono nate per tutelare i debitori in quei rapporti in cui usualmente i pagamenti avvengono in contanti e i ricevute si perdono col tempo: dopo tot mesi/anni, se il creditore non ha già chiesto, la legge presume che abbia riscosso e se il debitore semplicemente dice “ho pagato”, l’onere della prova contraria ricade sul creditore (che difficilmente potrà provare il negativo se non ha quietanza firmata). Se però il debitore ammette di non aver pagato e oppone solo la prescrizione, il giudice non applica la presunzione di pagamento, perché quella scatta solo se c’è un’affermazione di avvenuto pagamento (anche contro la verità, la legge permette al debitore di “mentire” in questo caso per proteggere la quiete dei rapporti). Insomma è un meccanismo peculiare, differente dalla prescrizione estintiva. Nella pratica attuale, con pagamenti tracciati, queste prescrizioni presuntive hanno perso molto rilievo. Riguardano cifre modeste di solito. Se sei debitore in uno di questi casi e vieni citato dopo anni, il tuo avvocato probabilmente ti consiglierà di dichiarare di aver saldato a suo tempo; a quel punto il creditore dovrà esibire una tua firma su un documento che attesti il contrario (cosa improbabile se la legge ha previsto termini così brevi proprio perché non circolano ricevute per così lungo). Se invece il debitore rimane inerte, il giudice applicherà la prescrizione ordinaria (che sarà di 5 o 10 anni di solito, e magari non ancora decorsa). La differenza pratica: la prescrizione normale devi eccepirla e portare prove del decorso; la presuntiva devi dichiarare il pagamento e non contestare di non dovere il debito in sé. Sembrano simili ma giuridicamente funzionano diversamente.
D17: Un mio creditore ha ottenuto una sentenza di condanna contro di me senza che mi sia difeso, ma il credito era già prescritto all’epoca. Posso fare qualcosa?
R: Situazione difficile. Se la sentenza è passata in giudicato (perché non hai fatto appello) o se era un decreto ingiuntivo non opposto in tempo, quel titolo è valido a prescindere dalla prescrizione originaria. Purtroppo, il giudice non l’avrà considerata proprio perché tu non l’hai eccepita. Non esiste uno strumento ordinario per far valere postumo la prescrizione non eccepita. Potresti tentare una revocazione straordinaria della sentenza dimostrando che c’è stato un errore di fatto o una frode; ma il fatto che fosse prescritto non è errore di fatto (è errore di diritto e per giunta dovuto alla tua mancata eccezione). Nemmeno l’opposizione di terzo è adatta. Se la notifica della citazione/decreto fu viziata e tu non ne hai avuta conoscenza in tempo, potresti far valere quel vizio: ad esempio, opposizione tardiva a decreto ex art. 650 cpc se provi che la notifica ti è giunta nulla e hai saputo tardi. In quell’opposizione tardiva, potresti eccepire la prescrizione e magari vincere. Ma se ti hanno notificato bene e tu hai ignorato, no, non c’è rimedio: la prescrizione si considera rinunciata implicitamente perché non eccepita in giudizio . Dovrai quindi subire il pagamento. L’unica consolazione: se il creditore poi rimane inattivo col titolo per 10 anni, allora almeno quel titolo si prescriverà per il futuro (actio iudicati).
D18: Una volta che un debito è dichiarato prescritto in giudizio, che succede?
R: Se la pronuncia (sentenza o ordinanza) accerta che il diritto è prescritto, la domanda del creditore viene rigettata in quanto infondata per sopravvenuta estinzione del diritto. Il debito viene quindi consolidato come non esigibile. Il creditore soccombente di regola non può riproporre la stessa domanda, perché andrebbe incontro a un giudicato negativo (che ha accertato l’estinzione). Quindi per quel credito la partita è chiusa. Potrebbe appellare quella sentenza, certo, sostenendo che la prescrizione non era maturata ecc., ma se passano i termini o perde l’appello, fine. Inoltre, il giudice se rigetta per prescrizione non entra nel merito (di solito); anche se magari il debitore era dovuto, non importa, viene respinto e basta. La formula tipica: “dichiara estinto per prescrizione il diritto fatto valere dall’attore” oppure “respinge la domanda perché il credito è prescritto”. Dopo ciò, il creditore non ha strumenti ulteriori, se non eventuali ricorsi per Cassazione se ravvede errori di diritto nell’applicazione della prescrizione. Se fosse proprio un caso ingiusto in coscienza (tipo un debitore si è arricchito di un maltolto ma la vittima perde per prescrizione), può esserci amarezza morale ma la legge privilegia la certezza. Per il debitore, avere una sentenza che attesta la prescrizione è definitivo: potrà opporla a qualsiasi ulteriore tentativo (fa stato tra le parti). Anche eventuali coobbligati beneficiano (es. se uno dei condebitori ottiene pronuncia di prescrizione comune, gli altri coobbligati ne giovano, di solito, essendo stessa obbligazione). Quindi sì, potrai stare tranquillo.
D19: Quali sono i costi legali per far valere la prescrizione? Ne vale la pena?
R: Eccepire la prescrizione in una causa non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli di difesa: è parte della normale attività dell’avvocato nella comparsa di risposta od opposizione. Se invece decidi tu di iniziare una causa di accertamento negativo per far dichiarare la prescrizione, dovrai pagarne le spese come attore, sperando poi di recuperarle se vinci. Di solito, conviene far valere la prescrizione come difesa, così se vinci il giudice di regola condanna l’attore (creditore) a pagare le spese legali tuoi, secondo tariffario. Quindi tu potresti non sborsare nulla o solo una parte minima (se il giudice liquida spese inferiori a quelle concordate col tuo legale, dovrai integrare la differenza). Va detto che i giudici a volte, soprattutto in materia di cartelle esattoriali, compensano le spese se ritengono che il ritardo dell’ente abbia confuso le acque. Ma spesso, soprattutto in cause civili tra privati, chi perde paga. Quindi far valere la prescrizione è generalmente conveniente. Immagina: debito di 10.000€, prescrizione chiara; spendi magari 1.500€ di avvocato, e ottieni rigetto domanda e condanna spese 1.500 a tuo favore – ti va in pari, risparmi comunque 10.000. Bisogna ovviamente valutare caso per caso con il legale: se è un importo modesto (es. 200€ di bolletta) magari non conviene andare in tribunale, meglio cercare di risolvere stragiudizialmente. Le spese variano anche dal grado di giudizio e complessità: se la controparte appella, devi difenderti in secondo grado, altre spese (ma di solito per 10k ne vale comunque la pena). In sintesi, far valere la prescrizione conviene, purché tu non abbia dubbi seri sulla fondatezza dell’eccezione. Un avvocato onesto ti dirà se è rischioso (tipo “mettiamo l’eccezione ma c’è questo atto in mezzo, non so se il giudice lo riterrà interruttivo…”). In quei casi, a volte si trova un compromesso col creditore. Ad esempio: credito di 100k, tu eccepisci prescrizione ma c’è 50% di rischio di perderla; magari si transige a 30k e chiudi, per evitare di pagarne 100 se va male o zero se va bene (scelta di rischio). Ogni situazione è a sé.
D20: Un creditore ha un decreto ingiuntivo contro di me, ma sono passati più di 10 anni senza che l’abbia mai eseguito. Posso farlo annullare?
R: Non “annullare” (il decreto in sé resta valido formalmente), ma se ora notificasse precetto o procedesse, tu puoi eccepire che è prescritto il diritto di procedere in forza di quel titolo . In pratica, fai un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc in cui chiedi al giudice dell’esecuzione di dichiarare improcedibile l’azione esecutiva perché l’ingiunzione è divenuta ineseguibile per prescrizione (essendo trascorsi oltre 10 anni senza atti). Se l’ultimo atto fu il decreto notificato, e poi silenzio per 10+ anni, è caso da manuale. Attento: se invece ci furono atti esecutivi infruttuosi (es. un pignoramento mobiliare nel frattempo, anche se poi estinto), quello ha interrotto. Ti serve che davvero zero atti esecutivi siano avvenuti. Se così è, il giudice accoglierà l’opposizione e di fatto il creditore non potrà più utilizzare quel titolo. Formalmente il decreto rimane, ma è vuoto di efficacia esecutiva. Non c’è un meccanismo per “cancellarlo” dai registri, semplicemente non può essere utilmente impiegato.
Conclusione
La prescrizione dei debiti è dunque un istituto che offre al debitore diligente una tutela fondamentale contro le pretese tardive dei creditori negligenti. Nel sistema giuridico italiano, la prescrizione svolge la funzione di stabilizzare i rapporti: il creditore è stimolato ad agire tempestivamente, il debitore dopo un certo periodo di inazione può legittimamente considerarsi libero. Tuttavia, come abbiamo visto, questa libertà deve essere attivamente difesa dal debitore stesso attraverso l’eccezione di prescrizione sollevata nelle sedi opportune . Il decorso del tempo da solo non basta se il debitore, per ignoranza o disattenzione, permette al creditore di ottenere provvedimenti esecutivi. Conoscere i propri diritti e i tempi è quindi essenziale: molti cittadini, privati e imprenditori, pagano indebitamente somme che non sarebbero più dovute, oppure subiscono cause evitabili, solo per mancata conoscenza dell’intervenuta prescrizione.
D’altro canto, abbiamo sottolineato che la prescrizione non deve essere vista come uno strumento per sottrarsi furbescamente ai doveri: è una garanzia legale e come tale va usata in buona fede. Per esempio, un debitore che scientemente lascia maturare la prescrizione magari approfittando di difficoltà di notifica, agisce sì legittimamente ma deve comunque rispettare le forme di legge. La controparte potrebbe cercare di reagire in modi subdoli (abbiamo parlato di minacce o artifizi da recuperatori). Ecco perché avere un consulente legale preparato fa la differenza: dal individuare esattamente il dies a quo della prescrizione (che talvolta non è intuitivo), al capire se un atto è realmente interruttivo, fino a condurre la difesa in giudizio in modo efficace.
Nel 2025, come abbiamo visto, la giurisprudenza ha emesso decisioni importanti che rafforzano la necessità di un comportamento reattivo del debitore: la Cass. 21240/2025 insegna che silenzio non è sempre d’oro (se taci su un’intimazione, perdi il diritto di far valere la prescrizione ), mentre altre pronunce confermano orientamenti di tutela (sanzioni tributarie quinquennali , contributi 5 anni , interessi quinquennali , ecc.). Il legislatore stesso, riducendo i termini per le bollette di utenze a 2 anni , ha mostrato attenzione per i consumatori, ma ha anche introdotto obblighi di comunicazione al cliente (che se non rispettati sospendono la prescrizione, nell’energia il venditore deve avvisare che la bolletta contiene consumi prescrivibili, se non lo fa il termine slitta ). Ciò evidenzia un trend: semplificare e accorciare i termini, ma anche responsabilizzare le parti.
In conclusione, dal punto di vista del debitore, il messaggio di questa guida è chiaro: vigilare sul tempo, tenere traccia delle proprie posizioni debitorie e non avere timore di far valere la prescrizione come difesa, poiché è un diritto sancito dalla legge e riconosciuto dalla magistratura . Contestualmente, agire con correttezza: non tentare trucchi fuori dalla legge (es. trasferire la residenza per far mancare notizie, contare su vizi creati ad arte) perché si rischia di scivolare nell’abuso. La strada maestra è conoscere le regole e seguirle.
Chiudiamo con un consiglio pratico finale: se hai dubbi sulla prescrizione di un tuo debito (o credito, dal lato opposto), consulta sempre le fonti normative (Codice Civile e leggi speciali) e le ultime pronunce pertinenti , e non esitare a farti assistere da un professionista. Una piccola spesa oggi può farti risparmiare una somma ben maggiore domani evitando di pagare ciò che non è dovuto.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile (R.D. 262/1942) – Libro VI, Titolo V: Art. 2934 c.c. (Estinzione dei diritti per prescrizione) ; Art. 2937 c.c. (Divieto di rinuncia preventiva e rinuncia alla prescrizione compiuta); Art. 2938 c.c. (Non rilevabilità d’ufficio della prescrizione) ; Art. 2943 c.c. (Interruzione della prescrizione) ; Art. 2944 c.c. (Ricognizione di debito/Interruzione per riconoscimento);Art. 2946 c.c. (Prescrizione ordinaria decennale) ; Art. 2947 c.c. (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno) ; Art. 2948 c.c. (Prescrizione quinquennale per casi speciali: annualità, interessi, ecc.) ; Art. 2953 c.c. (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi – actio iudicati 10 anni) ; Art. 2955–2961 c.c. (Prescrizioni presuntive di 6 mesi, 1 anno, 3 anni per crediti specifici).
- Legge 335/1995 art. 3, co. 9 – Riforma previdenziale: fissazione della prescrizione contributi in 5 anni (dal 1/1/1996) salvo atti interruttivi; coord. con DL 384/1992.
- D.P.R. 602/1973 (Riscossione) – Art. 25 (Cartella di pagamento); Art. 50 (Intimazione ad adempiere entro 5 gg, necessaria se >1 anno da notifica cartella) – vedi Cass. 21240/2025 sull’effetto preclusivo .
- D.Lgs. 472/1997 (Sanzioni tributarie) – Art. 20, co. 3: prescrizione 5 anni per diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie; applicazione art. 2953 c.c. se c’è giudicato .
- Codice della Strada – Art. 209: prescrizione 5 anni sanzioni amministrative (rinvio alla L. 689/81).
- Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) – commi introduttivi prescrizione biennale bollette: consumi energia elettrica (dal 1 marzo 2018) e gas (dal 1 gennaio 2019) e acqua (dal 1 gennaio 2020); obbligo informazione in bolletta al cliente .
- Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) – Artt. 24-27: pratiche commerciali aggressive e scorrette. Provvedimenti AGCM su recupero crediti aggressivo su prescritti (es. PS/8710 AGCM 2013) .
Sentenze e pronunce principali citate:
- Cass., Sez. Un. Civili, 17/11/2016 n. 23397 – Principio di diritto: la mancata impugnazione nei termini di legge della cartella di pagamento non comporta l’applicazione dell’art. 2953 c.c., per cui il credito rimane soggetto al termine prescrizionale proprio della natura del credito stesso (es. quinquennale per contributi previdenziali, tributi locali, ecc.), e non si converte in decennale .
- Cass., Sez. Trib., 21/07/2025 n. 21240 (rel. A. Crivelli) – Intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73: costituisce atto impugnabile; se non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa e preclude al contribuente di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla scadenza del termine di impugnazione . (In motivazione, richiama necessità di impugnare subito per non perdere la tutela).
- Cass., Sez. VI – 5, Ord. 26/02/2024 n. 4969 – Sanzioni tributarie: conferma prescrizione quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/97 per sanzioni non giudizialmente accertate; se invece provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si applica il termine decennale ex art. 2953 c.c.. Precisato che anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo hanno termine quinquennale autonomo ex art. 2948 n.4 c.c. .
- Cass., Sez. Lavoro, Ord. 27/03/2024 n. 8288 – Ribadito che l’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato (non di merito stretto) e può essere rilevata d’ufficio dal giudice se risultano atti interruttivi in atti ; conferma onere del debitore di eccepire prescrizione e onere del creditore di provare fatti interruttivi tempestivamente dedotti .
- Cass., Sez. I, 12/06/2025 n. 15684 – In materia di conto corrente con affidamento: gli addebiti relativi a interessi e competenze su saldo passivo entro i limiti dell’affido non costituiscono pagamenti esigibili e dunque non sono soggetti a prescrizione finché il fido permane . Occorre prima rideterminare il saldo al netto di poste illegittime e distinguere rimesse solutorie (extrafido) da ripristinatorie (intrafido) . (Conferma orientamento su rimesse bancarie solutorie vs ripristinatorie).
- Cass., Sez. Trib., 19/09/2024 n. 25222 – In tema di tributi erariali, afferma che se il credito erariale è fondato su accertamento divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato, non si applicano i termini di decadenza o prescrizione brevi, bensì opera il termine decennale ex art. 2953 c.c. . (Conformi Cass. 9431/2024 e altre).
- Cass., Sez. III, 29/02/2024 n. 5364 – Chiarisce che la proposizione di una domanda di mediazione interrompe la prescrizione solo se dal relativo verbale si evincono con certezza le pretese avanzate; nel caso di specie la mancata prova del contenuto dell’istanza di mediazione ha comportato il mancato riconoscimento dell’interruzione .
- Cass., Sez. III, 21/05/2025 n. 13556 – Esempio di applicazione del termine decennale per diritto soggetto originariamente a prescrizione breve: riconosce prescrizione decennale decorrente dall’entrata in vigore di norma che prevedeva un diritto a elargizione per vittime del dovere, trattandosi di diritto sorto ex lege e non esercitato (massima tratta da avvocato.it) . [Sentenza citata a titolo di esempio del decennale ordinario su diritti di credito derivanti da legge].
- Cass., Sez. Lav., 10/01/2025 n. 602 – In tema di contributi omessi per rapporto di lavoro convertito a tempo indeterminato, chiarisce decorrenza della prescrizione quinquennale INPS dal momento della scadenza originaria del termine di versamento (non dal giudicato sulla nullità del termine) . [Conferma indipendenza del termine prescrizionale quinquennale dei contributi anche in caso di pronunce giudiziali].
- Cass., Sez. Un., 16/12/2019 n. 33797 – Principio generale: la scadenza del termine per opporsi o impugnare un atto di riscossione a mezzo ruolo comporta irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine di prescrizione breve in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale . (Applicato a contributi previdenziali e entrate tributarie locali: in assenza di giudicato, resta prescrizione breve). Questa è la base confermata poi dalle sezioni semplici successive.
- Corte di Giustizia UE, sentenza 8/09/2011 (causa C-180/10) – (Non citata sopra, ma di contesto) Ha affermato che in materia di servizi telefonici la previsione nazionale di prescrizione biennale (all’epoca esistente per operatori mobili) non contrasta con il diritto UE. [Ora superata dalla riforma 2018 che ha introdotto 2 anni per tutte le utenze].
Hai ricevuto una richiesta di pagamento per un vecchio debito che pensavi fosse ormai prescritto? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto una richiesta di pagamento per un vecchio debito che pensavi fosse ormai prescritto?
👉 Attenzione: in alcuni casi i debiti prescritti possono tornare esigibili se non si reagisce correttamente o se vengono compiuti atti che interrompono la prescrizione.
In questa guida aggiornata al 2025, ti spiego quando un debito è davvero prescritto, in quali casi può “rivivere”, e come difenderti legalmente per evitare di dover pagare somme non più dovute.
💥 Cos’è la Prescrizione di un Debito
La prescrizione è il termine di tempo oltre il quale un creditore non può più chiedere legalmente il pagamento di un debito.
In pratica, se passa un certo numero di anni senza che il creditore agisca in modo formale, il diritto di credito si estingue per legge.
📌 Tuttavia, non basta che siano passati degli anni: serve verificare che non ci siano stati atti interruttivi o riconoscimenti del debito.
⚖️ I Principali Termini di Prescrizione
Ogni tipo di debito ha un termine di prescrizione diverso.
| Tipo di Debito | Termine di Prescrizione | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Imposte e tasse (IRPEF, IVA, IRES, IMU, TARI) | 10 anni | Art. 2946 c.c. |
| Contributi INPS/INAIL | 5 anni | Art. 3, L. 335/1995 |
| Multe e sanzioni amministrative | 5 anni | Art. 28, L. 689/1981 |
| Prestiti, mutui, fidi bancari | 10 anni | Art. 2946 c.c. |
| Bollette luce, gas, acqua, telefono | 5 anni | Art. 2948 c.c. |
| Canoni di locazione | 5 anni | Art. 2948 c.c. |
| Stipendi o salari non pagati | 5 anni | Art. 2948 c.c. |
| Cartelle esattoriali (in generale) | 5 anni | Cass. SS.UU. 23397/2016 |
📌 I termini decorrono dal giorno in cui il pagamento era dovuto ma ripartono da zero se il creditore compie atti interruttivi.
💠 Quando un Debito Prescritto Può Tornare Esigibile
Un debito non si “riattiva” da solo, ma può tornare esigibile nei seguenti casi:
🔹 1. Atto Interruttivo della Prescrizione
Se il creditore o l’Agenzia delle Entrate invia una notifica valida (cartella, decreto ingiuntivo, precetto, atto giudiziario), la prescrizione si interrompe e ricomincia da zero.
📌 Esempio: un debito prescritto dopo 5 anni si “riattiva” se nel frattempo ricevi un decreto ingiuntivo notificato regolarmente.
🔹 2. Riconoscimento del Debito
Se il debitore ammette o riconosce il debito, anche in modo implicito, la prescrizione si interrompe.
Succede, ad esempio, se:
- firmi una richiesta di saldo e stralcio;
- effettui un pagamento parziale;
- invii una lettera o e-mail di trattativa con il creditore.
📌 In questi casi, il debito riprende vita legalmente e può essere riscosso di nuovo.
🔹 3. Sentenza o Titolo Esecutivo
Se il creditore ha già ottenuto una sentenza o decreto ingiuntivo, la prescrizione passa da 5 a 10 anni, e il debito può essere eseguito coattivamente (pignoramento, ipoteca, ecc.).
📌 Anche un vecchio debito bancario o fiscale può tornare “vivo” se esiste un titolo esecutivo.
🔹 4. Società di Recupero Crediti e Fondi NPL
Molte società acquistano crediti deteriorati (NPL) da banche o finanziarie e inviano lettere o solleciti di pagamento.
Ma attenzione: solo gli atti notificati da soggetti legittimati e con prova di cessione valida interrompono la prescrizione.
📌 Se la società non prova di aver acquistato legalmente il credito, non può chiedere nulla.
⚠️ Cosa Fare se Ti Chiedono un Debito Prescritto
Se hai ricevuto una lettera o una richiesta di pagamento per un debito che ritieni prescritto:
1️⃣ Non pagare e non firmare nulla
Pagare o firmare un accordo riattiva la prescrizione e rende il debito nuovamente esigibile.
2️⃣ Chiedi la prova della validità del credito
Il creditore deve dimostrare:
- l’esistenza del debito;
- la mancanza di prescrizione;
- la prova della notifica di eventuali atti interruttivi.
📌 Se non può dimostrarlo, il debito non è più esigibile.
3️⃣ Invia una diffida legale o un’istanza di prescrizione
Con l’aiuto di un avvocato, puoi inviare una lettera di contestazione formale, dichiarando la prescrizione del debito e diffidando il creditore da ulteriori contatti.
📌 Questo blocca anche eventuali trattamenti illeciti dei tuoi dati personali da parte delle società di recupero crediti.
4️⃣ Impugna gli atti giudiziari ricevuti
Se ti arriva una cartella, un decreto ingiuntivo o un atto di pignoramento su un debito prescritto, puoi presentare:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (per debiti fiscali);
- opposizione al decreto ingiuntivo (entro 40 giorni);
- ricorso in opposizione agli atti esecutivi (per pignoramenti).
📌 Se il giudice riconosce la prescrizione, l’atto viene annullato e il debito cancellato definitivamente.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Copia della lettera o atto ricevuto;
- Documenti o contratti originari del debito;
- Eventuali ricevute di pagamento o comunicazioni con il creditore;
- Estratto di ruolo o atti notificati dall’Agenzia delle Entrate.
📌 Questi documenti servono per verificare se la richiesta è valida o se il debito è effettivamente prescritto.
⏱️ Tempi per la Difesa Legale
- Verifica della prescrizione: 3–5 giorni;
- Diffida o contestazione formale: 1 settimana;
- Opposizione o ricorso giudiziario: entro 40 o 60 giorni (a seconda del tipo di atto);
- Decisione del giudice: in 1–6 mesi circa.
📌 Agire subito è fondamentale: un atto notificato correttamente può interrompere la prescrizione e riaprire il debito.
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✅ Blocco immediato di richieste illegittime o cartelle prescritte.
✅ Cancellazione definitiva dei debiti non più esigibili.
✅ Protezione del patrimonio e dei tuoi diritti.
✅ Prevenzione contro riattivazioni fraudolente da società di recupero crediti.
✅ Assistenza completa davanti ai Tribunali e alla Corte Tributaria.
🚫 Errori da Evitare
❌ Pagare o firmare accordi senza verificare la prescrizione.
❌ Ignorare lettere o notifiche, sperando che “passino da sole”.
❌ Non conservare le prove di vecchie comunicazioni o pagamenti.
❌ Rivolgersi a intermediari non qualificati o agenzie non legali.
📌 Solo una verifica legale accurata ti garantisce la cancellazione definitiva dei debiti prescritti.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Verifica la prescrizione e la validità legale dei debiti contestati.
📌 Ti assiste nell’invio di lettere di diffida e richieste di annullamento.
✍️ Presenta ricorsi o opposizioni per bloccare atti di riscossione.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria o ai Tribunali Civili.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione definitiva del debito e alla tutela dei tuoi diritti.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e bancario.
✔️ Specializzato in prescrizione dei debiti e difesa contro società di recupero crediti.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di privati e imprese contro Agenzia delle Entrate e fondi NPL.
Conclusione
Un debito prescritto non può più essere riscosso, ma serve sapere quando e come far valere la prescrizione.
Con una consulenza legale mirata puoi bloccare richieste illegittime, contestare atti tardivi e ottenere la cancellazione definitiva del debito.
⏱️ Agisci subito: se ricevi una richiesta su un vecchio debito, verifica la prescrizione prima di pagare.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro le richieste di debiti prescritti può partire oggi stesso.