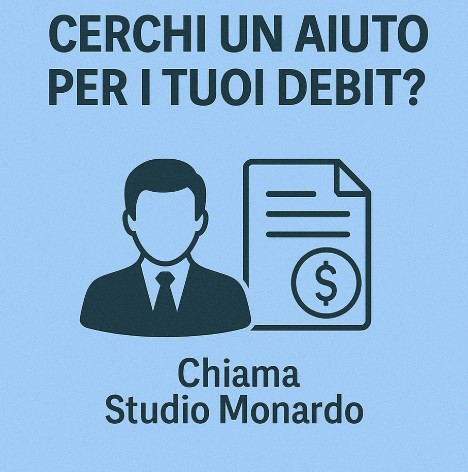Hai accumulato debiti con banche, finanziarie, fornitori o Agenzia delle Entrate e non riesci più a pagarli? Ti arrivano cartelle esattoriali, solleciti o minacce di pignoramento e non sai da dove cominciare? La buona notizia è che esistono soluzioni legali concrete per ridurre, rateizzare o cancellare i debiti, e un avvocato esperto in diritto tributario e crisi debitoria può aiutarti subito a ritrovare equilibrio e serenità.
Molte persone credono che non ci sia alternativa al fallimento personale o alla chiusura dell’attività, ma oggi la legge offre strumenti efficaci per difendersi dai creditori, sospendere la riscossione e ridurre l’importo complessivo dei debiti. Con la giusta strategia legale, puoi salvare i tuoi beni e ripartire.
Quando serve un aiuto legale per i debiti
Devi rivolgerti subito a un avvocato se:
- ricevi cartelle esattoriali o atti di pignoramento;
- hai debiti fiscali o contributivi con Agenzia delle Entrate o INPS;
- non riesci a pagare mutui, finanziamenti o prestiti bancari;
- hai fornitori o creditori che minacciano azioni legali;
- stai rischiando il pignoramento del conto, dello stipendio o della casa.
Un legale può analizzare la tua situazione e individuare la soluzione migliore per ridurre o azzerare i debiti, anche se hai già procedure di riscossione in corso.
Cosa può fare un avvocato per ridurre i debiti
Un avvocato specializzato in diritto tributario e sovraindebitamento può intervenire in vari modi per bloccare le azioni esecutive e trattare la riduzione del debito. Le principali soluzioni sono:
- Saldo e stralcio: negoziazione con banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate per chiudere il debito pagando solo una parte (spesso tra il 20% e il 50%).
- Rateizzazione del debito: ottenimento di piani di pagamento fino a 10 anni, evitando cartelle e pignoramenti.
- Composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012, oggi parte del Codice della Crisi): procedura giudiziale che consente di proporre ai creditori un piano sostenibile e ottenere la cancellazione dei debiti residui.
- Accordo con i creditori: definizione extragiudiziale con riduzione delle somme dovute.
- Sospensione della riscossione: blocco immediato di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi in presenza di vizi, ricorsi o procedure di composizione.
- Verifica di illegittimità dei debiti: controlli su interessi, anatocismo bancario, cartelle prescritte o errori nel calcolo fiscale.
Come funziona la riduzione dei debiti
L’avvocato analizza prima tutti i tuoi debiti (tributari, bancari e privati) e valuta:
- L’entità complessiva dell’esposizione;
- Le tue reali possibilità di pagamento;
- L’esistenza di eventuali vizi o prescrizioni;
- La strategia più conveniente (saldo e stralcio, rateizzazione, composizione della crisi, ricorso).
Dopo questa analisi, avvia le trattative con i creditori o presenta la domanda di composizione della crisi al Tribunale. In molti casi, è possibile ottenere una riduzione del debito fino al 70-80%, specialmente se si dimostra l’impossibilità oggettiva di pagare.
Quando i debiti possono essere ridotti o cancellati
Puoi ottenere la riduzione o l’annullamento dei debiti se:
- non possiedi beni di valore o patrimoni rilevanti;
- dimostri che la tua situazione economica non consente il pagamento integrale;
- hai subito eventi gravi (malattia, crisi aziendale, perdita del lavoro);
- collabori attivamente nel presentare una proposta credibile ai creditori;
- non hai commesso frodi o occultato patrimoni.
Il Tribunale può omologare il piano di rientro e cancellare i debiti residui al termine della procedura, liberandoti completamente.
Le strategie difensive più efficaci contro i creditori
- Bloccare subito pignoramenti e cartelle con un’istanza di sospensione cautelare;
- Impugnare atti illegittimi o prescritti dell’Agenzia delle Entrate o delle banche;
- Trattare un saldo e stralcio vantaggioso, pagando solo una parte del debito;
- Accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Dimostrare la mancata notifica o gli errori formali degli atti di riscossione;
- Negoziare piani di rientro sostenibili per evitare azioni esecutive.
Come scegliere l’avvocato giusto per ridurre i debiti
Affrontare una crisi debitoria richiede un avvocato con:
- specializzazione in diritto tributario e della riscossione;
- esperienza in trattative con Agenzia delle Entrate e istituti bancari;
- conoscenza delle procedure di composizione della crisi e del Codice della Crisi d’Impresa;
- collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro;
- capacità negoziale e strategica per ottenere riduzioni reali e legittime.
Un legale esperto può bloccare le azioni esecutive, ridurre le somme dovute e liberarti definitivamente dai debiti.
Cosa succede se non agisci subito
Ignorare i debiti non li cancella: li moltiplica. Se non ti difendi, rischi:
- pignoramenti su conti, stipendi, pensioni e beni;
- fermi amministrativi e ipoteche;
- iscrizione nelle banche dati dei cattivi pagatori (CRIF, CAI);
- cartelle e azioni esecutive;
- perdita del diritto di rateizzare o trattare.
Agire subito, invece, ti permette di bloccare tutto, trattare con i creditori e ripartire legalmente senza debiti.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta subito un avvocato se:
- sei sommerso da debiti fiscali o bancari;
- hai ricevuto cartelle esattoriali o pignoramenti;
- non riesci più a pagare le rate o le imposte;
- vuoi ridurre o azzerare legalmente i debiti e ripartire.
Un avvocato tributarista può:
- trattare saldo e stralcio o rateizzazioni con i creditori;
- attivare una procedura di composizione della crisi;
- bloccare pignoramenti e cartelle;
- ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti.
⚠️ Attenzione: se agisci in tempo, puoi ridurre drasticamente i tuoi debiti o cancellarli del tutto grazie agli strumenti di legge oggi previsti. Non aspettare che la situazione diventi irreversibile: un avvocato esperto può aiutarti a fermare i creditori, proteggere i tuoi beni e ripartire senza debiti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, sovraindebitamento e difesa contro la riscossione – spiega come ridurre i debiti, sospendere le azioni esecutive e tornare libero grazie all’assistenza di un avvocato specializzato.
👉 Hai debiti fiscali o bancari e vuoi liberartene?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, individueremo i debiti contestabili e costruiremo una strategia personalizzata per ridurli, sospendere la riscossione e ottenere la tua libertà economica.
Introduzione
Quando i debiti diventano insostenibili, la legge italiana offre strumenti per ridurli legalmente, evitando sanzioni più gravi. Negli ultimi anni l’ordinamento ha rafforzato il principio del “secondo chance” (seconda opportunità) in favore del debitore onesto ma sfortunato. Già con la Legge 3/2012 (la cosiddetta “legge salva-suicidi”), lo Stato ha introdotto procedure per consentire a privati e piccoli imprenditori sommersi dai debiti di pagare solo quanto effettivamente possono, cancellando il restante e ripartendo da zero . Dal 15 luglio 2022, la disciplina è stata riformata e unificata nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019, che ha assorbito la Legge 3/2012 mantenendone l’impianto di fondo. Il CCII (aggiornato con correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) ha ampliato e reso più efficaci gli strumenti di risanamento dei debiti per debitori non fallibili, ispirandosi a un principio di favor debitoris (tutela del debitore meritevole). In parallelo, continuano a esistere soluzioni extragiudiziali, come accordi a saldo e stralcio con i creditori, piani di rientro o le definizioni agevolate dei debiti fiscali, che spesso permettono cospicue riduzioni senza ricorrere al tribunale.
Questa guida – di livello avanzato e aggiornata a ottobre 2025 – esamina tutte le opzioni a disposizione di privati cittadini e imprenditori italiani per ridurre i propri debiti, dal punto di vista del debitore. Verranno analizzate le procedure giudiziali di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione), le soluzioni extragiudiziali (trattative, saldo e stralcio, piani di rateizzazione), nonché strumenti specifici per debiti fiscali, bancari e commerciali. Il taglio è pratico ma rigoroso: si forniranno riferimenti normativi attuali, si citeranno le sentenze più recenti della giurisprudenza (Corte di Cassazione 2020–2025) e si proporranno tabelle riepilogative, esempi numerici e una sezione di Domande & Risposte frequenti. L’obiettivo è mostrare come un avvocato esperto in diritto della crisi può aiutare concretamente a ridurre i debiti – legalmente e in via definitiva – permettendo al debitore di ritrovare stabilità finanziaria e dignità.
Crisi da debiti e sovraindebitamento: quadro generale
Prima di entrare nei singoli strumenti, è importante definire il perimetro normativo e i concetti chiave. In Italia il termine sovraindebitamento indica lo stato del debitore (cittadino, famiglia o piccolo imprenditore) che non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti – a causa di uno squilibrio finanziario permanente tra entrate e uscite. In pratica, rientra nel sovraindebitamento sia la situazione di crisi reversibile (difficoltà temporanea superabile) sia una vera e propria insolvenza (incapacità strutturale di adempiere). Fino al 2012, i debitori “civili” in queste condizioni non avevano strumenti giuridici efficaci per uscire dalla spirale debitoria (a differenza delle grandi imprese che potevano ricorrere al fallimento e concordato). La Legge n. 3/2012 ha colmato questo vuoto, introducendo tre procedure concorsuali “minori” riservate ai soggetti non fallibili (consumatori e imprese minori) per comporre la crisi da sovraindebitamento. Tali procedure mirano a ricalibrare il debito sulle effettive possibilità del debitore e a cancellare il debito residuo non pagabile (esdebitazione), pur garantendo un ritorno proporzionato ai creditori.
Dal 2022, come anticipato, la Legge 3/2012 è stata assorbita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, Titolo IV capo II). Il CCII dedica gli artt. 65–83 alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, mantenendo i tre schemi originari (piano del consumatore, accordo e liquidazione) con modifiche migliorative, e introducendo un quarto istituto speciale (esdebitazione “a zero”). Il principio generale è di facilitare l’accesso a queste procedure per i debitori meritevoli, evitando formalismi eccessivi che ne frustrino la finalità di risanamento. Si vuole evitare, ad esempio, che un errore formale blocchi la procedura: la tendenza giurisprudenziale è interpretare i requisiti in modo da non punire il debitore per mera imprudenza, riservando l’esclusione solo a comportamenti davvero fraudolenti o gravemente colposi. In altre parole, il debitore che agisce in buona fede (senza frode o dolo) può aspirare alla cancellazione finale dei debiti, ossia ad una piena riabilitazione economica e sociale.
Un altro concetto cardine è la distinzione tra debitori fallibili e non fallibili. Le procedure di sovraindebitamento sono riservate ai debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”): in base all’art. 2, comma 1, lett. c) CCII, si tratta degli imprenditori sotto determinate soglie dimensionali (cosiddetti “sotto soglia”), degli imprenditori agricoli, delle start-up innovative, nonché di tutte le persone fisiche non imprenditori (i consumatori). In sostanza, chi non rientra nelle procedure concorsuali maggiori può accedere agli strumenti di sovraindebitamento. I parametri di fallibilità (ancora oggi indicativi) sono: attivo patrimoniale superiore a €300.000, ricavi lordi oltre €200.000 annui o debiti per oltre €500.000 (se un’impresa supera anche uno solo di questi limiti nei tre esercizi precedenti, è soggetta alle procedure concorsuali ordinarie). Chi resta sotto tali soglie è appunto “non fallibile” e può usufruire delle procedure di composizione della crisi. Rientrano in questa categoria, ad esempio: i privati consumatori, i lavoratori autonomi e professionisti, le piccole imprese (artigiani, commercianti di piccole dimensioni), gli imprenditori agricoli (sempre esclusi dal fallimento), le start-up innovative, le associazioni e ONLUS, e – novità del CCII – più membri della stessa famiglia indebitata, che oggi possono presentare una procedura unitaria familiare. (Nota: restano invece soggetti alle procedure ordinarie le società di capitali e le imprese sopra soglia, che potranno accedere al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale, di cui diremo brevemente più avanti).
In sintesi, il quadro normativo vigente offre un’ampia gamma di soluzioni concorsuali “su misura” per i debitori civili e minori. Nei paragrafi che seguono analizzeremo dapprima le soluzioni extragiudiziali (accordi bonari con i creditori, piani di rientro, ecc.), poi nel dettaglio le procedure giudiziali di sovraindebitamento e gli strumenti specifici per tipologia di debito (fiscale, bancario, ecc.). Ogni sezione includerà i riferimenti normativi salienti e, ove opportuno, le ultime pronunce dei tribunali e della Corte di Cassazione che hanno interpretato tali norme. L’obiettivo è comprendere come, con l’aiuto di un avvocato esperto, il debitore sovraindebitato possa sfruttare al meglio queste opportunità per ridurre il proprio debito a una misura sostenibile, evitando misure esecutive aggressive e tornando in bonis (in regola) nel medio termine.
Strumenti extragiudiziali per ridurre i debiti
Prima di ricorrere a un giudice, è spesso possibile – e consigliabile – tentare di negoziare direttamente con i creditori soluzioni di saldo parziale o di rientro graduale del debito. Le trattative stragiudiziali permettono infatti di risolvere la crisi debitoria più rapidamente e con minori costi per entrambe le parti, evitando le incertezze di una causa. In questa sede vedremo i principali strumenti extragiudiziali a disposizione di un debitore (e del suo avvocato) per ottenere riduzioni del debito: l’accordo a saldo e stralcio, il piano di rientro rateale, il consolidamento dei debiti, nonché alcune azioni difensive (come la contestazione di addebiti illegittimi) che possono condurre a significative decurtazioni del dovuto. Va premesso che il successo di queste soluzioni dipende molto dal singolo caso: il creditore accetterà di rinunciare a parte del credito solo se percepisce che l’alternativa (procedere per via giudiziaria) è incerta, lunga o infruttuosa. Un avvocato specializzato sarà in grado di evidenziare al creditore proprio questi aspetti, costruendo una proposta convincente e tutelante per il debitore.
Accordo transattivo a saldo e stralcio
Il saldo e stralcio è un accordo bonario tramite cui il creditore accetta di estinguere il debito a fronte del pagamento immediato di una somma inferiore a quella originariamente dovuta. In sostanza, il debitore offre un certo importo (saldo), e il creditore “stralcia” (cancella) il residuo del credito. Questa soluzione è frequente con banche, finanziarie o fornitori quando il debitore è in grave difficoltà economica e non riesce più a pagare le rate o le fatture. Dal lato del debitore, il saldo e stralcio consente di chiudere la posizione debitoria pagando meno; dal lato del creditore, consente di recuperare almeno una parte del credito subito, evitando i costi e i tempi lunghi del recupero forzoso. Si pensi che un’azione giudiziale (es. decreto ingiuntivo e pignoramento) può durare 4 anni in media e richiedere anticipo di spese legali e d’esecuzione da parte del creditore. Rinunciare a una quota del credito in cambio di un pagamento rapido può quindi risultare conveniente per entrambe le parti.
Come procedere: In pratica, l’iniziativa parte spesso dal debitore (o dal suo legale), che invia al creditore una proposta scritta di saldo e stralcio. Prima però è fondamentale analizzare attentamente la posizione debitoria e la situazione economico-patrimoniale del debitore. Le due variabili chiave che determinano la percentuale di stralcio ottenibile sono: (1) il grado di difficoltà economica del debitore e (2) il tempo trascorso dal default del debito. In generale, più il debitore è nullatenente o in condizioni precarie, e più il debito è “vecchio”, maggiore sarà lo sconto ottenibile (poiché il creditore teme di non recuperare nulla altrimenti). Viceversa, se il debitore ha redditi o beni aggredibili, il creditore sarà meno disposto a concessioni significative. Spesso le banche, di fronte a crediti inesigibili o molto deteriorati, preferiscono cederli a società di recupero per una frazione del valore; ciò significa che, in situazioni estreme (es. debitore disoccupato, senza proprietà, debito ultra-prescritto), si possono ottenere riduzioni anche del 70–80% o oltre. Tuttavia, sconti superiori al 90% sono rari e limitati a casi davvero disperati. Una comunicazione onesta al cliente deve fargli comprendere che in media il risparmio ottenibile con un saldo e stralcio varia indicativamente dal 20% all’80% del debito originario, a seconda dei casi. In altri termini, il debitore pagherà tra l’80% e il 20% del dovuto (nelle situazioni comuni si colloca spesso verso metà, ad es. saldo al 50% del debito).
Una volta valutata la situazione, il legale aiuterà a determinare l’offerta concreta da fare. La proposta va inviata preferibilmente via PEC o raccomandata, corredata da documentazione che provi la situazione di difficoltà (es. ISEE basso, stato di disoccupazione, ulteriori debiti verso altri creditori, pignoramenti in corso, ecc.). Ciò serve a convincere il creditore che il debitore non può oggettivamente pagare di più. Occorre anche dimostrare la “concretezza” dell’offerta: ad esempio, se si propone il pagamento di €10.000 a saldo di un debito da €30.000, bisogna far capire che quella somma è immediatamente disponibile (magari perché un familiare la presta al debitore) e che solo accettando l’accordo il creditore potrà incassarla.
Esempio pratico: il signor Tizio aveva ottenuto un finanziamento di €15.000, poi ha perso il lavoro e non ha pagato più le rate. Negli anni, con interessi di mora e spese legali, il debito è lievitato a €18.000. Tizio non possiede immobili (tranne la prima casa gravata da mutuo) e non ha redditi, se non un piccolo sussidio. Dopo lunghe sollecitazioni, la banca cede il credito a una società di recupero. A questo punto Tizio, aiutato da un amico disposto a prestargli liquidità, offre €6.000 in un’unica soluzione per chiudere la pratica. Il creditore, valutati i pochi margini di recupero (considerando che la casa è già ipotecata dalla banca del mutuo e Tizio è disoccupato), accetta. Viene quindi formalizzato un accordo transattivo in cui il creditore dichiara di ricevere €6.000 “a saldo e stralcio” del debito, rinunciando irrevocabilmente a ogni ulteriore pretesa. Tizio esegue il pagamento convenuto e così ottiene la liberatoria: il debito residuo (€12.000) è cancellato definitivamente, la posizione viene chiusa e Tizio sarà anche cancellato dalla lista dei “cattivi pagatori” (CRIF) entro poco tempo.
Tutele importanti nell’accordo: è essenziale che l’accordo scritto di saldo e stralcio contenga la rinuncia espressa del creditore alla parte di credito non pagata e l’impegno a non intraprendere ulteriori azioni. L’accordo transattivo non ha automaticamente efficacia novativa (cioè non sostituisce l’obbligazione originaria se non viene eseguito), quindi bisogna prevedere che, una volta ricevuto il pagamento concordato, il creditore non possa più pretendere nulla per il futuro. Di norma, il creditore rilascerà una quietanza liberatoria che attesta il saldo definitivo della posizione. Attenzione: se il debitore non rispetta i termini dell’accordo (es. non paga la somma pattuita nei tempi previsti), il creditore potrà revocare i benefici e pretendere nuovamente l’intero credito originario. Per questo è importante proporre un saldo e stralcio solo quando si è certi di poter poi adempiere puntualmente all’importo promesso.
Ruolo dell’avvocato: sebbene un debitore possa teoricamente negoziare da solo, farsi assistere da un avvocato o consulente esperto massimizza le chance di successo. Un professionista saprà individuare il momento opportuno per avanzare la proposta (ad esempio dopo che il credito è stato svalutato o ceduto, o in prossimità di bilancio del creditore), eviterà errori formali e condurrà la trattativa in modo fermo ma costruttivo. Inoltre, il legale potrà verificare la legittimità del credito e usare eventuali contestazioni come leva negoziale (si veda oltre). Infine, curerà che l’accordo sia redatto correttamente, includendo clausole di tutela per il debitore, e che vengano poi eseguite le formalità conseguenti (es. cancellazione di ipoteche o pignoramenti pendenti, cancellazione dalle centrali rischi, ecc.).
Piani di rientro e dilazioni di pagamento
Una soluzione meno drastica, alternativa allo stralcio parziale, è il piano di rientro rateale del debito. In questo caso il debitore riconosce integralmente l’importo dovuto ma ottiene dal creditore una dilazione nel pagamento, magari con sospensione temporanea delle azioni esecutive. Si tratta dunque di rinegoziare le scadenze: il debito viene spalmato su un periodo più lungo, con rate sostenibili per il debitore. Spesso i piani di rientro prevedono anche la riduzione degli interessi futuri o la rinuncia a parte delle sanzioni. Ad esempio, un’azienda in difficoltà che deve €50.000 a un fornitore potrebbe accordarsi per pagare €5.000 al mese per 10 mesi, magari rinunciando agli interessi di mora maturati. Oppure un privato con rate arretrate di mutuo può concordare con la banca una rimodulazione del piano di ammortamento, aggiungendo le rate scadute in coda al piano o allungando la durata del prestito (questo è di fatto un nuovo piano di rientro in bonis).
Spesso gli stessi contratti finanziari prevedono clausole di “piano di rientro” in caso di difficoltà, oppure le banche adottano prassi di tolleranza prima di attivare il recupero coatto: ad esempio, possono proporre al cliente moroso di ricapitalizzare gli arretrati e riprendere i pagamenti regolari, magari dopo un periodo di sospensione. Dal 2016 al 2018, molte banche italiane hanno aderito alle moratorie ABI per concedere sospensioni o allungamenti di mutui ai clienti in temporanea difficoltà (e.g. sospensione delle rate per 12 mesi). Un avvocato può aiutare a trattare con la banca condizioni più eque, ad esempio negoziando che durante la moratoria non maturino interessi di mora.
Per i debiti con il Fisco o enti pubblici, esistono specifiche normative sulla dilazione: la rateizzazione amministrativa delle cartelle esattoriali. Oggi un contribuente può ottenere fino a 72 rate mensili (6 anni) di dilazione per debiti fino a €120.000 semplicemente presentando domanda all’Agente della Riscossione (rateazione “ordinaria” senza necessità di prove). Per importi superiori, o in caso di comprovata difficoltà, si possono ottenere piani “straordinari” fino a 120 rate (10 anni) previa dimostrazione dello stato di grave e protratta difficoltà economica. Recenti modifiche normative (D.L. 51/2023 e L. 197/2022) hanno elevato da 60.000 a 120.000 euro la soglia per la rateazione automatica senza documentazione, e introdotto maggiore flessibilità nei piani di pagamento a partire dal 2025 (per importi entro 120mila euro sarà possibile richiedere fino a 84 rate anche senza requisiti, poi decrescenti negli anni successivi). In ogni caso, quando si ottiene un piano di dilazione con l’Erario, occorre rispettarne le scadenze: il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, fa decadere la dilazione e riattiva la riscossione coattiva. Un avvocato può assistere nel presentare correttamente l’istanza di rateazione e nel valutare se vi siano margini per richiedere ulteriori proroghe o soluzioni agevolate (si veda oltre la sezione sui debiti fiscali).
Vantaggio e limiti dei piani di rientro: Il vantaggio principale è evitare azioni legali e proteggere eventualmente il proprio patrimonio (spesso, finché il debitore rispetta il piano concordato, il creditore si astiene da pignoramenti). Tuttavia, il piano di rientro non riduce l’ammontare del debito – se non per eventuali interessi futuri o piccole decurtazioni concordate. Inoltre, a differenza del saldo e stralcio, se il debitore fallisce nel rispettare il piano, si torna al punto di partenza con l’aggravante che potrebbe aver riconosciuto formalmente il debito (spesso il piano di rientro viene formalizzato in una ricognizione di debito o addirittura in un titolo esecutivo come una cambiale o un accordo autenticato). È quindi fondamentale pattuire piani realmente sostenibili e magari prevedere che in caso di ritardo il creditore invii un sollecito prima di risolvere l’accordo. Un avvocato farà attenzione a queste clausole, evitando che il debitore firmi impegni troppo gravosi.
Consolidamento debiti e rinegoziazione del credito
Un discorso a parte merita il consolidamento: se il debitore ha più prestiti o debiti sparsi, può valutare di unificarli accendendo un nuovo finanziamento che li estingua, così da avere una sola rata mensile inferiore alla somma delle precedenti. Questa non è tanto una riduzione del debito (il capitale da rimborsare resta la somma dei debiti originari, anzi con ulteriori interessi), quanto una ristrutturazione finanziaria per alleggerire la rata. Può essere utile se il debitore ha ancora sufficiente merito creditizio per ottenere un prestito di consolidamento a tasso conveniente. Tuttavia, chi è già fortemente indebitato spesso non riesce ad accedere a nuovo credito se non fornendo garanzie reali o fideiussioni (con il rischio di coinvolgere terzi). Il consolidamento quindi è una strada percorribile in situazioni di sovraindebitamento lieve o iniziale, magari tramite la surroga o rinegoziazione di un mutuo ipotecario per ottenere liquidità aggiuntiva da destinare a chiudere altri debiti.
Diverso dal consolidamento è il caso della rinegoziazione di un singolo rapporto di credito. Un esempio tipico: il cliente ha un mutuo o un prestito con tasso elevato o con durata breve che non riesce più a sostenere; può rivolgersi alla banca (magari tramite il suo legale) per chiedere una modifica delle condizioni – ad esempio, un allungamento della durata, la riduzione del tasso applicato o una temporanea sospensione delle rate. A volte gli istituti, soprattutto se il cliente è in difficoltà conclamata (p. es. ha già saltato diverse rate), sono disponibili a rinegoziare per evitare di dover classificare il credito a sofferenza o subire perdite maggiori. La Banca d’Italia incoraggia politiche di forbearance (remissione temporanea) quando il debitore affronta eventi eccezionali (per es. durante la pandemia COVID furono imposte moratorie generalizzate). Pertanto, interloquire proattivamente con la banca – meglio se tramite un avvocato che sappia muoversi con gli uffici legali dell’istituto – può portare a soluzioni come: riduzione del tasso al minimo (talora al tasso legale), trasformazione di uno scoperto esigibile a vista in finanziamento rateale, rinuncia ad interessi di mora e spese legali se il debitore riprende a pagare regolarmente, ecc. Queste misure equivalgono a una riduzione indiretta del debito, quantomeno degli oneri accessori.
Contestazione del debito: verifica di interessi usurari, anatocismo o vizi contrattuali
Un potente strumento nelle mani dell’avvocato per “ridurre” il debito è la contestazione giudiziale della sua validità o del suo ammontare. In molti rapporti bancari e finanziari si annidano irregolarità legali che possono portare a dichiarare nulli taluni addebiti – con effetto di ridurre il dovuto o addirittura, in casi estremi, annullare l’intero debito. Alcune aree tipiche di contenzioso sono:
- Usura bancaria: La legge n. 108/1996 prevede che se gli interessi pattuiti superano il tasso soglia d’usura vigente, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (solo la restituzione del capitale). Se il debitore sospetta che il TAN o il TAEG applicato a un prestito ecceda i limiti (sommando anche commissioni e spese), può far fare una perizia tecnica. Cassazioni successive (sent. n. 350/2013 e SS.UU. n. 24675/2017) hanno chiarito alcuni criteri di calcolo, ad es. escludendo l’usura sopravvenuta – ma se l’usura è originaria, il vantaggio per il debitore è enorme perché la banca perde il diritto agli interessi pattuiti. In sede di causa, il giudice potrebbe ridurre il debito dichiarando compensati gli interessi già pagati in eccedenza e non facendo maturare interessi ulteriori oltre il tasso soglia.
- Anatocismo: La capitalizzazione degli interessi (far produrre interessi agli interessi scaduti) è stata a lungo praticata trimestralmente dalle banche sui conti correnti, ma la giurisprudenza l’ha dichiarata illegittima per gli anni antecedenti il 2000. Ancora oggi, se si dimostra che in un rapporto di conto o mutuo vi è anatocismo non consentito, si possono stornare gli interessi composti indebiti, rideterminando il saldo. Ad esempio, un’apertura di credito con tassi capitalizzati trimestralmente tra 1990 e 1999 può generare un ricalcolo a vantaggio del correntista anche di decine di migliaia di euro, trasformando il saldo da negativo a positivo. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 24418/2010) e la successiva n. 9127/2015 hanno fissato i principi in materia, e la legge di stabilità 2014 ha vietato per il futuro l’anatocismo annuale (salvo esplicito accordo), sancendo di fatto che nessun interesse ulteriore è dovuto se la banca non rispettava tali condizioni.
- Commissioni e addebiti non trasparenti: Un’altra area di verifica sono le penali occulte o le clausole nulle. Ad esempio, nei contratti di leasing o di finanziamento al consumo talora venivano caricati costi assicurativi o commissionali non inclusi nel calcolo del TAEG comunicato: se ciò avveniva in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, il giudice può sanzionare la finanziaria applicando in sostituzione il tasso minimo BOT (come previsto dall’art. 125-bis TUB e norme affini), con notevole riduzione degli interessi dovuti dal consumatore. Ancora, le fideiussioni bancarie omnibus redatte secondo lo schema ABI 2003 sono state dichiarate nulle (parzialmente) per violazione della normativa antitrust: in virtù di ciò molti garanti possono essere liberati dall’obbligo di pagamento verso la banca. Ad esempio, se un debitore è anche fideiussore della propria società e la banca escute la garanzia, egli può eccepire la nullità della fideiussione se conforme allo schema ABI sanzionato da Banca d’Italia nel 2005 – e la Cassazione (SS.UU. n. 41994/2021) ha di recente confermato che tali fideiussioni sono parzialmente nulle, con esonero del garante per le clausole contestate.
In sintesi, un avvocato esperto passerà al setaccio i contratti di mutuo, i conti correnti affidati, i prestiti e ogni documento relativo al debito per individuare eventuali addebiti illegittimi o diritti del creditore insussistenti. La semplice prospettazione di una causa di questo tipo può mettere il creditore in condizione di accettare un accordo transattivo vantaggioso per il debitore (in luogo di rischiare in giudizio). Ovviamente, queste strategie vanno utilizzate in buona fede e se vi è effettivo fondamento tecnico, ma rappresentano un ulteriore modo in cui l’avvocato “riduce i debiti”: non per benevola concessione del creditore, ma facendo valere i diritti del debitore e togliendo dal conto ciò che per legge non è dovuto.
Altre soluzioni extragiudiziali e strumenti preventivi
Oltre a saldo e stralcio e dilazioni, meritano un breve cenno due strumenti introdotti di recente per gestire la crisi d’impresa prima che divenga insolvenza conclamata:
- Composizione negoziata della crisi: Introdotta nel 2021, è una procedura volontaria e confidenziale rivolta agli imprenditori (anche fallibili) in situazione di squilibrio, che consente di nominare un esperto indipendente per agevolare le trattative con i creditori (art. 12 D.L. 118/2021, ora confluito nel CCII). La composizione negoziata non impone riduzioni coattive ai creditori, ma offre al debitore alcuni vantaggi temporanei (es. può chiedere misure protettive al tribunale per sospendere azioni esecutive durante le trattative). Se le trattative riescono, si formalizza un accordo stragiudiziale con i creditori (che può poi essere omologato in tribunale su istanza del debitore, acquistando efficacia esecutiva erga omnes). Se falliscono, l’imprenditore può ripiegare su un concordato semplificato. Questo strumento esula dal campo del sovraindebitamento del privato, ma lo citiamo perché è una ulteriore opzione extragiudiziale per imprenditori in difficoltà, finalizzata a evitare un default ricorrendo all’assistenza di un esperto negoziatore. Ad esempio, un’azienda con più banche finanziatrici può, in composizione negoziata, proporre un accordo di ristrutturazione del debito (riduzione tassi, allungamento scadenze e magari una haircut parziale se i creditori concordano) con la regia dell’esperto e la supervisione del tribunale solo per le misure protettive. In tal caso, se tutti accettano, si ottiene una transazione globale senza attivare alcuna procedura concorsuale formale.
- Accordi volontari tra privati garanti: un accenno infine alla possibilità, per un debitore sovraindebitato che non intenda ricorrere al tribunale, di tentare un accordo “multilaterale” con tutti i propri creditori, sul modello di un piccolo concordato extragiudiziale. In mancanza di una legge che vincoli le minoranze dissenzienti (salvo omologare l’accordo ex art. 182-novies LF, oggi 23 CCII, riservato però a imprenditori maggiori), si tratta di puri accordi contrattuali che richiedono l’adesione di tutti i creditori per funzionare. Non di rado, famiglie indebitate con più finanziarie si sono rivolte a organizzazioni di consulenza debiti (tipo OCC privati) che trattano con ogni creditore separatamente per ottenere un piano equilibrato: es. ognuno accetta di ridurre il proprio credito del 30% e di ricevere il restante 70% in 5 anni. Se c’è collaborazione da parte dei creditori, questa soluzione è la meno onerosa e più rapida; tuttavia basta un creditore dissenziente per farla naufragare, poiché non esiste un meccanismo di forzatura della minoranza come invece accade nelle procedure giudiziali. Per questo, spesso il debitore serio, dopo alcuni tentativi infruttuosi sul piano bonario, decide di attivare le procedure di sovraindebitamento, che offrono strumenti giuridici per superare l’eventuale opposizione di creditori irriducibili (vedremo ad esempio il caso del cram-down sui creditori pubblici).
Nei prossimi capitoli passeremo dunque in rassegna le procedure concorsuali previste dal Codice della crisi per i debitori civili e minori. È lì che l’intervento di un avvocato specializzato diventa indispensabile: dalla predisposizione del piano da presentare in tribunale, alla collaborazione con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), fino alla difesa del debitore nelle eventuali opposizioni dei creditori e alla fase finale di esdebitazione. Tenete presente che molte volte si può (e conviene) combinare strumenti extragiudiziali e giudiziali: ad esempio, mentre si attende l’omologa di un piano del consumatore, si può comunque continuare a trattare un saldo e stralcio con un creditore per migliorare la proposta. Un buon avvocato valuterà tutte le opzioni e guiderà il debitore lungo il percorso più adatto al suo caso.
Procedure giudiziali di sovraindebitamento (ex Legge 3/2012 e CCII)
Passiamo ora alle procedure legali vere e proprie con cui un debitore sovraindebitato può ottenere una riduzione dei debiti e la loro cancellazione finale grazie all’intervento del tribunale. Come accennato, il Codice della Crisi prevede tre procedure fondamentali: (1) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il nuovo nome del “piano del consumatore”), (2) il concordato minore (ex accordo di composizione) per debitori non consumatori, e (3) la liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio). A queste si aggiunge una quarta procedura speciale: (4) l’esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione dei debiti senza alcun pagamento, in casi estremi). Esaminiamo ciascuna di esse nei dettagli di funzionamento, requisiti e ultime novità giurisprudenziali. Ricordiamo che tali procedure sono riservate ai soggetti non fallibili (come definito sopra) e che richiedono l’intervento di un OCC e la supervisione del Tribunale competente (sezione specializzata in materia di crisi da sovraindebitamento, di regola presso il tribunale del luogo di residenza del debitore).
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore)
Cos’è: È la procedura riservata alla persona fisica consumatore, ossia non fallibile e con debiti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Consiste nella presentazione al tribunale di un piano di pagamento dei debiti, formulato dal consumatore stesso (coadiuvato dall’OCC e dal legale), che prevede il soddisfacimento parziale o dilazionato dei creditori in misura sostenibile per il debitore. Non è necessario il consenso dei creditori: se il tribunale valuta il piano fattibile e “meritevole”, può omologarlo (approvarlo) e renderlo vincolante per tutti i creditori chirografari anche senza la loro adesione. In pratica, il debitore consumatore propone di pagare ai suoi creditori ciò che realisticamente può (ad esempio il 20% del totale, o certe somme mensili per 5 anni), e se tale proposta è ben documentata e rispettosa dei requisiti di legge, il giudice la omologa nonostante l’eventuale dissenso di uno o più creditori. Si tratta dunque di una procedura concorsuale negoziale-giudiziale: “negoziale” perché il debitore costruisce una proposta contrattuale, “giudiziale” perché è il tribunale a imporla ai creditori con il decreto di omologazione.
Requisiti chiave: I requisiti principali per accedere al piano del consumatore sono: (a) essere consumatore sovraindebitato, cioè persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi personali o familiari (cure, acquisto casa, spese di vita) e non connessi a un’attività d’impresa o professionale; (b) essere meritevole, cioè non aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, né aver frodato i creditori; (c) non aver già usufruito di procedure di sovraindebitamento con esdebitazione negli ultimi anni (in base al CCII, chi è già stato esdebitato non può accedere di nuovo, e tra una procedura e l’altra devono trascorrere almeno 4 anni); (d) avere una situazione finanziaria tale da poter offrire ai creditori qualcosa in più rispetto alla liquidazione del patrimonio (principio del “miglior soddisfacimento” rispetto all’alternativa liquidatoria). Quest’ultimo punto è importante soprattutto verso i creditori pubblici: il CCII consente di includere nel piano i debiti tributari e previdenziali anche con falcidie e dilazioni, ma a condizione che all’Erario non venga offerto meno di quanto otterrebbe da una liquidazione. In particolare, per IVA e ritenute non versate permane l’obbligo di integrale pagamento salvo che si dimostri che nemmeno vendendo tutti i beni si riuscirebbe a soddisfarle per intero. In pratica, l’OCC deve attestare che la proposta al Fisco è congrua (se, ad esempio, il piano offre al Fisco il 10% del debito, occorre dimostrare che in caso di liquidazione il Fisco prenderebbe anche meno del 10%). La Cassazione ha confermato questo principio: è ammissibile stralciare imposte nel piano del consumatore solo se c’è la garanzia che la quota offerta non sia inferiore al ricavabile liquidatorio. Su questo tema, una pronuncia recente Cass. civ. sez. I n. 576/2024 ha ribadito che dilazioni molto lunghe ai creditori privilegiati (come il Fisco) sono ammissibili purché trasparenti, e che la convenienza del piano rispetto alle alternative deve essere valutata dal giudice, non dai creditori (esattamente perché nel piano del consumatore i creditori non votano).
Procedura: Il consumatore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) abilitato (spesso istituito presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio), il quale nominerà un gestore della crisi. Con l’aiuto del gestore e dell’avvocato, il debitore predispone: l’elenco di tutti i debiti, l’elenco dei beni e delle spese di sostentamento, le eventuali cause di insolvenza, e soprattutto il Piano di ristrutturazione dei debiti, contenente la proposta dettagliata di pagamento. Il piano può prevedere qualsiasi forma tecnica: pagamento rateale parziale, falcidia (taglio) di alcune categorie di crediti, garanzie di terzi, mantenimento o meno dei beni di proprietà, ecc. – purché sia realistico e garantisca che il debitore potrà eseguirlo fino in fondo. Spesso il piano del consumatore può includere la continuità su alcuni contratti: ad esempio, se c’è un mutuo sulla prima casa, il piano può prevedere di mantenerlo pagandone le rate come da contratto (magari posticipando di un anno le scadenze arretrate grazie alla sospensione ottenibile). È anche possibile liberarsi di alcune situazioni: per es., molte persone intrappolate in cessioni del quinto dello stipendio hanno utilizzato il piano del consumatore per sospendere immediatamente le trattenute in busta paga e inserire il debito residuo verso la finanziaria nel piano come credito chirografario da soddisfare parzialmente. Una volta pronto, il ricorso viene depositato in tribunale: da quel momento il debitore può chiedere le misure protettive per sospendere eventuali pignoramenti in corso (nel CCII le misure protettive non sono automatiche, vanno richieste e il giudice le concede entro 10 giorni se necessario). Se concesse, tali misure bloccano nuove azioni esecutive e sospendono quelle già iniziate, nonché fermano il corso degli interessi per i chirografari. Il gestore OCC intanto avvisa i creditori dell’avvio della procedura .
Il giudice fissa quindi un’udienza per valutare l’omologazione del piano, ordinando la notifica ai creditori. Nel frattempo verifica d’ufficio l’ammissibilità formale (ad es. che il ricorrente abbia qualifica di consumatore, che abbia depositato tutti i documenti obbligatori, che non ricorra una causa di inammissibilità come atti in frode ai creditori) . All’udienza, i creditori possono comparire e fare opposizione solo per specifici motivi (es. contestare la meritevolezza o la convenienza comparativa del piano) – ma non c’è votazione. Infatti, come detto, la legge non richiede l’approvazione dei creditori per il piano del consumatore. Un creditore insoddisfatto non può impedire l’omologa lamentando che “riceverà poco”: la Cassazione ha chiarito che la convenienza in sé non è criterio di valutazione se non nel confronto con l’alternativa liquidatoria. In altre parole, il giudice omologa il piano se ritiene: che il debitore sia meritevole; che il piano sia fattibile; e che i creditori in generale ottengano col piano almeno quanto otterrebbero da una liquidazione (c.d. best interest test). Se queste condizioni ci sono, le eventuali opposizioni dei creditori vengono respinte e il piano viene omologato con decreto motivato.
Effetti dell’omologazione: Dal momento in cui il decreto di omologa diventa definitivo, il piano produce effetti obbligatori per tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti). I creditori dovranno quindi accontentarsi di quanto previsto dal piano e potranno agire esecutivamente solo per ottenere quelle somme (se il debitore non le pagasse secondo il calendario stabilito). Qualsiasi pendenza esecutiva viene definitivamente caducata. Se c’erano coobbligati o fideiussori estranei al piano, la loro posizione non è automaticamente liberata: ad esempio, se una persona aveva un garante, il creditore potrà rivalersi sul garante per la parte di debito che il piano non paga, a meno che anche il garante non abbia presentato a sua volta un proprio piano o sia parte di una procedura familiare. (Nota: nel caso di procedure familiari, introdotte dal CCII art. 66, coniuge o altri familiari conviventi possono presentare un piano comune se i debiti hanno origine comune, rendendo così l’accordo vincolante per tutti e “coprendo” anche le garanzie intrafamiliari.)
Da questo momento in poi si apre la fase di esecuzione del piano: il debitore dovrà rispettare gli impegni (versare le somme previste, eventualmente liquidare alcuni beni se il piano lo contempla). L’OCC sovrintende alla distribuzione di quanto pagato ai vari creditori secondo le percentuali previste. Importante: durante l’esecuzione, il debitore deve mantenere un comportamento retto; se dovesse ad esempio nascondere un sopravvenuto aumento di reddito o non versare ciò che potrebbe, il creditore o l’OCC possono chiederne la risoluzione e il piano verrebbe annullato con perdita delle protezioni. Invece, se tutto procede regolarmente, una volta completati i pagamenti previsti il debitore otterrà la esdebitazione: la cancellazione giuridica di tutti i debiti rimasti insoddisfatti. Nel CCII l’esdebitazione è incorporata nella procedura stessa: il giudice la dichiara con decreto senza necessità di apposita istanza (a differenza della vecchia legge). Così, il consumatore torna libero dai debiti residui e può riprendere la sua vita economica in equilibrio.
Caso esemplificativo: Caio è un privato che ha accumulato €100.000 di debiti (prestiti personali, carte di credito, bollette arretrate, qualche cartella esattoriale per tasse comunali). Ha un lavoro con stipendio netto €1.500/mese e vive in casa in affitto con famiglia a carico, quindi il suo surplus disponibile mensile è esiguo. Presenta un piano del consumatore offrendo di pagare €400 al mese per 5 anni a beneficio dei creditori chirografari, il che si traduce in circa €24.000 complessivi (pari grosso modo al 24% del debito totale). Dimostra che, se andasse in liquidazione, i creditori non otterrebbero nulla di più (non ha beni da vendere, e uno stipendio modesto su cui già grava il minimo vitale). Il giudice verifica che Caio non ha colpe gravi (si è indebitato per aiutare un familiare malato e per sopravvivere a un periodo di disoccupazione, circostanze sfortunate) e che il piano è sostenibile con il suo stipendio. Omologa dunque il piano. Caio inizia a versare i €400 mensili all’OCC, il quale ogni anno distribuisce ai creditori pro quota. Alcuni creditori avrebbero voluto più soldi, ma non possono opporsi efficacemente perché Caio è meritevole e non possiedono prove contrarie. Dopo 5 anni Caio ha versato i €24.000 promessi; il tribunale emette il decreto di esdebitazione che lo libera dai circa €76.000 non pagati. Tali crediti vengono definitivamente cancellati e Caio potrà ripartire senza quelle zavorre (fermo restando che per qualche tempo avrà un record nei sistemi di informazioni creditizie come persona che ha usato una procedura di sovraindebitamento).
Giurisprudenza recente sul piano del consumatore: La materia è stata oggetto di numerose pronunce, specialmente riguardo ai confini di chi è “consumatore” e alla meritevolezza. La Cassazione, Sez. I, 15 settembre 2023 n. 22699 (in sede di procedimento ex art. 363-bis c.p.c.) ha confermato un orientamento restrittivo: in presenza di una debitoria mista, parte personale e parte d’impresa, non si può usare il piano del consumatore . Bisogna guardare alla natura delle obbligazioni: se il soggetto ha debiti originati in larga parte da un’attività imprenditoriale ormai cessata, non può qualificarsi consumatore per includerli nel piano, dovendo eventualmente ricorrere al concordato minore . In altre parole, la qualifica soggettiva dipende dal titolo dei debiti contratti: lo aveva già detto Cass. 1869/2016 e la Cassazione 22699/2023 ha ribadito che quel criterio resta pienamente valido col nuovo Codice . Ad esempio – chiarisce Cass. 742/2020 – un fideiussore persona fisica può essere considerato consumatore se la fideiussione era prestata per fini estranei ad attività d’impresa propria (es. amico garante di mutuo altrui), mentre non lo è se garantiva la propria società. Sul requisito di meritevolezza, la Cassazione a Sezioni Unite n. 3819/2020 (e già SS.UU. 19427/2019) ha sottolineato che non va confuso con la semplice imprudenza: solo chi ha agito con dolo o colpa grave dev’essere escluso. Piccoli errori finanziari o sfortune non tolgono l’accesso, in linea col favor debitoris. Quanto alla fattibilità del piano, Cass. 576/2024 (citata) ha ammesso piani con pagamento dilazionato anche oltre i due anni di moratoria ai privilegiati purché si inizi entro quel termine – recependo il “Correttivo 2024” che consente appunto di iniziare a pagare mutui e Fisco entro 24 mesi dall’omologa, anche se il completamento andrà oltre. Infine, la Cass. 24870/2024 ha chiarito le impugnazioni: se il giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso, il debitore può proporre reclamo al collegio (Tribunale in composizione collegiale); se invece nega l’omologa dopo l’udienza, si tratta di un diniego di omologa che va appellato alla Corte d’Appello. Questa pronuncia riempie un vuoto normativo del CCII (confermando la tesi che i provvedimenti finali negativi sul piano sono reclamabili/appellabili a seconda della fase).
Concordato minore (Accordo di ristrutturazione per debitori non consumatori)
Cos’è: Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore – tipicamente piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, enti non profit, oppure persone fisiche che però hanno debiti di natura mista (parte personale e parte d’impresa). In sostanza, chi non rientra nella definizione di “consumatore” può comunque accedere al concordato minore. Questa procedura corrisponde all’ex “accordo di composizione della crisi” della L.3/2012, ma presenta caratteristiche in parte diverse: in primo luogo, richiede il voto dei creditori. Infatti, il debitore elabora – con l’ausilio dell’OCC – una proposta di concordato (un piano) suddividendo eventualmente i creditori in classi, e questa proposta viene sottoposta a votazione da parte dei creditori stessi. Per l’approvazione è necessaria una maggioranza qualificata (almeno il 60% dei crediti ammessi al voto, secondo la vecchia legge, mentre il CCII ha abbassato la soglia al 50% + 1 dei crediti votanti). Se la maggioranza approva e il tribunale omologa, il concordato minore diviene vincolante anche per i creditori dissenzienti; se i creditori rifiutano la proposta, la procedura può convertire in liquidazione controllata.
Struttura del piano: La proposta di concordato minore è più flessibile rispetto al piano del consumatore, in quanto può rivolgersi a creditori di vario genere (anche commerciali) e può prevedere soluzioni diversificate per classi di creditori. Ad esempio, un piccolo imprenditore agricolo potrebbe proporre di pagare integralmente i fornitori strategici (classe A) per continuare l’attività, pagare al 30% i restanti chirografari (classe B) e rinegoziare i debiti bancari ipotecari prolungando i piani di ammortamento (classe C). Il fine del concordato minore è la ristrutturazione complessiva dei debiti dell’impresa o dell’imprenditore, consentendo anche la continuità aziendale ove possibile. A differenza del concordato preventivo delle grandi imprese, il concordato minore è semplificato e calibrato su realtà di dimensioni ridotte e su persone fisiche imprenditori. Può prevedere anche l’apporto di risorse esterne (ad esempio, soci o familiari che apportano capitale per pagare i creditori in percentuale). Non è richiesta una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari imposta per legge (nel concordato preventivo ordinario vige il 20% minimo salvo liquidatorio), ma naturalmente la proposta dev’essere allettante abbastanza da ottenere il voto favorevole delle classi.
Procedura: Similmente al piano del consumatore, anche qui si parte con la nomina di un OCC e la predisposizione della proposta e del piano. Depositato il ricorso, il tribunale concede le eventuali misure protettive su richiesta (sospende pignoramenti etc.) e convoca i creditori per il voto. La votazione può avvenire in adunanza (incontro) o anche per via telematica/postale, secondo le indicazioni del giudice delegato. Serve, come detto, almeno la maggioranza (calcolata in base ai crediti). Attenzione: nel calcolo non si considerano i creditori che non esercitano il voto (quindi l’astensione nei fatti favorisce l’approvazione, perché conta solo il quorum dei votanti). Se più classi, occorre il voto favorevole di almeno una classe e l’assenza di discriminazioni ingiuste per le altre (principio di trattamento equo interclassi). Una volta ottenuta l’approvazione, il tribunale procede all’omologazione verificando legalità e meritevolezza. Nota: Nel concordato minore, a differenza del piano del consumatore, conta di più anche la valutazione di convenienza da parte dei creditori: se i creditori stessi hanno votato a favore, si presume che trovino la proposta conveniente rispetto alle alternative. Tuttavia, per i creditori cram-down (es. Erario dissenziente), il giudice deve verificare comunque il rispetto del loro trattamento minimo (come per il piano del consumatore, il Fisco non può essere trattato peggio del risultato liquidatorio). La Cassazione ha affermato che anche nel concordato minore il tribunale può omologare nonostante il voto contrario del Fisco se ritiene irragionevole il diniego e accertato il soddisfacimento minimo previsto dalla legge. Questo meccanismo, introdotto nel 2020, è una sorta di “cram down fiscale”: ad esempio, se il Fisco vota contro ma col concordato riceve comunque l’equivalente di quanto otterrebbe liquidando i beni del debitore, il giudice può omologare lo stesso (questo per evitare che un solo creditore pubblico blocchi tutto).
Esecuzione e esdebitazione: Dopo l’omologa, il liquidatore o lo stesso OCC (a seconda dei casi) sovrintende all’attuazione del piano concordatario: incassa eventuali somme promesse (es. se c’è da vendere un bene e distribuire il ricavato secondo il piano) e paga i creditori nelle misure concordate. Il debitore mantiene normalmente la gestione della sua attività sotto vigilanza, salvo che il piano preveda diversamente. Se il concordato viene eseguito correttamente fino al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti residuali non soddisfatti. Anche nel concordato minore, come in quello preventivo, l’esdebitazione è l’obiettivo finale: liberare il debitore dalle passività pregresse eccedenti. Nel CCII, l’esdebitazione persona fisica è quasi automatica: l’art. 282 prevede che decorso 3 anni dall’apertura della liquidazione (o al termine del piano concordatario) il debitore abbia diritto alla liberazione dai debiti senza bisogno di attendere la chiusura formale . Questo significa che nel concordato minore, se c’è una componente liquidatoria che dura anni, dopo 3 anni il debitore può già ottenere un’esdebitazione parziale. (Nel caso del piano del consumatore sopra Caio, i 5 anni di esecuzione già glielo consentono a fine piano; nel concordato minore, se una piccola impresa paga i creditori in 6 anni, potrebbe chiedere esdebitazione dopo 3 anni per i residui, anche se il piano continua – norma introdotta per allinearsi alla direttiva UE 2019/1023).
Esempio: la ditta individuale Rossi (elettricista) ha debiti per €200.000: €50k debiti personali (familiari), €150k debiti d’impresa (fornitori, banca per fido, IVA arretrata). Non essendo consumatore puro, Rossi propone un concordato minore: offre di pagare i fornitori al 40% in 2 anni grazie all’incasso di crediti futuri di lavoro (continuando l’attività), di pagare la banca integralmente ma con proroga delle scadenze su 5 anni (così mantiene la fiducia creditizia), e di pagare l’IVA arretrata al 30% (che è pari a quanto l’erario prenderebbe se lui vendesse l’unico furgone e gli strumenti). Divide queste in classi e chiede ai creditori di votare. Fornitori e banca, valutando che forse in un fallimento prenderebbero meno, approvano. L’Agenzia delle Entrate invece dà voto contrario perché la falcidia IVA non le piace; tuttavia, il tribunale – verificato che l’erario non potrebbe comunque ottenere di più (la ditta non ha beni di valore) – omologa lo stesso sfruttando la possibilità di confermare il concordato nonostante il voto contrario del creditore pubblico (cram-down). Rossi esegue il piano: in 2 anni paga i fornitori (che ottengono in totale €20k su €50k), continua a lavorare, paga regolarmente la banca e versa il 30% di IVA come concordato. A fine piano, il tribunale lo esdebita: i fornitori non possono più chiedere il restante 60%, l’Erario rinuncia al 70% IVA residuo. Rossi ha salvato la sua attività e ridotto i debiti a quelli compatibili con la prosecuzione (ha comunque pagato la banca e parte del resto, ma la differenza è stata cancellata).
Novità giurisprudenziali: Sul concordato minore la giurisprudenza ha dovuto chiarire soprattutto chi può accedervi. Un dubbio risolto è stato: può proporlo un ex imprenditore cancellato dal Registro Imprese? La Cassazione, con sentenza n. 4329/2020, ha detto di no: un imprenditore che ha cessato l’attività e si è cancellato dal Registro non può più accedere a procedure concordatarie (neppure quelle minori), perché la cancellazione presuppone la rinuncia a risanare l’impresa . La stessa logica vale per il concordato minore: è destinato a chi è ancora attivo o almeno vuole sistemare i debiti d’impresa residui; se uno ha chiuso bottega, l’unica via è la liquidazione controllata con eventuale esdebitazione. Questo orientamento, già sviluppato per il concordato preventivo, si applica in continuità nel CCII . Dunque, ad esempio, un ex imprenditore commerciale cancellato da 2 anni, con soli debiti d’impresa, non può oggi proporre un concordato minore: dovrà ricorrere alla liquidazione controllata e poi chiedere l’esdebitazione. Per situazioni promiscue (in parte risalenti a attività cessata), la Cassazione 22699/2023 già citata ha confermato che quell’ex imprenditore non può però neppure usare il piano del consumatore , quindi di nuovo la via è la liquidazione. In sintesi, concordato minore sì per imprenditori attivi o appena cessati, no per cessati da tempo. Un altro punto: Cass. 18609/2021 ha confermato che i soci illimitatamente responsabili (di SNC o SAS) possono accedere al concordato minore per i debiti sociali se la società non è fallibile (o se fallita, dopo il fallimento). Il CCII su questo è stato esplicito includendo tra i soggetti non fallibili anche i soci illimitatamente responsabili delle società personali. Infine, merita citare che il Concordato minore liquidatorio (quando il piano prevede solo liquidazione di beni e non continuità) non può essere utilizzato per “aggirare” il fallimento se il debitore in realtà era fallibile: la Cass. 7895/2022 ha avallato il tribunale che aveva dichiarato improponibile un concordato minore presentato da un soggetto ritenuto fallibile e già oggetto di istanza di fallimento (in quel caso il concordato minore era stato usato strumentalmente per bloccare il fallimento). Il CCII ha espressamente escluso dal concordato minore chi risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale (fallimento) – ribadendo la netta separazione di competenza.
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Cos’è: È la procedura di tipo liquidatorio che corrisponde al vecchio istituto della “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012. In pratica, il patrimonio del debitore sovraindebitato viene sottoposto a liquidazione giudiziale: un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni disponibili e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le regole delle priorità (privilegi, garanzie reali, ecc.). Si tratta di un “mini-fallimento” semplificato: il debitore spossessato dei beni (anche se non in modo totale come nel fallimento, perché qui alcuni beni possono essere esclusi ex lege, ad es. stipendio in parte), i creditori presentano le domande di ammissione al passivo, ecc. La liquidazione controllata può essere chiesta dallo stesso debitore (come scelta volontaria quando ritiene di non poter sostenere un piano di rientro) oppure dai creditori o dal P.M. in casi tassativi (ad es. se il debitore ha fatto atti in frode, il piano è stato revocato, ecc.). Per il debitore sovraindebitato, pur essendo l’ultima risorsa, la liquidazione offre comunque il beneficio finale dell’esdebitazione: al termine (o dopo 3 anni dall’apertura) il debitore persona fisica viene liberato dai debiti residui non soddisfatti. Ogni debitore non fallibile può accedere alla liquidazione controllata – compresi i consumatori, i piccoli imprenditori, gli ex imprenditori cessati da anni, le start-up, le associazioni, ecc. È la procedura di default se non è praticabile un accordo di ristrutturazione o se le altre procedure falliscono.
Quando si sceglie: Spesso il debitore ci arriva in due scenari: (a) o perché nessun piano o concordato è fattibile (debito troppo alto, nessuna capacità di pagamento futuro – si opta per liquidare quel poco che c’è); (b) oppure perché il debitore preferisce cedere i beni per pagare parzialmente i creditori e chiudere la faccenda più rapidamente, usufruendo poi dell’esdebitazione di diritto. Ad esempio, se il debitore possiede una casa che comunque verrebbe pignorata dai creditori, può lui stesso attivare la liquidazione controllata: si venderà la casa in tribunale, i creditori saranno soddisfatti col ricavato (in tutto o in parte), ma al termine egli potrà ottenere la cancellazione di tutti i debiti residui (cosa che non accadrebbe se i creditori agissero individualmente – dopo l’asta per uno, gli altri potrebbero restare insoddisfatti e il debitore ancora perseguitabile per il rimanente). Dunque la liquidazione offre la certezza del fresh start al termine, in cambio del sacrificio integrale del patrimonio disponibile.
Procedura in breve: Il debitore presenta ricorso (o i creditori istanza) di liquidazione. Se viene aperta, da quel momento scatta uno stay su tutte le azioni individuali (i pignoramenti in corso confluiscono nella procedura concorsuale). Si nomina un liquidatore (spesso un professionista nominato dal tribunale). Il debitore ha l’obbligo di collaborare e di consegnare tutti i beni non impignorabili. Si forma lo stato passivo (i creditori presentano domanda e vengono ammessi dal giudice delegato se i loro crediti sono documentati). Il liquidatore vende i beni (all’asta o mediante trattativa autorizzata) e incamera somme. Quindi ripartisce secondo le cause di prelazione: prima si pagano le spese di giustizia, poi eventuali creditori privilegiati (ad es. ipoteca fino a concorrenza), poi eventuali chirografari in percentuale. Durante la procedura, il debitore può mantenere una parte dei redditi per il sostentamento (il necessario per una vita dignitosa), mentre l’eccedenza va conferita alla massa attiva. Il CCII ha introdotto la durata massima: la liquidazione non può durare più di 4 anni per quanto riguarda l’obbligo di versamento delle eccedenze di reddito. Trascorsi 4 anni, il debitore di buona fede ha diritto di non essere più tenuto a contribuire con i redditi futuri (questo per evitare liquidazioni senza fine). In pratica se dopo aver venduto i beni immediatamente disponibili rimane ancora parte del debito insoddisfatta – scenario quasi certo – il debitore persona fisica dopo 4 anni chiude i pagamenti e può avviarsi verso l’esdebitazione.
Esdebitazione post-liquidazione: Il CCII ha reso l’esdebitazione più semplice e automatica: decorso il triennio (o alla fine della procedura se prima) il liquidatore riferisce sulla condotta del debitore e, se non emergono motivi ostativi, il tribunale dichiara esdebitato il debitore persona fisica . Non serve un’apposita domanda, è parte integrante della procedura (art. 282 CCII). Ci sono eccezioni: l’esdebitazione può essere negata se il debitore ha tenuto comportamenti dolosi, violato obblighi di collaborazione, o commesso irregolarità gravi (ad esempio, aver distratto beni ai danni dei creditori). Ma il principio di fondo è di concedere il beneficio a chi ha messo a disposizione tutto il patrimonio e si è comportato correttamente, indipendentemente dalla percentuale effettivamente pagata ai creditori. Questa è una differenza col passato: prima l’esdebitazione del fallito era discrezionale e non sempre concessa, ora è un diritto del debitore meritevole. Da notare che alcuni debiti non vengono comunque cancellati dall’esdebitazione, nemmeno dopo liquidazione: in particolare gli obblighi di mantenimento (alimenti), i debiti per risarcimento danni da fatto illecito e le sanzioni penali e amministrative non si estinguono . Quindi, ad esempio, se parte del debito era una multa stradale o un’ammenda penale, quella resta dovuta; se era un debito per alimenti all’ex coniuge, rimane anch’esso (lo stesso vale per i debiti da condanna per lesioni dolose, ecc., ritenuti inesdebitabili per ragioni etico-sociali). A parte tali eccezioni, tutti gli altri debiti civili e commerciali sono estinti.
Esempio: Mario ha 60 anni, nessun reddito fisso, e debiti personali per €300.000. Possiede solo la nuda proprietà di un piccolo immobile di famiglia. Non essendoci modo di pagare a rate cifre simili, Mario opta per la liquidazione controllata: conferisce l’immobile (che il liquidatore vende per €100.000, versando poi €100k al creditore ipotecario che ne aveva garanzia) e rinuncia a quel poco di TFR che gli spetta (distribuito ai chirografari al 5%). In 2 anni la liquidazione conclude. Mario ha perso quell’unico bene, ma a fine procedura il tribunale lo esdebità dai circa €200.000 rimasti scoperti. I creditori chirografari ricevono solo il 5%, ma il restante 95% viene cancellato. Mario non ha più alcun vincolo giuridico su di sé e può ripartire da zero gli ultimi anni della sua vita senza il peso dei debiti. Senza la procedura, invece, i creditori sarebbero rimasti insoddisfatti lo stesso (data l’assenza di patrimonio aggredibile), ma Mario sarebbe rimasto tecnicamente obbligato per tutta la vita, con la costante minaccia di pignoramento di qualsiasi entrata futura. L’esdebitazione gli ha permesso di chiudere i conti col passato.
Rapporto con le altre procedure: La liquidazione può essere un piano B se falliscono le altre procedure. Ad esempio, se il debitore presenta un piano del consumatore ma il tribunale lo dichiara inammissibile (perché, poniamo, emergono frodi), allora su istanza di un creditore può essere aperta d’ufficio la liquidazione (così i creditori non perdono tempo). Oppure, se il debitore propone un concordato minore e i creditori votano no, può chiedere la conversione in liquidazione controllata. Il CCII permette queste conversioni per non lasciare il debitore privo di tutela. Ovviamente, la liquidazione non richiede il consenso di nessun creditore e questi non possono opporsi all’apertura se ne ricorrono i presupposti. È il rimedio finale.
Meritevolezza in liquidazione ed effetti: Anche per accedere alla liquidazione il debitore deve essere di regola meritevole (non deve avere frodi in atto); in caso contrario i creditori potrebbero opporsi all’esdebitazione finale. Comunque, se anche un debitore non proprio irreprensibile viene ammesso, il giudice potrà poi negargli l’esdebitazione per punirne la condotta (così i debiti resterebbero, anche se formalmente nessuno potrà più aggredire i beni liquidati). Segnaliamo qui una apertura giurisprudenziale: già con sentenza 1869/2016 (Cass.) si era detto che pure chi ha avuto qualche colpa può essere ammesso, riservando la punizione ai casi di dolo o colpa grave – il CCII sembra recepire questa impostazione più morbida. In ogni caso, la stragrande maggioranza dei debitori in liquidazione ottiene poi l’esdebitazione, perché l’obiettivo della legge è la “riabilitazione” e non la punizione. Lo stesso art. 282 CCII definisce l’esdebitazione come “diritto” del debitore trascorso il triennio.
Esdebitazione del debitore incapiente (c.d. “esdebitazione a zero”)
Chiudiamo le procedure giudiziali con la novità più radicale introdotta dapprima nel 2020 e poi confermata all’art. 283 CCII: l’esdebitazione di nullatenente, cioè la possibilità per un debitore persona fisica privo di qualsiasi reddito o beni liquidabili, di ottenere la cancellazione di tutti i suoi debiti senza dover pagare nulla ai creditori. È una misura eccezionale, invocabile una volta sola nella vita e riservata ai casi umanamente più drammatici, in cui neppure una liquidazione patrimoniale avrebbe senso perché non c’è patrimonio. In un certo senso è un corollario del principio di meritevolezza: la società si fa carico di liberare dal peso dei debiti chi proprio non ha alcuna possibilità di pagare, pur avendo avuto un comportamento onesto e diligente.
Requisiti stringenti: Per ottenere questa esdebitazione “senza utilità” (senza utilità per i creditori), il debitore deve dimostrare: (a) di non possedere nulla di liquidabile – né beni mobili o immobili, né partecipazioni, né crediti esigibili; (b) di non avere redditi pignorabili (ad esempio vive solo di minime pensioni sociali o aiuti); (c) di non aspettarsi significativi miglioramenti nel prossimo futuro (insolvenza irreversibile); (d) di essere meritevole e di aver provato nei 4 anni precedenti a risolvere la situazione (ad esempio cercando lavoro, cercando accordi, insomma non deve essersi adagiato). Inoltre, come detto, non deve aver già fruito di esdebitazione in passato, e non deve aver causato il sovraindebitamento con condotte dolose. Sono esclusi dal beneficio, per espressa previsione, i debiti di origine personale “particolare”: alimenti dovuti, risarcimenti da illecito, sanzioni – questi restano dovuti anche dopo l’esdebitazione incapiente . Ciò significa che se ad esempio un nullatenente ha debiti per multe stradali o per assegni di mantenimento non pagati, non potrà vederli spazzati via con questo strumento (lo Stato non gli condona le sanzioni e di certo non cancella l’obbligo verso i figli, per dire). Ma se ha debiti verso banche, privati, bollette, affitti, ecc., allora sì.
Procedura semplificata: Si presenta un’istanza al tribunale chiedendo l’esdebitazione da incapiente ex art. 283 CCII. È consigliabile farsi assistere dall’OCC anche se la legge non lo impone espressamente, perché l’OCC redige una relazione che attesta l’assenza di patrimonio e la condizione di insolvenza totale. I creditori vengono informati e possono eventualmente opporsi se scoprono che il debitore ha nascosto qualcosa. Il tribunale valuta e se tutto è in regola emette un decreto che libera il debitore da tutte le obbligazioni pregresse. In pratica, i debiti vengono cancellati d’autorità. È un risultato straordinario ma giustificato dalla totale mancanza di alternative: se il debitore incapiente restasse formalmente obbligato, si creerebbe solo un perpetuo indebitamento irrecuperabile, con rischi di lavoro nero, usura e devianza (la ratio è anche sociale, per evitare che chi è senza scampo cada vittima di usurai o nella disperazione – da qui il nome popolare di “legge anti-suicidi”).
Obblighi successivi del debitore: Attenzione: il debitore esdebitato in questo modo ha un obbligo di “resa dei conti” per 4 anni successivi. Se entro 4 anni dovesse sopravvenire “una fortuna” – ad esempio eredità, vincita, consistente miglioramento reddituale – tale da permettergli di pagare almeno il 10% dei vecchi debiti, allora deve informare i creditori e il tribunale. In tal caso, potrebbe essere chiamato a versare quella parte ai creditori (non l’intero debito originario, ma appunto fino al 10% se può). Se invece nei 4 anni non succede nulla di rilevante (come spesso sarà), la liberazione diventa definitiva senza condizioni. Per monitorare ciò, la norma impone che il debitore comunichi annualmente all’OCC la propria situazione economica per 4 anni. È un piccolo “periodo di prova” per assicurarsi che l’esdebitato incapiente non vinca alla lotteria senza dare nulla ai creditori.
Esempio tipico: Sempronia, 70 anni, pensionata sociale, debiti pregressi per €50.000 con finanziarie e bollette non pagate. Vive in affitto, nessun bene intestato, nessun familiare su cui rivalersi. Per lei né un piano né una liquidazione avrebbero senso (non ha reddito né beni). Presenta istanza di esdebitazione incapiente. Il tribunale accerta che davvero non possiede nulla e che i debiti derivano da spese mediche e di sostentamento (nessuna frode, solo povertà). Accoglie quindi l’istanza: con decreto dichiara cancellati i €50.000 di debiti di Sempronia. I creditori (società finanziarie) devono azzerare i loro crediti verso di lei. Se domani Sempronia dovesse vincere €10.000 al Superenalotto, dovrebbe avvisarli e destinare €5.000 circa (il 10% di 50k) al pagamento parziale; ma ciò è improbabile. Più realisticamente, vivrà con la sua pensione di €600 al mese, ora però senza più lettere di diffida né minacce di pignoramento, potendo spendere quel poco che ha per le sue necessità quotidiane. Il sistema ha perso €50k non recuperati, ma ha evitato di creare un’esclusa sociale.
Tutele per le vittime di reati: Una novità del 2024: la legge di bilancio 2024 ha istituito un Fondo statale per indennizzare parzialmente i creditori vittime di usura o estorsione nel caso in cui i loro debitori ottengano l’esdebitazione da incapienti. Questo perché alcune associazioni di vittime avevano segnalato il rischio che chi presta denaro a un usurato poi veda cancellato il suo credito. Per ora (ottobre 2025) si attendono i decreti attuativi, ma è interessante notare l’attenzione agli equilibri: l’istituto dell’esdebitazione a zero resta eccezionale e circondato da cautele, per evitare abusi.
Importante da ricordare: l’esdebitazione del debitore incapiente è un’arma da usare una tantum. Chi ne beneficia non potrà più accedere ad altre procedure di sovraindebitamento in futuro (ovviamente, avendogli già azzerato i debiti). Ciò stimola il debitore stesso a valutare bene se chiedere questo “perdono” definitivo oppure se magari cercare di fare almeno un piccolo piano: ad esempio, se uno è nullatenente ma giovane e con prospettive di reddito, potrebbe preferire un piano del consumatore con pagamento di una parte, serbando la possibilità in futuro di agire di nuovo se servisse; mentre l’esdebitazione incapiente lo preclude. Un avvocato potrà consigliare quale strada conviene, anche in base all’entità dei debiti e delle prospettive di vita del cliente.
Debiti fiscali: cartelle esattoriali, rottamazione e saldo e stralcio tributario
I debiti verso il Fisco (Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia) e verso gli enti previdenziali costituiscono una categoria a parte, con proprie regole e possibilità di sgravio. Un avvocato che assiste un contribuente indebitato con l’erario valuterà sia gli strumenti “di massa” (rottamazioni, definizioni agevolate previste dal legislatore) sia le opzioni individuali (rateazioni, opposizioni a cartella, inserimento in procedure concorsuali come visto sopra). In Italia, dal 2016 ad oggi, i vari governi hanno periodicamente introdotto misure di “pace fiscale” per aiutare i contribuenti in difficoltà – si pensi alle rottamazioni delle cartelle e al saldo e stralcio per contribuenti in grave difficoltà, nonché al più recente stralcio automatico delle mini-cartelle. Esaminiamo dunque queste possibilità, aggiornate all’ultima finestra nota (2023-2024), ricordando che per i debiti tributari valgono anche, in sede concorsuale, le considerazioni già fatte (il Fisco può subire decurtazioni in un piano concordatario, ma con limiti per IVA e ritenute, e col rispetto del best interest test).
Definizione agevolata (Rottamazione delle cartelle esattoriali)
Per “rottamazione delle cartelle” si intende la possibilità di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi di mora, dunque versando solo le imposte/contributi dovuti e un minimo di interessi legali. La prima rottamazione risale al 2016 (D.L. 193/2016), seguita da altre edizioni: “rottamazione-bis” nel 2017, “rottamazione-ter” nel 2018 e infine la “rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Quest’ultima, attualmente in corso di esecuzione, consente di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I vantaggi sono: stralcio totale di sanzioni e interessi di mora e aggio di riscossione. Il contribuente paga quindi solo la quota capitale delle imposte/contributi e i rimborsi spese (notifica, esecuzione) eventualmente dovuti. Anche per le multe stradali è previsto sconto degli interessi, mentre la sanzione in sé va pagata (trattata come “capitale”). Per aderire alla rottamazione-quater 2023 bisognava presentare domanda entro il 30 giugno 2023 (termine poi prorogato al 30 settembre 2023). È possibile pagare il dovuto a rate: fino a 18 rate in 5 anni, con scadenze fissate al 31 ottobre 2023 (prima rata), 30 novembre 2023 (seconda) e poi trimestralmente fino al 2027. Il legislatore ha accordato anche delle proroghe di tolleranza: ad esempio, con decreto legge di fine 2023, il termine per pagare le prime due rate di ottobre e novembre 2023 è stato esteso al 18 dicembre 2023 senza perdere i benefici. Altre proroghe hanno spostato la 3ª rata al 2024 inoltrato (15 marzo) e così via. È importante rispettare queste scadenze: un ritardo oltre 5 giorni comporta la decadenza dalla definizione agevolata e la cartella “risorge” con sanzioni piene. Ma se il piano viene rispettato, il contribuente paga una frazione significativa in meno rispetto al dovuto originario.
Esempio: Tizio ha €10.000 di cartelle per IRPEF e IVA non pagate anni passati, di cui €4.000 sono interessi e sanzioni. Con la rottamazione, pagherà circa €6.000 (il capitale imposta + piccoli interessi legali) magari in 18 rate da ~€333/mese. Risparmierà €4.000 che vengono condonati. Se avesse anche una multa stradale di €500 diventata €800 con interessi, pagherà i €500 originari più notifica ma non gli interessi di mora.
Da notare: per alcune categorie di enti creditori (Comuni, enti locali), la rottamazione non opera automaticamente se l’ente ha deciso di non aderire. Ad esempio, la Camera di Commercio di Padova nel 2023 deliberò di non applicare lo stralcio parziale delle sanzioni per il proprio diritto annuale. In tali casi, il contribuente deve pagare integralmente oppure sperare in misure locali analoghe.
Stralcio automatico dei mini-debiti fino 1.000 euro
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un condono automatico per le vecchie cartelle di modesto importo. In particolare, l’art. 1 commi 222–230 L.197/2022 ha disposto l’annullamento d’ufficio di tutti i debiti di importo residuo fino a €1.000 affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Tale stralcio è avvenuto il 31 marzo 2023 (poi prorogato al 30 aprile 2023). Cosa comporta? Dipende dal tipo di ente creditore:
- Per i carichi di Stato, Agenzie fiscali ed enti previdenziali nazionali, lo stralcio ≤€1000 è stato integrale (capitale + interessi + sanzioni). Quindi, ad esempio, una cartella di €800 per IRPEF 2010 è stata completamente cancellata.
- Per i carichi di enti locali o diversi dallo Stato (es. Comuni, multe, Camera Commercio), la legge prevedeva uno stralcio parziale: venivano tolti interessi e sanzioni, ma rimaneva dovuto il capitale. Ciò significa, ad esempio, che una cartella di €300 per una multa stradale (con €200 multa + €100 interessi) è stata ridotta a €200 (la multa rimane da pagare, gli interessi no). Tuttavia, dava facoltà a questi enti di deliberare di non applicare lo stralcio parziale e quindi continuare a riscuotere tutto. Molti Comuni inizialmente erano confusi sulla convenienza: alcuni hanno deliberato di estendere lo stralcio integrale anche al capitale (facoltà concessa dalla norma entro 31/1/2023), altri hanno preferito mantenere la riscossione.
In ogni caso, per i debiti fino 1000 euro del periodo 2000-2015, dal 2023 c’è stata questa “pulizia di magazzino”. Il contribuente non doveva fare nulla: l’annullamento è avvenuto in automatico e l’Agente della Riscossione ha comunicato l’esito. Se qualcuno aveva già pagato prima del 31/3/23, ovviamente non riceve rimborso (il condono non dà diritto a restituire quanto già versato).
Effetto pratico: milioni di piccole cartelle (soprattutto multe comunali) sono state eliminate dai ruoli. Un piccolo sollievo per tanti cittadini. Ad esempio, Caio aveva 3 cartelle da €250 cadauna per TARI e multe 2012: ciascuna sotto €1000, tutte annullate al 31/3/23 (ma Caio deve comunque pagare in futuro la TARI corrente ecc., solo le vecchie pendenti sono state condonate nelle parti accessorie). Questo stralcio automatico si affianca alle definizioni agevolate per importi maggiori (che Caio sfrutterà per la cartella Equitalia 2018 da €3.000 che ha per IRPEF, rottamandola magari).
Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà
Oltre alle rottamazioni generali, c’è stata anche una misura di “saldo e stralcio” fiscale mirata ai contribuenti in comprovata difficoltà economica. In particolare, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) aveva previsto che le persone fisiche con ISEE fino a €20.000 potessero estinguere i carichi relativi a omessi versamenti tributari 2000-2017 pagando solo una percentuale del dovuto (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE e del tipo di carico). Questa misura – denominata proprio “Saldo e Stralcio” – era riservata a chi non riusciva a rottamare perché in grave e comprovata indigenza. Ha permesso, ad esempio, a soggetti nullatenenti ma con qualche debito fiscale di chiudere pagando solo il 16% se ISEE sotto €8.500. Fu un provvedimento una tantum (domande entro 30/4/2019); attualmente non è aperto un analogo saldo e stralcio “sociale”.
Tuttavia, la rottamazione-quater 2023 ha in parte replicato i suoi effetti: infatti, per i contribuenti decaduti dalle rottamazioni precedenti o che comunque avevano debiti esattoriali recenti, di fatto la definizione agevolata toglie tutte le sanzioni e interessi. Questo può equivalere a uno sconto percentuale anche notevole se sul debito c’erano molte penalità. Ad esempio, un contribuente che doveva €5.000 di IRPEF + €5.000 di sanzioni e interessi, con la rottamazione paga i soli €5.000 (50% del totale originario), che è un saldo e stralcio di fatto al 50%. Non dipende dall’ISEE in questo caso ma è generalizzato.
Transazione fiscale nelle procedure concorsuali: Infine, va ricordato che all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (per imprese maggiori) esiste l’istituto della transazione fiscale, cioè un accordo con l’Erario per il pagamento parziale dei tributi. Nelle procedure di sovraindebitamento (concordato minore e piano del consumatore), più che un accordo separato, si include il Fisco nel piano come visto, con eventuale falcidia. La differenza è che nel concordato minore il Fisco vota; nel piano del consumatore no, ma il giudice controlla la soglia minima. La giurisprudenza più recente è intervenuta per chiarire che anche IVA e ritenute possono essere falcidiate se c’è capienza, come recepito dal D.Lgs. 83/2022 (che ha attuato la direttiva UE): questo perché prima era dibattuto se l’IVA potesse essere tagliata. Ora è ammesso tagliare l’IVA in concordato se l’alternativa è che il Fisco in liquidazione non prenderebbe di più. Ad ogni modo, fuori dalle procedure concorsuali, il Fisco non può autonomamente accettare pagamenti parziali del capitale dovuto (lo impedisce il principio di indisponibilità del tributo salvo previsione di legge). Quindi, se non si entra in sovraindebitamento o concordato, l’unico modo per ridurre la somma da pagare al Fisco è approfittare di leggi come rottamazioni e stralci automatici. Un avvocato saprà sempre valutare se conviene attendere possibili nuovi condoni (in autunno 2023 si parlava di una possibile “rottamazione-quinqies” nel 2024, poi non concretizzatasi, ma in futuro chissà) o se invece accelerare e ricorrere a un piano del consumatore includendo i debiti fiscali con un certo taglio.
Opposizioni e vizi delle cartelle
Oltre alle misure legislative di favore, un avvocato controllerà anche la regolarità formale delle cartelle esattoriali e degli atti del Fisco. Spesso, infatti, i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si riducono non per condono ma perché parte non è dovuta per ragioni giuridiche. Ad esempio:
- Prescrizione: Le cartelle hanno termini di prescrizione (5 anni di norma per i tributi locali, contributi INPS, 10 anni per imposte erariali dopo notifica della cartella se non diversamente specificato). Se l’Agente della Riscossione non ha compiuto atti interruttivi tempestivi, il debito può essere prescritto. Un avvocato esaminerà la cronologia delle notifiche: se ad esempio una cartella IRPEF 2012 non è seguita da nessuna intimazione fino al 2020, quel credito potrebbe essere prescritto e l’avvocato potrà fare opposizione all’esecuzione eccependo la prescrizione, ottenendo l’annullamento dell’obbligo di pagamento. La Cassazione (SU 23397/2016) ha stabilito che la cartella non pagata non rende “eterno” il credito: continua a prescriversi nel termine proprio del tributo.
- Vizi di notifica: Molte cartelle non sono state notificate correttamente (errori nell’indirizzo, mancanza di relata, ecc.). Ciò può rendere inesigibile la pretesa se il contribuente non ne ha avuto conoscenza nei termini. Ad esempio, se una cartella è stata notificata via PEC a un indirizzo errato, è nulla; dopo i termini decadenziali l’ente non può rinotificarla validamente. Un avvocato può sollevare tale vizio e far annullare la cartella dal giudice tributario o dall’ordinario (a seconda del caso).
- Sospensioni e sgravi: Talvolta l’ente creditore (Es. Agenzia Entrate) dispone sgravio o annulla in autotutela la cartella, ma l’Agente della Riscossione non ferma le azioni. Presentando i provvedimenti, l’avvocato ottiene la sospensione immediata. Se il contribuente aveva diritto a un blocco (es. perché in pendenza di rateizzazione o contenzioso), ogni azione esecutiva intrapresa in violazione è illegittima.
- Impignorabilità prima casa: Su un versante diverso, l’avvocato tutela il debitore contro eccessi esecutivi: ad esempio ricordando all’Agenzia Riscossione che non può ipotecare o espropriare l’unica casa di abitazione del debitore (non di lusso) per debiti sotto €120.000 (D.L. 69/2013). Se ciò accadesse, si può ricorrere al giudice per cancellare l’ipoteca o bloccare la vendita. Questa è più che altro una difesa patrimoniale che non riduce il debito, ma salva l’immobile, costringendo eventualmente il Fisco ad accettare soluzioni alternative (come l’ipoteca di secondo grado o l’attesa, oppure a ridurre il debito via rottamazione perché non recupererà altrimenti).
In sintesi, nell’ambito dei debiti fiscali l’avvocato svolge un duplice ruolo: “commercialista” nel consigliare su rateazioni e condoni, e “avvocato difensore” nell’impugnare cartelle e fermi illegittimi per ridurre o azzerare il dovuto quando la legge gliene dà motivo.
Debiti bancari e finanziari: contestazioni, usura e soluzioni per il debitore
I debiti verso banche, società finanziarie (prestiti personali, mutui, carte di credito) rappresentano una quota importante delle situazioni di sovraindebitamento. Abbiamo già trattato le possibili trattative extragiudiziali (saldo e stralcio, piani di rientro) e le possibili azioni legali (usura, anatocismo, nullità contrattuali) che possono aiutare a ridurre questi debiti. Qui riassumiamo i punti chiave dal punto di vista del debitore assistito dal legale:
- Verifica del contratto di finanziamento: appena incaricato, l’avvocato chiederà tutta la documentazione del prestito/mutuo (contratto, piano ammortamento, estratti conto, ecc.). Attraverso un perito, effettuerà un ricalcolo per vedere se il tasso effettivo supera la soglia d’usura (tenendo conto di tutte le voci di costo) o se sono stati applicati interessi composti illegittimi. Se emergono irregolarità, il legale formulerà al creditore una contestazione formale: talvolta basta ciò per convincere la banca a intavolare una transazione riducendo il debito (preferiscono incassare qualcosa piuttosto che rischiare una causa dall’esito incerto). Se la controparte nega, l’avvocato può avviare una causa civile per accertare ad esempio l’usurarietà: in corso di causa, spesso i giudici nominano CTU contabili. Se confermato l’addebito illegale, la banca viene condannata a ricalcolare il debito restituendo gli importi indebiti. Ciò può portare, come accennato, a riduzioni molto significative del dovuto (ci sono stati casi in cui un mutuo in mora da €100.000 risultava già interamente pagato considerando l’usura, obbligando la banca a liberare l’ipoteca senza ulteriori pagamenti).
- Sospensione delle segnalazioni: Se pende contestazione su un debito bancario, l’avvocato può anche chiedere in via d’urgenza di sospendere la segnalazione del debitore come “cattivo pagatore” in Centrale Rischi o CRIF, se ci sono fondati motivi (ad esempio, se si dimostra prima facie che il debito è contestato per usura). Questo allevia la pressione sul debitore, che non si vede precluso l’accesso ad eventuale nuovo credito necessario (salvo che la segnalazione fosse già avvenuta: lì si può domandare la cancellazione ex post se la causa dà ragione al debitore).
- Riduzione delle rate: A volte ridurre il debito significa semplicemente ridurre l’importo della rata mensile a un livello sostenibile. Ciò può essere ottenuto chiedendo alla banca un piano di rinegoziazione o attivando un fondo di garanzia. Ad esempio, esiste il Fondo Gasparrini che consente la sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo prima casa in caso di perdita lavoro o problemi di salute; oppure, per i piccoli finanziamenti, il Fondo di prevenzione usura gestito da MCC può garantire nuovi prestiti a soggetti sovraindebitati purché destinati a ristrutturare i debiti a usura. Un avvocato ben informato potrà indirizzare il cliente verso queste opportunità, integrandole in una strategia complessiva (ad es., sfruttare 12 mesi di sospensione mutuo per destinare quelle risorse a fare offerte saldo e stralcio su altri debiti più onerosi).
- Cessione del quinto e delegazioni di pagamento: Un caso particolare di debito finanziario è la cessione del quinto dello stipendio/pensione. Molte persone si trovano con un quinto del salario già impegnato per prestiti e magari nel frattempo accumulano altri debiti. Come visto, se attivano una procedura di sovraindebitamento, la cessione del quinto viene sospesa d’ufficio dal giudice: il che significa che smettono di trattenere quel quinto in busta paga, e il residuo debito verso la finanziaria cedente viene trattato nel piano come un normale credito chirografario (magari decurtato). Questo è uno dei motivi per cui molti pensionati sovraindebitati ricorrono al piano del consumatore: consente loro di “riappropriarsi” della pensione intera, almeno temporaneamente, e respirare. Al di fuori di ciò, non è facile rinegoziare una cessione del quinto, a meno di rifinanziarla aumentando l’importo o allungando i tempi (ma sono operazioni costose in termini di ulteriori interessi). Un avvocato può però verificare se nel contratto di cessione erano state rispettate tutte le normative di trasparenza: ad esempio, ci sono stati casi di cessioni dichiarate nulle perché il TAEG effettivo (comprensivo di assicurazione obbligatoria) superava la soglia, o perché il cedente aveva altre cessioni non dichiarate e la finanziaria non aveva verificato (situazioni borderline).
- Sovraindebitamento e codice del consumo: Non bisogna dimenticare che i debiti bancari contratti da consumatori rientrano anche nelle tutele del Codice del Consumo. Se il finanziatore ha violato obblighi informativi, o se la stipula è avvenuta con pratiche aggressive, esistono armi di difesa. Ad esempio, se un pensionato ultrasettantenne è stato convinto a sottoscrivere un prestito con cambiali a tassi astronomici, l’avvocato può far leva su eventuali profili di nullità o annullabilità per incapacità naturale, ecc. In determinati casi estremi, la giurisprudenza ha annullato contratti per “approfittamento dello stato di bisogno” (usura soggettiva), anche se rari.
In conclusione su questo capitolo: i debiti verso banche e finanziarie possono essere ridotti e gestiti attraverso negoziazioni mirate e azioni legali calibrate. Un avvocato offre competenze che il singolo debitore difficilmente ha: conosce i precedenti giurisprudenziali, sa quando minacciare una causa di usura credibilmente, sa leggere un estratto conto bancario per individuarvi errori di calcolo e, soprattutto, può contrattare con le banche da pari a pari. Spesso infatti il cittadino che va in banca a spiegare che “gli interessi sono troppo alti” non viene ascoltato; mentre una lettera di uno studio legale con riferimenti alle circolari Banca d’Italia e alla Cassazione ottiene subito l’attenzione dell’ufficio legale dell’istituto, aprendo la porta a una transazione favorevole.
Debiti commerciali e verso fornitori: strategie per imprenditori
Infine, qualche considerazione sui debiti di natura commerciale: fornitori non pagati, affitti di locali in arretrato, bollette aziendali, canoni leasing, ecc. Per imprenditori e professionisti, questi debiti spesso generano decreti ingiuntivi, protesti e possono condurre a istanze di fallimento (se il debitore è fallibile). Dal punto di vista del debitore-imprenditore (individuale o società), ridurre i debiti commerciali richiede di negoziare dilazioni o falcidie con una moltitudine di creditori – ed eventualmente convocarli a un tavolo comune. L’avvocato, in questi casi, può agire come mediatore: contattare tutti i creditori proponendo un “piano di ristrutturazione” volontario. Ad esempio, l’azienda offre ai fornitori il 60% dei loro crediti, pagato in 12 mesi, magari minacciando che se non accettano la società dovrà liquidare e loro prenderebbero forse zero. Questa tecnica talvolta funziona se i creditori confidano nell’onestà dell’imprenditore e preferiscono non vederlo sparire dal mercato (specie se è un cliente importante). Il rischio è sempre il free rider: il creditore che, sperando di più, non aderisce. Senza un vincolo legale, come già detto, basta uno fuori dal coro per saltare tutto.
Ecco che il ruolo dell’avvocato è anche spiegare ai creditori che l’alternativa potrebbe essere peggiore (un lungo contenzioso, un fallimento con tempi biblici). Può essere utile farsi affiancare da un commercialista che illustri i numeri: “se l’azienda fallisce oggi, prevediamo un attivo di 20 centesimi per euro di credito; se invece accettate il piano, ne prendete 60 in un anno”. Queste argomentazioni razionali spesso fanno presa. Quando non bastano, si può ricorrere agli strumenti concorsuali maggiori: per società e imprese fallibili, c’è il concordato preventivo (che, come il minore, consente di imporre ai dissenzienti un taglio se la maggioranza approva). L’avvocato potrebbe consigliare all’imprenditore di presentare un concordato “in bianco” (richiesta prenotativa) per congelare le azioni esecutive, e nel frattempo sondare un accordo con i creditori – se sufficiente, formalizzarlo poi in un concordato vero e proprio.
Per le società di persone (snc, sas), dove i soci rispondono, occorre coordinare la gestione del debito: i soci illimitatamente responsabili potrebbero valutare la composizione della crisi personale contestuale a quella della società (il CCII consente procedure concordate coordinate tra società e soci). Ad esempio, se una SNC non fallibile vuole proporre un concordato minore ma ha anche debiti personali in capo ai soci, si può fare un unico concordato minore familiare includendo soci e società, data la comunanza economica – qui la competenza tecnica di un legale concorsualista è fondamentale.
Case study: un piccolo negozio (ditta individuale) accumula debiti con 5 fornitori per €100k totali. Due di essi avviano decreti ingiuntivi e pignorano la merce. L’avvocato fa da scudo: intavola transazioni con ciascuno, e suggerisce al cliente di reperire magari un finanziamento ponte (o capitale da investitori) per offrire ai fornitori un pagamento upfront. Propone quindi: “vi do il 50% entro un mese e vi saldo un altro 20% in 6 mesi, dopodiché vi considerate soddisfatti”. 4 fornitori su 5 accettano. L’ultimo, più ostico, viene convinto dal fatto che gli altri hanno firmato – e dal timore di restare l’unico a dover poi inseguire un debitore svuotato. Così si raggiunge un accordo stragiudiziale globale. Vengono redatte scritture private di transazione con ciascuno. L’avvocato predisponde anche delle liberatorie incrociate: i fornitori si impegnano a revocare i decreti ingiuntivi e cancellare eventuali ipoteche giudiziali a incasso avvenuto. Il debitore ottiene un taglio ~30% del debito complessivo e soprattutto il tempo per riprendersi. In questo scenario, se un solo fornitore avesse rifiutato, il piano sarebbe saltato e probabilmente si sarebbe dovuti ricorrere a una liquidazione (con tutti che prendono meno).
Va detto che per debiti commerciali il sistema non prevede condoni analoghi a quelli fiscali. Tuttavia, esistono alcune normative protettive: ad esempio la legge 3/2012 aveva introdotto la nozione di “merito creditizio” penalizzando quelle banche o finanziarie che avevano concesso prestiti a soggetti già sovraindebitati “dovendo se ne accorgere”. Questo concetto – più etico che giuridico – può essere sfruttato a livello dialettico: si può far notare a un fornitore che continuava a vendere a un cliente già insolvente che anche lui ha avuto la sua parte di rischio e quindi non può pretendere tutto. Non è un argomento giuridicamente vincolante, ma rientra in quell’abilità negoziale dell’avvocato nel dipingere la situazione non come “colpa esclusiva” del debitore.
Domande frequenti (FAQ) sulla riduzione dei debiti
D: Chi può accedere al “piano del consumatore”?
R: Possono proporlo solo i debitore consumatori, cioè persone fisiche che hanno fatto debiti per scopi estranei ad attività d’impresa (familiari, personali). Inoltre devono essere non fallibili (quindi non grandi imprenditori) e meritevoli (non avere frodato i creditori né causato il sovraindebitamento con colpa grave). Se una persona ha anche debiti da attività d’impresa (es. ex imprenditore con debiti aziendali), non può includere quelli nel piano del consumatore – dovrà eventualmente utilizzare il concordato minore o la liquidazione per quelli. In pratica: privati, lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati e professionisti con soli debiti personali sì; imprenditori in attività no (loro usano concordati maggiori); ex imprenditori con debiti misti no (devono separare le posizioni). Anche i fideiussori possono essere consumatori se la garanzia prestata era per scopi non imprenditoriali propri.
D: Come faccio a capire se sono “meritevole” per queste procedure?
R: In linea di massima, se non hai commesso atti di frode (es. distrarre beni per non pagarli) e non hai volutamente fatto debiti contando sullo stralcio, sei meritevole. La legge esclude chi ha agito con dolo o colpa grave. Cosa significa colpa grave? Secondo la Cassazione, non basta aver gestito male il denaro o essere stati imprudenti: dev’essere qualcosa come aver contratto debiti sapendo di non poterli pagare, sperperato ricchezza in giochi d’azzardo, o falsificato documenti. Invece, chi è sovraindebitato per circostanze sfortunate (malattia, perdita lavoro, crisi economica) di solito è considerato meritevole. Anche aver acceso troppi prestiti può non escludere, a meno che non emerga un comportamento gravemente irresponsabile. In pratica, i tribunali tendono a dare il beneficio del dubbio e ammettere il debitore salvo condotte davvero maliziose. Va segnalato però che se già beneficiasti di esdebitazione in passato, non potrai riottenerla (è un “bonus” una tantum per evitare abusi).
D: Posso includere anche i debiti con il Fisco (Agenzia Entrate, INPS) in un piano di sovraindebitamento?
R: Sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi nei piani (piano consumatore o concordato minore) e subire riduzioni o dilazioni. Ci sono però alcune condizioni speciali: il piano deve offrire al Fisco almeno quanto otterrebbe liquidando i beni del debitore】; inoltre, per alcuni tributi “sensibili” come IVA e ritenute previdenziali non versate, la legge richiede il pagamento integrale salvo il caso in cui il debitore dimostri che proprio non potrebbe pagarli neanche liquidando tutto. In sostanza, non puoi proporre di pagare un’aliquota bassissima di IVA se hai beni aggredibili, perché il tribunale non lo permetterebbe. Se però non hai nulla, puoi proporre anche un pagamento parziale di IVA, purché l’OCC attesti che è equo rispetto al ricavabile in liquidazione. Queste rigidità derivano da norme europee e nazionali per tutelare le risorse pubbliche. Detto ciò, sì: le cartelle esattoriali entrano nei piani e con l’omologa anche l’Erario viene vincolato allo stralcio (a differenza di quanto avviene fuori, dove il Fisco da solo non può accettare di rinunciare a imposte). Infine, ricorda che eventuali multe e sanzioni amministrative possono rientrare nel piano, ma se sono sanzioni per reati o di mantenimento, quelle non verranno esdebitate comunque .
D: Ho un mutuo sulla prima casa e altri debiti; se faccio la procedura rischio di perdere la casa?
R: L’obiettivo del piano del consumatore o concordato minore è evitare la perdita dei beni essenziali quando possibile. Se la tua casa è già ipotecata per il mutuo, il piano probabilmente prevederà di continuare a pagare il mutuo regolarmente (magari mettendo la banca in una classe separata). La legge consente anzi di chiedere la sospensione fino a 2 anni delle rate ai creditori privilegiati come la banca, così da riprendere fiato – sospensione che spesso le banche accettano perché l’alternativa sarebbe peggiore. Inoltre, per legge la prima casa non può essere pignorata dal Fisco sotto certe condizioni, e questa tutela rimane. Quindi, presentare un piano ti protegge di più rispetto al non fare nulla: in corso di procedura c’è la sospensione delle azioni esecutive, quindi eventuali aste vengono bloccate. Ci sono casi in cui per far funzionare il piano potrebbe essere necessario vendere la casa – ad esempio, se il tuo maggior asset è la casa e i creditori accettano il piano solo se l’immobile viene liquidato per pagarli. Ma questo lo decidi tu col supporto dell’OCC in fase di proposta: non c’è un automatismo per cui la casa viene venduta. Anzi, spesso i giudici incoraggiano soluzioni che mantengano la prima casa al debitore (es. pagare i creditori con altri mezzi, lasciando fuori l’abitazione). In liquidazione controllata invece la casa verrebbe venduta salvo eccezioni, ma ricorda che puoi optare per la liquidazione volontariamente se vedi che il piano è impossibile, ottenendo comunque l’esdebitazione finale.
D: Quanto tempo dura una procedura di sovraindebitamento?
R: Dipende dalla procedura e dal piano proposto. Indicativamente: un piano del consumatore dura il tempo necessario a pagare le rate previste – spesso 4 o 5 anni, ma possono essere anche più brevi o (raramente) più lunghi. La legge non fissa un massimo, ma la prassi è di non andare oltre 5–7 anni per non rendere troppo aleatorio il piano (un caso eccezionale vide un piano trentennale, ma non è la norma!). Un concordato minore di solito viene proposto in 3–5 anni per coerenza con la durata ragionevole, anche se nessuna norma fissa un tetto rigido. La liquidazione controllata ha per legge un orizzonte di 4 anni per la contribuzione dei redditi, ma se ci sono beni immobili da vendere la procedura tecnica può richiedere qualche anno aggiuntivo di attesa per le vendite (specie se aste deserte). Tuttavia, grazie all’art. 282 CCII, la esdebitazione scatta dopo 3 anni dall’apertura anche se la liquidazione non è conclusa. Quindi per il debitore la “durata percepita” è al massimo 3 anni e poi è libero, anche se magari il liquidatore continuerà a distribuire piccoli attivi residuali ai creditori. L’esdebitazione del debitore incapiente è la più veloce: giusto il tempo per il tribunale di esaminare la domanda e (se tutto ok) emettere il decreto – pochi mesi. Dopo c’è quel “periodo di controllo” di 4 anni, ma non è una procedura attiva, solo un monitoraggio.
D: Cosa succede se non riesco a rispettare il piano omologato?
R: Se il debitore non adempie ai pagamenti previsti dal piano/concordato, si rischia la risoluzione della procedura. Nel piano del consumatore, il tribunale su istanza dei creditori può dichiarare risolto il piano se il debitore è inadempiente e non ci sono margini di correzione. Idem nel concordato: basta il mancato pagamento significativo di quanto dovuto per far decadere l’accordo. In tal caso, i creditori riacquisiscono la facoltà di agire per il residuo debito non pagato. Ad esempio, se avevi un piano per pagare 30% e ti fermi dopo aver versato 15%, il giudice risolve e i creditori tornano a poterti chiedere il 85% iniziale (detratto quanto ricevuto). Insomma, si torna come prima meno i pagamenti eseguiti imputati a riduzione del debito. Inoltre, non potrai ottenere l’esdebitazione. Tuttavia, spesso i tribunali cercano di salvare il salvabile: se il problema è temporaneo (es. ritardo di qualche mese), magari convocano un’udienza per capire se il piano può essere modificato o concessa una proroga. Sta anche al debitore e al suo avvocato segnalare tempestivamente le difficoltà e proporre soluzioni (es. trovare un familiare che subentri nei pagamenti). Se proprio la risoluzione avviene, si può valutare di ripresentare magari una liquidazione controllata a quel punto (il CCII lo consente in certi limiti). Ma attenzione: se la risoluzione deriva da dolo del debitore (ha nascosto redditi etc.), allora è molto probabile che in nuove procedure il tribunale ti consideri non meritevole. Quindi è essenziale, una volta ottenuta l’omologa, fare di tutto per rispettarla. È un impegno serio, come un “fioretto” finanziario.
D: Se ho un coobbligato (es. un garante) nei debiti, la procedura lo libera?
R: No, di regola la procedura riguarda solo chi la propone. Se tu fai un piano e paghi ad esempio il 50% a un certo creditore, il fideiussore che garantiva per te potrebbe essere chiamato dal creditore per l’altro 50%. Ci sono delle eccezioni: se il coobbligato è tuo familiare convivente, potete presentare una procedura familiare congiunta e allora entrambi sarete coperti dalla stessa omologa. Oppure se il coobbligato è una tua società di persone non fallibile, potete fare concordato minore insieme. Ma se il garante è esterno e non partecipa, egli rimane obbligato per intero verso il creditore (salvo poi rivalersi su di te, ma se tu sei esdebitato non potrà). C’è un aspetto: quando un creditore viene soddisfatto parzialmente in una procedura e poi va dal garante per il resto, il garante potrebbe a sua volta avere titolo per un nuovo debito nei tuoi confronti, ma quell’obbligazione dovrebbe anch’essa considerarsi antecedente e dunque esdebitata (un tema complesso; diciamo che meglio coinvolgere i garanti nella procedura se possibile). Ad ogni modo, il Codice della Crisi non libera automaticamente i coobbligati non coinvolti. Diverso è nel caso del saldo e stralcio extragiudiziale: lì se un creditore firma che rinuncia al residuo, in linea di massima la rinuncia vale anche per i garanti (se non diversamente pattuito) perché il debito viene considerato estinto a tutti gli effetti. Quindi attenzione: se stai pianificando un accordo transattivo a saldo e stralcio con una banca e hai un garante, verifica con l’avvocato di inserire che la liberatoria riguarda anche il fideiussore, altrimenti la banca potrebbe riservarsi di perseguitare quest’ultimo per la parte non pagata.
D: Quali debiti NON possono mai essere cancellati neanche con queste procedure?
R: Sono pochi ma importanti: i debiti per obblighi alimentari (mantenimento a coniuge, figli) non sono falcidiabili né esdebitabili ; i debiti per danni da fatti illeciti extracontrattuali (es. risarcimento dovuto per lesioni volontarie, oppure per morte causata – in pratica se devi soldi per aver commesso un reato o un torto grave) restano dovuti per intero e non c’è esdebitazione che tenga; infine le multe penali o amministrative (ad es. un’ammenda penale, o le sanzioni amministrative pecuniarie): quelle non vengono perdonate, sebbene in alcune procedure possano essere incluse per la parte accessoria (interessi) ma il capitale multa resta. Questo è chiaramente previsto nell’esdebitazione incapiente ed è generalmente accolto come principio generale. Ciò significa, ad esempio, che se hai €10.000 di arretrati di mantenimento verso i figli, non potrai farli sparire: dovrai pagarli prima o poi, e un giudice non omologherà mai un piano che pretenda di cancellarli. Idem se devi €5.000 per una sanzione Antitrust: non potrai farla ridurre del tutto. Tutti gli altri tipi di debito, invece, sono potenzialmente cancellabili: prestiti, mutui, fornitori, bollette, leasing, tasse (con i limiti dell’IVA come detto), contributi, canoni… Su questi c’è ampia manovra per riduzioni e cancellazioni finali.
D: Quanto costa intraprendere una procedura di sovraindebitamento?
R: Ci sono tre voci di costo: (1) un contributo all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) per l’attività del Gestore; (2) il compenso dell’avvocato che ti assiste; (3) eventuali spese vive (bolli, notifiche, perizie). L’OCC di solito chiede un fondo spese iniziale (qualche centinaio di euro) e poi, se la procedura va a buon fine, trattiene un compenso approvato dal giudice a chiusura. Questo compenso è proporzionale al debito e all’attivo gestito, ma spesso è di qualche migliaio di euro. In alcuni casi gli OCC applicano tariffe agevolate per soggetti incapienti, rateizzando il loro compenso. L’avvocato normalmente chiede un anticipo e poi una quota a risultato (ci sono studi che, ad esempio, fanno pagare una percentuale solo sulla parte di debito effettivamente stralciata, filosofia del “paghi solo se riduciamo il debito”). Le cifre cambiano a seconda della complessità: indicativamente, per un piano del consumatore standard, l’insieme OCC+legale potrebbe costare tra i 3.000 e i 6.000 euro in totale. Può sembrare tanto, ma se ti stanno cancellando magari €50.000 di debiti è un investimento ben speso. Inoltre, alcuni costi possono essere inclusi nel piano stesso (pagati con le risorse apportate prima di soddisfare i creditori). Per esempio, il tribunale può autorizzare che una parte di quanto versi serva a pagare i compensi dei gestori e solo il resto ai creditori. Importante: nel caso di esdebitazione dell’incapiente, la legge prevede espressamente che la procedura deve essere gratuita o con costo minimo per il debitore. Molti OCC e legali infatti accettano quei casi quasi pro bono (c’è anche un fondo di solidarietà per remunerarli). Quindi se sei davvero nullatenente, non devi temere costi insostenibili: l’ordinamento vuole aiutarti, non aggravarti. In ogni caso, durante la prima consulenza l’avvocato ti darà un quadro chiaro: diffida di chi ti dice “tutto gratis” perché un po’ di spesa c’è, ma considera che è un percorso guidato complesso (il professionista si occupa di tutta la burocrazia, redige atti, va in tribunale – cose non banali).
D: Dopo l’esdebitazione, la mia “fama creditizia” migliorerà? Potrò avere prestiti in futuro?
R: L’esdebitazione viene annotata nelle banche dati dei fallimenti e, presumibilmente, anche nelle centrali rischi private in qualche modo. Tuttavia, è meglio di un fallimento a vita ovviamente. Diciamo che per qualche anno le banche potrebbero essere caute a ridarti credito, un po’ come accade per chi ha fatto un saldo e stralcio – rimane traccia. Banca d’Italia nel 2020 ha emanato disposizioni secondo cui gli intermediari finanziari devono segnalare se un credito è stato chiuso a saldo e stralcio, e ciò incide sul rating del cliente. Analogamente, chi esce da un piano di sovraindebitamento potrebbe avere difficoltà a ottenere nuovi prestiti se quell’informazione è nota. Però considera due cose: (1) molte procedure sono riservate, i dati non diventano pubblici come un fallimento (specie per il piano del consumatore: c’è un registro ministeriale ma non accessibile a chiunque, solo a soggetti autorizzati); (2) col tempo, se tieni un comportamento finanziario virtuoso e hai redditi stabili, potrai riacquisire fiducia. In concreto, c’è un caso storico: negli USA chi esce dal Chapter 7 bankruptcy di solito dopo 2–3 anni è sommerso di offerte di credito (a tassi altini) perché paradossalmente le finanziarie sanno che non potrà più fallire per un po’ e quindi glielo danno. In Italia non c’è tanta “cultura del fresh start” ancora, ma potrebbe evolvere. In ogni caso, l’approccio giusto è: prima liberarsi dei debiti insostenibili, poi ricostruire gradualmente reputazione creditizia senza ricadere in errori. Un avvocato e magari un consulente finanziario possono consigliarti su come gestire il post-esdebitazione (es. evitare di chiedere subito un mutuo milionario… meglio iniziare con piccoli crediti e ripagarli puntuale per ricostruire lo storico positivo).
D: A chi mi devo rivolgere per avviare queste procedure?
R: Puoi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) della tua zona – ce ne sono presso i tribunali, gli ordini dei commercialisti o avvocati, le camere di commercio. Lì troverai dei gestori esperti. È caldamente consigliato però anche avere un avvocato di fiducia tuo, specializzato in diritto fallimentare/sovraindebitamento, che lavori di concerto con l’OCC. Spesso gli OCC stessi ti diranno di nominare un legale. Alcuni OCC integrano la figura legale nel team, ma è bene che tu abbia un rappresentante dedicato per tutelare i tuoi interessi in giudizio e redigere il ricorso. Molti avvocati fanno squadra con commercialisti per offrire il servizio completo. In sintesi: primo passo potresti andare a una consulenza gratuita (molti la offrono) con uno studio legale specializzato o con l’OCC locale per capire fattibilità. Evita invece le società “ripiana debiti” improvvisate non abilitate – rivolgiti sempre a professionisti iscritti agli albi (avvocati, commercialisti) o agli OCC riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
D: Se sono un imprenditore “grande” (sopra soglia fallibilità) cosa posso fare per ridurre i debiti?
R: In tal caso non rientri nel campo del sovraindebitamento, ma hai altri strumenti: il concordato preventivo (giudiziale, simile al concordato minore ma per aziende medio-grandi) dove proponi ad esempio di pagare i chirografari a una certa percentuale; gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex art. 182-bis LF) che sono accordi privatistici con almeno il 60% dei creditori omologati dal tribunale e vincolanti; i piani attestati di risanamento (accordi non omologati pubblicati in registro, efficaci se tutti aderenti); e come detto la composizione negoziata introdotta di recente per trattare fuori dalle aule con una protezione minima. Per i debiti fiscali delle imprese maggiori c’è la transazione fiscale (art. 63 CCII) come parte del concordato o accordo, in cui l’Erario può acconsentire a stralci. Inoltre, la legge fallimentare e il CCII prevedono strumenti di esdebitazione del socio o dell’imprenditore individuale dopo la chiusura del fallimento (art. 278 CCII) – ora automatica dopo 3 anni. Quindi un “grande” imprenditore, se proprio l’azienda non è salvabile, può passare dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento) e ottenere poi l’esdebitazione personale. Se invece l’azienda può risorgere pagando parzialmente i debiti, il concordato preventivo in continuità è la via: cedi parte del business ai creditori, paghi in percentuale per liberare il resto. Sono procedure complesse che richiedono piani industriali, attestazioni di esperti e votazioni in adunanza, quindi sicuramente qui la figura del avvocato d’impresa affiancato da consulenti finanziari è imprescindibile. In questa guida ci siamo focalizzati su privati e piccole imprese, ma la filosofia è simile anche per le grandi: l’ordinamento oggi consente di ristrutturare il debito per ripartire, se c’è buona fede e uno going concern (una prospettiva di continuità) da salvaguardare.
D: Dopo aver risolto i debiti, come evitare di ritrovarsi in futuro nella stessa situazione?
R: Questa è forse la domanda più importante, al di là del diritto. Le procedure di sovraindebitamento esistono proprio per dare una seconda opportunità, ma implicitamente il legislatore si aspetta che il debitore ne faccia tesoro. Quindi, una volta libero dai debiti, è fondamentale adottare un approccio finanziario prudente: preparare un budget familiare, mettere da parte risparmi per le emergenze, evitare di ricorrere facilmente al credito al consumo, e se si è imprenditori, pianificare gli investimenti con attenzione e non accumulare passività fiscali. Spesso, durante la procedura, il debitore segue anche un percorso di educazione finanziaria forzata – ad esempio, deve confrontarsi con la realtà delle proprie entrate e uscite per convincere il giudice del piano. Questo processo è salutare: suggeriamo di mantenere quell’abitudine di monitorare i conti anche dopo. Molti OCC, al termine, danno consigli di counseling al debitore su come non ricadere (è interesse di tutti, anche del sistema bancario – tanto che vi sono progetti di microcredito sorvegliato per ex sovraindebitati). In sostanza: la legge ti toglie il macigno dei debiti passati, ma la scelta di non accumularne di nuovi sta a te. Se per causa di forza maggiore dovesse capitare di nuovo, tecnicamente la legge prevede che potrai riaccedere alle procedure solo trascorsi almeno 4 anni e non per più di una volta (l’esdebitazione incapiente, ad esempio, è concessa solo una volta nella vita). Quindi considerala davvero una nuova vita finanziaria da vivere con più consapevolezza.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo due tabelle riassuntive per avere un colpo d’occhio sulle varie soluzioni e relative caratteristiche.
Tabella 1 – Confronto tra gli strumenti per la riduzione dei debiti (giudiziali e stragiudiziali)
| Strumento | Chi può usarlo | Riduzione ottenibile | Coinvolgimento del Tribunale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio extragiudiziale | Debitori di qualsiasi tipo con singoli creditori disposti a trattare (privati o aziende). | Variabile, tipicamente pagamento del 20%–80% del debito (in casi estremi <10%). | No (accordo privato) | Richiede liquidità immediata per convincere il creditore. Il residuo stralciato è fiscalmente imponibile come sopravvenienza per l’azienda (non per privato insolvente). Attenzione a far rinunciare espressamente al restante. |
| Piano del consumatore (artt. 67–73 CCII) | Persona fisica consumatore (no debiti d’impresa) meritevole. | Decurtazione decisa dal giudice caso per caso; spesso <50%. Possibili dilazioni lunghe. | Sì (omologa dal Tribunale, senza voto creditori) | Copre tutti i debiti (tranne quelli esclusi ex lege) . Creditori non votano ma possono opporsi. Requisiti stringenti su meritevolezza e sostenibilità. |
| Concordato minore (artt. 74–83 CCII) | Debitore non consumatore sovraindebitato (piccolo imprenditore, ex imprenditore sotto soglia, professionista). | Decurtazione proposta dal debitore ma soggetta a voto creditori: in pratica dipende dalle negoziazioni e classi. | Sì (omologa dal Tribunale dopo voto creditori) | Richiede maggioranza ≥50% crediti votanti. Possibile continuità aziendale o liquidazione parziale. Anche qui esclusi debiti “non falcidiabili” (alimenti, danni, ecc.). |
| Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII) | Qualunque debitore non fallibile insolvente (consumatore o no); anche coattiva su istanza creditori in alcuni casi. | Non una “percentuale” definita: i creditori ricevono il ricavato della vendita dei beni. Spesso percentuale bassa (dipende dall’attivo). | Sì (Tribunale apre procedura, nomina liquidatore) | Il debitore perde i beni, ma ottiene l’esdebitazione dei debiti residui a fine procedura. Durata max contribuzione 4 anni. Procedura simile a un fallimento ma in scala ridotta. |
| Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) | Persona fisica nullatenente e senza reddito, meritevole, una volta sola. | 100% di stralcio (cancella tutti i debiti senza pagamento). | Sì (Tribunale emette decreto di esdebitazione) | Misura straordinaria “anti-suicidio”. Debitore sorvegliato 4 anni per eventuali sopravvenienze da segnalare. Debiti da alimenti, risarcimenti e sanzioni esclusi dal beneficio . |
| Rottamazione cartelle (“Definizione agevolata”) | Qualsiasi debitore con cartelle esattoriali rientranti nella finestra prevista (es. “quater” per carichi 2000-2022). | Azzeramento sanzioni e interessi di mora/aggi. In pratica risparmio medio 20–40%. | No (procedura amministrativa con AdER) | Richiede istanza entro termini di legge (es. 30/6/2023 per quater). Pagamento in unica soluzione o max 18 rate fino 5 anni. Decadenza se salto 5 giorni scadenza rata. Non impatta debiti non a ruolo. |
| Stralcio automatico ≤ €1000 (L.197/2022) | Debiti iscritti a ruolo ≤ €1000 dal 2000–2015. | Automatico: cancella interessi e sanzioni su enti locali, e intero importo su enti statali. | No (attuato d’ufficio da Agente Riscossione) | Attuato al 31/3/2023 pror. 30/4/2023. Enti locali potevano non aderire parziale o estendere integrale. Nessun effetto su debiti > €1000 né su debiti recenti post-2015. |
| Accordo stragiudiziale plurilaterale | Debitore con molti creditori disposti tutti a sottoscrivere accordo. | Variabile: concordato privatamente. Può replicare effetti di un concordato senza tribunale. | No (se tutti aderiscono, è contratto) | Rischioso: basta un dissenziente per far fallire. Nessuna protezione legale durante trattative (creditore può agire comunque). Consigliabile solo se pochi creditori e rapporti fiduciali. |
Tabella 2 – Principali differenze tra Piano del Consumatore e Concordato Minore
| Piano del consumatore | Concordato minore | |
|---|---|---|
| Soggetti ammessi | Consumatori (persone fisiche, debiti non d’impresa). | Debitori non fallibili non consumatori: es. piccoli imprenditori, professionisti, soggetti con debiti d’impresa. |
| Voto dei creditori | No voto. Decisione rimessa al giudice (creditori possono solo fare osservazioni/opposizioni). | Sì, voto richiesto. Serve maggioranza (>=50% crediti votanti) per approvazione. Dissentienti comunque vincolati se omologa. |
| Ruolo del Tribunale | Verifica requisiti, convoca udienza di omologa. Giudica meritevolezza e convenienza rispetto a liquidazione. Se ok, omologa imponendo il piano a tutti. | Verifica forma, indice adunanza dei creditori, controlla esito voto. Omologa se maggioranza c’è e piano rispetta legge (anche cram-down Fisco possibile). |
| Falcidiabilità debiti | Anche crediti privilegiati e fiscali falcidiabili/dilazionabili, ma con limiti (IVA/ritenute da pagare salvo incapienza). Nessun pagamento minimo per chirografari (decide giudice caso per caso). | Idem, con in più la dinamica del voto: la proposta deve essere appetibile per ottenere consenso. Possibilità classi con trattamenti diversi. Limite IVA/ritenute e best interest test si applicano comunque. |
| Coinvolgimento garanti/coobbligati | Non include garanti estranei; essi restano obbligati per quota non pagata. (Possibile procedura familiare se coobbligato convivente). | Uguale: il concordato vincola solo i debitori aderenti. Soci garanti non inclusi restano esposti (ma spesso soci di SNC partecipano contestualmente). |
| Esdebitazione finale | Al termine del piano eseguito, cancellazione debiti residui automatica. Se il piano fallisce (risoluzione), niente esdebitazione. | Esdebitazione per il debitore persona fisica dopo esecuzione del concordato (o dopo 3 anni dall’omologa). Se concordato risolto per inadempimento, niente esdebitazione salvo eventuale conversione in liquidazione. |
| Vantaggi | – Nessun bisogno di convincere i creditori (utile se molti dissenzienti).<br>– Protezione ampia appena ammesso: sospende pignoramenti.<br>– Ideale per soggetti con entrate costanti ma debito eccessivo.<br>– Consente salvaguardia dei beni essenziali se piano sostenibile. | – Coinvolge attivamente i creditori: maggiore buy-in (accordo consensuale).<br>– Può prevedere continuazione attività d’impresa (salva azienda).<br>– Flessibile (classi, vari strumenti anche societari).<br>– Include anche debiti professionali/commerciali altrimenti non trattabili in piano consumatore. |
| Svantaggi | – Criteri di ammissione severi (escluso se anche minimi profili imprenditoriali) .<br>– Rischio opposizione creditori: se giudice rigetta omologa, niente piano (no voto per riprovarci).<br>– Necessita meritevolezza alta (ogni comportamento discutibile può far saltare). | – Procedura più lunga e complessa (tempi per voto, maggioranze da raggiungere).<br>– Richiede negoziazione con creditori chiave prima della votazione (effort maggiore).<br>– Non adatto a consumatori (che non possono farlo).<br>– Se pochi creditori e uno grande non concorda, può bloccare tutto col voto (salvo cram-down fiscale). |
Conclusioni
Affrontare una situazione di debiti fuori controllo è un’esperienza angosciante, ma la legislazione italiana odierna offre una gamma di strumenti concreti per ottenere sollievo e uscire dall’impasse. Abbiamo visto che, con l’aiuto di un avvocato specializzato, un debitore può ridurre drasticamente il proprio carico debitorio: sia persuadendo i creditori a accettare meno tramite trattative di saldo e stralcio, sia ricorrendo alle procedure di sovraindebitamento che portano a piani sostenibili o perfino alla cancellazione integrale dei debiti (nei casi estremi meritevoli). Le sentenze più recenti confermano un orientamento di favore verso il debitore onesto: la Cassazione ribadisce che l’obiettivo è il fresh start, evitando interpretazioni punitive. Ciò significa che i tribunali – pur vigilando contro abusi – cercano soluzioni per omologare piani fattibili e concedere esdebitazioni quando la legge lo consente, anche superando l’eventuale opposizione di creditori pubblici che si mostrassero irragionevoli.
Dal lato pratico, il debitore deve fare la sua parte: affrontare il problema per tempo, affidarsi a professionisti seri e preparati, collaborare pienamente fornendo tutte le informazioni e documenti, e mantenere un atteggiamento trasparente e proattivo. In cambio, il sistema gli mette a disposizione un vero “percorso di riabilitazione” economica. L’avvocato esperto fungerà da guida: dapprima valuterà con lucidità la posizione debitoria (spesso chi è sommerso dai debiti fatica ad avere una visione d’insieme chiara), poi indicherà la strategia ottimale – magari iniziando con misure extragiudiziali immediate (bloccare azioni esecutive, negoziare proroghe) e contestualmente preparando il terreno per la procedura in tribunale o l’accordo complessivo. Essenziale è la preparazione tecnica: come abbiamo visto, è un ambito dove il dettaglio normativo (un comma di legge, una massima di Cassazione) può fare la differenza tra un’obiezione accolta o rigettata, tra un piano omologato o respinto.
In particolare, le novità del Codice della Crisi 2019-2024 hanno rafforzato le chance del debitore: introduzione delle procedure familiari, abbassamento delle maggioranze, esdebitazione più veloce e persino la possibilità di esdebitazione “a zero”. Queste innovazioni, accompagnate dalle pronunce chiarificatrici (es. Cass. 22699/2023 sul consumatore, Cass. 576/2024 sulla moratoria, Cass. 24870/2024 sui rimedi impugnatori), delineano un contesto in cui “fallire onestamente conviene”, nel senso che l’ordinamento preferisce vedere un debitore liberato e reinserito nell’economia piuttosto che un individuo condannato a vita dai debiti.
Va sottolineato che ogni caso è a sé: questa guida ha fornito linee generali e approfondimenti, ma la soluzione va sempre personalizzata. Un avvocato dovrà calibrare la proposta di piano sulle capacità reali del cliente (né troppo ottimista – che poi sarebbe irrealizzabile – né troppo pessimista – che penalizzerebbe inutilmente il cliente). Allo stesso tempo, l’avvocato farà da scudo contro pressioni indebite: una volta avviata la procedura o trattativa, i creditori non potranno più perseguitare individualmente il debitore, dovranno parlare con il suo legale o attendere la decisione del giudice. Questo da solo spesso ridona serenità mentale a chi magari riceveva telefonate minacciose quotidiane.
In conclusione, se vi trovate in una condizione di sovraindebitamento – che siate un privato oberato da prestiti o un piccolo imprenditore oppresso dai debiti – non disperate e non nascondete la testa sotto la sabbia. Oggi esiste un arsenale di soluzioni legali a vostra tutela. Rivolgetevi con fiducia a un professionista competente, analizzate insieme le opzioni (da un piano fattibile con rate sostenibili a, se necessario, la liquidazione con esdebitazione). Ricordate il principio fondante: la legge italiana “concede una nuova opportunità” al debitore sommerso , non vuole distruggerlo. Con l’assistenza giusta, l’incubo dei debiti può trasformarsi in un percorso di ristrutturazione e rinascita economica. L’avvocato può “ridurvi i debiti” – nei limiti consentiti – e soprattutto può restituirvi la libertà da quell’angoscia, permettendovi di tornare a pianificare il futuro senza catene finanziarie.
Fonti e riferimenti normativi (aggiornate a ottobre 2025):
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Titolo IV, artt. 65-83 CCII: Composizione delle crisi da sovraindebitamento; artt. 268-277: Liquidazione controllata; art. 283: Esdebitazione del debitore incapiente). Correttivi: D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 (attuazione Dir. UE 2019/1023), D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo Ter”).
- Legge 3/2012 (abrogata dal 15/7/2022 ma rilevante per precedenti) – Disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) – art. 1 commi 222-252: “Stralcio” automatico debiti fino €1.000 (2000-2015); Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) carichi 2000-30/6/2022.
- Decreto Legge 51/2023 conv. L. 87/2023 – modifiche a rateizzazioni esattoriali (innalzamento soglia automatica €120.000, flessibilità piani dal 2025).
- Cassazione Civile Sez. I, 26 luglio 2023 n. 22699 – Nozione di consumatore e debiti misti: conferma che debiti d’impresa pregressi escludono accesso al piano consumatore; ex imprenditore cancellato non ammesso a concordato minore (rinvio 363-bis inammissibile) .
- Cass. Civ. Sez. I, 15 settembre 2023 n. 22699 (decr. Prima Pres.) – v. sopra, ordinanza di rimessione Firenze.
- Cass. Civ. Sez. I, 12 gennaio 2024 n. 576 – Meritevolezza e dilazioni nel piano del consumatore: dilazioni lunghe ok se trasparenti; creditori non possono opporsi solo per scarsa convenienza (giudice valuta). Conferma moratoria fino 2 anni per privilegiati: basta iniziare a pagare entro 24 mesi, non finire.
- Cass. Civ. Sez. I, 13 giugno 2024 n. 24870 – Impugnazioni nel sovraindebitamento: decreto inammissibilità iniziale reclamabile al Tribunale collegiale; decreto di diniego omologa appellabile in Corte d’Appello.
- Cass. Civ. Sez. Un. 31 marzo 2020 n. 8053 – Meritevolezza: interpretazione non troppo rigorosa, non punire semplice imprudenza (richiama SU 19427/2019).
- Cass. Civ. Sez. I, 17 gennaio 2020 n. 742 – Fideiussore consumatore: garante persona fisica estraneo attività d’impresa può accedere come consumatore.
- Cass. Civ. Sez. I, 20 febbraio 2020 n. 4329 – Ex imprenditore cancellato: non ammesso a concordato (preventivo o minore) dopo cessazione attività .
- Cass. Civ. Sez. I, 11 ottobre 2016 n. 1869 – Definizione consumatore & meritevolezza: qualifica in base a natura obbligazioni all’origine ; meritevolezza: frode/colpa grave come esclusione, non semplice squilibrio finanziario.
- Cass. Civ. Sez. Un. 22 febbraio 2013 n. 24418 – Anatocismo bancario: conferma nullità capitalizzazione interessi trimestrali ante 2000; decorrenza prescrizione da chiusura conto.
- Cass. Civ. Sez. Un. 19 ottobre 2021 n. 41994 – Fideiussioni nulle antitrust: schema ABI 2003 anticoncorrenziale, nullità parziale clausole (libera garanti).
- Cass. Civ. Sez. Un. 13 novembre 2017 n. 24675 – Usura sopravvenuta: interessi moratori rilevano per usura, computo nel TEG, ecc. (indicazioni per cause usura bancaria).
- Circolare Banca d’Italia n.139/1991 e Provvedimento B.I. 19/6/2020 – disposizioni segnalazioni Centrale Rischi e CRIF in caso di accordi a saldo e stralcio (trasparenza verso sistema creditizio).
- Legge n. 108/1996 – Disciplina antiusura: tassi soglia trimestrali, nullità interessi usurari (art. 1815 c.c. co.2).
- D.P.R. 602/1973 art. 76 – Impignorabilità prima casa: espropriazione esattoriale immobiliare preclusa per unico immobile di residenza non di lusso, debito < €120k.
- Codice Civile art. 2740 (patrimonio garante debiti) e 2744 (divieto patto commissorio) – principi generali rilevanti in negoziazioni (es. no accordi automatici su beni).
- Direttiva UE 2019/1023 – Insolvency Directive (recepita dal D.Lgs. 83/2022): introduce tra l’altro esdebitazione entro 3 anni per imprenditore onesto, moratorie creditori privilegiati fino 2 anni, ecc. Principi integrati nel CCII.
- Relazioni ministeriali e linee guida: Relazione illustrativa D.Lgs. 14/2019; Linee guida CNDCEC su sovraindebitamento (2019); Linee guida OCC (varie) – per prassi applicative.
- Fonti istituzionali: Portale Ministero Giustizia sovraindebitamento; Portale Agenzia Entrate-Riscossione (FAQ Definizione 2023); Relazioni annuali OCC (es. ODCEC Roma 2023).
Hai troppi debiti con banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate e non riesci più a pagarli? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai troppi debiti con banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate e non riesci più a pagarli?
👉 Non disperare: oggi la legge ti permette di ridurre o cancellare legalmente i debiti, anche se sono elevati, e di bloccare pignoramenti, cartelle e interessi.
In questa guida scoprirai come un avvocato esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento può aiutarti a ridurre i debiti, salvare la casa e tornare a vivere sereno.
💥 Quando i Debiti Diventano Insostenibili
I segnali più comuni di una crisi da sovraindebitamento sono chiari:
- non riesci più a pagare rate, mutui o prestiti;
- hai ricevuto cartelle esattoriali o pignoramenti;
- il conto è bloccato dall’Agenzia delle Entrate o dalla banca;
- i creditori ti chiamano o scrivono continuamente;
- vivi nell’ansia di perdere tutto.
📌 Se ti riconosci in una di queste situazioni, non è troppo tardi: la legge ti offre strumenti per fermare le azioni esecutive e ridurre drasticamente i debiti.
⚖️ La Soluzione: la Legge sul Sovraindebitamento
La Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), permette a privati, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili di:
- bloccare i pignoramenti e le cartelle esattoriali;
- sospendere gli interessi e le sanzioni;
- pagare solo una parte del debito con un piano approvato dal Tribunale;
- ottenere la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).
📌 È una legge pensata proprio per chi ha perso il controllo delle proprie finanze ma vuole ripartire in modo onesto e sostenibile.
💠 Chi Può Usare la Legge per Ridurre i Debiti
Possono accedere alle procedure di riduzione o cancellazione dei debiti:
- Famiglie e privati cittadini con debiti verso banche, finanziarie o Fisco;
- Lavoratori autonomi o professionisti in difficoltà economica;
- Piccole imprese e ditte individuali non fallibili;
- Società cessate o inattive che non riescono più a far fronte ai debiti.
📌 Anche chi ha già subito pignoramenti, fermi o iscrizioni ipotecarie può richiedere la sospensione e l’apertura della procedura di composizione della crisi.
⚠️ Cosa Succede Dopo la Domanda
Una volta presentata la richiesta di composizione della crisi, il Tribunale può:
- sospendere tutti i pignoramenti e le azioni dei creditori;
- nominare un gestore della crisi che valuta la tua situazione;
- approvare un piano di ristrutturazione o liquidazione dei debiti;
- liberarti completamente dai debiti residui con la sentenza di esdebitazione.
📌 In molti casi, chi aveva centinaia di migliaia di euro di debiti ha pagato solo una piccola parte o addirittura nulla, grazie al piano approvato dal giudice.
🧩 Le Soluzioni Possibili per Ridurre i Debiti
1️⃣ Piano del Consumatore
Rivolto a privati e famiglie.
Permette di rimborsare solo in parte i debiti con rate sostenibili, bloccando interessi e azioni esecutive.
2️⃣ Accordo di Ristrutturazione
Riservato a imprenditori e professionisti.
Si basa su un accordo con i creditori e sull’approvazione del giudice.
📌 Una volta omologato, tutti i creditori devono rispettarlo.
3️⃣ Liquidazione Controllata (ex liquidazione del patrimonio)
Permette di vendere i beni disponibili per saldare i debiti e ottenere l’esdebitazione totale.
Ideale per chi vuole chiudere tutto e ripartire da zero.
💰 Esempi Reali di Riduzione dei Debiti
- Un imprenditore con 250.000 € di debiti ha ottenuto la riduzione al 20%.
- Una famiglia con mutuo, finanziamenti e cartelle ha sospeso i pignoramenti e pagato solo una quota minima.
- Un libero professionista ha azzerato i debiti residui dopo la liquidazione.
📌 Tutto questo è possibile solo con l’intervento di un avvocato specializzato, che presenta e gestisce la procedura davanti al Tribunale.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Elenco completo dei debiti e dei creditori;
- Cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi o precetti;
- Estratti conto bancari e finanziari;
- Contratti di prestito, mutui e leasing;
- Documenti sul reddito e sul patrimonio (buste paga, visure, immobili).
📌 Servono per ricostruire la situazione economica e individuare la strategia di difesa più efficace.
⏱️ Tempi della Procedura
- Richiesta e analisi dei documenti: 30 giorni circa;
- Nomina del gestore e deposito del piano: 1–3 mesi;
- Omologazione e sospensione dei pignoramenti: 60 giorni;
- Esdebitazione finale: 6–12 mesi, a seconda del Tribunale.
📌 Durante la procedura, nessun creditore può più agire contro di te.
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✅ Blocco immediato di pignoramenti e cartelle.
✅ Riduzione o cancellazione dei debiti fino al 90–100%.
✅ Protezione della casa e del reddito familiare.
✅ Recupero della serenità e della stabilità economica.
✅ Possibilità di ripartire da zero in modo legale.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare cartelle, precetti o pignoramenti.
❌ Accendere nuovi prestiti per coprire debiti vecchi.
❌ Firmare accordi senza assistenza legale.
❌ Aspettare troppo: dopo certe azioni esecutive, la procedura diventa più complessa.
📌 La chiave è agire subito: prima intervieni, più possibilità hai di salvare il tuo patrimonio e ridurre i debiti.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione economica e verifica i requisiti per la procedura.
📌 Ti assiste nella raccolta dei documenti e nella redazione del piano di rientro.
✍️ Predispone e deposita la richiesta di composizione della crisi al Tribunale.
⚖️ Ti rappresenta davanti al giudice e coordina il gestore della procedura.
🔁 Ti segue fino all’omologazione e alla definitiva cancellazione dei debiti.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto bancario, tributario e crisi da sovraindebitamento.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Specializzato nella riduzione e cancellazione legale dei debiti.
✔️ Esperienza pluriennale nella difesa di privati, famiglie e imprenditori contro banche, finanziarie e Fisco.
Conclusione
Essere pieni di debiti non significa essere senza via d’uscita.
Con l’aiuto di un avvocato specializzato puoi bloccare le azioni dei creditori, ridurre drasticamente le somme dovute e liberarti dai debiti in modo definitivo.
⏱️ Ogni giorno conta: agisci subito, prima che la situazione peggiori.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova vita senza debiti può cominciare oggi stesso.