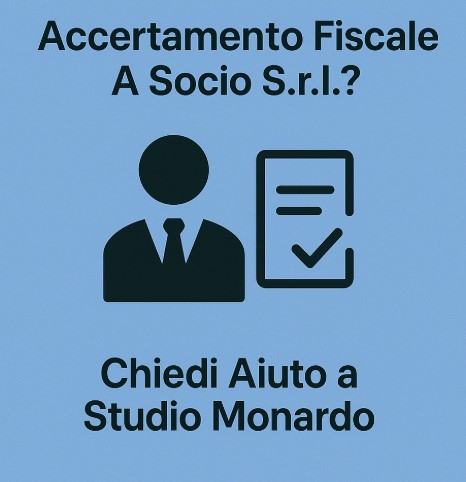Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale come socio di una S.r.l.? Si tratta di una delle situazioni più delicate nel diritto tributario, perché l’Agenzia delle Entrate può ritenere che il socio abbia percepito redditi non dichiarati o beneficiato di utili occulti distribuiti dalla società.
In pratica, il Fisco tenta di “estendere” l’accertamento effettuato sulla società anche ai soci, sostenendo che i maggiori redditi accertati alla S.r.l. siano stati incassati personalmente dai titolari delle quote. Tuttavia, questa presunzione non è automatica: l’Agenzia deve dimostrare con prove concrete che quei redditi siano stati effettivamente percepiti dai soci.
Con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in accertamenti societari, puoi bloccare la riscossione, impugnare l’avviso e difenderti da accertamenti ingiusti o infondati.
Cos’è l’accertamento fiscale al socio di S.r.l.
L’accertamento al socio è una conseguenza diretta di un controllo fiscale svolto sulla società. Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che una S.r.l. ha dichiarato meno redditi del dovuto o ha occultato ricavi, può emettere un accertamento separato anche verso i soci, imputando loro una quota proporzionale dei presunti utili non dichiarati.
Questo tipo di accertamento si basa su due presupposti principali:
- che la società sia “a ristretta base partecipativa”, cioè abbia pochi soci (familiari o persone legate da rapporti di fiducia);
- che gli utili extracontabili accertati alla società siano stati distribuiti ai soci, anche se non risultano formalmente dai bilanci.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che questa è solo una presunzione, e può essere vinta dal socio con prove contrarie.
Quando scatta l’accertamento per il socio di una S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate può notificare un accertamento personale al socio quando:
- la S.r.l. è stata già sottoposta ad accertamento fiscale;
- il Fisco ritiene che la società abbia distribuito utili in nero o extracontabili;
- il socio risulta aver ricevuto bonifici, compensi o vantaggi economici non giustificati;
- vengono individuate spese personali incoerenti con il reddito dichiarato;
- la società ha una ristretta base sociale e non risulta alcuna delibera di accantonamento o reinvestimento degli utili.
In questi casi, il Fisco presume che i maggiori redditi della società siano finiti nelle mani dei soci, anche senza prove dirette.
Come funziona la procedura di accertamento fiscale al socio
- Accertamento principale alla società: l’Agenzia accerta maggiori redditi o utili extracontabili della S.r.l.
- Estensione ai soci: sulla base di quei risultati, emette un secondo accertamento nei confronti dei soci, in proporzione alle loro quote.
- Invito al contraddittorio: il socio può essere convocato per fornire chiarimenti o dimostrare che non ha percepito alcun utile.
- Emissione dell’avviso di accertamento personale: se le spiegazioni non vengono accettate, viene notificato l’atto con l’imposta IRPEF, sanzioni e interessi.
- Ricorso entro 60 giorni: il socio può impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, chiedendo anche la sospensione della riscossione.
Quando l’accertamento al socio è legittimo
L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento verso il socio solo se:
- esiste un accertamento definitivo sulla società, non più contestabile;
- viene dimostrato che i maggiori utili societari sono stati effettivamente distribuiti;
- l’avviso è motivato in modo chiaro e specifico, spiegando come si collega alla posizione del socio;
- è stato rispettato il contraddittorio preventivo;
- non si basa su presunzioni generiche o automatiche.
In mancanza di queste condizioni, l’accertamento è illegittimo e impugnabile.
Quando l’accertamento al socio è nullo o impugnabile
Puoi impugnare l’accertamento se presenta:
- mancanza di motivazione autonoma, cioè se l’Agenzia copia l’accertamento della società senza analizzare la tua posizione personale;
- assenza di prove concrete della percezione di utili;
- violazione del contraddittorio;
- utilizzo di presunzioni non gravi, precise e concordanti;
- notifica irregolare o tardiva;
- assenza di accertamento definitivo sulla società.
La Cassazione ha stabilito che l’accertamento nei confronti del socio non può essere automatico e deve fondarsi su riscontri effettivi di incasso o distribuzione di utili.
Le conseguenze di un accertamento al socio
Un accertamento fiscale personale può comportare:
- maggiori imposte IRPEF da versare;
- sanzioni fino al 240% dell’imposta accertata;
- interessi e iscrizione a ruolo;
- cartelle esattoriali, pignoramenti e fermi amministrativi;
- possibili controlli bancari o patrimoniali personali.
Agire subito è fondamentale per evitare che l’accertamento diventi definitivo e bloccare la riscossione.
Come difendersi da un accertamento come socio di S.r.l.
Un avvocato tributarista può predisporre una difesa tecnica efficace basata su:
- verifica della legittimità della procedura (contraddittorio, motivazione, termini);
- analisi dei rapporti societari per dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti;
- produzione di prove contrarie, come verbali di assemblea, bilanci, reinvestimenti o versamenti dei soci;
- contestazione delle presunzioni dell’Agenzia, dimostrando che non c’è stato arricchimento personale;
- richiesta di sospensione cautelare della riscossione per evitare cartelle e pignoramenti.
Le strategie difensive più efficaci
- Dimostrare che i maggiori utili della società non sono stati distribuiti ma reinvestiti;
- Evidenziare che la S.r.l. ha deliberato perdite o riserve, non utili;
- Contestare la violazione del contraddittorio preventivo;
- Dimostrare che non esiste un accertamento definitivo sulla società;
- Produrre bilanci, verbali e documenti contabili che provano la tua estraneità ai redditi contestati;
- Invocare la giurisprudenza della Cassazione, che tutela il socio da presunzioni generiche.
Come scegliere l’avvocato giusto per difendersi
Affrontare un accertamento come socio di una S.r.l. richiede un avvocato con:
- specializzazione in diritto tributario e contenzioso fiscale societario;
- esperienza diretta in accertamenti contro soci e imprese a ristretta base;
- collaborazione con commercialisti e revisori contabili;
- conoscenza delle dinamiche societarie e della giurisprudenza fiscale;
- capacità di impugnare sia l’accertamento personale che quello societario collegato.
Un avvocato esperto può bloccare la riscossione, ridurre le somme accertate e far annullare l’avviso, dimostrando l’assenza di utili effettivamente percepiti.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un accertamento fiscale comporta:
- iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali esecutive;
- pignoramenti, fermi e ipoteche personali;
- danno economico diretto, anche se non hai percepito alcun utile;
- perdita definitiva del diritto di ricorso dopo 60 giorni.
Difenderti tempestivamente è l’unico modo per evitare che un accertamento infondato diventi definitivo e ti travolga con sanzioni e interessi.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta un avvocato se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale personale come socio di S.r.l.;
- la società è stata sottoposta a controllo e temi ripercussioni personali;
- vuoi dimostrare di non aver percepito utili o somme extracontabili;
- devi sospendere la riscossione o presentare ricorso.
Un avvocato tributarista può:
- impugnare l’avviso e richiedere la sospensione cautelare;
- dimostrare l’assenza di redditi effettivi;
- ottenere la riduzione o l’annullamento dell’accertamento;
- tutelarti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione.
⚠️ Attenzione: l’Agenzia delle Entrate non può tassare automaticamente i soci solo perché la società ha ricevuto un accertamento. Serve una prova concreta di percezione del reddito. Agisci subito con l’aiuto di un avvocato esperto: puoi bloccare la riscossione, impugnare l’atto e difenderti da un’accusa fiscale ingiusta.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e difesa di soci e imprese contro accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – spiega cos’è l’accertamento fiscale ai soci, quando è illegittimo e come difendersi efficacemente con l’assistenza di un avvocato specializzato.
👉 Hai ricevuto un accertamento fiscale personale come socio di S.r.l.?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’atto e costruiremo una strategia legale per impugnare l’accertamento, sospendere la riscossione e proteggere i tuoi diritti fiscali e patrimoniali.
Introduzione
Quando il Fisco contesta utili non dichiarati a una società a responsabilità limitata (S.r.l.) di piccole dimensioni, spesso estende l’accertamento fiscale anche ai suoi soci. In altre parole, se l’Agenzia delle Entrate scopre che la S.r.l. ha realizzato profitti “in nero” non risultanti dalla contabilità ufficiale, presume che tali somme siano state distribuite ai soci e tassa direttamente questi ultimi sul reddito non dichiarato. Si tratta di una procedura insidiosa per il contribuente, che può trovarsi improvvisamente destinatario di un avviso di accertamento personale pur non avendo materialmente percepito gli utili contestati.
Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, fornisce un’analisi avanzata dell’argomento dal punto di vista del debitore d’imposta (il socio contribuente). È rivolta sia a professionisti legali e fiscali (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) sia a imprenditori e privati soci di S.r.l., offrendo un linguaggio giuridico accurato ma al contempo divulgativo e ricco di esempi pratici. Verranno esaminate le normative italiane di riferimento e le più recenti sentenze in materia (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale), con indicazione delle strategie difensive efficaci da adottare subito per tutelarsi. Troverai inoltre tabelle riepilogative, una sezione di Domande & Risposte frequenti, e alcune simulazioni pratiche (casi di studio realistici con scenari di accertamento e relative difese).
Obiettivo: mettere il socio interessato in condizione di capire come reagire prontamente e al meglio a un accertamento fiscale derivante da utili extracontabili presunti, sfruttando tutti gli strumenti a disposizione (dal contraddittorio anticipato, all’adesione, fino al ricorso in giudizio). Seguendo un approccio strutturato, partiremo dalle nozioni generali, poi esamineremo il meccanismo dell’accertamento in capo ai soci di S.r.l., quindi illustreremo le possibili strategie difensive, senza trascurare i profili sanzionatori (amministrativi e penali) e le ultime novità normative fino al 2025.
Concetti generali e definizioni chiave
Per affrontare con cognizione di causa il tema dell’accertamento fiscale ai soci, è utile chiarire preliminarmente alcuni concetti fondamentali del diritto tributario italiano:
- Utili extracontabili (utili “in nero”) – Sono i profitti effettivamente conseguiti da un’attività economica ma non risultanti dalle scritture contabili ufficiali e non dichiarati al Fisco. Tipicamente derivano da ricavi occultati (vendite non fatturate o sottofatturate) oppure da costi fittizi o gonfiati inseriti in contabilità per ridurre artificiosamente l’utile. In sostanza, rappresentano la parte di utile aziendale che viene nascosta al Fisco, creando un disallineamento tra il reddito reale e quello dichiarato.
- Accertamento fiscale – È il procedimento attraverso cui l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) determina un maggiore reddito imponibile o maggiori imposte dovute da un contribuente rispetto a quanto da lui dichiarato. Può avvenire con vari metodi:
- Accertamento “analitico” (ordinario): si basa sui dati contabili del contribuente, rettificando singole poste ritenute irregolari (es. costi indeducibili) sulla base di prove dirette.
- Accertamento induttivo: ricostruisce il reddito in modo indiretto, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture, quando queste risultano inattendibili o incomplete. Si fonda su indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, anziché su documenti contabili. L’accertamento analitico-induttivo avviene se la contabilità esiste ma presenta irregolarità parziali; l’accertamento induttivo “puro” (art. 39, c.2 DPR 600/1973) avviene invece se manca del tutto una contabilità affidabile o vi sono gravi falsificazioni, consentendo al Fisco di ignorare i libri e basarsi solo su dati e coefficienti presuntivi. In tema di utili non contabilizzati, l’accertamento è per sua natura induttivo, perché il Fisco deduce** l’esistenza di ricavi/utile non dichiarati da segni indiretti (movimenti bancari anomali, incongruenze nei margini, ecc.).
- Accertamento sintetico del reddito (il c.d. “redditometro”): è un metodo di accertamento induttivo applicabile alle persone fisiche (IRPEF), disciplinato dall’art. 38 DPR 600/1973. Consente di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente in base alle spese sostenute (di qualsiasi genere) e agli incrementi patrimoniali, anziché basarsi sulle risultanze analitiche. In pratica, se il tenore di vita e le uscite di una persona risultano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, l’ufficio può presumere un reddito maggiore. Attualmente la legge prevede un doppio requisito per procedere in tal senso: il reddito accertato deve superare di almeno il 20% quello dichiarato e, in valore assoluto, deve eccedere di almeno 10 volte l’importo dell’assegno sociale annuo (indicativamente ~7.000 € × 10 = 70.000 €). Questo criterio – introdotto nel 2024 – mira a concentrare il redditometro sui casi di evasione medio-grande, escludendo i contribuenti con redditi modesti. L’accertamento sintetico è per sua natura presuntivo, ma la legge garantisce al contribuente la possibilità di fornire prova contraria, ad esempio dimostrando che le spese contestate sono state finanziate con redditi esenti o risparmi accumulati negli anni precedenti (non con redditi occultati dell’anno). Nota: Il cosiddetto redditometro “vecchio stile” basato su panieri di consumi medi statistici è stato oggetto di revisioni e nel 2024 il suo utilizzo è stato sospeso in attesa di criteri aggiornati; con la riforma citata l’accertamento sintetico è stato “rilanciato” con maggiori tutele e limiti, e senza obblighi di confronto con il contribuente se non a cose fatte. Tuttavia, per annualità pregresse (fino al 2015-2016) può ancora capitare un accertamento sintetico secondo i parametri all’epoca vigenti, con invito obbligatorio al contraddittorio prima dell’emissione dell’atto (come previsto dal previgente art. 38, c.7 DPR 600/1973).
- Presunzioni fiscali – Le presunzioni sono inferenze tramite cui, da un fatto noto, si deduce un fatto ignoto. In ambito tributario se ne fa largo uso per accertare redditi non dichiarati. Si distinguono:
- Presunzioni legali: stabilite espressamente da una norma di legge. Possono essere assolute (iuris et de iure) – non ammettono prova contraria – oppure relative (iuris tantum) – il contribuente può fornire prova contraria per confutarle.
- Presunzioni semplici: non previste da norme, ma lasciate alla valutazione del giudice, il quale deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 cod. civ.). In sede di accertamento, molte ricostruzioni induttive (compresi il redditometro o la presunzione di utili ai soci) rientrano tra le presunzioni semplici, quindi confutabili dal contribuente ma solo fornendo evidenze convincenti.
Nel nostro contesto, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti è ritenuta dalla Cassazione una presunzione semplice, sebbene consolidata e “rinforzata” da costante giurisprudenza. Non esiste infatti una legge che dica esplicitamente “gli utili extra-bilancio si presumono distribuiti ai soci”, ma è un principio elaborato dai giudici tributari nel tempo. Ciò significa che i soci hanno teoricamente diritto di provare il contrario, anche se – come vedremo – l’onere della prova è a loro carico ed è particolarmente arduo. - Società a ristretta base – Con questa espressione ci si riferisce a società di capitali (tipicamente S.r.l., ma anche S.p.A. “chiuse”) con un numero ridotto di soci, spesso legati da vincoli familiari o societari, tali da costituire un gruppo di controllo unitario. Non c’è un numero fisso per definire “ristretta base”, ma usualmente si intendono compagini di 2-5 soci al massimo, in cui i soci hanno un rapporto di fiducia o parentela e partecipano in maniera rilevante alla gestione. La ristrettezza della compagine è il presupposto di fatto su cui poggia la presunzione che eventuali utili occulti non rimangano nella società, bensì vengano spartiti tra chi controlla la società stessa. Per contro, in società ad ampia base azionaria (es. decine o centinaia di soci, come nelle società quotate) tale presunzione non opera, perché sarebbe poco realistico presumere una distribuzione occulta generalizzata. Va notato che la Cassazione ha esteso l’idea di “base ristretta” anche a catene societarie: ad es. se una piccola S.r.l. ha come unico socio un’altra società, ma quest’ultima a sua volta è posseduta da poche persone, si considera la sostanza e la presunzione può risalire ai soci persone fisiche finali.
- Onere della prova – Nel diritto civile e tributario italiano vige la regola generale per cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 cod. civ.). In ambito tributario, ciò si traduce nel fatto che spetta inizialmente al Fisco provare (anche tramite presunzioni) la maggiore pretesa impositiva. Tuttavia, una volta che l’ufficio ha fornito elementi presuntivi seri (es. evidenziato incongruenze forti, movimenti finanziari ingiustificati, ecc.), la prova contraria ricade sul contribuente. Questo principio è stato ribadito nel 2022 con l’introduzione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (riforma del processo tributario): tale norma sancisce espressamente che l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo puntuale la propria pretesa, indicando le ragioni oggettive su cui si fonda, pena la nullità dell’atto. Ma una volta superata questa soglia minima di prova da parte del Fisco, l’onere di fornire spiegazioni alternative passa al contribuente. Nel caso della presunzione di utili ai soci, l’Agenzia delle Entrate si limita a provare la ristretta base societaria e l’esistenza di utili non dichiarati, dopodiché considera assolto il proprio onere; toccherà ai soci dimostrare che quegli utili non sono finiti nelle loro tasche. Questo spostamento dell’onere probatorio è ben evidenziato dalla Cassazione ad esempio in tema di finanziamenti soci: se una S.r.l. a base familiare riceve versamenti di denaro dai soci e i loro redditi ufficiali non giustificano tale disponibilità, l’Ufficio presume che fossero utili in nero reimmessi in società, e in Cassazione si è chiarito che in tale scenario “l’onere di fornire la prova contraria si sposta interamente sul contribuente”. In sintesi, il socio deve prepararsi a dimostrare lui di non aver percepito utili occulti, una situazione probatoria tutt’altro che agevole (si tratta di provare un fatto negativo, ossia la mancata percezione di un reddito).
Inquadrati questi concetti, possiamo passare a esaminare come si svolge in concreto un accertamento fiscale che colpisce i soci di una S.r.l., quali sono i presupposti perché scatti la presunzione di distribuzione e soprattutto come il socio possa difendersi efficacemente, sia in via preventiva che nelle varie fasi del procedimento.
Riferimenti normativi di base
Esaminiamo la normativa italiana rilevante in materia di accertamenti induttivi e presunzione di utili ai soci, con le novità al 2025:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni accertamento imposte sui redditi): rappresenta il “testo base” in tema di accertamento tributario. In particolare:
- Art. 32: attribuisce all’Agenzia ampi poteri istruttori (richiesta documenti, questionari) e consente di utilizzare dati bancari come prova di ricavi non dichiarati (versamenti su conti non giustificati si presumono reddituali, salvo prova contraria del contribuente).
- Art. 38: disciplina l’accertamento sintetico per le persone fisiche. Dopo la riforma 2024 (D.Lgs. 108/2024), i commi 4 e seguenti prevedono il doppio requisito (scostamento >20% e reddito accertato > 10× assegno sociale) e ampliano le tipologie di prova contraria ammesse al contribuente.
- Art. 39: disciplina l’accertamento induttivo per imprenditori e lavoratori autonomi. Il comma 1 consente un accertamento analitico-induttivo se dalle scritture emergono inesattezze o violazioni gravi, ripetute e numerose tali da renderle parzialmente inattendibili. Il comma 2 permette l’accertamento induttivo puro (detto anche extracontabile) in caso di contabilità inattendibile o inesistente – ad esempio omissione di scritture obbligatorie, mancata presentazione del libro giornale, ecc. – autorizzando l’ufficio a determinare il reddito sulla base dei dati in suo possesso, di presunzioni prive dei requisiti di gravità/precisione (basta che siano semplici indizi coerenti) e di coefficienti presuntivi stabiliti per legge.
- Art. 40: (come modificato dal D.Lgs. 175/2014) riguarda le società di persone e prevede che, in caso di accertamento a una società di persone, i redditi rettificati vengano automaticamente imputati ai soci (trasparenza fiscale). Questo concetto si applica per legge alle società di persone, mentre per le società di capitali a ristretta base la giurisprudenza ha creato un meccanismo analogo per via presuntiva.
- Art. 41-bis: regola l’accertamento parziale, che consente all’ufficio di emettere avvisi limitati a specifici redditi non dichiarati (es. da segnalazioni) senza eseguire un accertamento completo, e senza pregiudicare la possibilità di ulteriori accertamenti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. Imposte sui Redditi – TUIR): contiene le definizioni delle categorie di reddito. Rilevano in particolare:
- Art. 44 e 47 TUIR: definiscono i redditi di capitale, includendo gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società. In base a queste norme, gli utili ufficialmente distribuiti ai soci di S.r.l. costituiscono redditi di capitale tassati in capo ai soci (oggi generalmente con ritenuta o imposta sostitutiva del 26%). Nel caso di utili extracontabili attribuiti presuntivamente, l’Agenzia li qualifica come redditi di capitale non dichiarati dai soci. Una specifica disposizione del TUIR (art. 47, comma 1, ultimo periodo) prevede che qualunque somma o bene proveniente dalla società al di fuori di regolare distribuzione di utili o restituzione di capitale si considera utile per il socio, a meno che si dimostri trattarsi di restituzione di finanziamenti. Questa norma supporta l’azione del Fisco quando riqualifica, ad esempio, prelevamenti di cassa del socio, utilità o fringe benefit non dichiarati oppure finanziamenti “anomali” come possibili utili nascosti.
- Art. 109, comma 4, lett. c) TUIR: stabilisce che non sono ammesse in deduzione le spese e gli oneri che trovano già contropartita in componenti positivi non tassati. Questo rileva perché, se il Fisco scopre utili in nero, tende a negare che vi siano costi correlati deducibili; se anche ci fossero stati costi “in nero” pagati in contanti, non essendo documentati non verranno riconosciuti, e l’utile occulto resta tassabile al lordo. (In altre parole, utili extracontabili = profitti netti non dichiarati).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): fondamentale carta dei diritti nel procedimento di accertamento. Dispone tra l’altro:
- Art. 7: obbligo di motivazione chiara degli atti tributari e di allegazione dei documenti richiamati; in caso di accertamento “derivato” da un PVC o da un accertamento alla società, l’avviso al socio deve dare conto degli elementi su cui si fonda (normalmente cita gli esiti del verbale di verifica o dell’avviso alla società).
- Art. 12, comma 7: dopo un processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia a seguito di verifica fiscale, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e memorie difensive, e l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima di tale termine (salvo casi di particolare urgenza, ad esempio imminente decadenza). Questa disposizione garantisce un contraddittorio endoprocedimentale: il socio, qualora il PVC riguardi la società di cui fa parte e contenga rilievi che potrebbero riflettersi su di lui, può (e deve) far pervenire deduzioni scritte all’ufficio entro 60 giorni, così che vengano valutate prima di emettere l’avviso.
- Art. 10: principio di buona fede e leale collaborazione, secondo cui i rapporti tra contribuente e Fisco devono essere improntati a reciproca fiducia. In sede difensiva, violazioni di questo principio (ad esempio un uso distorto delle presunzioni o il mancato rispetto del contraddittorio quando dovuto) possono essere sollevate, sebbene raramente conducano da sole all’annullamento dell’atto.
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Accertamento con adesione e conciliazione): prevede strumenti deflativi del contenzioso. Per il nostro tema:
- Art. 6, comma 1: consente al contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione dopo aver ricevuto un avviso di accertamento (entro il termine per ricorrere, ossia 60 giorni). La presentazione dell’istanza sospende automaticamente la scadenza per il ricorso per 90 giorni e obbliga l’ufficio a convocare il contribuente per un contraddittorio. Importante: il comma 1-bis introdotto nel 2014 consente persino di presentare un’istanza di adesione prima della notifica dell’accertamento (ad esempio dopo aver ricevuto un PVC), al fine di avviare il confronto e magari definire la questione prima che l’avviso venga emesso. Questa possibilità di “adesione preventiva” è poco nota ma può rivelarsi utile in casi complessi: costringe l’ufficio a negoziare col contribuente prima di formalizzare l’atto.
- Art. 7: disciplina gli effetti dell’adesione. Se l’accordo si raggiunge, viene redatto un atto di adesione con la nuova maggiore imposta concordata; il contribuente paga l’importo (in unica soluzione o rate) con sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo. L’adesione chiude in via definitiva il procedimento per quell’anno e materia.
- Art. 15: prevede la conciliazione giudiziale in corso di processo tributario (sia in primo sia in secondo grado), con possibilità di definire la lite davanti al giudice con un accordo transattivo e sanzioni ridotte al 40% del minimo (se conciliazione in primo grado) o al 50% (in appello).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Processo tributario): disciplina il ricorso alle Commissioni Tributarie, rinominate dal 2023 Corti di Giustizia Tributaria. Rilevano:
- Art. 2 D.Lgs. 546/92: competenza delle Corti di Giustizia Tributaria – i ricorsi contro avvisi di accertamento (inclusi quelli ai soci) vanno presentati alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (di solito quella della provincia dove ha sede il contribuente o l’ufficio).
- Art. 19: elenca gli atti impugnabili: l’avviso di accertamento al socio è un tipico atto impugnabile entro 60 giorni dalla notifica.
- Art. 17-bis (Reclamo e mediazione): abrogato dal 2024. Fino al 2023 prevedeva che, per controversie di valore fino a €50.000, il contribuente dovesse presentare un reclamo all’ufficio prima di poter instaurare il giudizio, con sospensione di 90 giorni; ciò per favorire una soluzione in autotutela o un accordo. La recente riforma (Legge 130/2022 attuata col D.Lgs. 156/2022 e D.Lgs. 119/2023) ha eliminato tale passaggio per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 in avanti. Dunque, nel 2025 il reclamo-mediazione non è più obbligatorio: il socio può ricorrere direttamente in giudizio anche per importi sotto 50mila euro. Rimane però possibile per le parti, su base volontaria, tentare soluzioni stragiudiziali o conciliazioni (come visto sopra).
- Art. 52: sospensione giudiziale dell’atto impugnato – il contribuente che ricorre può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento se dal pagamento deriverebbe un danno grave e irreparabile. Nel caso di avvisi ai soci, spesso gli importi possono essere elevati: se il socio non dispone di liquidità per pagare e intende attendere l’esito del giudizio, è opportuno presentare istanza di sospensione al Presidente della sezione (che decide con decreto motivato o assegna la discussione in camera di consiglio entro 180 giorni). Se concessa, la sospensione blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado. Questo strumento può evitare pignoramenti o iscrizioni ipotecarie in pendenza di causa, e va ponderato attentamente.
- Art. 7, comma 5-bis: introdotto dalla L. 130/2022, rafforza il principio che spetta al Fisco provare la fondatezza della pretesa tributaria. Sebbene di carattere generale, questo comma è stato richiamato in alcune pronunce per affermare che l’ufficio non può limitarsi a presunzioni deboli. Tuttavia, la Cassazione finora ha ritenuto che, nel caso specifico degli utili ai soci, la presunzione stessa (se basata su ristretta base e utili non contabilizzati) costituisca una prova presuntiva sufficiente, senza bisogno di ulteriori riscontri. Ciò ha suscitato critiche dottrinali, poiché sembra vanificare in parte lo spirito garantista della riforma: vedremo oltre come qualche spiraglio in favore del contribuente si stia comunque aprendo.
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28 comma 4: norma importante per i casi di società estinte. Prevede che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e del processo tributario, l’estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”. In pratica, se una società è stata cancellata dal Registro Imprese (ad esempio posta in liquidazione e chiusa), per i successivi 5 anni l’Amministrazione finanziaria può ancora emettere atti intestati alla società (notificandoli agli ex amministratori) e considerarli validi. Questo per evitare che la chiusura lampo di società con debiti fiscali impedisca gli accertamenti. Nel contesto degli utili extracontabili, questa norma fa sì che, se entro 5 anni dalla cancellazione vengono scoperti redditi non dichiarati in passato, l’ufficio possa emettere un accertamento “postumo” verso la società ormai estinta e parallelamente notificare ai soci l’attribuzione degli utili presunti. I soci, in sostanza, non possono eccepire l’inesistenza del soggetto societario come scudo: l’estinzione è “differita” a questi fini. La Corte Costituzionale ha giudicato legittima tale disciplina (sent. n. 170/2018 e n. 142/2021) in quanto volta a prevenire abusi. Resta però la debolezza della posizione dei soci, che si vedono recapitare accertamenti senza che la società possa più difendersi attivamente (tocca a loro far valere anche le ragioni che avrebbe avuto la società).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia) e Legge 31 agosto 2022, n. 130: hanno riformato in parte il sistema sanzionatorio penale-tributario e il processo tributario. Rilevante qui: la L.130/2022 ha introdotto l’art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 che condiziona l’accesso ad alcuni benefici penali (es. patteggiamento) al pagamento del debito tributario. Ne parleremo nella sezione penale, perché impatta la strategia difensiva complessiva (in certi casi pagare il dovuto può evitare condanne penali).
Oltre alle norme sopra elencate, va ricordato il ruolo della giurisprudenza (in particolare della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria) nell’aver plasmato e consolidato la materia. Molti principi operativi derivano da sentenze di legittimità degli ultimi decenni. Di seguito analizzeremo i principali orientamenti giurisprudenziali applicabili.
Come nasce l’accertamento di utili extracontabili ai soci
Vediamo ora quando e come l’Amministrazione finanziaria individua e contesta utili extracontabili, attivando la presunzione a carico dei soci. Occorre distinguere i presupposti di fatto (cioè le situazioni tipiche che insospettiscono il Fisco) e il procedimento attraverso il quale si passa dall’accertamento in capo alla società all’accertamento ai soci.
Presupposti tipici: segnali di evasione e controlli incrociati
L’accertamento di utili extra-bilancio parte solitamente dal riscontro di anomalie o irregolarità nelle dichiarazioni o nelle scritture contabili del soggetto verificato (la società). Ecco i principali indicatori che possono far scattare un controllo approfondito e portare alla scoperta di utili non dichiarati:
- Incongruenze contabili e indici di bilancio anomali: ad esempio margini di guadagno inspiegabilmente bassi rispetto al settore, ricavi dichiarati incongrui rispetto ai costi fissi, reiterate perdite d’esercizio nonostante aumento di patrimonio dei soci, ecc. Se un’azienda di piccole dimensioni dichiara sistematicamente utili esigui o zero, ma i soci mostrano benessere, scatta il sospetto di sotto-dichiarazione di ricavi.
- Dati dell’Anagrafe tributaria e altri incroci informativi: l’Agenzia incrocia milioni di dati. Un esempio classico: se un fornitore comunica nelle proprie dichiarazioni IVA di aver venduto beni per 100 a Alfa S.r.l., ma Alfa S.r.l. ha contabilizzato acquisti per soli 50, c’è uno scostamento che indica possibili fatture non registrate. Oppure, se un cliente (con scontrini parlanti, tessere, ecc.) dichiara di aver ricevuto vendite da Alfa S.r.l. ma Alfa non ha dichiarato quel ricavo, emerge un ricavo occultato. Questi controlli incrociati ormai avvengono anche con banche dati esterne (es. spesometro, operazioni sopra soglie, movimenti finanziari, ecc.).
- Indagini finanziarie sui conti bancari: l’ufficio può richiedere gli estratti conto bancari della società e anche dei soci/amministratori. Versamenti in banca non giustificati da fatture o prelievi ingenti potrebbero indicare fondi neri. In base all’art. 32 DPR 600, tutti i versamenti non giustificati si presumono ricavi tassabili, e tutti i prelevamenti non giustificati (per imprenditori) si presumono utilizzati per spese non documentate quindi correlati a ricavi in nero. Un caso frequente: se su un conto personale del socio compaiono accrediti periodici dalla società (senza causale ufficiale) o movimenti di denaro incompatibili col suo stipendio, il Fisco indaga per capire se sono utili occultamente distribuiti.
- Disallineamenti IVA e omesse fatturazioni: la Guardia di Finanza spesso controlla il magazzino e i corrispettivi. Se trova merce non giustificata o differenze tra vendite contabilizzate e giacenze, presume vendite in nero. Oppure se i ricarichi praticati sono troppo bassi rispetto al costo delle materie prime acquistate, sospetta ricavi non contabilizzati (es: acquisti per 100, vendite dichiarate 120 = mark-up 20%, quando di norma nel settore è 50%: potrebbe significare che in realtà si è venduto a 150 ma 30 non fatturati).
- Documentazione extracontabile: agende, appunti, “doppie contabilità”. Se in sede di verifica vengono trovati file Excel, block-notes o pendrive con annotazioni di incassi non registrati, il gioco è fatto: quelle evidenze diventano base per accertare utili occulti. Per esempio, celebri sono i casi del “libro mastro in nero” trovato in azienda con elenchi di somme, oppure email interne con istruzioni per dividere incassi fuori bilancio. Questi elementi forniscono al Fisco prove presuntive forti per ricostruire i redditi sottratti a tassazione.
- Tenore di vita dei soci: anche se formalmente il redditometro è uno strumento riferito al singolo contribuente, le informazioni sul lusso ostentato dai soci possono far avviare verifiche sulla società. Ad esempio, se i soci (o i loro familiari) guidano auto di grossa cilindrata di proprietà della società ma l’azienda dichiara redditi modestissimi, ciò può indicare che i costi della società celano in realtà utili goduti privatamente. Ugualmente, case di proprietà sociale usate dai soci, spese personali fatte passare in azienda (viaggi, barche, ecc.) sono tutti elementi che il Fisco riqualifica come utili in natura ai soci. I controlli del tenore di vita servono sia per accertamenti IRPEF sintetici sui soci, sia come riscontro negli accertamenti societari: se la società nega di aver distribuito utili in nero, ma i soci in quegli anni hanno arricchimento patrimoniale ingente, la tesi della distribuzione occulta si rafforza.
In sintesi, l’Amministrazione finanziaria utilizza un mix di analisi di bilancio, incrocio dati (fatture, spesometro, comunicazioni IVA), accessi e verifiche fisiche (controllo inventari, verifiche cassa), e indagini bancarie per far emergere situazioni in cui la società ha probabilmente nascosto ricavi. Una volta individuata la potenziale evasione a livello societario, sorge la questione: quegli utili extra, dove sono finiti? Ed ecco entrare in gioco la presunzione che siano andati ai soci.
Procedimento: dall’accertamento alla società all’accertamento al socio
Vediamo come si svolge concretamente l’iter di accertamento in questi casi, passo dopo passo:
- Verifica fiscale e accertamento alla società – In primo luogo l’Agenzia (o la Guardia di Finanza) effettua la verifica sulla società. Al termine, se riscontra maggiori ricavi imponibili, redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC) dettagliando le violazioni. La società ha 60 giorni per presentare osservazioni (art. 12 Statuto). Decorso tale termine, l’ufficio emette l’avviso di accertamento contro la società, rettificando il reddito d’impresa (IRES) dell’anno X di un certo importo, recuperando eventuale IVA evasa e applicando le relative sanzioni. Questo avviso viene notificato al legale rappresentante della società. Esempio: Alfa S.r.l. è accusata di aver occultato ricavi per €100.000 nel 2022; le viene quindi notificato un avviso accertando €100.000 di reddito in più, con maggiori imposte (IRES 24% su 100k = €24.000, IRAP se dovuta, IVA se quelle vendite erano da assoggettare ad IVA) e sanzioni (generalmente 90% dell’imposta evasa per infedele).
- Notifica degli avvisi ai soci – Contestualmente (spesso lo stesso giorno o a breve distanza) l’Agenzia notifica separati avvisi di accertamento ai singoli soci, riferiti al medesimo periodo d’imposta, nei quali assume che i maggiori utili non dichiarati dalla società siano stati distribuiti a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Riprendendo l’esempio: Alfa S.r.l. aveva 2 soci al 50%? Ognuno riceve un avviso per €50.000 di redditi di capitale non dichiarati nel 2022. Se i soci erano 4 con 25% ciascuno, sarebbe €25.000 a testa, e così via. L’avviso al socio ridetermina il suo reddito IRPEF personale per quell’anno aggiungendo l’importo presunto di utili, con tassazione secondo le regole dei dividendi (ad esempio, per utili 2022 percepiti nel 2022, trattandosi di partecipazioni qualificate, oggi sarebbero comunque soggetti ad imposta sostitutiva del 26%, ma spesso l’Agenzia li include nel reddito imponibile IRPEF e liquida l’imposta corrispondente; negli avvisi pre-2018 venivano tassati parzialmente al suo scaglione IRPEF). Anche qui si applicano sanzioni per infedele dichiarazione del socio (90% dell’imposta). Nei nostri numeri ipotetici: utili occultati €50.000 a socio, imposta IRPEF calcolata ~€19.000 per socio, sanzione €17.100 ciascuno (90%).
- Contenuto dell’avviso al socio – Tali avvisi in genere richiamano l’accertamento alla società. Possono allegare il PVC o l’avviso societario, oppure riprodurne i punti salienti. È essenziale leggere bene la motivazione: deve spiegare che, essendo Alfa S.r.l. a ristretta base, i maggiori utili accertati sono presunti distribuiti pro quota, e indicare almeno in sintesi i fatti da cui origina l’utile occulto (es: “occultamento ricavi risultante da verifica GdF del …, PVC n…, avviso a Alfa S.r.l. n… diventato definitivo/non impugnato/impugnato ecc.”). In alcuni casi l’accertamento al socio viene emesso prima che quello alla società sia definitivo: l’Agenzia non è tenuta ad attendere l’esito del ricorso della società, a meno che questo non sia in uno stadio iniziale tale da imporre la sospensione (vedi oltre). Importante: dal 2011 in poi l’avviso di accertamento è diventato esecutivo, cioè dopo 60 giorni può essere iscritto a ruolo e avviata la riscossione, anche in pendenza di giudizio. Questo vale anche per gli avvisi ai soci.
- Scenari di contenzioso – A questo punto sia la società sia i soci si trovano con atti impugnabili. Possono verificarsi varie situazioni:
- La società e i soci accettano e pagano (acquiescenza o adesione): il che chiude la questione, ma è raro perché di solito contestano. Se pagano con acquiescenza nei 60 gg, sanzioni ridotte a 1/3.
- La società fa ricorso, i soci no: se solo la società impugna il suo avviso e i soci lasciano scadere i loro termini, gli accertamenti ai soci diventano definitivi a prescindere da come finirà il giudizio della società. Quindi di regola conviene sempre che ogni socio presenti ricorso, quantomeno per tenersi aperta la possibilità di beneficiare di un esito favorevole del giudizio sulla società.
- I soci fanno ricorso, la società no: può capitare se la società è nullatenente o in liquidazione e decide di non difendersi (o magari è già estinta). In tal caso i soci devono impostare la propria difesa anche contestando il merito della pretesa societaria, perché l’accertamento ai soci dipende da quello. Attenzione: se l’avviso alla società diviene definitivo (perché non impugnato), i soci in giudizio potranno ancora contestare l’esistenza degli utili occulti? La giurisprudenza dice di sì, perché il giudice tributario del socio non è vincolato dal fatto che la società non abbia ricorso. Tuttavia, il fatto che la società abbia lasciato passare l’atto su di sé rende la difesa dei soci più difficile (in pratica dovranno provare l’inesistenza di utili che la società non ha contestato).
- Sia società che soci fanno ricorso: è l’ipotesi ideale per il contribuente, perché le cause possono procedere parallele. In teoria i due giudizi sono autonomi (diverse parti), ma c’è evidente connessione. Spesso i soci chiedono alla propria Corte di Giustizia Tributaria di sospendere il processo in attesa dell’esito di quello societario, per ragioni di economia processuale e perché l’annullamento dell’accertamento alla società toglierebbe base a quello ai soci. Normativa sul punto: l’art. 295 c.p.c. dispone la sospensione necessaria del processo se la decisione di una causa dipende dalla definizione di un’altra pendente; l’art. 337 c.2 c.p.c. prevede sospensione facoltativa se c’è una sentenza non definitiva influente. La Cassazione ha chiarito che: se il giudizio della società è ancora in primo grado, la causa del socio è da sospendere obbligatoriamente; se la società ha già una sentenza (es. vinto o perso in CTP) ma pendono appello o Cassazione, la sospensione è discrezionale. In pratica molti giudici sospendono in attesa del giudizio societario almeno fino all’appello. Nel caso contrario (il processo del socio va avanti per primo), può succedere di avere decisioni contrastanti. È quindi importante, se si è difensori di tutti, coordinare le difese: coerenza nelle argomentazioni e magari sollecitare la trattazione congiunta o la sospensione.
- Definizioni intermedie – In ogni fase c’è spazio per soluzioni concordate:
- Adesione: la società e/o i soci possono avviare accertamento con adesione prima del giudizio. Ad esempio, la società potrebbe trovare un accordo (pagare un po’ meno imposte) ma non essere in grado di garantire che i soci non vengano tassati. L’ufficio, su utili ai soci, di solito è rigido: se l’utile occulto è accertato, pretende di tassarlo anche ai soci. Però in adesione si può trattare almeno sulle sanzioni o su esclusioni di soci minori (ci sono stati casi in cui l’ufficio, valutate prove di estraneità, ha lasciato fuori uno dei soci dall’accertamento).
- Conciliazione giudiziale: durante il processo, soprattutto se emergono incertezza sugli esiti, le parti possono proporre una conciliazione: ad esempio, ridurre l’imponibile contestato e le sanzioni. Questo può far risparmiare tempo e soldi (sanzioni ridotte al 40%). Nel contesto di utili ai soci, una conciliazione tipica potrebbe essere: la società riconosce un certo ammontare di ricavi in nero inferiore a quello iniziale e i soci accettano di pagare su quell’ammontare ridotto. Il tutto formalizzato con accordo in udienza.
In ogni caso, il fulcro del contenzioso sarà la presunzione di distribuzione: la società potrebbe contestare di aver avuto utili in nero, e in subordine affermare che comunque non furono distribuiti; i soci dal canto loro focalizzeranno la difesa sul “non percepimento” degli utili. Approfondiamo dunque proprio come funziona questa presunzione e quali sono le vie per superarla.
Presunzione di distribuzione ai soci nelle società a ristretta base
Siamo giunti al cuore della questione: la regola secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base societaria, i maggiori utili accertati si presumono distribuiti “pro quota” ai soci. Esaminiamo dapprima i fondamenti di questa presunzione e il suo ambito di applicazione; poi vedremo quali strumenti di prova contraria hanno i contribuenti per combatterla e come si è evoluto l’orientamento giurisprudenziale fino ad oggi (2025).
Fondamento giurisprudenziale e ambito della presunzione pro-soci
Come anticipato, non c’è una norma di legge che imponga automaticamente la tassazione ai soci per gli utili extra della società di capitali. Questo meccanismo nasce da un orientamento consolidato della Corte di Cassazione (formatosi già dagli anni ‘80-‘90 sul concetto di “ristretta base”). La ratio è la seguente: in una piccola S.r.l. (es. a conduzione familiare) c’è una comunanza di interessi tra i soci tali per cui, se l’azienda produce utili occulti evadendo le tasse, è verosimile che tali somme non restino inutilizzate in azienda, bensì vengano “spartite” informalmente fra i soci stessi, che essendo pochi e d’accordo tra loro se ne ripartiscono i benefici. Spesso la Cassazione parla di “vincolo di solidarietà e di complicità fra i soci” a base della presunzione.
Quindi la presunzione opera quando sussistono due condizioni essenziali: (1) la società ha una compagine ristretta; (2) sono stati accertati utili extracontabili non dichiarati dalla società. Se c’è questo scenario, scatta la regola: quegli utili occulti si considerano distribuiti ai soci nell’anno in cui l’azienda li ha conseguiti, salvo prova contraria. Importante: la distribuzione presunta è pro-quota secondo la partecipazione di ciascuno al capitale sociale (salvo evidenza che la ripartizione sia stata in altre proporzioni). Ad esempio, Cassazione ribadisce: “nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione della loro distribuzione pro quota ai soci”.
Questa presunzione è stata applicata originariamente a soci persone fisiche, ma di recente la Cassazione ha chiarito che vale anche se i soci sono altre società. Nell’ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025, la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui una S.r.l. con pochi soci era partecipata interamente da due società di capitali (holding): i giudici hanno detto che conta la sostanza economica: se dietro le holding vi sono poche persone che controllano il tutto, gli utili extrabilancio si considerano comunque attribuiti a queste ultime (risalendo la catena). Quindi, la presunzione “oltre lo schermo societario” estende l’attribuzione fino ai soci finali effettivi. Questo per evitare che basti frapporre una società intermedia per eludere la tassazione in capo alle persone fisiche: le società intermedie vengono considerate meri involucri ai fini della presunzione. Ad esempio, se Gamma S.r.l. (base ristretta) è posseduta al 100% da Delta Holding S.p.A., a sua volta di proprietà di due persone, un utile occulto di Gamma sarà imputato ai due individui (tramite Delta). Di fatto l’Agenzia in questi casi può: contestare a Delta un dividendo extra ricevuto (come reddito di impresa per Delta) e inoltre contestare ai soci di Delta un dividendo extra da Delta – ma questo secondo passaggio normalmente avverrà solo quando Delta distribuirà utili. Più frequente è che, se i soci finali sono persone fisiche identificabili, l’accertamento salti direttamente a loro, trattando l’interposto come trasparente.
Non occorre – precisa la giurisprudenza – che i soci siano legati da vincoli familiari o tutti amministratori: basta che siano pochi. Anche soci non coinvolti formalmente nella gestione rientrano nella presunzione per il solo fatto di far parte del ristretto gruppo proprietario. Ad esempio Cass. ord. 12288/2025: presunzione applicata “anche se i soci non sono legati da vincoli familiari”. E come vedremo, proprio la posizione del socio eventualmente “passivo” è stata oggetto di evoluzione per quanto concerne la prova contraria.
Importante è chiarire che la presunzione non dipende dall’effettivo rinvenimento delle somme presso i soci. Cioè, non serve che il Fisco provi che il socio ha comprato beni di lusso o ha ricevuto bonifici dalla società. La Cassazione ha sempre detto che l’Ufficio non deve dimostrare il transito materiale del denaro, perché per definizione gli utili “in nero” circolano in contanti o occultamente. Quindi l’assenza di evidenze bancarie di accrediti non salva il socio: “non occorre che l’avviso al socio si fondi anche su elementi di riscontro quali l’analisi delle movimentazioni bancarie e l’acquisto di beni di valore non giustificabili col reddito”. Questa affermazione (ordinanza Cass. 12288/2025) sottolinea come basti la struttura societaria ristretta per dare solidità alla presunzione.
La Corte considera questa presunzione di natura giurisprudenziale come una “regola di esperienza” tanto consolidata da assurgere quasi a regola di diritto. Per citare Cass. 21593/2024: “in tema di imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base, accertati utili extra-bilancio, opera la presunzione della loro distribuzione pro quota ai soci, salva prova contraria”. Dunque oggi chiunque si trovi in uno schema del genere sa che è assai probabile un accertamento parallelo a soci.
Riepilogo in tabella: condizioni e caratteristiche della presunzione.
| Presupposti per presunzione | Conseguenza fiscale | Note giurisprudenziali |
|---|---|---|
| Società di capitali a ristretta base (pochi soci, es. familiari o soci unici) e utili/proventi non dichiarati accertati in capo alla società (ricavi in nero, utili occultati, ecc.) | Presunzione (relativa) che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote, nello stesso periodo d’imposta. Il socio viene tassato sul relativo importo come reddito di capitale non dichiarato. | La presunzione è consolidata da Cassazione dal 1983 in poi. Non serve prova di trasferimenti finanziari ai soci. L’onere di provare il contrario grava sui soci (dimostrare utili non distribuiti ma reinvestiti, o estraneità). Vale anche se i soci sono altre società (si guarda ai soci finali). |
Cosa rientra negli “utili extracontabili” presunti distribuiti
Un punto importante: quali voci di reddito della società generano la presunzione di distribuzione? In prima battuta si pensa ai ricavi non dichiarati (es. vendite in nero). Ma ci sono situazioni più sfumate. Ad esempio, se la società ha utilizzato fatture false o costi inventati per abbattere l’utile, la ripresa fiscale consiste nel “togliere” quei costi e far emergere un utile maggiore. Questa maggiore base imponibile è a tutti gli effetti un utile extrabilancio (perché l’azienda in realtà non ha sostenuto quei costi finti, quindi ha risparmiato cash). La Cassazione ha confermato che anche gli utili “emersi” da costi indeducibili fittizi rientrano nella presunzione: es. in Caso 1 sotto vedremo utili da fatture false considerati distribuibili ai soci.
Viceversa, se l’accertamento riguarda costi realmente sostenuti ma contestati dal fisco (per difetto di inerenza, ecc.), allora non c’è un utile “monetario” corrispondente – c’è un maggior reddito tassabile per ragioni fiscali, ma l’azienda non ha incassato nulla in più, anzi ha speso. In tal caso la presunzione di distribuzione non dovrebbe applicarsi, perché non vi è un arricchimento occulto. Ad esempio, se il Fisco disconosce una spesa perché non inerente all’attività (ma realmente pagata), l’utile tassabile sale solo “virtualmente” e non ci sono soldi extra da dividere (anzi, l’azienda ha meno cassa per via di quella spesa). Su questo punto esiste giurisprudenza di merito che esclude la presunzione quando l’accertamento fiscale verte solo su questioni valutative o formali che non generano liquidità in più. Tuttavia, l’Amministrazione spesso tende comunque ad applicarla, specie se la natura del costo contestato è dubbia (temono che un costo non inerente celi in realtà un’utilità privata per soci). Se ad esempio la società deduce come costo la vacanza del socio spacciata per viaggio di lavoro, l’ufficio può al contempo: negare il costo in capo alla società e tassare il socio per una sorta di fringe benefit non dichiarato. Non è esattamente “utile distribuito”, ma l’effetto è analogo (il socio ha goduto di un benefit pagato dalla società). In definitiva, possiamo dire che rientrano nella presunzione tutte le somme che, per effetto dell’accertamento, risultano essere state disponibili nella sfera aziendale e non contabilizzate come utili: ricavi occultati, costi fittizi (che liberano utile occulto), sconti di merce sottobanco, beni sociali utilizzati privatamente, ecc. Non vi rientrano invece componenti positivi “figurativi” (crediti inesigibili stornati, ecc.) privi di consistenza economica reale. Su questi ultimi casi, la difesa del socio potrà puntare per dimostrare che non c’era nulla da distribuire.
La prova contraria del contribuente: evoluzione della giurisprudenza
Essendo una presunzione iuris tantum (relativa), resta teoricamente aperta al socio la possibilità di provarne il contrario. Cosa significa “provare il contrario” in questo contesto? Vuol dire dimostrare che i maggiori utili accertati non sono stati in realtà distribuiti ai soci. La Cassazione, per molti anni, è stata molto restrittiva su quali elementi potessero costituire prova contraria valida. L’orientamento tradizionale (fino a circa il 2020) affermava che l’unica prova liberatoria efficace fosse mostrare che gli utili extracontabili erano stati o accantonati in azienda, o reinvestiti nell’attività, o eventualmente distratti da terzi senza coinvolgimento dei soci. Al di fuori di queste situazioni, poco altro veniva ammesso. Ad esempio: – Accantonamento: provare che i soldi in nero sono rimasti nelle casse sociali o in un fondo occulto per essere reinvestiti. Ma come si prova? Forse mostrando che poi sono comparsi in bilancio anni dopo come sopravvenienze o come versamenti in conti aziendali. – Reinvestimento: provare che l’utile occulto è stato usato per comprare beni aziendali, pagare debiti aziendali, ecc., e non distribuito ai soci. – Attribuzione a terzi: situazione in cui, ad esempio, l’utile occulto se lo appropria l’amministratore di fatto o un socio occulto, all’insaputa degli altri. Se un socio riesce a dimostrare che un altro soggetto si è intascato tutto (magari l’amministratore infedele), potrebbe evitare la tassazione su di sé.
Inoltre, la Cassazione affermava che la mera negazione dei soci di aver ricevuto qualcosa non vale. Né vale far vedere che i conti correnti personali non mostrano accrediti: l’ovvio contro-argomento è che i soldi occulti circolano in contanti o all’estero, quindi è normale che non ci sia traccia bancaria. Ad esempio, Cass. 2288/2025 ha escluso che un socio potesse difendersi esibendo l’estratto conto personale in cui non risultavano entrate: la Corte ha detto che l’utile in nero poteva essergli stato dato cash o tramite paradisi fiscali, quindi l’assenza di movimenti non prova nulla.
Va detto che nel corso degli anni alcuni spiragli sono stati aperti in casi specifici. La giurisprudenza di merito (Commissioni Tributarie) ha talora accolto difese basate su circostanze particolari, costringendo la Cassazione a esprimersi. Esempi di situazioni in cui i giudici hanno ritenuto superata la presunzione: – Il socio aveva agito contro gli amministratori disonesti, ad esempio presentando denuncia querela per appropriazione indebita degli utili occulti. Cass. n. 21573/2005: la Corte ritenne che se un socio (minoritario) denuncia i soci di maggioranza per gestione fraudolenta, ciò è incompatibile con la “complicità” tra soci; dunque lui non va tassato sugli utili in nero che altri si sono presi. – Il socio svolgeva tutt’altra attività lontano dalla società: Cass. n. 18042/2018 cita il caso di un socio professionista esterno che non partecipava alla gestione, riconoscendo che la sua posizione poteva differire da chi era dentro. – Il socio non è coinvolto in un procedimento penale dove invece risultano imputati gli altri soci per evasione: Cass. n. 24870/2021 considera questo elemento (assenza di coinvolgimento) un indizio di estraneità alla spartizione illecita.
Questi casi suggerivano che la “estraneità” del socio alla gestione potesse essere una chiave. Per molto tempo però la Cassazione ha ribadito che, anche se un socio era formalmente estraneo, comunque rimaneva socio e la presunzione colpiva ugualmente, perché la prova contraria non poteva risolversi nella sola affermazione “non sapevo/nulla ho preso”. In sostanza fino a pochi anni fa si riteneva che il socio dovesse comunque provare che l’utile era restato in società o volato altrove, non bastava dire “ero un socio di nome”.
Novità 2025: proprio su questo aspetto si è avuta una parziale apertura. Con la sentenza n. 2464/2025 la Cassazione, pur confermando la validità generale della presunzione, ha riconosciuto maggiore considerazione alla prova contraria dell’estraneità del socio. In tale pronuncia, per la prima volta a chiare lettere, la Corte afferma che se un socio dimostra di essere stato totalmente estraneo alla gestione sociale, ciò è sufficiente a superare la presunzione di distribuzione rispetto a lui. Viene quindi superato il tradizionale insegnamento secondo cui la sola estraneità non bastava perché, si diceva, non prova che l’utile non fu distribuito (potevi essere estraneo ma intascare comunque). Ora la Corte considera che, se un socio riesce a provare di non aver avuto alcun ruolo né vantaggio, cade il presupposto della “complicità” tra soci che sorregge la presunzione.
Attenzione però: si tratta di un’apertura su un piano teorico, ma la prova richiesta è molto rigorosa. Il socio deve dimostrare un’“assoluta estraneità”. Nel caso in esame, nonostante i soci avessero portato elementi (conti personali in rosso, beni pignorati per debiti sociali, etc. a loro favore), la Cassazione ha comunque rinviato la causa per riesaminare se quelle prove fossero davvero sufficienti. Segno che non è facile soddisfare i giudici. Per convincerli, il socio dovrà produrre più elementi concordanti: ad esempio che vive lontano e non partecipa alle assemblee, che non è amministratore né ha deleghe, che magari lavora altrove a tempo pieno, che i conti correnti suoi e dei familiari non evidenziano arricchimenti, che non ha beneficiato di beni sociali (auto, case), che altri soci hanno ammesso di aver trattenuto loro gli importi, ecc. Anche eventuali testimonianze nel parallelo processo penale (se i soci attivi sono imputati e quello passivo no) possono essere d’ausilio. Insomma, occorre costruire un quadro convincente che quel socio era “socio solo sulla carta” e non ha condiviso gli utili occulti.
Resta sempre valida come prova contraria la dimostrazione che l’utile occulto ha avuto un impiego alternativo dentro la società. Ad esempio se si prova che i fondi neri sono stati utilizzati per acquistare di nascosto macchinari o pagare maestranze in nero, ecc., allora effettivamente non c’è stata distribuzione perché il denaro è stato reinvestito. Presentare documenti che tracciano questo flusso è complesso, ma se esistono (magari appunti contabili paralleli) possono essere usati. Anche versamenti dei soci a copertura di perdite possono essere rilevanti: se in quell’anno i soci hanno dovuto immettere denaro proprio per far fronte a difficoltà aziendali, è poco credibile che al contempo stessero ritirando utili occulti.
In definitiva, oggi possiamo riassumere così la difesa del socio contro la presunzione: – Provare che il socio non ha ricevuto nulla perché l’utile occulto è stato usato altrimenti (esempio: rimasto in cassa come fondo segreto, usato per investimenti aziendali, sottratto fraudolentemente da amministratori senza distribuirlo, ecc.). – Oppure provare che quel socio, pur teoricamente beneficiario pro quota, in realtà era all’oscuro e fuori dalla gestione, tanto da escludere la sua partecipazione alla spartizione. In pratica, sgretolare l’idea di “comunanza di scopo” tra i soci relativamente a quell’utile.
La seconda via è utile soprattutto per soci di minoranza o estranei alla famiglia di controllo. La prima via è da percorrere per tutti, perché se convincente toglie proprio la base per tassare chiunque.
Da notare: se in giudizio il socio riesce a dimostrare che nessun socio ha percepito l’utile (perché rimasto in azienda), allora tutti i soci dovrebbero essere sollevati. Più comune però è che uno cerchi di salvarsi indicando che un altro si è preso tutto – in tal caso di solito l’Agenzia cercherà allora di tassare quell’altro per l’intero utile occulto. Ciò apre problematiche di riparto dell’onere fra soci, ma sono situazioni peculiari.
Imputazione ai soci: importo lordo o netto?
Un aspetto tecnico da considerare: quando l’utile extrabilancio viene imputato al socio, l’importo è conteggiato al lordo delle imposte societarie o al netto? Ad esempio, se la società ha occultato €100.000 di ricavi, su cui avrebbe dovuto pagare 24% di IRES (€24.000), il socio viene tassato su 100k (come se li avesse incassati per intero) o su 76k (ipotizzando che, se fosse stato utile regolare, 24k sarebbero andati al Fisco e 76k dividendo netto)? La prassi e la giurisprudenza prevalente dicono: importo lordo. Cioè il socio viene tassato come se avesse percepito l’intero importo evaso dalla società. Questo produce innegabilmente una forma di doppia imposizione economica: la società paga le imposte evase sul 100%, e i soci pagano a loro volta imposta su quel medesimo 100%. Sommati, i due livelli di tassazione possono superare anche il 60-70% del profitto originario. Purtroppo ciò è considerato legittimo: non c’è una norma che coordini le due tassazioni, perché formalmente sono due soggetti diversi (società e socio) tassati su basi diverse (reddito d’impresa e reddito di capitale). La logica sottostante è punitiva: se hai cercato di eludere entrambi i livelli di tassazione, vieni colpito su entrambi quando scoperto. In altre parole, il sistema considera che il socio, ricevendo utili in nero, non abbia sopportato la normale tassazione societaria su di essi, e quindi gliela fa pagare come se fosse tutto reddito “ordinario” suo. Quindi il socio viene tassato sull’importo lordo evaso, senza alcuno scomputo per quanto pagato dalla società. Non si può neppure eccepire formalmente la violazione del divieto di doppia imposizione, perché quella vale per la stessa imposta sul medesimo soggetto, mentre qui tecnicamente è IRES sulla società e IRPEF (o imposta sostitutiva) sul socio, soggetti diversi.
L’unico correttivo potrebbe avvenire a posteriori: se, ad esempio, l’Agenzia per errore imputasse ai soci un importo superiore all’utile occulto (doppioni, ecc.), quello sarebbe contestabile. Ma finché ciascuno è tassato sulla sua quota proporzionale, non c’è rimedio. La giurisprudenza conferma: “i soci devono comunque pagare la loro parte e viceversa – non c’è compensazione. … il socio è tassato sull’importo lordo degli utili occulti, senza scomputo dell’IRES teorica”. Duro da digerire, ma vero.
Per completezza, va ricordato che in passato (prima della riforma 2018) i dividendi da partecipazioni qualificate erano imponibili IRPEF solo al 49,72% (poi 58,14%). In qualche vecchio accertamento i soci cercarono di sostenere che l’utile occulto doveva semmai esser tassato con quelle percentuali (quindi già in parte “netto”). La Cassazione però ha sempre rigettato queste tesi, dicendo che non si applicano le percentuali da dividendo, bensì si tratta di reddito non dichiarato e come tale interamente tassabile (anche perché spesso il periodo d’imposta era antecedente alle ritenute secco del 26%). Oggi comunque, con l’allineamento al 26%, la questione percentuale si pone meno.
Presunzione post-estinzione della società
Una situazione particolare è quella in cui la società viene dissolta prima che si scopra l’evasione. Come visto, la legge (art. 28 c.4 D.Lgs. 175/2014) consente di notificare accertamenti entro 5 anni dalla cancellazione. In pratica l’ufficio emette l’avviso come se la società esistesse ancora, e parallelamente attiva la presunzione verso i soci. In tal caso i soci, dopo la chiusura della società, si trovano ad affrontare da soli l’accertamento.
Qui c’è da distinguere due profili: – Responsabilità patrimoniale per debiti fiscali societari: di regola i soci di S.r.l. non rispondono con patrimonio proprio dei debiti sociali (c’è autonomia patrimoniale perfetta). Tuttavia l’art. 2495 c.c. prevede che, se vi sono crediti insoddisfatti in sede di liquidazione, i creditori sociali possono chiedere ai soci quanto questi hanno riscosso in sede di liquidazione. Questo principio viene usato dal Fisco per recuperare imposte dovute dalla società estinta attingendo ai soci, ma solo entro il limite di quanto incassato in liquidazione (se hanno avuto riparti di attivo). – Tassazione dei redditi extra in capo ai soci: è un’altra cosa. Qui non si tratta di far pagare ai soci l’IRES evasa dalla società, ma di tassare i soci sul reddito presuntamente percepito. E questo la legge lo permette senza limiti di quota, perché presuppone che se c’erano utili in nero, i soci li abbiano potuti ricevere oltre a quanto formalmente incassato come riparto finale.
In pratica i soci non sono al riparo dall’accertamento sugli utili occulti solo perché la società è stata chiusa. Anzi, come osservato da molti, la loro posizione è addirittura più debole perché non c’è più la persona giuridica a fare da bersaglio principale: il Fisco punta direttamente a loro senza la “mediazione” della società. Certo, i soci conservano il diritto di difesa: possono far valere che la società si era sciolta senza attivo (quindi se c’erano utili in nero, magari erano stati persi o utilizzati per pagare debiti, per cui non li hanno avuti). Non possono però opporre la cessazione come motivo per non essere tassati. La Cassazione ha confermato: “cancellata la società, i soci rischiano di rimanere soggetti all’insidia degli utili extracontabili”.
Da notare: l’art. 28 c.4 di cui sopra a sua volta scade dopo 5 anni. Se il Fisco scopre l’evasione oltre 5 anni dopo la chiusura, non può più emanare atti validi. Dunque i soci sarebbero salvi (salvo ipotesi di frode penalmente rilevante che potrebbe far riaprire termini, ma sono casi limite).
In sintesi, la morte della società non immunizza i soci dalla presunzione. Il socio, ex post, potrà al più limitare la sua esposizione argomentando che non ha ricevuto nulla in liquidazione: se la società si è sciolta con un passivo netto, ogni utile occulto pregresso potrebbe essersi volatilizzato per coprire perdite. Ad esempio, se la società è andata in decozione, si può sostenere che eventuali utili neri erano stati spesi per tenere a galla l’azienda e non distribuiti. Ma si tratta appunto di prove di fatto.
Difendersi dall’accertamento: strategie e strumenti
Dal punto di vista del debitore d’imposta (sia esso la società accertata, sia il socio che riceve l’avviso), affrontare un accertamento di questo tipo richiede un approccio strutturato su più livelli. Bisogna valutare i vizi formali e sostanziali dell’atto, sfruttare gli strumenti procedurali a disposizione per guadagnare tempo o risolvere in via amministrativa, e predisporre le argomentazioni di merito più efficaci. In questa sezione vedremo le principali strategie difensive da mettere in campo “subito e bene” dopo aver ricevuto l’accertamento fiscale.
Valutare l’atto e individuare possibili errori o punti deboli
Il primo passo è un’analisi accurata dell’avviso di accertamento (o degli avvisi, se sono più d’uno) appena notificato. Il contribuente, con l’aiuto del proprio consulente (avvocato o commercialista), deve esaminare:
- Termini di decadenza: verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini previsti. In generale l’accertamento sulle imposte dirette va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ad esempio, redditi 2020 -> entro il 31/12/2025). Se la dichiarazione non fu presentata, c’è tempo fino al settimo anno. Bisogna controllare che l’avviso rechi la data di spedizione/notifica entro quel termine. Se fosse tardivo, è nullo per decadenza. Attenzione ai casi di raddoppio dei termini per reato tributario: se l’evasione integra un reato e la notitia criminis viene inviata alla Procura, il termine raddoppia (5 anni -> 10 anni). Quindi se, poniamo, l’accertamento riguarda fatti 2018 con reato, può arrivare fino al 2028. È un dettaglio tecnico, ma va considerato.
- Notifica regolare: controllare che la notifica sia avvenuta secondo le norme (consegna a persona giusta o raccomandata AR, etc.). Vizi di notifica possono essere sanati col ritiro dell’atto, ma in alcuni casi gravi (notifica a indirizzo errato e conoscenza tardiva) si può eccepire nullità se ha pregiudicato la difesa.
- Motivazione e allegati: la motivazione deve spiegare la pretesa e riportare gli elementi essenziali. Se l’avviso del socio si basa su un PVC o altro atto, quest’ultimo deve essere allegato (art.7 L.212/2000) o comunque il contenuto deve essere trascritto. Se mancasse completamente l’allegazione di un PVC ricco di dati, c’è vizio di motivazione. Anche qui, però, spesso i giudici non annullano facilmente per questo motivo se il contribuente conosceva il PVC.
- Contraddittorio: verificare se era previsto un contraddittorio obbligatorio non effettuato. Ad esempio, per accertamento sintetico redditometrico su soci, l’art. 38 vecchio comma 7 imponeva l’invito a comparire. Se l’ufficio l’avesse saltato, l’atto potrebbe essere annullabile (Cass. sez. un. 2015 sul punto). Nel caso di utili ai soci da accertamento societario, non c’è una norma specifica di contraddittorio col socio prima dell’atto (si suppone che il contraddittorio col socio avvenga nel processo). Tuttavia, se la società ha presentato osservazioni al PVC nei 60 gg e l’ufficio non le ha minimamente considerate, si può far leva su ciò in giudizio (violazione art.12 Statuto). Non rende nullo l’atto di per sé, ma è un elemento di critica.
- Elementi probatori addotti dall’ufficio: l’atto del socio deve fondarsi su qualcosa. Se, ipoteticamente, la società non è stata accertata oppure se l’accertamento societario è stato annullato da un giudice, l’atto al socio cade. Bisogna quindi vedere se l’accertamento societario sussiste e con quali esiti. Se la società ha già vinto in primo grado quando arriva l’avviso al socio, quest’ultimo deve assolutamente portare a conoscenza del suo giudice quella sentenza favorevole, chiedendo magari la sospensione in attesa che passi in giudicato. Viceversa, se la società ha perso, i soci devono combattere in salita dimostrando l’errore.
- Importi: controllare che la somma imputata al socio corrisponda esattamente alla sua quota di partecipazione sugli utili occulti contestati alla società. Se c’è un errore (ad es. imputati €60k invece di €50k per sbaglio), evidenziarlo subito e chiederne lo stralcio.
- Sanzioni: verificare che le sanzioni applicate siano quelle corrette (tipicamente, 90% imposta per infedele). Se l’atto è per omessa dichiarazione (es. socio non ha proprio presentato la dichiarazione per quell’anno e gli aggiungono il reddito di capitale), la sanzione sarebbe dal 120% al 240%. Verificare inoltre eventuali cause di non punibilità di sanzioni (obiettiva incertezza, ecc.), anche se in questo campo è difficile invocarla – però chiederne l’esclusione non nuoce.
- Calcolo interessi: in genere gli avvisi indicano imposta, sanzione e interessi. Gli interessi sono dovuti per legge (tasso di circa il 4% annuo), ma un errore macroscopico nel loro calcolo potrebbe essere contestato (raro).
In questa fase iniziale, conviene anche raccogliere tutta la documentazione e le informazioni utili per preparare le difese. Quindi: – Ottenere copia integrale del PVC e dell’avviso alla società (se non li si ha già). – Recuperare bilanci, estratti conto societari e personali dei soci degli anni interessati. – Fare mente locale su eventuali circostanze favorevoli: es. “in quell’anno la società aveva perso un cliente importante” (spiegazione economica del perché i ricavi erano bassi senza frode), oppure “quel ricavo in nero in realtà fu usato per comprare un macchinario a nero poi rivenduto” (ipotesi di reinvestimento). – Identificare possibili testimoni o dichiarazioni: se c’è un procedimento penale, vedere se vi sono testimonianze che scagionano qualcuno. Oppure lettere, email interne che suggeriscono che Tizio socio minoritario era tenuto all’oscuro.
In pratica si prepara il “processo” facendo un check-up di fatti, norme e prove.
Scelta immediata: adesione o ricorso (o entrambi)
Entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, il contribuente deve decidere come muoversi. Le strade non si escludono a vicenda, ma vanno ponderate: – Istanza di accertamento con adesione: come detto, presentandola si ottiene una sospensione di 90 giorni dei termini per il ricorso e si apre un canale di dialogo con l’ufficio. Vantaggi: più tempo per preparare la difesa; chance di negoziare una riduzione di imposta e sanzioni; se si arriva a un accordo, fine della vicenda senza processo e con sanzioni ridotte 1/3. Svantaggi: l’adesione implica comunque riconoscere qualcosa; se il Fisco è inflessibile (e su utili ai soci spesso lo è, considerandola materia grave di evasione) si rischia di perdere tempo; in più, l’adesione comporta la rinuncia al ricorso se firmata. Nel caso di un socio convinto di non aver colpe, aderire può risultare amaro. Tuttavia, può valere la pena presentare l’istanza almeno per sondare le intenzioni dell’ufficio. Soprattutto quando l’accertamento è chiaramente eccessivo o contiene errori, spesso in sede di adesione si può ottenere un aggiustamento. Esempio: se imputati €100k ma il socio ha documenti che provano che in realtà i ricavi in nero erano la metà, l’ufficio di fronte a evidenze potrebbe accettare di ridurre le pretese in adesione. – Ricorso diretto: preparare il ricorso e depositarlo entro 60 giorni (o 150 se c’è stata adesione senza esito) in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente. Vantaggi: si porta la questione davanti a un giudice terzo; se si hanno buone argomentazioni, c’è speranza di annullamento integrale; consente di chiedere sospensione per bloccare la riscossione. Svantaggi: tempi più lunghi, costi legali, incertezza dell’esito; se si perde si pagano anche spese di giudizio e sanzioni intere (salvo conciliazione). In genere, quando l’importo in gioco è elevato e/o si ritiene il proprio diritto, si opta per il ricorso.
Va sottolineato: presentare adesione non preclude di fare ricorso successivamente (semplicemente il termine slitta). Quindi molti consigliano: comunque presentare istanza di adesione – perché dà più tempo e magari porta a un accordo – e contestualmente iniziare a redigere il ricorso così da essere pronti se l’accordo fallisce. Durante i 90 giorni di adesione, si può anche valutare meglio la strategia processuale.
Se il valore della lite è basso e il contribuente preferisce chiudere in fretta per ragioni personali, c’è l’opzione acquiescenza: pagare tutto entro 60 gg, ottenendo sanzioni ridotte 1/3. Ad esempio, se l’imposta è piccola ma la battaglia legale costerebbe di più, può convenire. Ma nel nostro tema di solito gli importi non sono trascurabili, quindi raramente si fa acquiescenza.
Un altro fattore: dal 2023 il ricorso può essere deciso da giudice monocratico se l’importo è sotto €3.000. I casi di utili ai soci di importo così basso sono rari; ma se per ipotesi un socio avesse una cifra modesta contestata, sappia che il suo ricorso verrà deciso in udienza da un solo giudice, con iter più snello.
Riassumendo, entro i primi due mesi conviene: – Presentare istanza di adesione per sicurezza, a meno che si sia già certi di voler solo litigare (ma l’adesione dà comunque la sospensione dei termini, che è utile). – Se si aderisce, preparare il ricorso ugualmente, ma tenerlo “nel cassetto” pronto all’evenienza. – Se non si aderisce, predisporre e depositare il ricorso entro 60 gg. – In ogni caso, considerare se chiedere sospensione giudiziale immediata: di solito la si chiede subito con il ricorso, evidenziando il danno (es. importo enorme che porterebbe a dover vendere casa, ecc.). Nei 180 gg successivi il giudice deciderà sulla sospensiva, che se concessa ferma la riscossione.
Da evidenziare: per presentare ricorso per valore sopra 3.000 € è obbligatorio il difensore abilitato (avvocato, commercialista o esperto contabile). Il socio quindi dovrebbe affidarsi a un professionista. Dato il tecnicismo della materia, è fortemente consigliabile farlo anche per importi piccoli.
Argomentazioni difensive di merito
Nel merito, quali sono le linee difensive che il socio (o la società) può sviluppare per far valere le proprie ragioni? Le riassumiamo qui, ricordando che vanno sempre adattate al caso concreto e supportate da elementi probatori:
- Negare l’esistenza degli utili occulti – Questa è la difesa sul fatto generatore: contestare che la società abbia realizzato i maggiori ricavi accusati. Ad esempio, se l’Agenzia ha ricostruito ricavi presunti con una certa metodologia (coefficiente, confronto con acquisti, ecc.), si può dimostrare che quel metodo è errato o sovrastima. Caso tipico: l’ufficio dice “avevi X ricavi in nero perché hai comprato materie prime per 100 e hai dichiarato vendite per 120, mentre il markup medio è 2, quindi dovevi vendere a 200”. La difesa potrebbe mostrare che in realtà quelle materie prime sono state in parte distrutte o scartate, quindi il fatturato in linea era realistico. Oppure l’ufficio trova 100k di versamenti bancari non giustificati e li assume ricavi: il socio può fornire spiegazione lecita (es. erano finanziamenti soci o prestiti da terzi documentati). Se si riesce a far crollare l’assunto che vi fossero utili in nero, cade tutta la costruzione, sia per la società che per i soci. Questa strategia va condotta soprattutto nel ricorso della società. Il socio individualmente può riprendere tali argomenti nel proprio ricorso, ma ovviamente se la società non impugna è più difficile per lui da solo contestare l’an dei ricavi occulti (può comunque farlo, magari portando quei documenti che la società non ha presentato). Ad ogni modo, evidenziare ogni debolezza del ragionamento dell’ufficio: presunzioni non gravi, dati incompleti, errori matematici, ecc. Ad esempio, se la base è un verbale GdF, cercare se mancano le prove di incassi in nero (a volte sono ipotesi). Se il giudice è convinto che l’evasione non sia provata solidamente (presunzioni non gravi né precise), può annullare l’atto.
- Contestare vizi procedurali sostanziali – Ad esempio: difetto di contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio. Nel caso di accertamento sintetico a soci persone fisiche, se l’ufficio non li ha invitati a spiegare la loro capacità di spesa prima di emettere l’atto (per anni fino al 2015), ciò può essere motivo di nullità (giurisprudenza altalenante, ma si può tentare). Altri esempi: l’avviso è motivato per relationem ma senza allegare gli atti: come detto, se questo ha impedito la conoscenza dei fatti contestati, è censurabile. Oppure ancora: mancanza di sottoscrizione valida (dev’essere firmato da dirigente titolato; se non lo è, atto nullo). Questi aspetti formali vanno tutti verificati e eventualmente sollevati come motivi di ricorso. Spesso non sono risolutivi da soli (il giudice può dire “sì manca un allegato ma tanto tu lo conoscevi”), però in alcuni casi hanno portato ad annullare accertamenti.
- Evidenziare eventuali difformità con l’accertamento alla società – Se, poniamo, la società ha vinto in primo grado e i giudici hanno stabilito che i ricavi in nero erano solo 50 e non 100, il socio può usare quella sentenza (non definitiva, ma comunque autorevole) per dire: l’avviso a me per 100 è infondato. Si può anche chiedere la sospensione in attesa del giudizio finale, ma nel frattempo il giudice del socio potrebbe limitarsi a ridurre l’importo in linea con quanto deciso nella causa della società. C’è un istituto chiamato giudicato esterno: una sentenza passata in giudicato riferita alla società può fare stato nel giudizio del socio. Quindi, se per caso la società definisce la lite (conciliazione o sentenza passata) con utili occulti ridotti, i soci dovrebbero beneficiare di ciò (anche eventualmente facendo ricorso per “errore di fatto” in caso fossero già soccombenti su importi maggiori). Sono situazioni complesse, ma da tener presenti.
- Prova contraria sulla distribuzione – Su questo punto ci siamo dilungati prima. Nel ricorso del socio, un capitolo fondamentale sarà: “anche se la società avesse realizzato utili extra, essi non mi sono stati distribuiti”. Qui bisogna portare tutto il materiale possibile a supporto: bilanci postumi che mostrano che l’azienda aveva buchi finanziari, e quindi gli utili in nero sono serviti a tapparli e non ad arricchire i soci; evidenziare che magari nessuna spesa personale anomala è emersa per il socio (stile di vita invariato); se ci sono soci di maggioranza e minoranza, il minoritario può anche insinuare “li avrà presi tutto il socio di maggioranza” (in modo più elegante: “non emerge alcun elemento che colleghi proprio me alla percezione di detti utili, essendo invece emerso che il socio X, amministratore, disponeva di ingenti risorse non tracciate…”). Di sicuro, se sussistono elementi che contraddicono la percezione di redditi occulti da parte dei soci, vanno valorizzati. Ad esempio, come nel caso citato in Cass.2464/2025, i soci hanno esibito prove che loro versavano soldi anziché prelevarli (case ipotecate per debiti, conti in rosso). Questo è un ottimo argomento: se un socio ha dovuto metterci soldi di tasca propria per tenere in piedi la società, è assurdo dire che contemporaneamente ne stesse segretamente traendo profitti. Oppure se si dimostra che gli utili non esistevano in forma liquida, ad es. erano crediti non registrati poi andati persi o merce trafugata, etc. Insomma, cercare di spezzare il nesso “utili non dichiarati = arricchimento del socio”.
- Invocare l’applicazione dell’art. 7, c.5-bis D.Lgs.546/92 sul riparto onere prova – Questo è un motivo giuridico: far presente al giudice che la nuova normativa impone all’ufficio una prova solida e che nel caso di specie l’ufficio si è basato esclusivamente su presunzioni semplici, chiedendo quindi un vaglio severo. In pratica, dire: “a norma dell’art.7 co.5-bis, l’Ufficio doveva dimostrare in modo circostanziato la pretesa; qui invece c’è solo una presunzione di distribuzione, non corroborata da altri elementi a carico del socio – ciò rende l’accertamento carente”. Alcune commissioni tributarie hanno annullato atti per questo motivo (es. CTR Emilia 2023 cit. in ConsulenzaLegaleItalia, che rigettò appello Entrate per non aver assolto all’onere probatorio nella contestazione di costi). Dunque, pur sapendo che la Cassazione ad oggi è rigida, vale la pena sollevare la questione: potrebbe trovare orecchie sensibili in giudici di primo/secondo grado, specie se la presunzione appare davvero esile.
- Rideterminazione dell’imponibile pro socio – In subordine, se proprio non si riesce a far annullare tutto, proporre almeno una riduzione. Ad esempio: se ritenete che l’ufficio abbia esagerato nel quantificare i ricavi occulti, provate a rifare i conti in modo più aderente e suggerite al giudice tale quantificazione minore (magari supportandola con perizia di parte). Il giudice tributario ha il potere di ridurre le pretese se le ritiene eccessive rispetto alle evidenze (potere di valutazione equitativa in caso di presunzioni semplici). Ad esempio, può dire: “non erano 100k di ricavi in nero, ma 50k” e quindi dimezzare l’imposta. Sempre meglio di nulla.
In concreto, nel ricorso del socio conviene strutturare i motivi così: – 1) Insussistenza della base imponibile occultata: contestare che la società abbia realizzato i maggiori redditi (qui ovviamente se si difende anche la società, basta richiamare quanto dedotto da essa). – 2) Inapplicabilità presunzione in difetto condizioni (eventualmente): esempio, se la società avesse 6 soci, si potrebbe sostenere che non è ristretta base (tesi debole oltre 5, ma tentar non nuoce). Oppure se l’utile accertato era solo frutto di riprese formali (costi indeducibili reali) argomentare che non era utile distribuibile. – 3) Mancato assolvimento onere probatorio da parte del Fisco: richiamo art.7 c.5-bis e mancanza indizi individualizzati sul socio. – 4) Prova contraria del socio: qui elencare tutto ciò che mostrerebbe non percezione (estraneità, reinvestimento, ecc.), magari suddividendo in sottoparagrafi (es. “assenza di arricchimento personale di Tizio in quegli anni”, “utilizzo aziendale dei fondi occulti per…”, “estraneità di Tizio alla gestione”). – 5) Errori di calcolo/importi (se ce ne sono). – 6) Sanzioni: chiedere, in caso di conferma dell’imposta, almeno la riduzione delle sanzioni al minimo o l’applicazione delle attenuanti (per esempio, a volte se il comportamento è stato indotto da incertezza normativa su una deduzione, si può chiedere di non applicare sanzioni ex art. 6 D.Lgs.472/97).
Strumenti procedurali durante il contenzioso
Oltre alla presentazione del ricorso e dell’eventuale appello, ricordiamo alcuni strumenti a disposizione del contribuente durante la causa tributaria, utili per rafforzare la difesa:
- Istanza di sospensione dell’atto: come detto, va presentata con il ricorso (o anche dopo se emergono rischi) per sospendere l’esecutività dell’avviso. Nel motivarla, sottolineare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato: ad esempio, l’importo elevato potrebbe costringere a cessare l’attività, o espropriare la casa di abitazione, ecc. Allegare documenti (es. situazione patrimoniale) per convincere il giudice. Sul fumus boni iuris (cioè probabilità di vittoria) anticipare brevemente i punti forti della difesa. Se la sospensione viene concessa, il ruolo non verrà affidato finché non arriva la sentenza di primo grado (o se era già stato affidato, Agenzia Riscossione non potrà procedere).
- Produzione documentale e memorie: nel processo tributario è ammessa la produzione di tutti i documenti utili fino a 20 giorni prima dell’udienza di primo grado (ed entro 30 gg dal ricorso in appello). Il socio deve sfruttare questo: ad esempio, se recupera estratti conto, contratti, perizie, ecc. dopo il deposito del ricorso, può produrli con una memoria integrativa. Anche articoli di stampa, statistiche di settore, tutto può servire. Non c’è discovery da parte dell’Agenzia, quindi sta al contribuente portare elementi.
- Consulenza tecnica d’ufficio (CTU): raramente usata nel tributario, ma possibile. Se la quantificazione dei ricavi occulti è complessa, il contribuente può chiedere al giudice di nominare un consulente tecnico per rifare i calcoli indipendentemente. Ad esempio, in caso di contabilità parallela intricata, far analizzare a un CTU i flussi può giovare. Il giudice decide discrezionalmente se ammetterla. Se i conteggi dell’ufficio appaiono manifestamente errati, una CTU può confermare errori e portare ad annullamento parziale.
- Testimonianze/dichiarazioni rese altrove: nel processo tributario ordinario non è ammessa l’escussione di testimoni (art. 7 D.Lgs.546/92 vieta la prova testimoniale). Tuttavia, se vi sono dichiarazioni già raccolte in altri procedimenti (es. dichiarazioni rese a verbale durante il controllo, o testimonianze in sede penale), queste possono essere allegate come documenti. Ad es., se in un processo penale l’amministratore ha confessato “quei soldi li ho tenuti io senza dire nulla agli altri soci”, tale verbale può essere prodotto a vantaggio dei soci inconsapevoli. Allo stesso modo, se i clienti/fornitori in verifica hanno reso dichiarazioni che ridimensionano la portata delle vendite in nero, vanno presentate.
- Interazione col processo penale: se parallelo. Se è in corso un procedimento penale per i medesimi fatti (ad es. dichiarazione fraudolenta), si può valutare di chiedere al giudice tributario una sospensione del processo tributario in attesa dell’esito penale (art. 295 c.p.c.), qualora il penale possa accertare i fatti con autorità di cosa giudicata. In realtà, come discusso, un’eventuale assoluzione penale non vincola il giudice tributario se basata su insufficienza di prove, per cui spesso conviene proseguire ugualmente col tributario senza aspettare. Tuttavia, alcune difese coordinano i due processi: ad esempio, in penale talvolta è opportuno patteggiare, ma come abbiamo visto serve pagare il dovuto per poterlo fare nei reati di infedele/omessa dichiarazione. La scelta dipende dal contesto.
- Conciliazione giudiziale: come già accennato, fino all’udienza di trattazione è possibile trovare un accordo transattivo con l’ufficio. Spesso l’ufficio stesso (l’Avvocatura dello Stato o il funzionario delegato) poco prima dell’udienza di merito propone una conciliazione se intravede rischio di perdere. Per esempio, potrebbero offrire di ridurre imposta e sanzioni del 30% ciascuna. Il contribuente valuterà: se la proposta è buona e elimina incertezza, può accettare. La conciliazione va formalizzata in udienza e omologata dal giudice, dopodiché l’atto si considera definito in quei termini. Nota: con la riforma 2023 la conciliazione può essere anche su singoli gradi di giudizio (es. in appello col pagamento del 90% di quanto dovuto). Dunque anche se si perde in primo grado, c’è ancora chance di patteggiare uno sconto in appello.
Riassumendo, la chiave per difendersi bene è: giocare d’anticipo, usare tutti gli strumenti disponibili (memorie, adesione, sospensiva), e soprattutto presentare al giudice un quadro coerente e documentato che smonti la presunzione o quantomeno ne riduca l’impatto. Bisogna far emergere il ragionevole dubbio che i soci abbiano davvero beneficiato di quegli utili occulti.
Aspetti sanzionatori e penali correlati
Un accertamento fiscale su utili in nero comporta non solo il recupero delle imposte evase, ma anche pesanti sanzioni amministrative e possibili conseguenze penali tributarie. È importante comprenderle per gestire al meglio la situazione (ad esempio decidere se pagare subito per attenuare guai penali, o come chiedere rateizzazioni). Esaminiamo separatamente sanzioni e profili penali.
Sanzioni amministrative tributarie
Dal punto di vista societario e personale abbiamo due set di sanzioni: – Sanzioni alla società: la violazione tipica è la dichiarazione infedele dei redditi (art. 1 D.Lgs. 471/97). Questa si configura quando l’imposta evasa supera (per singolo tributo) i 5% di quella dichiarata o €2 milioni. In casi di utili occultati, di solito tali soglie sono superate, quindi c’è materia. La sanzione base per dichiarazione infedele è il 90% della maggiore imposta dovuta. Può salire fino al 180% in presenza di circostanze aggravanti (frode, recidiva) ma di norma l’ufficio applica il minimo del 90%. Quindi, se Alfa S.r.l. evaso IRES per €24.000, la sanzione è €21.600. Se evaso IVA per €22.000, sanzione €19.800, ecc.. – Sanzioni al socio: il socio che non ha indicato nella propria dichiarazione i redditi di capitale percepiti (presunti) ha anche lui commesso dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs.471/97), oppure omessa dichiarazione se addirittura non presentò il modello (ma quest’ultima ipotesi è rara, di solito presentava la dichiarazione ma senza includere quell’importo). La sanzione quindi è sempre il 90% della maggiore IRPEF dovuta su quegli utili, elevabile al 180% in casi estremi. Ad esempio, se su €50.000 di utili in nero la maggiore IRPEF è €20.000, la sanzione sarà €18.000 (90%). Stessa logica di riduzioni/aggravanti come sopra.
Va segnalato che l’art. 6 comma 4 del D.Lgs.472/97 esclude sanzioni per omessa dichiarazione di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Cioè se quell’utile fosse stato soggetto a ritenuta d’imposta (come i dividendi di partecipazioni non qualificate, tassati alla fonte), il socio non viene sanzionato per non averlo dichiarato. Ma nel nostro caso gli utili occulti ovviamente non hanno subìto alcuna ritenuta, e l’ufficio li tassa con imposta sostitutiva/IRPEF recuperandola tutta: quindi la sanzione si applica eccome.
Riduzioni sanzioni: possono essere ridotte in varie circostanze: – Adesione all’accertamento: comporta sanzioni ridotte a 1/3. Quindi dal 90% si scende al 30% della maggiore imposta. Idem se adesione la fa la società, 1/3 su quelle. – Acquiescenza (pagamento senza ricorso): anche qui sanzioni a 1/3 (art.15 D.Lgs.218/97). – Conciliazione giudiziale: sanzioni al 40% del minimo in primo grado, 50% in appello. – Esimenti: se il contribuente prova che c’era obiettiva incertezza normativa sull’obbligo tributario, le sanzioni vanno annullate (art. 6 comma 2 D.Lgs.472/97). Ma negli utili in nero difficilmente si può invocare: la norma è chiara, è un’evasione palese, non un cavillo interpretativo.
Un caso limite: se il socio riuscisse a dimostrare che lui era completamente estraneo e in buona fede, potrebbe tentare di invocare l’assenza di colpevolezza (art. 5 c.1 D.Lgs.472/97) per ottenere l’annullamento delle sanzioni a suo carico. Ad esempio, socio di minoranza inconsapevole: potenzialmente, se il giudice gli toglie l’imposta per estraneità, a maggior ragione le sanzioni non ci sono. Se invece, ipotesi strana, gli lasciassero l’imposta ma lo ritenessero incolpevole, potrebbero tecnicamente applicare imposta senza sanzioni (è raro, ma vi sono principi generali per cui le sanzioni presuppongono la colpa quantomeno). In pratica, però, se il socio perde sul merito, le sanzioni gliele confermano quasi sempre.
Interessi: oltre alle sanzioni, vanno pagati gli interessi di mora sulle imposte evase. Decorrono dal giorno in cui l’imposta andava pagata originariamente. Per IRPEF 2019, ad esempio, dal 1° luglio 2020. Il tasso negli ultimi anni è intorno al 3-4% annuo e l’Agenzia lo calcola fino alla data di notifica dell’avviso (poi ci sono interessi di ritardata iscrizione se non si paga, ecc.). Gli interessi non sono riducibili né condonabili se non pagando prima possibile (ma tanto fino al giorno del versamento maturano).
In caso di soccombenza in giudizio: se il contribuente fa ricorso e perde, in appello o Cassazione, deve pagare l’intera sanzione (o quella stabilita dal giudice se l’ha rimodulata). Non ci sono ulteriori aggravi (prima era previsto +50% in appello per le sanzioni, ma è stato abolito). Il giudice può ridurre le sanzioni in sentenza per equità se lo ritiene (ad esempio se il contribuente ha cooperato).
Sanzioni e definizioni agevolate: da segnalare che a volte il legislatore introduce condoni o definizioni agevolate delle liti che prevedono lo stralcio totale delle sanzioni (come la “tregua fiscale” del 2023 per le liti pendenti fino a 2019). Non è sistematico, ma va tenuto d’occhio: se capitasse, potrebbe convenire aderire e pagare solo le imposte, con sconto su sanzioni e interessi.
In conclusione, il peso sanzionatorio è elevato: il socio deve calcolare che, oltre all’imposta evasa, dovrà sborsare quasi un altro importo simile in sanzioni e interessi. Ad esempio, €20.000 di IRPEF evasa -> €18.000 di sanzione ridotta, più interessi ~€2.000 (a spanne), totale ~€40.000. Ciò spiega perché spesso i contribuenti cercano accordi per ridurre l’impatto complessivo.
Reati tributari e conseguenze penali
L’emersione di utili extracontabili di una certa rilevanza può configurare uno o più reati tributari, puniti dal D.Lgs. 74/2000. Vediamo quali reati tipicamente si presentano e come si intrecciano con l’accertamento:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti falsi (art.2 D.Lgs.74/2000): se l’azienda ha occultato utili tramite false fatture di acquisto (costi fittizi), come nel Caso 1 di esempio, si integra questo reato. Soglia: se l’imposta evasa (sommando IRES e IVA indebita) supera €100.000. Pena: reclusione 4 a 8 anni (limiti aumentati dalla riforma 2019). Nell’esempio Alfa S.r.l., l’amministratore fratello sarebbe imputato per questo (100k costi falsi, IVA evasa 22k > soglia €30k IVA, IRES evasa 24k > soglia 30k? Forse no per IRES, ma per IVA sì, reato configurabile).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3): simile al precedente ma per condotte fraudolente diverse da false fatture, ad es. doppie contabilità, operazioni simulate. Soglia evasa > €100.000. Potrebbe applicarsi se, ad esempio, si teneva un doppio libro segreto e si è presentata dichiarazione infedele con artifizi.
- Dichiarazione infedele (art.4): scatta quando l’imposta evasa supera €100.000 e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a tassazione supera il 10% del dichiarato o comunque €2 milioni. Nel caso di utili in nero, se l’azienda ha evaso oltre 100k € di imposta (somma di IRES + IVA, in genere l’IVA evasa non conta per questo reato, è a parte), e i ricavi non dichiarati sono oltre il 10% del totale dichiarato, l’amministratore commette dichiarazione infedele. Pena: reclusione 2 a 4,5 anni (aumentata nel 2019). Per i soci, la dichiarazione infedele personale (es. non dichiarare dividendi) è tecnicamente reato se imposta evasa >100k e utile non dichiarato >10% reddito dichiarato o >€2m. Potrebbe capitare se un socio percepisce un dividendo occulto enorme e non lo dichiara. In tal caso anche il socio commetterebbe reato di dichiarazione infedele. Tuttavia, in pratica, l’attenzione penale è concentrata sugli amministratori autori dell’evasione societaria; per il socio che semplicemente incassa può essere contestato concorso in quel reato o riciclaggio se nasconde proventi, ma raramente lo si imputa di dichiarazione infedele a titolo autonomo (specie perché i dividendi se fossero regolari non li dichiarerebbe comunque, essendo a ritenuta fissa).
- Omessa dichiarazione (art.5): se la società non ha proprio presentato la dichiarazione (evasione totale) ed evaso > 50k imposta, è reato. Se il socio non presenta la sua dichiarazione e doveva più di 50k, reato. Ma casi particolari.
- Emissione di fatture false (art.8): se l’azienda era quella che emetteva fatture per creare costi falsi ad altre, può scattare per i rappresentanti.
- Occultamento/distruzione di documenti contabili (art.10): se l’azienda teneva contabilità parallela e occultava libri per non far ricostruire gli utili, reato (pena 3-7 anni). In alcuni casi in presenza di doppi bilanci.
- Omesso versamento IVA (art.10-ter): se gli utili in nero comportano anche IVA non versata oltre €250k, l’amministratore potrebbe essere imputato pure di questo.
Nel nostro contesto tipico, i reati probabili sono: dichiarazione fraudolenta (se c’è artificio), o dichiarazione infedele (se solo omissioni di ricavi), e l’amministratore/legale rappresentante ne risponde. I soci che non gestiscono direttamente di solito non sono imputati, a meno che si dimostri un loro concorso (es. socio attivo che ordina di tenere doppi conti).
Interazione con la fase tributaria: – Quando c’è un sospetto di reato, la GdF o AdE trasmette denuncia alla Procura. Ciò come detto raddoppia i termini di accertamento. Inoltre, possono scattare misure cautelari penali: es. sequestro preventivo per equivalente sui beni della società o dell’amministratore, fino all’ammontare imposte evase. Recentemente, con Cass. 1519/2025 CGT Calabria (citata in Ratio), è stato convalidato un sequestro conservativo sui beni di una società e dei soci in un caso di cessione sospetta e distribuzione utili che poteva vanificare la riscossione. Quindi, l’autorità può bloccare patrimoni a garanzia del credito erariale (il penale lo fa con sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
- Pagamento e cause di non punibilità: la riforma del 2019 ha introdotto l’art.13-bis D.Lgs.74/2000 che stabiliva che per alcuni reati (tra cui dichiarazione infedele e omessa) il pagamento del debito tributario integrale fosse condizione per accedere al patteggiamento e causa di non punibilità (per reati dichiarativi meno gravi). La Corte Costituzionale nel 2021 ha dichiarato illegittimo subordinare il patteggiamento ai reati più gravi (fraudolenta) al pagamento perché irragionevole; ma per i reati come infedele la condizione rimane. Ciò significa: se l’amministratore viene accusato di dichiarazione infedele, per poter patteggiare la pena deve aver estinto tutto il debito tributario (imposte, sanzioni, interessi). Se non paga, niente patteggiamento e va a processo ordinario. Anche se patteggiasse senza pagare (ammettiamo ipotesi concessa), c’è il rischio concreto che il giudice disponga comunque la confisca dei beni per equivalente all’imposta evasa. Insomma: pagare il dovuto è praticamente la via maestra per uscire bene sul piano penale. Se l’azienda o i soci saldano l’erario, spesso in questi casi scatta la causa di non punibilità per particolare tenuità (se sotto soglie minime) o comunque il giudice può attenuare di molto la pena.
- Indipendenza dei giudizi penale e tributario: un punto cruciale. Il giudicato penale non vincola il giudice tributario, se non in rari casi. Ciò vuol dire che, come da FAQ sotto, assoluzione penale ≠ automatico annullamento imposte. L’assoluzione magari arriva per mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma in campo tributario valgono le presunzioni e uno standard di prova inferiore, quindi il fisco può comunque esigere le somme. C’è giurisprudenza di Cassazione che lo esplicita: le presunzioni tributarie possono non bastare per condannare penalmente, ma essere sufficienti per l’accertamento fiscale. Ingiusto a vedersi ma legale. Viceversa, una condanna penale definitiva aggrava molto la posizione in sede tributaria: se un giudice penale dice che Tizio ha occultato 100k di ricavi, difficilmente in Commissione Tributaria si potrà sostenere il contrario.
In sintesi, il contribuente e i suoi consulenti devono considerare attentamente la strategia penale in parallelo a quella fiscale: – Se l’importo è grande e c’è rischio galera, può convenire pagare subito (magari chiedendo prestiti o vendendo beni) per fruire di attenuanti o non punibilità. Questo però contrasta con l’interesse a non pagare se si crede di aver ragione nel tributario. È un dilemma classico. Una via di mezzo è cercare definizioni agevolate (rate, rottamazioni) o depositare somme a garanzia in attesa dell’esito. – Durante le trattative col Fisco (adesione, conciliazione) tenere presente l’impatto sul penale: se definisco pagando tot, risolvo forse penalmente, se non definisco e trascino può peggiorare. – Patteggiamento: se si vuole patteggiare la pena, bisogna aver sistemato col Fisco. Oppure confidare che il reato contestato non richieda il pagamento (es. dichiarazione fraudolenta non lo richiede dopo la sentenza Corte Cost).
Infine, da menzionare: in alcuni casi il socio di maggioranza che ha incassato utili in nero potrebbe essere incriminato per autoriciclaggio se ha impiegato quei proventi in altre attività, ma solitamente resta all’interno del reato fiscale.
In conclusione, l’aspetto penale in materia di utili occulti riguarda più la figura gestionale (amministratore) che i soci passivi. Tuttavia i soci coinvolti dovrebbero coordinarsi con i professionisti anche su questo fronte. Talvolta, mostrare collaborazione in sede fiscale (pagando o aderendo) può convincere la Procura a concedere attenuanti o soluzioni meno afflittive. È sempre un delicato bilanciamento tra rischi economici e personali.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito proponiamo una serie di domande comuni sul tema “accertamento fiscale da utili extracontabili presunti al socio”, con risposte concise che riassumono quanto visto finora e forniscono indicazioni pratiche.
D: Cosa significa esattamente “utili extracontabili”?
R: È sinonimo di utili “in nero”, ossia profitti effettivamente realizzati da una società ma non registrati nelle scritture contabili e quindi non dichiarati al Fisco. Possono derivare da vendite non fatturate, ricavi occultati o anche da imposte risparmiate indebitamente tramite costi fittizi. In pratica è la parte di utile aziendale nascosta al Fisco. Nel caso di società di capitali, tali utili restano nella disponibilità occulta dei soci/amministratori fino a che non vengono scoperti.
D: Come fa l’Agenzia delle Entrate a scoprire utili non contabilizzati?
R: Utilizza vari strumenti di controllo incrociato e analisi. Ad esempio: confronta i dati forniti da fornitori e clienti (se un fornitore dichiara vendite a una società ma quest’ultima non le registra, emerge uno scostamento); svolge indagini finanziarie sui conti bancari aziendali e dei soci (versamenti ingenti senza giustificazione contabile possono indicare ricavi in nero); verifica il tenore di vita dei soci (acquisti di lusso non compatibili col reddito dichiarato possono segnalare utili occulti goduti privatamente); effettua accessi e ispezioni presso l’azienda (controllo fisico del magazzino, ricerca di doppie scritture o appunti extracontabili). Inoltre incrocia indicatori economici con i dati medi di settore: se i margini o il volume d’affari dichiarati sono inspiegabilmente bassi rispetto a imprese simili, scattano approfondimenti. La Guardia di Finanza ha reparti specializzati che, durante le verifiche, sanno scovare anomalie contabili e flussi di denaro non ufficiali.
D: In cosa consiste l’“accertamento induttivo basato su presunzioni”?
R: È un tipo di accertamento in cui l’Amministrazione ricostruisce il reddito imponibile del contribuente non (o non solo) in base ai libri contabili, ma tramite indizi e presunzioni. Si parla di analitico-induttivo quando i libri esistono ma sono in parte inattendibili, e di induttivo puro quando manca del tutto una contabilità affidabile. Si basa su presunzioni che per legge devono essere gravi, precise e concordanti: ossia un insieme di elementi presuntivi sufficientemente robusti (es. movimenti finanziari non spiegati, percentuali di ricarico anomale, consumi di materie prime incoerenti con le vendite dichiarate, ecc.). Se tali presunzioni reggono, l’ufficio può quantificare maggiori ricavi o minori costi e determinare un nuovo reddito imponibile su cui applicare le imposte. È quindi un accertamento “per deduzione logica”, contrapposto all’accertamento analitico classico che si fonda solo su prove dirette (come fatture mancanti o scritture false). Nel nostro caso, l’accertamento di utili extracontabili è per definizione induttivo, perché deduce l’esistenza di utili nascosti da segni indiretti di evasione (non risultando questi utili da documenti contabili ufficiali).
D: Quando scatta la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili?
R: Questa presunzione scatta automaticamente (salvo prova contraria) in presenza di due condizioni: 1. La società accertata è una società di capitali a ristretta base partecipativa (pochi soci, spesso familiari o comunque collegati fra loro). 2. Viene accertato un maggior reddito imponibile non dichiarato (utili extracontabili) in capo alla società.
Se c’è questo scenario, si presume che i maggiori utili siano stati distribuiti “pro quota” ai soci nell’anno stesso in cui la società li ha conseguiti. Ad esempio, una S.r.l. con 2 soci al 50% ha occultato utili per €100.000 nel 2022: il Fisco presuppone che €50.000 siano andati a ciascun socio nel 2022 come utili in nero, e notifica ai soci avvisi per tassare quei €50.000 a testa come redditi di capitale non dichiarati. (Naturalmente il socio può cercare di provare il contrario, vedi oltre.)
D: La presunzione vale anche se i soci non sono persone fisiche ma altre società?
R: Sì, vale comunque. La Cassazione ha chiarito nel 2025 che anche se la compagine sociale è formata da altre società (ad esempio holding, fiduciarie), l’importante è vedere se dietro di esse il controllo è in poche mani. Se la sostanza è che c’è un piccolo gruppo familiare o di soci di riferimento che, tramite le varie scatole societarie, detiene l’azienda, la presunzione si applica ugualmente. In altre parole, le società intermediarie sono considerate un “mero schermo” non opponibile al Fisco. Occorrerà poi imputare gli utili ai soci finali effettivi. Quindi, se Alfa S.r.l. (base ristretta) ha come unico socio Beta S.r.l., e questa a sua volta è posseduta da due fratelli, l’utile occulto di Alfa sarà considerato distribuito pro quota ai due fratelli (tramite Beta). In pratica l’Amministrazione non si ferma alla forma: risale la catena partecipativa fino alle persone fisiche di controllo.
D: Sono socio al 10% di una S.r.l. familiare, ma non sono parente né coinvolto nella gestione. Rischio di dover pagare tasse su utili che non ho mai ricevuto?
R: Potenzialmente sì, secondo la presunzione generale. Tuttavia, hai la possibilità di difenderti dimostrando la tua estraneità ai fatti di gestione. La Cassazione di recente (orientamento minoritario ma accolto) ha riconosciuto che se il socio prova di essere stato totalmente estraneo alla conduzione societaria (un socio solo di nome, senza poteri né ruolo attivo), la presunzione di distribuzione non deve applicarsi a lui. Quindi nel tuo caso dovresti, in caso di accertamento, presentare in giudizio tutti gli elementi che provano che tu non partecipavi agli utili e non avevi voce in capitolo: ad esempio, non eri amministratore, vivevi altrove, nessun bonifico o beneficio a tuo favore dalla società; magari i soci di maggioranza possono testimoniare che reinvestivano tutto in azienda e tu non percepivi nulla. Se riesci a convincere i giudici, potresti essere escluso dalla tassazione degli utili in nero (o quantomeno far annullare l’avviso verso di te). Attenzione però: è una difesa non facile, serve estraneità “assoluta” dimostrata. Se semplicemente eri socio minoritario ma comunque sapevi e lasciavi fare, la presunzione tenderà a colpire anche te. È fondamentale raccogliere prove concrete della tua estraneità (es. verbali assemblee dove non compari, corrispondenza che mostra che eri tenuto all’oscuro, ecc.).
D: Come posso provare che i soci non si sono divisi gli utili in nero?
R: La prova classica è mostrare che gli utili extra sono rimasti nell’azienda, cioè sono stati reinvestiti o accantonati. Ad esempio, se il denaro in nero è confluito in una cassa occulta e usato per comprare macchinari poi registrati ufficialmente (magari formalizzati come “apporto soci” in un secondo momento), potresti documentare questo flusso. Un’altra prova, come detto, può essere la totale estraneità di uno o più soci. Inoltre, qualsiasi elemento che contraddica la percezione di utili in nero da parte dei soci: ad esempio, l’assenza di qualunque aumento di ricchezza personale dei soci in quegli anni (niente acquisti di case, auto, investimenti); addirittura, se vi sono tracce che i soci hanno dovuto immettere denaro proprio per sostenere la società (es. finanziamenti soci versati, fideiussioni personali escusse per debiti bancari), ciò mal si concilia con l’idea che abbiano anche prelevato utili occulti. Nel caso esaminato dalla CTR poi sfociato in Cass. 2464/2025, ad esempio, i soci provarono: zero movimenti bancari anomali a loro favore, conti correnti anzi in rosso; case dei soci pignorate per debiti sociali; insomma, nessun beneficio economico per loro. Questi indizi hanno convinto il giudice d’appello (anche se poi Cassazione ha chiesto di riesaminarli nel merito). In sintesi: puoi utilizzare estratti conto, bilanci, documenti aziendali e qualsiasi fatto (anche testimonianze in sede penale, o dichiarazioni rese in sede di adesione) che faccia capire che quei soldi non sono finiti ai soci ma sono stati destinati altrove o non sono proprio mai esistiti come utili liquidi (ad esempio erano crediti fittizi mai incassati, ecc.).
D: La società ha già pagato le imposte evase su quegli utili; devono pagarle di nuovo i soci? Non è una doppia tassazione?
R: In realtà, sì e no. È una doppia imposizione economica ma non illegittima. Il sistema fiscale sulle società di capitali prevede di base due livelli di tassazione: società (IRES) e soci (IRPEF sui dividendi). Se si froda il Fisco occultando utili, quando vieni scoperto recuperano entrambi i livelli: la società paga l’IRES evasa, e i soci pagano l’IRPEF sul dividendo in nero. Non c’è una norma che eviti al socio di essere tassato se la società ha pagato, perché sono due soggetti diversi e due presupposti distinti. Inoltre, come abbiamo chiarito, i soci vengono tassati sull’importo lordo degli utili occulti, senza scomputo dell’IRES teorica. Dunque succede spesso che sommando il prelievo su società e soci si superi anche il 60-70% dell’utile, è vero. È duro, ma è la conseguenza di aver cercato di eludere entrambi i livelli. Possiamo dire che il sistema punisce così la doppia evasione (societaria e personale). In altre parole, la legge considera che il socio, ricevendo utili in nero, non abbia sopportato il prelievo societario, quindi glielo fa pagare per intero come se fosse reddito ordinario suo. Quindi, purtroppo, sì: anche se la società paga, i soci devono comunque pagare la loro parte, e viceversa – non c’è compensazione. L’unico caso in cui il socio potrebbe ottenere qualcosa è se l’ufficio ha erroneamente imputato al socio più del dovuto (ad esempio conteggi duplicati); allora va corretta la determinazione. Ma se tutto è fatto secondo le regole attuali, il socio non può eccepire doppia tassazione giuridica, perché il reddito di capitale del socio è un’altra categoria rispetto al reddito d’impresa della società.
D: Cosa succede se la società viene sciolta prima che il Fisco scopra gli utili occulti? I soci sono responsabili?
R: Sì, i soci rimangono responsabili. La chiusura della società non è un escamotage per sfuggire: la legge (art. 28 c.4 D.Lgs. 175/2014) consente di notificare accertamenti entro 5 anni dalla cancellazione. L’Agenzia, in tali casi, di fatto accerta il reddito evaso come se la società vivesse ancora e lo attribuisce direttamente ai soci. In pratica, arriva al socio un avviso di accertamento per il reddito di partecipazione relativo agli anni in cui la società era attiva, presumento che eventuali utili non dichiarati siano finiti a lui in sede di liquidazione o prima (come distribuzioni extra-bilancio). I soci rispondono entro il limite di quanto hanno ricevuto dal patrimonio sociale in liquidazione, ma attenzione: se parliamo di utili in nero, per definizione non comparivano nel bilancio finale, quindi il Fisco assume che se li sono presi fuori bilancio. In sostanza, i soci non sono al riparo; anzi, come evidenziato in dottrina, la loro posizione è più debole perché non c’è più la società come entità interposta a fare da “scudo”. Avranno comunque diritto di difesa e di provare che magari la società si era sciolta senza attivo (quindi se c’erano utili in nero sono andati persi o spesi per debiti). Ma non possono opporre la cessazione come motivo di non tassabilità. Anche la Cassazione ha detto che, cancellata la società, “i soci rischiano di rimanere soggetti all’insidia degli utili extracontabili”. Dunque, sciogliere l’azienda non immunizza dal fisco sugli utili nascosti di prima.
D: Quali sanzioni fiscali si applicano in caso di accertamento di utili in nero?
R: Dal lato società, la violazione tipica è dichiarazione infedele dei redditi (aver indicato un reddito inferiore al reale). La sanzione amministrativa prevista è il 90% della maggiore imposta accertata. Può arrivare fino al 180% in caso di comportamenti fraudolenti o recidiva, ma in genere l’ufficio applica il 90% (minimo). Se c’è anche IVA evasa, la sanzione è il 90%-180% dell’IVA non versata. Dal lato socio, la mancata indicazione di redditi di capitale nella sua dichiarazione IRPEF è anch’essa dichiarazione infedele (o omessa, se non ha proprio presentato il dichiarativo). Anche qui la sanzione è il 90%-180% dell’imposta corrispondente evasa. Quindi, ad esempio, se a un socio si imputano €50.000 in più di reddito (con imposta poniamo €20.000), la sanzione sarà €18.000 (90% di 20k) più interessi. Tali sanzioni possono essere ridotte: – a 1/3 in adesione (accordo col fisco prima del ricorso), – a 1/3 in acquiescenza (se non si fa ricorso e si paga entro 60 gg), – al 40% in caso di conciliazione giudiziale (accordo in corso di processo). Se invece il contribuente fa ricorso e perde del tutto, pagherà il 100% (o la % che il giudice ritiene equa se l’ha modificata). Oltre a questo, ci sono gli interessi di mora (circa 4% annuo) che maturano sulle imposte evase dal momento in cui avrebbero dovuto essere versate fino al pagamento. Non ci sono in casi di evasione sconti sulle imposte: quelle vanno saldate integralmente. Le sanzioni invece possono essere persino annullate se il contribuente prova che c’era obiettiva incertezza normativa (difficile qui) o altre cause di non punibilità, ma è raro. In soldoni, il carico fiscale totale consisterà in: imposta evasa + sanzione + interessi, per ciascun tributo e per ciascun soggetto, società e socio. Fortunatamente, eventuali definizioni agevolate (se il legislatore le prevede) potrebbero permettere di pagare solo imposte senza sanzioni, ma sono misure straordinarie.
D: Posso rateizzare il pagamento se vengo accertato?
R: Sì. Ci sono varie possibilità: – In adesione: l’accordo di accertamento con adesione consente fino a 8 rate trimestrali (o 16 se l’importo supera €50.000). La prima rata va pagata entro 20 giorni dalla firma, le successive ogni 3 mesi con interessi legali. Basta rispettare le scadenze e l’accordo resta valido. – Dopo avviso definitivo: se non si aderisce e l’accertamento diventa definitivo (perché sono scaduti i termini o perché hai perso il ricorso), l’importo viene affidato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) che emetterà una cartella o comunque un’intimazione di pagamento. A quel punto, puoi chiedere a loro la dilazione: tipicamente fino a 72 rate mensili (6 anni) in modo abbastanza automatico se dimostri una situazione di temporanea difficoltà (sotto certe soglie non serve nemmeno una prova forte), oppure fino a 120 rate (10 anni) in casi di grave e comprovata difficoltà (serve un’istruttoria in cui mostri che la rata mensile supera il 20% del tuo reddito). Con la rateizzazione della riscossione, si evitano azioni esecutive finché si paga regolarmente. – In pendenza di giudizio: se hai un ricorso in corso e non ottieni sospensione, potresti comunque richiedere la dilazione del famoso 1/3 provvisorio che ti chiedono dopo 60 giorni. In passato Equitalia la concedeva; oggi con l’avviso di accertamento esecutivo il meccanismo è un po’ diverso, ma di fatto, se la cartella (o l’affidamento provvisorio) parte, puoi rateizzare come detto sopra anche durante il contenzioso. Quindi, una volta che un importo è passato a riscossione, vale quanto detto.
In generale il Fisco tende a facilitare il pagamento dilazionato se uno mostra collaborazione. Attenzione però: la rateizzazione non ferma gli interessi di mora, che continuano a maturare sulle somme dilazionate, e decade se salti più di 5 rate. Inoltre, dal punto di vista penale, la rateizzazione non blocca il procedimento, a meno che il giudice penale non decida di sospenderlo in attesa del pagamento (possibile ex art.13-bis D.Lgs.74). Quindi se interessano i benefici penali occorre completare i pagamenti per dimostrare l’estinzione del debito (o aderire a eventuali sanatorie). Ma almeno, con la rateazione si evita il peso immediato e si scongiurano pignoramenti mentre si paga.
D: Ho ricevuto un PVC (Processo Verbale di Constatazione) della Guardia di Finanza che contesta utili extracontabili; cosa devo fare prima che arrivi l’accertamento?
R: In base allo Statuto del Contribuente, hai 60 giorni dal rilascio del PVC per presentare osservazioni e richieste all’ufficio (Agenzia Entrate) prima che emetta l’avviso (salvo casi di particolare urgenza fiscale). È molto utile sfruttare questo periodo per preparare una memoria difensiva scritta: in essa puoi controbattere punto per punto i rilievi del PVC, portare documenti integrativi, spiegazioni e quant’altro possa convincere l’ufficio a non emettere (o attenuare) l’accertamento. Ad esempio, se la GdF ti ha imputato vendite in nero stimate da certi dati, tu in quei 60 gg produci ulteriori pezze giustificative che ridimensionano l’accertamento (es. prove che parte della merce era difettosa e non vendibile, o che determinati movimenti di conto erano finanziamenti, ecc.). L’ufficio è tenuto a valutare tali osservazioni. Se emergono elementi validi, a volte l’ufficio in autotutela archivia o riduce l’importo (capita di rado, ma è possibile). Inoltre, presentare una memoria ti tornerà utile nel successivo contenzioso, per dimostrare la tua collaborazione e mettere “a verbale” le tue ragioni. Quindi, da fare assolutamente: raccogliere tutto il materiale difensivo e inviarlo con raccomandata A/R o PEC all’ufficio impositore competente, entro 60 giorni dal PVC. Questo è particolarmente importante perché, se poi vai in giudizio, il giudice apprezzerà che avevi già sollevato quei punti prima (e potrà valutare negativamente se l’ufficio li ha ignorati del tutto). Nel frattempo, puoi cominciare a pensare alla strategia successiva (adesione o ricorso). Ricorda che, se credi di avere elementi risolutivi, potresti anche presentare un’istanza di accertamento con adesione prima ancora dell’avviso (è ammesso per legge, art.6 c.1-bis D.Lgs.218/97). Questo obbligherà l’ufficio a invitarti per discutere prima di emettere l’atto. Non tutti lo sanno, ma è una possibilità: “adesione pre-accertamento”. Valuta col tuo consulente se conviene nel tuo caso.
D: Potrei cavarmela col penale patteggiando la pena anche se non riesco a pagare il debito tributario?
R: In teoria il patteggiamento (applicazione pena su richiesta) è possibile per i reati tributari. Tuttavia, la legge aveva introdotto una condizione (nel 2019) per cui per i reati di dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa, bisognava pagare tutti i debiti tributari per poter patteggiare. Questa condizione è stata in parte dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sent. 247/2021) nella parte in cui riguardava i reati più gravi (fraudolenti), ma rimane per infedele e omessa. Quindi per dichiarazione infedele (che è il reato tipicamente connesso agli utili in nero occultati) occorre aver estinto il debito per poter accedere al patteggiamento (art.13-bis D.Lgs.74). In caso contrario, dovresti affrontare il processo ordinario, con tutti i rischi del caso. Anche qualora il patteggiamento fosse eccezionalmente concesso senza pagamento (poniamo reato non coperto dall’obbligo di pagamento), sappi che senza pagamento c’è altissima probabilità che il giudice disponga la confisca di beni per un valore equivalente all’imposta evasa. Quindi cambia poco: o paghi tu spontaneamente e ottieni magari la non punibilità (perché per alcuni reati minori pagare integralmente prima del giudizio estingue il reato), o se non paghi rischi che ti confischino coattivamente beni di quel valore dopo condanna. In conclusione, pagare il dovuto è la via maestra per uscire pulito penalmente. Se proprio non puoi pagare tutto, cerca almeno di ridurre il debito con definizioni agevolate (a volte compaiono “rottamazioni” delle sanzioni, ecc.) o di pagare a rate chiedendo la sospensione del processo penale. Ma la regola attuale lega strettamente il beneficio penale al pagamento.
D: Una mia assoluzione nel processo penale (ad es. perché il fatto non sussiste) mi solleva automaticamente dal dover pagare le imposte?
R: No, non automaticamente. Il giudicato penale non ha effetto vincolante nel tributario (a parte casi rari di sentenze di assoluzione per insussistenza del fatto materiale, che potrebbero far venir meno l’oggetto della pretesa fiscale, ma comunque bisogna attivarsi). Se vieni assolto perché si stabilisce che non c’era volontà di evasione o che non ci sono prove oltre il dubbio, ciò non significa che fiscalmente non devi nulla: magari il fatto c’è stato ma non provato penalmente oltre ogni dubbio. In pratica potresti essere assolto in dubbio, ma l’evasione sul piano civilistico può essere ritenuta comunque avvenuta in base alle presunzioni. Dovrai comunque portare la sentenza assolutoria all’attenzione del giudice tributario se il contenzioso è ancora pendente, sperando che lo convinca. Ma non c’è un automatismo. Viceversa, una condanna penale (soprattutto se definitiva) di solito aggrava la posizione nel tributario: se è accertato penalmente che hai occultato tot ricavi, in Commissione difficilmente ti daranno ragione nel negare la pretesa fiscale. Però formalmente ogni giudice decide in autonomia. Quindi riassumendo: assolto penalmente non vuol dire non tassato, purtroppo. C’è chi ha vinto il penale e poi ha dovuto pagare lo stesso le imposte. La Cassazione ha proprio detto che le presunzioni tributarie possono essere insufficienti per condannare penalmente ma bastare per l’accertamento fiscale. È ingiusto a vedersi, ma dipende dallo standard di prova differente.
D: Quali modelli o documenti dovrei predisporre subito dopo aver ricevuto un avviso di accertamento per utili extracontabili?
R: Consigliamo di attivarti con due documenti chiave: 1. Un’istanza di accertamento con adesione (se vuoi guadagnare tempo e tentare una negoziazione). Va fatta in carta libera e inviata all’ufficio competente (meglio via PEC se disponibile). Puoi usare un modello fac-simile, indicando i tuoi dati, gli estremi dell’avviso e chiedendo espressamente di essere convocato per definire in contraddittorio. Nell’istanza puoi anche anticipare sinteticamente le tue contestazioni (“in riferimento a quanto riportato nell’avviso preciso sin d’ora che… ad es. i ricavi presunti sono sovrastimati perché…”). L’importante è spedirla entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (o 30 gg se fosse un atto doganale, ma nel nostro caso imposte dirette, quindi 60 gg). Questa istanza sospende i termini di ricorso per 90 giorni, dandoti respiro. Se trovi un accordo, pagherai con sanzioni ridotte di molto. 2. In parallelo, prepara il ricorso tributario da presentare in Corte di Giustizia Tributaria se l’adesione non produce risultati. Il ricorso deve contenere: intestazione al giudice competente, i tuoi dati e quelli del tuo difensore (nota: per valore oltre €3.000 devi farti assistere da un difensore tecnico abilitato), gli estremi dell’atto impugnato, i motivi di ricorso in fatto e diritto (cioè le tue argomentazioni), e le conclusioni (es. chiedi annullamento integrale dell’avviso, con vittoria di spese). Va sottoscritto e notificato all’ente impositore (preferibilmente via PEC) entro i termini (60 gg, salvo sospensioni da adesione). Nella sezione successiva di questa guida forniamo un fac-simile di ricorso tributario con uno schema generale adattabile al caso di utili extracontabili. In ogni caso, avere il ricorso già pronto ti permette di depositarlo tempestivamente se l’adesione fallisce. Non aspettare l’ultimo giorno.
D: Se vinco il ricorso in primo grado e l’avviso viene annullato, i soci ottengono automaticamente rimborso di quanto eventualmente pagato?
R: Sì, se l’atto viene annullato con sentenza passata in giudicato e tu (o i soci) avevate versato somme, queste sono da rimborsare. Spesso però accade che in corso di giudizio i contribuenti, per evitare misure esecutive, paghino spontaneamente un po’ (ad es. il famoso 1/3 provvisorio). In caso di vittoria finale, vanno presentate istanze di rimborso all’Agenzia oppure la restituzione avviene d’ufficio dopo un po’. Consigliamo di monitorare e sollecitare il rimborso, allegando copia della sentenza. Se la sentenza di primo grado non è definitiva (perché l’ufficio appella), normalmente non rimborsano ancora: bisogna attendere esito finale o eventualmente chiedere esecuzione provvisoria se possibile (non sempre immediato nel tributario). Comunque, a conclusione positiva della vicenda, ciò che hai pagato in più ti spetta di ritorno, con interessi legali. Assicurati quindi di avviare la procedura di rimborso appena ne hai diritto.
Esempi pratici e casi di studio
Per chiarire ulteriormente come si applicano nella realtà i principi e le regole esposte, presentiamo una serie di casi pratici simulati, basati su situazioni tipiche riscontrabili in Italia. Gli esempi illustrano il meccanismo dell’accertamento e le possibili difese dal punto di vista del contribuente.
Caso 1: Società familiare e costi fittizi – utili occulti presunti distribuiti (Cass. reale 15274/2025)
Situazione: Alfa S.r.l., società a responsabilità limitata composta da 2 soci (fratello e sorella, 50% ciascuno), gestisce un’attività di commercio all’ingrosso di materie plastiche. Nel 2021 la Guardia di Finanza scopre che Alfa S.r.l. ha acquistato fatture false da una “cartiera” (società fittizia) per 100.000 €, relative a operazioni mai avvenute, con lo scopo di detrarre IVA e abbattere il reddito imponibile. In particolare, Alfa ha registrato nel 2019 un finto acquisto di materie plastiche da Beta S.r.l. (società inesistente creata per emettere fatture) per 100.000 €, che però non corrisponde a merce reale fornita.
Accertamento: L’ufficio emette nel 2022 un avviso di accertamento verso Alfa S.r.l. disconoscendo quel costo di 100.000 €. Conseguenze per Alfa:
– Aumenta il reddito imponibile 2019 di Alfa di 100.000 € (prima Alfa aveva dichiarato utile quasi zero).
– Recupera l’IVA indebitamente detratta su quella fattura (€22.000 circa, supponendo IVA 22%).
– Calcola maggiori imposte: IRES 24% su 100k = €24.000; IRAP 3,9% su 100k = €3.900 (l’IRAP viene rettificata se Alfa è soggetta a IRAP).
– Applica sanzione 90% su IRES (€21.600) e analoghe sanzioni su IVA (€19.800, il 90% di 22k) e IRAP (€3.510, il 90% di 3.9k).
Contestualmente, data la ristretta base familiare, l’Agenzia emette anche avvisi di accertamento per IRPEF 2019 a ciascuno dei due soci, presumendo che l’utile extra (€100k) sia stato distribuito metà a testa:
– Ogni socio vede imputarsi €50.000 di “utile extracontabile distribuito”.
– Ciò genera per ciascuno una maggiore IRPEF dovuta (aliquote progressive: supponiamo che con 50k in più ciascun socio entri nello scaglione del 38%, quindi in media pagherà circa €19.000 di IRPEF aggiuntiva a testa).
– Sanzione 90% su ciascun €19k ≈ €17.100 a socio, più interessi.
In aggiunta, parte una segnalazione penale: l’amministratore (il fratello, che era il legale rappresentante) è indagato per dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art.2 D.Lgs.74/2000, perché ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti) e correlativamente per frode IVA.
Difesa: Alfa S.r.l. e i soci decidono di impugnare gli atti. Vediamo alcuni possibili sviluppi difensivi: – Adesione (tentata): in fase di accertamento con adesione, la società ammette l’errore (riconosce che quella fattura era falsa) ma chiede di evitare la tassazione ai soci spiegando che l’utile non fu affatto distribuito ma usato per coprire buchi di liquidità. L’ufficio è rigido: accetta di ridurre le sanzioni al minimo (come da legge) ma mantiene la pretesa sui soci. Non si raggiunge accordo completo. Si va quindi in giudizio. – Ricorso della società: Alfa S.r.l. contesta la validità del metodo accertativo. In realtà qui c’è una prova diretta della frode (la fattura falsa scoperta), quindi sul merito la società ha poco da fare – infatti in Cass. 15274/2025 il ricorso societario fu rigettato. Forse l’unico appiglio è eccepire che Alfa aveva comunque scritture regolari e non sarebbe stato lecito l’accertamento induttivo puro: ma essendo state riscontrate fatture false, l’accertamento analitico-induttivo è giustificato. Quindi la società punta magari a transigere in corso di processo se possibile, ad esempio patteggiando sanzioni. – Ricorso dei soci: i due soci presentano ricorso separatamente, ma con difese coordinate. L’argomentazione centrale: non abbiamo mai percepito quell’utile. Spiegano che Alfa nel 2019 era in crisi di liquidità e quelle somme “risparmiate” con la frode fiscale furono in realtà impiegate per pagare fornitori reali e stipendi, non certo distribuite. Allegano estratti conto aziendali che mostrano la difficoltà finanziaria (saldo negativo in banca, ecc.). Inoltre, la sorella (socio al 50% ma non coinvolta nella gestione) sottolinea la propria estraneità: era una semplice socia di capitale, non amministrava né sapeva delle fatture false (tant’è che il penale vede imputato solo il fratello). Porta a sostegno dichiarazioni rese dal fratello alla Guardia di Finanza in cui lui si assume tutta la responsabilità e afferma che la sorella non c’entrava e non ha avuto un euro. – Pronuncia di primo grado: la Commissione Tributaria potrebbe accogliere parzialmente queste tesi. Ad esempio, potrebbe confermare l’accertamento sulla società (data la prova evidente della frode) ma escludere la sorella dalla presunzione, riconoscendo che era estranea. Magari invece conferma l’imputazione al fratello (amministratore) ritenendo che almeno lui abbia beneficiato de facto del risparmio d’imposta. Quindi, in questo scenario ipotetico, la sentenza di CTP annulla l’avviso verso la sorella e riduce del 50% quello verso il fratello (perché l’altro 50% rimarrebbe non distribuito). – Conseguenze: l’Agenzia potrebbe appellare sulla parte della sorella. Il fratello, nel frattempo, potrebbe valutare di patteggiare in penale, ma per farlo deve aver pagato: supponiamo che, temendo la reclusione, faccia un mutuo e versi tutto il dovuto all’erario (società + socio). Questo pagamento, nel giudizio tributario d’appello, non cambia la sostanza (il ricorso prosegue, semmai il fratello potrebbe rinunciare per cessata materia se ha pagato e non contesta oltre). – Sentenza finale: la CGT di secondo grado conferma: niente tassazione per la sorella, e conferma la tassazione sul fratello del suo 50%. La Cassazione nel 2025 (ordinanza n. 15274) respinge definitivamente il ricorso dell’Agenzia: riconosce che, essendo i soci soltanto due e fratello-sorella, la presunzione in teoria si applicherebbe, ma rileva che nel frattempo il fratello ha patteggiato ammettendo di aver orchestrato la frode e di averne tratto beneficio esclusivo, mentre la sorella è risultata estranea (non imputata). Dunque, la Corte – bilanciando art. 7 c.5-bis e presunzione – decide di dare prevalenza alle prove di estraneità per la sorella. L’avviso al fratello resta dovuto (tanto ha pagato). La sorella ottiene ragione definitiva: le viene rimborsato quanto eventualmente pagato in pendenza di giudizio.
Commento: Questo caso mostra come, in presenza di fatture false e utili occulti generati da costi fittizi, l’accertamento ai soci scatta duro. Tuttavia, evidenziando la crisi aziendale e l’estraneità di taluni soci, si può evitare almeno in parte la doppia tassazione. Nella realtà, la Cassazione 15274/2025 ha affermato proprio il principio che anche se i soci sono società (era un caso di holding), la presunzione vale ugualmente – segno della rigidità dell’approccio. Ma è lecito ritenere che, davanti a prove nette, i giudici possano modulare l’applicazione sui singoli soci.
Caso 2: Finanziamenti soci e ricavi in nero – accertamento induttivo e onere della prova (Cass. 7739/2025)
Situazione: Gamma S.r.l. (3 soci: A 40%, B 40%, C 20%, tutti familiari) attraversa difficoltà di liquidità. Nel 2020 riceve dai soci finanziamenti in contanti per complessivi €300.000, formalmente registrati come prestiti soci fruttiferi. Tuttavia, i redditi dichiarati dei soci A e B erano modesti (30k annui), e non giustificavano la disponibilità di quelle somme; il socio C invece ha venduto proprio nel 2020 una casa ereditata ricavando 250k. L’Agenzia sospetta che quei “finanziamenti soci” siano in realtà ricavi in nero generati da Gamma e poi reimmessi in società. In pratica: Gamma avrebbe sottratto ricavi al fisco e li avrebbe “ripuliti” facendoli figurare come denaro apportato dai soci.
Accertamento: con ordinanza 24.06.2025 n.16904 (dato fittizio ma rifacendoci a Cass. 16904/2025), la Cassazione ribadisce la legittimità di procedere con accertamento induttivo puro ex art.39 c.2 DPR 600/73 in presenza di elementi indiziari come assenza di delibere che giustifichino il finanziamento, incongruenza tra capacità reddituale dei soci e somme versate, uso di contanti. Nella nostra simulazione, l’ufficio: – Disconosce i finanziamenti come tali e li considera ricavi non dichiarati di Gamma per €300.000. – Emana accertamento a Gamma per maggiori ricavi 2020 di €300k, con IVA evasa (22% di 300k=66k) e IRES evasa (24% di 300k=72k), più sanzioni 90% su entrambi. – Emana anche accertamenti IRPEF 2020 ai soci A, B, C presumendo distribuiti utili extra pro-quota: quindi A €120k, B €120k, C €60k di utile. – Calcola IRPEF aggiuntiva e sanzioni su ciascuno.
Difesa: – Gamma S.r.l. impugna sostenendo che l’accertamento è infondato perché i versamenti soci erano leciti: provenivano, per C, dalla vendita della casa (documentata con atto notarile e bonifici); per A e B, da risparmi familiari accumulati (viene prodotta documentazione bancaria di prelievi di contante dai conti delle mogli, etc.). Gamma contesta inoltre che non c’erano altri indizi di ricavi in nero (nessuna incongruenza contabile, margini in linea, ecc.). Argomenta quindi che l’accertamento induttivo è arbitrario e non basato su presunzioni gravi, ma solo su congetture. – I soci A e B allegano prove di aver ricevuto denaro in prestito da parenti per poi girarlo alla società (esibiscono dichiarazioni giurate dei genitori che attestarono di aver consegnato loro 100k in contanti dalle proprie casse). Il socio C mostra i conti correnti con l’accredito di 250k dal rogito e i successivi prelievi per versarli in Gamma. Chiedono l’annullamento degli avvisi verso di loro, sottolineando che se anche vi fossero stati utili occulti, comunque loro non hanno percepito nulla ma anzi hanno sborsato. – In primo grado, la CTP potrebbe dare ragione in parte ai contribuenti: per il socio C, ad esempio, potrebbe riconoscere la provenienza lecita (vendita casa) e quindi escludere almeno €250k dall’accertamento (il che annullerebbe di fatto la quota di utile extracontabile imputata a C, e ridurrebbe i ricavi non dichiarati di Gamma a 50k – quelli finanziati da A e B). Per A e B, se le spiegazioni sono meno solide (affidarsi a risparmi di famiglia non tracciati è debole), potrebbe ritenere che per €50k (25k ciascuno) non c’era capacità e dunque quell’importo fosse effettivamente provento occulto di Gamma. Così la sentenza CTP forse determina: riduzione dei ricavi in nero da 300k a 50k; di conseguenza tassazione soci solo su 50k pro quota (20k A, 20k B, 10k C). – La Cassazione, con ord. 7739/2025 (reale) però ribalta una decisione favorevole avuta in CTR: infatti la CTR Lombardia aveva creduto alla prova dei contribuenti (vendita partecipazione, etc.), ma la Cassazione ha stabilito che l’onere della prova spetta al contribuente e non basta dimostrare la provenienza lecita delle somme, bisogna anche dimostrare la capacità economica dei soci di effettuarle . Nel nostro scenario, se CTR avesse dato ragione a Gamma, l’ufficio avrebbe fatto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art.2697 c.c. e la Cassazione avrebbe potuto accogliere come in 7739: la CTR non avrebbe considerato adeguatamente l’elemento della sproporzione dei redditi dei soci A e B. – Dunque, la Cassazione ordina un nuovo esame: la causa torna in CTR di rinvio dove, seguendo i principi di diritto enunciati, è probabile che vengano confermate le pretese del fisco almeno per A e B. Infatti la Cassazione chiarisce: la mancanza di redditi adeguati dei soci a giustificare il finanziamento è un forte elemento presuntivo di utili occulti; una volta che il Fisco lo dimostra, spetta ai contribuenti provare che i fondi erano loro e non provenivano dalla società, e non è sufficiente tracciare la provenienza lecita, bisogna provare che i soci ne avevano la disponibilità economica indipendente. – Quindi probabilmente il risultato finale: Gamma perde e deve pagare su almeno parte dei 300k; i soci A e B vengono tassati sui rispettivi utili (perché non hanno provato di essere capaci di finanziare con mezzi propri); il socio C forse riesce a evitare la tassazione sulla sua quota, avendo dimostrato una fonte di denaro congrua (250k da vendita).
Commento: Questo caso illustra l’importanza dell’onere della prova nei finanziamenti soci sospetti di celare utili neri. La Cassazione conferma che l’ufficio può presumere il reimpiego di utili in nero nei finanziamenti e, se i soci non dimostrano di avere ricchezza propria sufficiente, l’accertamento induttivo è legittimo. Quindi per difendersi in tali casi occorre presentare una documentazione molto rigorosa della capacità finanziaria dei soci. Anche vendite di beni – come visto – possono non bastare se l’autorità giudicante ritiene che comunque i contanti possano provenire dalla società stessa (magari la vendita è un pretesto, penseranno i più maliziosi). Fondamentale in questi scenari sarebbe predisporre a monte delibere formalizzate dei finanziamenti, meglio se con bonifici tracciati da conti intestati ai soci (e capienti). L’assenza di delibere e l’uso di contanti sono segnali negativi forti.
Caso 3: Socio inconsapevole vs socio amministratore – esito differenziato (orientamento in evoluzione)
Situazione: Delta S.p.A. è una piccola società di capitali (forma giuridica S.p.A., ma 5 soci in tutto) attiva nel settore edile. Due soci (padre e figlio) possiedono il 60% e gestiscono di fatto l’azienda; gli altri tre soci detengono ciascuno il 10% e sono investitori estranei alla famiglia, senza ruoli operativi. Nel 2022 viene accertato che Delta ha tenuto una contabilità parallela per anni, con incassi in nero da vendite di immobili non registrati per 1 milione di euro. Viene emesso accertamento per utili non dichiarati su Delta e presunta distribuzione ai soci pro quota (600k ai due di controllo – 300k ciascuno – e 100k a testa ai tre piccoli soci).
Difesa: I tre soci al 10% (soci di capitale puri) si oppongono fermamente: portano prove di assoluta estraneità. Uno è un professionista che vive in un’altra città e non ha mai partecipato a un CdA; un altro è un fondo d’investimento rappresentato da un trustee; il terzo è una cugina anziana che ha solo messo capitale anni fa. Inoltre, nel procedimento penale avviato per frode fiscale, nessuno dei tre è indagato, mentre padre e figlio lo sono. I tre soci presentano anche copia di una querela che, appena scoppiato il caso, hanno sporto contro padre e figlio accusandoli di averli defraudati non distribuendo utili veri né fornendo bilanci corretti. Padre e figlio, invece, cercano di patteggiare penalmente, e nel frattempo in sede tributaria sostengono (senza molto costrutto) che gli utili sono rimasti in azienda – difficile da provare con 1 mln in nero trovati in un conto estero intestato proprio al padre.
Esito ipotetico: Dato lo scenario, è plausibile che in primo grado i giudici tributari disapplichino la presunzione per i soci estranei. Le circostanze sono quelle eccezionali che la Cassazione ha indicato: presentazione di querela verso gli amministratori (come in Cass. 21573/2005), socio professionalmente lontano (Cass. 18042/2018), non coinvolgimento nel penale (Cass. 24870/2021). La CTP può quindi annullare gli avvisi verso i tre piccoli soci, ritenendo fornita la prova contraria che quegli utili non furono da loro percepiti. Contestualmente, mantiene l’accertamento sui due soci maggioritari (che in effetti avevano occultato e trattenuto il milione). In appello, l’ufficio insiste contro i piccoli soci, ma la CTR conferma: la presunzione è vinta dalle prove presentate. L’Agenzia ricorre per Cassazione, ma la Cassazione – rifacendosi magari proprio alla sentenza 2464/2025 – rigetta il ricorso, sancendo che la CTR ha correttamente valutato l’“assoluta estraneità” dei piccoli soci come prova contraria sufficiente.
Commento: Qui vediamo l’applicazione concreta dell’apertura giurisprudenziale: i soci di minoranza non coinvolti, che addirittura hanno agito contro gli amministratori, vengono salvati dalla tassazione. Questo riflette equità: sarebbe ingiusto far pagare imposte su utili rubati dai soci di maggioranza senza coinvolgere i minori (che anzi sono vittime in un certo senso). Non a caso la Cassazione in passato aveva segnalato proprio situazioni analoghe come esempi di prova contraria che dovrebbe essere accolta. Tuttavia va ribadito: casi come questo sono rari e devono essere supportati da prove molto forti. Non basta dire “ero minoranza, non so nulla” – qui addirittura c’è una querela contro i maggiori, a dimostrazione di conflittualità e non complicità.
Caso 4: Accertamento post-liquidazione e soci liquidatori – responsabilità dopo estinzione
Situazione: Omega S.r.l., 3 soci (ognuno 1/3), viene posta in liquidazione nel 2018 e cancellata nel 2020 dal Registro Imprese. Durante la liquidazione, i soci hanno ricevuto ciascuno €50.000 come riparto finale. Nel 2023 l’Agenzia scopre che negli anni 2016-2017 Omega aveva omesso ricavi per €300.000. La società però ormai è estinta.
Accertamento: Grazie all’art. 28 c.4 D.Lgs.175/2014, l’ufficio nel 2023 notifica un avviso di accertamento intestato a “Omega S.r.l. in liquidazione (già estinta)” presso il domicilio dell’ex liquidatore, accertando maggiori redditi per 300k (IRES e IVA relative). E contestualmente invia ai 3 ex soci avvisi per redditi di partecipazione 2016-2017, imputando loro 100k di utili extracontabili a testa (presumendo distribuiti in quegli anni).
Difesa: Gli ex soci obiettano che Omega fu chiusa senza attivo oltre a quanto distribuito ufficialmente. Sostengono che i 300k in nero, se c’erano, furono utilizzati per pagare debiti e coprire perdite pregresse, tanto che al momento della liquidazione non ne rimaneva traccia. Producono il bilancio finale di liquidazione che mostrava solo cassa residua per 150k (distribuita 50k a testa) e una nota dei liquidatori che segnalava che parte dei debiti era stata estinta “con sopravvenienze attive non contabilizzate” – un modo velato per dire che si usò cassa occulta. Inoltre, i soci eccepiscono che comunque, essendo Omega cessata, l’avviso avrebbe dovuto essere solo a loro (tesi minoritaria superata dalla normativa, ma la sollevano).
Esito ipotetico: Le commissioni tributarie tenderanno a seguire la legge: la società si considera ancora esistente ai fini dell’accertamento fino al 2025, quindi l’atto a Omega è valido. Ciò stabilisce formalmente l’evasione di 300k. Per i soci, tuttavia, il giudice valuta che i soci non hanno ricevuto oltre a €50k ciascuno (già tassati come capital gain da liquidazione forse). Quindi potrebbe decidere di limitare la tassazione dei soci a 50k ciascuno (quanto effettivamente incassato in liquidazione), o addirittura di non tassarli ulteriormente se ritiene che i 50k erano da considerare coperti da utili regolari (dipende dai conti). Però, per la quota di utili in nero non erogata in liquidazione, se i soci non dimostrano dove sia finita, la presunzione dice che l’avranno presa occultamente prima. Difficile scampo: i soci potrebbero allora puntare a far valere la limitazione di responsabilità: art.2495 c.c. dice soci responsabili di debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in liquidazione. Ecco, questo è un punto chiave: i soci potrebbero sostenere che anche se vengono tassati ora per utili occultati, quell’imposta in realtà è un debito della società che loro pagano da “responsabili” e quindi non eccedente ciò che hanno avuto (50k). Se il Fisco chiedesse loro più imposte di quante ne hanno avute (ipotizziamo 100k utili occulti a testa -> 100k 26% = 26k imposta ciascuno, ok rientra nei 50k ricevuti, quindi ok). – In conclusione, i soci magari perdono* la causa e devono pagare quelle IRPEF, ma di fatto le coprono con parte dei 50k incassati nel 2020 (dovranno tirar fuori 26k + sanzioni). Moralmente è un po’ ingiusto, perché quei 50k erano forse puliti, ma essendo la società chiusa nessuno paga l’evasione societaria se non loro.
Commento: Questo scenario fa capire la portata del prolungamento quinquennale: i soci anche a distanza di anni subiscono gli effetti della presunzione. Non c’è una difesa forte, se non quella di dimostrare che non c’erano utili occulti reali. Ma qui li hanno pure ammesso di fatto (sopravvenienze non contabilizzate). L’unica speranza è ottenere che i giudici riconoscano che gli utili in nero se ne sono andati per coprire debiti, quindi non configurano redditi per i soci. Giuridicamente però l’utile occulto, anche se usato per pagare un debito, sarebbe reddito prodotto e poi speso (non deducibile): la società avrebbe dovuto dichiararlo e poi poteva dedurlo solo se speso in costi deducibili (pagare debiti pregressi non cambia la natura). Quindi i soci difficilmente la spuntano.
In definitiva, nei casi post-estinzione, i soci devono prepararsi a pagare per chiudere la faccenda, salvo importi minuscoli. La norma li sacrifica in nome dell’interesse erariale.
Questi casi coprono una gamma di situazioni possibili e mostrano come, a seconda delle circostanze, l’esito possa variare notevolmente: a volte il socio riesce a evitare la tassazione (caso 3), altre volte subisce in pieno (caso 1 e 2 parzialmente), altre ancora si trova in posizioni miste (caso 4). La miglior difesa è sempre prevenire: mantenere la contabilità regolare, evitare pratiche opache come finanziamenti non giustificati, deliberare formalmente i movimenti coi soci, e ovviamente non occultare ricavi. In mancanza, quando l’accertamento arriva, bisogna agire con tempestività e usare ogni mezzo probatorio per ribaltare o attenuare le presunzioni del Fisco.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39 e 40: disciplina degli accertamenti sintetici e induttivi sui redditi. (Riformato dal D.Lgs. 108/2024 in tema di redditometro).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 44 e 47: definizione dei redditi di capitale e utili da partecipazione. (Prevede tassazione dividendi, anche occulti).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, c.7: diritto del contribuente a presentare osservazioni entro 60 giorni dal PVC. Art. 7: obbligo di motivazione e allegazione atti.
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6: accertamento con adesione (sospende termini e riduce sanzioni a 1/3).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis: (abrogato dal 2024) reclamo/mediazione per liti fino 50k. Art. 7 c.5-bis: onere della prova in capo all’ufficio. Art. 52: sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28 c.4: differimento di 5 anni degli effetti estintivi delle società ai fini tributari. (Confermato da Corte Cost. 142/2021 e Cass. 21593/2024).
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2-5: reati di dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa. Art. 13-bis: causa di non punibilità/patteggiamento condizionato al pagamento integrale.
- Cass., Sez. Trib., ord. 31 luglio 2024 n. 21593: conferma presunzione di distribuzione utili occulti in società a base ristretta, salva prova contraria.
- Cass., Sez. Trib., ord. 9 maggio 2025 n. 12288: ribadisce che basta accertare base ristretta e utili occulti perché scatti presunzione pro quota; l’ufficio non deve provare movimenti bancari dei soci.
- Cass., Sez. Trib., ord. 13 novembre 2024 n. 29289: (citata in dottrina) legittimità presunzione utili ai soci anche senza attendere giudizio su società.
- Cass., Sez. Trib., ord. 24 giugno 2025 n. 16904: finanziamenti soci non giustificati come indizio grave di ricavi in nero, onere della prova a carico contribuente.
- Cass., Sez. Trib., ord. 20 marzo 2025 n. 7739: onere della prova finanziamento soci; cassato verdetto CTR che non aveva considerato insufficienza redditi soci a giustificare versamenti .
- Cass., Sez. Trib., ord. 9 giugno 2025 n. 15274: presunzione distribuzione utili anche se soci sono altre società (base ristretta “di fatto”).
- Cass., Sez. Trib., ord. 8 febbraio 2025 n. 2464: (commentata su Eutekne) per la prima volta aperta a considerare prova contraria l’estraneità totale del socio alla gestione, superando precedente orientamento.
- Cass., Sez. Trib., ord. 3 febbraio 2021 n. 24870: riconosce che se socio non coinvolto in inchiesta penale per utili occulti a differenza di altri, può essere indice di estraneità (citata in dottrina).
- Cass., Sez. V Pen., sent. 247/2021 (Corte Cost.): ha eliminato obbligo pagamento debito per patteggiamento reati fraudolenti, mantenendolo per infedele.
- Cass., Sez. Unite, sent. 1775/2002: principio indipendenza giudicato penale e tributario (vedi anche Cass. 15065/2014: presunzioni tributarie rilevano in sede fiscale anche se non sufficienti in sede penale).
- Corte Giust. Trib. I Grado Lecce sent. 850/2023: interpretazione art.7 co.5-bis D.Lgs.546 – onere a carico Fisco di dimostrare pretesa.
- Circolare AE n. 1/2008 (sulle società di comodo e presunzioni di distribuzione utili ai soci di base ristretta) – evidenzia approccio AE.
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale come socio di una S.r.l.? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale come socio di una S.r.l.?
👉 È una situazione molto delicata: l’Agenzia delle Entrate può tentare di attribuirti redditi o utili non dichiarati, spesso in modo automatico e senza prove concrete.
In questa guida scoprirai come funziona l’accertamento fiscale ai soci, quando è legittimo, e come difenderti subito e bene con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto tributario e societario.
💥 Cos’è un Accertamento Fiscale ai Soci di S.r.l.
Un accertamento fiscale ai soci è un procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al socio di una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) redditi non dichiarati, derivanti da utili presunti o distribuzioni extracontabili.
📌 In pratica, l’Ufficio sostiene che gli utili non dichiarati dalla società siano stati percepiti dai soci, anche se non risultano dai bilanci o dai verbali assembleari.
Può accadere, ad esempio, quando:
- la società è sottoposta ad accertamento per ricavi non dichiarati;
- si sospetta che i soci abbiano prelevato utili “in nero”;
- il socio ha movimenti bancari non coerenti con il reddito dichiarato;
- la S.r.l. è a ristretta base sociale (pochi soci, spesso familiari).
⚖️ Quando l’Accertamento al Socio È Legittimo
L’Agenzia può emettere un accertamento al socio solo se:
- la società ha subito un accertamento già definitivo;
- dimostra che i ricavi extracontabili sono stati effettivamente distribuiti ai soci;
- rispetta il contraddittorio preventivo con il contribuente;
- motiva chiaramente l’origine e l’importo dei redditi contestati.
📌 Se mancano questi requisiti, l’accertamento è nullo per difetto di motivazione o di prova (Cass. 24991/2020).
💠 Accertamento Unitario: Società e Soci
Quando la società è di ristretta base partecipativa (pochi soci, legami familiari o gestionali), l’Agenzia tende a usare il cosiddetto accertamento unitario:
presume che gli utili extracontabili accertati nella S.r.l. siano automaticamente distribuiti ai soci.
📌 Tuttavia, si tratta di una presunzione che può essere vinta, dimostrando che:
- gli utili sono stati reinvestiti nella società;
- non sono stati percepiti personalmente;
- l’accertamento alla società non è ancora definitivo.
In molti casi, i giudici tributari hanno annullato gli accertamenti perché la presunzione di distribuzione non era supportata da prove reali.
⚠️ Le Conseguenze per il Socio
Un accertamento fiscale al socio può comportare:
- 💰 Recupero di IRPEF e addizionali su utili presunti;
- ⚖️ Sanzioni fino al 240% dell’imposta accertata;
- 📈 Interessi di mora e aggi fiscali;
- 🏦 Iscrizione a ruolo, cartelle esattoriali e pignoramenti;
- 🚫 Controlli bancari personali per ricostruire flussi di denaro.
📌 Ma se l’accertamento è basato solo su presunzioni o sul reddito societario non definitivo, può essere impugnato e annullato.
🧩 Le Strategie di Difesa Possibili
1️⃣ Dimostrare che l’Utile Non È Stato Distribuito
La società può aver reinvestito gli utili o non averli materialmente distribuiti.
L’avvocato può provare che:
- i fondi sono rimasti nei conti societari;
- non ci sono movimenti di denaro a favore dei soci;
- la società ha perdite pregresse o riserve di capitale.
📌 Se manca la prova della percezione effettiva, l’imposizione è illegittima.
2️⃣ Contestare la Presunzione Automatica
L’Agenzia spesso applica in modo automatico la presunzione di distribuzione ai soci.
Ma la Cassazione ha stabilito che la presunzione non basta da sola: servono prove concrete e individualizzate.
📌 Se l’Ufficio non dimostra un reale arricchimento del socio, l’accertamento va annullato.
3️⃣ Eccepire la Mancanza di Contraddittorio
L’Agenzia deve sempre permettere al socio di presentare osservazioni e prove prima di emettere l’atto.
📌 In mancanza di contraddittorio, l’accertamento è nullo per violazione del diritto di difesa.
4️⃣ Impugnare l’Avviso di Accertamento
Il socio può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo:
- la sospensione immediata della riscossione;
- l’annullamento totale o parziale dell’atto;
- il riconoscimento dell’assenza di redditi percepiti.
📌 Nei casi urgenti, il giudice può sospendere l’esecuzione in 48 ore.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Copia dell’avviso di accertamento ricevuto;
- Bilanci, verbali assembleari e conti correnti societari;
- Documentazione bancaria personale;
- Copia dell’accertamento notificato alla società;
- Comunicazioni e verbali della Guardia di Finanza o dell’Agenzia.
📌 Questi documenti servono per dimostrare che non hai percepito redditi extracontabili e che la società ha agito in modo regolare.
⏱️ Tempi della Procedura
- Contraddittorio con l’Agenzia: 30–60 giorni;
- Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: possibile in 48 ore;
- Decisione del giudice: in 6–12 mesi circa.
📌 Durante la sospensione, non possono essere avviate azioni esecutive o iscrizioni a ruolo.
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✅ Annullamento dell’accertamento per presunzioni infondate.
✅ Blocco immediato della riscossione e delle sanzioni.
✅ Difesa coordinata tra socio e società.
✅ Riduzione o cancellazione delle somme accertate.
✅ Assistenza completa in ogni grado di giudizio.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare l’avviso pensando che sia “a carico della società”.
❌ Non fornire prove sull’assenza di distribuzione degli utili.
❌ Pagare subito senza verificare la legittimità dell’atto.
❌ Presentare il ricorso fuori termine.
📌 Anche se la società è sotto accertamento, i soci devono difendersi personalmente: l’accertamento ai soci è un atto autonomo.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’avviso e verifica la legittimità delle presunzioni applicate.
📌 Ti assiste nella raccolta delle prove e nella difesa coordinata con la società.
✍️ Redige e deposita ricorsi fondati su giurisprudenza e principi di diritto tributario.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in ogni grado.
🔁 Ti segue fino alla sospensione o all’annullamento definitivo dell’accertamento.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e contenzioso societario.
✔️ Specializzato nella difesa di soci e amministratori contro accertamenti fiscali.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di società e soci di S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Un accertamento fiscale ai soci di una S.r.l. non è automatico né definitivo:
con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, dimostrare di non aver percepito utili e ottenere l’annullamento dell’atto.
⏱️ Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso: ogni giorno è fondamentale.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro l’accertamento fiscale da socio può partire oggi stesso.