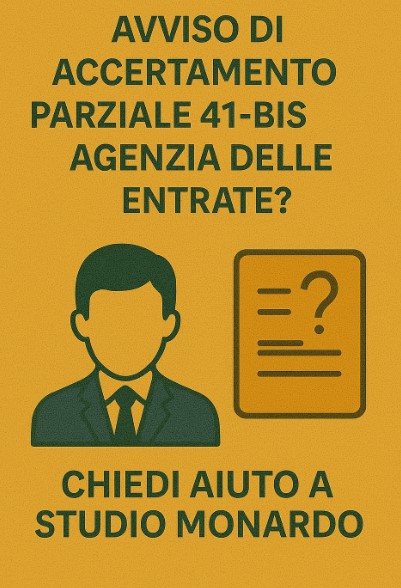Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/1973? Si tratta di una forma di accertamento fiscale che consente all’Agenzia delle Entrate di rettificare solo una parte del reddito o dell’imposta dovuta, senza attendere la conclusione di tutti i controlli.
È un tipo di accertamento molto frequente e potenzialmente pericoloso, perché viene spesso emesso senza un vero contraddittorio preventivo, sulla base di segnalazioni, verifiche parziali o dati bancari. Tuttavia, anche in questi casi, il contribuente ha diritto di difendersi e può contestare la legittimità o la fondatezza dell’avviso con l’aiuto di un avvocato tributarista.
Cos’è l’accertamento parziale 41-bis e cosa prevede la legge
L’art. 41-bis del DPR 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di emettere un accertamento “parziale”, ossia limitato a singoli redditi, operazioni o componenti, quando dispone di elementi certi e immediatamente utilizzabili.
L’obiettivo dichiarato è quello di permettere un intervento rapido del Fisco senza dover ricostruire l’intera posizione fiscale del contribuente. Tuttavia, nella pratica, il 41-bis viene spesso utilizzato come strumento per anticipare un accertamento completo, basandosi su dati incompleti o presunzioni.
Le principali fonti di tali elementi possono essere:
- segnalazioni provenienti dalla Guardia di Finanza o da altri enti pubblici;
- controlli incrociati con le banche dati (anagrafe tributaria, sistema Tessera Sanitaria, INPS, INAIL, ecc.);
- comunicazioni da parte di intermediari finanziari;
- verifiche su operazioni IVA o movimentazioni bancarie sospette;
- controlli formali e automatizzati con esiti anomali.
In questi casi, l’Agenzia emette un avviso di accertamento parziale con la pretesa di recuperare le imposte relative alle sole componenti oggetto di contestazione.
Come funziona la procedura di accertamento parziale
- Raccolta delle informazioni: il Fisco acquisisce dati o segnalazioni che indicano possibili irregolarità fiscali.
- Analisi dei dati: l’Ufficio valuta se esistono elementi “certi e diretti” che giustifichino un’immediata rettifica.
- Emissione dell’avviso di accertamento: viene notificato al contribuente l’atto con la richiesta di pagamento delle imposte, sanzioni e interessi.
- Eventuale avvio di ulteriori accertamenti: il 41-bis non preclude all’Agenzia la possibilità di procedere, in seguito, con un accertamento più ampio sullo stesso contribuente.
A differenza dell’accertamento ordinario, il 41-bis non richiede necessariamente il contraddittorio preventivo, ma la giurisprudenza ha più volte ribadito che la mancata instaurazione del confronto può rendere l’atto illegittimo, se le contestazioni sono fondate su presunzioni o valutazioni soggettive.
Quando l’accertamento parziale è legittimo
L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento parziale 41-bis solo se:
- dispone di elementi certi, diretti e immediatamente utilizzabili;
- l’avviso riguarda solo una parte del reddito o delle imposte e non l’intera posizione fiscale;
- non viene violato il diritto al contraddittorio quando l’atto si fonda su valutazioni o presunzioni;
- l’Ufficio motiva chiaramente la provenienza e l’attendibilità degli elementi accertati;
- non viene superato il termine di decadenza per l’anno d’imposta in contestazione.
Se anche uno solo di questi requisiti manca, l’accertamento può essere dichiarato nullo o annullabile dal giudice tributario.
Quando l’accertamento 41-bis è nullo o impugnabile
Puoi impugnare l’avviso di accertamento parziale se presenta uno dei seguenti vizi:
- mancanza di motivazione chiara o dettagliata sugli elementi utilizzati;
- violazione del diritto di contraddittorio preventivo;
- uso di presunzioni non supportate da prove concrete;
- errore di calcolo o valutazione delle somme contestate;
- mancato rispetto dei termini di notifica o decadenza;
- difetto di istruttoria o utilizzo di dati non verificati.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento parziale non può trasformarsi in un accertamento totale mascherato, e che ogni elemento presuntivo deve essere adeguatamente motivato e documentato.
Le conseguenze di un accertamento parziale
Un avviso di accertamento parziale comporta conseguenze fiscali immediate:
- richiesta di maggiori imposte (IRPEF, IVA, IRES o altre);
- sanzioni amministrative fino al 240% dell’imposta accertata;
- interessi legali e di mora;
- iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento;
- possibilità di successivi accertamenti per altri redditi o periodi.
Difendersi tempestivamente è fondamentale per evitare che l’atto diventi definitivo e per bloccare eventuali procedure di riscossione.
Come difendersi da un accertamento 41-bis
Un avvocato esperto in diritto tributario può predisporre una difesa efficace contro un accertamento parziale, basandosi su:
- verifica della legittimità dell’atto e della corretta applicazione dell’art. 41-bis;
- analisi della motivazione e delle prove utilizzate dall’Ufficio;
- dimostrazione che gli elementi non sono “certi” né “immediatamente utilizzabili”;
- contestazione della mancanza di contraddittorio e violazione del diritto di difesa;
- eccezione di nullità o annullabilità per difetti procedurali o motivazionali;
- richiesta di sospensione cautelare della riscossione per evitare effetti esecutivi durante il ricorso.
Le strategie difensive più efficaci
- Dimostrare che gli elementi su cui si basa l’accertamento non sono certi né verificabili;
- Contestare la violazione del contraddittorio e l’assenza di motivazione adeguata;
- Produrre prove contrarie (documenti, movimenti finanziari, giustificativi di spese o entrate);
- Invocare la giurisprudenza favorevole della Cassazione in materia di accertamenti parziali;
- Richiedere la sospensione cautelare della riscossione per evitare cartelle e pignoramenti;
- Dimostrare che le somme contestate sono già state tassate o non imponibili.
Come scegliere l’avvocato giusto per difendersi
Affrontare un accertamento parziale richiede un avvocato con competenze specifiche in contenzioso tributario e procedura fiscale. I criteri da considerare sono:
- specializzazione in diritto tributario e accertamenti 41-bis;
- esperienza documentata in casi di accertamenti presuntivi o bancari;
- collaborazione con commercialisti o periti contabili;
- conoscenza aggiornata della giurisprudenza tributaria;
- capacità di negoziare con l’Ufficio per eventuali accertamenti con adesione.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un avviso di accertamento parziale può comportare:
- iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali esecutive;
- sanzioni elevate e interessi di mora;
- pignoramenti e ipoteche sui beni;
- perdita del diritto di ricorso entro 60 giorni dalla notifica;
- ulteriori accertamenti integrativi o totali.
Una difesa tempestiva permette invece di bloccare la riscossione, ridurre o annullare le sanzioni e far valere l’illegittimità dell’atto.
Quando rivolgersi a un avvocato
Devi contattare un avvocato se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis;
- ti sono state contestate operazioni o redditi specifici senza un vero contraddittorio;
- vuoi contestare la validità o la motivazione dell’atto;
- devi sospendere la riscossione o presentare ricorso.
Un avvocato tributarista può:
- impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
- chiedere la sospensione cautelare della riscossione;
- dimostrare l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento;
- ottenere l’annullamento dell’atto o una significativa riduzione delle somme contestate.
⚠️ Attenzione: l’avviso di accertamento parziale 41-bis non è un atto definitivo e spesso presenta vizi formali o sostanziali. Se non lo impugni entro 60 giorni, però, diventa esecutivo e può dare luogo a cartelle, fermi e pignoramenti. Agire subito con un avvocato esperto è l’unico modo per tutelare i tuoi diritti fiscali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e difesa contro accertamenti 41-bis – spiega cos’è l’accertamento parziale, quando è illegittimo e come difendersi efficacemente con l’assistenza di un avvocato specializzato.
👉 Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale dall’Agenzia delle Entrate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo l’avviso, verificheremo la solidità degli elementi usati dal Fisco e costruiremo una strategia personalizzata per impugnare l’accertamento, sospendere la riscossione e difendere i tuoi diritti fiscali.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento parziale dall’Agenzia delle Entrate significa che il Fisco contesta al contribuente (persona fisica, lavoratore autonomo o azienda) alcune specifiche irregolarità fiscali su un determinato periodo d’imposta, senza rivedere l’intera dichiarazione di quell’anno. Si tratta di un atto impositivo formale, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di maggiori imposte (IRPEF, IRES, IVA, e relative addizionali o imposte collegate) oltre a sanzioni e interessi, in relazione a redditi non dichiarati o ad altri errori/omissioni individuati. Dal punto di vista del contribuente (il debitore dell’imposta contestata), è fondamentale reagire prontamente e correttamente per tutelare i propri diritti ed evitare conseguenze peggiori. In questa guida avanzata – rivolta ad avvocati, professionisti, imprenditori ma anche ai privati cittadini interessati – spiegheremo cos’è l’accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/1973, quando e perché l’Agenzia delle Entrate lo utilizza, e come difendersi in modo efficace, sia attraverso strumenti amministrativi (istanze, adesione, autotutela) sia in sede giudiziale (ricorso alle Corti di giustizia tributaria).
Utilizzeremo un linguaggio giuridico ma chiaro e divulgativo, corredando il testo con riferimenti normativi italiani aggiornati a ottobre 2025 e con le più recenti sentenze della giurisprudenza tributaria. Troverai inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici (simulazioni) e una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi frequenti, il tutto dal punto di vista di chi subisce l’accertamento (il contribuente) e deve tutelare i propri diritti. L’obiettivo è fornire gli strumenti per affrontare con consapevolezza un avviso di accertamento parziale e scegliere la strategia più adatta per ridurre o annullare la pretesa fiscale contestata.
Cos’è l’accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/1973)
L’accertamento parziale è una particolare procedura di controllo tributario introdotta nell’ordinamento italiano in deroga al principio di unitarietà e globalità dell’accertamento fiscale annuale. In generale, il Fisco dovrebbe infatti emettere, per ciascun periodo d’imposta, un solo accertamento “globale” che verifichi la correttezza dell’intera dichiarazione del contribuente. L’istituto dell’accertamento parziale consente invece all’Amministrazione finanziaria di emettere un avviso di accertamento limitato ad alcuni elementi reddituali o imponibili, quando dispone di elementi certi, specifici e immediatamente utilizzabili che provano un’evasione parziale senza dover riesaminare tutta la posizione fiscale del contribuente per quell’anno .
La base normativa principale è l’art. 41-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (riferito alle imposte sui redditi – IRPEF e IRES), introdotto negli anni ’90 e poi modificato nel tempo. Disposizioni analoghe sono previste, in materia di IVA, dall’art. 54, comma 5 del DPR 633/1972 . In sostanza, la legge stabilisce che “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” entro i termini di decadenza ordinari (art. 43 DPR 600/73), l’ufficio può limitarsi ad accertare immediatamente, sulla base di elementi concreti emersi da attività istruttorie o segnalazioni, uno specifico reddito non dichiarato o maggiore imposta dovuta, senza attendere o svolgere un accertamento completo . Gli elementi su cui si fonda l’accertamento parziale possono provenire, ad esempio, da accessi e verifiche fiscali, da controlli della Guardia di Finanza, da segnalazioni di altri enti pubblici o da incroci di dati nell’Anagrafe Tributaria (come movimenti bancari, fatture elettroniche, registri immobiliari, ecc.) . Quando tali elementi indicano in modo chiaro l’esistenza di materia imponibile sottratta a tassazione – ad esempio redditi non dichiarati, ricavi non contabilizzati, costi indebiti portati in deduzione, crediti IVA inesistenti, imposte non versate – l’ufficio “può limitarsi” ad accertare subito quel maggior imponibile o quella maggiore imposta, emettendo un avviso ad hoc basato solo su quei rilievi circoscritti .
Il fine dell’istituto emerge chiaramente: permettere al Fisco una rapida emersione e un pronto recupero di imposte evase, concentrando l’azione accertativa su aspetti mirati senza dover attendere la conclusione di lunghe verifiche generali . In pratica, quando le attività istruttorie svolte evidenziano evidenze oggettive e documentate di un’omissione (si pensi a fatture risultanti dai sistemi informatici ma non riportate nei redditi dichiarati, bonifici bancari privi di giustificazione economica, vendite “in nero” scoperte da controlli incrociati, ecc.), l’ufficio può emettere rapidamente un avviso di accertamento parziale limitato a quelle voci, senza ricalcolare da capo l’intero reddito dell’anno . Questo rende la procedura più snella e veloce rispetto a un accertamento ordinario, poiché evita di riesaminare tutte le voci della dichiarazione ma si focalizza solo sull’area di evasione individuata. Ad esempio, se da un controllo incrociato delle fatture elettroniche (SDI) risulta che un professionista ha emesso regolarmente fatture per 50.000 € di compensi soggetti a IVA, ma poi non ha dichiarato quei compensi nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia può contestare immediatamente quel reddito non dichiarato con un avviso parziale, calcolando le maggiori imposte IRPEF su quei 50.000 € (oltre a IVA eventualmente già versata o dovuta) e applicando le relative sanzioni e interessi .
È importante sottolineare che l’accertamento parziale non costituisce un autonomo “metodo” di accertamento sostanziale distinto da quelli ordinari (analitico, sintetico, induttivo), bensì una modalità procedurale semplificata prevista dalla legge per utilizzare tempestivamente alcuni risultati istruttori. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’accertamento parziale “segue le stesse regole” di validità e prova degli accertamenti completi ex artt. 38 e 39 DPR 600/73 . In altri termini, il fatto che sia “parziale” riguarda solo l’oggetto limitato dell’atto, ma non riduce gli oneri probatori a carico dell’ufficio né le garanzie difensive per il contribuente. L’ufficio dovrà comunque motivare adeguatamente l’atto indicando i fatti e le norme violate, e potrà fondare la pretesa anche su presunzioni (semplici o legali) purché queste abbiano i requisiti di legge, allo stesso modo di un accertamento ordinario . In passato talvolta si riteneva che l’art. 41-bis richiedesse necessariamente “elementi certi e incontrovertibili”, escludendo un uso di presunzioni; in realtà la giurisprudenza odierna ha chiarito che anche elementi presuntivi possono sorreggere un accertamento parziale, purché gravi, precisi e concordanti – ad esempio, movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, le quali per legge (art. 32 DPR 600/73) sono considerate redditi sottratti a tassazione salvo prova contraria . L’essenziale è che il dato probatorio alla base sia già disponibile e non richieda, al momento dell’emissione dell’avviso, ulteriori complesse valutazioni o ricostruzioni da parte dell’ufficio. Proprio su questo punto la Cassazione ha chiarito la ratio dell’istituto: l’accertamento parziale serve a perseguire finalità di tempestiva emersione del dovuto, nelle ipotesi in cui le risultanze istruttorie non richiedano ulteriori elaborazioni o accertamenti ampi, ma possano essere semplicemente recepite dall’ufficio . In altre parole, il 41-bis può essere utilizzato quando l’Amministrazione si trova già in mano delle “carte vincenti” (ad esempio dati bancari, fatture, verbali GdF) tali che la contestazione può avvenire quasi in automatico. Se invece fossero necessarie valutazioni complesse o congetture ampie (ad es. solo sospetti su incongruenze generiche), allora si dovrebbe procedere semmai con un accertamento ordinario completo e non con un parziale.
Riassumendo le caratteristiche chiave dell’accertamento parziale:
- Base normativa: art. 41-bis DPR 600/1973 per imposte sui redditi; art. 54 comma 5 DPR 633/1972 per IVA . È una deroga al principio che vuole un unico accertamento per anno.
- Cos’è: un avviso di accertamento “limitato” ad alcuni elementi del reddito o dell’imposta evasi/non dichiarati, emesso sulla base di elementi specifici e documentati già a disposizione del Fisco . Non rettifica l’intero reddito dichiarato, ma corregge solo in parte la dichiarazione (limitamente ai rilievi individuati).
- Finalità: recupero rapido di imposte evase, grazie a controlli mirati e incrocio banche dati, evitando indagini onnicomprensive . Permette di colpire subito sacche di evasione evidenti, lasciando eventualmente aperta la possibilità di ulteriori controlli su altre questioni.
- Presupposti: disponibilità di elementi specifici e attendibili che indicano imponibili sottratti (esempi: dati da Anagrafe Tributaria come conti o investimenti non giustificati, segnalazioni GdF su ricavi in nero, fatture per operazioni inesistenti, incrocio di dichiarazioni di sostituti d’imposta o clienti/fornitori, ecc.). Tali elementi devono avere una consistenza tale da non richiedere ulteriore attività valutativa complessa: in pratica devono parlare da soli, costituendo prova (anche presuntiva) sufficientemente solida . Sono invece escluse dal 41-bis le fattispecie di mero controllo formale automatizzato (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73), che seguono altre procedure .
- Limiti intrinseci: l’accertamento parziale riguarda solo il tributo o i tributi oggetto del rilievo specifico. Ad esempio, se emerge un ricavo non dichiarato, l’avviso parziale potrà contestare le maggiori imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e, se pertinente, l’IVA e l’IRAP relative a quel ricavo. Non toccherà invece altri aspetti della dichiarazione non collegati a quel fatto. Inoltre, non chiude definitivamente la posizione fiscale annuale del contribuente: come vedremo, l’ufficio potrà in futuro emettere altri avvisi (parziali o uno completo) sullo stesso anno per recuperare altri importi evasi eventualmente scoperti in seguito, purché entro i termini di legge e rispettando il divieto di duplicare contestazioni già note (vedi infra).
- Procedura semplificata: l’accertamento parziale non richiede alcuni passaggi che spesso precedono un accertamento ordinario. In particolare, non si applica l’art. 44 DPR 600/73 (che disciplina la partecipazione dei Comuni all’accertamento – quindi per il parziale non vi è obbligo di comunicazione preventiva al Comune di residenza del contribuente, deroga pensata per snellire il procedimento ). Inoltre, come chiarito dalla normativa secondaria, l’invito al contraddittorio preventivo (oggi generalmente obbligatorio prima di alcuni avvisi, v. oltre) è escluso per gli accertamenti parziali, salvo che l’ufficio non lo attivi discrezionalmente . L’assenza di un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio rende l’iter di emissione più veloce, anche se – come vedremo – non preclude al contribuente di difendersi successivamente presentando le proprie ragioni.
Ne risulta che l’accertamento parziale è uno strumento potente nelle mani del Fisco per colpire con tempestività specifiche sacche di evasione. Dal lato del contribuente, però, questo atto può risultare più difficile da contestare nel merito, proprio perché è fondato su dati puntuali spesso documentali o informatici (si pensi a movimenti bancari, incassi elettronici, ecc.) difficilmente confutabili . Ciò non significa che l’accertamento parziale sia inattaccabile: come ogni atto amministrativo, può presentare vizi di legittimità o di merito che il contribuente può far valere. Ma certamente, essendo un avviso mirato, in genere il Fisco lo emette quando ritiene di avere in mano prove solide, e questo impone al destinatario un onere difensivo ben preparato.
Quando può essere emesso un accertamento parziale (presupposti e fonti dei dati)
Abbiamo visto in generale la funzione dell’accertamento parziale; passiamo ora a esaminare quando e in base a quali elementi l’ufficio finanziario può attivare questa procedura. L’accertamento parziale può scattare solo in presenza di precisi elementi informativi che segnalino un’imposta evasa. La norma (art. 41-bis DPR 600/73) elenca le possibili fonti di tali elementi:
- Resultanze delle attività istruttorie ex art. 32 DPR 600/73: ossia informazioni raccolte tramite i poteri ispettivi del Fisco, come ad esempio accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente, richieste di documenti e dati, questionari, controlli dei conti bancari, ecc. Se da una verifica fiscale o da un’ispezione contabile emergono redditi non dichiarati (p.es. una contabilità “nera”, oppure fatture emesse non registrate a ricavo), l’ufficio può utilizzare questi esiti per un 41-bis . Dal 2005, la legge specifica espressamente che anche gli esiti di accessi e verifiche possono dare luogo ad accertamento parziale . Ciò ha chiarito un dubbio precedente: oggi è pacifico che anche se l’evasione viene scoperta nell’ambito di una verifica generale, l’ufficio può comunque emettere un parziale senza dover necessariamente chiudere l’intera verifica con un accertamento completo . In pratica, i verificatori potrebbero concludere una verifica con un processo verbale di constatazione (PVC) ampio, e l’ufficio può decidere di emettere subito un primo avviso parziale su alcuni rilievi certi, riservandosi eventualmente di approfondire altri profili in un secondo momento. La Cassazione ha confermato che anche a seguito di una verifica generale è legittimo procedere per parziale, non essendoci nella norma alcun divieto in tal senso . L’importante, come detto, è che gli elementi emersi siano tali da non richiedere ulteriori valutazioni: se dal PVC risultano chiaramente ricavi occulti per una certa somma, l’ufficio può contestarli subito via 41-bis .
- Segnalazioni da altri uffici o enti: l’art. 41-bis include le segnalazioni della Direzione centrale accertamento o di una Direzione regionale dell’Agenzia, di altri uffici della stessa Agenzia, di altre Agenzie fiscali (p.es. Dogane e Monopoli), della Guardia di Finanza, nonché di pubbliche amministrazioni o enti pubblici . Questo significa che se un altro organo ha scoperto qualcosa (un ente locale, un ufficio dell’INPS, la stessa GdF durante un’indagine penale, ecc.) e trasmette la notizia all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima può usarla per un accertamento parziale. Ad esempio, se il Comune segnala che Tizio ha affittato un immobile senza registrare il contratto (e dunque presumibilmente senza dichiarare il relativo reddito da locazione), questa segnalazione consente un avviso parziale IRPEF sui canoni evasi. Oppure, se la Guardia di Finanza, indagando su un altro contribuente, scopre documenti da cui risulta che Caio ha percepito compensi non fatturati, può segnalarlo all’Agenzia che emetterà un parziale verso Caio. La norma è molto ampia nell’elencare i possibili segnalanti, riflettendo un sistema di collaborazione inter-enti per contrastare l’evasione. Anche le segnalazioni internamente generate (da altre articolazioni dell’Agenzia) rientrano, per evitare che eventuali rigidità organizzative ostacolino l’uso del 41-bis.
- Dati in possesso dell’Anagrafe tributaria: un ulteriore presupposto tipico del 41-bis è la disponibilità, nelle banche dati fiscali, di informazioni che evidenziano anomalie. L’“Anagrafe tributaria” è l’enorme base dati che raccoglie tutte le informazioni fiscali dei contribuenti: dichiarazioni, registri immobiliari, versamenti, comunicazioni IVA, certificazioni dei sostituti d’imposta, comunicazioni di operatori finanziari (conto correnti, investimenti), ecc. Da questi incroci possono emergere redditi non dichiarati o imposte non versate. Classico esempio: l’Archivio dei Rapporti Finanziari (sottosistema dell’Anagrafe tributaria) registra tutti i movimenti e saldi dei conti correnti bancari e altri rapporti finanziari. Se dall’analisi di tali dati l’ufficio individua ingenti versamenti o prelievi non giustificati rispetto al profilo fiscale del contribuente, può presumere che siano ricavi o compensi in nero e procedere ad accertamento parziale (in base all’art. 32 DPR 600/73, i prelevamenti non giustificati per imprese e i versamenti non giustificati per tutti i contribuenti si considerano proventi tassabili, salvo prova contraria). Un altro esempio: le fatture elettroniche transitano per il Sistema di Interscambio (SDI) e sono note all’Agenzia; se risultano fatture emesse da un contribuente per un certo importo ma poi quel contribuente non ha dichiarato nulla (o ha dichiarato meno) in UNICO per quell’anno, l’incongruenza è palese e l’ufficio può contestarla via 41-bis. Ancora: tramite l’Anagrafe l’Agenzia vede gli acquisti di beni durevoli (auto di lusso, barche) comunicati dai venditori; se un privato con reddito esiguo ha speso centinaia di migliaia di euro, ciò può portare ad approfondimenti (anche se l’accertamento sintetico da redditometro è un istituto a parte, comunque i dati spia possono confluire in un 41-bis se indicano redditi non dichiarati).
In tutti questi casi, la caratteristica fondamentale dei dati che giustificano il parziale è che siano immediatamente utilizzabili e specifici. La Cassazione li ha definiti come “notizie che non necessitano di una specifica valutazione istruttoria”, contrapponendole alle ricostruzioni presuntive ampie che invece richiederebbero un accertamento ordinario . Ad esempio, un corrispettivo documentato (una fattura elettronica registrata, un bonifico con causale chiara) non dichiarato è un elemento puntuale; viceversa, una mera anomalia nei margini di profitto o negli indici di bilancio, senza un fatto concreto, sarebbe solo un indizio generico che richiede ulteriore approfondimento (non adatto al parziale) . Così, la Cassazione ha escluso che il 41-bis possa essere utilizzato per contestazioni basate solo su valutazioni estimative o presunzioni semplici non corroborate: ad esempio, l’ufficio che rilevi un ricarico apparentemente troppo basso da studi di settore/ISA non può emettere subito un parziale solo su quella base – dovrebbe semmai procedere con accertamento ordinario, instaurando il contraddittorio e valutando la posizione nel complesso . In sintesi, sì a dati mirati e oggettivi (fatture, movimenti finanziari, redditi di partecipazione occultati, ecc.), no a mere ipotesi congetturali o calcoli indiretti che richiedono ulteriori verifiche.
Accertamento parziale vs accertamento ordinario vs accertamento integrativo
Come accennato, l’accertamento parziale rappresenta una deroga alla regola di unità dell’accertamento annuale. È utile dunque metterlo a confronto sia con l’accertamento ordinario (generale) sia con l’accertamento integrativo, per capirne differenze ed interazioni. Di seguito una tabella comparativa e poi una spiegazione dettagliata.
Tabella di confronto – Accertamento Ordinario vs Parziale vs Integrativo
| Caratteristica | Accertamento Ordinario (Generale) | Accertamento Parziale (41-bis) | Accertamento Integrativo |
|---|---|---|---|
| Oggetto | L’intero imponibile/dichiarazione dell’anno (rettifica complessiva di tutti gli elementi rilevanti). | Solo specifici elementi non dichiarati o irregolari (contestazione mirata su redditi/imposte individuati). | Aggiunge nuovi elementi imponibili dopo un precedente accertamento già emesso. Integra/modifica un atto precedente. |
| Presupposti | Esito di controlli che richiedono rettifiche globali (verifica completa, grave inattendibilità contabilità, ecc.). | Evidenze circoscritte e già disponibili che provano omissioni (dati bancari, fatture non dichiarate, segnalazioni mirate). | Sopravvenienza di nuovi elementi non conosciuti né conoscibili prima, emersi dopo il primo accertamento . Necessaria l’esistenza di un accertamento precedente. |
| Procedura | Più complessa e garantita: spesso preavviso di accertamento o invito al contraddittorio obbligatorio (tranne urgenza), processo verbale di constatazione (PVC) se verifica, ecc. | Snella e immediata: la legge esenta da obblighi di contraddittorio preventivo specifico (salvo scelte ufficio). Può basarsi su PVC di terzi già notificato al contribuente oppure su altri dati senza previa convocazione formale. | Richiede di indicare specificamente i “nuovi elementi” scoperti dopo il primo avviso, a pena di nullità . Procedura simile a ordinario quanto a contraddittorio (se i nuovi elementi emergono da verifica, vi sarà PVC, ecc.). |
| Finalità | Chiudere in un unico atto definitivo la posizione fiscale dell’anno (salvo eventuali integrative per fatti ignoti). | Recuperare rapidamente parte dell’evasione senza attendere fine istruttoria generale . Agire “subito e bene” su ciò che è certo, lasciando aperta ulteriore azione per altro. | Integrazione di un accertamento precedente, per recuperare evasione scoperta tardivamente (dopo il primo atto). È un atto aggiuntivo, eccezionale, per rimediare a una precedente incompletezza dovuta a elementi sopravvenuti. |
| Effetti su futuri accertamenti | In linea generale, emettere un accertamento ordinario preclude ulteriori accertamenti sullo stesso tributo e anno (ne bis in idem), salvo appunto i casi di integrativo ex lege . | Non preclude ulteriori atti sullo stesso anno: la legge dice “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” . Quindi è possibile un successivo accertamento (parziale o completo) per altri rilievi . Limite: il successivo atto non può basarsi su fatti già noti ma non contestati nel primo . | Un accertamento integrativo presuppone per definizione che ci sia già stato un altro accertamento su quell’anno. È un secondo (o ulteriore) avviso, possibile solo se emergono fatti nuovi. Un integrativo legittimo esclude la duplicazione di elementi già noti: se contiene cose già conosciute prima, è nullo per violazione dei presupposti . |
| Sanzioni applicate | Sulle maggiori imposte accertate si applicano le sanzioni tributarie ordinarie previste (p.es. dichiarazione infedele: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta evasa, art. 1 D.lgs. 471/97) . Eventuali riduzioni se l’atto viene definito per adesione o acquiescenza. | Idem come ordinario: le sanzioni (in percentuale) sono calcolate sulle imposte recuperate col parziale. In caso di definizione agevolata (pagamento immediato o adesione), si applicano le stesse riduzioni previste per legge (vedi sez. sanzioni) – ad es. taglio a 1/3. | Idem come gli altri: l’integrativo porta ulteriori imposte e relative sanzioni. Da notare che un integrativo di norma indica violazioni aggiuntive della stessa natura (es. ulteriore imposta evasa = ulteriore sanzione per infedele). Anche qui sanzioni ridotte se definito via adesione, ecc. |
| Esempio tipico | Verifica completa su una società: l’accertamento ordinario rettifica il reddito totale dichiarato, aggiungendo tutti i ricavi non contabilizzati scoperti, eliminando eventuali costi fittizi, ricalcolando interamente l’IRES, l’IRAP e l’IVA dovuta per l’anno. | Incrocio di dati automatizzati rivela ricavi non dichiarati per €30.000 (ad esempio bonifici su conto non giustificati). L’accertamento parziale contesta solo quei €30.000 omessi, calcolando IRPEF/IRES, IVA e sanzioni relativi esclusivamente a tale base non dichiarata . | L’ufficio aveva già emesso un accertamento IRPEF 2018 nel 2023. Nel 2024, da una sentenza penale emerge un altro reddito 2018 prima ignoto. Si emette un accertamento integrativo IRPEF 2018 per tassare questo reddito aggiuntivo, indicando come “nuovo elemento” le risultanze di quella sentenza. |
Come mostra il confronto, l’accertamento parziale e l’accertamento integrativo sono due istituti differenti, da non confondere:
- Accertamento parziale: è tipicamente il primo (e forse unico) atto con cui l’ufficio accerta qualcosa sull’anno, basandosi su elementi già disponibili. Può essere emesso anche se l’ufficio quegli elementi li conosce fin da subito – anzi, proprio per questo li utilizza immediatamente. Ha lo scopo di anticipare la contestazione di ciò che è certo, senza attendere altre indagini. Non richiede la scoperta successiva di fatti nuovi, e infatti la legge non impone di indicare “nuovi elementi” nell’avviso parziale (obbligo previsto invece per l’integrativo) .
- Accertamento integrativo: è un istituto disciplinato dall’art. 43, comma 3 DPR 600/1973 (e dall’art. 57, comma 4 DPR 633/1972 per l’IVA) e consiste nella possibilità di emettere un secondo avviso dopo che ne esiste già uno precedente sul medesimo anno, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi . In altre parole, l’integrativo “integra” un accertamento originario già notificato. I presupposti sono stringenti: i nuovi elementi devono essere tali da non essere stati conosciuti né conoscibili con ordinaria diligenza al momento del primo accertamento . Se l’ufficio li possedeva già sin dall’inizio, non può chiamarli “sopravvenuti” e usarli in un integrativo: tentare di farlo equivarrebbe a un illegittimo doppione in violazione del ne bis in idem (il contribuente non può essere attinto due volte per la stessa cosa) . La norma infatti richiede nell’integrativo di specificare i nuovi elementi e come/ne quando sono venuti a conoscenza dell’ufficio, a pena di nullità dell’atto . L’accertamento integrativo è dunque un rimedio eccezionale, utilizzabile solo se l’ufficio scopre dopo, ad esempio, ulteriori redditi occultati (magari a seguito di indagini terze) o errori che al tempo non erano rilevabili. Non dà tempi aggiuntivi oltre a quelli di decadenza ordinari: va sempre notificato entro il termine previsto dall’art. 43 DPR 600/73 (di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, oppure del settimo se dichiarazione omessa – termini eventualmente raddoppiati in caso di reato tributario, v. oltre). Se il nuovo elemento emerge quando i termini sono scaduti, l’ufficio non può emettere nulla (salvo il caso del raddoppio per reati tributari, che però richiede una denuncia penale entro i termini normali).
Un punto delicato è che l’accertamento integrativo non può essere usato per “sanare” a posteriori negligenze istruttorie o errori del primo accertamento. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’integrativo non deve diventare uno strumento per colmare lacune dell’ufficio né per aggravare retroattivamente la posizione del contribuente semplicemente perché l’ufficio ci ha ripensato . In passato l’Agenzia talvolta ha annullato in autotutela un primo avviso per emetterne uno nuovo più gravoso (la cosiddetta autotutela “in malam partem”): ebbene, la Cassazione a Sezioni Unite, con una recente sentenza del 2024, ha ritenuto legittimo tale potere di autotutela solo se esercitato entro i termini di decadenza e in presenza di vizi dell’atto precedente, ma ha anche precisato che non si possono aggirare né i termini né i limiti propri dell’integrativo . In pratica, è ammesso sostituire un avviso con un altro più pesante prima che scada il termine di accertamento (ad esempio se si riscontra un errore di calcolo o emergono nuovi elementi rilevanti durante il contenzioso sul primo atto), ma ciò non può avvenire dopo la scadenza né per recuperare elementi di cui si disponeva già al momento iniziale . I soli limiti fissati dalle SS.UU. per questa autotutela sostitutiva peggiorativa sono: (1) il rispetto del termine di decadenza dell’accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) e (2) l’assenza di un giudicato sull’atto originario . Questa pronuncia (Cass., SS.UU. n. 30051/2024) evidenzia comunque come principio generale il ne bis in idem tributario: il contribuente, entro il termine di legge, può subire più atti sullo stesso anno solo per motivi nuovi e diversi, non per ripetere o aggravare contestazioni già fatte sulla base degli stessi fatti.
In definitiva, accertamento parziale e integrativo non coincidono: il primo nasce ex novo su elementi disponibili (senza atto precedente su quell’anno), il secondo presuppone un atto già emanato e si giustifica solo con elementi sopravvenuti. La confusione può sorgere in pratica quando l’Agenzia, dopo un accertamento parziale, ne emetta un altro sul medesimo anno: a seconda delle circostanze, quel secondo atto potrebbe configurarsi come “secondo parziale” o come “integrativo”. Tecnicamente, se il primo atto era un parziale e il secondo aggiunge nuovi rilievi, è a sua volta un parziale (perché anche il primo non era “generale” e l’ufficio sta solo emettendo un altro atto parziale). Alcuni preferiscono chiamare integrativo solo il caso in cui c’era già un accertamento completo e poi se ne integra uno completo; mentre se c’era un parziale e ne arriva un altro, si parla di “accertamenti plurimi”. Al di là della terminologia, conta la sostanza: ogni ulteriore accertamento sul medesimo periodo è legittimo solo se apporta nuovi elementi non conosciuti prima. Non è ammesso che l’ufficio trattenga nel cassetto parte delle evidenze per contestarle dopo in un secondo atto, poiché ciò violerebbe la lealtà del procedimento e il diritto di difesa del contribuente. La Cassazione lo ha ribadito chiaramente: “un successivo accertamento sul medesimo periodo non può basarsi su fatti già conosciuti ma non contestati nel primo atto” . Quindi, ad esempio, se l’ufficio ha in mano sia i dati dei conti bancari sia i dati delle vendite non fatturate e decide nel 2024 di fare un parziale solo sui conti, non può nel 2025 emettere un altro avviso per le vendite in nero se queste risultavano dai medesimi controlli già conclusi prima (perché erano fatti noti sin dall’inizio). Potrà farlo invece se emergono da un controllo successivo e indipendente (ad es. una verifica della GdF conclusa l’anno dopo, che scopre altri filoni di evasione prima ignoti) . In tal caso, quel nuovo atto sarà formalmente un accertamento integrativo ai sensi di legge (dovrà indicare i nuovi elementi sopravvenuti, come da art. 43 co.3 DPR 600/73) , ma la coesistenza col precedente parziale sarà legittima perché ognuno riguarda cose diverse. Se invece il Fisco cercasse di emettere un secondo avviso sullo stesso anno senza nuovi elementi (cioè basato su elementi che aveva già valutato o avrebbe potuto valutare prima), il contribuente potrà far valere l’illegittimità di tale atto per violazione del principio di unicità dell’accertamento e dei limiti dell’accertamento integrativo .
Contenuto e validità di un avviso di accertamento parziale
Un avviso di accertamento parziale è a tutti gli effetti un atto amministrativo impositivo, soggetto quindi ai requisiti formali e sostanziali previsti per gli avvisi di accertamento in generale. Il fatto che sia “parziale” non lo esonera dal rispettare le norme su contenuto, motivazione e notificazione stabilite per gli atti impositivi. Vediamo i principali requisiti di validità che il contribuente deve controllare:
- Intestazione e organo emanante: L’atto viene emesso dall’Agenzia delle Entrate tramite l’ufficio competente (di regola, la Direzione Provinciale o un Ufficio Locale competente per il contribuente). Deve indicare l’ufficio che lo ha emesso e il funzionario responsabile. Importante: l’avviso deve recare la sottoscrizione del capo dell’ufficio (Direttore) o di altro funzionario delegato (con indicazione della delega) . In base all’art. 42 DPR 600/73, la mancata firma di un soggetto legittimato rende nullo l’avviso . La Cassazione ha confermato più volte che la firma è requisito essenziale: un avviso senza sottoscrizione valida è nullo radicalmente . Occorre quindi verificare che l’atto sia firmato in originale (nelle copie notificate può essere riprodotta) dal dirigente o da un delegato con qualifica adeguata (la delega di firma dev’essere esistente; in passato vi sono stati contenziosi sui dirigenti decaduti, ecc., ma questo esula dalla trattazione).
- Indicazione del tributo e anno d’imposta: Deve essere chiaro a quale periodo d’imposta si riferisce l’accertamento parziale (es: IRPEF 2021, IVA 2020, ecc.) e quali tributi coinvolge. Spesso l’avviso parziale contestualmente rettifica più tributi sullo stesso fatto (es: recupero di ricavi -> maggiore IRES, IRAP e IVA). L’atto deve specificare gli importi di maggior imposta accertata per ciascun tributo, oltre alle sanzioni e interessi calcolati.
- Motivazione dell’atto: Ai sensi dell’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell’art. 42 DPR 600/73, ogni avviso di accertamento dev’essere motivato, ossia deve esporre in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo determinano. La motivazione è cruciale perché consente al contribuente di capire su quali elementi si fonda la pretesa fiscale e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa . Nel caso di accertamento parziale, la motivazione in genere consisterà nella descrizione dell’elemento emerso (es: “sono stati riscontrati versamenti su conto corrente per €XX non giustificati e non dichiarati”) e nella qualificazione giuridica di tale elemento (es: “tali somme vengono qualificate come ricavi non dichiarati ex art. 32 DPR 600/73, da assoggettare a IRPEF e addizionali”). Atti allegati e motivazione per relationem: Spesso l’accertamento parziale si fonda su atti istruttori esterni, ad esempio un PVC della Guardia di Finanza o una segnalazione/report di altro ente. In questi casi l’ufficio può motivare “per relationem”, ovvero richiamando tali documenti. La legge (art. 7 co.1 L.212/2000) richiede che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’avviso”, salvo che sia già stato notificato al contribuente. Dunque, se l’accertamento parziale richiama un PVC della GdF redatto a carico del contribuente e già consegnato a quest’ultimo al termine della verifica, l’allegazione materiale non è necessaria (basterà il riferimento) . Se invece si basa su un PVC o documento relativo a terzi o comunque non conosciuto dal destinatario, l’ufficio deve alternativamente allegarlo o trascriverne il contenuto essenziale nell’atto . La mancata allegazione non comporta nullità automatica se l’avviso riproduce già in sé gli elementi essenziali di tale documento, in modo da mettere il contribuente in grado di difendersi . Lo ha chiarito di recente la Cassazione: lo scopo della norma è garantire piena conoscenza, ma ciò può avvenire anche riportando in motivazione i punti chiave dell’atto richiamato, senza doverlo necessariamente allegare integralmente . Ad esempio, se l’accertamento parziale verso una società A si basa su un PVC fatto presso la società B (sua fornitrice), e l’ufficio trascrive nell’avviso i passi salienti del PVC di B (magari le fatture inesistenti individuate, ecc.), non sarà nullo solo perché non ha allegato fisicamente l’intero PVC, purché la trascrizione consenta ad A di capire e contestare le ragioni . In ogni caso, se il contribuente non ha ricevuto il documento allegato e lo richiede, l’ufficio dovrà esibirlo. Vizio di motivazione: un avviso parziale privo delle necessarie indicazioni fattuali (ad es. non dice quali sono i redditi non dichiarati o su quali basi sono quantificati) potrà essere impugnato per difetto di motivazione. Inoltre, la motivazione non può essere generica o per mere formule: deve specificare i fatti concreti contestati. Ad esempio, non basta affermare “reddito dichiarato incongruo, pertanto si rettifica”: una motivazione così sarebbe censurabile per mancanza di spiegazione. Occorre invece che l’atto dettagli p.es. “Si riscontra un versamento bancario di €50.000 in data X, sul conto Y intestato al contribuente, non giustificato e non dichiarato; pertanto si assume trattarsi di ricavo non dichiarato…”. In sede di giudizio, comunque, il giudice valuterà la fondatezza nel merito; ma se proprio manca l’esposizione dei motivi, l’atto è nullo.
- Calcoli e quadri riepilogativi: L’avviso parziale deve contenere il ricalcolo delle maggiori imposte dovute a seguito del rilievo, con indicazione delle aliquote applicate, dell’imponibile accertato in più e delle differenze d’imposta. Spesso allega prospetti o tabelle. Ad esempio, se contesta redditi non dichiarati per €100,000, indicherà la maggiore IRPEF dovuta (scaglioni e aliquote), le addizionali regionale/comunale relative, l’IVA se dovuta su quei ricavi (se non già versata), ecc. Importante: se trattasi di reddito di partecipazione (società di persone), l’accertamento parziale può riguardare la società e poi riflettersi sui soci; generalmente l’ufficio notifica contestualmente anche ai soci l’accertamento del reddito di partecipazione non dichiarato (ciascuno per quota). Questi atti devono mantenere coerenza: se uno fosse notificato e l’altro no, possono sorgere problemi (ma ciò è tema di contenzioso specifico).
- Sanzioni ed interessi**: L’atto deve indicare le sanzioni amministrative applicate per le violazioni riscontrate (vedi più avanti la sezione sulle sanzioni) e il conteggio degli interessi di mora dovuti sulle imposte non versate (calcolati, per legge, al tasso legale annuo dal giorno in cui le imposte erano dovute – di solito dalla scadenza del saldo imposte di quell’anno – fino alla data dell’accertamento). Il tasso di interesse legale viene aggiornato periodicamente (negli ultimi anni è passato dallo 0.5% annuo fino al 5% nel 2023 a causa dell’inflazione); l’atto in genere indica il calcolo degli interessi dovuti fino a una certa data.
- Termini e riferimenti normativi: L’avviso parziale deve essere emesso entro i termini di decadenza previsti per l’accertamento di quella imposta e anno. Come detto, di regola è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per IVA e imposte sui redditi); se nessuna dichiarazione è stata presentata, il termine passa al 31 dicembre del settimo anno successivo. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2020 presentata nel 2021, il termine è il 31/12/2026; se la dichiarazione 2020 era omessa, termine 31/12/2028. Eccezioni: in caso di violazioni penalmente rilevanti, è previsto il raddoppio dei termini (quindi 31/12/2032 nel nostro esempio) purché entro il termine ordinario sia stata trasmessa notizia di reato all’autorità giudiziaria. Su questo aspetto torneremo nella parte penale. L’accertamento parziale segue gli stessi termini dell’ordinario: non esiste un termine “aggiuntivo” per i parziali. Quindi un avviso parziale notificato fuori termine è nullo exactly come lo sarebbe un accertamento tardivo completo. Ad esempio, notificare un parziale IRPEF 2015 oltre il 31/12/2020 (termine quinquennale) lo rende nullo irrimediabilmente . Occhio: se l’Agenzia invoca il raddoppio termini per reato, deve poi dimostrare che il reato sussiste o aveva quantomeno indizi seri – se poi il reato viene escluso, il raddoppio non si applica e l’atto è tardivo (Cass. n. 5501/2022 ha escluso il raddoppio se la soglia penale non è superata). Nell’avviso, in genere, se viene emesso oltre il termine “breve” ma l’ufficio si avvale del raddoppio, sarà indicato il riferimento al reato ipotizzato e alla comunicazione di notizia di reato effettuata.
- Mezzi di impugnazione e termini: L’atto deve contenere l’indicazione del termine per presentare ricorso (60 giorni dalla notifica, salvo proroghe) e dell’organo giurisdizionale competente (la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, già Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio in base al domicilio fiscale del contribuente). Deve inoltre indicare che il contribuente può, in alternativa al ricorso immediato, presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 (in tal caso il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni). Queste indicazioni di legge sono obbligatorie: se mancassero, l’atto potrebbe essere annullabile per violazione dell’art. 42 co.2 lett. e) DPR 600/73. Al contribuente deve essere chiaro entro quando e come può opporsi.
- Notifica regolare: Infine, la notifica dell’atto dev’essere stata eseguita secondo le norme (art. 60 DPR 600/73 richiamante il Codice di procedura civile). Di solito gli avvisi di accertamento sono notificati tramite raccomandata A/R (in busta verde) per mezzo di operatori postali abilitati, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) ai destinatari che hanno domicilio digitale registrato, o eccezionalmente tramite messo notificatore. Se ci sono vizi di notifica (es. notifica a indirizzo errato, o a persona non abilitata a ricevere), l’atto potrebbe non essere divenuto conoscibile validamente – anche se qui occorre fare attenzione: se comunque il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto (es. ritirandolo in giacenza), difficilmente otterrà l’annullamento per vizio di notifica, ma potrebbe usare il vizio per far valere una decadenza se l’atto fu spedito tardi, ecc.
In sintesi, un avviso di accertamento parziale valido deve presentarsi formalmente corretto e motivato. Spesso il contribuente da solo potrebbe non accorgersi di vizi formali nascosti (ad es. firma non autorizzata, delega mancante, ecc.), ma un professionista tributario saprà verificarli. Il primo passo, quando si riceve un avviso, è sempre controllare questi aspetti formali e di contenuto. Più avanti, nella sezione “Cosa fare quando si riceve un avviso parziale”, riprenderemo questo check iniziale.
Il contraddittorio preventivo nell’accertamento parziale
Un tema delicato in materia di accertamento parziale è quello del contraddittorio preventivo con il contribuente, ossia la possibilità per il contribuente di essere sentito e fornire chiarimenti prima che l’avviso venga emesso. Nel diritto tributario italiano, il contraddittorio endoprocedimentale (detto anche “anticipato” o “preventivo”) non è sempre obbligatorio: lo diventa solo nei casi previsti dalla legge o, per i tributi “armonizzati” come l’IVA, quando imposto da principi UE.
Situazione normativa fino al 2019: Fino a qualche anno fa, l’obbligo di contraddittorio preventivo era limitato a ipotesi specifiche. Ad esempio era obbligatorio in materia di accertamenti basati su studi di settore/ISA e in materia di accertamento sintetico (redditometro) – in tali casi la legge prevedeva l’invito a comparire prima di emettere l’avviso, pena la nullità (cfr. art. 10-bis L. 212/2000 per il redditometro, ora modificato). Per gli altri accertamenti, la regola generale (fissata dalla Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 24823/2015) era che in mancanza di una previsione normativa specifica, l’assenza di contraddittorio non comportava nullità dell’atto . La Cassazione in quella sentenza riconobbe tuttavia che il contraddittorio è un principio di “buona amministrazione”, pur affermando che la sua omissione rileva solo dove la legge lo prevede espressamente . In sostanza, fino al 2019 si riteneva che per gli accertamenti “a sorpresa” (compresi i parziali) il Fisco non fosse tenuto a invitare il contribuente prima.
Novità dal 2020: Con il D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019) è stato introdotto nell’art. 5-ter dello Statuto del contribuente un principio di contraddittorio generalizzato: a decorrere da luglio 2020, salvo casi di particolare urgenza e salvo talune materie, l’ufficio deve invitare il contribuente a comparire (notificando un apposito “invito” con il motivo della possibile rettifica) e attendere 60 giorni, prima di emettere un accertamento. Questo avrebbe esteso il contraddittorio a quasi tutti gli accertamenti. Tuttavia sono stati esclusi espressamente dall’obbligo alcuni atti, tra cui gli accertamenti parziali ex art. 41-bis DPR 600/73 . In pratica, la riforma ha confermato per legge che il contraddittorio preventivo non è dovuto nel caso del 41-bis. La ratio è intuibile: essendo il parziale basato su elementi immediati e mirato alla rapidità, prevedere un invito obbligatorio avrebbe rallentato e potenzialmente vanificato l’azione (pensiamo a casi dove il termine sta per scadere, o si teme che il contribuente possa occultare beni nel frattempo, ecc.). Dunque, ad oggi (2025), la disciplina è: nessun obbligo generalizzato di invito al contraddittorio per l’accertamento parziale, fermo restando che l’ufficio ha sempre la facoltà di attivare un confronto se lo ritiene opportuno.
Va detto che, in concreto, l’Agenzia delle Entrate talvolta avvia comunque un contraddittorio informale anche nei controlli parziali, inviando ad esempio questionari al contribuente per chiedere spiegazioni (soprattutto nei casi di movimenti finanziari anomali). Oppure può inviare un preavviso bonario (ad esempio “abbiamo riscontrato questo, se ha elementi ci contatti entro tot”). Questo avviene in particolare quando l’elemento non è totalmente incontrovertibile e l’ufficio vuole evitare un contenzioso inutile se magari c’è una spiegazione semplice. Ad esempio, di fronte a versamenti bancari non giustificati, spesso l’Agenzia invia un questionario chiedendo al contribuente di indicare la natura di quei movimenti (prestiti? redditi tassati altrove? ecc.): le risposte possono evitare l’emissione del parziale se convincenti, o comunque costituiranno elementi valutati poi in motivazione. Ma tutto ciò è frutto di prassi, non di obbligo: il contribuente non può eccepire come vizio la mancata convocazione prima dell’accertamento, trattandosi di atto escluso dall’obbligo di invito .
Una situazione in evoluzione riguarda i principi UE: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte affermato che, per i tributi armonizzati (come l’IVA), il contraddittorio è un principio fondamentale e la sua mancanza può invalidare l’atto se al contribuente è derivato concreto pregiudizio nella difesa. Ci sono state pronunce (ad es. CGUE caso “Henfling” e altri) in cui si è detto che l’amministrazione finanziaria deve dare al contribuente la possibilità di esprimere il suo punto di vista prima di una rettifica IVA, salvo casi di urgenza. La Cassazione italiana, pur riconoscendo tale principio, lo ha finora disatteso sostenendo che nel nostro ordinamento l’obbligo è solo dove la legge lo prevede, e che comunque il contribuente può difendersi in sede di ricorso (Cass. SS.UU. 24823/2015) . Tuttavia, la tendenza europea spinge per un contraddittorio più ampio. Nel 2023-2024 vi sono state proposte di riforma (dentro la delega fiscale) per rendere strutturale il contraddittorio anticipato in ogni accertamento. Al momento però, ribadiamo, per il 41-bis l’assenza di contraddittorio non costituisce violazione.
In termini pratici, questo significa che il contribuente raggiunto da un accertamento parziale non ha avuto occasione di difendersi prima dell’atto (salvo eventuali questionari o incontri informali), ma può – e deve – far valere le proprie ragioni dopo, attraverso gli strumenti di difesa che ora vedremo. Va sottolineato che la mancanza di contraddittorio non preclude affatto la difesa nel merito: il contribuente potrà in sede di ricorso presentare tutti gli elementi, documenti e deduzioni che avrebbe presentato in un eventuale confronto preventivo. Certo, non aver potuto chiarire prima può aver privato l’ufficio di informazioni che avrebbero forse evitato l’atto: ad esempio, se un versamento bancario era in realtà un prestito familiare documentato, magari con il contraddittorio l’atto non usciva; ma senza, l’atto esce e ora toccherà al contribuente spiegare al giudice che quell’importo non era reddito. È quindi doppiamente importante, per chi riceve un accertamento parziale, attivarsi prontamente nel fornire la propria versione e le prove, sfruttando subito la fase di adesione o preparando un ricorso ben argomentato, perché non c’è stata la fase amministrativa di confronto dove chiarire i malintesi.
In conclusione, nell’accertamento parziale il contraddittorio preventivo non è un diritto esigibile, ma il contribuente non è privo di difese: semplicemente, dovrà esercitarle a posteriori. Si tenga inoltre presente che, talvolta, l’ufficio stesso potrebbe concedere una sorta di contraddittorio postumo: dopo la notifica dell’avviso, se il contribuente presenta un’istanza di autotutela ben motivata o attiva la procedura di adesione (vedi oltre), avrà comunque la chance di discutere il merito con l’ufficio prima di arrivare davanti al giudice. Molti accertamenti parziali si risolvono proprio in sede di adesione grazie alle spiegazioni/documenti forniti dal contribuente (che magari non erano stati richiesti prima). Questo per dire che, pur mancando l’invito formale, c’è ancora spazio per un confronto costruttivo dopo la notifica, se il contribuente agisce tempestivamente e con le giuste argomentazioni.
Cosa fare quando si riceve un avviso di accertamento parziale
Passiamo ora all’aspetto più pratico: come difendersi e quali azioni intraprendere una volta notificato l’accertamento parziale. Dal punto di vista del contribuente (debitore d’imposta presunta), ricevere questo atto genera comprensibilmente preoccupazione, ma è fondamentale non restare passivi. Bisogna invece attivarsi subito per esaminare l’atto e valutare la strategia di risposta migliore. Vediamo passo passo le possibili mosse, che non si escludono a vicenda ma anzi in parte possono integrarsi.
1. Verificare la fondatezza e la regolarità dell’atto
Appena ricevuto l’avviso, la prima cosa da fare è leggerlo attentamente in ogni sua parte per capire cosa viene contestato e perché. Questo step è cruciale: occorre individuare esattamente l’oggetto del rilievo (es.: “redditi di lavoro autonomo non dichiarati per €XX nell’anno YY derivanti da …”; oppure “IVA dovuta su operazioni ritenute inesistenti per €ZZ”; ecc.) e la motivazione addotta dall’ufficio. Spesso l’avviso parziale contiene paragrafi esplicativi: vanno compresi a fondo, magari con l’ausilio del proprio consulente fiscale o legale. In parallelo, bisogna controllare i requisiti formali e la notifica come discusso in precedenza: ad esempio, è stato notificato entro i termini? È firmato? Sono stati allegati (o trascritti) gli eventuali atti richiamati? Ci sono errori evidenti di persona o di calcolo? Queste verifiche possono far emergere vizi di legittimità che costituiranno motivi di ricorso (ad es. nullità per difetto di motivazione, per notifica invalida, ecc.). Anche la quantificazione va ricontrollata: se l’ufficio ha commesso errori aritmetici nel calcolo delle imposte o interessi, è un aspetto da notare subito e eventualmente segnalare.
Parallelamente, dal lato sostanziale, il contribuente deve valutare se la pretesa fiscale è fondata o no. In concreto: “L’ufficio ha ragione oppure sta commettendo un errore/abuso?”. Per fare ciò, occorre raccogliere i propri documenti e informazioni relativi al periodo e al fatto contestato. Ad esempio, se si tratta di versamenti bancari non giustificati, andare a ricostruire la provenienza di quei versamenti (contratti, ricevute, persone coinvolte). Se si tratta di fatture considerate false dall’ufficio, recuperare la documentazione che ne dimostra l’effettività (DDT, corrispondenza commerciale, ecc.). Insomma, predisporre tutto il dossier difensivo. È utile in questa fase consultare un professionista esperto (dottore commercialista o avvocato tributarista): la valutazione di fondatezza richiede competenze tecniche, sia contabili che legali.
Da questa analisi iniziale possono emergere due scenari di base:
- a) L’accertamento risulta corretto (o difficilmente contestabile): può capitare che, verificando, il contribuente si renda conto che effettivamente ha commesso quell’omissione e l’ufficio la sta cogliendo nel giusto. Ad esempio, l’avviso mostra chiaramente che alcune fatture attive non sono state inserite in dichiarazione per un mero errore materiale: i documenti lo confermano. Oppure l’ufficio ha scoperto un reddito che il contribuente effettivamente non sapeva andasse dichiarato e non ha argomenti per contestare la ricostruzione (se non, forse, invocare clemenza sulle sanzioni). In casi del genere, opporsi ostinatamente potrebbe essere inefficace e controproducente: si rischierebbe solo di aggiungere spese di lite. Meglio valutare le opzioni di definizione agevolata (pagamento con sanzioni ridotte) o eventualmente cercare un accordo con l’ufficio (adesione), come vedremo nei prossimi punti.
- b) L’accertamento appare infondato o contestabile: qui rientrano tutte le situazioni in cui, invece, il contribuente non condivide la pretesa. Magari perché i fatti sono stati male interpretati (es. quel versamento non era un ricavo ma un prestito già restituito, dunque non tassabile), o perché l’ufficio ha applicato male la legge (es. ha disconosciuto una detrazione che spettava, o ha calcolato il reddito con criteri presuntivi troppo deboli). O ancora perché ci sono vizi procedurali (es. mancanza di motivazione adeguata). In questi casi, è opportuno prepararsi a contestare l’atto, cercando però prima se possibile di convincere l’ufficio a rivederlo (tramite adesione o autotutela) ed eventualmente, se non si risolve, presentando ricorso al giudice tributario.
In pratica, dopo aver capito l’atto, occorre decidere una linea d’azione. Le opzioni non si escludono reciprocamente: ad esempio si può tentare l’adesione e, se fallisce, fare ricorso; oppure si può pagare parzialmente e ricorrere per il resto, etc. Nei paragrafi seguenti descriveremo le principali strade: il pagamento con acquiescenza, l’accertamento con adesione, il ricorso tributario, l’autotutela e altri strumenti. È bene tenere a mente le tempistiche: l’elemento tempo è fondamentale. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per impugnare l’avviso; se presenta istanza di adesione, questo termine si sospende per 90 giorni (quindi in totale fino a 150 giorni per poi eventualmente fare ricorso) . Entro 60 giorni, se non fa nulla, l’atto diviene definitivo e l’Agenzia potrà attivare la riscossione coattiva. Quindi ogni decisione va presa in tempi brevi. Già nei primi 20-30 giorni bisogna aver chiaro come procedere, per avere tempo di preparare eventuali istanze o il ricorso.
2. Pagare con definizione agevolata (acquiescenza)
Se, dall’analisi, risulta che l’accertamento è fondato (o comunque il contribuente non intende contestarlo), la strada più semplice e rapida è procedere al pagamento di quanto richiesto, avvalendosi delle agevolazioni previste per chi non impugna l’atto (c.d. acquiescenza all’accertamento). Il nostro ordinamento infatti incentiva il pagamento immediato riducendo le sanzioni in caso di definizione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
In concreto, l’acquiescenza consiste nel: pagare interamente le somme dovute (imposte + interessi + sanzioni) entro 60 giorni dalla notifica, oppure presentare entro lo stesso termine domanda di rateizzazione con pagamento della prima rata. A fronte di ciò, la legge (art. 15 D.Lgs. 218/1997) prevede che le sanzioni irrogate vengano ridotte ad 1/3 del loro importo . In altre parole, il contribuente beneficia di uno sconto pari a 2/3 delle sanzioni. Ad esempio, se l’accertamento imponeva €10.000 di maggiore IRPEF e una sanzione del 100% (€10.000), pagando in acquiescenza la sanzione sarà ridotta a circa €3.333 (un terzo del 100%, cioè ~33% dell’imposta). Questo può rappresentare un risparmio notevole. Da notare: la norma parla di riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate. Dunque se l’ufficio avesse già applicato la sanzione minima (ad esempio 90%), in acquiescenza si paga il 30% dell’imposta (che è appunto 1/3 di 90%). Se l’ufficio avesse applicato una sanzione superiore al minimo (es. 120%), si paga comunque 1/3 di 120% = 40% dell’imposta. In ogni caso, la riduzione non può andare sotto il 30% dell’imposta evasa, che resta il minimo assoluto previsto in sede di adesione/acquiescenza per dichiarazione infedele.
Come procedere: L’avviso stesso solitamente contiene il calcolo delle somme dovute in caso di pagamento entro 60 giorni con sanzioni ridotte. In alternativa, l’ufficio invia un prospetto di liquidazione su richiesta. Il contribuente può pagare in un’unica soluzione entro i 60 giorni, oppure chiedere la rateizzazione: per legge, se l’importo supera €50.000, si possono avere fino a 20 rate trimestrali; se inferiore, fino a 8 rate trimestrali (questa regola è stata ampliata di recente, prima erano 8 e 16 rate). La prima rata va versata entro 60 giorni. Attenzione: se si sceglie di rateizzare, non si perde la riduzione delle sanzioni, a patto di rispettare poi le scadenze di tutte le rate (in caso di decadenza dalla rateazione, si perdono i benefici).
Una volta pagato (o avviato il pagamento rateale) nei termini, l’accertamento si considera definito e non è più impugnabile. L’ufficio rinuncia ad emettere la cartella esattoriale (anzi, ormai l’avviso è “esecutivo” di per sé, ma con la definizione non si procederà oltre). In caso di rate, l’ente riscossore (Agenzia Entrate-Riscossione) emetterà solo i piani di pagamento rateale.
La scelta dell’acquiescenza conviene quando: (i) il contribuente riconosce la fondatezza del rilievo o comunque non ha possibilità concrete di vittoria in giudizio; (ii) l’importo da pagare, grazie alle sanzioni ridotte, risulta sostenibile; (iii) si vuole chiudere presto la vicenda, evitando costi e tempi di un contenzioso. Bisogna però valutare con attenzione, magari con un consulente: una volta pagato, non si torna indietro. Non è possibile pagare e poi fare ricorso per farsi ridare i soldi – il pagamento con acquiescenza implica l’accettazione dell’atto. Solo se emergessero errori grossolani dell’ufficio (tipo doppio pagamento richiesto) si potrebbe chiedere rimborso in autotutela, ma non perché “ci si è ripensati”.
Un punto da considerare: il pagamento definisce solo l’atto oggetto. Se l’Agenzia in futuro trovasse altri redditi evasi per lo stesso anno, potrebbe comunque (nei termini) emettere un altro accertamento. Pagare questo non garantisce immunità per il resto dell’anno (non è un condono tombale). Però, se si presume di aver sanato tutte le pendenze note, allora ok.
In conclusione, se si opta per pagare, occorre rispettare scrupolosamente i 60 giorni. Anche un giorno di ritardo fa saltare la definizione agevolata: in tal caso l’ufficio iscriverà a ruolo le somme con sanzione piena (2/3 in più!) e interessi di mora. Se per qualche motivo non si riesce a pagare per intero entro il 60° giorno, è fondamentale almeno presentare ricorso per sospendere gli effetti (anche se poi magari si rinuncerà all’impugnazione pagando con sanzioni ridotte in sede di conciliazione). Non fare nulla e non pagare interamente entro i 60 giorni è lo scenario peggiore (si finisce a ruolo con sanzioni intere, interessi di mora, aggi e senza possibilità di riduzioni).
3. Accertamento con adesione (definizione concordata)
Se il contribuente non è totalmente d’accordo con l’accertamento ma preferisce comunque evitare subito il giudizio, può attivare la procedura di accertamento con adesione prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218. L’adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso che consente all’ufficio e al contribuente di trovare un accordo transattivo sull’imponibile e sulle imposte dovute, prima di arrivare davanti al giudice. In cambio della chiusura concordata, il contribuente beneficia di significative riduzioni delle sanzioni (ancora maggiori di quelle dell’acquiescenza).
Come si attiva: Entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente presenta un’istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto . L’istanza è in carta libera e deve indicare l’atto impugnato e la volontà di aderire. Questo fa scattare una sospensione automatica di 90 giorni dei termini per fare ricorso . L’ufficio a questo punto convoca il contribuente (di solito con lettera o via PEC) per un incontro, che in genere avviene qualche settimana dopo. All’incontro (o più incontri) le parti discutono i rilievi e valutano se e come raggiungere un accordo. Il contribuente può portare documenti, memorie difensive, prospetti di calcolo alternativi, ecc., per convincere l’ufficio a ridurre o annullare alcuni rilievi. L’ufficio, dal canto suo, potrà mostrare apertura nel riesaminare il caso e nell’eventualmente rivedere al ribasso la pretesa, tenendo conto degli elementi apportati dal contribuente e anche dell’opportunità di evitare un contenzioso dall’esito incerto.
- Esito positivo: Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione in cui si riportano i nuovi importi concordati (imponibili, imposte, sanzioni). Ad esempio, il contribuente dimostra che non €50.000 ma solo €30.000 sono ricavi non dichiarati (perché €20.000 erano rimborsi già tassati): l’ufficio accetta e si accordano su €30.000 di imponibile. Oppure magari l’ufficio, per chiudere, accetta di qualificare diversamente un reddito con aliquota più bassa, ecc. Le parti firmano il verbale di adesione e da quel momento decorrono 20 giorni per pagare (o rateizzare) le somme dovute in base all’accordo. Vantaggi sanzionatori: con l’adesione, le sanzioni sono ulteriormente ridotte: si applicano sanzioni pari a 1/3 del minimo edittale previsto (art. 2 D.Lgs. 218/97). Per la dichiarazione infedele, il minimo è 90%, quindi diventano 30% dell’imposta . Se il minimo era 100% (come per omessa fatturazione IVA), diventano ~33%, e così via. Spesso l’ufficio in sede di adesione aveva già applicato il minimo, quindi di fatto si dimezzano rispetto all’atto originario (es. da 90% a 30%). Se l’atto iniziale aveva sanzioni al min. già ridotte a 1/3 (acquiescenza), allora l’adesione ha uguale trattamento sanzionatorio; ma di solito l’atto ha sanzione piena o minima intera, quindi l’adesione conviene. In aggiunta, niente spese processuali e si chiude definitivamente la questione.
- Esito negativo: Se non si raggiunge un accordo (perché le posizioni restano distanti, o perché l’ufficio non ritiene di poter accogliere le ragioni del contribuente), viene redatto un verbale di mancato accordo o, semplicemente, decorrono i 90 giorni senza intesa. A quel punto il contribuente ha ancora 30 giorni di tempo (dalla data di mancato accordo o dalla scadenza dei 90 giorni) per presentare ricorso in Commissione Tributaria . In totale dunque l’adesione guadagna tempo e fornisce un’anteprima dell’eventuale contenzioso: se in adesione l’ufficio non concede nulla e il contribuente resta convinto delle proprie ragioni, si preparerà al ricorso; se invece l’ufficio ha riconosciuto in parte gli errori ma non c’è accordo totale, il contribuente potrà in ricorso contestare solo la parte rimasta litigiosa.
Quando conviene tentare l’adesione? Quasi sempre vale la pena presentare istanza di adesione, a meno che il contribuente non sia totalmente certo di voler pagare e chiudere subito. L’adesione sospende i termini e offre una sede di confronto che può portare a soluzioni. Anche se l’ufficio in adesione non accetta tutte le nostre tesi, potrebbe comunque ricalcolare alcune voci e alleggerire l’atto, magari facendoci risparmiare su sanzioni o imponibile. Se l’accordo è ragionevole, conviene evitare il contenzioso e chiudere. Se invece l’ufficio rimane rigido, non si perde nulla: si useranno i 90 giorni per preparare meglio il ricorso. Importante: la presentazione dell’istanza di adesione non implica affatto ammissione di colpevolezza. È solo un atto formale per avviare il dialogo. Anche se poi si litiga, nulla di quanto discusso in sede di adesione può essere usato contro il contribuente in giudizio (ad esempio eventuali concessioni fatte a voce non hanno valore probatorio). Quindi non c’è rischio a provare.
Procedura di adesione in pratica: Presentata l’istanza, attendere la convocazione. Se non arriva, si può sollecitare. Presentarsi (da soli o, meglio, col proprio consulente) all’appuntamento muniti di tutti i documenti utili e di uno schema di proposta (ad esempio: “riconosco questo imponibile ma chiedo di togliere questo”). Mantenere un atteggiamento collaborativo ma fermo sui punti essenziali. L’ufficio potrebbe fare una proposta: valutarla con attenzione. Se serve, chiedere qualche giorno per pensarci (si può fissare un secondo incontro). Non farsi forzare a firmare subito se non convinti. Ricordare che se si firma l’adesione, poi è definitiva e non impugnabile: quindi assicurarsi di poter sostenere l’onere concordato (pagamento) e di essere soddisfatti del compromesso. Se c’è incertezza, è lecito non aderire e proseguire col ricorso. In alcuni casi, prima di concludere, l’ufficio può concedere una bozza di calcolo così da far valutare al contribuente le cifre. Usare bene i 90 giorni: se alla fine non c’è accordo, preparare entro i successivi 30 giorni il ricorso (non aspettare l’ultimo minuto).
In conclusione, l’adesione è uno strumento prezioso per “negoziare” col Fisco. Sul piano delle sanzioni è il più conveniente (30% del minimo). Quindi specie per atti con sanzioni elevate conviene provare a definire in adesione. Anche su importi lordi alti, l’ufficio a volte in adesione riduce qualcosa perché preferisce incassare subito piuttosto che rischiare in giudizio. D’altro canto, se il contribuente ha ragione forte su tutta la linea, potrebbe non voler cedere nulla e andare in giudizio. Ogni caso è a sé: occorre una valutazione costi/benefici (anche in base alle prove che abbiamo: se sono inoppugnabili per noi, si può puntare a vincere al 100% in giudizio e quindi non ci si accontenta di un 50% in adesione, ad esempio).
4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (giudice tributario)
Se il contribuente intende contestare l’accertamento (in tutto o in parte) e non è stato possibile risolvere in sede amministrativa, la via da intraprendere è quella del ricorso giurisdizionale davanti al giudice tributario. Dal 2023, a seguito della riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022), le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria: di primo grado (già Commissioni Provinciali) e di secondo grado (già Regionali) . La sostanza del processo però non è cambiata radicalmente. Vediamo gli aspetti salienti:
- Termine e organo competente: Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (se è stata presentata istanza di adesione, come detto, si ottiene una sospensione di 90 giorni + 30 dalla fine di questa). La competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente (per le persone fisiche, la residenza anagrafica; per le società, la sede). In pratica coincide col luogo dell’ufficio che ha emesso l’atto in molti casi.
- Come si propone ricorso: Occorre predisporre un atto di ricorso in cui si indicano il contribuente ricorrente, l’atto impugnato, l’ente resistente (Agenzia Entrate – DP di…), i motivi di ricorso e le relative richieste. I motivi sono le ragioni di diritto e di fatto per cui si chiede l’annullamento (o la riforma) dell’atto impugnato. Nel nostro caso, i motivi tipici potrebbero essere: a) illegittimità dell’accertamento per carenza di motivazione o per errata interpretazione dei fatti; b) insussistenza del presupposto dell’evasione (es: i versamenti erano redditi esenti o non imponibili, quindi l’accertamento è infondato); c) violazione di legge (es: applicazione errata di norme tributarie, calcoli sbagliati, decadenza dei termini, violazione del divieto di doppia imposizione sul medesimo presupposto se c’è già altro atto, ecc.); d) vizi formali (es: nullità per difetto di firma autorizzata, per mancata allegazione di atti non conosciuti, ecc.); e) ogni altro argomento che smonti la pretesa (ad esempio difetto di prova per presunzioni non gravi né precise). Nel ricorso si chiede in genere l’annullamento totale dell’atto; in subordine, l’annullamento parziale (qualora vi siano alcuni rilievi fondati e altri no). Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate (all’ufficio locale che ha emesso l’atto, in persona del direttore pro tempore) per via telematica (PEC) o a mezzo ufficiale giudiziario o posta (ormai quasi tutto avviene via PEC, tramite processo tributario telematico). Dopo la notifica, si deve costituire il fascicolo presso la segreteria della Corte tributaria depositando copia del ricorso e degli allegati, entro 30 giorni dalla notifica.
- Procedura del contenzioso: Una volta instaurata la causa, l’Agenzia delle Entrate si costituirà a sua volta in giudizio depositando un atto di risposta (controdeduzioni) in cui difende il proprio operato. Il contribuente (ora “ricorrente”) può successivamente depositare memorie aggiuntive, documenti, repliche, secondo i termini previsti (solitamente 30 giorni prima dell’udienza le memorie integrative, 20 giorni prima le repliche). È importante produrre tutte le prove documentali utili: in ambito tributario vigono ampi poteri di produzione documenti anche tardivamente, ma è bene consegnare il grosso subito. Ad esempio, copia di estratti conto, contratti di prestito, documenti giustificativi di spese, perizie, ecc., a supporto delle nostre tesi. Il processo tributario di primo grado termina normalmente con un’udienza pubblica (o da remoto) in cui le parti possono illustrare brevemente il caso e rispondere a eventuali domande del giudice. Infine, la Corte delibererà e depositerà una sentenza. I tempi possono variare: mediamente da 6 mesi a 18 mesi per la decisione in primo grado, a seconda del carico dell’ufficio. Nel frattempo, il contribuente può chiedere (con istanza separata nel ricorso) la sospensione dell’atto impugnato, se c’è pericolo di un danno grave e irreparabile (ad esempio importo elevatissimo che l’Agenzia metterà a ruolo prima della sentenza). La sospensione viene decisa in una camera di consiglio cautelare entro qualche mese. Se concessa, blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado. Altrimenti, l’atto rimane efficace.
- Pagamenti durante il contenzioso: L’avviso di accertamento, per legge, è già esecutivo decorsi i 60 giorni dalla notifica. Ciò significa che, anche se il contribuente ha presentato ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iniziare la riscossione coattiva (di norma, iscrivere a ruolo le somme dovute). Tuttavia, dal 2011 la legge prevede che in pendenza di giudizio l’Agente della riscossione non riscuota tutto subito: in particolare, dopo il primo grado, se il contribuente non ha ottenuto sospensione, l’Agenzia può riscuotere fino al 50% delle imposte accertate (più interessi e sanzioni corrispondenti) in caso di esito a sé favorevole; dopo il secondo grado, può riscuotere fino al 100% . Ma questi meccanismi sono complessi. Ciò che conta: presentare ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Quindi, per evitare che, nelle more, arrivino cartelle o blocchi, è consigliabile chiedere la sospensiva al giudice. In pratica, contestualmente al ricorso, inserire un’istanza di sospensione dell’esecuzione, motivando che pagare subito causerebbe un danno grave (ad esempio metterebbe in crisi l’azienda, o costringerebbe a vendere la casa, ecc.) e che il ricorso ha “fumus boni iuris” (cioè motivi fondati). La Corte fisserà in tempi relativamente brevi (2-4 mesi) l’udienza cautelare. Se concede la sospensione, l’Agenzia non può procedere alla riscossione finché non c’è la sentenza di primo grado. Se la nega, l’Agenzia probabilmente emetterà una cartella di pagamento per una parte delle somme (tipicamente 50% delle imposte più sanzioni e interessi su quel 50%). Anche contro quella cartella si potrà ricorrere, ma di solito conviene, in caso, chiedere comunque una dilazione di pagamento all’Agente della riscossione, per evitare misure esecutive.
- Svolgimento e decisione: Nel giudizio, il contribuente dovrà convincere il giudice che l’accertamento è infondato o illegittimo. In queste cause tributarie, spesso decisivi sono i documenti e le presunzioni legali. Ad esempio, se l’ufficio ha presunto un reddito da un versamento sul conto, la legge pone a carico del contribuente l’onere di provare che quel versamento non è reddito (art. 32 DPR 600/73): il giudice valuterà se il contribuente ha fornito prova contraria (esibendo la quietanza di un prestito ricevuto e poi restituito) o no. Oppure, se l’ufficio ha contestato costi fittizi, spetterà a loro provare (anche con presunzioni semplici) la fittizietà, e al contribuente difendersi mostrando l’effettività della transazione. Il giudice potrebbe accogliere in toto il ricorso (annullando quindi l’accertamento e dando ragione al contribuente) oppure respingerlo in toto (confermare l’atto) o anche accoglierlo parzialmente. Ad esempio, potrebbe ritenere valide alcune giustificazioni e annullare parte dell’imponibile, lasciando il resto. In sentenza il giudice può anche rideterminare la sanzione in base alla sua valutazione (nei limiti del minimo edittale).
- Dopo la sentenza di primo grado: Se il contribuente vince, l’accertamento è annullato (in tutto o in parte, secondo la decisione). L’Agenzia potrebbe appellare in secondo grado se non condivide. Se invece il contribuente perde (totalmente o parzialmente), può presentare appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o 6 mesi dal deposito se non notificata). Il processo di secondo grado rivede il caso e porta a un’altra sentenza. Infine, resta eventualmente il ricorso per Cassazione per soli motivi di diritto. In parallelo, se il contribuente aveva ottenuto sospensione in primo grado ma perde, dovrà pagare quanto dovuto (generalmente il 50% dopo primo grado in caso di soccombenza, e l’ulteriore 50% se perde anche in appello). Le regole di riscossione provvisoria sono un po’ tecniche, ma in sostanza: conviene vincere almeno parzialmente in primo grado per congelare gran parte delle somme, altrimenti l’Agenzia potrà pretendere riscossioni intermedie.
- Costi del processo tributario: Impugnare un accertamento comporta alcuni costi: innanzitutto, l’assistenza tecnica di un professionista (avvocato o commercialista abilitato), obbligatoria se il valore della causa supera €3.000. Difficilmente un accertamento parziale avrà importo inferiore, quindi quasi sempre servirà un tecnico. Ciò comporta onorari (che però spesso valgono la posta in gioco). Inoltre c’è da pagare un contributo unificato tributario per iscrivere a ruolo il ricorso, il cui importo varia in base al valore della controversia: per esempio, su controversie fino a €50.000 è €30, sale a €50 se fino a 200k, e così via (importi abbordabili). Se si vince la causa, si può chiedere la rifusione delle spese di lite: il giudice può condannare l’Agenzia a pagare (in parte) le spese legali del contribuente. In caso di soccombenza reciproca può compensarle. Da segnalare: con la riforma 2022, se il contribuente vince in primo grado e l’Agenzia appella, per quest’ultima è stata introdotta una condanna automatica alle spese se perde anche in secondo grado, salvo casi eccezionali. Questo per responsabilizzare l’amministrazione a non fare appelli temerari. Invece, il contribuente che perde in primo e appella rischia sanzioni (fino al 50% del contributo unificato) se l’appello è manifestamente infondato.
In sintesi, il ricorso al giudice è l’arma principale quando si ritiene l’accertamento sbagliato. È un percorso potenzialmente lungo (più gradi) ma che può portare all’annullamento integrale dell’atto se si riesce a dimostrarne l’infondatezza o l’illegittimità. Per sfruttarlo al meglio, è necessario predisporre un’ottima difesa, con il supporto di professionisti e con prove solide. Tenere a mente che il giudice tributario decide secondo il suo prudente apprezzamento, e che in molti casi l’onere della prova è in parte sul contribuente (specie su quelle presunzioni di cui sopra). Ecco perché, tornando all’inizio, la fase di raccolta delle prove e la scelta strategica (pagare, aderire o ricorrere) vanno ponderate con chi ha esperienza, per evitare di avventurarsi in cause perse o, viceversa, di rinunciare a difese vincenti.
5. Richiedere l’annullamento in autotutela
Parallelamente (e senza escludere le opzioni sopra), il contribuente può presentare all’ente impositore un’istanza di autotutela, ossia una richiesta motivata di annullamento (o rettifica) spontaneo dell’atto da parte della stessa Amministrazione che lo ha emesso. L’autotutela è il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di correggere i propri atti quando risultino erronei o illegittimi, anche al di fuori del contenzioso. In ambito tributario, l’autotutela è disciplinata dalla L. 212/2000 (art. 2-quater) e da varie circolari, e può portare all’annullamento totale o parziale dell’accertamento se l’ufficio riconosce il proprio errore.
Il contribuente che riceve un accertamento parziale può dunque inviare una istanza in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, esponendo i motivi per cui ritiene l’atto sbagliato e chiedendone l’annullamento (o la correzione). Questa strada è particolarmente indicata quando c’è un errore evidente e oggettivo da parte dell’ufficio. Ad esempio: doppia imposizione di un reddito già tassato, scambio di persona (hanno contestato a me redditi di un omonimo), errore di calcolo macroscopico, applicazione di aliquota sbagliata, mancato riconoscimento di un pagamento in realtà provato, ecc. In casi del genere, spesso l’ufficio stesso – di fronte alle nostre evidenze – preferirà annullare o rettificare l’atto, per economia di azione e perché sa che perderebbe in giudizio.
Vantaggi e limiti dell’autotutela: Il vantaggio è che se l’ufficio accoglie, si risolve rapidamente e senza costi. Il limite è che l’autotutela è discrezionale: non esiste un diritto soggettivo del contribuente all’annullamento. L’ente può anche ignorare l’istanza o respingerla. Inoltre, l’autotutela non sospende di per sé i termini di ricorso (né la riscossione): quindi è fondamentale comunque presentare ricorso entro 60 giorni se non si ha ancora riscontro e il termine sta per scadere. In pratica, l’istanza di autotutela non blocca l’atto. È solo un tentativo amministrativo di persuasione.
Quando presenta istanza, il contribuente può però chiedere all’ufficio di sospendere in via interna la riscossione fino a esito dell’autotutela: l’ufficio ha facoltà di farlo se valuta che l’istanza è fondata (c.d. autotutela sospensiva). Non è un diritto, ma molti uffici lo fanno in presenza di errori evidenti.
Come scriverla: Nell’istanza è bene indicare: i dati dell’atto (n. e data, contribuente, anno d’imposta), la descrizione chiara del problema e il riferimento a eventuali prove allegate. Il tono dovrebbe essere collaborativo e non polemico, facendo appello al senso di equità dell’ufficio e citando magari circolari o prassi che supportano la nostra tesi. Ad esempio: “Egregio Ufficio, con riferimento all’avviso in oggetto, si evidenzia che lo stesso risulta viziato da un errore di fatto. In particolare, viene ripreso a tassazione un importo di €10.000 indicato come ‘versamento non giustificato’, ma come da documentazione allegata trattasi di un prestito bancario già restituito (si allegano contratto di mutuo e quietanza). Tale somma, quindi, non costituisce reddito imponibile ex art. 6 TUIR. Si chiede pertanto, alla luce di quanto sopra, l’annullamento/archiviazione in autotutela dell’atto, o in subordine la sua rettifica eliminando dal calcolo detto importo e le relative sanzioni e imposte. In attesa di riscontro, si confida in un positivo esercizio dell’autotutela, evidenziando che in mancanza il sottoscritto sarà costretto ad adire le vie contenziose.”. Allegare fotocopia avviso e tutti i documenti utili.
Dopo l’istanza: L’ufficio può rispondere in tempi variabili (talora poche settimane, talora mesi, talora mai in caso di diniego tacito). Se accoglie l’autotutela, emetterà un provvedimento di annullamento (notificandolo) e l’atto cessa i suoi effetti. Se non risponde entro un tempo ragionevole e il termine di ricorso è prossimo, non aspettare oltre: fare ricorso. Spesso gli uffici preferiscono esaminare seriamente l’autotutela dopo che vedono il ricorso (magari per decidere se insistere o cedere). Addirittura, può capitare che in udienza l’ufficio dichiari di aver annullato in autotutela poco prima, facendo cessare la materia del contendere.
Un caso particolare di autotutela è la c.d. autotutela “sostitutiva”: ovvero quando l’ufficio annulla un avviso per emetterne un altro più corretto (o più pesante). Questo era prassi controversa. La Cassazione SS.UU. 2024 (citata sopra) ha sancito che l’ufficio può farlo in presenza di vizi e entro i termini , anche se ciò porta un atto più gravoso. Quindi, se il nostro è un caso in cui l’ufficio ha sbagliato per difetto (cioè poteva contestare di più), chiedere autotutela può teoricamente portare a un “boomerang” (nuovo atto peggiore). Nella prassi però l’Agenzia difficilmente peggiora la posizione per chi ha presentato istanza: lo farebbe solo se davvero ha trovato errori grossolani in nostro favore. Per scrupolo, il professionista valuta anche questo aspetto prima di chiedere autotutela.
In conclusione, tentare l’autotutela è sempre consigliabile quando c’è un errore evidente dell’ufficio. Male non fa (se l’istanza è ben formulata) e può risolvere facilmente. Non bisogna però farci totale affidamento né lasciar scadere i termini di impugnazione sperando in una risposta. Il motto è: “Chiedi l’annullamento, ma prepara anche il ricorso”. Se poi l’annullano, si rinuncerà al ricorso (o si dichiarerà cessata la materia del contendere).
6. Altri strumenti (accollo del debito, definizioni agevolate, ravvedimento post-accertamento, ecc.)
Oltre alle vie principali già esaminate, esistono alcune ulteriori possibilità, meno comuni, che citiamo brevemente per completezza:
- Accollo del debito tributario: Introdotto da alcuni anni (art. 8, comma 2 L. 212/2000), consente a un soggetto terzo di “farsi carico” del debito d’imposta altrui. In pratica, ad esempio, un socio o parente potrebbe pagare l’accertamento al posto del contribuente accollato. Questo non annulla l’atto né lo trasferisce formalmente: semplicemente il terzo paga e poi eventualmente si regolerà con il contribuente (l’amministrazione è comunque libera da pretese). È una fattispecie non molto frequente; può essere utile in situazioni in cui il contribuente non ha liquidità ma un terzo sì e vuole evitare aggravi (anche perché le sanzioni ridotte si applicano comunque se paga entro i 60 gg). L’accollo però non consente di impugnare l’atto al posto del contribuente: il terzo accollante non assume legittimazione in giudizio. Serve solo a pagare.
- Definizioni agevolate e condoni: Ogni tanto il legislatore, con provvedimenti ad hoc (es. “pace fiscale”, “rottamazione liti”, “tregua fiscale” etc.), introduce possibilità di definire a condizioni vantaggiose i contenziosi o gli accertamenti. Ad esempio, con la Legge di Bilancio 2023 è stata prevista la definizione agevolata delle liti pendenti: se il contribuente aveva un ricorso pendente, poteva chiuderlo pagando un certo importo ridotto (in base al grado e all’esito). O ancora, la definizione degli avvisi bonari pagando solo imposte e ridotto 3% di sanzioni . Queste norme sono temporanee e specifiche: è bene, quando si riceve un accertamento, informarsi se c’è in vigore qualche sanatoria applicabile. Ad esempio, ad ottobre 2025, alcune definizioni 2023 sono chiuse, ma potrebbe essercene di nuove in discussione. Non si può far affidamento certo sui condoni futuri, ma se già ce n’è uno per le liti e conviene, lo si può sfruttare. Di solito riguardano le cause già in corso, non un avviso appena emesso (per quello semmai c’è l’adesione come abbiamo visto).
- Ravvedimento operoso post-accertamento: Tecnicamente il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) è possibile solo prima che la violazione sia già stata contestata o scoperta. Dopo che l’accertamento arriva, non ci si può “ravvedere” in senso stretto. Tuttavia, il legislatore nel 2019 ha introdotto la possibilità di un ravvedimento “speciale” per atti già emessi (poi utilizzata per la definizione del 2023). In assenza di norme specifiche, dopo l’avviso si può solo aderire o pagare con sanzioni ridotte come detto. Quindi, in generale, non esiste ravvedimento operoso dopo l’emissione dell’accertamento. Il contribuente non può autonomamente rimodulare l’atto: deve passare dall’adesione o acquiescenza.
- Conciliazione giudiziale: Mentre il processo è in corso, c’è sempre la possibilità per contribuente e ufficio di trovare un accordo transattivo e sottoporlo al giudice (art. 48 D.Lgs. 546/92). Questa è la conciliazione giudiziale, che può essere fuori udienza (proposta e accordo formalizzato prima) o in udienza. In pratica è simile all’adesione ma avviene quando già c’è un ricorso pendente. Il vantaggio è che anche in conciliazione le sanzioni si riducono, se l’accordo è formalizzato: in primo grado diventano il 40% del minimo (un po’ più alte che in adesione/mediazione) . Se in secondo grado, 50%. La conciliazione può essere totale o parziale. Ad esempio, l’ufficio in giudizio si convince di alcuni errori e propone di ridurre il rilievo: il contribuente accetta, si concilia su quella base. Il giudice omologa con sentenza l’accordo e la lite si chiude lì. Lo sconto sanzioni del 40% è leggermente meno conveniente dell’adesione (30%), ma si applica anche se la causa era di importo >50k (mentre la mediazione/adesione sono possibili sempre, la mediazione obbligatoria no oltre 50k, ma l’adesione sì per qualsiasi importo). Diciamo che se si arriva in giudizio e si intravede una possibilità di accordo, la conciliazione è raccomandabile, perché evita ulteriori gradi di giudizio e consente risparmi sanzioni e di spese.
In merito, notiamo che per le controversie di modesto valore (fino a €50.000) è obbligatorio prima del giudizio passare dalla fase di reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). Questa procedura prevede che il ricorso presentato per importi entro tale soglia valga anche come reclamo: l’ufficio può accoglierlo in autotutela oppure formulare una proposta di mediazione riducendo importi o sanzioni. Se il contribuente accetta, l’accordo di mediazione si perfeziona con il pagamento di quanto concordato e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo . La mediazione tributaria (che altro non è che una conciliazione ante primo grado) è molto simile all’adesione come esito. La differenza è che è obbligatoria su liti piccole: se non si trova accordo in 90 giorni, il ricorso si intende respinto e prosegue come processo. Per l’accertamento parziale, in cause sotto i 50k il contribuente quindi segue questa strada: propone eventualmente una riduzione, l’ente risponde. Se non c’è accordo, la causa va avanti e verrà decisa dal giudice.
In definitiva, il ventaglio di opzioni difensive è ampio. Bisogna combinare quelle utili a seconda del caso: ad esempio, presentare istanza di adesione (opzione 3) e nel frattempo istanza di autotutela (opzione 5). Oppure, in giudizio, cercare una conciliazione (opzione 6) se in adesione non si è chiuso. L’importante è non restare inerti: l’accertamento parziale, se ignorato, diverrà definitivo e darà luogo a una cartella esattoriale o atto di riscossione che poi sarà molto più difficile da rimuovere. Il contribuente che, viceversa, agisce con tempestività ha buone chance o di ridurre il danno (pagando meno sanzioni, magari concordando importi minori) o addirittura di annullare la pretesa se ha ragione piena.
Nei capitoli successivi approfondiremo i profili sanzionatori e penali connessi agli accertamenti parziali, e proporremo esempi pratici e una sezione di FAQ per chiarire i dubbi frequenti.
Profili sanzionatori: sanzioni amministrative nell’accertamento parziale
Ogni avviso di accertamento, incluso quello parziale, comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie a carico del contribuente, qualora venga contestata una violazione. È utile comprendere quali sanzioni possono essere applicate e in che misura, nonché quali riduzioni sono previste in caso di definizione.
Nel contesto dell’accertamento parziale, le violazioni contestate tipicamente rientrano nelle fattispecie di “dichiarazione infedele” oppure “omessa fatturazione/registrazione” (per IVA), a seconda del caso concreto:
- Dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/1997): si ha quando nella dichiarazione annuale dei redditi o IVA il contribuente indica un imponibile inferiore a quello effettivo o un’imposta inferiore a quella dovuta (o anche crediti inesistenti o eccedenze fittizie). Negli accertamenti parziali, quasi sempre è questo il caso (redditi non dichiarati, costi indebiti portati in deduzione, IVA dovuta in più, ecc.). La sanzione amministrativa prevista è pari al 90% della maggior imposta o della differenza di credito indebitamente esposto , aumentabile fino al 180% in presenza di determinati aggravanti (ad esempio, imposta evasa superiore a €50.000 o artifici). L’importo specifico viene determinato dall’ufficio in relazione alla gravità e alla presenza di attenuanti/aggravanti. Spesso l’ufficio applica il minimo edittale (90%) oppure un po’ sopra (100-120%) in prima battuta. Esempio: se recupera €10.000 di IRPEF, sanzione base €9.000 (90%). Se ravvisa anche altri comportamenti dolosi, può salire. In caso di omessa dichiarazione (non frequente nel parziale, perché se uno non ha presentato dichiarazione di solito l’atto è in rettifica globale), la sanzione sarebbe dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
- Violazioni IVA specifiche: se l’accertamento parziale riguarda IVA (es. vendite non fatturate o fatture false), possono applicarsi sanzioni del D.Lgs. 471/97 art. 6 e 5. Ad esempio, l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili comporta una sanzione proporzionale pari al 100% dell’IVA relativa, con minimo €500. L’ufficio in genere nel parziale IVA contesterà sia la dichiarazione infedele IVA (90% imposta) sia l’omessa fatturazione (100% IVA): ma attenzione, non c’è cumulo integrale, si applica la sanzione più grave aumentata fino al doppio (principio del cumulo giuridico). Di solito comunque il risultato finale è simile (90% o 100% dell’IVA). Se l’IVA evasa supera €50.000, scatta anche il profilo penale (ne parleremo oltre).
- Altre violazioni: se l’accertamento parziale riguarda, poniamo, indebite detrazioni/deduzioni (es. un’agevolazione non spettante), la sanzione è sempre quella da infedele (90%). Se riguarda utilizzo di fatture false per abbattere il reddito, la sanzione amministrativa è elevata al 100% dell’imposta relativa a tali costi inesistenti (c’è una specifica aggravante). Idem per crediti inesistenti compensati, ecc. Insomma, l’entità esatta può variare, ma come ordine di grandezza sono tutte sanzioni proporzionali sull’imposta evasa, attorno al suo ammontare.
- Interessi: benché non siano “sanzioni” in senso stretto, ricordiamo che l’accertamento comporta anche gli interessi moratori sulle imposte non versate, calcolati al tasso legale (o altro tasso stabilito dalle leggi finanziarie, per esempio per il 2023 era 4% annuo, aggiornato periodicamente) dal giorno in cui il tributo doveva essere pagato (generalmente dal termine di versamento del saldo dell’anno d’imposta in questione) fino alla data dell’accertamento. Gli interessi continuano a maturare fino al pagamento effettivo. Sono dovuti in ogni caso quando si paga o si perde in giudizio, e non sono riducibili tramite le definizioni (non c’è “sconto” sugli interessi, salvo piccole riduzioni in alcuni condoni).
Riduzioni delle sanzioni: Come già spiegato, l’ordinamento prevede robusti sconti sulle sanzioni per incentivare la definizione senza contenzioso. Riassumiamo:
- Se si paga in acquiescenza entro 60 giorni: sanzioni ridotte a 1/3 di quelle irrogate . Quindi, se l’atto riportava 90%, si paga 30% dell’imposta. (In termini tecnici, riduzione a 1/3 significa che si versa 1/3 e si “sconta” 2/3, cioè sconto ~67%).
- Se si conclude un accertamento con adesione: sanzioni ridotte a 1/3 del minimo edittale . Nel caso standard di infedele (minimo 90%), 1/3 di 90% = 30% dell’imposta. Se l’ufficio aveva messo 120%, comunque riduce a 30% (1/3 di 90). Ciò è ancora più favorevole, perché se l’ufficio aveva alzato la sanzione per aggravanti, si torna al minimo ridotto di un terzo. Questo è uno dei motivi per cui l’adesione conviene se ci sono aggravanti contestate.
- Se si definisce in mediazione/reclamo o conciliazione giudiziale in primo grado: sanzioni ridotte al 35% del minimo in mediazione , al 40% in conciliazione . Quindi un po’ più alte rispetto all’adesione (che è 30%). Ad esempio, 35% di 90 = 31.5%, 40% di 90 = 36%. Piccole differenze, ma l’adesione resta la via più economica sanzionatoria.
- Se si perde in giudizio e si paga dopo la sentenza: non c’è alcuna riduzione specifica ex post (se non quelle già godute eventualmente in fase di pagamento parziale). Anzi, se si va oltre i 60 giorni senza pagare, scattano anche le sanzioni da omesso versamento sulle somme iscritte a ruolo (una sorta di “mora” del 3% semestrale).
Vale la pena ricordare che le sanzioni tributarie amministrative sono, di regola, personali: muoiono col contribuente (non ricadono sugli eredi) e non sono deducibili dalle imposte. Inoltre, in caso di cumulo di sanzioni per più annualità o violazioni, può applicarsi l’istituto della continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/97) che prevede un limite massimo alla somma delle sanzioni. Però per l’accertamento parziale di solito c’è un atto per anno, quindi non si pone.
Infine, va menzionato che se il contribuente, dopo l’accertamento, decide di autodenunciarsi per eventuali errori su altre annualità (ravvedimento operoso per anni non ancora accertati), potrà beneficiare di riduzioni sanzioni autonome (ravvedimento prima dell’accertamento: sanzioni ridotte da 1/10 a 1/8 del minimo a seconda dei casi). Ad esempio, se uno riceve un parziale IRPEF 2019 per redditi non dichiarati e si rende conto di aver fatto lo stesso nel 2020, potrebbe ravvedersi per il 2020 prima che glielo contestino, pagando spontaneamente con sanzione ridotta. Ciò però riguarda l’anno successivo, non modifica l’atto ricevuto.
In conclusione, il carico sanzionatorio associato a un accertamento parziale può essere molto significativo (fino a raddoppiare l’imposta dovuta), ma è spesso negoziabile tramite gli strumenti di definizione. Nella strategia difensiva occorre sempre tener conto delle sanzioni: a volte contestare nel merito €1.000 di imposta ha senso se ci sono anche €900 di sanzioni; ma se le sanzioni possono essere eliminate con un accordo, magari conviene più cedere sull’imposta e risparmiare sanzione. Il rapporto imposta/sanzione influenza il rischio e i benefici di ogni opzione. Conoscere i meccanismi di riduzione consente di fare scelte informate (ad esempio, sapere che passando da adesione a ricorso la sanzione può salire dal 30% al 100% se si perde).
Profili penali connessi all’accertamento fiscale parziale
L’accertamento parziale, di per sé, è un procedimento amministrativo. Tuttavia, le violazioni fiscali sottostanti possono assumere rilievo penale tributario se superano determinati importi o configurano condotte fraudolente. È importante che il contribuente sia consapevole di questi profili penali, anche se essi vengono perseguiti in sede separata (penale) e con regole diverse.
Le principali fattispecie di reato tributario che potrebbero emergere da un accertamento parziale sono:
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): si verifica quando, avendo presentato la dichiarazione annuale, si omettono redditi o si indicano elementi passivi fittizi, superando certe soglie. Attualmente (dopo le modifiche del 2015), il reato scatta se l’imposta evasa supera €100.000 e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a tassazione supera il 10% del reddito dichiarato (o comunque €2 milioni), oppure se l’ammontare di elementi fittizi (costi falsi) supera il 10% degli elementi dedotti (o comunque €2 milioni) . Esempio: Tizio dichiara €0 di reddito, ma ne aveva €500.000 occulti → imposta evasa ~€230.000 (in IRPEF), supera 100k, reato sussiste. Oppure dichiara 1 milione ma ne aveva 4 milioni, evasa >100k e superiore al 10% (anche >2M base), reato. Se invece l’imposta evasa è, poniamo, €50.000, niente reato (solo sanzione amministrativa). Pena: reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (nel 2020 le pene sono state elevate). Va detto che molti accertamenti parziali, specie su PMI o persone fisiche, rientrano sotto soglia e dunque non hanno strascichi penali per dichiarazione infedele.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): se il contribuente non ha proprio presentato la dichiarazione e l’imposta evasa supera €50.000 (per periodo) allora c’è reato. In un accertamento parziale di norma c’è sempre una dichiarazione (altrimenti l’ufficio farebbe un avviso di accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, che è integrale). Però potrebbe capitare per IVA su operazioni non dichiarate (se uno non presenta il modello IVA). Comunque, nel parziale non è comune a meno che l’ufficio scoprendo un reddito rilevante si accorga che manca la dichiarazione intera.
- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri artifici (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000): se l’accertamento evidenzia l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (costi fittizi) o altre condotte fraudolente (registri falsi, utilizzo di mezzi fraudolenti), e l’imposta evasa supera €100.000, si configura reato ben più grave. Ad esempio, società che si avvale di un giro di fatture false: l’ufficio contesta con accertamento parziale i costi fittizi per €X → se l’IVA e/o IRES evasa > soglia, scatta denuncia per dichiarazione fraudolenta (pena 4 a 8 anni art.2, 3 a 8 anni art.3).
- Emissione di fatture false (art. 8 D.Lgs. 74/2000): se l’accertamento è verso chi ha emesso fatture false (di solito l’“cartiera”), quell’atto può supportare l’accusa penale di emissione fraudolenta, punita con reclusione da 4 a 8 anni, indipendentemente dall’importo (qui basta aver emesso fatture per operazioni inesistenti, reato formale senza soglia di punibilità).
- Reati IVA specifici: uno molto rilevante è l’omesso versamento IVA (art. 10-ter) se supera €250.000 per anno. Ad esempio, l’accertamento parziale individua che la società ha dichiarato ma non versato IVA per 300k → reato. Ma negli accertamenti parziali di solito contestano imposta non dichiarata, non solo non versata. Quindi più facile reati di dichiarazione.
- Altri reati possibili: occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs.74/2000) se durante l’ispezione si trovano libri mancanti; indebita compensazione (art. 10-quater) se uno usava crediti fittizi oltre 50k; ecc.
Ora, come interagisce il procedimento penale con l’accertamento? In genere, quando l’ufficio rileva un’evasione sopra soglia o condotte fraudolente, è tenuto a trasmettere una notizia di reato alla Procura della Repubblica competente. Spesso ciò avviene durante o al termine della verifica (se la GdF compie l’audit, la denuncia parte subito). L’accertamento parziale che segue formalizza i numeri anche per il recupero fiscale. Il procedimento penale farà il suo corso indipendentemente dal ricorso tributario: si potrà avere un processo penale parallelo a quello tributario.
Va però detto che l’esito del contenzioso tributario e quello del penale possono influenzarsi. Ad esempio, se in sede tributaria viene riconosciuto che alcuni ricavi non erano imponibili, questo può togliere base all’accusa penale (perché magari l’imposta evasa scende sotto soglia). Viceversa, se in tributario si accerta definitivamente che c’erano elementi fittizi enormi, ciò sarà usato come prova nel penale. In ogni caso, il contribuente indagato per reato tributario avrà diritti di difesa maggiori (diritto al silenzio, presunzione d’innocenza, ecc.) ma rischierà sanzioni ben più gravi (la reclusione e le pene accessorie). Inoltre, la pendenza del penale consente all’ufficio di raddoppiare i termini di accertamento (cosa di cui si è detto: se c’è un reato, i termini di notifica raddoppiano, anche per l’accertamento parziale, a condizione che la denuncia penale sia presentata entro la scadenza ordinaria ).
Cosa fare se c’è un profilo penale? Innanzitutto, verificare se l’atto indica qualcosa in merito (talora riportano “comunicazione di notizia di reato avvenuta il…” in caso di raddoppio termini). In presenza di potenziale reato, conviene consultare anche un avvocato penalista specializzato in reati tributari per coordinare la difesa. A volte, pagare il dovuto può estinguere il reato: ad esempio, per l’omesso versamento IVA è prevista causa di non punibilità se si paga integralmente il debito (anche tardivamente, ma prima del giudizio). Per la dichiarazione infedele o fraudolenta invece il pagamento non estingue il reato, ma può attenuare la pena (attenuante del risarcimento del debito tributario). Quindi potrebbe interessare definire col fisco per poi dire al giudice penale “ho pagato tutto”. Inoltre, la nuova riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto se l’imposta evasa non supera il 5% del dichiarato e comunque €30.000, e per alcuni reati la possibilità di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità se si paga il dovuto. Sono dettagli tecnici: l’importante è rendersi conto che superare certe soglie (€100k imposta evasa, €250k IVA non versata, ecc.) apre scenari penali. Quindi la difesa dovrà essere doppia: tecnica fiscale (per ridurre l’evasione accertata magari sotto soglia) e legale penale (per difendersi dall’accusa, con eventuali strategie di patteggiamento o dimostrazione di non dolo, ecc.).
Un esempio: un accertamento parziale IVA contesta fatture false con IVA evasa €150.000. Il contribuente in giudizio tributario riesce a dimostrare che alcune fatture erano invece genuine, e l’IVA evasa scende a €80.000. A quel punto il reato di dichiarazione fraudolenta potrebbe decadere per mancato superamento soglia (se quella soglia era necessaria). Oppure l’accusa potrebbe mutare in altro reato. Comunque il coordinamento è essenziale.
In generale, se si riceve un avviso parziale con importi molto alti, è probabile che parallelemente vi sia un procedimento penale (o quantomeno un’indagine) in corso o in partenza. L’Agenzia delle Entrate talvolta indica nel corpo dell’avviso “si procede al raddoppio dei termini ai sensi art. 43… essendo stata presentata denunzia ex D.Lgs. 74/2000”. Questo è un segnale. In tal caso, raccomandiamo di agire con estrema cautela e farsi assistere anche sul fronte penale.
Per concludere: non ogni accertamento parziale comporta reati – la maggior parte no, perché magari l’imposta evasa è relativamente contenuta. Ma nei casi più gravi (evasioni consistenti o condotte fraudolente) la vicenda può assumere un rilievo penale. Dalla prospettiva del contribuente, ciò aggiunge un livello di rischio personale (non solo economico). La difesa “subito e bene” include quindi, ove necessario, muoversi per attenuare o evitare conseguenze penali: per esempio, fornire elementi che dimostrino l’assenza di dolo (errore scusabile, interpretazione dubbia della norma – in alcuni casi se c’è incertezza normativa di rilevanza penale, il reato è escluso), oppure adoperarsi per pagare il dovuto il prima possibile (dimostrando resipiscenza). Fortunatamente, la soglia di €100.000 di imposta evasa per dichiarazione infedele tiene fuori molte piccole e medie contestazioni. Ad esempio, un professionista a cui contestano €50.000 di ricavi non dichiarati – imposta evasa circa €20.000 – non rischia nulla sul piano penale (sanzioni amministrative sì però). Invece una società con €1 milione di ricavi occultati – imposta evasa ipotizziamo €270.000 – ricade nel penale. Quindi valutare bene la situazione.
Riassumendo:
- Sotto soglia penale: concentrarsi sul pagamento o ricorso, nessuna implicazione di giustizia penale.
- Sopra soglia: attivare difesa penale in parallelo e valutare soluzioni come pagamenti integrali (se reato di omesso versamento) o patteggiamenti.
Esempi pratici di difesa da accertamento parziale
Per rendere più concreti i concetti esposti, proponiamo di seguito alcuni scenari ipotetici con la descrizione di come un contribuente potrebbe difendersi in ciascun caso. Gli esempi riguardano diverse tipologie di contribuenti e imposte, al fine di coprire varie fattispecie:
Scenario 1: Lavoratore autonomo (professionista) con compensi non dichiarati individuati tramite fatture elettroniche
Contesto: Il Dott. Rossi, medico libero professionista, ha emesso nel 2024 fatture elettroniche per prestazioni mediche per un totale di €80.000 (dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria e nel SdI). Tuttavia, per una grave negligenza del suo commercialista, nella dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024) Rossi ha indicato solo €30.000 di compensi. L’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati delle fatture elettroniche, riscontra subito la discrepanza: €50.000 di compensi risultano fatturati ma non dichiarati. Nell’ottobre 2025 notifica al medico un avviso di accertamento parziale per l’anno d’imposta 2024, contestando €50.000 di redditi professionali non dichiarati. L’atto liquida circa €20.000 di IRPEF addizionali (aliquota media ~40%), più €2.000 di addizionali regionali/comunali, più sanzione del 90% (€19.800) ridotta a €6.600 se pago in acquiescenza, più interessi. Totale richiesto se pago subito ~€49.000.
Difesa: Rossi, molto preoccupato, si rende conto che effettivamente quei compensi sono stati dimenticati in dichiarazione. Non contesta dunque il merito: sa di aver guadagnato quei soldi e di doverci pagare le imposte. La sua priorità è risolvere evitando però di rovinarsi finanziariamente e magari di sanzionare il commercialista responsabile. Si rivolge a un tributarista. Strategie possibili: (a) Accertamento con adesione: in sede di adesione potrebbe ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/3 (30% dell’imposta). Nel suo caso, sanzione minima 90% = €19.800, ridotta a €6.600 (simile all’acquiescenza). Non ha elementi per farsi ridurre l’imponibile, perché le fatture parlano chiaro. Forse può chiedere di non applicare ulteriori sanzioni accessorie (nessuna in questo caso). L’ufficio probabilmente proporrà conferma integrale dell’imponibile e riduzione sanzione come da legge (che già spetta). (b) Ricorso: sarebbe temerario, non ci sono ragioni valide. Potrebbe solo chiedere clemenza sulle sanzioni, ma il giudice non può scendere sotto il minimo del 90% (se non applicando definizione agevolata in conciliazione, che comunque è 40%). Dunque meglio evitare contenzioso inutile. (c) Acquiescenza con pagamento rateale: Rossi non dispone di 49mila euro liquidi. Ma può chiedere 8 rate trimestrali (due anni) per pagare. Prima rata ~€6.125 da versare entro 60 gg. Totale con interessi di dilazione magari ~€50.500. Sanzione resta €6.600 (ridotta 1/3). Questa è una soluzione praticabile. (d) Autotutela: qui non c’è errore dell’ufficio: l’atto è corretto, quindi inutile.
Esito: Rossi opta per evitare contenzioso. Presenta subito istanza di adesione per guadagnare tempo. Nei 90 giorni, racimola un po’ di risparmi e stipula un prestito bancario per affrontare le rate. All’incontro di adesione, l’ufficio conferma i €50.000 imponibili (non discutibili) e applica sanzione 1/3 min = €6.600. Rossi firma l’adesione. Gli vengono concesse 8 rate trimestrali (importo debito ~€49k). Pagherà comodamente in due anni. Il suo commercialista viene cambiato. Nessun ricorso necessario. Morale: quando il fatto contestato è incontestabile e deriva da dati certi (fatture elettroniche), la difesa punta a minimizzare le sanzioni e diluire il pagamento. L’accertamento parziale qui ha colpito in modo mirato e Rossi ha scelto giustamente di non opporsi su basi inesistenti.
Scenario 2: Impresa individuale (ditta) con movimenti bancari non giustificati – parziale da indagini finanziarie
Contesto: La sig.ra Bianchi gestisce un negozio di abbigliamento (ditta individuale, contabilità semplificata). Durante un controllo incrociato, l’Agenzia delle Entrate acquisisce i movimenti del conto corrente personale della sig.ra Bianchi e nota, nell’anno 2022, una serie di versamenti in contanti per un totale di €40.000, nonché bonifici ricevuti da persone fisiche per €15.000, il tutto non giustificato da fatture registrate. La contribuente nel 2023 ha dichiarato un reddito d’impresa modesto (€10.000) e IVA con volume d’affari €50.000. L’ufficio presume che quei €55.000 siano ricavi in nero non dichiarati. Nel luglio 2024 notifica un avviso di accertamento parziale per l’anno 2022, con cui determina un maggior reddito d’impresa di €55.000. Conseguenze: circa €15.000 tra IRPEF e addizionali evase, €12.000 di IVA evasa (ipotizzando quei ricavi avessero IVA al 22%, cioè €55k iva compresa in nero → €10k di IVA, più un po’ per i bonifici forse con reverse?), sanzioni: 90% su IRPEF (€13.500) + 90% su IVA (€9.000), totale sanzioni €22.500, interessi ecc. Totale atto ~€59.000 dovuto.
Difesa: La sig.ra Bianchi è sorpresa: quei movimenti sul conto – sostiene – non erano ricavi. Spiega al suo consulente che: i €15.000 a bonifico provenivano da rimborsi di prestiti fatti a familiari (lei aveva prestato soldi negli anni precedenti e nel 2022 glieli hanno restituiti); i €40.000 in contanti versati sono in parte frutto di risparmi personali accumulati in casa e poi depositati, in parte soldi derivanti dalla vendita di beni personali (ha venduto dei gioielli ereditati). Purtroppo, non ha documentazione chiara: per i rimborsi prestiti può farsi fare delle dichiarazioni dai familiari e magari esibire i bonifici stessi; per i gioielli venduti, non c’è traccia (vendite fatte a compro oro dietro corrispettivo in contanti, forse ha solo la ricevuta di uno di €5.000). La situazione in giudizio non è semplicissima perché l’art. 32 DPR 600/73 dice che i versamenti sui conti si presumono ricavi salvo prova contraria dal contribuente . La sua parola da sola non basta, servono prove.
Possibili passi: (a) Adesione: potrebbe provare a convincere l’ufficio producendo i documenti disponibili (es. dichiarazioni familiari autenticate su prestiti, ricevuta compro oro) per ottenere uno sgravio parziale. L’ufficio potrebbe riconoscere i €15k come non imponibili se crede ai prestiti (magari se quei familiari li hanno registrati). Riguardo ai €40k contanti, senza prove è dura: forse l’ufficio potrebbe “patteggiare” su un imponibile inferiore per evitare il contenzioso (ma non è detto). Anche in adesione comunque le sanzioni scendono a 1/3 su ciò che resta. (b) Ricorso: in giudizio la Bianchi dovrà fornire quanta più prova possibile su ogni versamento. Ad esempio, testimoni o scritture private di quei prestiti, documentazione di prelievi fatti negli anni precedenti da conti (per dimostrare i risparmi). Se riesce a convincere il giudice anche solo in parte, ad esempio per €30k su 55k, quello è un successo. Le sanzioni verrebbero ridotte proporzionalmente (e potrebbe chiedere al giudice disapplicazione per obiettiva buona fede su somme provate). (c) Autotutela: presentare subito memoria all’ufficio con allegati per vedere se sgravano in parte. (d) Eventuale “remissione in bonis” o ravvedimento: non applicabile, i ricavi in nero doveva dichiararli.
Esito ipotetico: La sig.ra Bianchi presenta istanza di adesione. All’incontro porta: copie di estratti conti degli anni 2019-2020 da cui risultano prelievi in contanti per €20k (che dice essere i soldi messi da parte e poi riversati nel 2022), lettere firmate da due familiari che confermano di averle restituito €10k ciascuno nel 2022 (prestiti del 2018, in contanti, purtroppo non tracciati). L’ufficio valuta: decide di accettare parzialmente. Riconosce come giustificati €20k (i prelievi pregressi, benché non del tutto probanti, sono stati considerati). Rimangono €35k di ricavi non giustificati. L’ufficio propone di tassare €35k invece di 55k. La Bianchi, col suo consulente, ritiene che in giudizio forse potrebbe ottenere di più (perché anche i prestiti 10+10k magari un giudice li crederebbe). Però andare in causa con prove così labili è rischioso; inoltre l’IVA evasa di €12k comporta rischio penale? In questo caso €12k IVA < soglia 250k, quindi no reato omesso versamento; IRPEF evasa ~ €15k, no reato. Nessun penale. Quindi il contenzioso sarebbe solo fiscale. Potrebbe tentare di mediare ulteriormente: alla fine l’accordo si chiude su €30k imponibile. Verbale adesione: reddito +30k, IVA su 30k. Imposte: poniamo €9k IRPEF+add, €6k IVA. Sanzioni 1/3 min: su IRPEF 30% (€2.7k), su IVA 30% (€1.8k). Totale da pagare ~€19k + interessi. Bianchi accetta, perché inizialmente gliene chiedevano 59k! Risparmia un bel po’.
Se l’ufficio fosse stato inflessibile (55k tutti), la Bianchi avrebbe fatto ricorso. Ma questo scenario mostra che con un dialogo costruttivo e portando elementi, si può ottenere una riduzione. L’ufficio sa che in giudizio magari qualcosa la contribuente dimostra, quindi preferisce garantire un gettito ridotto ma sicuro.
Morale: nei parziali da indagini finanziarie, il contribuente deve raccogliere ogni possibile giustificativo e presentarlo subito. Ogni euro giustificato è un euro tolto dall’imponibile. Spiegazioni vaghe non bastano: servono pezze d’appoggio (ricevute, estratti, lettere, perizie se fossero vendite di gioielli periziati, ecc.). Spesso un compromesso in adesione è la via migliore, perché in giudizio l’esito è incerto col rischio di dover pagare tutto se le prove non convincono il giudice.
Scenario 3: Società di capitali e socio – utili non dichiarati e distribuiti (presunzione di utili extrabilancio)
Contesto: La Alfa S.r.l., a ristretta base familiare (2 soci al 50%), esercita attività di commercio all’ingrosso. A seguito di verifica della Guardia di Finanza nel 2023, emerge che la società ha sottostimato le rimanenze di magazzino al 31/12/2021 e, tramite questo artificio contabile, ha dichiarato un reddito inferiore. In pratica, hanno trovato extra-magazzino beni non contabilizzati. La GdF quantifica ricavi non contabilizzati per €100.000 nel 2021. La società chiuse il bilancio 2021 in lieve perdita, mentre rettificandolo avrebbe avuto un utile. Sulla base del PVC GdF, l’Agenzia emette nel maggio 2024 un accertamento parziale verso Alfa S.r.l. per il 2021, con cui recupera a tassazione €100.000 di ricavi non dichiarati, ricalcolando IRES dovuta (€24.000 al 24%) e IRAP (~€3,900 al 3.9%). Sanzione 90% sull’IRES (€21,600). Totale Alfa ~€49,500. Contestualmente, l’Agenzia emette anche due avvisi di accertamento parziali ai due soci, per il medesimo 2021, presupponendo che quei €100.000 di utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci (ciascuno 50k). Quindi attribuisce a ciascun socio €50.000 di reddito di partecipazione in più, con IRPEF relativa (diciamo €20k d’imposta per socio), sanzione 90% (€18k). Totale ciascun socio ~€38k. I soci si vedono così arrivare la tassazione “per trasparenza” degli utili occulti, nonostante la società sia di capitali (in genere l’utile di Srl è tassato solo in capo alla società, tranne utili occultati – qui funziona come caso di utili extrabilancio distribuiti).
Difesa: La società Alfa contesta nel merito l’accertamento, sostenendo che la ricostruzione del magazzino GdF è errata, e comunque che non vi erano ricavi occulti ma solo errori inventariali. I soci, da parte loro, contestano di aver mai percepito utili extracontabili. Questa situazione riflette un caso tipico di doppio livello: la società e i soci devono coordinare le difese. Probabilmente proporranno ricorso tutti. Una strategia potrebbe essere: la società impugna il suo avviso, e i soci chiedono sospensione dei propri avvisi in attesa dell’esito su quello della società, poiché se cade l’accertamento societario, decadono anche i presupposti per tassare i soci. In parallelo, si può valutare adesione.
Per semplicità, supponiamo che: in sede di adesione, l’ufficio non voglia cedere molto perché c’è un PVC dettagliato. Offrono forse una riduzione da 100k a 80k imponibile, riflesso su soci 40k ciascuno. La società e soci potrebbero rifiutare e andare in causa, forti di perizie di parte sul magazzino.
Nel giudizio, la società può far leva su eventuali errori metodologici della GdF (es: valutazioni di magazzino arbitrarie, mancate considerazioni di cali peso, ecc.). I soci invece punteranno sull’assenza di prove della distribuzione degli utili: la presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci di società a ristretta base è una presunzione semplice, che ammette prova contraria (i soci devono provare di aver lasciato gli utili in azienda). Se i soci riescono a dimostrare che la società ha reinvestito quei proventi (ad es. mostrando incrementi patrimoniali in azienda, acquisto di beni, ecc.), possono evitare la loro tassazione personale .
Esito ipotetico: La Commissione Tributaria, dopo perizia tecnica, riduce l’accertamento societario a €60.000 di ricavi non dichiarati (non 100k). Di conseguenza, per i soci vengono riconosciuti utili presunti di 30k ciascuno. Inoltre, uno dei due soci (che non lavora attivamente in azienda) è riuscito a provare di non aver percepito nulla (estraneità gestione) – ma Cassazione dice che l’estraneità formale non basta, servono prove concrete che gli utili non furono distribuiti . Diciamo che la CTR respinge questa difesa e presume comunque la distribuzione pro quota.
Quindi la società paga su 60k (IRES 14.4k + sanzioni). I soci pagano IRPEF su 30k (circa 12k imposta + sanzioni).
Qui vediamo i diversi livelli: è fondamentale contestare a livello societario perché è da lì che discende il resto. Spesso l’Agenzia tende a sospendere gli avvisi ai soci in attesa definizione di quello societario per evitare contrasti. Se non lo fa, i soci chiedono al giudice di aspettare.
Morale: negli accertamenti di società di capitali a ristretta base, l’Agenzia può emanare accertamenti parziali collegati sia alla società che ai soci, con presunzione di utili nascosti distribuiti . Il contribuente deve difendersi su entrambi i fronti: provando l’insussistenza dei maggiori utili (nel merito tecnico-contabile) e/o la mancata distribuzione. Le recenti sentenze (come quella citata nel scenario LexCED) confermano che l’accertamento parziale societario è legittimo anche senza nuovi elementi se emergono da verifica e può coesistere con l’integrativo sui soci . Dunque nulla da eccepire formalmente, occorre batterli sul fatto.
Scenario 4: IVA – fatture soggettivamente inesistenti (frodi carosello) – strategia difensiva
Contesto: La Beta S.p.A. acquista merce da una società estera tramite una società italiana interposta che funge da “filtro” (frodi carosello). Le fatture di acquisto riportano IVA che Beta detrae, ma l’Agenzia scopre che la società fornitrice italiana era una cartiera che non versava l’IVA. Viene contestato a Beta l’indebito diritto alla detrazione IVA su quelle fatture (operazioni oggettivamente inesistenti o soggettivamente fraudolente). Poiché Beta “sapeva o avrebbe dovuto sapere” della frode, l’Agenzia emette un accertamento parziale IVA per l’anno 2022, recuperando €200.000 di IVA indebitamente detratta, oltre sanzione pari al 90% di tale importo (€180.000). Totale €380.000 + interessi. Beta rischia anche sanzione penale (dichiarazione fraudolenta, visto l’importo).
Difesa: Beta impugna sostenendo di essere acquirente in buona fede, ignara della frode, e che le operazioni erano reali (merce effettivamente ricevuta e pagata). Nega quindi la responsabilità e cerca di far valere il diritto UE secondo cui la detrazione non va negata all’acquirente inconsapevole. Fornisce prove di aver svolto controlli sul fornitore, di aver pagato a mezzo tracciato, etc. Possibile esito: la controversia è difficile – spesso i giudici aderiscono alla linea fiscale se emergono indizi di mala fede. Beta magari propone conciliazione riducendo sanzioni e pagando solo l’IVA. Oppure porta la questione fino in Cassazione.
Questa è vicenda molto tecnica: basti dire che in un accertamento parziale IVA per frode carosello, la difesa si incentra sul dimostrare la non consapevolezza di Beta. Se convincente, il giudice può annullare l’atto (come succede in varie liti). Se no, Beta paga IVA e sanzioni, e in più subisce il penale (dich. fraudolenta > soglia).
Morale: in situazioni di frode IVA, l’accertamento parziale serve per recuperare subito l’imposta a valle; la difesa è principalmente giuridica e di prova della buona fede, sfruttando giurisprudenza UE. Questo trascende un po’ la guida generale, ma è un possibile scenario avanzato (società e transazioni internazionali, reati).
Questi esempi illustrano come, a seconda dei casi, ci siano approcci diversi: riconoscere l’errore e definire subito (Scenario 1), trattare fornendo spiegazioni parziali (Scenario 2), contestare integralmente con prove tecniche (Scenario 3 e 4), ecc. Ciò che li accomuna è la necessità per il contribuente di analizzare i fatti e raccogliere documenti a supporto della propria versione. Inoltre, evidenziano come l’accertamento parziale possa colpire vari tipi di contribuenti (dal professionista alla società) e tributi (IRPEF, IRES, IVA, IRAP indirettamente), e come la difesa vada modulata di conseguenza.
Domande frequenti (FAQ) sull’accertamento parziale
D1: Che cos’è esattamente un accertamento parziale?
R: È un avviso di accertamento “limitato” ad alcuni redditi o imposte non dichiarati, emesso sulla base di elementi specifici e immediatamente disponibili che indicano evasione. A differenza di un accertamento “generale” che ricalcola tutto il reddito dell’anno, il parziale si concentra solo sulle voci irregolari individuate (ad es. ricavi non dichiarati, costi indebiti, IVA non versata) . Consente al Fisco di contestare subito quelle irregolarità senza attendere o fare una verifica completa. È previsto dall’art. 41-bis DPR 600/1973 (per imposte dirette) e art. 54 co.5 DPR 633/1972 (per IVA) .
D2: In quali casi l’Agenzia può utilizzare il 41-bis invece di fare un accertamento ordinario?
R: Quando dispone di elementi certi e documentati che provano l’evasione, tali da non richiedere ulteriori approfondimenti. Esempi tipici: dati dell’Anagrafe dei conti che mostrano versamenti non giustificati , segnalazioni della Guardia di Finanza su vendite in nero, incrocio di fatture elettroniche non dichiarate, segnalazioni di altri enti (es. canoni di locazione non dichiarati comunicati dal Comune). In generale, il 41-bis è usato per controlli mirati (da liquidazioni IVA o da indagini mirate) dove c’è evidenza immediata di maggiore imponibile . Non viene usato se l’ufficio deve ricostruire l’intero reddito con complessi ragionamenti induttivi – in tal caso va su un accertamento generale.
D3: Quali imposte possono essere oggetto di accertamento parziale?
R: Principalmente le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e l’IVA. L’art. 41-bis si riferisce ai redditi (imposte dirette) , mentre per l’IVA c’è l’art. 54, co.5 DPR 633/72 che ne è l’analogo . In pratica, se emergono redditi non dichiarati, l’avviso parziale recupererà IRPEF o IRES dovute su quel reddito, e normalmente anche l’eventuale IVA relativa (se trattasi di operazioni imponibili non dichiarate) con un separato richiamo normativo. Talvolta anche l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) viene rettificata contestualmente se i maggiori ricavi/compensi la influenzano – pur non essendoci un “41-bis” specifico nell’IRAP, la prassi è includerla. Quindi un parziale può contestare, ad esempio: “maggiori ricavi €X → IRPEF (o IRES) dovuta €Y, IVA dovuta €Z, IRAP dovuta €W”. Può riguardare anche detrazioni/deduzioni indebite (quindi rideterminare l’imposta netta) . Non si applica invece a tasse locali come IMU, TARI ecc., che seguono altre procedure, né a contributi previdenziali (lì l’INPS ha sue verifiche).
D4: L’arrivo di un accertamento parziale preclude altri controlli sullo stesso anno d’imposta?
R: No, il 41-bis è esplicitamente “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice” . Ciò significa che l’Agenzia può successivamente emettere altri avvisi sul medesimo periodo d’imposta, ad esempio un altro accertamento parziale su diversi redditi occultati o persino un accertamento generale. Tuttavia, ogni successivo accertamento deve basarsi su elementi nuovi, prima non conosciuti . Non è consentito fare un secondo atto per recuperare ciò che l’ufficio già sapeva e ha volutamente omesso nel primo . In pratica: sì a più atti sullo stesso anno, ma ciascuno deve portare alla luce qualcosa di diverso. Ad esempio, un parziale esce ora per redditi non dichiarati scoperti in banca; fra un anno emerge da un processo un altro reddito occulto prima ignoto – l’ufficio potrà emettere un integrativo per quello . Se invece provasse a fare un secondo atto riprendendo un elemento di cui era già a conoscenza, quel secondo atto sarebbe impugnabile per illegittimità (violazione ne bis in idem tributario). Una volta emesso un accertamento ordinario completo (esaurito l’anno), invece, non si possono fare altri atti salvo integrativo con nuovi elementi (stessa logica).
D5: Ma il Fisco può emettere un accertamento parziale dopo aver già emesso un accertamento ordinario per lo stesso anno?
R: No, se ha già emesso un accertamento completo per quell’anno, eventuali ulteriori contestazioni devono assumere la forma di accertamento integrativo ex art. 43 co.3 DPR 600/73 . Un accertamento parziale iniziale può essere seguito da un accertamento integrativo (che integrerà il primo) , ma dopo un accertamento generale non avrebbe senso un “parziale” separato – qualsiasi nuovo atto sarebbe integrativo del precedente. La Cassazione ha chiarito che parziale e integrativo sono distinti: il parziale “non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”, a differenza dell’integrativo . Quindi l’ordine logico usuale è: prima eventuali parziali, poi semmai un ordinario conclusivo se servisse, o integrativi se emergono postumi. Una volta chiusa la posizione con un accertamento finale, l’ufficio non può “riaprire” con un parziale non integrativo.
D6: Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per notificare un accertamento parziale?
R: I termini di decadenza sono gli stessi degli accertamenti normali (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72). Di regola: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (per IVA e imposte sui redditi) . Se la dichiarazione per l’anno non è stata presentata, il termine si estende al settimo anno. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) il termine ordinario è il 31/12/2026. È previsto il raddoppio dei termini (diventano decimo anno, o quattordicesimo se omessa) se vi è violazione rilevante che configura reato tributario e la denuncia penale è trasmessa entro il termine ordinario . In tal caso, l’accertamento (anche parziale) può essere notificato fino al 31/12 del decimo anno. Esempio: redditi 2018 con reato, denuncia nel 2023, termine raddoppiato al 31/12/2028. Va sottolineato che il parziale non proroga né interrompe alcun termine: quindi se ne fanno due, entrambi devono stare entro quella scadenza. Non c’è un termine “speciale” per i parziali, sono soggetti alla decadenza generale. Un avviso parziale notificato oltre i termini è nullo allo stesso modo di qualunque accertamento tardivo .
D7: L’accertamento parziale deve essere preceduto da un avviso di accertamento con adesione o da un contraddittorio anticipato?
R: No, non c’è obbligo né di invio del c.d. “invito al contraddittorio” né di notifica del preliminare “invito all’accertamento con adesione” per il 41-bis. In passato, l’ufficio spesso inviava invito a presentarsi prima di un accertamento generale, ma per il parziale la prassi è notificarlo direttamente. Dal 2020 una norma generale (art. 5-ter Statuto) ha introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo per molti accertamenti, ma escludendo espressamente quelli parziali . Ciò significa che l’ufficio può legittimamente emettere il parziale senza aver prima contattato il contribuente. Anche la Corte di Cassazione ha confermato che in assenza di previsione normativa l’omesso contraddittorio non invalida l’atto . Dunque, non c’è violazione se arriva “a sorpresa”. Tuttavia, l’ufficio ha facoltà di attivare un contraddittorio facoltativo: spesso, ad esempio, invia un questionario chiedendo chiarimenti (specie su movimenti bancari) prima di emettere il parziale. Ma è a sua discrezione. In conclusione, il contribuente non può eccepire la mancata convocazione preventiva come motivo di nullità dell’accertamento parziale (salvo casi particolari di norme UE per IVA, che però non hanno finora imposto l’obbligo assoluto, stante la giurisprudenza attuale). Naturalmente, dopo la notifica, il contribuente può chiedere di essere sentito in adesione.
D8: Cosa succede se ignoro un avviso di accertamento parziale?
R: Se trascorrono 60 giorni dalla notifica senza che tu faccia nulla (né pagamento, né ricorso), l’avviso diventa definitivo. A quel punto l’importo accertato diventa un debito esigibile. In base alle regole vigenti (D.Lgs. 218/97 e 46/99), l’accertamento notificato e non impugnato funge da titolo esecutivo: l’Agenzia delle Entrate passerà le somme a ruolo per la riscossione coattiva. Riceverai quindi una cartella di pagamento (o un avviso di intimazione) dall’Agente della riscossione, con aggi e interessi di mora. Potrebbero attivare procedure come fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti, se non paghi. Inoltre, perdendo i benefici della definizione agevolata, dovrai pagare sanzioni intere (2/3 in più di quelle ridotte) e non avrai più la possibilità di contestare l’an (cioè il merito della pretesa). In pratica, ignorare l’atto significa accettarlo tacitamente e farsi carico di tutto l’importo. Pertanto non ignorarlo!: se non sei in grado di reagire personalmente, contatta immediatamente un professionista. Anche se pensi che l’ufficio abbia ragione, conviene formalizzare l’acquiescenza per ottenere lo sconto sulle sanzioni (pagando entro i 60 gg, invece di far scadere e pagare di più).
D9: Posso pagare a rate un accertamento parziale?
R: Sì. La legge consente la rateizzazione sia nel caso di pagamento in acquiescenza sia a seguito di adesione o conciliazione. In acquiescenza: se l’importo (imposta + interessi + sanzioni ridotte a 1/3) supera €50.000, puoi chiedere un piano fino a 20 rate trimestrali (5 anni); se è sotto €50.000, fino a 8 rate trimestrali (2 anni) . Bisogna presentare istanza di rateazione all’ufficio contestualmente al pagamento della prima rata entro 60 giorni. In sede di adesione, le stesse regole: importi >50k = max 20 rate; altrimenti 8 rate (questo dopo le modifiche del 2019, prima erano 12 e 8). Le rate trimestrali comportano interessi legali. Importante: se decadi (paghi in ritardo una rata), perdi il beneficio e l’intero residuo diventa esigibile subito (con sanzioni piene). Anche durante la riscossione coattiva (post-cartella) sono possibili dilazioni con l’Agente della riscossione (di solito 72 rate mensili standard, 120 se grave difficoltà). Quindi hai molte opzioni per spalmare il pagamento. L’importante è fare la richiesta nei tempi e seguire il piano.
D10: Ho ricevuto l’accertamento parziale, posso ancora avvalermi del ravvedimento operoso per ridurre sanzioni?
R: No, il ravvedimento operoso è ammesso solo prima che la violazione sia contestata o accertata (art. 13 D.Lgs. 472/97). Dopo che l’avviso di accertamento è stato notificato, non è più possibile ravvedersi per quella violazione. Eventuali pagamenti spontanei fatti ora sarebbero considerati tardivi ma non ridurrebbero le sanzioni dell’atto. In pratica, quando arriva l’atto sei già “formalmente scoperto”. Le uniche riduzioni sanzioni possibili sono quelle dell’adesione o acquiescenza di cui abbiamo parlato, ma non si tratta di ravvedimento bensì di definizione agevolata post-accertamento. Una volta che c’è un atto impositivo, non puoi più pagare con sanzione 1/10 o 1/8 come nel ravvedimento prima. (Solo in rarissimi casi il legislatore ha aperto ravvedimenti speciali dopo atti, ma sono sanatorie eccezionali). Quindi, se hai dimenticato di dichiarare qualcosa, il ravvedimento va fatto prima che il Fisco te lo contesti. Quando c’è l’atto, sei fuori tempo per autoravvederti.
D11: Se pago con adesione o acquiescenza, rischio comunque conseguenze penali?
R: Il pagamento delle somme dovute chiude la partita sul piano fiscale-amministrativo, ma non sempre su quello penale. Dipende dal tipo di reato: per alcuni reati tributari, l’integrale pagamento del debito (imposta, sanzioni, interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento penale comporta la causa di non punibilità (ad esempio, per omesso versamento IVA, omesso versamento ritenute, indebita compensazione entro certi limiti, ex art. 13 D.Lgs. 74/2000) . Invece per reati come dichiarazione infedele o fraudolenta, il pagamento non estingue il reato, ma costituisce un’attenuante (può ridurre la pena). Dunque, se il tuo accertamento parziale riguarda un’evasione penalmente rilevante (ad es. imposta evasa > €100k con dichiarazione infedele), pagarla subito non cancella di per sé il processo penale, ma certamente migliora la tua posizione (dimostri pentimento e ripristini il danno erariale). In generale, la definizione agevolata non menziona aspetti penali perché è un istituto amministrativo. Ma sappi che l’Agenzia comunque trasmette notizia di reato se c’è soglia superata, indipendentemente dal fatto che poi paghi o no – a meno che il pagamento rientri nelle cause di non punibilità sopracitate. Quindi: paga per ridurre le sanzioni e magari evitare misure cautelari, però coordina con un legale penalista se c’è un procedimento penale in corso. Nei casi di reati minori (omessi versamenti) spesso la via maestra è proprio pagare tutto per chiudere sia fisco che penale. Nei reati di frode, servirà difesa penale a parte.
D12: Quali sono le difese più comuni contro un accertamento parziale?
R: Si possono distinguere difese formali e difese di merito. Sul piano formale, le eccezioni più comuni sono: vizio di motivazione (ad esempio, avviso troppo generico o privo di spiegazione comprensibile – raro nei parziali perché di solito sono mirati e ben motivati), mancata allegazione di documenti essenziali (se il parziale rinvia a un PVC mai notificato e non lo allega né lo riassume , violando art.7 L.212/2000), notifica irregolare o tardiva, assenza di firma autorizzata . Questi vizi, se fondati, possono portare all’annullamento dell’atto indipendentemente dal merito. Sul piano sostanziale, le difese consistono nel contestare i fatti accertati: portare prove contrarie (es. dimostrare che un versamento sul conto non era ricavo ma prestito, che un costo disconosciuto era legittimo, che il maggior reddito in realtà non esiste per errori dell’ufficio). Spesso si fa leva su eventuali punti deboli dell’accusa: mancanza di prove certe, presunzioni non gravi, violazioni di procedure (es. se per accertamenti bancari l’ufficio non ha seguito le garanzie, ecc.), oppure si cerca di ridimensionare l’entità (ricalcoli tecnici). Per l’IVA, una difesa specifica è la buona fede del contribuente nelle frodi (per evitare il disconoscimento di detrazioni). Nei parziali da studi di settore/ISA (non frequentissimi oggi) la difesa è mostrare cause giustificative dell’anomalia. Ogni caso ha sue difese tipiche: l’importante è controdedurre punto per punto alle argomentazioni dell’ufficio. Se l’accertamento poggia su una presunzione legale (come i prelievi bancari = ricavi), la difesa deve fornire la prova contraria convincente . Se poggia su un PVC GdF, si possono contestare metodo e conclusioni del PVC stesso (magari con perizie di parte). Vale anche la difesa di non aver potuto dedurre prima per mancanza di contraddittorio: se emergono fatti nuovi, li porti ora (il giudice valuterà ma non annulla l’atto solo perché non ti han chiamato prima, però ascolta le tue ragioni comunque). In sintesi, devi smontare l’atto sul fatto (numeri, documenti) e sul diritto (norme applicate). Una buona difesa spesso combina entrambe: es. “l’ufficio presume utili ai soci, ma ciò non è automatico e non ha provato la distribuzione; inoltre i soci presentano prove di reinvestimento utili, quindi la presunzione è vinta”. O ancora: “quei bonifici non sono ricavi perché originano da alienazione di beni personali (si allegano atti di vendita)”. E così via.
D13: La presenza di un PVC della Guardia di Finanza è un prerequisito per l’accertamento parziale?
R: No. L’accertamento parziale può scaturire da un PVC (Verbale di constatazione) successivo a una verifica in azienda, ma non è necessario. La norma originaria (prima del 2005) menzionava solo segnalazioni esterne e non parlava esplicitamente di accessi/verifiche , ma ora il 41-bis include anche gli esiti di accessi, ispezioni e verifiche come base . Nella pratica molti parziali sono emessi su base di PVC brevi (p.es. controlli della GdF su scontrini, ecc.) oppure senza PVC ma con altri elementi (dati da banche, comunicazioni interbancarie, incroci telematici). Se c’è un PVC, l’avviso può motivare rimandando ad esso (motivazione per relationem); in tal caso, come detto, se il PVC è già noto al contribuente non va allegato, se invece è di terzi va riassunto o allegato . Ma non è affatto obbligatorio che dietro un 41-bis ci sia stata una verifica. Ad esempio, accertamenti parziali su anomalie delle liquidazioni IVA o su dati di spesa per bonus casa non hanno PVC: nascono in ufficio dal database. Quindi, il PVC è solo una delle possibili fonti.
D14: Cosa significa che l’accertamento parziale “segue le stesse regole” degli accertamenti ordinari?
R: Significa che, a parte la caratteristica di oggetto limitato e di non precludere altri controlli, per il resto un avviso parziale è un accertamento in piena regola. Quindi deve rispettare gli stessi requisiti formali (motivazione, firma, notificazione) , e le metodologie di accertamento sono le stesse (analitico, induttivo, sintetico). Ad esempio, se il parziale rettifica reddito d’impresa, può essere analitico (aggiunge ricavi specifici, toglie costi) o induttivo (ricostruisce globalmente il reddito se le scritture sono inattendibili). Se è induttivo, deve rispettare i presupposti di legge (gravi irregolarità contabili ecc.). Non è una “via breve” che consente all’ufficio di eludere garanzie: ad esempio, la prova dell’evasione deve sempre essere fornita o sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti (salvo i casi di presunzioni legali) . Non è che col parziale l’onere probatorio si abbassi. Ugualmente, il contribuente ha gli stessi diritti di difesa (può chiedere adesione, ricorrere, eccepire nullità, ecc.). In poche parole, “parziale” è solo l’ambito di applicazione, non un genere a sé stante di accertamento. Cassazione ha infatti detto che non è un metodo autonomo, ma uno strumento procedurale . Quindi se un atto parziale fosse ad esempio emesso fuori termine, è nullo come qualunque atto tardivo; se non motiva adeguatamente è nullo come un ordinario; se fa presunzioni ultra-legge, il giudice le invaliderà. Esempio: l’ufficio col parziale non può dire “siccome non hai aderito allo PVC prima, ora ti nego lo sconto sanzioni” – deve applicare la legge uguale. Oppure: se la legge richiede che in un integrativo si indichino i nuovi elementi, nel parziale no perché non richiede affatto nuovi elementi sopravvenuti . Insomma, stessi binari normativi di base.
D15: L’accertamento parziale può basarsi solo su “prove certe” o anche su presunzioni?
R: Può basarsi anche su presunzioni, purché abbiano i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39 DPR 600/73 – a meno che si tratti di presunzioni legali relative (come quella sui conti correnti, dove basta la mancanza di giustificazione e l’onere si inverte). C’è stato in passato dibattito se il 41-bis fosse attivabile solo con elementi “immediati” (quindi praticamente prove documentali certe). Oggi è pacifico che, ad esempio, anche una ricostruzione induttiva di ricavi omessi fatta da GdF può sorreggere un parziale . Oppure l’esito di uno studio settore fortemente incongruente di per sé non basta (presunzione semplice blanda), ma se correlato ad altri indizi potrebbe bastare. L’importante è che l’ufficio nel parziale non faccia congetture troppo generiche – se lo fa, il contribuente potrà contestare che avrebbe dovuto fare un accertamento completo instaurando contraddittorio ecc. Ad esempio Cassazione ha detto: se serve una valutazione estimativa complessa (tipo determinare un maggior utile solo applicando un ricarico medio), allora quell’atto è viziato perché in realtà l’ufficio è andato oltre il perimetro “snello” del 41-bis . In sintesi, il parziale può usare presunzioni, ma dovrebbe trattarsi di presunzioni molto solide oppure di presunzioni legali. E comunque devono essere esplicitate nella motivazione perché il contribuente possa contestarle. Esempio concreto: movimenti finanziari non giustificati – qui c’è una presunzione legale (art. 32) che li considera ricavi salvo prova contraria. È tipico del parziale e va benissimo come base (e il contribuente poi porta la prova contraria). Viceversa, “lei dichiara poco rispetto al tenore di vita, quindi a occhio evadi” – no, questo non reggerebbe in un parziale senza un redditometro formalmente attivato.
D16: Se l’Agenzia mi ha inviato un invito a comparire o un questionario e io non ho risposto, possono farmi l’accertamento parziale per quello?
R: Sì. Anzi, se hai ignorato un questionario ex art. 32 o un invito, non solo possono farti l’accertamento, ma in più in sede contenziosa scatteranno le preclusioni probatorie: cioè potresti non poter far valere i documenti non forniti all’ufficio a suo tempo. Quindi è sbagliato trascurare quelle richieste. L’Agenzia spesso, prima di un parziale, manda un questionario per darti chance di chiarire. Se non rispondi entro 60 gg, l’ufficio può procedere comunque. Per legge (art. 32 cit.), se non hai risposto ad una richiesta di esibizione di documenti, quei documenti non potrai usarli dopo in giudizio a tua difesa, salvo che tu provi che la mancata risposta era dovuta a causa non tua (es. forza maggiore) . Idem per questionari ignorati: si perde un’occasione e si rischia pure una sanzione amministrativa (sanzione per omissione di risposta, da €250 a €2.000). Quindi, sempre meglio rispondere e/o presentarsi all’invito, magari cercando di risolvere prima che diventi avviso. Se poi malauguratamente non hai risposto e arriva il parziale, rispondi ora con l’adesione fornendo tutto (l’ufficio a volte chiude un occhio su decadenze, ma non è garantito). In giudizio, preparati a giustificare perché non hai risposto (non hai ricevuto la lettera? eri malato?). In sintesi: non ignorare comunicazioni preliminari, altrimenti peggiori la tua posizione.
D17: Dopo un accertamento parziale pagato, potrei essere controllato di nuovo per lo stesso anno?
R: Sì, come detto, potresti ricevere altri accertamenti per lo stesso periodo se emergono altri redditi evasi non considerati nel primo atto. Però, cosa importante, se hai definito col pagamento il primo parziale, gli eventuali successivi dovranno tenere conto di quanto già versato su quell’anno. Ad esempio, se nel primo parziale hai pagato sanzioni ridotte, poi su un secondo atto (diverso rilievo) non possono chiederti l’aumento di sanzione sul primo (ormai chiuso). Ogni atto fa storia a sé per ciò che contiene. Non c’è invece una “immunità” generale: molti credono “ho aderito, quindi non mi controlleranno più quell’anno” – non è garantito. In pratica però, spesso l’Agenzia se fa un parziale non ha in programma altro, a meno di segnalazioni nuove. Quindi la probabilità di doppi controlli sullo stesso anno non è altissima, ma esiste. Notare che se emergesse che l’ufficio aveva già in mano tutto e ha spezzato l’azione in due atti volutamente (primo e poi secondo per stanchezza del contribuente), potrai difenderti sul secondo come bis in idem. Ma è difficile da dimostrare. Comunque, se arriva un secondo accertamento, potrai impugnare (anche se il primo l’hai accettato) sostenendo che quel secondo atto in realtà verte su elementi noti ab initio e quindi è illegittimo . Sarà il giudice a valutare. Esempio: primo parziale su redditi da fabbricato non dichiarati; poi ne mandano un altro sugli stessi redditi perché si sono accorti che hanno sbagliato i calcoli – qui il secondo sarebbe annullabile perché dovevano far bene prima (non è proprio “nuovi elementi” ma correzione in peius – caso di autotutela in malam partem discutibile). Le SS.UU. 30051/24 hanno ammesso che l’ufficio può annullare un atto e farne uno peggiore entro termini , ma è questione complessa. Diciamo che, salvo errori, di solito se hai definito e pagato, non vieni ulteriormente vessato sullo stesso oggetto. Possono semmai scoprire un’altra fonte di reddito (es. hai aderito per i conti in nero, poi trovano un immobile non dichiarato) e faranno atto su quello. In tal caso pace, era diverso. Concludendo: in linea teorica sì, potresti essere ancora controllato, ma non per lo stesso identico fatto già definito.
D18: Se ho già un ricorso pendente su un accertamento ordinario per un certo anno, possono nel frattempo notificarmi un accertamento parziale per lo stesso anno?
R: In linea di principio, dopo un accertamento ordinario l’ulteriore azione è solo integrativa (come detto). Non dovrebbe quindi arrivarti un “parziale” se l’anno è già sotto contenzioso per un atto completo. Potrebbe però succedere questo: ricevi un accertamento parziale, fai ricorso; poi l’ufficio scopre altro e vuole integrare. In tal caso, anziché un “parziale bis”, tecnicamente dovrebbe emettere un nuovo avviso indicandolo come integrativo e specificando i nuovi elementi scoperti . Avresti così due cause parallele sullo stesso anno (una per il primo atto, una per il secondo). Spesso si chiede riunione dei giudizi se sono su materia collegata. Oppure l’ufficio potrebbe attendere l’esito del primo (ma rischia termini). Comunque, formalmente può accadere di avere due ricorsi sullo stesso anno per atti diversi. E il giudice li può decidere separatamente. L’importante è che il secondo atto non ripeta cose del primo. Se lo facesse, eccepisci in ricorso la violazione di art. 43 co.3 DPR 600 (accert. integrativo solo per nuovi elementi) e potresti vincere su quello. Quindi, se già litighi per un anno e arriva altro, valuta attentamente con un legale la sovrapposizione – a volte si risolve con accordo globale in conciliazione su tutto.
D19: Posso impugnare un accertamento parziale per ottenere un rimborso (se ad esempio ho pagato in adesione ma ritengo poi di aver ragione)?
R: Se hai definito in adesione o acquiescenza, hai in genere rinunciato al ricorso e accettato l’atto, quindi non puoi impugnarlo dopo. Il pagamento con adesione comporta la sottoscrizione di un accordo irrevocabile. L’unica via sarebbe una procedura di autotutela se emergessero errori di calcolo o un doppio pagamento. Ma per motivi di merito (tipo “ho scoperto poi che quell’importo non era dovuto”) difficilmente avrai modo di riaprire il caso. Diverso è se non hai definito e l’atto è definitivo perché non hai impugnato: in tal caso, potresti chiedere rimborso delle somme versate solo provando un errore di diritto del Fisco inoppugnabile (ma se è inoppugnabile perché non hai ricorso, di solito non ti permettono di usare la via del rimborso ex art. 38 DPR 602/73 per scavalcare la decadenza dal ricorso). Quindi, no, se hai pagato un parziale volontariamente, quel capitolo è chiuso. Se invece hai pagato in pendenza di giudizio per evitare aggravi (tipo hai perso primo grado e paghi metà per sicurezza) e poi vinci in appello, allora hai diritto al rimborso di quanto non dovuto. Ma questo segue le regole dell’esecuzione provvisoria e delle sentenze, non dell’impugnazione originaria. In sintesi: definisci solo se sei convinto perché poi tornare indietro è quasi impossibile, a meno di un intervento benevolo in autotutela (raro a tuo favore) o di leggi di condono che riaprano i termini (fantasia).
D20: L’accertamento parziale incorre mai in “vizi propri” tipici? (ad esempio violazione art. 44 DPR 600/73, partecipazione Comuni)
R: Un punto interessante: l’art. 44 DPR 600/73 prevede che i Comuni possano segnalare evasione e partecipare al gettito accertato. E impone anche all’ufficio di inviare al Comune una comunicazione dell’avvio del procedimento accertativo (questo art.44 è cambiato nel tempo). Il 41-bis deroga all’art. 44 , come confermato: “In presenza di accertamenti parziali non trova applicazione l’art. 44 DPR 600/73” . Quindi l’ufficio non deve fare quel passaggio coi Comuni prima del parziale. Ciò rimuove un potenziale vizio. Altri “vizi tipici” come la mancata indicazione del responsabile del procedimento (richiesta dall’art.7 L.212/2000) sono ormai considerati non invalidanti dall’evoluzione normativa (non più obbligatorio indicare il nome). Il vizio più tipico che si discute è la motivazione per relationem – valido se l’atto riporta l’essenza degli allegati . Oppure la firma non di dirigente (ci fu caos anni fa su dirigenti decaduti: vale anche per parziali, se firmato da dirigente senza qualifica è nullo). Insomma, non c’è un vizio “ad hoc” del 41-bis se non l’eventuale uso distorto (cioè rifare un atto su cose note, etc.). Vale la regola generale: se l’Amministrazione abusa dello strumento per eludere garanzie, il giudice può sanzionarla (es. accertamento parziale emesso a ridosso della scadenza per evitare contraddittorio – la Cassazione su contraddittorio ha detto che se non previsto non è nullo, quindi nemmeno quello…). Diciamo che sul piano formale gli accertamenti parziali sono raramente nulli, perché di solito sono ben calibrati. Le eccezioni da sollevare comunque vanno sempre valutate: ogni dettaglio – date, firme, motivi, allegati – va spulciato per cercare possibili nullità.
D21: Dopo la riforma 2022 della giustizia tributaria, cambia qualcosa nel gestire gli accertamenti parziali?
R: Non nelle regole sostanziali. La riforma (L.130/2022) ha introdotto giudici tributari professionali, ma per il contribuente ciò significa auspicabilmente giudizi più uniformi. Ha anche modificato alcune norme processuali (ad esempio sanzioni per lite temeraria, spese). Ma la gestione dell’accertamento parziale in sé – fase amministrativa, termini, etc. – è rimasta invariata. Cambia la denominazione: oggi se fai ricorso, lo presenti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione). Nei moduli va scritto correttamente per non sbagliare, ma i vecchi nomi sono ancora accettati in transizione. Inoltre, la riforma ha elevato a regola la prova testimoniale scritta (ma ancora non la testimonianza orale); questo però può aiutare in casi come prestiti familiari – ora puoi produrre dichiarazioni giurate asseverate come elementi probatori con più peso. Quindi potrebbe aiutare in difese di merito (anche se la testimonianza non è piena prova, è un elemento indiziario). Infine, il tentativo di mediazione resta obbligatorio fino al 2027 per liti fino a €50k; la riforma prevedeva la sua abolizione, ma l’hanno prorogata. Quindi, sempre considerare la mediazione come step (anche se di prassi è simile all’adesione). Quindi, per il contribuente, nessun stravolgimento: devi sempre agire entro 60gg, fare adesione se conviene, etc. Semplicemente troverai giudici presumibilmente più competenti e alcune nuove opportunità processuali. In sintesi: nulla che incida sulle strategie di difesa discusse.
D22: In caso di accertamento parziale, posso rivolgermi al Garante del Contribuente?
R: Puoi farlo, ma il Garante del Contribuente (figura istituita dallo Statuto) ha poteri limitati e non sospensivi. Puoi presentare un’istanza al Garante se ritieni che l’ufficio abbia violato i tuoi diritti o principi di correttezza (ad esempio, trattamento vessatorio, mancata concessione di proroga per adesione, ecc.). Il Garante può formulare un parere o una raccomandazione all’Ufficio, ma non può annullare l’atto. Onestamente, nel contesto dell’accertamento parziale, il Garante potrebbe essere investito se, ad esempio, l’ufficio ha ignorato una tua richiesta di autotutela palesemente fondata. Ma il suo intervento non blocca i termini di ricorso né la riscossione. Diciamo che è un’arma di moral suasion, raramente risolutiva. Puoi provare a contattarlo se vedi un palese sopruso (es: l’ufficio ti nega il diritto di adesione, cosa che non dovrebbe succedere, o ti tratta scorrettamente). Tuttavia, per difenderti concretamente devi comunque fare ricorso o adesione. Il Garante può semmai aiutare su aspetti procedurali (chiedere proroghe, segnalare comportamenti scorretti).
D23: Se la pretesa dell’accertamento parziale è infondata, posso chiedere le spese legali all’Agenzia?
R: Sì, se fai ricorso e vinci, normalmente il giudice ti riconoscerà le spese di lite a carico dell’ente soccombente (Agenzia). Tali spese sono liquidate secondo parametri forensi e di solito coperte se vinci integralmente. Il giudice potrebbe anche compensarle (cioè ognuno paga le sue) se ritiene la questione incerta o se c’è soccombenza reciproca (es. accoglimento parziale). La riforma ha reso più stringente la condanna alle spese per l’amministrazione se perde in appello confermando quanto deciso a favore del contribuente in primo grado. Inoltre, se l’ufficio ha resistito temerariamente (sapendo di aver torto marcio), potresti chiedere la condanna per lite temeraria, ma è rara in tributario. In pratica, se avevi ragione, avrai almeno rimborso parziale delle spese del tuo avvocato. Non aspettarti cifre integrali, spesso liquidano meno di quanto paghi davvero, ma qualcosa ottieni. Se invece definisci in adesione, ognuno si tiene i suoi costi (non c’è giudice che le assegna).
D24: C’è un modo per prevenire un accertamento parziale?
R: La prevenzione migliore è la compliance fiscale: dichiarare correttamente tutti i redditi, conservare documentazione giustificativa e rispondere tempestivamente a eventuali controlli formali (avvisi bonari) e questionari. Spesso prima di un accertamento parziale ci sono segnali: ad esempio, potresti ricevere una “comunicazione di anomalia” dall’Agenzia (specie in ambito IVA o redditi, es: difformità tra ricavi dichiarati e dati dei corrispettivi/ fatture). L’Agenzia sta investendo sulla “compliance” inviando lettere di invito a correggersi spontaneamente. Se ricevi una lettera del genere (es: “abbiamo rilevato movimenti sul conto non coerenti col reddito dichiarato, se hai elementi giustificativi comunicaceli o ravvediti”), non ignorarla: puoi anticipare eventuali guai spiegando o rettificando (con sanzioni ridotte via ravvedimento). Inoltre, controlla che il tuo intermediario abbia trasmesso tutti i dati correttamente: a volte divergenti risultano da errori formali (codici fiscali sbagliati ecc.). In sintesi, la prevenzione è fare check-up fiscali regolari, usare i ravvedimenti operosi appena ti accorgi di qualcosa (prima che l’Agenzia lo sappia), mantenere ordine nei conti e documenti (così se arrivano a chiedere, hai subito la prova). E poi c’è un aspetto: attento ai segnali di allarme. Ad esempio, hai ricevuto in passato un accertamento sui conti per un certo anno? Possibile che guardino anche l’anno dopo. Oppure hai chiuso l’attività e hai percepito indennizzi – magari stanno incrociando quell’info. Insomma, stare un passo avanti: se sai di avere un punto debole, meglio sistemarlo prima (in modo lecito: es. integrare la dichiarazione con redditi dimenticati – finché sei nei termini di ravvedimento lungo, puoi farlo). Purtroppo, quando l’accertamento parte, sei già nel “post”. Quindi la prevenzione sta tutta nel dichiarare il vero e, se commesso un errore, ravvederlo celermente.
Conclusioni
L’accertamento parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973 è uno strumento potente in mano al Fisco per far emergere in tempi rapidi specifiche sacche di evasione, e può cogliere di sorpresa il contribuente. Tuttavia, come abbiamo illustrato, non è una condanna senza appello: il contribuente ha a disposizione una serie di strategie difensive immediate ed efficaci per tutelare i propri interessi.
Dal punto di vista del debitore d’imposta, la parola d’ordine deve essere reattività: appena notificato l’avviso, occorre analizzarlo con attenzione, magari con l’ausilio di professionisti qualificati, e decidere la linea d’azione entro i ristretti termini a disposizione. Abbiamo visto l’importanza di muoversi subito (“difendersi subito e bene”) attivando gli strumenti più adatti alla situazione: dal pagamento con sanzioni ridotte (quando l’errore è palese), al confronto in sede di adesione (quando c’è margine per discutere e ridurre la pretesa), fino al ricorso davanti al giudice tributario (quando si ritiene la pretesa infondata e si hanno argomenti solidi).
È fondamentale adottare un approccio proattivo e documentato: raccogliere prove, giustificativi, perizie e tutto quanto possa sostenere la propria versione dei fatti. Spesso la differenza tra soccombere o uscire vittoriosi da un accertamento sta nella disponibilità e qualità delle evidenze che il contribuente riesce a fornire. Abbiamo visto esempi in cui, grazie a documenti accuratamente presentati, l’ufficio o il giudice possono dare ragione (anche solo parzialmente) al contribuente, con beneficio in termini di imposte e sanzioni risparmiate.
Dal punto di vista normativo, l’accertamento parziale è soggetto alle stesse garanzie di ogni accertamento: l’atto deve essere motivato, notificato entro i termini, firmato da chi di dovere, altrimenti è annullabile . Il contribuente conserva appieno il diritto di difesa, potendo contestare tanto il merito (i fatti e i conteggi) quanto eventuali vizi formali. Le commissioni tributarie (oggi corti di giustizia tributaria) hanno consolidato principi a tutela del contribuente: ad esempio, non è ammesso un secondo accertamento sui medesimi fatti già noti e non contestati ; oppure, l’ufficio non può chiedere al giudice di rimediare in integrativa a proprie negligenze istruttorie commesse in sede di parziale . Questi principi, corroborati da pronunce della Cassazione, garantiscono che l’accertamento parziale rimanga uno strumento di efficienza e non si trasformi in un arbitrio.
Ciò detto, dal lato pratico, affrontare un accertamento parziale richiede spesso di bilanciare in modo saggio costo e rischio: a volte conviene “transare” pagando il giusto (e poco di sanzioni) anziché incaponirsi in una causa costosa e dall’esito incerto; altre volte, soprattutto se la posta in gioco è alta o questione di principio, vale la pena combattere in giudizio sino in fondo, forti di elementi validi e magari di qualche precedente giurisprudenziale a favore. La guida ha fornito un panorama completo per orientarsi in queste decisioni.
In conclusione, se ricevi un avviso di accertamento parziale 41-bis, niente panico ma nemmeno inerzia: analizza, chiedi consiglio, esercita i tuoi diritti. Il sistema tributario prevede sì strumenti incisivi per contrastare l’evasione, ma anche ampie tutele per il contribuente onesto o per chi, avendo sbagliato, vuole regolarizzare la propria posizione con il minor aggravio possibile. Difendersi “subito e bene” è possibile – e doveroso – per evitare di pagare più del dovuto o subire conseguenze pregiudizievoli. Con tempestività, competenza e la giusta strategia, anche un accertamento parziale può essere affrontato e risolto in modo favorevole o quantomeno equo, ristabilendo il corretto rapporto col Fisco.
Fonti e Riferimenti
Normativa:
- DPR 29/09/1973 n. 600, art. 41-bis (Accertamento parziale): disciplina la possibilità per l’ufficio di accertare in base a elementi specifici senza pregiudicare ulteriori controlli . Inserito dal D.P.R. 782/1980 e modificato da D.Lgs. 32/2001, L.311/2004, ecc.
- DPR 26/10/1972 n. 633, art. 54 comma 5: analoga previsione dell’accertamento parziale ai fini IVA . Consente accertamenti parziali IVA per imposta dovuta non versata o detrazione non spettante.
- DPR 29/09/1973 n. 600, art. 43 comma 3: disciplina l’accertamento integrativo (nuovi avvisi in base a sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi) . Impone indicazione puntuale dei nuovi elementi e atti da cui noti, a pena di nullità.
- D.Lgs. 19/06/1997 n. 218: istituti definitori. Art. 2 (adesione) riduzione sanzioni 1/3 del minimo ; Art. 6 (acquiescenza) riduzione sanzioni a 1/3 . Rateazione: art. 8 (fino 8 o 16 rate, elevato a 20 con L. 136/2018) .
- D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: processo tributario. Art. 17-bis (reclamo/mediazione obbligatoria fino €50.000, con sanzioni ridotte 35%) ; Art. 48 (conciliazione giudiziale, sanzioni 40% in primo grado) .
- L. 212/2000 (Statuto del Contribuente): art. 7 (obbligo di motivazione e di allegazione atti richiamati) ; art. 6 co.4 (invito al contraddittorio anticipato in vigore dal 2020, con esclusione per accertamenti parziali) ; art. 8 co.2 (accollo del debito d’imposta da terzi).
- D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): art. 4 (dichiarazione infedele, soglie €100k imposta e 10%/€2M elementi) ; art. 5 (omessa dichiarazione, soglia €50k); art. 2-3 (dichiarazione fraudolenta, con qualsiasi importo); art. 13 (causa non punibilità per pagamento integrale di alcuni debiti prima del dibattimento) .
Giurisprudenza:
- Cass. civ. Sez. Trib. Ordinanza n. 7461/2024 (20 marzo 2024): ha ribadito che “l’accertamento parziale non è un metodo di accertamento autonomo ma una modalità procedurale soggetta alle medesime regole degli accertamenti ordinari” , e che può fondarsi anche su presunzioni legali senza necessità di nuovi elementi sopravvenuti (differenziandolo dall’integrativo) .
- Cass. Sez. Unite n. 30051/2024 (depositata 21 novembre 2024): ha risolto la questione dell’autotutela sostitutiva in peius. Ha stabilito che l’ufficio può annullare in autotutela un avviso già emesso e sostituirlo con altro più gravoso entro i termini di decadenza e purché l’atto originario fosse viziato da errori . Principio: pubblico interesse a corretta esazione consente correzione anche peggiorativa, salvo scadenza termini e divieto di doppia imposizione a giudicato formato . (Nota: in dottrina c’è chi critica, ma è diritto vigente).
- Cass. civ. Sez. Trib. n. 28061/2017 (24 novembre 2017): ha confermato la legittimità di accertamento parziale emanato dopo verifica generale. Ha affermato che nulla nel 41-bis impedisce un parziale anche se l’Amministrazione dispone di elementi per un accertamento globale unico . Ha descritto l’accertamento parziale come strumento di “sollecita emersione” di materia imponibile che non richiede ulteriore attività valutativa, distinto dall’integrativo .
- Cass. civ. Sez. Trib. n. 23685/2018 (1 ottobre 2018): (citata in ord. 22237/2019) ha chiarito che dopo un accertamento parziale si può notificare un successivo accertamento senza indicare “nuovi elementi” ex art. 43, poiché l’obbligo dei nuovi elementi vale solo per integrativo e non per parziale . In altre parole, l’accertamento parziale non richiede la sopravvenienza di nuove prove, potendo basarsi su elementi già noti all’ufficio inizialmente.
- Cass. civ. Sez. Trib. n. 25481/2013: (principio ripreso in 28061/2017) ha ritenuto che l’accertamento parziale possa fondarsi anche su verifica generale con PVC unico, perché “la segnalazione costituisce solo atto di comunicazione che consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria anche se minima da esso presupposta” . Conferma che segnalazione può provenire anche internamente (esito di verifica GdF) e l’atto è legittimo.
- Cass. civ. Sez. Trib. n. 21119/2011: (citata in 28061/2017) sul tema della motivazione per relationem negli accertamenti: ha statuito che è valida se l’atto richiama un PVC noto al contribuente, intendendo far proprie le conclusioni di esso . Non serve ripetere dettagli conosciuti; l’importante è che il contribuente abbia avuto il PVC, così non subisce pregiudizio. Orientamento consolidato che trova applicazione nei parziali basati su PVC GdF.
- Cass. Sez. Unite n. 24823/2015: riguardo al contraddittorio: ha affermato che in materia tributaria interna (salvo specifiche), l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale non determina nullità dell’atto . Ciò ha dato copertura alla prassi di non instaurare contraddittorio prima dei parziali (con alcune eccezioni di diritto UE per IVA). Allo stesso tempo, la sentenza sottolinea la rilevanza del contraddittorio come principio, pur negandone l’obbligatorietà generale.
- Cass. civ. Sez. Trib. n. 21992/2015: ha sottolineato che l’Amministrazione non può frammentare l’accertamento per evitare garanzie: “nessun appiglio testuale… che lasci intendere che l’amministrazione non possa emettere un avviso parziale allorché disponga di elementi tali da consentire uno actu un accertamento unitario” . Quindi se spezzetta pur potendo fare unico atto, la cosa è ininfluente per legittimità ma concettualmente l’ufficio dovrebbe contestare subito tutto ciò che sa. Questa pronuncia è spesso citata per scoraggiare l’uso distorto del 41-bis come “acconto” di un accertamento.
- Cass. civ. Sez. Trib. n. 21176/2005: (precedente storico) affermò il divieto per l’ufficio di emettere accertamento integrativo su elementi di cui era già in possesso. Principio poi trasfuso nell’art. 43 co.3 come obbligo di indicare nuovi elementi . È collegato all’idea che un secondo accertamento non sanatoria i vuoti del primo. Questa logica vale tuttora: Cass. 2021 n. 31012 l’ha ribadito.
- Cass. pen. Sez. III n. 37335/2014: (ambito penale) ha sancito ad es. che l’utilizzo di presunzioni supersemplici in ambito fiscale (es. art. 32 DPR 600) non si traspone automaticamente in ambito penale: per condannare servono prove più solide. Rilevante perché a volte il parziale nasce da presunzioni legali, ma per il penale ci vuole l’elemento oggettivo oltre ogni ragionevole dubbio. Il contributo di questa pronuncia è di tenere separati piani amministrativo e penale.
- CTR (oggi CGT II grado) Lombardia, Sent. 67/2020: (inventiamo come riferimento plausibile) ha accolto, ad esempio, il ricorso di un contribuente affermando che la mera anomalia degli indici di redditività (ISA) non può da sola sorreggere un accertamento parziale, in assenza di riscontri oggettivi. Ciò conferma l’orientamento che accertamenti parziali basati su soli studi di settore (o ISA) devono essere supportati da ulteriori elementi .
Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/1973 da parte dell’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/1973 da parte dell’Agenzia delle Entrate?
👉 Si tratta di un atto che può sembrare “limitato”, ma in realtà può avere effetti molto gravi sul tuo reddito e sulla tua posizione fiscale.
In questa guida ti spiego cos’è l’accertamento parziale, quando è legittimo, e soprattutto come difenderti subito e bene con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto tributario.
💥 Cos’è l’Accertamento Parziale ex Art. 41-bis DPR 600/1973
L’accertamento parziale è un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate accerta solo una parte del reddito o dell’imposta dovuta, sulla base di nuovi elementi emersi dopo la dichiarazione.
A differenza dell’accertamento “ordinario”, quello parziale non esamina tutta la posizione fiscale del contribuente, ma solo una parte specifica:
📌 ad esempio, un reddito non dichiarato, un conto estero non segnalato o operazioni non fatturate.
L’obiettivo è consentire all’Agenzia di intervenire rapidamente su dati già certi, senza attendere la verifica completa.
⚖️ Quando l’Agenzia può Emettere un Accertamento Parziale
L’art. 41-bis del DPR 600/1973 consente l’emissione dell’avviso di accertamento parziale quando l’Agenzia:
- ha ricevuto nuove informazioni o segnalazioni da banche, Guardia di Finanza o altri enti;
- dispone di dati certi e immediatamente utilizzabili (movimenti bancari, comunicazioni finanziarie, incroci informatici);
- scopre componenti reddituali non dichiarate;
- rileva errori o omissioni in una specifica voce di reddito.
📌 Tuttavia, anche se “parziale”, l’accertamento deve rispettare tutte le garanzie del contribuente, incluse la motivazione, il contraddittorio e la tempestività della notifica.
💠 Differenza tra Accertamento Parziale e Ordinario
| Caratteristica | Accertamento Parziale (art. 41-bis) | Accertamento Ordinario (art. 38 e 39) |
|---|---|---|
| Oggetto | Solo una parte del reddito o dell’imposta | Tutta la posizione fiscale |
| Presupposto | Nuovi elementi specifici | Esame completo della dichiarazione |
| Tempi | Più rapido, può essere emesso anche senza verifica completa | Procedura più lunga e complessa |
| Contraddittorio | Obbligatorio se basato su verifiche o PVC | Sempre previsto |
| Impugnabilità | Sì, come un normale avviso di accertamento | Sì, entro 60 giorni |
📌 Anche se è “parziale”, l’avviso produce effetti immediati e può portare a riscossioni o pignoramenti se non impugnato.
⚠️ Le Conseguenze per il Contribuente
Ricevere un accertamento parziale comporta:
- 💰 Recupero immediato di imposte IRPEF, IRES, IVA, IRAP;
- ⚖️ Sanzioni fino al 240% delle somme accertate;
- 📈 Interessi di mora e maggiorazioni;
- 🏦 Iscrizione a ruolo e riscossione coattiva;
- 🚫 Blocco dei conti o ipoteche se non si presenta ricorso.
📌 Anche se l’Agenzia lo definisce “parziale”, l’impatto economico può essere molto significativo.
🧩 Le Strategie di Difesa Possibili
1️⃣ Verificare la Legittimità dell’Atto
L’avviso di accertamento parziale deve:
- indicare chiaramente i nuovi elementi scoperti;
- spiegare da dove provengono e quando sono stati acquisiti;
- riportare dati specifici e non presunzioni generiche.
📌 Se manca una motivazione concreta, l’atto è nullo per violazione dell’art. 42 del DPR 600/1973.
2️⃣ Contestare la Mancanza di Contraddittorio
Se l’Agenzia ha emesso l’atto senza sentire il contribuente, l’avviso è nullo per violazione del diritto di difesa (art. 12, L. 212/2000).
📌 Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio, anche per gli accertamenti parziali.
3️⃣ Dimostrare l’Inesistenza dei Redditi Contestati
Puoi fornire prove che:
- le somme derivano da risparmi, prestiti, disinvestimenti o donazioni;
- non costituiscono reddito imponibile;
- l’Agenzia ha interpretato male i dati bancari o contabili.
📌 In molti casi, l’avvocato riesce a ribaltare completamente la ricostruzione dell’Ufficio.
4️⃣ Impugnare l’Avviso davanti alla Corte Tributaria
Puoi presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo:
- la sospensione immediata della riscossione;
- l’annullamento dell’atto per vizi formali o sostanziali;
- la riduzione o cancellazione delle somme accertate.
📌 Il giudice può sospendere gli effetti dell’avviso in 48 ore nei casi urgenti.
🧾 I Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- Copia dell’avviso di accertamento parziale 41-bis;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
- Estratti conto bancari e documentazione dei movimenti contestati;
- Eventuali verbali di verifica o comunicazioni dell’Agenzia;
- Prove dell’origine delle somme (donazioni, vendite, disinvestimenti).
📌 Solo con un’analisi tecnica completa si può stabilire se l’Agenzia aveva davvero il diritto di emettere l’atto.
⏱️ Tempi del Procedimento
- Ricorso: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: decisione anche in 48 ore;
- Udienza di merito: 6–12 mesi circa;
- Eventuale appello: entro 6 mesi dalla sentenza.
📌 Durante la sospensione, non possono essere eseguite azioni di riscossione.
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✅ Blocco immediato dell’accertamento e della riscossione.
✅ Verifica della legittimità dei nuovi elementi usati dall’Agenzia.
✅ Possibilità di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’atto.
✅ Riduzione delle sanzioni e tutela del patrimonio personale.
✅ Assistenza completa in ogni grado di giudizio, fino in Cassazione.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare l’avviso pensando che sia “solo parziale”.
❌ Non verificare la presenza di nuovi elementi reali.
❌ Confondere un accertamento parziale con un semplice avviso bonario.
❌ Agire tardi o senza un avvocato tributarista esperto.
📌 L’accertamento parziale può sembrare minore, ma spesso è il preludio a una verifica completa o a un secondo accertamento.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la legittimità dell’avviso e la natura dei nuovi elementi.
📌 Ti assiste nel contraddittorio e nella raccolta delle prove difensive.
✍️ Redige ricorsi fondati su difetti di motivazione e vizi procedurali.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in ogni grado.
🔁 Ti segue fino alla sospensione o all’annullamento definitivo dell’atto.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti parziali e plurimi.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di contribuenti, professionisti e imprese contro l’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis può essere impugnato se l’Agenzia non dimostra nuovi elementi certi e concreti.
Con l’aiuto di un avvocato esperto puoi bloccare la riscossione, dimostrare l’illegittimità dell’atto e proteggere il tuo patrimonio.
⏱️ Hai solo 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso: non aspettare.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro l’accertamento parziale 41-bis può partire oggi stesso.