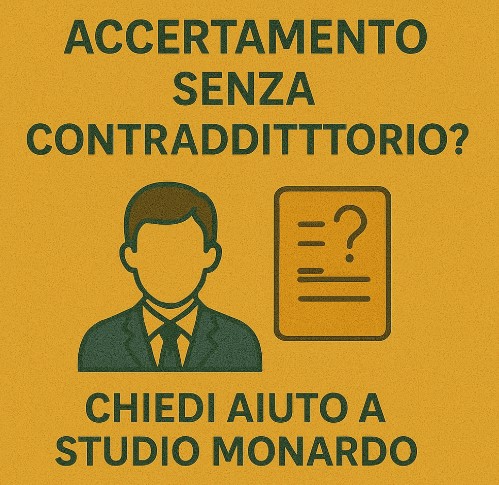Hai ricevuto un avviso di accertamento senza contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate? Si tratta di una delle forme più insidiose di accertamento fiscale, perché il Fisco determina il reddito o i tributi dovuti senza prima ascoltare il contribuente o consentirgli di fornire chiarimenti.
In altre parole, l’Agenzia emette direttamente l’avviso di accertamento senza aver instaurato quel confronto preventivo (detto “contraddittorio”) che serve a garantire il diritto di difesa. Tuttavia, l’assenza di contraddittorio può rendere l’atto nullo o illegittimo, e può essere impugnata con successo con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario.
Cos’è l’accertamento senza contraddittorio e quando si applica
L’accertamento senza contraddittorio si verifica quando l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento senza invitare il contribuente a fornire spiegazioni preventive, come invece prevede la normativa e la giurisprudenza europea e nazionale.
Il contraddittorio è infatti un principio fondamentale di trasparenza e lealtà amministrativa, riconosciuto dallo Statuto del Contribuente (art. 12, comma 7, L. 212/2000) e ribadito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE.
Tuttavia, in alcuni casi l’Agenzia tenta di aggirare tale obbligo, sostenendo che non sia necessario, ad esempio:
- per gli accertamenti automatizzati o da controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973);
- quando ritiene che i dati siano “oggettivi e incontestabili”;
- per ragioni di urgenza o scadenza dei termini;
- nei casi in cui si proceda solo su base documentale o informatica (incroci di dati, banche dati, segnalazioni).
Nella maggior parte delle ipotesi, però, la mancata instaurazione del contraddittorio viola il diritto di difesa del contribuente e rende l’accertamento illegittimo o annullabile.
Come funziona un accertamento senza contraddittorio
- Raccolta delle informazioni: l’Agenzia acquisisce dati da banche dati, anagrafe tributaria, intermediari finanziari o altri enti.
- Analisi automatizzata o selettiva: vengono incrociati redditi, spese, movimentazioni e incoerenze fiscali.
- Emissione diretta dell’avviso di accertamento: senza invito al contraddittorio, viene notificato l’atto con la determinazione delle imposte, sanzioni e interessi.
- Riscossione immediata: dopo 60 giorni, se non impugnato, l’accertamento diventa esecutivo e può dare luogo a cartelle e pignoramenti.
In sostanza, il contribuente scopre l’esistenza dell’accertamento solo al momento della notifica, senza aver potuto fornire chiarimenti o difendersi prima.
Quando l’accertamento senza contraddittorio è illegittimo
Un accertamento emesso senza contraddittorio è illegittimo se:
- riguarda materie che richiedono valutazioni discrezionali o presuntive (es. accertamenti induttivi, sintetici o bancari);
- non viene indicato il motivo per cui non è stato instaurato il contraddittorio;
- l’Ufficio non motiva l’urgenza o la presunta impossibilità del contraddittorio;
- non viene rispettato il termine di 60 giorni per le osservazioni del contribuente dopo l’accesso o l’ispezione (art. 12, Statuto del Contribuente);
- l’atto è basato su dati incompleti, errati o non verificabili.
La giurisprudenza è chiara: l’accertamento deve essere annullato, poiché l’Agenzia ha violato il diritto al contraddittorio e il principio di buona amministrazione.
Quando è nullo o impugnabile
Puoi impugnare un accertamento senza contraddittorio se presenta uno dei seguenti vizi:
- mancanza totale di contraddittorio preventivo;
- difetto di motivazione sulle ragioni dell’omissione;
- assenza di prove concrete del reddito o dell’imposta accertata;
- errore di calcolo o di ricostruzione dei redditi;
- mancato rispetto dei termini di decadenza;
- violazione del diritto europeo al giusto procedimento.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sent. 24823/2015) ha affermato che il contraddittorio è obbligatorio in tutti gli accertamenti fondati su presunzioni o valutazioni discrezionali. In caso contrario, l’atto è nullo.
Le conseguenze di un accertamento senza contraddittorio
Un accertamento emesso senza il tuo coinvolgimento può comportare:
- maggiori imposte e sanzioni (anche fino al 240% dell’imposta);
- iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali;
- pignoramenti, fermi o ipoteche;
- interessi di mora e spese di riscossione;
- possibili segnalazioni penali in caso di importi elevati o presunte evasioni.
Agire tempestivamente è fondamentale per evitare che l’atto diventi definitivo ed esecutivo.
Come difendersi da un accertamento senza contraddittorio
Un avvocato tributarista può contestare l’accertamento e tutelarti efficacemente con una strategia difensiva mirata, che include:
- verifica della legittimità dell’atto: controllo del rispetto dell’obbligo di contraddittorio e della motivazione;
- contestazione della procedura: dimostrare che l’Ufficio avrebbe dovuto ascoltare il contribuente prima dell’emissione dell’avviso;
- analisi delle prove utilizzate: molte volte i dati o le presunzioni su cui si fonda l’atto sono parziali o errati;
- eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa: principio sancito dalla Costituzione e dal diritto UE;
- richiesta di sospensione della riscossione per bloccare l’esecutività dell’atto durante il ricorso.
Le strategie difensive più efficaci
- Dimostrare la violazione del contraddittorio obbligatorio;
- Contestare la mancanza di motivazione sull’omissione del confronto;
- Evidenziare l’assenza di prove concrete a supporto dell’accertamento;
- Richiedere la sospensione cautelare della riscossione;
- Invocare la giurisprudenza favorevole della Cassazione e della Corte di Giustizia UE;
- Fornire prova contraria tramite documenti, giustificativi o ricostruzioni contabili indipendenti.
Come scegliere l’avvocato giusto per difendersi
Affrontare un accertamento senza contraddittorio richiede un legale con esperienza specifica nel contenzioso tributario. Ecco i requisiti essenziali:
- specializzazione in diritto tributario e accertamenti fiscali;
- esperienza documentata in ricorsi per nullità da mancanza di contraddittorio;
- collaborazione con consulenti fiscali o periti contabili;
- aggiornamento costante sulla giurisprudenza tributaria;
- capacità di mediare con l’Ufficio per eventuali definizioni agevolate o adesioni.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un accertamento senza contraddittorio comporta:
- formazione del ruolo esecutivo e avvio della riscossione;
- pignoramenti e ipoteche;
- perdita del diritto di ricorso dopo 60 giorni;
- sanzioni e interessi crescenti;
- impossibilità di contestare successivamente la legittimità della procedura.
Difendersi subito è l’unico modo per bloccare la pretesa del Fisco e far valere la violazione del tuo diritto di difesa.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta immediatamente un avvocato se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento senza essere stato invitato al contraddittorio;
- l’Agenzia ha emesso un atto basato su dati presuntivi o bancari;
- vuoi contestare la violazione del diritto di difesa;
- devi sospendere la riscossione o presentare ricorso.
Un avvocato esperto in diritto tributario può:
- impugnare l’avviso di accertamento per nullità;
- chiedere la sospensione cautelare della riscossione;
- dimostrare la violazione del contraddittorio obbligatorio;
- tutelarti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione.
⚠️ Attenzione: un accertamento emesso senza contraddittorio può sembrare definitivo, ma in realtà è spesso viziato e annullabile. Se non viene impugnato nei termini, però, diventa esecutivo e può comportare gravi conseguenze economiche. Agisci subito: un avvocato esperto può far valere la violazione del tuo diritto di difesa e ottenere l’annullamento dell’atto.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e difesa contro accertamenti illegittimi – spiega cos’è l’accertamento senza contraddittorio, quando è nullo e come difendersi efficacemente con l’assistenza di un avvocato specializzato.
👉 Hai ricevuto un avviso di accertamento emesso senza essere stato ascoltato?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la procedura, verificheremo la violazione del contraddittorio e costruiremo una strategia personalizzata per impugnare l’accertamento, sospendere la riscossione e difendere i tuoi diritti fiscali.
Introduzione
In ambito fiscale e amministrativo, il contraddittorio endoprocedimentale – ovvero il dialogo preventivo tra autorità e contribuente/debitore prima dell’emissione di un atto impositivo o sanzionatorio – è un principio cardine dello Stato di diritto. Tale principio garantisce trasparenza, partecipazione e tutela del diritto di difesa durante il procedimento amministrativo, permettendo al destinatario di esporre le proprie ragioni prima che l’atto diventi definitivo . In Italia, tuttavia, l’applicazione generalizzata di questo principio nei procedimenti di accertamento è stata a lungo controversa e limitata solo ad alcune ipotesi specifiche. Storicamente, il contraddittorio preventivo era espressamente previsto solo in determinati casi (ad esempio nelle verifiche fiscali svolte “in loco” presso il contribuente), mentre veniva escluso in altri (come nei controlli “a tavolino” effettuati in ufficio senza un’ispezione in azienda) . Ciò ha determinato disparità di trattamento procedurale e frequenti contenziosi sulla legittimità degli accertamenti emessi senza contraddittorio, soprattutto quando il contribuente si vede recapitare un avviso “a sorpresa” senza aver avuto occasione di chiarire i fatti prima.
Negli ultimi anni, legislatore e giurisprudenza hanno progressivamente esteso l’obbligo di contraddittorio, riconoscendone l’importanza in (quasi) tutti i settori impositivi. Una svolta cruciale è arrivata con la riforma fiscale del 2023, attuata dal D.lgs. 219/2023, che ha introdotto un nuovo articolo 6-bis nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) generalizzando il contraddittorio preventivo per la quasi totalità degli atti fiscali impugnabili . Parallelamente, la giurisprudenza – sia nazionale (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale) che dell’Unione Europea (Corte di Giustizia UE) – ha contribuito a delineare i confini e le eccezioni del principio, imponendo ad esempio il rispetto del contraddittorio in materia doganale e in ambito IVA (tributi “armonizzati” dall’UE) e riconoscendo la rilevanza di questo diritto di partecipazione quale espressione del diritto di difesa garantito dal diritto comunitario . Nonostante i progressi, permangono alcuni ambiti in cui la portata del contraddittorio è meno definita – come i procedimenti previdenziali o certi procedimenti sanzionatori amministrativi – creando incertezze sulla legittimità di accertamenti “unilaterali” (emessi senza previo confronto).
In questa guida avanzata esamineremo nel dettaglio quando un accertamento può considerarsi illegittimo per difetto di contraddittorio e come difendersi efficacemente da tali atti, dal punto di vista del contribuente/debitore. Analizzeremo i fondamenti normativi e gli sviluppi giurisprudenziali nei vari settori (tributario statale, tributi locali, dazi doganali, accise, sanzioni amministrative, contributi previdenziali, ecc.), con particolare attenzione alle novità introdotte dalla riforma 2023 e alle sentenze più recenti delle supreme corti italiane ed europee. Forniremo inoltre tabelle riepilogative, casi pratici simulati, nonché una sezione di Domande & Risposte, per chiarire i dubbi più comuni. L’obiettivo è offrire a professionisti (avvocati, dottori commercialisti), imprenditori e privati uno strumento completo e aggiornato (ottobre 2025) per orientarsi nel complesso ambito degli accertamenti senza contraddittorio – comprendendo quando tali atti possano essere annullati per violazione del contraddittorio e come tutelare al meglio i diritti del destinatario.
(Nota: per accertamento intendiamo qualsiasi atto autoritativo con cui l’Amministrazione pretende un tributo, una sanzione o un credito verso un privato – ad esempio avvisi di accertamento tributario, avvisi di addebito contributivo, verbali sanzionatori – emesso senza avere prima instaurato un formale contraddittorio con l’interessato).
Il Principio del Contraddittorio: Quadro Generale
Prima di addentrarci nei singoli settori, è utile delineare i tratti essenziali del principio del contraddittorio e la sua base normativa generale. Nell’ordinamento italiano, il diritto del destinatario di partecipare al procedimento amministrativo trova fondamento nella Legge generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). Questa legge prevede in via generale l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento e di consentire agli interessati di presentare memorie e documenti (artt. 7 e 10 L. 241/1990). In altre parole, al privato dev’essere data la possibilità di essere ascoltato e di contribuire alla formazione dell’atto prima che questo venga emanato, specie se l’atto incide negativamente sui suoi diritti o interessi. Il contraddittorio endoprocedimentale è quindi espressione del più ampio principio del giusto procedimento, correlato ai valori costituzionali del buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Va però subito precisato che i procedimenti tributari (ossia quelli concernenti accertamenti di imposte, tasse, sanzioni fiscali) sono tradizionalmente sottratti all’applicazione diretta delle norme generali della L.241/1990, essendo regolati da disposizioni speciali (in primis lo Statuto dei Diritti del Contribuente, L.212/2000) e da principi elaborati dalla giurisprudenza. Ciò ha storicamente creato un “doppio binario”: nel diritto amministrativo comune il contraddittorio era (ed è) la regola generale, mentre nel diritto tributario il contraddittorio preventivo è rimasto a lungo l’eccezione, previsto solo in casi specifici stabiliti dalla legge.
Che cos’è esattamente il contraddittorio endoprocedimentale? Si tratta del diritto del contribuente (o comunque del destinatario di un potenziale provvedimento sfavorevole) di essere informato delle risultanze istruttorie o delle contestazioni che l’ente intenderebbe muovere, prima che venga emesso l’atto finale, e di poter quindi presentare le proprie osservazioni, documenti e controdeduzioni. Il contraddittorio deve essere “effettivo”, non meramente formale: ciò implica che l’autorità procedente deve mettere il contribuente in condizione di conoscere gli elementi a suo carico e di esporre le proprie difese, e dovrà poi valutare realmente tali difese, motivando l’atto finale anche in relazione alle eventuali ragioni prospettate dall’interessato.
Dal punto di vista funzionale, il contraddittorio serve a duplice scopo: da un lato, tutela il diritto di difesa del cittadino (evitando che subisca decisioni errate o basate su informazioni incomplete, senza aver potuto dire la sua); dall’altro, migliora l’azione amministrativa stessa, perché consente all’ufficio di acquisire elementi e chiarimenti direttamente dal soggetto coinvolto, potendo così correggere eventuali errori o valutare soluzioni alternative prima che la decisione sia presa in via definitiva . Come ha sottolineato la Corte Costituzionale, il contraddittorio endoprocedimentale ottimizza il controllo fiscale (è strumentale al buon andamento della finanza pubblica) e allo stesso tempo garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare sin dalla fase amministrativa eventuali errori a suo danno .
Riassumendo, il principio del contraddittorio si inserisce nel contesto più ampio dello stato di diritto e dei diritti fondamentali: nell’ordinamento UE, ad esempio, è considerato parte integrante del diritto a una buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali (Carta di Nizza) . Il diritto “di essere ascoltati” prima di un provvedimento lesivo è riconosciuto come principio generale del diritto UE e nazionale. Tuttavia, come vedremo, la sua attuazione concreta varia a seconda del tipo di procedimento e delle norme specifiche vigenti in ciascun ambito.
Nei paragrafi seguenti, esamineremo l’evoluzione del contraddittorio nel diritto tributario italiano, dove la situazione è stata a lungo frammentaria, e poi illustreremo il nuovo quadro normativo dopo la riforma del 2023. Successivamente analizzeremo come il principio si applica (o meno) nelle diverse tipologie di accertamento: dai tributi erariali ai tributi locali, dai dazi doganali alle accise, fino ai procedimenti sanzionatori amministrativi e agli accertamenti contributivi. Infine, tratteremo le conseguenze giuridiche di un accertamento emanato in violazione del contraddittorio e i rimedi che il destinatario può attivare per far valere tale vizio, includendo esempi pratici di impugnazione.
Evoluzione Storica del Contraddittorio negli Accertamenti Fiscali
1. Le prime aperture normative: La prima codificazione esplicita del contraddittorio in ambito tributario risale allo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000). In particolare, l’art. 12, comma 7 di tale legge introdusse una garanzia importante ma circoscritta: nei casi di accertamento conseguente a verifiche fiscali in loco (accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, tipicamente quelli svolti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate in azienda), l’ufficio non può emanare l’avviso di accertamento prima di 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza . Durante questo intervallo di 60 giorni, il contribuente può presentare osservazioni e richieste che devono essere valutate dall’ufficio; nell’eventuale atto di accertamento emanato dopo, l’Ufficio è tenuto a confutare adeguatamente le osservazioni del contribuente qualora intenda disattenderle . La sanzione per il mancato rispetto di tale regola (ovvero per l’emissione “ante tempus” dell’atto, prima dello scadere dei 60 giorni senza urgenza) è la nullità dell’avviso di accertamento . Questa previsione, limitata testualmente alle verifiche “sul posto”, è stata a lungo l’unico caso di obbligo normativo generalizzato di contraddittorio nel sistema tributario italiano . Per tutte le altre tipologie di accertamento fiscale – ad esempio i controlli cosiddetti “a tavolino” svolti in ufficio sulla base di dati contabili, incroci di informazioni, controlli bancari, ecc. – la legge non imponeva un’analoga attesa né un confronto preventivo, a meno che norme specifiche lo prevedessero per singoli tributi .
Oltre a questo, un altro obbligo di contraddittorio “mirato” era previsto per gli accertamenti basati sugli studi di settore (strumenti statistici per stimare i ricavi delle imprese): l’art. 10, comma 3-bis della L. 146/1998 stabiliva – già prima del 2020, poi confluito in norme sugli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) – che se un accertamento si fonda esclusivamente sugli studi di settore, l’ufficio deve invitare il contribuente a comparire per avviare un contraddittorio, pena la nullità dell’atto. La Cassazione aveva interpretato tale obbligo in senso restrittivo: esso vale solo se lo studio di settore è l’unico fondamento dell’accertamento; se invece l’ufficio lo integra con altri elementi (es. gravi incongruenze contabili, antieconomicità, etc.), allora non vi è obbligo di contraddittorio preventivo in quanto l’accertamento non è “standardizzato” . Questo per dire che, prima delle riforme recenti, esistevano alcune ipotesi normative puntuali in cui l’Agenzia era tenuta a sentire il contribuente (verifiche in loco, studi di settore come unico elemento) ma, al di fuori di queste, nessuna clausola generale imponeva un contraddittorio anticipato negli accertamenti tributari.
2. L’orientamento della Cassazione e la sentenza “Ecotec”: Di fronte a questa frammentazione normativa, la giurisprudenza ha iniziato a interrogarsi se fosse possibile desumere un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale anche in assenza di un’esplicita previsione di legge. In un primo momento, alcune pronunce della Corte di Cassazione parvero riconoscere un principio generale: si argomentava che, poiché lo Statuto del Contribuente all’art. 10 comma 1 afferma principi di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente, da ciò discenderebbe un dovere per l’amministrazione di ascoltare il contribuente prima di emettere un atto impositivo a suo danno . Alcune sentenze di metà anni 2010 giunsero quasi a sostenere che il contraddittorio preventivo fosse un diritto immanente, di rango generale, nell’ordinamento tributario, in virtù di principi costituzionali (buon andamento, diritto di difesa) e comunitari. Questa tendenza culminò in due pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nel 2014 (note come caso Ecotec, sentenze nn. 19667 e 19668/2014), le quali – sia pur in vicende particolari – sembrarono aprire alla generalizzazione del contraddittorio come principio generale anche in mancanza di norme specifiche . Tali sentenze riguardavano in realtà atti di riscossione (iscrizioni ipotecarie) in epoca antecedente a una norma che introdusse l’obbligo di preavviso; i giudici, nel motivare, fecero ampie considerazioni sul valore del contraddittorio, lasciando intendere che esso fosse espressione di principi generali nazionali ed europei e auspicando una sua applicazione più ampia . Queste pronunce generarono discussione su una possibile “svolta” giurisprudenziale.
Tuttavia, ben presto la Cassazione sentì il bisogno di chiarire e unificare l’indirizzo, per evitare incertezze. Con la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015, la Suprema Corte ridimensionò l’idea di un obbligo generalizzato privo di base legale e fissò i principi destinati a valere fino alla recente riforma del 2023. Nel principio di diritto enunciato in quella sentenza (Cass. SS.UU. 24823/2015) si afferma chiaramente che, allo stato della legislazione vigente (2015), non esisteva nel diritto nazionale un obbligo generale per l’amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio prima di un accertamento, a pena di invalidità, salvo che ciò fosse specificamente previsto da una norma . Di conseguenza, per i tributi non armonizzati (quelli interni, come IRPEF, IRES, IRAP, tributi locali) l’obbligo di contraddittorio sussisteva solo nei casi espressamente previsti (es. art. 12, c.7 Statuto, studi settore, ecc.), mentre per i tributi armonizzati dall’UE (come l’IVA e i dazi doganali) trovava applicazione diretta il diritto UE, il quale invece impone il contraddittorio. In tale ultima ipotesi, disse la Cassazione, la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto in ogni caso, anche in materia tributaria, però a condizione che in giudizio il contribuente assolva all’onere di indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe prospettato se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e purché tali ragioni non siano “puramente pretestuose” . Questa condizione è la cosiddetta “prova di resistenza”: in pratica l’atto impositivo su tributi UE (IVA, dazi) emesso senza contraddittorio va annullato se (e solo se) il contribuente dimostra di aver subito un reale pregiudizio, indicando quali elementi avrebbe potuto far valere a proprio discarico; diversamente, se non indica nulla di concreto o se le sue doglianze appaiono meramente dilatorie, l’atto può essere considerato valido nonostante il vizio procedurale .
In sintesi, la Cassazione SU 24823/2015 ha tracciato una linea netta (accogliendo in pieno l’impostazione euro-unitaria ma negando un obbligo generalizzato interno):
- Per i tributi “armonizzati” (IVA, accise, dazi UE): obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale derivante dal diritto UE; la sua violazione comporta invalidità dell’atto impugnato, a condizione che il contribuente, in giudizio, specifichi quali argomenti avrebbe sollevato nel contraddittorio e che tali argomenti non siano pretestuosi . In altre parole, in ambito IVA/doganale il contraddittorio era da ritenersi necessario già prima della riforma, ma con la clausola della prova di resistenza (onere a carico del contribuente) .
- Per i tributi “non armonizzati” (imposte sui redditi, IRAP, tributi locali): nessun obbligo generalizzato di contraddittorio in assenza di norma; il contraddittorio era dovuto solo nei casi specifici previsti da leggi nazionali (come art. 12, c.7 Statuto per le verifiche in loco, o accertamenti da studi di settore esclusivi, etc.) . Dunque, un avviso di accertamento “a tavolino” relativo ad IRPEF, emesso prima del 2024 senza contraddittorio, non era annullabile per questo motivo, salvo violazione di qualche disposizione settoriale (e.g. non aver invitato per studio settore esclusivo, oppure non aver rispettato l’eventuale contraddittorio previsto da norme anti abuso ecc.). Questo orientamento ha così consolidato la distinzione: ambito armonizzato = contraddittorio necessario in via di principio; ambito nazionale = contraddittorio omesso tollerato, salve eccezioni di legge .
La sentenza del 2015 pose fine al precedente contrasto (originato dal caso Ecotec) e fu successivamente ribadita da numerose pronunce. Ad esempio, Cass. 26974/2020 ha confermato che per i tributi non armonizzati non esiste obbligo di contraddittorio salvo previsioni espresse, richiamando proprio i principi delle SS.UU. 2015 . Parimenti, Cass. 14357/2022 (Sez. V) ha escluso l’obbligo di contraddittorio per i tributi locali, sempre rifacendosi al “diritto vivente” antecedente la riforma (lo vedremo meglio in seguito). In poche parole, fino al 2023 lo stato del diritto era questo: nessun obbligo di contraddittorio per gli accertamenti fiscali interni, a meno di norma specifica; obbligo invece per IVA/dazi con il temperamento della prova di resistenza . Come vedremo, questa impostazione è destinata a mutare radicalmente con l’intervento legislativo del 2023.
3. L’influenza del diritto europeo: Mentre la giurisprudenza interna delimitava l’ambito del contraddittorio, a livello europeo la Corte di Giustizia UE aveva già affermato da tempo il valore generale del principio. Già con la sentenza Sopropé del 18 dicembre 2008 (C-349/07), relativa a dazi doganali, la Corte di Lussemburgo dichiarò che il diritto di essere ascoltati prima di un provvedimento sfavorevole è parte integrante dei diritti di difesa ed è un principio generale del diritto comunitario, applicabile ogni volta che un’amministrazione intenda adottare un provvedimento lesivo in ambito di applicazione del diritto UE . Ciò significa che, anche in assenza di una norma nazionale esplicita, quando l’accertamento riguarda materie disciplinate dal diritto dell’Unione (come l’IVA, essendo tributo armonizzato, o i dazi), le autorità nazionali devono garantire il contraddittorio in ossequio al principio comunitario . Successivamente, con le cause riunite Kamino e Datema (CGUE, 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13), è stato precisato che non ogni violazione del diritto al contraddittorio comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: spetta al giudice nazionale verificare se, in assenza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso . Questa è, appunto, la logica della prova di resistenza: l’atto viziato può essere mantenuto se si dimostra che ascoltare il contribuente non avrebbe cambiato nulla, mentre va annullato se la mancata partecipazione ha concretamente leso il suo diritto di difesa . Tale approccio “sostanzialistico” – volto ad evitare annullamenti per meri vizi formali privi di effettivo pregiudizio – è stato recepito dalla Cassazione italiana per i tributi armonizzati . Di fatto, la Cassazione con SU 2015 ha trapiantato i concetti di Kamino: per IVA/dazi, contraddittorio obbligatorio + prova di resistenza (onere al contribuente) .
In ambito doganale, va ricordato che il legislatore UE aveva già positivizzato il contraddittorio: il Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, applicabile dal 2016) prevede espressamente, all’art. 22(6), che prima di adottare decisioni che comportano obblighi per le persone (es. un avviso di recupero di dazi), le autorità doganali comunicano agli interessati gli elementi rilevanti e danno loro possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Dunque, nelle procedure doganali il diritto di essere sentiti è un obbligo normativo specifico, oltre che principio generale; la sua violazione infirma l’atto adottato (salvo il solito temperamento della prova di resistenza, riconosciuto dalla CGUE). Non sorprende, quindi, che l’ambito doganale sia stato pioniere nel riconoscimento del contraddittorio: da sempre, in virtù delle norme comunitarie, un accertamento doganale senza previa contestazione e fase di risposta del contribuente è considerato illegittimo .
Alla luce di questi sviluppi europei, il quadro fino al 2023 era composito: da un lato, forti sollecitazioni dalla giurisprudenza UE a estendere il contraddittorio come garanzia generale; dall’altro, la giurisprudenza interna che – pur riconoscendo l’importanza del principio – ne limitava l’obbligo ai casi di derivazione comunitaria o a quelli espressamente previsti dalla legge. In mezzo, si poneva la questione se colmare questo divario fosse compito del giudice (interpretazione conforme a principi generali) o del legislatore. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2023, è intervenuta proprio su questo punto: chiamata a pronunciarsi sull’assenza di un obbligo di contraddittorio per i controlli “a tavolino” dell’Agenzia Entrate (quindi per tributi non armonizzati, tema sollevato dalla CTR Toscana), la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione ma, contestualmente, ha spronato il legislatore a intervenire . La Corte Costituzionale ha osservato che la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo – rimasto finora limitato a ipotesi specifiche – risultava ormai distonica rispetto all’evoluzione del sistema, sia normativa che giurisprudenziale, e ha affermato che spetta al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente, prevedendo il contraddittorio in ogni tipo di controllo fiscale, modulandone forme e tempi a seconda delle peculiarità dei procedimenti . Pochi mesi dopo, questo invito ha trovato accoglimento: il Parlamento, con la legge delega n. 111/2023, ha chiesto espressamente di introdurre il contraddittorio generalizzato “a pena di nullità” negli accertamenti, e il Governo ha dato attuazione con il d.lgs. 219/2023 di fine 2023.
Passiamo dunque ad esaminare cosa prevede la riforma 2023/2024, che rappresenta un punto di svolta nella materia.
La Riforma Fiscale 2023: l’Obbligo Generalizzato di Contraddittorio (art. 6-bis Statuto del Contribuente)
Con la Legge 9 agosto 2023 n. 111 (delega per la riforma fiscale) il Parlamento ha indicato al Governo l’obiettivo di estendere in via generalizzata il principio del contraddittorio anticipato, prevedendo che la sua omissione comporti la nullità degli atti . In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 8 dicembre 2023 n. 219 (pubblicato a gennaio 2024), che ha modificato lo Statuto dei Diritti del Contribuente (L.212/2000) introducendo, tra l’altro, l’art. 6-bis intitolato “Principio del contraddittorio” . Questa nuova disposizione, entrata in vigore il 18 gennaio 2024 , rappresenta la svolta attesa: per la prima volta nel nostro ordinamento tributario si sancisce un obbligo generalizzato di contraddittorio per (quasi) tutti gli accertamenti, superando la distinzione tra tributi armonizzati e non.
Vediamo i punti chiave dell’art. 6-bis L.212/2000:
- Ambito oggettivo (comma 1): “Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo” . Ciò significa che ogni atto fiscale che il contribuente potrebbe impugnare davanti al giudice tributario (Commissioni/nuove Corti di Giustizia Tributaria) – ad es. avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni tributarie, atti di contestazione, cartelle di pagamento per cui sia prevista impugnabilità autonoma, ingiunzioni fiscali locali, ecc. – deve essere preceduto da un confronto con il contribuente. L’assenza di tale contraddittorio comporta la annullabilità dell’atto, ossia un vizio che il contribuente può far valere in giudizio ottenendo l’annullamento (in pratica, una nullità relativa deducibile su eccezione di parte). È importante notare che nella formulazione finale si usa “annullabilità” e non “nullità”: su questo aspetto torneremo più avanti (il legislatore delegato ha usato un termine diverso da quello voluto nella delega, suscitando qualche dibattito ).
- Eccezioni (comma 2): Il diritto al contraddittorio preventivo non sussiste (quindi l’atto può essere emesso senza questa fase) in due situazioni: (i) per gli atti “automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale” individuati con decreto del MEF; (ii) per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione . La prima categoria si riferisce a quegli atti emessi in massa attraverso procedure automatizzate o di semplice liquidazione (es: controlli formali art.36-ter DPR 600/73, liquidazioni da 36-bis, calcoli di imposte dovute in base ai dati dichiarati, ecc.), per i quali un contraddittorio preventivo generalizzato sarebbe poco praticabile. Sarà un decreto ministeriale a stilare l’elenco di questi atti esclusi: ad oggi (ottobre 2025) il decreto è stato emanato e include ad esempio avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità automatiche, etc. La seconda eccezione – il pericolo per la riscossione – riguarda i casi in cui l’Ufficio ha fondato motivo di ritenere che attendere i tempi del contraddittorio possa compromettere la possibilità di riscuotere il credito (tipicamente perché il contribuente potrebbe sottrarsi, alienare beni, espatriare con le somme…). In tali ipotesi l’Amministrazione può saltare il contraddittorio, ma deve darne motivazione nell’atto, spiegando le ragioni d’urgenza/fondato pericolo. Fuori da queste due eccezioni tassative, tutti gli altri accertamenti sono soggetti all’obbligo di contraddittorio.
- Modalità del contraddittorio (comma 3): L’Amministrazione finanziaria, per attivare il contraddittorio, comunica al contribuente uno schema di atto (ossia una bozza del provvedimento impositivo che intende emettere) assegnando un termine di almeno 60 giorni perché il contribuente possa presentare eventuali controdeduzioni, oppure – su richiesta – accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo . La comunicazione dev’essere fatta con modalità idonee a garantire la conoscibilità (solitamente notifica formale o PEC). L’atto definitivo non può essere emanato prima della scadenza del termine concesso per il contraddittorio . Dunque, la procedura prevede: notifica dello schema di atto -> attesa di almeno 60 giorni (durante i quali il contribuente può inviare memorie, documenti, chiedere accesso agli atti) -> eventuale emanazione dell’atto finale, tenendo conto di quanto emerso nel contraddittorio.
- Salvaguardia dei termini di decadenza: Un elemento importante introdotto dal comma 3 è che, se i 60 giorni di contraddittorio cadono a ridosso della decadenza del termine per emanare l’atto (cioè se l’Ufficio rischia di “sforare” i termini di legge per fare l’accertamento a causa dell’attesa), la legge allunga automaticamente i termini di decadenza. In particolare, se la scadenza del termine di 60 giorni è successiva al termine ultimo per emettere l’atto, oppure se tra la fine del contraddittorio e la decadenza restano meno di 120 giorni, il termine di decadenza per l’accertamento è prorogato al 120º giorno successivo alla fine del contraddittorio . In pratica, si concede all’amministrazione tempo aggiuntivo per concludere l’accertamento, così da eliminare qualunque incentivo a saltare il contraddittorio per motivi di urgenza temporale. Questo meccanismo risponde a un’esigenza pratica: evitare che, ad esempio, a fine anno l’Ufficio sia tentato di emettere accertamenti last-minute senza contraddittorio per non far decadere la potestà impositiva. Ora la legge gli permette di notificare lo schema, aspettare i 60 gg e sforare eventualmente l’anno, perché quei giorni vengono recuperati.
- Obbligo di motivazione (comma 4): L’atto definitivo adottato all’esito del contraddittorio deve dar conto delle osservazioni del contribuente e contenere la motivazione sulle ragioni per cui eventualmente l’Ufficio le ha respinte (in tutto o in parte) . Questo rafforza la tutela del contribuente: non basta che vi sia il contraddittorio formale, ma l’Ufficio deve considerare nel merito le difese presentate e dimostrare di averlo fatto. In mancanza, l’atto risulterebbe viziato per difetto di motivazione. Ad esempio, se il contribuente nei suoi scritti difensivi solleva un’obiezione specifica (es. un errore di calcolo dell’imposta) e l’ente impositore non ne tiene conto nell’avviso finale né spiega perché la rigetta, l’atto potrebbe essere annullato per carenza di motivazione. Si noti che questa previsione è in continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza sull’art.12 c.7 Statuto: la Cassazione ha spesso annullato avvisi post-verifica in loco non tanto per il mancato rispetto del termine, quanto perché l’Ufficio non aveva valutato e confutato le memorie presentate dal contribuente entro i 60 giorni . Ora tale dovere di motivazione sulle osservazioni del contribuente è esplicito nella legge per tutti i contraddittori.
In definitiva, dal 2024 abbiamo una regola generale: qualsiasi avviso o atto impositivo, prima di essere emesso, deve passare per una fase di contraddittorio di almeno 60 giorni, salvo rari casi eccezionali (controlli automatizzati e urgenze pericolo riscossione). La violazione di questa regola comporta l’annullabilità dell’atto, che in sede contenziosa potrà essere fatta valere dal contribuente. È una novità epocale per il diritto tributario italiano, che recepisce finalmente quel “giusto procedimento tributario” auspicato dalla dottrina e dalla Consulta .
Decorrenza e coordinamento: La norma si applica agli atti emessi dal 1° gennaio 2024 (in realtà, formalmente dal 18 gennaio, ma di fatto la maggior parte degli atti 2024 rientra). Il legislatore, però, non ha reso l’applicazione retroattiva né ha disciplinato espressamente il regime transitorio. Ciò significa che gli accertamenti notificati prima dell’entrata in vigore di art. 6-bis continuano ad essere giudicati secondo la disciplina previgente . Ad esempio, un avviso “a tavolino” notificato a dicembre 2023 senza contraddittorio non potrà essere annullato invocando l’art.6-bis (che non esisteva ancora): si applicheranno i principi Cassazione 2015, per cui se è IRPEF non c’era obbligo (atto valido), se è IVA c’era obbligo ma con prova di resistenza necessaria, ecc. Viceversa, un avviso emesso dopo l’entrata in vigore deve rispettare la nuova legge. Le Sezioni Unite della Cassazione sono già intervenute nel 2025 (sent. n. 21271/2025, come vedremo) per chiarire che per gli accertamenti antecedenti la riforma vale la regola precedente, mentre per quelli successivi vale la nuova disciplina .
È interessante notare che la legge delega chiedeva di introdurre il contraddittorio “a pena di nullità”, mentre l’articolo introdotto parla di “annullabilità”. La differenza potrebbe sembrare sottile, ma dal punto di vista giuridico “nullità” suggerisce un vizio insanabile e rilevabile d’ufficio (in teoria anche oltre i termini), mentre “annullabilità” implica che l’atto è valido finché non venga impugnato e annullato dal giudice su eccezione di parte. Di fatto, in sede processuale tributaria i termini per impugnare sono brevi e la rilevabilità d’ufficio delle nullità è dibattuta, per cui la distinzione potrebbe avere un impatto limitato: il contribuente dovrà comunque impugnare l’atto nei termini e sollevare il difetto di contraddittorio come motivo. Non può aspettarsi che la nullità venga dichiarata d’ufficio se lui stesso non propone ricorso, né potrà farlo oltre i termini di decadenza dell’impugnazione (in pratica, “nullità” o “annullabilità” portano allo stesso risultato operativo: l’atto va impugnato tempestivamente). Resta però un tecnicismo importante: il Governo ha optato per la annullabilità, forse per allinearsi alla terminologia già presente altrove nello Statuto (es. art. 6, c.5 Statuto, in materia di iscrizione a ruolo senza contraddittorio in caso di incertezze su dichiarazione, pure definita “annullabile”) .
Contraddittorio e atti non tributari: Va sottolineato che l’art.6-bis opera nell’ambito degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ciò include anche le sanzioni tributarie amministrative (perché anche le cartelle/atti di irrogazione sanzioni tributarie si impugnano in Commissione tributaria). La riforma invece non copre altri atti non fiscali (ad es. sanzioni amministrative diverse, atti impositivi non tributari). Su questi, valgono le regole generali di cui diremo in seguito, ma il nuovo art.6-bis non si applica direttamente.
Estensione a enti locali: Per evitare disparità, il D.Lgs. 219/2023 ha inserito anche delle norme (art. 1 commi 3-bis e 3-ter L.212/2000) che impongono alle Regioni ed enti locali di non introdurre regole in materia tributaria con garanzie inferiori a quelle statutarie . In sostanza, il principio del contraddittorio preventivo è ora vincolante anche per i tributi locali: i Comuni, le Province, le Regioni, quando emanano accertamenti relativi a IMU, TARI, imposte regionali etc., devono anch’essi rispettare il contraddittorio secondo il modello dello Statuto (nessuna delibera locale potrebbe esonerarli). Se un Comune emettesse un avviso senza contraddittorio ora violerebbe il principio generale. Nei fatti, molti enti locali dovranno adeguare i propri regolamenti e procedure per implementare questa fase di contraddittorio (spesso mai prevista in passato, se non come facoltà).
Coordinamento con l’art. 12, comma 7 (verifiche fiscali): Un dubbio interpretativo riguarda il rapporto tra il nuovo art.6-bis e il preesistente art.12 comma 7 Statuto (quello dei 60 giorni post-verifica in loco). In linea di principio, entrambe le norme mirano a garantire un contraddittorio, ma in due contesti diversi: l’art.12, c.7 opera quando c’è stata una verifica presso il contribuente e impone di attendere 60 giorni prima di emettere l’atto; l’art.6-bis opera per tutti gli atti impugnabili e impone di inviare lo schema e attendere 60 giorni. Si potrebbe pensare che nelle verifiche in loco ora si debba fare doppio contraddittorio (prima i 60 gg post PVC, poi magari un altro invito formale). In realtà, è opinione diffusa che nelle verifiche in loco l’obbligo di contraddittorio sia soddisfatto già dall’osservanza dell’art.12, c.7: il contribuente riceve il processo verbale di chiusura verifica (PVC) e ha i 60 giorni per presentare osservazioni, quindi ha già un contraddittorio. L’Ufficio, nel rispetto di ciò, non dovrebbe essere tenuto a notificare anche lo “schema di atto” ex art.6-bis, poiché ridonderebbe. Inoltre, il comma 2 dell’art.6-bis esclude gli atti di controllo formale e pronta liquidazione individuati da DM: tra questi, probabilmente, sarà incluso l’avviso emesso subito dopo PVC in caso di urgenza motivata (che già ora poteva succedere ex art.12,7). In pratica, art.12, c.7 rimane in vigore e coesiste: se la verifica in loco si è conclusa, l’Ufficio deve comunque aspettare i 60 giorni e rispondere alle memorie; allo scadere può emettere l’avviso definitivo senza dover fare un ulteriore passaggio. L’importante è che il contribuente abbia avuto quei 60 giorni per il contraddittorio – che è proprio ciò che vuole la nuova norma. Dunque, nel caso di verifiche in azienda, si può ritenere che il contraddittorio avvenga sulla base del PVC (come prima), mentre per tutte le altre ipotesi (controlli da remoto, accertamenti bancari, ecc.) ora c’è il nuovo obbligo di invito a contraddittorio ex art.6-bis.
Primi effetti pratici: Dal 2024 in poi, l’Agenzia delle Entrate (e gli altri enti impositori) si sono dovuti attrezzare per gestire questa fase di contraddittorio su larga scala. Sono stati predisposti modelli di “Invito a contraddittorio” o “Comunicazione di esito controllo” in cui si illustra al contribuente l’oggetto del contendere (ad esempio maggior reddito accertato, imposta dovuta, sanzioni) allegando lo schema di avviso di accertamento, e si concede il termine per presentare osservazioni. È un cambiamento procedurale significativo: i contribuenti ora ricevono un “preavviso” dell’accertamento e hanno occasione di interloquire, eventualmente correggendo errori o fornendo documenti chiarificatori, prima che l’avviso diventi ufficiale. Ciò può portare anche a chiudere positivamente alcuni casi senza neanche arrivare all’emissione dell’atto, qualora l’ufficio, ricevute le spiegazioni, ritenga di archiviare o ridurre la pretesa. Di converso, se il contraddittorio non avviene o avviene in modo inadeguato, il contribuente potrà far valere la violazione davanti al giudice per ottenere l’annullamento dell’atto.
Nei prossimi paragrafi analizzeremo come il nuovo quadro normativo (e, prima, quello previgente) si declina nelle varie tipologie di accertamento e nei diversi settori, poiché, se è vero che dal 2024 la regola generale copre quasi tutto, restano alcune peculiarità e restano gli atti non strettamente tributari che seguono logiche proprie. Inoltre, esamineremo la giurisprudenza più recente (2024-2025) che ha già affrontato questioni di contraddittorio preventivo sia nel regime precedente che in quello successivo alla riforma.
Ambiti di Applicazione: contraddittorio nei vari tipi di accertamento
In questa sezione passeremo in rassegna i principali ambiti applicativi del principio del contraddittorio, evidenziando per ciascuno la situazione prima della riforma (fino al 2023) e dopo la riforma (dal 2024 in poi). I settori considerati saranno:
- Accertamenti tributari statali (imposte dirette, IRPEF/IRES, IRAP, IVA, altri tributi erariali)
- Accertamenti in materia IVA e altri tributi armonizzati (che in parte si sovrappone con sopra, ma con peculiarità UE)
- Accertamenti doganali e accise
- Tributi locali (IMU, TARI, imposte comunali/provinciali)
- Sanzioni amministrative tributarie (penalità fiscali)
- Altre sanzioni amministrative non tributarie (multe, sanzioni di altro genere, per confronto)
- Accertamenti contributivi previdenziali (INPS, INAIL)
Per ciascuno vedremo se il contraddittorio era considerato obbligatorio oppure no e cosa è cambiato.
Accertamenti tributari statali (imposte dirette e altri tributi non armonizzati)
Questo paragrafo riguarda gli accertamenti relativi a imposte come IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, altre imposte dirette nazionali, e in generale tributi non armonizzati dall’UE.
- Prima della riforma (fino al 2023): Come già spiegato, non vi era un obbligo generale di contraddittorio per gli accertamenti “a tavolino” su questi tributi . L’amministrazione finanziaria poteva legittimamente emettere un avviso di accertamento senza aver previamente interpellato il contribuente, salvo i casi particolari previsti da specifiche norme. Le principali eccezioni in ambito statale erano:
- Verifiche in loco: se l’accertamento era conseguente a una verifica fiscale presso il contribuente (accesso, ispezione, verifica dalla G.d.F. o AE), vigeva l’art.12 comma 7 Statuto con obbligo di attesa 60 giorni e facoltà per il contribuente di presentare memorie . La violazione di questa regola (accertamento emesso prima dei 60 giorni senza urgenza) comportava la nullità dell’atto , come sancito dalla Cassazione SS.UU. 18184/2013 e confermato poi costantemente (in gergo “nullità per vizio procedimentale ante tempus”). Ad esempio, Cass. 1035/2022 ha ribadito che un avviso emanato anticipatamente – senza attendere i 60 gg dal verbale di chiusura – è illegittimo .
- Accertamenti da studi di settore (o ISA): per gli anni d’imposta fino al 2016 (studi di settore) e successivi (ISA), la legge imponeva il contraddittorio se l’ufficio intendeva emettere un accertamento basato sulle risultanze di tali parametri statistici. In particolare, l’art. 10, co.3-bis L.146/1998 (poi confluito nel DLgs 218/1997) obbligava l’ufficio a inviare invito al contraddittorio al contribuente prima di emettere un accertamento fondato sugli studi di settore, pena la nullità dell’avviso. La giurisprudenza aveva delimitato questa nullità ai casi in cui l’accertamento fosse interamente basato sugli studi, mentre se lo scostamento dallo studio era solo uno degli indizi e c’erano ulteriori elementi, non scattava l’obbligo (come chiarito dalla Cassazione, es. ord. 24783/2025) . Esempio: Cass. 24783/2025 ha confermato che se i ricavi vengono ricostruiti con metodologia analitico-induttiva considerando anche altri fattori (perdite ripetute, mancanza di redditi alternativi, ecc.), allora il contraddittorio preventivo non è obbligatorio, a differenza del caso in cui l’accertamento fosse fondato solo sugli studi di settore .
- Altre previsioni specifiche: c’erano poi alcuni casi particolari previsti dalla legge in cui era previsto un coinvolgimento del contribuente prima dell’atto. Ad esempio, per l’accertamento sintetico (redditometro), il DL 78/2010 imponeva di convocare il contribuente per spiegazioni prima di emettere l’atto definitivo; per le imposte registro su atti notarili, in taluni casi l’ufficio inviava un avviso di rettifica che poteva essere seguito da controdeduzioni; oppure in materia di transfer pricing l’ordinamento prevedeva forme di dialogo (documentazione idonea, ecc.). Ma si trattava di ipotesi settoriali. Di default, un accertamento IRPEF basato su controlli bancari o su ricostruzioni induttive poteva essere emesso senza contraddittorio e la difesa del contribuente avveniva solo ex post in contenzioso.
La Cassazione – come visto – escludeva la possibilità per il contribuente di far annullare un accertamento “a tavolino” IRPEF/IRAP lamentando solo l’omesso contraddittorio, perché “il nostro diritto interno, diversamente da quello UE, non conteneva una clausola generale in tal senso” . Perfino per i tributi locali (che comunque rientrano tra i non armonizzati) la stessa Cassazione ha chiarito che fino al 2023 nessun obbligo di contraddittorio gravava sui Comuni (lo vedremo infra). Quindi, il contribuente destinatario di un avviso di accertamento “nazionale” pre-2024, se non rientrava nei casi sopra, non poteva far annullare l’atto solo perché non era stato sentito prima. Poteva eventualmente contestare che l’atto fosse errato nel merito, ma non invocare un vizio procedurale in assenza di obbligo normativo.
- Dopo la riforma (dal 2024): Con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis Statuto, quanto sopra è radicalmente cambiato. Adesso tutti gli accertamenti tributari statali – incluse le imposte dirette e altri tributi prima “non armonizzati” – devono essere preceduti da contraddittorio, a pena di annullabilità . Quindi un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2024, emesso dall’Agenzia delle Entrate senza invito al contraddittorio e senza rientrare nelle eccezioni (atto non automatizzato e senza pericolo riscossione), è annullabile su ricorso del contribuente per violazione dell’art.6-bis. In giudizio il contribuente non ha più bisogno di dimostrare quale pregiudizio ha subito (in teoria la norma non richiede alcuna “prova di resistenza” esplicita): la violazione in sé integra motivo sufficiente di annullamento . Ciò rappresenta una tutela molto più forte rispetto al passato. È però prudente, in ricorso, indicare comunque quali argomentazioni difensive si sarebbero volute presentare se il contraddittorio ci fosse stato, non tanto perché sia obbligatorio, ma perché rafforza la posizione sostanziale e rende evidente che l’omissione non è un vizio “innocuo” (evitando rischi di interpretazioni restrittive). Alcuni commentatori, infatti, si sono chiesti se la giurisprudenza richiederà comunque al contribuente un minimo di specificazione sul pregiudizio (in ossequio al principio di leale collaborazione e per evitare annullamenti meramente formali) . La ratio della norma però è chiara: il vizio di omesso contraddittorio, nel nuovo regime, è di per sé causa di annullamento senza ulteriori oneri per il contribuente . Basterà dimostrare che l’atto rientrava tra quelli soggetti (atto impugnabile) e che l’Ufficio non ha inviato alcun invito né bozza, né ha atteso 60 giorni.
Un’altra rilevante novità è che, venendo meno la necessità di invocare principi generali, cade la distinzione armonizzati/non armonizzati ai fini interni: ora anche per IRPEF o tributi locali il contraddittorio è obbligatorio. La Cassazione, con SU 21271/2025, ha però precisato che ciò vale per gli atti successivi alla riforma; per quelli precedenti (come in quel caso, un accertamento a tavolino IRPEF 2011) continua a non esservi nullità per mancanza di contraddittorio . Nella stessa sentenza, la Corte ha ribadito che la prova di resistenza era concetto valido ante riforma solo per gli armonizzati, mentre post riforma la violazione “rileva ex se” in base alla legge interna .
In pratica, dal 2024: – Per un accertamento IRPEF, IRES, IRAP, registro, etc., sempre contraddittorio (salvo atti automatizzati tipo liquidazioni 36-bis, escluse da DM). – L’art. 12, c.7 resta specificamente applicabile alle verifiche in loco, ma come detto, se quella procedura è rispettata, l’esigenza di contraddittorio è soddisfatta. Se invece – caso raro – un accertamento in loco fosse emesso prima dei 60 gg senza urgenza, si potrebbe far valere sia la nullità ex art.12 c.7 sia l’annullabilità ex art.6-bis, insomma il risultato non cambia: atto invalidabile. – Il contraddittorio diventa un passaggio obbligato anche per gli uffici “interni” dell’Agenzia (prima, ad esempio, molte Direzioni provinciali facevano controlli bancari o altre verifiche e notificavano direttamente avvisi; ora devono predisporre e inviare la bozza e gestire le risposte). Ciò potrebbe allungare un po’ i tempi di accertamento, ma come visto la legge ha compensato con l’estensione dei termini di decadenza per evitare problemi.
In conclusione, per i tributi erariali interni la situazione è passata da un estremo all’altro: da “contraddittorio non dovuto salvo eccezioni” a “contraddittorio sempre dovuto salvo eccezioni” (in gran parte di carattere organizzativo). Questo realizza finalmente quel bilanciamento tra poteri del Fisco e garanzie del contribuente che la dottrina auspicava da tempo.
IVA e tributi “armonizzati” (IVA, dazi, accise)
Dedichiamo un paragrafo specifico all’IVA e agli altri tributi armonizzati dall’Unione Europea, come i dazi doganali e le accise, poiché per essi il contraddittorio era rilevante già prima della riforma, in virtù del diritto UE.
- Prima della riforma: Per l’IVA, imposta armonizzata, valevano i principi delineati dalla CGUE e recepiti dalla Cassazione SU 24823/2015: quindi l’obbligo di contraddittorio esisteva, come derivazione diretta dei diritti di difesa UE , e la violazione comportava invalidità dell’atto a condizione che il contribuente in giudizio indicasse le sue potenziali difese (prova di resistenza) . In pratica, se l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento IVA senza contraddittorio (e non era un caso di frode palese o urgenza riscossione), il contribuente poteva eccepirlo; il giudice avrebbe annullato l’atto se il contribuente aveva specificato quali elementi avrebbe addotto a suo favore e ritenuto tali elementi non meramente dilatori . Ad esempio, Cass. 1969/2017 e Cass. 11560/2018 (richiamate in Cass. 26974/2020) hanno ribadito che in materia IVA la violazione del contraddittorio comporta nullità purché il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere . La giurisprudenza era abbastanza costante su ciò dal 2015 in poi: non risultano casi in cui un avviso IVA sia stato ritenuto valido malgrado l’omissione se il contribuente aveva allegato il pregiudizio. Al contrario, in alcuni casi l’annullamento è stato negato quando il contribuente non aveva indicato alcuna specifica ragione (limitandosi a lamentare il vizio formale): in queste situazioni la Cassazione ha applicato rigorosamente la prova di resistenza, dicendo che se l’eccezione è generica l’atto non si annulla .
Va detto che per l’IVA esistevano anche norme interne settoriali che in parte anticipavano il contraddittorio: ad esempio, l’art. 54-bis DPR 633/72 prevedeva che a seguito di alcune verifiche la GdF rilasciava processo verbale e il contribuente poteva inviare memorie (dinamica simile all’art.12 Statuto); inoltre, l’art.5-ter DLgs 218/1997 (introdotto nel 2019) già imponeva un invito al contraddittorio per alcuni accertamenti sui periodi d’imposta più recenti (ma con ambito limitato). L’orientamento giurisprudenziale comunque faceva leva soprattutto sul principio generale UE e copriva l’IVA in ogni caso.
Per i dazi doganali, come detto, la situazione era ancor più favorevole al contribuente: il codice doganale unionale prevede formalmente il contraddittorio (diritto di essere sentiti) e la CGUE fin da Sopropé 2008 ha stabilito che la sua mancanza vizia l’atto. La Cassazione già prima del 2015 annullava gli avvisi di rettifica dazi se non vi era stata la previa notifica dell’esito del controllo con possibilità di replica (v. es. Cass. 8399/2013, 24923/2015 ecc.). Non solo: in dogana la “prova di resistenza” è stata applicata con severità a sfavore dell’Amministrazione, nel senso che si presumeva il pregiudizio salvo prova contraria. In altre parole, mentre per l’IVA la prova di resistenza era a carico del contribuente, in dogana spesso si riteneva che spettasse all’Amministrazione dimostrare che la partecipazione del privato non avrebbe cambiato l’esito . Ciò perché il diritto UE doganale formalmente richiede l’audizione, dunque se salta quella fase l’onere è sull’autorità che vuole far valere comunque l’atto (questo in linea con Kamino 2014, dove la CGUE disse che l’annullamento non è automatico ma va verificato se in mancanza dell’irregolarità la decisione “avrebbe potuto” differire; alcuni giudici nazionali interpretano che sia il fisco a dover provare che nulla sarebbe cambiato). Ad ogni modo, il contraddittorio doganale era considerato un must: la prassi dell’Agenzia Dogane era da tempo di emettere avvisi di accertamento dazi solo dopo aver inviato un “Avviso di revisione dell’accertamento” o un invito a presentare osservazioni (come previsto dall’art. 11 D.Lgs. 374/90 per i dazi). La giurisprudenza sia italiana che UE sul doganale era uniforme: atto doganale emesso senza previa contestazione -> illegittimo (salvo ipotesi di urgenze per decadenza o frodi in cui pure il codice consente notifica immediata) .
Le accise (es. accisa su alcol, oli minerali, energia, tabacchi) rientrano tra i tributi armonizzati (direttive UE) e seguono una logica simile ai dazi. Anche qui, l’Amministrazione delle Dogane in genere emette atti di rettifica con contraddittorio (spesso c’è un processo verbale di constatazione e poi il recupero). Non c’è una norma specifica come l’art.22 CDU, ma si applicano per via analogica i principi generali UE. Cass. 20068/2019, ad esempio, ha annullato un avviso di accisa per mancanza di contraddittorio, richiamando i principi CGUE. Quindi, in sintesi: – IVA, Dazi, Accise (pre-2024): contraddittorio dovuto per principio UE; omissione = invalidità con prova di resistenza (in diversa modulazione: onere contribuente per IVA, tendenzialmente a carico ufficio per dazi) .
- Dopo la riforma (dal 2024): L’art. 6-bis Statuto si applica ovviamente anche agli atti riguardanti tributi armonizzati, perché sono anch’essi “atti impugnabili dinanzi al giudice tributario”. Quindi, ad esempio, un avviso di accertamento IVA 2024 deve rispettare sia il nuovo obbligo interno sia quello UE – che ora coincidono. In pratica, l’obbligo di contraddittorio per IVA/dazi ora è doppiamente garantito: dal diritto nazionale (che non distingue più tra IVA e IRPEF) e dal diritto UE (che lo chiedeva già prima). La differenza principale è che, venendo introdotto un obbligo ex lege italiano, cade la necessità di scomodare la prova di resistenza come condizione processuale: l’atto IVA senza contraddittorio violerebbe direttamente l’art.6-bis, dunque sarebbe annullabile a prescindere . Alcuni si chiedono se, in virtù comunque dell’influenza UE, i giudici pretenderanno ancora dal contribuente una dimostrazione di specifiche difese frustrate. Tuttavia, dato che ora c’è una norma nazionale chiara (“a pena di annullabilità”), è probabile che la giurisprudenza non applichi più la prova di resistenza almeno come requisito tassativo per annullare, ma al massimo la consideri come criterio equitativo (ad esempio, se il contribuente stesso in giudizio ammettesse che non aveva nulla da opporre, il giudice potrebbe valutare la possibilità di non annullare per un vizio innocuo – ma si tratterebbe di casi limite) . L’avvocatura erariale potrebbe ancora cercare di introdurre argomenti di “inesistenza di pregiudizio” per salvare atti viziati, ma con una norma interna di nullità sarà molto più difficile farli accogliere .
In dogana, l’art.6-bis si applica soprattutto agli atti di accertamento dell’IVA all’importazione (che vanno in Commissione tributaria). Per i dazi veri e propri, l’ambito di impugnazione è sempre il giudice tributario quindi sì, anche per quelli. Già prima comunque Dogane rispettava il contraddittorio, per cui non c’è grande impatto pratico se non l’eliminazione di eventuali contese su chi debba provare il pregiudizio.
In conclusione, dal 2024 per IVA, dazi, accise vi è piena sovrapposizione tra tutela UE e tutela italiana: il contraddittorio è obbligatorio e la mancanza porta all’annullamento dell’atto su ricorso, senza distinzioni. Il contribuente farà bene comunque a indicare nel ricorso quali sono le sue ragioni di merito (così il giudice vede che l’annullamento non è “per un cavillo” ma perché c’era sostanza da discutere), ma formalmente basterà invocare la violazione dell’art.6-bis e dell’eventuale norma UE (art.41 Carta di Nizza, art.22 CDU per dazi, giurisprudenza CGUE). Possiamo dire che il principio europeo del contraddittorio è stato integrato stabilmente nel nostro ordinamento grazie alla riforma, superando quella “disarmonia” lamentata dalla Consulta.
Va aggiunto che resta anche in vigore l’art.5-ter D.Lgs. 218/1997, introdotto nel 2019, che aveva già previsto l’obbligo di invito al contraddittorio per i tributi armonizzati in casi di controlli a tavolino su annualità recenti, con disciplina della prova di resistenza. Questo art.5-ter di fatto è ora assorbito dall’art.6-bis, e infatti il legislatore ha coordinato le norme: per gli atti emessi dal 30/04/2024 sono state modificate anche le norme sull’accertamento con adesione (D.Lgs.218/97) per integrare il nuovo contraddittorio generalizzato . Senza entrare in tecnicismi, ciò significa che la fase di contraddittorio può evolvere in un’adesione (se le parti trovano un accordo) oppure concludersi con il diniego dell’ufficio e l’emissione dell’atto. L’importante è che, in un modo o nell’altro, il contribuente abbia avuto voce prima dell’atto finale.
Accertamenti doganali e accise (profili specifici)
Abbiamo in parte già trattato i dazi e le accise insieme all’IVA, ma riassumiamo i concetti chiave focalizzandoci sul punto di vista pratico del destinatario (operatore doganale, depositario fiscale di accise, etc.):
- Già da molti anni, grazie alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza, nel settore doganale un accertamento senza contraddittorio è illegittimo praticamente da sempre . La Dogana, prima di emettere un avviso di pagamento di maggiori dazi, invia tipicamente un “avviso di rettifica” o una “contestazione” indicando le differenze riscontrate (ad esempio da un controllo a posteriori su un’importazione) e assegna un termine (spesso 30 giorni) per memorie. Se ciò non avviene, la giurisprudenza dichiara nullo l’atto. La Corte di Giustizia UE con la sentenza Sopropé e poi con Kamino/Datema ha posto le basi, la Cassazione le ha recepite (già Cass. 4283/2010 e 10658/2011 annullavano avvisi doganali senza previa notifica). La prova di resistenza in dogana è sempre richiesta in via teorica, ma in concreto raramente il fisco riesce a dimostrare che la partecipazione del contribuente non avrebbe cambiato nulla, se il contribuente almeno enuncia qualche possibile elemento a suo favore . Per esempio, se la dogana riliquida una voce tariffaria senza consultare l’importatore e quest’ultimo in giudizio dice “avrei fornito certificati di origine alternativi”, l’atto verrà annullato per violazione del contraddittorio, perché non si può escludere che quei certificati avrebbero cambiato l’esito.
- Con la riforma 2023, l’unica differenza è formale: ora il contribuente doganale può invocare direttamente l’art.6-bis L.212/2000 (tramite il rinvio dell’art.1, c.3-bis Statuto agli enti impositori diversi dallo Stato centrale) oltre alle norme UE. Ma non cambia molto, perché già prima il giudice tributario annullava comunque per violazione di principi comunitari (che hanno primazia). Possiamo dire che è quasi una duplicazione di tutela.
- Nelle accise, contesto affine (anche l’accisa sull’energia o sugli alcolici è armonizzata da direttive UE), la prassi vede spesso un Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dall’Agenzia Dogane e Monopoli in caso di controlli presso i depositi fiscali o le aziende. Già quel PVC costituisce un inizio di contraddittorio (l’operatore può fare osservazioni), poi eventualmente arriva l’atto di recupero. La riforma consolida anche qui che se – poniamo – un Ufficio Accise emettesse una rettifica senza aver seguito questi passi, l’atto è annullabile per art.6-bis e principi UE.
In sintesi, per operatori doganali e soggetti obbligati in materia di accise, non molto cambia nel merito: avevano già il diritto di essere ascoltati prima, continuano ad averlo; ora c’è anche la copertura esplicita della legge nazionale che rafforza la loro posizione. È comunque utile che nelle memorie difensive in giudizio essi specifichino quali documenti o spiegazioni avrebbero fornito se fossero stati interpellati: ciò per superare agevolmente la “prova di resistenza” (ancorché in teoria non più necessaria come prima, è bene non dar adito a dubbi) .
Tributi Locali (IMU, TARI, TASI, Tosap, ecc.)
I tributi locali – come l’IMU (imposta municipale sugli immobili), la TARI (tassa rifiuti), l’addizionale IRPEF comunale, la TOSAP/COSAP (occupazione suolo pubblico), l’ICP (pubblicità) e simili – meritano una trattazione a parte perché finora si sono mossi su un binario parallelo a quello statale, spesso con meno garanzie procedurali. Gli accertamenti dei Comuni o Enti locali in genere vengono notificati al contribuente senza particolari “preavvisi” o inviti, sebbene alcuni Comuni abbiano spontaneamente introdotto prassi di confronto con il contribuente (ad esempio avvisi bonari prima dell’atto formale).
- Situazione pre-riforma: Non esisteva alcuna norma generale che imponesse il contraddittorio per i tributi locali. La Legge 212/2000, prima delle modifiche, si applicava anche ai tributi locali per molti aspetti, ma l’art.12, comma 7 Statuto (quello dei 60 giorni) si riferisce a verifiche dell’Agenzia Entrate o Guardia di Finanza, dunque non copriva, ad esempio, le attività di accertamento del Comune su IMU o TARI. La giurisprudenza è stata chiara nell’escludere obblighi impliciti: la Cassazione ha più volte affermato che per i tributi locali non vige un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, se la legge non lo prevede . Ad esempio, Cass. ord. 26886 del 5/10/2021 (caso TARSU) ha precisato che non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo per il Comune, notando anzi che l’art.73 D.Lgs. 507/1993 lascia solo la facoltà al Comune di invitare il contribuente a esibire documenti o rispondere a questionari, ma senza obbligo né sanzione per la mancata instaurazione . In quella pronuncia si legge che il Comune “può” introdurre un contraddittorio nel procedimento, ma non “deve”, e l’omissione non inficia l’atto . Altre decisioni: Cass. 14357/2022 (riguardo IMU) conferma l’assenza di un obbligo generalizzato; Cass. 27421/2018 aveva già negato che lo Statuto del contribuente imponesse il contraddittorio per i tributi locali, se non recepito da norme locali. Dunque, prima del 2024, un avviso di accertamento IMU notificato senza nessun preavviso era purtroppo legittimo e il contribuente non poteva far leva su un vizio procedurale di quel tipo. Doveva semmai contestare il merito (es: “il calcolo è sbagliato”, “l’immobile è esente”, ecc.). Solo in specifici casi la legge prevedeva qualcosa: per es., in materia di tributi sui rifiuti, alcune norme regolamentari consentivano al contribuente di presentare denunce di superfici e al comune di chiedere chiarimenti; per la ICI (antenata IMU) non c’era contraddittorio preventivo se non in caso di rendite presunte (in cui c’era un invito a provvedere). Insomma, nessun obbligo strutturale.
- Dopo la riforma: Come accennato, il D.Lgs. 219/2023 ha aggiunto in testa allo Statuto (art.1 commi 3-bis e 3-ter) dei principi per cui le disposizioni dello Statuto rappresentano livelli minimi di tutela anche per i tributi delle regioni e degli enti locali, che non possono prevedere garanzie inferiori . In più, poiché l’art.6-bis si applica a “tutti gli atti impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria”, e gli avvisi di accertamento IMU/TARI sono atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, anche questi rientrano nell’obbligo di contraddittorio. Quindi, dal 2024 un Comune che vuole notificare un avviso di accertamento IMU deve prima comunicare al contribuente una bozza di atto con le motivazioni (es: “risultano omessi versamenti IMU per l’anno X sull’immobile Y per €…, ecco il calcolo”) e dare almeno 60 giorni per controdedurre . Se non lo fa, l’avviso è viziato e il contribuente potrà farlo annullare dal giudice tributario per violazione dell’art.6-bis. Inoltre, il Comune non potrà dire “ma noi non sapevamo”: la legge è chiara e impone a regioni ed enti locali di adeguarsi ai principi statali. Molti Comuni si sono attivati emanando circolari interne o modificando i regolamenti per introdurre questa fase. È presumibile che nel periodo di transizione alcuni atti locali sfuggano alla regola (per scarsa conoscenza della novità): in tali casi, di fronte a un ricorso, quasi sicuramente l’ente locale perderà la causa e l’atto sarà annullato. A conferma: già alcune Commissioni Tributarie (ora CGT) nel 2024 hanno annullato avvisi TARI e IMU notificati subito a gennaio 2024 senza invito, riconoscendo l’applicabilità immediata dell’art.6-bis (fatti riportati in riviste specializzate).
Va detto che per i piccoli Comuni questa rappresenta una sfida organizzativa, perché significa gestire un contraddittorio che richiede magari personale e tempo. Tuttavia, la norma c’è e va rispettata. Alcuni Comuni potrebbero cercare rifugio nelle eccezioni: per esempio, definire certi avvisi come “automatizzati” per esonerarsi. Ma attenzione: l’esenzione per atti automatizzati vale solo per quelli individuati dal Ministero dell’Economia via decreto , e verosimilmente riguarderà quasi solo atti dell’Agenzia delle Entrate (tipo avvisi bonari). Gli accertamenti comunali IMU non sono atti automatizzati di liquidazione di dichiarazione, ma veri e propri accertamenti di omesso pagamento, dunque non rientrano nell’eccezione. Quanto al “pericolo per la riscossione”, è di difficile applicazione in ambito locale (situazioni di pericolo che il contribuente scappi col mattone? improbabile). Quindi difficilmente un Comune potrà saltare il contraddittorio per motivi legittimi; dovrà, piuttosto, implementarlo.
Esempio pratico: Il Comune Alfa accerta nel 2025 che il Sig. Rossi non ha pagato l’IMU 2024 per una seconda casa. Pre-riforma avrebbe direttamente spedito l’avviso di accertamento con sanzioni e interessi. Post-riforma, dovrà inviare a Rossi una “Comunicazione di accertamento IMU non pagata” in cui illustra l’omissione e allega lo schema di avviso (o comunque indica importi e basi imponibili), dando 60 giorni per eventuali chiarimenti. Rossi in quei 60 giorni potrebbe, ad esempio, produrre documenti che provano che l’immobile era abitazione principale (esente) o che c’è stato un errore del catasto. Il Comune valuterà e poi emetterà l’avviso definitivo motivando. Se il Comune non facesse nulla di tutto ciò e notificasse direttamente l’avviso, Rossi nel ricorso potrà eccepire la violazione del contraddittorio preventivo e chiederne l’annullamento, con ottime probabilità di vittoria stante il nuovo quadro normativo.
Prima del 2024, Rossi non avrebbe avuto questa carta procedurale in mano, ma solo difese di merito. Ecco quindi che dal punto di vista del contribuente locale c’è una tutela aggiuntiva importante.
Un aspetto interessante: alcuni interpretano che l’art.6-bis potrebbe applicarsi non solo agli atti dell’ente impositore locale, ma anche agli atti emessi dall’Agente della Riscossione impugnabili davanti al giudice tributario. Ad esempio, la cartella di pagamento relativa a un tributo locale: è un atto impugnabile in commissione. Dovrebbe essere preceduta da contraddittorio? Su questo il dibattito è aperto: l’art.6-bis letteralmente parla di atti impugnabili dinanzi al giudice tributario – e una cartella lo è (per vizi propri o per far valere vizi dell’atto presupposto). Tuttavia, la cartella deriva da un ruolo spesso formato automaticamente. Probabilmente la si farà rientrare tra gli atti automatizzati di liquidazione esclusi dall’obbligo , specie se è emissione a seguito di omesso pagamento di accertamento definitivo. Diverso se fosse una ingiunzione fiscale comunale (titolo esecutivo alternativo alla cartella usato da alcuni comuni): quella è impugnabile e non del tutto automatizzata. In attesa di indicazioni ministeriali, resta un’area grigia. In generale, però, per i tributi locali “sostanziali” (IMU, TARI, imposte, canoni), il contraddittorio è oramai una tappa obbligata.
Sanzioni Amministrative (violazioni extra-tributarie)
Il tema del contraddittorio si pone anche al di fuori dell’ambito strettamente tributario. Molti utenti si chiedono: “Ho ricevuto una sanzione amministrativa (es. una multa stradale, una sanzione edilizia, una sanzione per violazione ambientale, ecc.) senza essere stato sentito prima: è legittimo? Avevo diritto a un contraddittorio anticipato?”.
Occorre distinguere, perché le procedure sanzionatorie amministrative (non penali) seguono regole proprie, spesso previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 (la legge generale sulle sanzioni amministrative). In generale: – Per le violazioni amministrative istantanee (es: multa per eccesso di velocità, per divieto di sosta, etc.), la prassi è che la contestazione avviene immediatamente (o con notifica successiva) e il contraddittorio è spostato a posteriori: cioè il destinatario può presentare ricorso o opposizione all’autorità competente (es. al Prefetto o al Giudice di Pace per le multe stradali). Non c’è, di norma, un obbligo di sentirlo prima di emettere il verbale di multa: la contestazione avviene di solito contestualmente all’accertamento dell’infrazione (ti fermano e ti contestano sul posto, che è già una forma di contraddittorio sommario; oppure se autovelox ti mandano verbale e tu poi hai diritto di difenderti con ricorso). Dunque, in ambito di sanzioni del Codice della Strada, ad esempio, non esiste un contraddittorio “preventivo” all’irrogazione della sanzione, ma ciò è compensato dal fatto che la sanzione stessa non è definitiva e l’interessato può opporsi entro termini, esponendo le proprie ragioni. Questo è considerato sufficiente a garantire il diritto di difesa, anche secondo la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa.
- Per altre sanzioni amministrative, la Legge 689/1981 prevede invece una fase di contestazione e difesa scritta prima dell’ordinanza-ingiunzione. Funziona così: quando viene accertata una violazione (ad es. in materia di lavoro, ambiente, commercio, ecc.), l’autorità competente notifica al presunto trasgressore un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo. Da quel momento, l’interessato ha 30 giorni per presentare scritti difensivi e documenti e per chiedere, se vuole, di essere sentito . L’Autorità (es. Prefetto per molte violazioni, o l’ente regolatore per altre) deve esaminare questi scritti e poi emette il provvedimento finale (ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione, oppure archiviazione). Questo schema vale per esempio per: sanzioni amministrative del Prefetto (es. multe non pagate, il Prefetto emette ordinanza), sanzioni antiriciclaggio del MEF, sanzioni comminate da Autorità indipendenti (Antitrust, Privacy – che però hanno procedure proprie con udienze), sanzioni per illeciti edilizi (il Comune contesta e poi ingiunge la sanzione), etc. In tutti questi casi, la legge stessa prevede un contraddittorio: la mancata previsione di contraddittorio potrebbe far dubitare di costituzionalità il procedimento. Dunque, se un ente emette un’ordinanza-ingiunzione senza aver prima contestato la violazione o senza aver esaminato le difese, l’interessato può impugnarla (davanti al giudice competente, di solito il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dei casi) lamentando il vizio di procedura. E i giudici spesso annullano tali provvedimenti per violazione del diritto di difesa (ex L.689/81 o ex L.241/90). Ad esempio, vi sono sentenze dei TAR che hanno annullato sanzioni amministrative perché l’ente non aveva dato riscontro alle memorie presentate dal privato in sede di precontenzioso, violando l’obbligo di motivazione e partecipazione.
- Diritto amministrativo generale: Ricordiamo che per i provvedimenti amministrativi in generale (non tributari), l’art. 7 L.241/1990 obbliga a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti interessati, dando loro modo di partecipare. Le sanzioni amministrative sono provvedimenti amministrativi e, se non coperte da procedura speciale, ricadono in questo obbligo. Quindi, se un Comune intendesse emettere una sanzione atipica (es. revoca di un’autorizzazione con contestuale sanzione pecuniaria) dovrebbe prima comunicare l’avvio del procedimento all’interessato e valutare le sue memorie. La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, TAR) è ferma nel ritenere illegittimi i provvedimenti sanzionatori adottati senza contraddittorio, quando questo era esigibile secondo L.241/90, a meno che ricorrano circostanze di urgenza o pericolo concreto (art.7 e 8 L.241 prevedono esenzioni se vi sono ragioni di impedimento obiettivo).
In sintesi, nelle sanzioni amministrative non tributarie il contraddittorio esiste spesso come fase procedurale obbligatoria (contestazione degli addebiti e difesa prima della decisione). Se viene omesso, l’atto finale (es. l’ordinanza-ingiunzione) può essere impugnato e annullato. Il punto di vista del destinatario è: a differenza del settore tributario pre-2024 dove poteva non esserci nulla, nel settore amministrativo extratributario c’era già la L.689/81 a tutelarlo. Dove invece la legge speciale nulla diceva, interveniva la L.241/90 con l’obbligo di comunicazione di avvio. Dunque, anche prima, era raro un caso in cui un cittadino subisse una sanzione amministrativa consistente senza almeno aver avuto la chance di dire la sua (fanno eccezione, come detto, le multe stradali che hanno logiche diverse, o le sanzioni “istantanee” dove contraddittorio differito in sede di ricorso).
Esempio: Tizio viene sorpreso dall’ASL con rifiuti smaltiti male; il funzionario redige verbale di contestazione di illecito amministrativo ambientale. Tizio ha 30gg per difendersi. Se Tizio invia una memoria spiegando che in realtà aveva autorizzazione, l’ente deve esaminarla. Se l’ente emette comunque ordinanza di multa senza nemmeno menzionare le giustificazioni di Tizio, quell’ordinanza può essere annullata dal giudice per difetto di motivazione/contraddittorio (è successo in vari casi, dove le memorie non considerate portano all’illegittimità per violazione art. 10 L.241/90). Viceversa, se l’ente non contesta affatto e manda direttamente la multa, violerebbe l’art. 14 L.689/81 e l’atto sarebbe nullo.
Impatto della riforma 2023: Da notare che l’art. 6-bis Statuto parla di atti impugnabili davanti al giudice tributario. Quindi non si applica alle sanzioni amministrative generiche, che vanno dal giudice ordinario o al TAR. Dunque, la riforma fiscale non riguarda questo settore. Tuttavia, parallelamente, la delega fiscale chiedeva contraddittorio anche per gli atti sanzionatori tributari (che ora è stato introdotto) . Per le sanzioni non tributarie, si potrebbe un domani pensare a un analogo principio generale. Ma, come detto, c’era già, nel contesto generale, la L.241 e la L.689.
In conclusione: per il cittadino/imprenditore che subisce una sanzione amministrativa (non fiscale), il consiglio è di verificare se il procedimento doveva prevedere la sua partecipazione. Se sì e ciò non è avvenuto, vi sono buone chance di far annullare l’atto in sede di ricorso, invocando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa (in base alle norme generali sopra citate). Questo aspetto però esula un po’ dal “contraddittorio negli accertamenti” fiscali che è il focus principale della guida, ma abbiamo voluto menzionarlo per completare il quadro delle tutele del debitore anche fuori dall’area tributaria.
Accertamenti contributivi previdenziali (INPS, INAIL)
Un ambito peculiare è quello degli accertamenti contributivi previdenziali, ad esempio quando l’INPS contesta a un’azienda omessi versamenti di contributi o quando, a seguito di ispezione del lavoro, viene notificato un verbale con contributi evasi. Queste situazioni non sono “tributi” in senso stretto (i contributi sono dovuti ad enti previdenziali, non rientrano nella giurisdizione tributaria ma in quella ordinaria, se contenzioso), e lo Statuto del Contribuente formalmente non si applica a essi. Ci si può chiedere: esiste un obbligo di contraddittorio anche qui?
- Fino ad oggi (2025): Non esiste una norma generale equivalente all’art.12 Statuto per le ispezioni INPS, però in pratica le procedure ispettive prevedono una certa partecipazione. Ad esempio, quando l’Ispettorato del Lavoro/INPS effettua un controllo in azienda, spesso al termine rilascia un verbale di accertamento (verbale unico di accertamento e notificazione) in cui contesta le irregolarità (es. lavoro nero, contributi non versati su certe somme). L’azienda può entro un certo termine presentare difese a quegli organi (mi riferisco al regime pre-riforma Dlgs 149/2015). Anche se non codificato come Statuto, nella prassi l’INPS talvolta attende o comunque valuta eventuali controdeduzioni prima di emettere l’avviso di addebito. In passato, l’INPS attendeva 30 giorni dal verbale prima di iscrivere a ruolo (per prassi interna). Inoltre, l’art. 30 del DL 78/2010 aveva previsto che i verbali di accertamento in materia contributiva fossero immediatamente esecutivi decorsi 90 giorni dalla notifica senza pagamento né ricorso amministrativo: questo lasciava intendere che entro quei 90 giorni l’azienda potesse presentare un’istanza di riesame o di autotutela. In ogni caso, la giurisprudenza sulla necessità del contraddittorio in ambito contributivo è ondivaga. Alcuni tribunali hanno fatto applicazioni analogiche dello Statuto del contribuente in casi di contributi assimilabili a tributi (in particolare per i premi INAIL, considerati fiscalizzati). Ma la Cassazione generalmente ha detto che lo Statuto si riferisce a rapporti tributari, non estensibile sic et simpliciter a rapporti contributivi.
La Corte Costituzionale, per parte sua, non si è ancora pronunciata specificamente su un obbligo di contraddittorio nelle procedure INPS. Tuttavia, data l’importanza del principio generale, nulla vieta che in futuro vi sia un allineamento.
In assenza di norme speciali, valgono anche qui i principi della L.241/1990: essendo un procedimento amministrativo (accertativo di un credito contributivo), l’ente dovrebbe – salvo eccezioni – comunicare l’avvio e far partecipare. Alcune sentenze hanno annullato avvisi INPS se l’ente non aveva risposto a osservazioni del contribuente: ad esempio, ci sono pronunce di Corti d’Appello che hanno ritenuto violato il diritto di difesa quando l’INPS non aveva considerato memorie difensive inviate dall’azienda dopo l’ispezione. Altre volte però i giudici hanno detto che la fase ispettiva stessa costituiva contraddittorio (l’azienda firma verbali, può dire cose durante l’ispezione).
- Con la riforma fiscale 2023: L’art.6-bis Statuto non copre gli atti INPS, perché non sono impugnabili in Commissione tributaria ma in Tribunale ordinario (se l’azienda fa opposizione). Inoltre, l’INPS non è un ente locale o regionale, quindi la clausola di adeguamento di art.1, c.3-bis Statuto (che vale per regioni/enti locali) non la riguarda . Ciò significa che la riforma tributaria non ha direttamente imposto all’INPS di fare contraddittorio in tutti i casi. Tuttavia, sarebbe auspicabile che anche in quell’ambito si adegui la prassi per coerenza di sistema. In realtà, con l’avvento del processo di “armonizzazione” dei sistemi, potrebbe intervenire il legislatore con una norma parallela per i contributi. Ma ad oggi non risulta.
Quindi, se un’azienda riceve nel 2025 un avviso di addebito INPS per contributi omessi, notificato senza alcun preavviso o invito, potrà lamentarne la scorrettezza ma non avrà una norma specifica da invocare come l’art.6-bis. Potrà certo richiamare principi costituzionali (art.97, 24), la Carta UE se applicabile (talvolta la CGUE in materia di contributi previdenziali – che non sono armonizzati – non è intervenuta; però se riguardasse contributi su distacchi transnazionali potrebbe profilarsi un discorso UE di libera circolazione?), o la L.241/1990 se ritiene che quell’avviso sia atto finale di un procedimento non urgentedove andava comunicato l’avvio. Non c’è molta giurisprudenza di legittimità da citare qui, dunque la difesa è più in termini generali di equità e buon andamento.
Da notare: per le ispezioni previdenziali, esisteva prima una norma (art.4, c.1 DM 11/2011) che prevedeva, simile allo Statuto, un intervallo di 60 giorni tra la notifica del verbale finale e l’emissione dell’avviso di addebito, salvo casi particolari, per consentire al trasgressore di pagare con sanzioni ridotte o presentare osservazioni. Quella norma è stata abrogata nel 2021 (DL 146/2021). Ciò di fatto ha eliminato un cuscinetto di contraddittorio che era previsto per le ispezioni: dal 2022 l’INPS teoricamente può emettere subito l’avviso di addebito dopo il verbale. In assenza di obblighi, sta alla sensibilità dell’Istituto. Questa abrogazione è stata criticata perché è andata in senso opposto alla tendenza pro-contraddittorio.
Ecco quindi che, paradossalmente, nel 2022-2023 il contribuente fiscale aveva meno diritti di contraddittorio di prima (nessun obbligo post-verifica contributiva) mentre nel 2024 il contribuente fiscale ne ha ottenuto di più (obbligo generalizzato negli accertamenti tributari). C’è una asimmetria: se l’INPS fa un controllo contributivo e l’Agenzia Entrate uno fiscale, oggi l’Agenzia deve fare contraddittorio, l’INPS no (per legge). Questo potrebbe in futuro essere oggetto di discussione anche in sede di giudizio di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. Ad esempio, due aziende subiscono accertamenti, uno fiscale e uno contributivo, la prima viene tutelata col contraddittorio ex lege, la seconda no. Art.3 Cost. di uguaglianza potrebbe essere invocato.
Riassumendo sulla previdenza: attualmente il punto di vista del contribuente/debitore è che non ha un diritto certo a essere pre-audito in materia di contributi, però può sempre provare a interagire con l’ente. È comunque buona prassi che, in caso di contestazioni contributive, l’azienda invii memorie o richieste di riesame subito, perché anche se la legge non lo impone, potrebbe convincere l’INPS a rivedere l’atto (l’INPS ha il potere di autotutela). Inoltre, in sede giudiziale (di fronte al giudice del lavoro), l’azienda potrà sostenere che la mancanza di dialogo preventivo ha portato a un atto errato e che ciò viola i principi di correttezza. Non c’è garanzia di successo automatica per questo argomento, ma può contribuire a persuadere il giudice se l’atto appare viziato anche nel merito.
Conseguenze dell’Omesso Contraddittorio: Nullità dell’atto, Prova di Resistenza e Rimedi
Dopo aver analizzato quando il contraddittorio è obbligatorio e com’è evoluto l’obbligo, è fondamentale comprendere quali sono le conseguenze se l’amministrazione emette ugualmente un atto senza aver attivato il contraddittorio dovuto, e come il contribuente/debitore può far valere questo vizio per tutelarsi.
Nullità o annullabilità dell’atto
Come già accennato, un accertamento emesso in violazione di un obbligo di contraddittorio è affetto da un vizio che ne comporta l’invalidità. Il termine usato può essere “nullità” o “annullabilità”, a seconda dei contesti normativi: – Nel linguaggio comune si parla di atto nullo o illegittimo. Formalmente, l’art.6-bis Statuto parla di “pena di annullabilità”. Ciò significa che l’atto non è inesistente ab origine, ma può essere annullato dal giudice su ricorso del contribuente. Dunque, il contribuente deve attivarsi (non è che l’atto svanisce da solo). Se non impugna entro i termini, l’atto – per quanto viziato – diventerà definitivo e dovrà comunque essere pagato. – Nullità insanabile: La legge delega parlava di nullità, lasciando intendere un vizio grave. In dottrina, alcuni ritengono che l’omissione del contraddittorio sia un vizio di legittimità che rende l’atto nullo in senso proprio (cioè rilevabile anche d’ufficio, stante la natura di ordine pubblico del diritto di difesa). La differenza pratica però è minima perché nel processo tributario la rilevabilità d’ufficio di vizi non eccepiti è molto limitata. In ogni caso, per sicurezza, è bene dedurre sempre il vizio di contraddittorio nel ricorso introduttivo: se non lo si fa, si può incorrere in decadenza dal motivo (soprattutto ora che è un vizio “relativo”).
In passato, quando non c’era norma generale ma solo principi giurisprudenziali, la Cassazione parlava di “invalidità dell’atto” e di annullamento se prova di resistenza superata. Ad esempio Cass. SU 24823/2015 definiva l’atto IVA senza contraddittorio “invalidabile in ogni caso” a condizione etc. . Non usava il termine nullità per i tributi non armonizzati (perché non c’era obbligo) e invece parlava di invalidità per quelli armonizzati (ove c’è obbligo da fonte UE).
Oggi, con art.6-bis, possiamo affermare: – Atto emesso dopo il 2024 senza contraddittorio (pur dovuto): è annullabile, ovvero il giudice tributario su ricorso lo annulla. I giudici useranno il termine nullità in sentenza? Probabile sì (“dichiara nullo l’avviso impugnato”), anche se tecnicamente è annullabilità. L’effetto per il contribuente è che l’atto viene eliminato, come se non fosse mai stato emesso, salvo che l’Ufficio eventualmente possa rinnovarlo (vedi oltre). – Atto emesso prima del 2024 in materia armonizzata senza contraddittorio: fino al 2023 i giudici annullavano anch’essi (chiamandola nullità) se il contribuente aveva indicato le sue difese mancate . Se non le aveva indicate, rigettavano il ricorso (quindi l’atto restava valido). Quindi l’invalidità era “condizionata”. – Atto emesso prima del 2024 in materia non armonizzata senza contraddittorio: non era motivo di annullamento perché l’obbligo non c’era. Dunque ricorso incentrato solo su questo veniva respinto (o meglio neanche proposto perché si sapeva inutile, ci si concentrava su altri motivi di merito).
Un dettaglio importante: cosa succede dopo l’annullamento per difetto di contraddittorio? L’ente impositore può riprendere l’azione accertatrice rifacendo il procedimento correttamente, oppure decade per sempre la pretesa? La risposta dipende dal caso: – Se il vizio viene dichiarato dal giudice e ormai il termine di decadenza per l’accertamento è trascorso, l’ente non potrà più emettere un nuovo avviso (perché decaduto). Questo è il “rischio” per il fisco: se salta il contraddittorio e il giudizio finisce dopo anni con l’annullamento, magari non c’è più tempo per riprendere le somme. Viceversa, se dopo l’annullamento c’è ancora tempo (o l’annullamento è avvenuto in autotutela entro i termini), l’ente può notificare un nuovo atto, stavolta previa osservanza del contraddittorio. – Per i tributi armonizzati, già la CGUE disse: l’annullamento per difetto contraddittorio non impedisce all’amministrazione di reiterare il procedimento tenendo conto delle osservazioni del contribuente (caso Bensada Benallal C-161/15). Quindi l’annullamento è “procedurale” e non sostanziale; il fisco può provarci di nuovo, se è ancora nei tempi. – Esempio: avviso IVA 2022 emesso senza contraddittorio, il contribuente lo impugna, nel 2025 la Corte di giustizia tributaria lo annulla. Poiché l’anno d’imposta 2022 non è ancora decaduto (decade a fine 2027 per IVA), l’Agenzia può riemetterlo correggendo la procedura (invitando prima l’interessato etc.). Quindi il contribuente ottiene intanto l’annullamento, e poi eventualmente dovrà rilitigare sul nuovo atto (se non risolto in contraddittorio). – Se invece l’anno fosse stato ultimo e ormai la decadenza è passata, l’annullamento chiude la partita a favore del contribuente (il debito non è più recuperabile).
Nullità e processo tributario: Nel processo tributario riformato (D.Lgs. 546/1992 come mod. da D.Lgs. 156/2015 ecc.), la nullità dell’atto impositivo è uno dei motivi tipici di ricorso. I giudici non possono introdurre motivi d’ufficio nuovi (eccetto nullità assolute per difetto di notifica, ma vabbè). Il difetto di contraddittorio è causa di annullamento su eccezione di parte: deve essere il contribuente a eccepirlo subito. Non può tirarlo fuori in appello se in primo grado non l’aveva fatto (sarebbe motivo nuovo precluso). Quindi, ribadiamo: va inserito come motivo nel ricorso iniziale, ben argomentato.
Il principio della “prova di resistenza”
Abbiamo citato più volte questa espressione peculiare, è opportuno dedicarle un chiarimento autonomo. La prova di resistenza in materia di contraddittorio consiste, in sostanza, nella verifica del pregiudizio effettivo subito dal contribuente per non essere stato ascoltato. L’idea è: si annulla l’atto per omesso contraddittorio solo se quella omissione può aver avuto un’incidenza concreta sul risultato; se invece sentire il contribuente sarebbe stato del tutto inutile (perché ad esempio non aveva nulla da aggiungere, oppure perché aveva ammesso ogni addebito), allora non ha senso annullare l’atto solo per il vizio formale . È un principio di origine europea finalizzato a evitare che atti materialmente corretti vengano annullati per un formalismo innocuo .
Nella pratica processuale, la prova di resistenza ha assunto la forma di un onere a carico del contribuente: questi, impugnando l’atto viziato, deve indicare quali elementi avrebbe potuto far valere in sede preaccertativa e che avrebbero potuto portare a una decisione diversa . La Cassazione SU 2015 lo ha definito con parole complesse: le ragioni devono essere non pretestuose e tali che la loro opposizione tempestiva non appaia uno sviamento dello strumento difensivo . In parole povere, il contribuente deve addurre motivi di merito plausibili (non scuse campate in aria) che avrebbero potuto convincere il Fisco a non emettere (o a ridurre) quell’accertamento. Se lo fa, l’atto va annullato; se non lo fa, il giudice considera la violazione priva di effetto invalidante.
Applicazioni tipiche prima del 2024: – In ambito IVA, come visto, era regola ferrea: senza contraddittorio, l’atto è annullabile solo se il ricorrente indica i suoi argomenti non pretestuosi . Se omette di farlo, ricorso respinto per carenza di nocumento. – In ambito dazi, tendenzialmente anche qui veniva chiesto al contribuente di far presente il suo potenziale apporto (anche se alcune pronunce lo interpretavano come onere del fisco di provare il contrario). Ad ogni modo, raramente un importatore rimane completamente senza nulla da dire – quindi di solito la prova di resistenza era soddisfatta appena il contribuente sollevava un punto che non era stato considerato. – In ambito tributi interni (pre-riforma), la Cassazione SU 2015 escluse proprio l’obbligo, quindi non c’era spazio per prova di resistenza: il ricorrente veniva battuto sul principio, senza neppure entrare in pregiudizi perché “nessun obbligo, nessun vizio”, fine.
Situazione post-riforma: Con l’art.6-bis che sanziona direttamente la mancanza di contraddittorio con l’annullabilità, appare che la prova di resistenza non sia più richiesta in questi termini per gli atti soggetti alla nuova norma . Infatti la legge non menziona affatto un onere di allegazione del contribuente. Semmai, la relazione illustrativa accennava che il contraddittorio serve ad evitare errori e contenzioso inutile, per cui se il contribuente è annullato l’atto potrà essere rinnovato. Non c’è traccia di “il giudice annulla solo se…”. Pertanto, si può affermare che nel nuovo regime la violazione del contraddittorio è di per sé causa di annullamento senza ulteriori condizioni .
Tuttavia, dobbiamo chiederci: come si comporteranno i giudici italiani ed europei? La Corte di Giustizia mantiene fermo il principio di necessità del pregiudizio (Kamino docet). Ma ora c’è una norma interna più favorevole (che annulla ipso facto). Può il giudice italiano applicare la norma interna più favorevole se quella UE direbbe di fare un check? In realtà non c’è conflitto, perché la Corte UE ha detto che l’assenza di contraddittorio fa annullare se il procedimento poteva andare diversamente – ma non ha imposto di non annullare se il contribuente non prova niente; ha solo detto che spetta al giudice valutare. Con una legge che impone l’annullamento comunque, lo Stato italiano sta offrendo una tutela più ampia al contribuente di quella minima europea, e ciò è consentito (non infrange il diritto UE dare più garanzie). Quindi nessun problema: l’Italia può sancire nullità senza prova di resistenza e anzi lo ha fatto.
Possibili scenari residui di prova di resistenza: – Se il contribuente stesso dichiara esplicitamente di non avere nulla da eccepire nel merito dell’accertamento (ipotesi iper-teorica, perché chi fa ricorso qualcosa da dire ce l’ha), allora il giudice potrebbe dire: beh, il vizio c’è ma non ha recato pregiudizio perché il contribuente ammette tutto. In tal caso, forse si applicherebbe l’art.156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo, vizio irrilevante) e si salverebbe l’atto. Ma è molto improbabile: un “bravo difensore” non dirà mai “non avevo nulla da dire comunque” . – Se il contribuente, pur invitato a contraddittorio, non partecipa volutamente e poi impugna lamentando errori che avrebbe potuto segnalare prima: questa è la situazione opposta, contraddittorio offerto ma non sfruttato. Qui non è un difetto di contraddittorio (perché l’ente ha fatto la sua parte), però il contribuente ha perso un treno. I giudici potrebbero non vedere di buon occhio chi solleva questioni che avrebbe potuto già sollevare nella fase precontenziosa. Alcune pronunce (vd. CTR Veneto 2021) hanno affermato che se il contribuente non collabora nel contraddittorio, poi non può pretendere di far valere certi argomenti in giudizio come se niente fosse (principio di lealtà). Ma bisogna stare attenti: il contraddittorio amministrativo non toglie il diritto alla difesa tecnica in giudizio. Quindi, a nostro avviso, se pure il contribuente non ha partecipato, non perde il diritto di contestare l’atto in causa. Al più potrebbe vedersi rinfacciare che non ha prodotto prima documenti che aveva: ecco, in quel caso il giudice potrebbe valutarlo negativamente (sul piano della credibilità). – Anche nel nuovo processo tributario c’è un istituto simile alla prova di resistenza: l’art. 7, co.5-bis D.Lgs.546/92 (introdotto nel 2016) dice che “Il giudice non può annullare l’atto per vizi formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Questo è in linea col concetto: se è mero vizio formale ininfluente sul contenuto, niente annullamento. Ci si chiede se i giudici considereranno l’omesso contraddittorio un vizio “formale” a cui applicare questo 5-bis. La maggior parte dice di no: il contraddittorio incide potenzialmente sul contenuto, quindi se non c’è stato non possiamo dire che l’atto sarebbe stato identico comunque, a meno che, appunto, il contribuente ammetta la fondatezza integrale. Quindi il 5-bis non dovrebbe bloccare l’annullamento per difetto di contraddittorio (non è un semplice timbro mancante, ma un diritto difensivo violato).
Conclusione operativa per il contribuente: Anche se ora non è più obbligatorio, è fortemente consigliato indicare nel ricorso quali siano le difese che si sarebbero volute prospettare nel contraddittorio mancante . Per due motivi: 1. Convince di più il giudice mostrando che non è un mero espediente dilatorio. Ad esempio, scrivere: “Se fossi stato interpellato avrei segnalato all’ufficio che quei ricavi erano già tassati all’estero, circostanza che l’ufficio ignorava” – questo rende palese il pregiudizio. 2. Qualora in futuro si profilassero interpretazioni restrittive (o si scoprisse che la CGUE pretende comunque la valutazione del pregiudizio), il contribuente risulta aver ottemperato a quell’onere.
Inoltre, dal punto di vista pratico, inserire queste argomentazioni di merito nel motivo procedurale permette al giudice tributario, se volesse, di decidere anche sul merito (a volte i giudici preferiscono evitare sentenze di mero rito e vogliono entrare nel merito per non lasciare tutto aperto). Quindi potrebbe succedere che il giudice dica: “Sì, contraddittorio violato, atto annullabile, peraltro le eccezioni del contribuente sul merito erano fondate/infondate” ecc. Anche se formalmente, una volta riconosciuto il difetto procedurale, dovrebbe limitarsi ad annullare senza valutare il merito (che diventerebbe assorbito). Ma non tutti i collegi seguono pedissequamente questo schema; alcuni, per evitare un futuro re-accertamento, preferiscono esprimersi su tutto (il che però non è l’ortodossia processuale).
Rimedi esperibili dal contribuente
Il contribuente/debitore che si vede notificare un atto impositivo senza contraddittorio, e ritiene che invece un contraddittorio fosse dovuto, ha a disposizione essenzialmente due strade: 1. Ricorso giurisdizionale all’autorità competente, facendo valere come motivo di impugnazione la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. 2. Richiesta in autotutela all’Amministrazione, evidenziando il vizio e invitando l’ente ad annullare/revocare l’atto spontaneamente prima di andare in giudizio.
Vediamole in dettaglio.
1) Ricorso in sede giurisdizionale: È il mezzo principale di tutela. A seconda del tipo di atto: – Se trattasi di atto tributario (avviso accertamento imposte, avviso liquidazione, cartella per tributi, sanzione tributaria), la giurisdizione è quella tributaria: occorre presentare ricorso alla Commissione/CGT provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (120 giorni se si è prima esperito accertamento con adesione). Nel ricorso si dedurrà, come primo motivo (o comunque tra i motivi iniziali di forma) la violazione dell’art.6-bis L.212/2000 (se atto post-2024) oppure, se atto precedente ma su tributo armonizzato, la violazione dei principi generali UE e la conseguente invalidità . È utile citare le sentenze di Cassazione e Corte UE pertinenti (come Cass. SU 21271/2025 per chiarire il regime previgente , Cass. SU 24823/2015, Corte Cost. 47/2023 se rilevante, e magari Cass. 26974/2020 per tributi locali pre riforma , etc.). Nel ricorso, come detto, specificare le ragioni che si sarebbero dedotte in contraddittorio e che l’ente non ha potuto valutare . – Se si tratta di atto di tributo locale, sempre giudice tributario (stessa procedura, citando anche art. 1, c.3-bis Statuto se si vuole evidenziare che i comuni erano tenuti ad adeguarsi). – Se è un atto doganale/accisa, la giurisdizione è anch’essa quella tributaria (dazio e IVA import sono tributi). Quindi ricorso in Commissione con i medesimi argomenti, invocando magari specificamente l’art.22 par.6 CDU e la giurisprudenza UE (Sopropé, Kamino) come parametri violati oltre che l’art.6-bis (ormai). – Se è un atto sanzionatorio non tributario (es: ordinanza Prefetto, sanzione Antitrust), va distinto: molte andranno davanti al Giudice di Pace o al Tribunale in sede di opposizione L.689/81, oppure al TAR se di autorità amministrative indipendenti. In tali ricorsi, si invocherà la L.689/81 (art.14) e L.241/90 (art.7 e 10) a sostegno del vizio di mancato contraddittorio. Ad esempio: “Violazione dell’art.14 L.689/81: mancata previa contestazione all’interessato – violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.) – eccesso di potere per difetto di istruttoria dovuto a mancato coinvolgimento del destinatario” ecc. Questa guida è focalizzata sul tributario, ma il concetto è analogo: nel ricorso l’assenza di contraddittorio è un motivo di illegittimità.
È importante nel ricorso chiedere espressamente l’annullamento dell’atto impugnato per quel motivo, e richiedere, in via subordinata, qualunque altra tutela si ritenga opportuna (es: se per ipotesi il giudice non volesse annullare l’intero atto, potrebbe annullare parzialmente o ridurre l’importo). Nel caso del contraddittorio, di norma l’atto si annulla integralmente e bisogna rifare da zero il procedimento.
2) Autotutela: Prima di arrivare in giudizio, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’Ufficio che ha emanato l’atto, segnalando la mancanza del contraddittorio obbligatorio e chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’atto. Questa strada è volontaria per l’amministrazione: non c’è un obbligo di accoglimento. Però, se il caso è palese (ad esempio l’Ufficio stesso si accorge di aver emesso per errore un accertamento il 30 gennaio 2024 senza contraddittorio), potrebbe essere disponibile ad annullarlo in autotutela per poi rinotificarlo correttamente con invito. In genere l’autotutela è utile anche per sospendere eventualmente la riscossione in pendenza di ricorso (ma con la riforma del 2022 la riscossione dell’accertamento è sospesa ex lege se fai ricorso, quindi meno problematico di un tempo).
Vale la pena tentare l’autotutela? Dipende: se i tempi stringono, meglio depositare comunque il ricorso entro 60 giorni per non rischiare, e parallelamente presentare l’istanza di autotutela (se poi l’ente annulla l’atto spontaneamente, si potrà rinunciare al ricorso). Se i tempi lo consentono, si può anche presentare prima l’istanza e vedere. Ma attenzione: l’istanza di autotutela non sospende il termine di ricorso. Quindi non fate affidamento su quella, a meno che contestualmente non chiediate (quando previsto) l’accertamento con adesione che invece sospende.
Strumento alternativo: Accertamento con adesione. Se il contribuente riceve un avviso di accertamento senza essere stato sentito prima (nel vecchio regime, o magari anche nel nuovo se l’ufficio erroneamente non ha ottemperato), egli può presentare istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni, il che sospende i termini di impugnazione per 90 giorni e apre una fase di discussione con l’ufficio (un contraddittorio postumo, se vogliamo). Questa è un’arma a doppio taglio: da un lato consente di dialogare e magari risolvere la questione riducendo importi o producendo prove – a volte l’ufficio in sede di adesione riconosce errori e annulla l’atto o lo riduce significativamente. Dall’altro lato, qualcuno potrebbe dire: se il contribuente attiva l’adesione e discute nel merito, sanerebbe il vizio di contraddittorio iniziale perché comunque c’è stato un confronto, sia pure dopo la notifica dell’atto. La Cassazione però ha escluso che l’adesione sanifichi vizi dell’accertamento, essendo una fase diversa e eventuale: se l’adesione poi non si conclude con accordo, il contribuente può sempre impugnare l’atto e far valere i vizi originari (tra cui l’omesso contraddittorio). Quindi, il contribuente può tentare la carta dell’adesione senza per questo rinunciare alla possibilità di eccepire il difetto di contraddittorio nel successivo ricorso . Ovviamente, se in adesione emergono i punti difensivi, l’Ufficio potrebbe emettere un atto integrativo o motivare meglio: dipende. In ogni caso, è un’opzione da considerare strategicamente.
Ricapitolando i consigli pratici: – Tempestività: Non lasciar scadere i termini. Il contraddittorio è una “nullità relativa”: devi ricorrere entro 60 gg (per tributi) o entro i termini dell’autorità competente per sanzioni. Altrimenti l’atto, ancorché viziato, diviene definitivo ed esecutivo. – Completezza: Nel ricorso, formula un motivo ad hoc: ad esempio, titolo del motivo: “Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale – art. 6-bis L.212/2000 – nullità dell’atto per difetto di contraddittorio” oppure “Violazione dei diritti di difesa del contribuente (art.41 Carta UE, art.97 Cost.) – Omesso contraddittorio – Cass. SS.UU. 24823/2015” a seconda del caso. Sviluppa l’argomentazione citando la norma (nel nuovo regime, testualmente: “tutti gli atti impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da contraddittorio…”, il che qui non è avvenuto). Se applicabile, menziona eventuali eccezioni e perché non ricorrono (es: “l’atto impugnato non rientra tra quelli automatizzati esclusi né il Fisco ha motivato un’urgenza riscossiva”). Concludi che pertanto l’atto è invalido. – Argomenti di merito: Subito dopo, nello stesso motivo o separatamente, indica cosa avresti detto nel contraddittorio. E poi sviluppa gli altri motivi di merito (nel caso l’atto non venga annullato per il vizio formale, hai sempre le ragioni di sostanza). – Documentazione: Se esiste un obbligo normativo specifico (tipo un regolamento comunale che prevedeva l’invito e il Comune l’ha disatteso), allega quel regolamento o citane gli estremi. Se è Cassazione, cita le massime o i passi rilevanti . Nel processo tributario telematico puoi allegare anche le sentenze come documenti. – Comportamento in udienza: Se il giudice appare non convinto (“ma in fondo lei cosa avrebbe detto?”), ribadisci i tuoi punti di merito per far vedere che il pregiudizio c’è. Se invece il giudice è già convinto sul vizio, magari insisterà meno sul merito.
Infine, una considerazione: il contraddittorio preventivo, in un sistema ideale, dovrebbe ridurre il contenzioso perché molti errori si correggono prima, o il contribuente capisce la pretesa e magari aderisce. Quindi non è solo uno “scudo” difensivo per far annullare gli atti; può essere un momento risolutivo. Dal lato contribuente, sfruttare il contraddittorio significa spesso poter evitare proprio di arrivare al ricorso. Se l’ente accoglie le tue osservazioni, l’accertamento verrà archiviato o modificato in modo accettabile. Pertanto, il primo consiglio è: partecipare attivamente ai contraddittori quando offerti (non ignorare gli inviti credendo che sia tempo sprecato). Farlo può risolvere problemi in via amministrativa più rapidamente e senza costi di giudizio.
Domande Frequenti (FAQ) sul Contraddittorio negli Accertamenti
Di seguito proponiamo una serie di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni in materia di contraddittorio endoprocedimentale e accertamenti, specialmente alla luce delle novità normative.
D: Che cos’è esattamente il “contraddittorio endoprocedimentale” nell’ambito degli accertamenti fiscali?
R: È il diritto del contribuente (o comunque del destinatario di un provvedimento impositivo/sanzionatorio) di partecipare al procedimento amministrativo prima che sia emanato l’atto finale a suo carico. In pratica significa che l’ufficio, prima di emettere un avviso di accertamento o una sanzione, deve mettere il contribuente in condizione di conoscere le contestazioni mosse e di esporre le proprie difese (sia oralmente che per iscritto). Questo avviene tipicamente attraverso la notifica di una comunicazione o invito, contenente gli elementi emersi a carico del contribuente (es: maggior reddito accertato, imposte non versate, ecc.), e la concessione di un termine (di regola 60 giorni) per presentare osservazioni e documenti. Il contraddittorio è “endoprocedimentale” perché si svolge all’interno del procedimento amministrativo, cioè prima che l’atto venga finalizzato e notificato formalmente. Scopo del contraddittorio è garantire la partecipazione e il diritto di difesa, nonché migliorare la qualità della decisione amministrativa grazie al contributo informativo del privato . Ad esempio, se in un controllo fiscale risultano omissioni, il contribuente in contraddittorio potrebbe spiegare che in realtà certi redditi sono esenti o che c’è un errore di persona, evitando un accertamento sbagliato.
D: Quando è obbligatorio, per legge, che l’Amministrazione finanziaria attivi il contraddittorio prima di emettere un accertamento?
R: Dal 18 gennaio 2024, con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, il contraddittorio è obbligatorio in via generale per tutti gli atti tributari impugnabili, a pena di annullabilità . Fanno eccezione solo: (a) gli atti emessi in modo automatizzato o di mero controllo formale (che saranno elencati da un decreto ministeriale) , e (b) i casi di motivata urgenza per pericolo nella riscossione . Dunque praticamente tutti gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica/liquidazione, provvedimenti di irrogazione sanzioni tributarie, atti di contestazione, etc. devono essere preceduti da un invito al contraddittorio con termine di almeno 60 giorni. Prima di tale riforma, l’obbligo era frammentario: vigeva espressamente solo in alcuni casi (verifiche in loco con art.12, c.7 L.212/2000 , accertamenti standardizzati da studi di settore, alcuni tributi armonizzati per giurisprudenza). La Cassazione infatti, fino al 2023, distingueva: per i tributi armonizzati (es. IVA) l’obbligo era riconosciuto in via pretoria , per i non armonizzati no . Oggi questa distinzione non c’è più: qualsiasi accertamento fiscale deve avere il contraddittorio preventivo, salvo le due eccezioni citate. Anche i Comuni e gli enti locali devono rispettare questa regola nei loro accertamenti (IMU, TARI, ecc.), per effetto del rinvio contenuto nel novellato art.1, commi 3-bis e 3-ter dello Statuto . Oltre all’ambito tributario, esistono obblighi di contraddittorio anche in altri procedimenti amministrativi (come quelli sanzionatori in genere, ai sensi della L.689/81 e L.241/90), ma nel campo fiscale la svolta è arrivata con la riforma del 2023.
D: Il contraddittorio preventivo è richiesto anche per le cartelle esattoriali o per gli atti della riscossione?
R: In linea di massima no, gli atti della riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di mora, pignoramenti) non rientrano tra quelli soggetti a contraddittorio endoprocedimentale generalizzato. Questo perché il contraddittorio si riferisce alla formazione dell’atto impositivo (dove c’è margine di discussione sul se e quanto sia dovuto). La cartella di pagamento, invece, è un atto meramente esecutivo che deriva da qualcosa di già determinato (ruolo formatodall’ente impositore), e serve a iniziare la riscossione. Tuttavia, bisogna fare distinzione: – Se la cartella concerne tributi (es. IRPEF) e scaturisce da un controllo formale automatizzato della dichiarazione, siamo nel caso degli atti automatizzati di liquidazione: questi, per espressa previsione, sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio (art.6-bis, co.2) . Infatti, qui il contraddittorio è già incorporato nel meccanismo degli “avvisi bonari” (comunicazioni ex art.36-bis e 36-ter DPR 600/73), che sono in sostanza un contraddittorio ante-cartella: se il contribuente non risponde o paga, poi parte la cartella. – Se la cartella riguarda il recupero di un tributo a seguito di accertamento non definitivo (com’è possibile da quando gli accertamenti esecutivi rendono riscuotibile 1/3 anche se impugnati), il contraddittorio doveva essere eventualmente fatto prima dell’accertamento stesso. La cartella in sé non richiede un ulteriore contraddittorio. – Per sanzioni amministrative non fiscali (multe stradali, ecc.) che passano per cartelle, vale il procedimento proprio (di norma, contestazione immediata o possibilità di ricorso successivo, ma non un contraddittorio prima della cartella). – Un caso particolare: la cartella emessa direttamente per omesso versamento IMU (senza un precedente accertamento formale). Secondo la nuova legge, l’accertamento IMU deve avere contraddittorio; ma se un Comune saltasse l’accertamento e iscrivesse a ruolo IMU non versata, inviando cartella, sarebbe un aggiramento. Si ritiene che in tal caso la cartella sarebbe impugnabile anche per difetto di contraddittorio a monte, perché l’ente avrebbe dovuto emettere l’atto di accertamento con invito. Insomma, la cartella come titolo derivato eredita i vizi del procedimento impositivo. Se manca del tutto la fase accertativa contraddittoria obbligatoria, la cartella può essere invalidata.
In sintesi, gli atti dell’Agente della Riscossione (cartelle, intimazioni) non prevedono contraddittorio preventivo, ad eccezione di alcuni casi particolari (come il preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, introdotti da norme specifiche – es. art.77 DPR 602/73 richiede preavviso 30gg al debitore prima di ipoteca). Ma questo è un altro tipo di contraddittorio, successivo all’accertamento ed interno alla fase esecutiva. La regola del 2024 riguarda la fase di formazione del debito fiscale, non la sua esecuzione.
D: Cosa succede se l’Ufficio emette un avviso di accertamento senza aver instaurato il contraddittorio quando avrebbe dovuto? L’atto è nullo?
R: L’atto è affetto da un vizio che ne comporta l’invalidità, in particolare l’annullabilità su ricorso. In altri termini, se il destinatario impugna l’atto davanti al giudice competente deducendo la violazione del contraddittorio, il giudice dovrà annullare l’atto (salvo casi eccezionali di mancanza di pregiudizio, di cui diremo). La nuova norma (art.6-bis) esplicita che tali atti sono “annullabili” . Ciò implica che il contribuente deve attivarsi per far valere il vizio: deve proporre ricorso entro i termini previsti (60 giorni per gli atti tributari) e sollevare il motivo di difetto di contraddittorio. Se rimane inerte, l’atto – benché viziato – diverrà definitivo trascorsi i termini, e non potrà più essere contestato. Dunque non è una “nullità assoluta” rilevabile in ogni tempo, ma una nullità relativa (annullabilità) che richiede l’iniziativa del contribuente . Una volta che il giudice annulla l’atto, esso viene eliminato e perde efficacia. L’Amministrazione potrà eventualmente rinnovarlo, questa volta rispettando il contraddittorio, solo se è ancora entro i termini di decadenza per accertare (altrimenti perde la chance). Ad esempio, se un avviso 2024 viene annullato nel 2026 per questo vizio, il Fisco potrà riemetterlo correggendo la procedura, sempre che non sia scaduto il termine dell’azione accertatrice per quell’anno.
Prima del 2024, quando l’obbligo era riconosciuto solo a livello giurisprudenziale per IVA/dazi, la Cassazione diceva che la violazione del contraddittorio comportava la nullità dell’atto purché il contribuente avesse specificato le ragioni difensive che avrebbe dedotto (la cosiddetta “prova di resistenza”) . Oggi questa condizione non è più espressa dalla legge interna. Significa che tendenzialmente il giudice annullerà l’atto a prescindere dalle ragioni di merito, perché la legge parla di annullabilità in ogni caso di violazione. Tuttavia, è buona prassi per il contribuente indicare comunque quali argomenti avrebbe sollevato, così da dimostrare il concreto pregiudizio (evitando l’ipotesi di un vizio considerato formale ma ininfluente) .
D: Cos’è la “prova di resistenza” legata al contraddittorio? È ancora necessaria?
R: La “prova di resistenza” è, come detto, il test del pregiudizio: consiste nel verificare se, in assenza del contraddittorio, il contribuente abbia subito un danno concreto alle proprie difese, ossia se avesse effettivamente elementi validi da opporre che avrebbero potuto influire sull’atto . In passato, la giurisprudenza la richiedeva – specialmente per gli accertamenti IVA e doganali – come condizione per annullare l’atto: il contribuente doveva “resistere alla prova” indicando puntualmente quali fatti o argomenti avrebbe presentato e che non ha potuto presentare per colpa dell’ufficio . Se non lo faceva, l’atto veniva mantenuto valido anche se c’era stata omissione di contraddittorio . Un esempio: se l’ufficio recuperava IVA per fatture ritenute false senza sentire il contribuente, e questi in giudizio non portava alcuna giustificazione o prova contraria (limitandosi a dire “non mi hanno sentito”), la Cassazione non annullava l’atto: occorreva che il contribuente dicesse “se mi avessero sentito avrei prodotto documenti che provano la reale esistenza delle operazioni, ad esempio i contratti, i trasporti, ecc.” .
Con la nuova normativa, formalmente la prova di resistenza non è più richiesta come requisito: la legge sancisce l’annullabilità automatica senza dire “salvo che il contribuente non avesse nulla da dire”. Quindi, in teoria, il contribuente non ha più l’onere di dimostrare il pregiudizio. Tuttavia, dal punto di vista strategico, conviene sempre evidenziare quali sarebbero state le difese. Questo per due ragioni: (1) per convincere il giudice che il vizio non è meramente formale, e (2) perché il diritto UE continua a prevedere che gli atti non vadano annullati per vizi formali ininfluenti (principio del raggiungimento dello scopo). Dunque, la best practice è: nel ricorso, dopo aver eccepito il difetto di contraddittorio, specificare quali elementi si sarebbero prospettati se il contraddittorio ci fosse stato . Ad esempio: “L’atto è nullo perché l’ufficio non ha attivato il contraddittorio; il contribuente avrebbe potuto far presente, in tale sede, che i ricavi presunti dall’ufficio erano in realtà già stati tassati come proventi straordinari nell’anno precedente, circostanza documentalmente provata ma ignota all’ufficio”. In questo modo, si supera abbondantemente qualsiasi “prova di resistenza”. In conclusione, oggi la prova di resistenza è tendenzialmente assorbita nella nuova disciplina, ma il concetto rimane: se il contribuente non ha alcuna argomentazione difensiva (caso raro), l’annullamento di un atto formalmente corretto potrebbe teoricamente essere rifiutato (ma ripetiamo, succederà solo in situazioni limite).
D: Ci sono casi in cui l’Ufficio può legittimamente evitare il contraddittorio preventivo?
R: Sì, come accennato la legge prevede delle eccezioni: – Atti automatizzati e di controllo formale: se l’atto rientra in questa categoria (sarà dettagliata da un decreto ministeriale), il contraddittorio non è dovuto . Pensiamo alle liquidazioni automatiche delle imposte sui redditi o IVA sui dati dichiarati dal contribuente stesso (c.d. avvisi bonari): in tal caso già esiste una comunicazione di irregolarità a cui il contribuente può rispondere in 30 giorni. Quella è considerata una forma di contraddittorio semplificato. Quindi l’iscrizione a ruolo conseguente (la cartella) non richiede ulteriore contraddittorio. Anche gli atti di recupero di crediti d’imposta dichiarativi (bonus compensazioni indebite) possono essere considerati “automatizzati”. – Fondato pericolo per la riscossione: se l’Amministrazione ravvisa che vi è un rischio concreto che, dilatando i tempi per sentire il contribuente, questo possa sottrarsi al pagamento o rendere difficile la riscossione (ad esempio occultando patrimoni, trasferendo residenza all’estero, dissipando l’attivo), allora può emettere l’atto immediatamente, senza contraddittorio, motivando le ragioni di urgenza . Questa situazione sarà presumibilmente rara e da usare con cautela: la motivazione deve essere seria e specifica (non bastano formule generiche tipo “si teme che il contribuente non paghi”). Un esempio legittimo potrebbe essere un caso in cui il contribuente sta per fallire o sta cedendo beni e l’Erario deve cristallizzare il credito e iscrivere ipoteca subito. – Controlli “sul posto” con particolare urgenza: qui si ricollega all’art.12, c.7 Statuto, che già consentiva di saltare il termine di 60 giorni post-verifica in caso di “particolare e motivata urgenza”. Questo rimane valido: ad esempio, se durante una verifica in azienda emerge che l’impresa sta chiudendo e c’è pericolo concreto di perdita del gettito, l’ufficio può emettere l’accertamento prima dei 60 giorni (e prima di valutare le osservazioni). È una fattispecie simile al pericolo per la riscossione di cui sopra. – Altre possibili esclusioni: Va detto che l’art.6-bis, comma 2 rinvia a un decreto per individuare gli atti esclusi. C’è la possibilità che vengano esonerati altri casi di minore impatto. Ad esempio, si discute se escludere gli accertamenti parziali di importo modesto, o i rimborsi d’imposta negati (che già di per sé contengono un contraddittorio nella fase istruttoria). Ma al momento le eccezioni certe sono solo quelle due.
In ogni caso, se l’ufficio salta il contraddittorio appellandosi a un’urgenza, deve darne conto nell’atto spiegando i motivi. Se non lo fa, o se i motivi sono pretestuosi, il giudice potrà sindacare e dichiarare nullo l’atto. Dunque, l’ufficio ha sì facoltà di evitare il contraddittorio in situazioni limite, ma se ne assume la responsabilità e deve convincere che era davvero necessario.
D: Come posso difendermi se ricevo un avviso di accertamento emesso senza contraddittorio?
R: Innanzitutto, verifica che l’atto rientri tra quelli per cui il contraddittorio era obbligatorio. Se ad esempio è un avviso di accertamento IRPEF notificato nel 2025 senza alcun invito precedente, allora c’è chiaramente un vizio. Se invece è una semplice comunicazione di irregolarità (che non è un atto impugnabile definitivo), quello è parte del contraddittorio stesso, quindi non è irregolare. Oppure se è un atto emesso nel 2023 (prima della riforma) relativo a IRPEF, in quel momento la legge non imponeva contraddittorio – ma se fosse IVA la giurisprudenza lo esigeva: vedi come inquadrare il tuo caso. Una volta appurato che l’ufficio avrebbe dovuto convocarti o inviarti lo schema di atto e non lo ha fatto: – Puoi presentare una istanza di autotutela all’ente impositore, facendo presente la violazione e chiedendo l’annullamento dell’atto. A volte l’Amministrazione, riconosciuto l’errore procedurale, preferisce annullare in via di autotutela per evitare il contenzioso che perderebbe certamente. Ci sono già stati casi così in questi primi mesi del 2024. – Non attendere troppo: il termine per impugnare decorre comunque (di solito 60 giorni dalla notifica per gli atti tributari, 30 giorni per ordinanze prefettizie, ecc.). Quindi, se l’atto non viene ritirato spontaneamente in tempo utile, occorre presentare ricorso al giudice competente. Nel ricorso indicherai, come motivo, la violazione del contraddittorio. Per gli atti fiscali, citerai l’art.6-bis L.212/2000 (se applicabile temporalmente) e altre norme rilevanti (es. art.12, c.7 se era verifica in loco , oppure i principi UE per IVA/dazi , o ancora, per i locali, l’art.1, co.3-bis Statuto e magari Cass. 26886/2021 che diceva che non c’era obbligo ante, per sottolineare che post invece c’è). Il tutto accompagnato dalle argomentazioni di merito che non hai potuto esporre prima. – Richiedi al giudice l’annullamento integrale dell’atto. Se nel frattempo l’atto comporta un pagamento (ad esempio è un accertamento esecutivo che scadrebbe mentre pende il ricorso), valuta di presentare anche istanza di sospensione cautelare al giudice, sottolineando che c’è fumus boni iuris evidente data la violazione procedurale palese. – Se l’atto è una cartella per tributi, e ritieni che doveva precederla un accertamento con contraddittorio (vedi il caso dell’IMU omessa), puoi impugnare la cartella eccependo il vizio a monte (mancata emissione dell’atto presupposto contraddittorio). È un po’ più complesso proceduralmente, ma fattibile. – In parallelo, come accennato altrove, puoi decidere di presentare istanza di accertamento con adesione (per atti fiscali) entro 60 giorni, il che sospende i termini e ti dà la possibilità di avviare una discussione con l’ufficio dopo l’emissione. Questo non sana automaticamente il vizio, ma se trovi un accordo, rinunci al contenzioso e risolvi; se non lo trovi, presenti ricorso (i 60 gg iniziali + 90 sospensione = 150 gg totali di tempo, che non sono pochi). In ricorso potrai comunque lamentare il difetto originario di contraddittorio – la giurisprudenza ha confermato che l’aver esperito il tentativo di adesione non preclude poi di eccepire i vizi dell’atto .
In buona sostanza, la difesa consiste nel far valere con decisione il diritto violato. Oggi i giudici tributari sono ben consapevoli dell’importanza del contraddittorio (è stato anche oggetto di formazione specifica), quindi trovare un giudice che minimizza questo vizio è sempre meno probabile. Nel caso improbabile in cui il giudice di primo grado respinga il motivo (magari per una sua interpretazione restrittiva), valuta di proporre appello: le Commissioni Regionali (oggi CGT secondo grado) e la Cassazione hanno fissato principi piuttosto netti pro-contribuente sulla questione. Ad esempio, la Cassazione a Sezioni Unite nel 2025 ha ribadito che ante riforma l’obbligo c’era solo per IVA con prova resistenza e post riforma c’è per tutti . Quindi hai buone basi normative e giurisprudenziali per far valere le tue ragioni.
D: Il contraddittorio preventivo si applica anche alle sanzioni tributarie (per es. le sanzioni per infedele dichiarazione)?
R: Sì. Poiché le sanzioni amministrative tributarie (quelle non penali) sono atti impugnabili davanti al giudice tributario, rientrano a pieno titolo nell’art.6-bis. In pratica, se l’ufficio intende irrogare una sanzione tributaria (ad esempio per omessa fatturazione IVA o per infedele dichiarazione), deve attivare il contraddittorio. Spesso l’irrogazione delle sanzioni è contestuale all’accertamento del tributo. In tal caso, l’invito a contraddittorio riguarderà sia la maggiore imposta che le sanzioni proposte. Non serviranno due inviti separati. Ma se, ipoteticamente, l’ufficio volesse emanare un atto di solo irrogazione sanzioni (capita, ad esempio, quando le sanzioni vengono irrogate in un momento diverso dal recupero del tributo), anch’esso andrà preceduto da contraddittorio. Questo è coerente con la logica della delega fiscale, che parlava di contraddittorio generalizzato “per tutti gli atti impositivi e sanzionatori” a pena di nullità . Aggiungerei che, al di là dello Statuto, anche la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo (art.6 CEDU) e la Carta UE riconoscono che, quando si tratta di sanzioni assimilabili a penali (le sanzioni tributarie talvolta lo sono come natura), il diritto di difesa deve essere garantito. Quindi, doppia tutela. In concreto: se ricevo un atto di irrogazione di sole sanzioni tributarie (mettiamo, un provvedimento che mi contesta sanzioni per indebite compensazioni, emesso nel 2025, senza avermi interpellato prima), quell’atto è annullabile per difetto di contraddittorio tanto quanto un accertamento. Idem per un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che propone sanzioni amministrative: la GdF deve farmi firmare il verbale e poi c’è la fase di controdeduzioni ex art.12, c.7 (che si applica anche alle sanzioni connesse ai rilievi).
D: Se il contribuente viene invitato al contraddittorio ma non si presenta o non invia osservazioni, perde qualche diritto in seguito?
R: No, non perde il diritto di difendersi in giudizio. La partecipazione al contraddittorio è una facoltà, non un obbligo imposto al contribuente. Quindi, se questi non ne approfitta, potrà comunque impugnare l’atto successivo e far valere in quella sede tutte le sue ragioni. Tuttavia, occorre riflettere: ignorare il contraddittorio non è consigliabile, perché: – Si perde l’occasione di chiarire possibili malintesi o di offrire elementi che potrebbero evitare il contenzioso. – L’ufficio, non ricevendo risposte, emanerà l’atto con i soli elementi a sua disposizione, magari irrigidendosi. – In giudizio, se il contribuente tira fuori per la prima volta documenti o argomenti che avrebbe potuto presentare nel contraddittorio, l’ente potrebbe sostenere che sono tardivi o che denotano poca buona fede. Non c’è un automatismo legale su questo (il giudice deve comunque valutarli), però sul piano psicologico non giova. – Inoltre, alcune Commissioni Tributarie hanno affermato che se un contribuente non partecipa al contraddittorio, poi non può lamentarsi di eventuali difetti del provvedimento che avrebbe potuto far correggere prima. Questo non è un limite giuridico, è più che altro un discorso di equità: chi è stato silente quando poteva parlare, difficilmente convincerà poi il giudice che quell’ascolto gli avrebbe giovato, visto che non ha nemmeno provato.
In sintesi: non si perde il diritto al ricorso né ad alcuna eccezione, ma è saggio non arrivare a tanto. Meglio partecipare al contraddittorio e mettere subito sul tavolo le proprie difese. Soltanto nel caso in cui il contribuente, per ragioni strategiche, preferisca non scoprire le proprie carte (magari perché sta raccogliendo prove che ancora non ha), potrebbe voler tacere. Ma attenzione: oggi, con l’art.6-bis, anche se il contribuente non risponde nulla all’invito, l’atto uscirà trascorsi i 60 giorni e non potrà essere annullato per vizio procedurale, perché il contraddittorio è stato formalmente attivato (è il contribuente che non ne ha usufruito). Quindi tacere non dà alcun vantaggio processuale. Piuttosto, se non si hanno elementi pronti entro 60 giorni, conviene chiedere all’ufficio una proroga (spesso la concedono) o quantomeno depositare una memoria in cui si anticipa che ulteriori elementi saranno portati in giudizio.
Dunque, il consiglio universale: partecipate al contraddittorio preventivo. È un vostro diritto, esercitarlo non vi precluderà successivamente nulla, e anzi potrebbe risolvere la questione prima, oppure mettere agli atti elementi favorevoli che poi, se ignorati, saranno un’arma in più in giudizio.
D: Quali atti sono considerati “automatizzati” e quindi esclusi dal contraddittorio?
R: Al momento (ottobre 2025) le categorie di atti automatizzati esclusi dal contraddittorio non sono ancora state ufficialmente enumerate in un decreto ministeriale definitivo (anche se una bozza esiste). In base all’art.6-bis, co.2, possiamo delineare però cosa si intende: – Atti “automatizzati” o “sostanzialmente automatizzati”: sono quegli atti emessi senza un effettivo intervento valutativo dell’ufficio, ossia generati da procedure informatiche sulla base di dati certi. Esempi classici: gli avvisi di liquidazione emessi ex art.36-bis DPR 600/73 (controllo automatico delle dichiarazioni, dove si correggono errori aritmetici, si recuperano importi non versati risultanti dal confronto con i versamenti, ecc.), oppure gli avvisi ex art.36-ter (controllo formale delle dichiarazioni, dove l’ufficio chiede e rettifica documentazione detrazioni/deduzioni). In questi casi, già la legge prevedeva l’invio di una comunicazione di irregolarità (il famoso “avviso bonario”) che costituisce di fatto un mini-contraddittorio: il contribuente può pagare con sanzioni ridotte o segnalare eventuali errori dell’ufficio entro 30 giorni. Dunque, un contraddittorio c’è già (anche se dopo l’elaborazione iniziale). Probabilmente il MEF nella sua lista includerà questi atti. – Atti di “pronta liquidazione”: potrebbe riferirsi agli avvisi di liquidazione per imposte relative a formalità dove l’imposta è autoliquidata dall’utente (per esempio imposta di registro autoliquidata dai notai, dove se c’è differenza viene fuori automaticamente). In generale, atti dove l’ufficio si limita ad applicare tariffe o calcoli su dati forniti dal contribuente. – Atti di controllo formale individuati con DM: come sopra, gli esiti di controlli formali ex 36-ter, oppure gli esiti dei controlli formali sulle agevolazioni (tipo controllo dei requisiti dei bonus prima di erogare i rimborsi). – Un esempio esplicito: la norma delega n.111/2023 menzionava “fuori dei casi dei controlli automatizzati e formali” . Quindi la volontà è di escludere proprio le comunicazioni automatiche (dichiarazione dei redditi, LIPE IVA etc.). Per quelle, in effetti, la compliance avviene già con avvisi bonari e ravvedimento.
Altri atti che potrebbero essere esclusi: – Avviso di liquidazione per omesso/tardivo versamento di imposta sostitutiva (ad esempio liquidazione imposta sostitutiva sui TFR, che è un atto che l’Agenzia fa in base a dati INPS, poco valore aggiunto). – Richieste di documenti (che non sono atti impositivi in sé, ma a scanso di equivoci potrebbero nominare che un semplice invito art.32 a esibire documenti non è atto impugnabile, quindi non rientra). – Provvedimenti di rimborso negativi? Non sono proprio “automatizzati”, e sono impugnabili. Forse no, quelli implicano valutazioni, quindi contraddittorio sì.
In attesa di elenco ufficiale, diciamo che tutti gli atti derivanti da mero controllo informatico delle dichiarazioni sono esclusi, mentre gli accertamenti veri e propri (che implicano un giudizio e un calcolo nuovo) sono inclusi.
D: Il nuovo obbligo di contraddittorio allunga i tempi dell’accertamento?
R: Sì, potenzialmente sì, ma il legislatore ha predisposto un meccanismo per compensare. Normalmente, l’ufficio deve attendere almeno 60 giorni dal momento in cui invia lo “schema di atto” al contribuente prima di poter emanare l’accertamento definitivo . Quindi c’è un tempo di attesa fisiologico aggiuntivo. Tuttavia, per evitare che questo causi la decadenza dei termini di accertamento (che di solito scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo), la legge prevede che se il termine di decadenza cade mentre è in corso o subito dopo il contraddittorio, esso venga prorogato di 120 giorni . In pratica: – Se l’ufficio invia un invito al contraddittorio il 30 ottobre e il termine di decadenza per accertare quell’anno scade il 31 dicembre, è ovvio che aggiungendo 60 giorni si andrebbe oltre. Quindi la norma sposta in avanti la scadenza al 120° giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio. – Questo significa che l’ufficio avrà tempo fino circa a fine aprile dell’anno seguente per emettere l’atto (120 giorni dopo fine dicembre). Così i 60 giorni di contraddittorio “stanno dentro” senza pregiudizio. – Se invece l’ufficio muove con più anticipo, diciamo a giugno, i 60 giorni finiscono ad agosto e c’è ancora margine fino a dicembre, quindi nessun problema. La proroga di 120 giorni scatta solo quando necessario (è condizionata).
Nei casi in cui il contraddittorio si conclude molto a ridosso dei termini di decadenza, c’è un particolare: la norma dice che “se tra la fine del contraddittorio e il termine di decadenza ci sono meno di 120 giorni, il termine è posticipato di modo che ci siano comunque 120 giorni” . Questo per garantire all’ufficio almeno 4 mesi di tempo per valutare le osservazioni e procedere, scongiurando la fretta. Quindi, sì i tempi del procedimento sono più lunghi, ma i termini di legge per l’accertamento sono automaticamente prorogati di riflesso, così l’Erario non perde gettito per via del contraddittorio. L’effetto pratico per il contribuente è che potrà ricevere avvisi anche oltre la fine dell’anno, entro quel supplemento di 120 gg, quando il contraddittorio è avviato a fine anno.
Ad esempio, molti inviti a contraddittorio per l’anno d’imposta 2018 (il cui termine di decadenza originario era 31/12/2023) sono stati notificati a fine 2023; se il contraddittorio è avvenuto nei primi mesi 2024, gli avvisi definitivi possono arrivare entro fine aprile 2024 grazie a questa estensione, e saranno ancora tempestivi. Senza la norma, sarebbero decaduti.
In definitiva, dal lato del contribuente, c’è un vantaggio in termini di tempi di difesa (hai 60 giorni per preparare controdeduzioni, invece l’avviso prima poteva arrivare senza preavviso), ma c’è anche da aspettarsi che gli accertamenti possano arrivare un po’ più tardi rispetto al passato, proprio per il meccanismo di posticipo.
D: Se l’Ufficio ha rispettato la procedura di contraddittorio (mi ha invitato e io ho presentato le mie osservazioni) ma poi nell’accertamento finale non ha tenuto conto di nulla e non ha nemmeno risposto alle mie osservazioni, posso far annullare l’atto?
R: Questo tocca il tema dell’obbligo di motivazione. L’art.6-bis comma 4 impone che l’atto definitivo “tenga conto delle osservazioni del contribuente” e sia motivato con riferimento ai rilievi che l’ufficio non intende accogliere . Ciò significa che se tu contribuente hai presentato, poniamo, 5 osservazioni nel contraddittorio, l’avviso di accertamento che arriva deve in qualche modo rispondere a quelle: magari accoglierne alcune (correggendo l’atto di conseguenza) e rigettarne altre spiegandone il perché. Se l’ufficio emette invece l’atto come se nulla fosse, ignorando del tutto le tue memorie, allora l’atto è viziato per difetto di motivazione e per violazione di legge (non ha adempiuto al comma 4). In giurisprudenza, già prima della riforma, si annullavano atti post-contraddittorio se l’Amministrazione non confutava le difese. Ad esempio, Cass. 701/2020 ha annullato un accertamento perché l’ufficio aveva copiato-incollato il PVC senza rispondere alle osservazioni presentate dal contribuente nei 60 giorni (violando art.12,7 Statuto che implicitamente richiede di valutare e replicare a quelle osservazioni) . Ora con la norma esplicita, a maggior ragione: un avviso che ignora le tue controdeduzioni è illegittimo per difetto di motivazione, e potrai impugnarlo chiedendone l’annullamento. In pratica, siamo in un caso un po’ diverso dall’omesso contraddittorio: qui il contraddittorio c’è stato ma non è stato “effettivo” perché l’ente non lo ha considerato effettivamente. È come un processo dove il giudice non esamina le prove della difesa: vizio di motivazione della sentenza.
Quindi sì, potrai far valere questo vizio. Attenzione però: se l’ufficio ha risposto in modo sintetico ma c’era molto da dire, non è che l’atto è nullo solo perché la risposta è breve; l’importante è che emerga che ha letto e valutato. Per esempio: “Il contribuente ha eccepito A, B, C; si osserva che A è infondato perché…; B non è pertinente; C è parzialmente accolto riducendo la pretesa di X euro.” Questo basta come motivazione. Se invece neanche menziona A, B, C e mantiene integralmente, è annullabile. Spesso, comunque, se l’ente non considera un’osservazione rilevante, il giudice se ne accorge e lui stesso annulla l’atto per errore di valutazione di merito (oltre che vizio di motivazione). Ad ogni modo, si configura un vizio sia procedurale (violazione art.6-bis, co.4) sia sostanziale (violazione art.3 L.241/90 sulla motivazione, e art.7 D.Lgs.546/92 che richiede atti motivati).
D: Questa nuova disciplina del contraddittorio potrebbe essere considerata retroattiva o applicabile a procedimenti iniziati prima?
R: No, la nuova disciplina non è retroattiva. Vale per gli atti emessi dopo la sua entrata in vigore (18/1/2024). Un atto notificato nel 2023 non può essere impugnato sostenendo la violazione dell’art.6-bis (che allora non esisteva). La Corte di Cassazione, come visto, con SU 21271/2025 ha proprio chiarito che gli accertamenti “a tavolino” antecedenti l’art.6-bis restano disciplinati dalle regole previgenti . Quindi, se hai un contenzioso in corso su un accertamento 2019, ad esempio, non potrai invocare la nuova legge, ma solo le tesi in base ai principi all’epoca (se tributo armonizzato potresti far leva sulla giurisprudenza comunitaria, se non armonizzato niente contraddittorio generalizzato). Di converso, tutti gli atti emanati da quella data in poi devono uniformarsi. Non ci sono eccezioni: anche per annualità pregresse se l’atto esce dopo gennaio 2024, occorre il contraddittorio. Ad esempio, un accertamento relativo al 2018 ma notificato a febbraio 2024 è soggetto a 6-bis (e infatti molti uffici a fine 2023 hanno mandato inviti per accertamenti di anni passati che dovevano notificare nel 2024).
Non c’è quindi retroattività in senso proprio, ma è chiaro che la riforma incide anche su procedimenti in corso a cavallo dell’anno: se al 18/1/24 il tuo controllo non era ancora culminato in un atto, l’ufficio da quel momento in poi doveva adeguarsi alla nuova procedura. C’è stata qualche discussione su “se l’invito è partito prima del 18/1 ma l’atto esce dopo, vale comunque?“. La risposta ragionevole è che contano gli atti emessi da quella data. Quindi anche se ti avessero ascoltato prima senza un obbligo, va benissimo. Non c’è un pregiudizio per te. In sintesi, per impugnare devi far riferimento allo stato della normativa (o della giurisprudenza) vigente quando l’atto è stato emanato.
Tabella riepilogativa – Contraddittorio: prima e dopo la riforma 2023
Per meglio visualizzare le differenze tra il regime previgente e quello attuale, riportiamo una tabella riepilogativa sui principali tipi di accertamento e la necessità del contraddittorio.
| Tipologia di Atto/Procedimento | Contraddittorio – Fino al 2023 | Contraddittorio – Dal 2024 (art.6-bis) | Riferimenti normativi/giurisprudenziali |
|---|---|---|---|
| Verifica fiscale in loco (accesso Guardia di Finanza/Agenzia in azienda) – segue avviso di accertamento | Obbligatorio attendere 60 giorni dal verbale finale, salvo urgenza. Omissione = nullità dell’atto. | Rimane obbligatoria l’attesa 60 gg ex art.12 c.7; inoltre l’atto finale deve considerare le osservazioni. (Art.6-bis si coordina con art.12, c.7) | Art. 12, co.7 L.212/2000 ; Cass. SS.UU. 18184/2013 (nullità “ante tempus”). |
| Accertamento “a tavolino” – tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP) | NO obbligo generalizzato (salvo studi di settore). L’atto poteva essere emesso senza contraddittorio. | SÌ obbligo sempre. Invito con schema di atto e ≥60 gg per memorie, pena annullabilità se omesso. | Cass. SS.UU. 24823/2015 (nessun obbligo generale pre-riforma) ; Art.6-bis L.212/2000 (dal 2024) . |
| Accertamento fondato esclusivamente su studi di settore/ISA | Sì, obbligo di invito a comparire per contraddittorio (ex art.10, co.3-bis L.146/98). Omissione = nullità. Se studi non esclusivi, obbligo non applicato . | Sì, rientra nell’obbligo generale (oltre che in norme specifiche eventualmente vigenti). | Art.10, co.3-bis L.146/1998; Cass. 268/2020 e 24783/2025 (se plurifattoriale, no obbligo ante). |
| Accertamento IVA (tributo armonizzato) – a tavolino | Sì per principio giurisprudenziale UE: obbligo di contraddittorio. Omissione = nullità dell’atto se contribuente indica le difese non presentate (prova di resistenza) . | Sì, obbligo per legge nazionale, senza più necessità formale di prova di resistenza (anche se opportuno indicare difese). | Cass. SS.UU. 24823/2015 (obbligo IVA con prova res.) ; CGUE Sopropé 2008 , Kamino 2014 ; Art.6-bis L.212/2000. |
| Accertamento Doganale (dazi) | Sì per normativa UE (art.22 CDU) e giurisprudenza. Contraddittorio obbligatorio prima della liquidazione dei dazi. Omissione = annullamento atto (di regola richiesto pregiudizio, raramente non c’è). | Sì, obbligo (coperto già da norme UE; art.6-bis rafforza ma era già prassi). Prova di resistenza: non formalmente richiesta ma vale discorso generale UE. | Art. 22.6 Reg. UE 952/2013 (Codice Doganale); CGUE Kamino 2014; Cass. 10658/2011. |
| Accertamento Accise (tributi armonizzati) | Sì in base a direttive UE e principio generale di difesa. (Spesso previsto da norme settoriali). Omissione = vizio (giurisprudenza analogica alle dogane). | Sì, obbligo generale ex lege. (Molto simile a dogane: contraddittorio era già garantito per prassi). | Dir. 2008/118/CE e succ. (accise); Cass. 20068/2019. Art.6-bis L.212/2000. |
| Tributi Locali (IMU, TARI, TASI, ICP, etc.) | NO obbligo generalizzato (nessuna norma previgente). Accertamenti emessi senza contraddittorio considerati legittimi . (Solo facoltà per Comune di chiedere info). | SÌ obbligo ora esteso anche a enti locali. Invito al contribuente e 60 gg anche per avvisi IMU/TARI ecc., pena annullabilità. | Cass. 26886/2021 (no obbligo ante per TARSU) ; Cass. 14357/2022 (no obbligo per trib. locali ante). Art.1, co.3-bis L.212/2000 (introdotto da D.lgs.219/23) ; Art.6-bis L.212/2000. |
| Sanzioni Tributarie (escluse penal-tributarie) | Caso per caso: per es., obbligo di contraddittorio per sanzioni da studi di settore (sì, derivando da accertamento). In generale, se parte di accertamento fiscale, seguivano regime dell’accertamento (nessun obbligo se tributo non armonizzato). | Sì, obbligo anche per atti di irrogazione sanzioni autonomi. (In pratica, rientrano tra “atti impugnabili”). L’invito riguarderà anche le sanzioni collegate. | Delega L.111/2023 parla di atti sanzionatori; art.6-bis include atti impugnabili (sanzioni lo sono, in CTR). Cass. 10811/2016 (su obbligo contraddittorio in sanzioni IVA ante). |
| Sanzioni amministrative non tributarie (ordinanze-ingiunzioni Prefetto, sanzioni autorità) | Sì, di regola previsto da L.689/81: obbligo di contestazione e 30 gg per difese prima di ordinanza. Omissione = vizio procedurale (ordinanza annullabile dal giudice). (Per multe CdS: contraddittorio ex post via ricorso). | (Fuori ambito L.212/2000) – Rimane disciplina L.689/81 e L.241/90. La riforma fiscale non cambia queste procedure. | Art.14 L.689/1981 (diritto difesa nelle sanzioni amm.ve); art.7 e 10 L.241/1990. Giurisdizione GdP/Tribunale/TAR secondo materia. |
| Contributi previdenziali (INPS, INAIL) | No obbligo da Statuto (non applicabile). Prassi ispettiva: consegna verbale e 30 gg per osservazioni prima di avviso, ma non sancito da norma (dal 2021 abrogato obbligo 60gg). Omissione contraddittorio valutata caso per caso dai giudici (non diritto soggettivo chiaro). | (Fuori ambito L.212/2000) – Nessun obbligo introdotto dalla riforma tributaria. Si applicano solo principi generali di buona amministrazione (L.241/90) se invocabili. | – (Art.4 DM 11/2011 abrogato). Cass. civ. sez.lav 15398/2014 (esclude estensione art.12 Statuto a INPS). Possibile evoluzione futura a favore contraddittorio. |
(Legenda: NO = non obbligatorio; SÌ = obbligatorio. “Ante” = situazione prima della riforma 2023; “Post” = situazione dopo.)
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio come applicare questi concetti nella realtà, esaminiamo alcuni casi pratici simulati, dal punto di vista di un contribuente (debitore) che si trova ad affrontare accertamenti senza contraddittorio, e vediamo come potrebbe svolgersi la difesa.
Caso 1: Accertamento IRPEF 2019 notificato nel 2023 senza contraddittorio
Scenario: La ditta individuale Alfa riceve a novembre 2023 un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2019, con cui si rettificano i ricavi in base a indagini finanziarie (movimenti bancari non giustificati) e si richiedono €50.000 tra maggiori imposte e sanzioni. L’avviso è stato emesso “a tavolino”, senza che prima l’Agenzia inviasse alcuna comunicazione o richiesta di chiarimenti ad Alfa sulla questione. Alfa rimane sorpresa perché avrebbe potuto spiegare che molti versamenti sul conto riguardavano prestiti di famiglia e non ricavi non dichiarati, ma non le è stato chiesto nulla prima.
Analisi: L’anno 2019, atto notificato nel 2023, quindi prima della vigenza di art.6-bis. Tributo: IRPEF (non armonizzato). Secondo la giurisprudenza 2015-2023, non vi era obbligo legale di contraddittorio per questo tipo di accertamento a tavolino, e il mancato invito non è, di per sé, motivo di nullità . Alfa può sicuramente lamentare una scorretta prassi dell’ufficio, ma giuridicamente non ha un appiglio normativo forte. Non può invocare art.6-bis (non ancora in vigore), né il principio UE (IRPEF non è tributo armonizzato). Dovrebbe sperare in un revirement giurisprudenziale, assai improbabile stante SU 2015.
Come difendersi: La strategia difensiva di Alfa dovrà puntare principalmente sul merito: fornire in ricorso (alla Commissione tributaria) tutte le prove che quei versamenti non erano reddito tassabile (es. contratti di mutuo tra familiari, prove documentali dei prestiti, ecc.). Può menzionare nel ricorso che l’ufficio, a suo avviso, ha violato i principi di collaborazione e buona fede (art.10 Statuto) non instaurando un contraddittorio, ma è consapevole che, sul piano legale, ciò non è causa di nullità dell’atto . Dovrà quindi concentrarsi su vizi di motivazione (se l’avviso non spiega le ragioni) e sull’assenza di presupposti (i movimenti non erano reddito). In udienza potrebbe argomentare che se fosse stato sentito prima l’accertamento non sarebbe proprio stato emesso, evidenziando una certa iniquità procedurale; però sa che i giudici si atterranno al diritto vigente. Probabilmente il ricorso di Alfa verrà deciso entrando nel merito: se porta prove convincenti, potrà vincere; altrimenti perderà. Il difetto di contraddittorio in sé non porterà all’annullamento (lo conferma il fatto che tante sentenze ante 2024 su IRPEF danno ragione al Fisco su questo punto, vedi Cass. 26974/2020 ).
Esito atteso: L’esito dipenderà dal merito. Poniamo che Alfa riesca a dimostrare con estratti conto e scritture private che €30.000 su €50.000 erano prestiti non reddituali: il giudice potrebbe accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’accertamento di conseguenza. Magari condannerà l’ufficio alle spese se ritiene che non aver dialogato prima sia stato un comportamento censurabile che ha gonfiato il contenzioso. Ma non annullerà l’intero atto solo perché è mancato il contraddittorio, vista la giurisprudenza applicabile al 2019. Alfa quindi ottiene giustizia sul quantum ma non sul principio procedurale (che però varrà per il futuro).
Caso 2: Avviso di accertamento IVA 2022 notificato nel luglio 2023 senza contraddittorio
Scenario: La società Beta Srl subisce un accertamento IVA per l’anno 2022 (quindi tributo armonizzato) notificato a metà 2023. L’oggetto: l’ufficio contesta indebitamente detrazioni IVA su alcune fatture, ritenute soggettivamente inesistenti (fornitore ritenuto cartiera). Beta non era stata informata prima: né un PVC, né un questionario sulle fatture; l’accertamento arriva “a sorpresa” con richiesta di IVA e sanzioni. Beta avrebbe potuto portare elementi a difesa (es. prove che le operazioni erano reali, documenti sul fornitore, ecc.).
Analisi: Tributo IVA, anno 2022, atto pre-riforma (luglio 2023). Secondo Cass. SU 2015, qui c’era un obbligo di contraddittorio per derivazione comunitaria . La violazione comporta invalidità dell’atto se Beta dimostra in giudizio quali argomenti avrebbe sollevato a sua discolpa . Dunque Beta ha un buon appiglio procedurale: l’accertamento IVA senza contraddittorio endoprocedimentale è illegittimo, a meno che Beta non abbia alcuna difesa sostanziale (ma Beta le ha).
Come difendersi: Beta presenterà ricorso alla Commissione tributaria, eccependo in limine la violazione dei diritti di difesa UE e del principio di contraddittorio. Richiamerà la giurisprudenza: CGUE Sopropé (2008) che sancisce il diritto di essere sentiti ; CGUE Kamino (2014) che prevede l’annullamento se il procedimento poteva andare diversamente ; Cass. SU 24823/2015 che in materia IVA richiede l’onere per il contribuente di indicare le proprie difese pretermesse . Beta nel ricorso elencherà accuratamente le prove e ragioni che avrebbe addotto: ad es. che il fornitore non è fittizio perché esistevano DDT, pagamenti tracciati, ecc., e che l’IVA è stata effettivamente versata dall’emittente. Allegando tali elementi, Beta supera la “prova di resistenza”. È probabile che il solo vizio di contraddittorio convinca la Commissione a annullare l’atto integralmente, rinviando l’ufficio eventualmente a rinnovarlo se ancora in termini. In effetti, varie sentenze di merito già prima della riforma annullavano accertamenti IVA per omesso contraddittorio, a fronte di contestazioni non pretestuose del contribuente .
Esito atteso: La Commissione potrebbe accogliere il ricorso di Beta dichiarando nullo l’avviso per violazione del diritto al contraddittorio, dato che Beta ha evidenziato elementi che avrebbero potuto incidere sull’accertamento e l’ufficio l’ha privata della possibilità di farli valere . L’ufficio magari in giudizio proverà a sostenere che Beta sapeva benissimo della frode e che comunque le sue osservazioni non avrebbero cambiato l’esito (tentando di negare il pregiudizio), ma spetterà al giudice valutare: se Beta ha presentato elementi solidi, la Commissione non li può ignorare e constaterà che sentire Beta prima poteva portare a escludere almeno parte della pretesa. Dunque annullerà l’atto. L’Agenzia delle Entrate, a quel punto, se ancora nei termini (per l’anno 2022 c’è tempo fino a fine 2027), potrebbe riemettere un nuovo accertamento IVA rifacendo la procedura correttamente: cioè inviando un “Invito al contraddittorio” a Beta (anche se nel 2023 non c’era art.6-bis, potrà farlo come autotutela) per poi emanare un atto rivalutato. Beta, però, nel frattempo avrà guadagnato tempo e avrà potuto circoscrivere la contestazione.
Caso 3: Accertamento per redditi 2024 notificato nel 2025 senza contraddittorio
Scenario: Il contribuente Gamma riceve a ottobre 2025 un avviso di accertamento sintetico (redditometro) per l’anno d’imposta 2024: l’Agenzia ritiene, in base alle spese sostenute (acquisto auto di lusso, barca, etc.), che Gamma abbia avuto un reddito non dichiarato significativo. L’avviso richiede maggior IRPEF e addizionali per €30.000. Prima di emetterlo, però, l’ufficio non ha inviato alcun invito al contraddittorio, nonostante la legge prevedesse (anche prima della riforma, in verità) l’obbligo di sentire il contribuente in caso di accertamento sintetico (art.38 DPR 600/73 modif. dal 2010). Gamma era del tutto all’oscuro e avrebbe potuto spiegare che alcune di quelle spese (es. l’auto) sono state sostenute grazie a risparmi pregressi o donazioni dei genitori, e non con reddito 2024.
Analisi: Anno 2024, atto emesso nel 2025, tributo IRPEF. Qui art.6-bis si applica a pieno . L’ufficio avrebbe dovuto inviare a Gamma uno schema di accertamento sintetico e attendere 60 giorni per le sue prove (cosa peraltro già obbligatoria per normativa specifica del redditometro). L’omissione del contraddittorio rende l’atto annullabile ipso iure.
Come difendersi: Gamma farà ricorso alla neo-istituita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, invocando esplicitamente l’art.6-bis L.212/2000: “tutti gli atti impugnabili sono preceduti a pena di annullabilità da contraddittorio”, cosa che qui non è avvenuta . Inoltre citerà l’art.38, co.7 DPR 600/73 (che impone di invitare il contribuente a spiegare le spese prima di emettere accertamento sintetico). È un caso dove c’è doppia violazione. Nel ricorso Gamma indicherà le fonti esenti da tassazione che spiegano le spese (risparmi, donazione). Quindi anche sul merito ha elementi. Probabilmente l’ufficio, realizzato l’errore procedurale, potrebbe persino annullare in autotutela l’accertamento appena riceve il ricorso, per poi rifarlo correttamente (infatti la Circolare interna dell’AdE sulla riforma invita gli uffici a non intestardirsi in cause perse ma rifare piuttosto l’atto). Se ciò non avviene, la Corte tributaria quasi certamente annullerà l’accertamento per vizio di contraddittorio, senza neanche bisogno di esaminare il merito (che rimane assorbito).
Esito atteso: L’atto di accertamento sintetico 2024 di Gamma verrà annullato integralmente dalla Corte, per violazione di legge (art.6-bis Statuto) e difetto di procedura. L’Ufficio potrà riemetterlo (il termine di decadenza per il 2024 è fine 2029, quindi c’è tempo) ma dovrà prima convocare Gamma, il quale nel contraddittorio post-sentenza porterà i documenti che giustificano le spese. Non è escluso che, valutati tali documenti, l’ufficio rinunci a un nuovo accertamento o lo ridimensioni. In ogni caso, Gamma avrà evitato, grazie alla tutela del contraddittorio, di subire un accertamento sbagliato senza essere ascoltato: nel peggiore dei casi, subirà un secondo accertamento basato su elementi più accurati (il che è comunque un miglioramento rispetto al primo).
Caso 4: Avviso di rettifica Doganale (dazi all’importazione) emesso senza previa comunicazione
Scenario: La società ImportX importa merci dalla Cina. Nel 2025, l’Agenzia Dogane svolge un controllo a posteriori sulle bollette del 2024 e ritiene che alcune merci fossero classificate con voce doganale errata (aliquota dazi 5% anziché 12%). Senza inviare alcuna comunicazione di accertamento o avviso di revisione, l’Agenzia notifica direttamente un Avviso di pagamento dazi chiedendo €100.000 di dazi in più, più IVA e interessi. ImportX, che pure durante i controlli aveva collaborato fornendo documenti, non aveva però ricevuto un verbale conclusivo né la possibilità di contradditorio formale.
Analisi: Materia doganale, pieno ambito UE: l’art.22.6 del Codice Doganale dell’Unione impone l’audizione del destinatario prima di adottare una decisione sfavorevole . La giurisprudenza comunitaria e nazionale considera ciò un diritto fondamentale. L’omissione di questo passaggio rende la decisione (avviso di pagamento) illegittima, salvo che l’Amministrazione provi in giudizio che ascoltare ImportX non avrebbe cambiato nulla. ImportX sostiene invece che, se avvisata, avrebbe potuto produrre un Binding Tariff Information (parere tariffario) della UE o altre perizie che confermano la correttezza della classificazione originale. Quindi il pregiudizio c’è.
Come difendersi: ImportX farà ricorso alla Corte tributaria (giudice competente anche per dazi), eccependo la violazione dell’art.41 Carta UE (diritto a buona amministrazione e difesa) e dell’art.22 CDU. Richiamerà la sentenza Sopropé e altre, evidenziando che in ambito doganale il contraddittorio è obbligatorio ex se e che la Cassazione da anni annulla avvisi doganali emessi senza avviso di accertamento e senza attendere le osservazioni (citando ad es. Cass. 17396/2010). Nel ricorso, ImportX dettaglierà quali prove avrebbe addotto (per esempio: una consulenza tecnica sul prodotto importato che conferma la classificazione a 5%). Vista la mole di motivazioni, è assai probabile che l’Avvocatura dello Stato stessa riconoscerà il vizio. Il giudizio potrebbe chiudersi con una sentenza che annulla l’avviso di pagamento dazi per violazione dei diritti di difesa dell’importatore.
Esito atteso: L’avviso di rettifica doganale sarà annullato. L’Agenzia Dogane potrà procedere a nuova revisione dell’accertamento: dovrà notificare a ImportX un Avviso di accertamento con esito in cui espone la nuova classificazione e concede tempo per replicare. Solo dopo, eventualmente, potrà emettere un nuovo avviso di pagamento (se ancora convinta). ImportX nel frattempo avrà prodotto le sue evidenze; può darsi che l’Agenzia, valutandole, decida di classificarne alcune come chiedeva ImportX, riducendo i dazi. In caso contrario, ImportX potrà impugnare di nuovo ma almeno avrà avuto il confronto dovuto. In dogana, comunque, data la cultura del contraddittorio già radicata, è raro che accada come nel caso di esempio (un avviso senza preavviso); se è accaduto, i giudici non transigono e danno ragione all’importatore .
Caso 5: Verbale di accertamento INPS 2025 senza attesa 60 giorni
Scenario: L’Ispettorato del Lavoro/INPS effettua a marzo 2025 un’ispezione presso l’azienda Zeta. A fine accesso, rilascia un Verbale Unico contestando l’impiego di 3 lavoratori in nero e richiedendo €80.000 di contributi e sanzioni civili. Il giorno stesso, l’INPS emette l’Avviso di Addebito per l’importo dovuto e lo notifica a Zeta, senza attendere alcun periodo per eventuali memorie difensive dell’azienda. Ciò avviene perché la norma che prima prevedeva l’attesa di 60 gg (abrogata) non c’è più, e l’INPS ha deciso di procedere immediatamente.
Analisi: Non essendo un atto fiscale, l’art.6-bis Statuto non si applica direttamente. Tuttavia, l’azienda Zeta ritiene che sia stata lesa nel diritto di difesa, poiché avrebbe potuto opporre qualcosa (ad esempio, sostiene che 1 dei 3 lavoratori non era “in nero” ma un parente che aiutava occasionalmente senza obbligo contributivo). La L.241/90 sulla partecipazione procedimentale potrebbe applicarsi, ma qui c’è una disciplina speciale delle ispezioni. Purtroppo, l’abrogazione del 2021 ha tolto il salvagente dei 60 gg. Quindi formalmente l’INPS è in regola con la normativa attuale. Bisogna valutare se i giudici del lavoro considerino comunque doveroso un contraddittorio. Alcune sentenze post-2021 hanno criticato l’eliminazione del termine, sostenendo che resta il principio di lealtà procedimentale: difficile dire se convinceranno tutti i giudici.
Come difendersi: Zeta impugnerà l’Avviso di Addebito innanzi al Tribunale (sezione lavoro) competente. Nel ricorso solleverà sia motivi di merito (contestando magari l’ammontare o la qualifica di “lavoro nero” per uno dei soggetti) sia motivi di procedura: invocherà l’applicazione analogica dei principi dello Statuto Contribuenti o comunque dell’art. 24 Cost., affermando che l’assenza di uno spazio temporale per difendersi pre-atto ha leso il suo diritto di difesa. Potrà citare la Corte Cost. 47/2023 dove la Consulta parla di contraddittorio come principio generale anche in settori vari , benché il caso riguardasse tributi. E citerà magari pronunce di Cassazione lavoro che enfatizzano la necessità di considerare le controdeduzioni del soggetto ispezionato (ad es. Cass. lav. 27237/2018, che annullò un verbale INPS perché l’ispettore non aveva tenuto conto di alcune giustificazioni dell’azienda). Insomma, costruirà un argomento di equità e buon andamento.
Esito atteso: Questo caso è incerto. Non essendoci norma chiara pro-contraddittorio, dipenderà molto dalla sensibilità del giudice. Alcuni tribunali potrebbero dire: la legge speciale non prevede attesa, ergo l’INPS poteva legittimamente emettere subito l’addebito; ciò non toglie che Zeta ha comunque il pieno diritto di difendersi ora in giudizio sul merito (contraddittorio differito). Altri giudici, più attenti ai principi, potrebbero invece dichiarare nullo l’avviso per “difetto di procedimento” e rimandare gli atti all’INPS perché rinnovi la notifica dopo aver valutato meglio la situazione. Non c’è uniformità. Se Zeta perdesse in primo grado sul punto procedurale, potrebbe appellare e magari in appello un orientamento diverso accoglie. Non c’è garanzia. Questo evidenzia come nel settore contributivo la tutela del contraddittorio sia oggi più debole e incerta rispetto al settore tributario, e ciò potrebbe in futuro portare a richieste di riforma anche lì. Nel frattempo, Zeta fa bene a mettere comunque in evidenza il tema, perché anche se non porta all’annullamento immediato, può inclinare il giudizio a suo favore su altri aspetti (un giudice che vede l’INPS troppo affrettato potrebbe valutare con occhio più critico anche il merito).
In conclusione, abbiamo visto attraverso queste simulazioni che il contraddittorio endoprocedimentale è ormai un elemento fondamentale nei rapporti tra Fisco (e in generale P.A.) e contribuenti. Nel panorama attuale (ottobre 2025), grazie alle riforme normative e all’evoluzione giurisprudenziale, i contribuenti dispongono di potenti strumenti per far valere i propri diritti di partecipazione e difesa: un atto emesso senza dare voce preventiva al cittadino potrà essere neutralizzato davanti a un giudice, nella stragrande maggioranza dei casi . Parallelamente, l’Amministrazione è incentivata a migliorare la propria attività istruttoria, confrontandosi col contribuente in modo trasparente prima di formalizzare pretese, con possibili effetti positivi di riduzione del contenzioso futuro.
Dal punto di vista del debitore/contribuente, il messaggio è chiaro: conoscere i propri diritti procedurali è essenziale quanto conoscere le ragioni di merito. Un contribuente informato sarà in grado di: – Riconoscere quando un atto è viziato per difetto di contraddittorio e agire tempestivamente per far valere questo vizio. – Sfruttare attivamente le occasioni di contraddittorio per ridurre o evitare contestazioni. – Impostare una difesa completa in sede di ricorso, unendo questioni formali e sostanziali per ottenere l’annullamento o la rettifica dell’atto impugnato.
L’assistenza di uno studio legale specializzato in materia tributaria/amministrativa può rivelarsi decisiva nel guidare il contribuente attraverso questi passi: un avvocato aggiornato sulle ultime sentenze e normative saprà individuare immediatamente se l’iter seguito dall’ente impositore è regolare o meno, e potrà costruire ricorsi efficaci che integrano la dimensione procedurale (ad esempio citando Cass. SS.UU. 21271/2025 appena uscita ) con quella sostanziale. Ciò aumenta sensibilmente le chance di successo nel tutelare i diritti del contribuente e, eventualmente, annullare l’atto impositivo illegittimo.
In definitiva, “sapere e sapersi difendere” in tema di accertamento senza contraddittorio significa oggi: – pretendere il rispetto delle garanzie procedimentali sancite dalla legge; – non esitare a farle valere in giudizio quando vengono ignorate; – nel contempo, preparare sempre le proprie argomentazioni di merito, perché un contraddittorio ben sfruttato o un ricorso ben argomentato nel merito rimangono le armi migliori per convincere l’Amministrazione (o il giudice) dell’infondatezza della pretesa.
Grazie a questi strumenti, il contribuente non è più un soggetto passivo che subisce l’azione fiscale, ma un protagonista attivo del procedimento tributario, in posizione di più equa parità con l’Amministrazione finanziaria. E con un’adeguata consulenza legale, può far valere appieno tale posizione.
Fonti Normative e Giurisprudenziali (Riferimenti)
- Statuto dei Diritti del Contribuente – L. 27 luglio 2000, n.212, art. 12 comma 7 (garanzia contraddittorio post-verifica in loco) e art. 6-bis (Principio del contraddittorio introdotto da D.Lgs. 219/2023) .
- Delega Fiscale 2023 – Legge 9 agosto 2023, n.111, art. 4, comma 1, lett. b) (principio di contraddittorio generalizzato “a pena di nullità”) .
- D.Lgs. 8 dicembre 2023, n.219 (Attuazione Delega Fiscale) – Modifiche allo Statuto del Contribuente: inserimento art.6-bis e art.1 commi 3-bis e 3-ter (estensione garanzie a tributi locali) .
- Legge 7 agosto 1990, n.241, artt. 7-10 (partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di presentare memorie). Principio generale di contraddittorio per atti amministrativi.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.38 (accertamento sintetico del reddito) – obbligo di contraddittorio (come modificato da DL 78/2010) per redditometro.
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, art.5-ter (introdotto da DLgs 156/2015) – obbligo di invito al contraddittorio (previgente) per taluni accertamenti fiscali e “prova di resistenza” codificata . (Norma ora superata dall’art.6-bis).
- Codice Doganale dell’Unione – Reg. (UE) 952/2013, art.22(6) – diritto dell’operatore economico di essere ascoltato prima di decisioni sfavorevoli .
- Carta dei Diritti Fondamentali UE, art.41 – Diritto a una buona amministrazione, includente il diritto di difesa e al contraddittorio .
- Corte Costituzionale (Italia):
- Sentenza n.47/2023 – contraddittorio endoprocedimentale nei tributi: non esteso ai controlli a tavolino (questione inammissibile) ma monito al legislatore sulla necessità di generalizzazione .
- Sentenza n.71/2015 – principio del contraddittorio come parte del giusto procedimento (in altro contesto; citata in massime) .
- Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili:
- Sent. n.24823 del 9/12/2015 – Principio di diritto: nessun obbligo generalizzato di contraddittorio per tributi non armonizzati; obbligo per tributi armonizzati con invalidità atto se contribuente enuncia le ragioni difensive in giudizio (prova di resistenza) .
- Sent. n.18184/2013 – (SU) Violazione art.12, c.7 Statuto comporta nullità dell’accertamento “ante tempus” (anche se nullità non espressa dalla norma) .
- Sent. n.21271 del 25/07/2025 – (SU) Conferma orientamento pre-riforma: obbligo contraddittorio solo per tributi armonizzati con prova di resistenza, non per altri (per atti ante 2024) . Chiarisce che dal 2024 vige obbligo generalizzato ex lege.
- Cassazione – Sez. Tributaria (alcune significative):
- Ord. n.26974 del 26/11/2020 – ribadisce: obbligo di contraddittorio solo per tributi armonizzati, non per tributi locali/nazionali salvo previsioni espresse .
- Ord. n.26886 del 05/10/2021 – (trib. locali) afferma nessun obbligo di contraddittorio preventivo per TARSU (tributo locale) prima della riforma .
- Sent. n.14357 del 05/05/2022 – conferma assenza obbligo contraddittorio per tributi locali ante riforma (IMU, TARI etc.) .
- Ord. n.24783 dell’08/09/2025 – chiarisce che per accertamenti da studi di settore misti (analitico-induttivi, non fondati esclusivamente sullo studio) l’obbligo di contraddittorio ante riforma non sussiste; richiama SU 2025 e distinzione tributi armonizzati .
- Ord. n.13620 del 17/05/2023 – (cita Fiscoetasse) avvenuto annullamento avviso per omesso contraddittorio (non reperibile, fonte non ufficiale).
- Sent. n.701 del 15/01/2019 – conferma nullità avviso se ufficio non replica a osservazioni contribuente ex art.12, c.7 Statuto (caso ante riforma) .
- Sent. n.11560 dell’11/05/2018 – ribadisce per tributi armonizzati: atto nullo se contribuente indica ragioni non pretestuose non valutate dall’ufficio .
- Corte di Giustizia UE:
- Sentenza 18/12/2008, C-349/07: diritto di essere ascoltati prima di decisione lesiva in materia di dazi doganali è principio generale e la violazione vizia la decisione .
- Sentenza 03/07/2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13: conferma obbligo contraddittorio in ambito doganale; violazione comporta annullamento dell’atto se il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso senza l’irregolarità (introduce concetto prova di resistenza a livello UE) .
- Sentenza 09/11/2017, C-298/16: (materia IVA) riconosce diritto di difesa del contribuente e accesso al fascicolo anche se la legge nazionale non prevedeva contraddittorio preaccertamento (Romania).
Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate senza essere mai stato convocato o ascoltato prima? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate senza essere mai stato convocato o ascoltato prima?
👉 Potresti avere in mano un atto illegittimo, impugnabile per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio preventivo.
In questa guida ti spiego cos’è il contraddittorio nel procedimento tributario, quando è obbligatorio e come difenderti con l’aiuto di uno studio legale specializzato in diritto tributario.
💥 Cos’è il Contraddittorio nel Procedimento Tributario
Il contraddittorio è il diritto del contribuente a partecipare al procedimento di accertamento, presentando osservazioni, documenti e chiarimenti prima che l’Agenzia delle Entrate emetta l’avviso di accertamento.
📌 È un principio fondamentale di giustizia amministrativa e trasparenza, sancito dall’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e riconosciuto dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
⚖️ Quando il Contraddittorio è Obbligatorio
L’Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente instaurare il contraddittorio quando:
- è stato redatto un processo verbale di constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza o dell’Ufficio;
- si tratta di accertamenti basati su verifiche o ispezioni nei locali del contribuente;
- l’atto si fonda su presunzioni, ricostruzioni o dati induttivi;
- vengono utilizzati elementi raccolti da terzi o da altre indagini.
📌 In questi casi, l’Agenzia deve notificare il PVC e attendere almeno 60 giorni per consentire al contribuente di presentare le proprie osservazioni.
⚠️ Quando l’Assenza di Contraddittorio Rende Nullo l’Atto
Un accertamento è nullo se:
- è stato emesso prima della scadenza dei 60 giorni dal rilascio del PVC;
- il contribuente non è mai stato invitato a fornire chiarimenti;
- non è stato rispettato l’obbligo di motivazione e trasparenza;
- l’atto contiene errori o presunzioni non verificate;
- si tratta di un accertamento “a tavolino” senza partecipazione del contribuente.
📌 Secondo la Corte di Cassazione (Sez. Unite, sent. n. 24823/2015), la mancanza di contraddittorio è un vizio che comporta la nullità dell’intero procedimento.
💠 Perché il Contraddittorio È Fondamentale
Il contraddittorio non è una semplice formalità:
serve a garantire che l’Agenzia delle Entrate non emetta accertamenti basati su errori o presunzioni sbagliate.
Durante questa fase, il contribuente può:
- fornire prove e documenti per chiarire la propria posizione;
- contestare errori materiali o calcoli errati;
- dimostrare che le somme non sono imponibili;
- evitare la notifica dell’avviso, se le spiegazioni vengono accolte.
📌 Saltare questa fase significa negare al contribuente il diritto di difesa preventiva, e l’atto diventa contestabile per vizio procedurale.
⚠️ Le Conseguenze di un Accertamento Senza Contraddittorio
Un accertamento emesso senza contraddittorio può portare a:
- 💰 Recupero di imposte e sanzioni non dovute;
- ⚖️ Avviso di accertamento nullo o annullabile;
- 🏦 Iscrizione a ruolo e riscossione illegittima;
- 🚫 Pignoramento o blocco dei conti;
- ⏱️ Contenzioso tributario prolungato, se non impugnato in tempo.
📌 Con l’assistenza di uno studio legale esperto, puoi impugnare e far annullare l’intero accertamento.
🧩 Le Strategie di Difesa Possibili
1️⃣ Eccepire la Violazione del Contraddittorio
Puoi chiedere al giudice tributario di annullare l’atto perché l’Agenzia non ti ha convocato o non ha rispettato i termini dei 60 giorni.
📌 È una nullità assoluta, riconosciuta dalla giurisprudenza di Cassazione e della Corte UE.
2️⃣ Dimostrare l’Infondatezza dell’Accertamento
Se l’accertamento è stato emesso senza confronto, spesso si basa su dati parziali o errati.
L’avvocato può dimostrare che:
- le presunzioni sono infondate;
- i dati bancari non rappresentano redditi imponibili;
- l’Ufficio ha ignorato prove già fornite dal contribuente.
📌 L’assenza di contraddittorio mina la credibilità e la validità dell’accertamento.
3️⃣ Presentare Ricorso Tributario
Puoi impugnare l’atto entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo:
- la sospensione immediata della riscossione;
- la dichiarazione di nullità per violazione del diritto di difesa;
- in subordine, la riduzione o rettifica dell’imposta accertata.
📌 In caso di urgenza, il giudice può sospendere gli effetti dell’atto in 48 ore.
🧾 I Documenti da Consegnare allo Studio Legale
- Copia dell’avviso di accertamento ricevuto;
- Processo verbale di constatazione (PVC) o verbali di verifica;
- Comunicazioni e notifiche dell’Agenzia;
- Documentazione contabile e fiscale;
- Prove scritte o bancarie ignorate dall’Ufficio.
📌 Questi documenti permettono all’avvocato di verificare se i termini e le garanzie procedurali sono stati rispettati.
⏱️ Tempi del Procedimento
- Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica.
- Sospensione cautelare: possibile in 48 ore.
- Sentenza di primo grado: in circa 6–12 mesi.
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può riscuotere né procedere con pignoramenti.
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✅ Annullamento per violazione del diritto di difesa.
✅ Blocco immediato della riscossione.
✅ Riduzione o cancellazione dell’imposta accertata.
✅ Prevenzione di cartelle, ipoteche e pignoramenti.
✅ Tutela completa davanti alle Corti di Giustizia Tributarie.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare l’avviso perché “non ti hanno convocato prima”.
❌ Non verificare i 60 giorni dal PVC alla notifica.
❌ Agire senza un avvocato esperto in diritto tributario.
❌ Presentare il ricorso fuori termine.
📌 L’assenza di contraddittorio è un vizio formale grave: può annullare l’intero accertamento, ma solo se eccepito correttamente.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’intero procedimento e verifica se l’Agenzia ha violato il contraddittorio.
📌 Ti assiste nella raccolta delle prove e nel ricorso tributario.
✍️ Redige ricorsi fondati su giurisprudenza e Statuto del Contribuente.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in ogni grado di giudizio.
🔁 Ti segue fino alla sospensione o all’annullamento definitivo dell’atto.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti emessi senza contraddittorio.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di contribuenti, imprese e professionisti contro l’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Un accertamento emesso senza contraddittorio è un atto gravemente viziato e può essere annullato.
Con l’assistenza di uno studio legale esperto puoi bloccare la riscossione, difendere i tuoi diritti e ottenere la cancellazione dell’accertamento illegittimo.
⏱️ Hai 60 giorni dalla notifica per agire: non aspettare.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro un accertamento senza contraddittorio può partire oggi stesso.