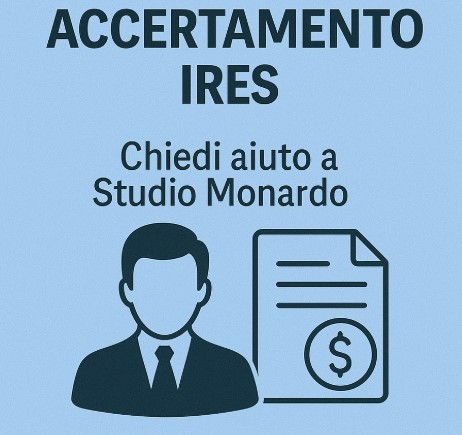Hai ricevuto un avviso di accertamento IRES da parte dell’Agenzia delle Entrate? È uno dei controlli fiscali più delicati per le società di capitali, perché il Fisco contesta un reddito imponibile superiore a quello dichiarato e pretende il pagamento di imposte, sanzioni e interessi.
In pratica, l’Agenzia ritiene che la tua società abbia occultato ricavi, gonfiato costi o gestito in modo non corretto la contabilità, e ricalcola l’IRES dovuta con una ricostruzione analitica o presuntiva dei redditi.
Ma attenzione: l’accertamento IRES non è definitivo. Con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto, puoi impugnare l’avviso, sospendere la riscossione e far annullare le pretese illegittime.
Cos’è l’accertamento IRES e su cosa si basa
L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è l’imposta sui redditi delle società di capitali e degli enti commerciali, disciplinata dal TUIR (D.P.R. 917/1986).
L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento IRES quando ritiene che il reddito dichiarato non rappresenti quello effettivo, basandosi su:
- anomalie contabili o incongruenze nei bilanci;
- ricavi non dichiarati o costi fittizi;
- operazioni inesistenti o simulate;
- movimenti bancari non coerenti con le scritture contabili;
- controlli incrociati con fornitori, clienti o dati fiscali di terzi;
- accertamenti IVA o IRAP collegati.
L’avviso di accertamento IRES può derivare da una verifica fiscale, da un controllo documentale o da segnalazioni della Guardia di Finanza.
Come funziona la procedura di accertamento IRES
- Analisi dei dati contabili e fiscali: l’Agenzia confronta i bilanci, i registri IVA e i conti economici.
- Richiesta di chiarimenti o accesso in azienda: il contribuente può essere convocato o sottoposto a ispezione.
- Invito al contraddittorio: l’Ufficio invita la società a fornire prove e spiegazioni.
- Emissione dell’avviso di accertamento: se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, l’Agenzia notifica l’atto con il ricalcolo dell’IRES, sanzioni e interessi.
- Ricorso entro 60 giorni: la società può impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, chiedendo la sospensione della riscossione.
Quando un accertamento IRES è legittimo
L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento IRES solo se:
- ha raccolto elementi certi, gravi e concordanti che dimostrino il maggior reddito;
- l’avviso è motivato in modo chiaro e dettagliato;
- ha rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo con la società;
- le rettifiche derivano da dati contabili verificabili, non da presunzioni generiche;
- sono stati rispettati i termini di decadenza (5 anni, o 7 in caso di omessa dichiarazione).
In mancanza di questi requisiti, l’accertamento è illegittimo e impugnabile.
Quando l’accertamento IRES è nullo o impugnabile
Puoi impugnare un accertamento IRES se presenta uno o più dei seguenti vizi:
- mancato contraddittorio con il contribuente;
- motivazione carente o generica;
- presunzioni arbitrarie o non dimostrate;
- utilizzo di dati bancari non verificabili;
- errori di calcolo o doppia imposizione;
- mancata valutazione delle prove difensive presentate dalla società;
- violazione dei termini di decadenza o notifica irregolare.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’Agenzia non può basarsi su sospetti o differenze contabili non spiegate, ma deve fornire riscontri oggettivi e consentire alla società di difendersi prima dell’avviso.
Le conseguenze di un accertamento IRES
Un accertamento IRES può comportare conseguenze molto pesanti:
- recupero di imposte su ricavi presunti o costi non riconosciuti;
- sanzioni amministrative fino al 240% dell’imposta accertata;
- interessi di mora e iscrizione a ruolo;
- pignoramenti, fermi e ipoteche in caso di mancato pagamento;
- nei casi più gravi, segnalazione alla Procura per dichiarazione fraudolenta o infedele.
Difendersi subito è fondamentale per bloccare la riscossione e tutelare la società.
Come difendersi da un accertamento IRES
Un avvocato tributarista può predisporre una strategia difensiva mirata, basata su:
- Verifica della legittimità dell’atto: controllo della regolarità della procedura e della motivazione;
- Analisi dei calcoli e delle presunzioni: individuazione di errori materiali o interpretativi;
- Produzione di prove contabili e documentali: bilanci, scritture contabili, contratti, giustificativi di spese e ricavi;
- Dimostrazione della correttezza della contabilità: prova che i dati fiscali sono coerenti con la realtà aziendale;
- Richiesta di sospensione cautelare: per bloccare la riscossione durante il contenzioso.
Le strategie difensive più efficaci
- Dimostrare che i ricavi presunti non esistono o sono già tassati;
- Contestare l’uso di medie o percentuali di settore non pertinenti;
- Evidenziare errori di imputazione di costi o ricavi;
- Dimostrare la legittimità delle spese contestate;
- Contestare la violazione del contraddittorio o la carenza di motivazione;
- Richiedere la sospensione della riscossione e la revisione dell’avviso.
Come scegliere l’avvocato giusto per difendersi
Affrontare un accertamento IRES richiede un legale con:
- specializzazione in diritto tributario e contenzioso fiscale;
- esperienza diretta in accertamenti su società di capitali;
- collaborazione con commercialisti e revisori legali;
- conoscenza approfondita della normativa IRES e della giurisprudenza tributaria;
- capacità di negoziazione con l’Agenzia delle Entrate per definizioni agevolate o accertamenti con adesione.
Un avvocato esperto può impugnare l’avviso, sospendere la riscossione e ottenere la riduzione o l’annullamento della pretesa fiscale.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un accertamento IRES comporta gravi conseguenze:
- l’avviso diventa definitivo ed esecutivo dopo 60 giorni;
- l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme e avviare la riscossione coattiva;
- pignoramenti e ipoteche sui beni aziendali;
- sanzioni e interessi crescenti;
- possibile responsabilità personale dell’amministratore in caso di reati tributari.
Difendersi tempestivamente è l’unico modo per proteggere la società e il suo patrimonio.
Quando rivolgersi a un avvocato
Devi contattare un avvocato se:
- la tua società ha ricevuto un avviso di accertamento IRES;
- l’Agenzia ti contesta ricavi presunti o costi non deducibili;
- vuoi sospendere la riscossione o presentare ricorso;
- intendi dimostrare la correttezza della contabilità aziendale.
Un avvocato tributarista può:
- impugnare l’avviso di accertamento IRES e chiederne la sospensione cautelare;
- dimostrare l’infondatezza delle presunzioni del Fisco;
- ottenere l’annullamento o la riduzione delle somme contestate;
- rappresentare la società davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione.
⚠️ Attenzione: un accertamento IRES si basa spesso su ricostruzioni presuntive o su errori contabili che possono essere smontati. Con una difesa tempestiva e documentata puoi bloccare la riscossione, contestare le irregolarità e difendere la tua società.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e difesa delle società contro accertamenti IRES – spiega cos’è l’accertamento IRES, quando è illegittimo e come difendersi efficacemente con l’assistenza di un avvocato specializzato.
👉 Hai ricevuto un avviso di accertamento IRES?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il bilancio e la contabilità, verificheremo la legittimità dell’avviso e costruiremo una strategia personalizzata per impugnare l’accertamento, sospendere la riscossione e proteggere la tua società.
Introduzione
Ricevere un avviso di accertamento relativo all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è uno degli eventi più temuti per imprese e contribuenti. Si tratta di un atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente (società di capitali, imprenditore individuale o ente) un’imposta aggiuntiva da pagare, spesso accompagnata da sanzioni e interessi. L’accertamento fiscale può mettere a serio rischio la stabilità finanziaria di un’azienda e va affrontato bene e subito, preferibilmente con l’ausilio di un avvocato esperto in diritto tributario.
In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 e arricchita con le normative vigenti e le più recenti sentenze – esamineremo in dettaglio come difendersi da un accertamento IRES. Adotteremo un taglio professionale ma divulgativo, rivolgendoci sia ad avvocati che assistono i clienti in materia tributaria, sia a imprenditori e privati cittadini che vogliono capire cosa fare nell’immediato e quali strategii possono mettere in campo. Verranno fornite spiegazioni giuridiche approfondite, esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte frequenti, il tutto dal punto di vista del contribuente/debitore che si trova a dover contestare una pretesa fiscale.
Tra i temi trattati vi saranno la procedura di accertamento fiscale (dall’avvio dei controlli alla notifica dell’atto), i diritti del contribuente durante le verifiche, le varie tipologie di accertamento IRES e i relativi termini di decadenza, nonché le possibili irregolarità (vizi formali e sostanziali) che possono rendere nullo un avviso. Un focus particolare sarà dedicato agli strumenti “deflattivi” del contenzioso, ovvero quelle soluzioni che permettono di risolvere o attenuare la controversia prima o in alternativa al ricorso in tribunale: dall’accertamento con adesione alla mediazione (istituto recentemente abrogato), dalla conciliazione giudiziale all’acquiescenza e all’autotutela. Infine, verranno illustrate strategie di difesa nelle diverse fasi (amministrativa e contenziosa) e per diversi soggetti (società di capitali, ditte individuali, enti non commerciali, ecc.), con simulazioni di casi pratici e le risposte alle domande più comuni.
Cos’è l’accertamento IRES e quando scatta
L’avviso di accertamento è il principale strumento con cui l’Agenzia delle Entrate recupera imposte ritenute evase o non versate correttamente . In sostanza è un provvedimento impositivo formale, notificato al contribuente, che rettifica i redditi o le imposte dichiarate e quantifica le maggiori somme dovute a titolo di IRES (corporate tax), oltre a interessi e sanzioni. Di norma, l’avviso di accertamento scaturisce da un’istruttoria o verifica fiscale condotta dagli uffici finanziari competenti : ciò può avvenire a seguito di controlli in sede (accessi, ispezioni e verifiche presso l’azienda), di controlli “a tavolino” (analisi a distanza della documentazione contabile e delle banche dati) oppure di controlli automatizzati sulle dichiarazioni.
L’Agenzia delle Entrate emette avvisi di accertamento per una pluralità di tributi, ma in questa guida ci focalizziamo sull’accertamento riguardante l’IRES, l’imposta applicabile al reddito delle società di capitali e degli enti commerciali (aliquota ordinaria 24%). Anche gli imprenditori individuali e le società di persone possono subire accertamenti analoghi sul reddito d’impresa (in tal caso si tratta però di IRPEF anziché IRES); i principi difensivi, comunque, sono in buona parte comuni. Un avviso IRES può contestare, ad esempio, ricavi non dichiarati, costi dedotti indebitamente o altre violazioni che abbiano comportato un minor imponibile e quindi un minor tributo versato.
Va precisato che spesso le verifiche sul campo sono svolte dalla Guardia di Finanza, che redige un Processo Verbale di Constatazione (PVC) contenente i rilievi, ma non è la GdF a emettere l’avviso finale . Quest’ultimo viene sempre emesso dall’Agenzia delle Entrate competente, la quale può adottare (in tutto o in parte) le conclusioni della Guardia di Finanza nel formulare la pretesa tributaria definitiva. Dunque, un accertamento IRES può originare sia da controlli interni dell’Agenzia sia da un’attività investigativa della Guardia di Finanza confluita in un PVC.
Tempi di notifica (decadenza): la legge impone termini stringenti entro cui l’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, pena la decadenza. Per le imposte sui redditi, il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta da accertare . Ad esempio, per il periodo d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) l’eventuale accertamento IRES deve essere notificato entro il 31 dicembre 2026. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione (o questa è nulla), il termine si estende al 31 dicembre del settimo año successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata . In aggiunta, in caso di violazioni che configurano un reato tributario obbligatoriamente denunciabile (ad es. dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione oltre soglie di punibilità), i termini di decadenza raddoppiano (passando quindi a 10 anni e 14 anni rispettivamente) , purché la denuncia penale sia trasmessa entro i termini ordinari. Oltre tali scadenze, l’amministrazione finanziaria perde il potere di accertare quel periodo d’imposta.
In sintesi, l’accertamento IRES “scatta” quando il Fisco ravvisa una discrepanza significativa tra il dichiarato e il dovuto: ciò può emergere da controlli incrociati, indicatori di anomalie (ad esempio indici di bilancio antieconomici, scostamenti dagli Indici Sintetici di Affidabilità – ISA), movimenti bancari ingiustificati, segnalazioni della Guardia di Finanza o semplici errori materiali. L’obiettivo dell’avviso è rettificare la dichiarazione del contribuente e recuperare a tassazione i redditi sottratti, assicurando il corretto gettito delle imposte .
Tipologie di accertamento e metodi di determinazione del reddito
A seconda delle circostanze e della qualità delle evidenze disponibili, l’Amministrazione finanziaria può adottare diversi metodi di accertamento per determinare il reddito imponibile e le imposte evase. In ambito IRES (e in generale per le imposte sui redditi) le principali tipologie di accertamento sono riassunte nella tabella seguente:
| Tipologia di accertamento | Descrizione e presupposti | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Accertamento analitico | Si basa sui dati dichiarati e sulle scritture contabili del contribuente. Il Fisco rettifica puntualmente singoli elementi del reddito d’impresa (ricavi, costi, ecc.) riscontrando errori o violazioni attraverso la documentazione esaminata . Presuppone che la contabilità sia regolare nelle sue linee generali (attendibile), consentendo controlli analitici voce per voce. | Art. 39, c.1, D.P.R. 600/1973 (per imprese e autonomi); Art. 40, D.P.R. 600/1973 (per società di persone). |
| Accertamento induttivo (extra-contabile) | Viene utilizzato quando la contabilità del contribuente è inattendibile o mancante in misura tale da non consentire un controllo analitico . Il reddito viene quindi determinato “fuori dai libri”, con metodi induttivi: il Fisco può prescindere dalle risultanze formali e basarsi su indizi e dati esterni. In questo caso sono ammesse presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza , a differenza dell’accertamento analitico. È lo scenario più sfavorevole per il contribuente, perché l’Ufficio può accertare le maggiori imposte evase sulla base di presunzioni semplici, anche se non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (prove più labili). | Art. 39, c.2, D.P.R. 600/1973 (contabilità inattendibile); Art. 41, D.P.R. 600/1973 (omessa dichiarazione, accertamento d’ufficio). |
| Accertamento analitico-induttivo | Forma ibrida: la contabilità è formalmente tenuta, ma presenta incompletezze o dati non veritieri. L’Ufficio rettifica il reddito sia basandosi sui dati contabili attendibili sia tramite presunzioni su elementi non dichiarati. Ad esempio può ricostruire ricavi non contabilizzati mediante indici di settore o prove indirette, una volta riscontrate gravi incongruenze nei conti . In genere richiede presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza (se applicato nell’ambito dell’art. 39, c.1, lett. d)). | Art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. 600/1973 (contabilità formalmente regolare ma inattendibile nel merito). |
| Accertamento sintetico | Metodo riservato alle persone fisiche, non applicabile direttamente alle società. Determina il reddito complessivo del contribuente partendo da indicatori di capacità contributiva (spese di lusso, investimenti, tenore di vita – il cosiddetto redditometro). Se dalle spese sostenute emergono redditi in nero, l’Ufficio può presumere un maggior reddito personale imponibile IRPEF. Questo strumento non riguarda l’IRES (che tassa solo redditi societari), ma può coinvolgere l’imprenditore individuale sul piano personale . | Art. 38, D.P.R. 600/1973 (redditometro persone fisiche). |
| Accertamento da indagini finanziarie | Non è una categoria a sé, ma una tecnica istruttoria trasversale. Consiste nell’utilizzare i dati dei conti bancari e finanziari del contribuente (acquisiti ex art. 32 DPR 600/73) per individuare ricavi non dichiarati. Versamenti non giustificati sui conti vengono presunti come ricavi tassabili (se il contribuente non prova la loro irrilevanza fiscale) ; analogamente, prelevamenti ingiustificati oltre 1.000 € giornalieri (o 5.000 € mensili) possono essere considerati acquisti in nero quindi ricavi non dichiarati . Le risultanze bancarie alimentano poi un accertamento analitico, induttivo o parziale. | Art. 32, c.1, n. 2), D.P.R. 600/1973 (poteri di indagine su conti); Art. 32, c.1, n. 7), D.P.R. 600/1973 (presunzioni su movimenti bancari). |
| Accertamento d’ufficio | Riguarda i casi di omessa dichiarazione (o dichiarazione nulla). L’Ufficio determina il reddito imponibile ex officio, sulla base dei dati e informazioni disponibili, utilizzando anche mere presunzioni semplici (senza obbligo di dimostrarne la gravità/precisione) . In pratica, quando il contribuente omette la dichiarazione, è molto più facile per l’Agenzia delle Entrate recuperare a tassazione i redditi non dichiarati, dato che la prova richiesta all’Ufficio è meno rigorosa rispetto agli altri accertamenti. | Art. 41, D.P.R. 600/1973 (accertamento d’ufficio, omessa dichiarazione). |
| Accertamento parziale | Consente al Fisco di contestare velocemente singoli redditi o imponibili specifici, senza attendere un accertamento completo. Può avvenire, ad esempio, quando emergono elementi certi su una sola fonte di reddito non dichiarato. L’avviso “parziale” non preclude ulteriori accertamenti sul resto della posizione fiscale . In pratica l’Agenzia può emettere più avvisi: il primo rettifica subito l’aspetto emerso (ad es. un reddito non dichiarato rilevato da un controllo incrociato), riservandosi di esaminare altro in seguito. | Art. 41-bis, D.P.R. 600/1973 (accertamento parziale); Art. 54, c.5, D.P.R. 633/1972 (accertamento parziale IVA). |
| Accertamento integrativo | È un accertamento successivo ad un primo avviso già notificato, reso necessario dalla scoperta di nuovi elementi che evidenziano ulteriore imponibile sottratto. L’Amministrazione finanziaria può emettere un secondo avviso (o successivi) per lo stesso periodo d’imposta, integrando il precedente, purché entro i termini di decadenza. Nel nuovo atto devono essere indicati specificamente i fatti sopravvenuti o prima ignoti che giustificano la rettifica aggiuntiva . | Art. 43, c.3, D.P.R. 600/1973 (integrazione o modifica dell’accertamento). |
Tutti questi metodi accertativi sono soggetti al sindacato del giudice tributario in caso di ricorso, ma ciascuno presenta margini di difesa diversi. Ad esempio, negli accertamenti analitici (o analitico-induttivi) il carico probatorio a carico del Fisco è più rigoroso, dovendo fondarsi su elementi oggettivi o presunzioni dotate di una certa solidità. Negli accertamenti induttivi puri, invece, l’ufficio ha maggiore libertà (potendo usare presunzioni semplici non qualificate) , anche se la motivazione dell’atto deve sempre spiegare le ragioni e i criteri di calcolo seguiti, pena la nullità dell’avviso . Dal lato del contribuente, contestare un accertamento analitico significa spesso dimostrare la correttezza delle proprie scritture o l’assenza dei fatti addotti dal Fisco; difendersi da un accertamento induttivo richiede invece di smontare le presunzioni e le stime ufficiose (magari producendo documenti e spiegazioni alternative per giustificare le anomalie rilevate).
Garanzie procedurali e vizi dell’avviso di accertamento
L’emissione di un avviso di accertamento deve avvenire nel rispetto di una serie di garanzie procedurali previste dall’ordinamento a tutela del contribuente. La violazione di tali regole può comportare l’illegittimità o l’annullabilità dell’atto impositivo. Di seguito riepiloghiamo le principali garanzie e i corrispondenti vizi che possono essere fatti valere in sede di difesa:
- Obbligo di motivazione e conoscenza degli atti: ogni avviso deve contenere l’indicazione chiara dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato (art. 7, co.1, L. 212/2000). Ciò implica che il contribuente debba poter comprendere esattamente da quali elementi è scaturita la pretesa fiscale. Inoltre, se l’atto fa riferimento a documenti o verbali (ad esempio un PVC della Guardia di Finanza, o un rapporto relativo a verifiche svolte presso terzi), tali documenti devono essere allegati all’avviso oppure già notificati al contribuente . In caso contrario, l’atto risulta carente di motivazione e dunque nullo per violazione dell’obbligo di comunicare gli elementi su cui si fonda . Ad esempio, un avviso basato su un processo verbale redatto verso un soggetto terzo è stato annullato in giudizio proprio perché tale verbale non era stato allegato né previamente comunicato al contribuente destinatario .
- Sottoscrizione e competenza dell’ufficio: l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto da un dirigente o funzionario delegato dell’ufficio competente (normalmente, il Direttore o Capo Area dell’Agenzia) ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973. La mancanza di firma oppure la firma apposta da soggetto non autorizzato costituisce un vizio dell’atto che può renderlo nullo. In passato, ad esempio, sono stati annullati avvisi firmati da funzionari privi di formale delega di firma o appartenenti a uffici territorialmente non competenti. Si tratta di vizi formali assoluti, che però devono essere fatti valere tempestivamente in giudizio (entro 60 giorni), al pari degli altri motivi di ricorso .
- Diritto al contraddittorio endoprocedimentale: il contraddittorio anticipato (ossia la possibilità per il contribuente di essere ascoltato e di controdedurre prima dell’emissione dell’avviso) è un cardine del giusto procedimento tributario. In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente (accessi e ispezioni, tipicamente svolti dalla Guardia di Finanza o dai funzionari AE), lo Statuto del Contribuente garantisce il diritto di presentare osservazioni entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni (trasmissione del PVC), periodo durante il quale l’ufficio non può emettere l’accertamento . Notificare l’avviso prima di tale termine, senza attendere le eventuali memorie difensive, viola l’art. 12, co. 7, L. 212/2000 e comporta la nullità dell’atto – salvo che ricorrano casi di particolare e motivata urgenza, da esplicitare nell’avviso stesso. Questo principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, che hanno annullato avvisi emessi prematuramente ignorando il termine dilatorio di 60 giorni .
- Invito al contraddittorio per accertamenti “a tavolino”: dal 1° luglio 2020 la normativa impone il contraddittorio preventivo anche al di fuori delle verifiche in loco. In base all’art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997 (introdotto dal DL 34/2019), per le imposte sui redditi e IVA l’ufficio deve notificare un invito a comparire al contribuente (quando non vi sia stato un PVC), offrendogli la possibilità di discutere i rilievi prima di emettere l’avviso . La mancata attivazione di questo contraddittorio “in ufficio” rende l’accertamento annullabile se il contribuente, impugnandolo, dimostra in giudizio che l’assenza di confronto ha influenzato negativamente la decisione (cosiddetta prova di resistenza) . Anche su questo fronte la disciplina si è evoluta: la riforma del 2022-2023 ha inserito nello Statuto dei Contribuenti un nuovo articolo 6-bis che generalizza l’obbligo di contraddittorio per qualsiasi atto impositivo impugnabile, a pena di nullità, salvo che nei casi di accertamenti automatizzati o di particolare urgenza. Dunque, oggi il diritto al contraddittorio costituisce la regola generale, e ogni eccezione (ad esempio, urgenza di evitare la decadenza) deve essere motivata dall’ufficio.
- Altri vizi formali: ulteriori irregolarità che possono inficiare l’avviso includono l’omessa indicazione delle modalità e termini di impugnazione (Commissione competente e 60 giorni per il ricorso) come previsto dall’art. 19, co.2, D.Lgs. 546/1992; errori sulla identificazione del contribuente destinatario o sul periodo d’imposta; difetti di notificazione (es. notifica effettuata a indirizzo o PEC errati) e vizi attinenti alle sanzioni (ad esempio, mancata applicazione di cause di non punibilità o di cumulo giuridico se dovuti). Molti di questi vizi, sebbene non sempre comportino la nullità assoluta dell’atto, possono essere fatti valere in sede di ricorso per ottenerne l’annullamento totale o parziale.
In sintesi, un avviso di accertamento per essere valido deve essere motivatamente fondato, emanato da organi competenti seguendo il giusto procedimento. La verifica del rispetto di queste garanzie costituisce uno dei primi compiti dell’avvocato tributarista: individuare un vizio procedurale può portare all’annullamento immediato dell’atto senza nemmeno affrontare il merito fiscale.
Soluzioni deflattive prima del ricorso: acquiescenza, adesione e autotutela
Quando l’avviso di accertamento viene notificato, il contribuente ha 60 giorni per valutare come reagire . In questo lasso di tempo si possono percorrere alcuni strumenti alternativi al ricorso giudiziario, mirati a risolvere la controversia in via amministrativa o comunque a ridurre il contendere. Le principali opzioni deflattive sono:
- Acquiescenza immediata: consiste nell’accettare integralmente l’avviso di accertamento e pagare le somme dovute entro 60 giorni, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni. In particolare, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del minimo previsto . L’acquiescenza richiede il pagamento integrale dell’imposta accertata (oltre interessi) e delle sanzioni ridotte; il pagamento può avvenire anche in forma rateale (fino a 8 rate trimestrali, elevate a 16 rate se l’importo supera 50.000 €) . Questa soluzione è indicata quando il contribuente, magari dopo essersi consultato con un esperto, riconosce la fondatezza della pretesa fiscale o comunque valuta di non avere margini di difesa sufficienti. Pagando subito, infatti, evita il contenzioso e limita la sua esposizione alle sole imposte (senza aggravio di ulteriori sanzioni). È possibile anche l’acquiescenza parziale sulle sole sanzioni: ad esempio, il contribuente può decidere di impugnare solo l’imposta e, nel frattempo, pagare le sanzioni in misura ridotta (1/3) per evitare rischi su di esse .
- Accertamento con adesione: è una procedura di definizione concordata dell’accertamento, regolata dal D.Lgs. 218/1997, che consente di evitare il giudizio trovando un accordo con l’ufficio sulle imposte dovute. Il contribuente può presentare un’istanza di adesione entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso (anche contestualmente chiedendo di accedere agli atti) e la presentazione dell’istanza sospende automaticamente il termine per fare ricorso per 90 giorni. L’ufficio convocherà quindi il contribuente per instaurare un contraddittorio su fatti e calcoli; durante l’incontro (o incontri) le parti possono raggiungere un’intesa su un importo di imposte inferiore a quello originariamente accertato. Se si perfeziona l’accordo, viene redatto un atto di adesione con le nuove somme concordate; il contribuente dovrà versare le somme (imposte e interessi) entro 20 giorni dalla firma (anche qui con possibilità di rateazione in 8 o 16 rate) e le sanzioni vengono ridotte ad 1/3 . L’accertamento con adesione è vantaggioso quando la pretesa fiscale non è palesemente infondata ma neppure totalmente corretta: in situazioni dubbie o complesse può convenire negoziare col Fisco per ottenere una riduzione delle imposte e una chiusura rapida della vertenza . Occorre tuttavia impegnarsi nel contraddittorio fornendo all’ufficio elementi convincenti per ottenere uno sconto. In caso di mancato accordo, al termine dei 90 giorni (o in caso di interruzione delle trattative prima) il contribuente ha comunque 30 giorni di tempo per presentare ricorso. Va segnalato che durante la pendenza dell’adesione sono sospesi anche i termini di riscossione (l’ufficio non iscrive a ruolo somme ulteriori).
- Autotutela amministrativa: consiste nell’istanza rivolta direttamente all’ufficio emittente affinché annulli o rettifichi in via di autotutela l’avviso, riconoscendo spontaneamente un errore (di fatto o di diritto). Questo strumento può essere utile in presenza di errori evidenti dell’accertamento – ad esempio un palese scambio di persona, un doppio conteggio dello stesso reddito, oppure la dimostrazione documentale che un rilievo è infondato. Tuttavia va sottolineato che l’autotutela è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione: l’ufficio non è obbligato ad accogliere l’istanza del contribuente. Inoltre, la presentazione dell’istanza non sospende affatto il termine di 60 giorni per fare ricorso . È quindi pericoloso affidarsi solo all’autotutela: se l’ufficio non risponde o rigetta la richiesta (evenienza frequente), trascorsi i 60 giorni il contribuente si ritroverebbe privo di difese. In pratica, l’istanza di autotutela può essere presentata – preferibilmente con l’assistenza di un avvocato tributarista – ma senza rinunciare parallelamente a predisporre il ricorso o a perseguire altre forme di definizione. L’autotutela ha invece valore quando consente di correggere l’atto prima che questo diventi definitivo (ad esempio, l’ufficio stesso può annullare in autotutela un avviso evidentemente erroneo, evitando al contribuente la fatica del ricorso).
- Reclamo e mediazione: per completezza, ricordiamo che fino al 2023 era prevista una procedura obbligatoria di reclamo/mediazione tributaria per le controversie di valore fino a 50.000 €. In sostanza, prima di adire il giudice il contribuente doveva presentare un reclamo all’ufficio, il quale poteva accogliere in tutto o in parte (mediazione) la richiesta annullando/riducendo l’atto. Questo istituto – disciplinato dall’art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992 – è stato abolito a partire dagli atti notificati dal 2024 . Oggi, quindi, anche per importi sotto 50.000 € si può proporre direttamente ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, senza passare dal reclamo. Restano naturalmente possibili forme di componimento in sede giudiziale (v. oltre, la conciliazione), ma l’iter preliminare amministrativo non è più obbligatorio.
Nota: Oltre agli strumenti sopra elencati, esistono misure “deflattive” prima ancora dell’emissione dell’avviso. Ad esempio, il contribuente può aderire integralmente a un Processo Verbale di Constatazione (PVC) della Guardia di Finanza entro 30 giorni dal suo rilascio, ottenendo una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo . Analogamente, la definizione agevolata di un invito al contraddittorio dell’ufficio prima dell’avviso comporta sanzioni ridotte ad 1/8. Queste opzioni – applicabili rispettivamente nella fase di verifica e in quella pre-accertamento – richiedono di accettare tutte le contestazioni contenute nel PVC o nell’invito, ma permettono un abbattimento maggiore delle sanzioni rispetto all’adesione dopo l’avviso. Sono strategie da valutare con tempestività (spesso entro 30 giorni) e con l’ausilio del difensore, qualora si ritenga conveniente chiudere subito la partita fiscale evitando l’emissione dell’atto.
Difesa in giudizio: il contenzioso tributario
Se il contribuente ritiene l’accertamento infondato (in tutto o in parte) e non raggiunge una definizione nell’ambito amministrativo, può presentare ricorso alla giustizia tributaria. Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (salvo sospensioni dovute a adesione, come visto) alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (ex Commissione Tributaria Provinciale). Nel ricorso si possono dedurre sia motivi di merito (contestando la pretesa fiscale nel suo fondamento) sia motivi di legittimità (vizi formali o procedurali dell’atto impositivo). Dal 2023 le Commissioni Tributarie hanno assunto la nuova denominazione di Corti di Giustizia Tributaria e il processo è stato oggetto di riforma: i giudici tributari sono ora togati (professionali), in primo grado le controversie di modico valore (fino a 5.000 €) sono decise da un giudice monocratico, ed è stata introdotta la possibilità di svolgere udienze da remoto (videoconferenza) e di utilizzare la prova testimoniale scritta , prima non ammessa.
Il giudizio tributario si instaura con la notifica del ricorso all’ente impositore (Agenzia delle Entrate) e ad eventuali altri soggetti coinvolti (Agenzia Entrate-Riscossione se già intervenuta per il ruolo, etc.), quindi il deposito telematico presso la segreteria della Corte tributaria. Il processo oggi è integralmente telematico tramite il Portale della Giustizia Tributaria: atti e documenti si depositano online, le comunicazioni avvengono via PEC e il fascicolo è digitale.
Effetti della proposizione del ricorso: è importante evidenziare che il ricorso non sospende automaticamente la riscossione dell’avviso. In base alla legge, decorsi 60 giorni dalla notifica, l’accertamento non pagato diviene esecutivo e l’Agenzia può iniziare la riscossione provvisoria di una parte delle imposte contestate (in genere il 50% degli importi accertati a titolo d’imposta, limitato però al 1/3 del totale in contestazione) . In pratica, durante il processo il contribuente potrebbe dover versare circa 1/3 delle imposte oggetto di causa (senza sanzioni, queste sono sospese), in attesa della sentenza . Se poi perde in primo grado, l’ente impositore può riscuotere un ulteriore 50% delle imposte ancora contestate (arrivando ai 2/3), e dopo la sentenza di secondo grado l’intero importo residuo. Interessi e eventuali aggi di riscossione maturano nel frattempo sulle somme non pagate. Per evitare o limitare la riscossione provvisoria, il contribuente ha la facoltà di chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (in tutto o in parte). La sospensiva viene concessa se il ricorrente dimostra sia il fumus boni iuris (cioè che il ricorso presenta elementi fondati e non pretestuosi) sia il periculum in mora (cioè che dall’esecuzione immediata deriverebbe un danno grave e irreparabile) . La richiesta di sospensione va proposta nel ricorso e viene decisa in tempi rapidi (oggi la legge impone la fissazione dell’udienza cautelare entro 30 giorni ). In caso di accoglimento, l’efficacia esecutiva dell’avviso viene bloccata (eventualmente subordinando la sospensione a una garanzia finanziaria, cauzione o polizza; tuttavia per i contribuenti “affidabili” in base agli indici ISA non può essere richiesta garanzia ). La sospensione dell’atto resta in vigore fino alla sentenza di primo grado.
Svolgimento e decisione: la causa tributaria si sviluppa in modo simile a un processo civile, ma con alcune particolarità. Le parti (contribuente ricorrente ed ente impositore resistente) scambiano memorie scritte secondo termini fissati dal D.Lgs. 546/1992. La fase istruttoria è di regola documentale, ma – come accennato – dal 2023 è ammessa la testimonianza (per iscritto) su autorizzazione del giudice e si possono disporre consulenze tecniche. Il carico della prova nel merito spetta prevalentemente all’Amministrazione finanziaria: la recente riforma ha esplicitato che è il Fisco a dover provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto, e il giudice deve basare la decisione sulle prove emerse in giudizio, annullando l’atto se la prova risulta mancante o insufficiente . Ciò codifica un principio favorevole al contribuente, imponendo all’ente impositore di fornire elementi concreti a supporto delle proprie pretese (presunzioni generiche o supposizioni non sono sufficienti). Dall’altro lato, rimane a carico del contribuente l’onere della prova quando egli agisce per ottenere rimborsi d’imposta non conseguenti a pagamenti già eseguiti o fa valere esimenti (ad es. dimostrare costi deducibili, esenzioni, ecc.). Terminata l’istruttoria, la causa viene decisa con sentenza. La Corte tributaria può accogliere totalmente il ricorso (annullando l’atto impugnato), accoglierlo parzialmente (annullando in parte o riducendo l’accertamento) oppure respingerlo (confermare per intero la pretesa).
La sentenza di primo grado è titolo esecutivo immediato. Se il contribuente risulta vittorioso, ha diritto al rimborso delle somme eventualmente già versate in pendenza di giudizio (oltre interessi) . Se invece perde, come si diceva l’Agenzia può procedere alla riscossione ulteriore. In ogni caso, la parte soccombente può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Il giudizio di appello rivede nel merito e nel diritto la decisione di primo grado. Dopo la sentenza di appello, è ammesso infine il ricorso per Cassazione (entro 60 giorni) ma solo per motivi di legittimità (violazioni di legge o vizi di motivazione rilevanti): la Corte di Cassazione non rivede i fatti, ma assicura l’uniforme interpretazione delle norme. Una volta concluso il giudizio (o scaduti i termini per impugnare senza che sia stato proposto appello o ricorso ulteriore), l’accertamento diviene definitivo a tutti gli effetti.
Conciliazione giudiziale: durante il processo tributario le parti hanno un’ulteriore opportunità di accordo, detta conciliazione. Si tratta di un compromesso transattivo sulla pretesa fiscale, che può essere perfezionato in udienza oppure fuori udienza (per scambio di proposte scritte). La conciliazione può essere totale (chiude l’intera lite) o parziale (ad esempio, limita la contestazione ad alcuni rilievi). Se le parti (contribuente e ufficio) trovano un accordo, il giudizio si chiude con un verbale di conciliazione omologato dal giudice, avente efficacia di sentenza. I vantaggi della conciliazione sono: il contribuente ottiene uno sconto sulle sanzioni (ridotte al 40% del minimo in caso di conciliazione in primo grado, al 50% in caso di conciliazione in appello) e paga quanto concordato evitando ulteriori aggravi; l’ufficio incassa subito (o ratealmente in max 8 rate) le somme concordate evitando l’incertezza del giudizio. La conciliazione è spesso conveniente quando in corso di causa emergono elementi nuovi o quando entrambe le parti intravedono rischi nella prosecuzione del giudizio. Da notare che la conciliazione, a differenza dell’adesione, comporta il pagamento di una quota (seppur ridotta) di spese del processo di primo grado (il contributo unificato dovuto).
Costo del contenzioso e rischi: il processo tributario richiede il contributo di un difensore abilitato (avvocato tributarista, commercialista o altro professionista abilitato), tranne che per le liti di valore molto basso (fino a 3.000 €, per cui è ammessa l’autodifesa). Occorre mettere in conto, oltre alle imposte e interessi eventualmente dovuti, anche i costi di assistenza legale. La recente riforma ha reso la condanna alle spese una regola generale: la parte soccombente viene normalmente condannata a rimborsare le spese legali della controparte . In passato le spese erano spesso “compensate” (ognuno le pagava da sé), ma oggi il giudice tributario tende ad addebitare le spese a chi perde, salvo eccezioni. Inoltre, in caso di lite temeraria – ricorso pretestuoso o manifestamente infondato – il giudice può imporre a carico del contribuente soccombente un’ulteriore sanzione (ex art. 15, co.2-quater, D.Lgs. 546/92). Questo significa che il ricorso non va presentato superficialmente o solo per “prendere tempo”: è fondamentale valutare bene le chance di successo con il proprio difensore .
In conclusione, la fase del contenzioso tributario è quella in cui il contribuente, di fronte a un accertamento che ritiene ingiusto, fa valere in giudizio i propri diritti. È un campo tecnico e complesso, governato da regole formali stringenti e da un continuo aggiornamento giurisprudenziale. Affrontarlo con l’assistenza di un avvocato esperto in materia tributaria è praticamente indispensabile per costruire una difesa efficace, evitare errori procedurali e aumentare le probabilità di successo. La difesa in giudizio ben preparata può portare all’annullamento totale dell’avviso (se ne vengono riconosciute l’illegittimità o l’infondatezza) o quantomeno a una significativa riduzione delle somme dovute.
Difesa del contribuente a seconda della forma giuridica
Le strategie di difesa vanno calibrate anche in base alla tipologia del contribuente soggetto all’accertamento:
- Società di capitali (S.p.A., S.r.l., etc.): essendo persone giuridiche distinte, l’accertamento IRES colpisce direttamente la società. La difesa in questo caso può essere più articolata e coinvolgere profili aziendali complessi. Ad esempio, spesso per le società si contestano costi indeducibili (come spese non inerenti all’attività d’impresa) o ricavi sottratti mediante operazioni infragruppo potenzialmente elusive. In sede difensiva è cruciale esibire una contabilità accurata e documentazione di supporto per ogni operazione. Ad esempio, se il Fisco nega la deducibilità di alcuni costi (consulenze, sponsorizzazioni, royalties infragruppo), la società dovrà dimostrarne l’inerenza e la congruità al business . Nel caso di presunti utili dirottati all’estero (transfer pricing non allineato al valore di mercato tra consociate), potrebbero essere necessarie perizie tecniche a supporto. Va considerato anche il profilo penale: qualora l’accertamento rilevi evasioni oltre soglia (es. imposta evasa > 150.000 € per dichiarazione infedele), gli amministratori della società potrebbero incorrere in denunce penali (D.Lgs. 74/2000). In questi frangenti, una chiusura anticipata del contenzioso tributario (con acquiescenza o adesione) può talvolta giovare anche in sede penale (ad esempio, l’integrale pagamento del debito tributario estingue alcuni reati tributari) . Dunque per le società di capitali la difesa richiede un approccio integrato: contabile, legale-tributario e talvolta penale, con il coordinamento tra avvocati tributaristi e consulenti aziendali.
- Imprenditori individuali e ditte individuali: quando l’attività è esercitata in forma individuale (impresa “persona fisica”), l’accertamento colpisce direttamente la persona del titolare, con riflessi sia sul reddito d’impresa (soggetto a IRPEF) sia sul suo patrimonio personale. Spesso gli accertamenti verso ditte individuali nascono da analisi bancarie (movimentazioni sui conti personali non giustificate dai redditi dichiarati) o da indici di evasione rilevati (ad esempio, ricavi dichiarati molto inferiori agli studi di settore/ISA di categoria). In questi casi, una linea difensiva tipica consiste nel fornire spiegazioni credibili e documentate per giustificare eventuali “ricavi presunti”: ad esempio dimostrare che i versamenti sul conto personale provenivano da risparmi di famiglia, da disinvestimenti o da finanziamenti ricevuti (e non da vendite in nero) . Nell’accertamento “sintetico” del reddito personale (redditometro), l’imprenditore individuale può difendersi provando che il proprio tenore di vita (spese per immobili, auto, viaggi, etc.) è sostenuto da redditi esenti o da redditi di altri periodi, oppure da disponibilità patrimoniali pregresse . È importante, per l’imprenditore individuale, tenere ben separate le finanze dell’attività da quelle familiari: una contabilità chiara e l’uso di conti dedicati all’impresa aiutano molto in sede di verifica. In caso di esito sfavorevole del contenzioso, l’imprenditore risponde dei debiti tributari con tutti i suoi beni personali (essendo un soggetto unico), il che rende ancora più essenziale valutare con attenzione le opportunità di definizione agevolata o di accordo transattivo con l’ufficio.
- Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS): questi enti godono di un regime fiscale agevolato per le attività istituzionali (non profit) ma sono soggetti a IRES per le eventuali attività di natura commerciale. Le contestazioni del Fisco spesso mirano a dimostrare che l’ente, pur definendosi “non commerciale”, abbia svolto in realtà attività lucrative o che abbia indebitamente usufruito di esenzioni. Ad esempio, un’associazione culturale che incassa quote elevate da non soci per servizi, o una ONLUS che svolge attività commerciale concorrenziale, rischiano un accertamento che riqualifichi l’ente come commerciale, togliendo le esenzioni e tassando i proventi prima esenti . In sede difensiva, l’ente dovrà provare di aver rispettato i requisiti statutari e operativi per la qualifica non commerciale: dimostrare che eventuali ricavi “accessori” sono stati reinvestiti nelle finalità istituzionali, che non vi è stata distribuzione (neppure indiretta) di utili ai soci, e che le attività lucrative erano marginali e strumentali agli scopi ideali dell’ente. È essenziale esibire bilanci e rendiconti dettagliati, verbali assembleari e ogni prova che le entrate contestate abbiano natura istituzionale (o che le agevolazioni fiscali sono state applicate correttamente). In caso di esito negativo, l’ente non commerciale può vedersi recuperare l’IRES (al 24%) sui proventi riqualificati come commerciali, oltre a IVA e altre imposte eventualmente dovute, con un impatto finanziario potenzialmente grave. Per questo, la strategia preventiva migliore per gli enti è mantenere una netta separazione contabile tra attività istituzionali e commerciali e verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti di legge, così da poter resistere efficacemente a eventuali accertamenti.
Esempi pratici di difesa da accertamenti IRES
Di seguito presentiamo tre ipotetici scenari, ispirati a casi reali, per illustrare come le strategie difensive si applicano nella pratica:
Caso 1 – Verifica della Guardia di Finanza e nullità per vizio procedurale: Una S.r.l. manifatturiera subisce una verifica fiscale dalla GdF. Dal Processo Verbale di Constatazione (PVC) emerge che l’azienda avrebbe effettuato vendite in nero per 500.000 € in tre anni, basandosi sul ritrovamento di documentazione extracontabile. La società, entro 60 giorni dal PVC, presenta osservazioni contestando la ricostruzione: spiega che parte di quei documenti si riferivano a preventivi non accettati e che alcuni importi erano stati già contabilizzati regolarmente. Ciononostante l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento imputando ricavi non dichiarati per l’intero importo contestato (con relative sanzioni per infedele dichiarazione). L’avviso, tuttavia, viene emesso solo 30 giorni dopo la chiusura della verifica, violando il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente (art. 12, c.7). La società, con il supporto dell’avvocato, decide di impugnare l’avviso enfatizzando questo vizio procedurale oltre a riproporre le contestazioni di merito sulle cifre. In giudizio, la Commissione (Corte di Giustizia Tributaria) accerta la violazione del diritto al contraddittorio e dichiara nullo l’accertamento in toto, senza nemmeno bisogno di esaminare il merito della pretesa. L’Erario viene condannato alle spese. Commento:* questo caso evidenzia l’importanza di individuare eventuali vizi formali: la S.r.l. ha beneficiato di una “scappatoia” legale, evitando un’imposta robusta (circa 120.000 € di IRES evasa più IVA e sanzioni) grazie alla tutela procedurale violata dal Fisco.
Caso 2 – Accertamento da indagini finanziarie e difesa con prove documentali: Il sig. Bianchi è titolare di una ditta individuale (commercio al dettaglio) in contabilità semplificata. Un accertamento scaturisce dall’analisi del suo conto corrente personale: l’Agenzia delle Entrate rileva versamenti per 80.000 € in un anno, a fronte di ricavi dichiarati per solo 50.000 €. Presumendo che i 30.000 € di differenza siano ricavi non dichiarati, notifica un avviso di accertamento IRPEF recuperando tasse e sanzioni su tale importo. Bianchi, assistito dal suo difensore, predispone la difesa nel merito. Riesce a dimostrare, con estratti conto e bonifici, che quei 30.000 € derivavano in realtà da una serie di prestiti familiari: versamenti effettuati dai genitori e dalla sorella sul suo conto, allo scopo di aiutarlo ad acquistare un appartamento (operazione estranea all’attività d’impresa). Inoltre esibisce una scrittura privata di mutuo familiare, firmata all’epoca, e documenti che provano la capacità finanziaria dei parenti. Tali elementi vengono presentati nel ricorso, ribaltando la presunzione dell’Ufficio. In udienza, l’Agenzia riconosce la validità delle prove e accetta di conciliare la controversia: l’accertamento viene annullato limitatamente ai 30.000 € contestati (riconosciuti come non imponibili), mentre Bianchi accetta di versare una piccola integrazione per una lieve discordanza (5.000 € di ricavi sotto-fatturati che sono emersi durante il contraddittorio). Grazie alla conciliazione, le sanzioni su tale importo residuo vengono ridotte al 40% e Bianchi chiude la vicenda senza ulteriori strascichi. Commento: questo caso mostra l’efficacia della difesa basata su prove documentali precise*: il contribuente è riuscito a superare la presunzione di ricavi in nero fornendo una giustificazione concreta per le movimentazioni bancarie (onere che gli spetta, ai sensi dell’art. 32 DPR 600/73). La soluzione conciliativa in giudizio ha permesso inoltre di evitare sanzioni piene e ulteriori costi.
Caso 3 – Accertamento ad un ente non profit e soluzione parziale: L’Associazione “Sport&Salute” (ASD dilettantistica senza fini di lucro) riceve un accertamento IRES: il Fisco contesta che, negli anni 2021-22, l’ente abbia svolto attività commerciali mascherate, imponendole il pagamento dell’IRES su ricavi per 60.000 €. In particolare, vengono qualificati come redditi imponibili: (a) 40.000 € di “contributi volontari” ricevuti da aziende sponsor (secondo l’Ufficio sono sponsorizzazioni pubblicitarie tassabili); (b) 20.000 € incassati dall’ASD tramite una convenzione con un Comune per gestire un impianto sportivo (secondo l’Ufficio, attività commerciale di servizi). L’Associazione si oppone, sostenendo che quei proventi erano legati alle finalità istituzionali: gli sponsor hanno versato somme a titolo di liberalità in cambio solo di minima visibilità (dunque da considerare erogazioni liberali, esenti ai sensi dell’art. 143 TUIR), mentre la convenzione col Comune rientrava nell’attività sportiva sociale. In sede di adesione, l’ASD documenta che il 100% di tali somme è stato reinvestito in attività sportive gratuite per i soci e nella manutenzione dell’impianto (presenta bilanci, ricevute di spesa, foto degli eventi finanziati). Evidenzia inoltre che sul punto (b) l’ASD agiva quale braccio operativo del Comune senza scopo di lucro. L’Ufficio, riconoscendo parte delle argomentazioni, rivede al ribasso la pretesa: in sede di accertamento con adesione si raggiunge l’accordo per tassare solo 30.000 € (viene accertata la natura commerciale delle sponsorizzazioni per 30.000 €, ma riconosciuto il carattere istituzionale del resto). Le sanzioni sul dovuto vengono ridotte ad 1/3 e l’Associazione evita il contenzioso. Commento: la difesa degli enti non commerciali richiede di provare concretamente la coerenza delle entrate con gli scopi istituzionali. In questo scenario, grazie alla collaborazione in sede di adesione, si è ottenuto un risultato equilibrato: il Fisco ha riconosciuto la buona fede dell’ente su una parte dei proventi, mentre l’ente ha accettato di tassare la quota effettivamente assimilabile ad attività commerciale (scongiurando però conseguenze più gravi, come la perdita totale della qualifica di ente non commerciale).
Domande frequenti (FAQ)
D: Cos’è l’IRES e chi è tenuto a pagarla?
R: IRES è l’Imposta sul Reddito delle Società, dovuta dai soggetti IRES: società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), enti pubblici e privati che svolgono attività commerciali, e dagli enti non commerciali (limitatamente ai redditi di natura commerciale). L’aliquota d’imposta è pari al 24%. Attenzione: la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha introdotto una riduzione d’aliquota al 20% per le imprese che reinvestono parte significativa dei propri utili in beni strumentali e nuova occupazione (la cosiddetta “IRES premiale”) . Le persone fisiche (imprenditori individuali, professionisti) non pagano IRES ma IRPEF sui redditi d’impresa; tuttavia un accertamento fiscale sulle loro attività segue logiche simili a quelle IRES.
D: Entro quando può essere notificato un avviso di accertamento IRES?
R: Di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi oggetto di controllo . Ad esempio, per un’IRES 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) il termine è il 31/12/2026. Se la dichiarazione per l’anno in questione non è stata presentata (omessa) o è nulla, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo . Tali termini ordinari possono essere raddoppiati (quindi 10 anni in caso di dichiarazione presentata, 14 anni se omessa) qualora l’Ufficio riscontri una violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per un reato tributario previsto dal D.Lgs. 74/2000 . In pratica, se l’evasione configura un reato (es. dichiarazione fraudolenta, occultamento di attività), il Fisco ha più tempo per accertare. Oltre questi termini l’accertamento è nullo, ma bisogna fare attenzione: se il contribuente riceve un PVC o un invito al contraddittorio, i termini di decadenza si estendono di 120 giorni (per effetto dell’art. 3, co.3-bis, D.Lgs. 218/97).
D: Che succede se ignoro o non impugno l’avviso di accertamento?
R: Se entro 60 giorni non presenti ricorso (né hai attivato adesione o altre definizioni), l’accertamento diventa definitivo . Ciò significa che l’imposta, le sanzioni e gli interessi accertati diventano un debito esigibile a tutti gli effetti. L’Agenzia iscriverà le somme a ruolo e incaricherà l’Agente della Riscossione di recuperarle coattivamente. Potresti dunque ricevere una cartella di pagamento trascorso qualche mese. In mancanza di pagamento, si attiveranno misure cautelari ed esecutive: ad esempio il fermo amministrativo dei tuoi automezzi, l’ipoteca su tuoi immobili e il pignoramento di conti correnti, stipendi, crediti verso clienti, ecc. Ignorare l’accertamento non è mai consigliabile: anche in caso di difficoltà economica, è preferibile attivarsi per ottenere una rateazione o cercare una soluzione con l’ufficio (ad esempio attraverso l’adesione) piuttosto che subire inerzialmente la riscossione forzata.
D: È possibile rateizzare le somme di un accertamento?
R: Sì. In fase amministrativa, sia con l’acquiescenza che con l’accertamento con adesione, la legge consente un pagamento rateale fino a 8 rate trimestrali (estese a 16 rate se l’importo dovuto supera 50.000 €) . In sede di conciliazione giudiziale il pagamento può parimenti essere dilazionato in 8 rate trimestrali. Inoltre, se l’accertamento viene iscritto a ruolo (cioè trasmesso all’Agente della Riscossione dopo la definitività), è possibile chiedere una rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili (6 anni) – concessa di solito per debiti oltre 120 €, previa dimostrazione di difficoltà – oppure, in casi di grave e comprovata situazione di precarietà, piani straordinari fino a 120 rate (10 anni). Va ricordato che la prima rata di acquiescenza/adesione va versata entro 60 giorni dall’avviso (termine di impugnazione) e che il mancato pagamento di anche una sola rata successiva fa decadere dal beneficio, rendendo immediatamente dovuto il residuo con sanzioni piene.
D: Come si calcolano le sanzioni in caso di definizione agevolata?
R: Dipende dallo strumento utilizzato: – Con acquiescenza o accertamento con adesione, le sanzioni vengono ridotte ad 1/3 di quelle originariamente irrogate . Ad esempio, se nell’avviso era stata contestata una sanzione del 90% sull’imposta evasa, con l’adesione la pagherai al 30%.
– Con adesione integrale al PVC (definizione agevolata del processo verbale prima dell’avviso), le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo previsto .
– Con definizione agevolata dell’invito al contraddittorio (art. 5, co.1-bis, D.Lgs. 218/97), le sanzioni scendono a 1/8 del minimo.
– Con conciliazione giudiziale, in caso di accordo in primo grado le sanzioni sono dovute al 40% (riduzione del 60%) e in appello al 50% (riduzione del 50%) .
Queste riduzioni riguardano solo le sanzioni amministrative tributarie. Interessi e altri oneri (aggo, spese di notifica) restano dovuti per intero, ma naturalmente riducendosi la base imponibile e le sanzioni si riduce l’ammontare su cui gli interessi maturano. Va aggiunto che, in caso di definizione (acquiescenza/adesione), l’importo delle sanzioni ridotte deve essere versato nei termini previsti: diversamente, la definizione non si perfeziona e si decade dal beneficio.
D: Quali sono i vizi formali più comuni che possono invalidare un accertamento?
R: I principali sono:
– Difetto di motivazione (art. 7 L.212/2000) – l’atto non espone chiaramente i fatti accertati e le norme applicate, oppure richiama altri atti (es. PVC) senza allegarli né averli notificati al contribuente . Ciò lede il diritto di difesa e comporta nullità assoluta dell’avviso.
– Violazione del contraddittorio – ad esempio, avviso emanato prima dei 60 giorni dal PVC in assenza di urgenza dimostrata , oppure omesso invito al contraddittorio obbligatorio (per atti dal 2020 in poi) senza circostanze eccezionali. Tali violazioni rendono l’atto annullabile dal giudice (nullità relative), previa valutazione dell’effettivo pregiudizio difensivo subito dal contribuente (c.d. prova di resistenza, salvo i casi di nullità ex lege come per il PVC).
– Vizi di notifica – se l’avviso non viene notificato correttamente (esempio: inviato alla persona o all’indirizzo sbagliati, o consegnato oltre i termini), può risultare inesistente o nullo. Ad esempio, una notifica via PEC a un indirizzo non appartenente al contribuente è giuridicamente inesistente.
– Mancanza di sottoscrizione o incompetenza – se l’atto non è firmato da un dirigente/funzionario delegato dell’AdE territorialmente competente, viola l’art. 42 DPR 600/73 e la giurisprudenza lo considera nullo. Questo vizio fu al centro delle note sentenze sulle “deleghe di firma” invalide (Corte Cass. nn. 22800/2015 e simili).
– Errori grossolani o doppie imposizioni – casi in cui il Fisco richiede importi evidentemente non dovuti, ad esempio tassando due volte lo stesso reddito o attribuendo al contribuente redditi di un terzo omonimo. Tali atti, se non corretti in autotutela, vengono annullati in giudizio.
In generale, quando un accertamento presenta vizi formali, è necessario comunque impugnarlo nei termini: l’atto nullo, infatti, non viene annullato d’ufficio dall’Amministrazione e se il contribuente non reagisce può diventare definitivo .
D: L’accertamento IRES può riguardare anche l’IVA e altre imposte?
R: Sì, spesso gli avvisi di accertamento per i redditi sono “plurimi”, cioè includono rilievi anche ai fini IVA, IRAP o altri tributi collegati. Ciò avviene perché da un medesimo fatto (es. un ricavo non dichiarato) derivano tipicamente violazioni plurime: imposta sui redditi evasa, IVA sulle vendite evasa, eventuale IRAP non versata, ecc. L’avviso indica per ciascun tributo la maggiore imposta e le sanzioni. Dal punto di vista difensivo, ci si difende sul fatto generatore dell’imponibile (esempio: se dimostri che il ricavo contestato in realtà non esiste, cadono sia l’IRES che l’IVA). Occorre però fare attenzione alle peculiarità dei singoli tributi: per l’IVA, ad esempio, valgono rigidi obblighi di contraddittorio derivati dal diritto UE (un avviso IVA senza previa convocazione può essere nullo senza prova di resistenza) ; per l’IRAP, la contestazione può riguardare la presenza di un’autonoma organizzazione, ecc. In caso di definizione (adesione, conciliazione) è prassi risolvere insieme tutti i rilievi tributari per chiudere completamente la vertenza. Se invece alcuni aspetti restano in sospeso (es. si definisce l’IRES ma si litiga sull’IVA), bisognerà proseguire il contenzioso per quella parte residua.
D: Un accertamento fiscale può portare a conseguenze penali?
R: Sì, quando l’evasione contestata supera certe soglie o avviene con modalità fraudolente previste dalla legge penale tributaria (D.Lgs. 74/2000). Ad esempio, la dichiarazione infedele oltre la soglia di 100.000 € d’imposta evasa (per IRES/IRPEF) o 50.000 € per IVA è reato; l’omessa dichiarazione oltre 50.000 € di imposta evasa è reato; l’uso di fatture false o l’occultamento di scritture configurano reati di frode fiscale, ecc. In tali casi l’Agenzia delle Entrate trasmette una notizia di reato alla Procura. Il procedimento penale segue il suo corso (indagini, eventuale processo), indipendente dall’esito del contenzioso tributario. Tuttavia vi è interazione: se il contribuente definisce l’accertamento e paga il dovuto, questo può incidere positivamente sul penale. La legge prevede cause di non punibilità o attenuanti per chi estingue il debito tributario: ad esempio, pagare integralmente imposte e interessi prima dell’apertura del dibattimento estingue i reati di omesso versamento e dichiarazione infedele, e attenua la pena per alcuni altri (riduzione fino a metà) . Viceversa, una sentenza penale di assoluzione perché “il fatto non sussiste” (es: non c’era evasione) può giovare in sede tributaria se ottenuta prima della definizione. In sintesi, l’accertamento fiscale e il procedimento penale viaggiano su binari paralleli ma connesi: in situazioni del genere è cruciale che l’avvocato tributarista e l’eventuale avvocato penalista del contribuente coordinino la strategia difensiva.
D: Perché è importante farsi assistere da un avvocato esperto in questi casi?
R: Perché la materia è complessa e costellata di insidie procedurali. Un avvocato tributarista conosce sia le strategie sostanziali (quali prove fornire, come contestare efficacemente le pretese nel merito) sia i cavilli formali che possono annullare l’atto (vizi di notifica, termini decadenziali, difetti di motivazione, ecc.). Inoltre, un professionista esperto sa valutare obiettivamente le possibilità di successo e consigliare la via migliore: ad esempio, quando conviene trattare con l’ufficio per una soluzione transattiva e quando invece è preferibile andare in giudizio. Sa anche gestire gli aspetti tecnici del processo tributario (depositi telematici, osservanza dei termini perentori, calcoli di imposte e sanzioni) evitando errori fatali. Infine, avere un rappresentante qualificato dà al contribuente maggiore forza nei confronti dell’Amministrazione, spesso favorendo anche esiti conciliativi più vantaggiosi. In definitiva, per difendersi bene e subito da un accertamento fiscale, il ruolo di un difensore competente è centrale e – considerati i valori in gioco – di norma vale l’investimento.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Statuto dei diritti del contribuente: Legge 27 luglio 2000 n.212, art. 7 (obbligo di motivazione degli atti) e art. 12 (garanzie nelle verifiche fiscali) .
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600: Disposizioni comuni sull’accertamento delle imposte sui redditi – in particolare artt. 32 (poteri istruttori, indagini finanziarie) , 38 (accertamento sintetico persone fisiche), 39 (metodi di accertamento analitico e induttivo) , 41 e 41-bis (accertamento d’ufficio e parziale) , 42 (motivazione e sottoscrizione avvisi) e 43 (termini di decadenza dell’accertamento) .
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218: Definizione degli accertamenti – disciplina dell’adesione all’accertamento e altre procedure deflattive (accertamento con adesione, art. 6; adesione ai PVC, art. 5-bis; acquiescenza, art. 15) .
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: Processo tributario – si vedano in particolare art. 17-bis (reclamo e mediazione, abrogato dal 2024 ), art. 22 (costituzione in giudizio del ricorrente), art. 47 (sospensione giudiziale dell’atto impugnato) , art. 48 (conciliazione giudiziale), art. 68 (riscossione frazionata in pendenza di giudizio) , art. 15 (condanna alle spese e lite temeraria) .
- Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 (conv. L.58/2019): art. 4-octies – Introduzione dell’obbligo di invito al contraddittorio per accertamenti fiscali (in vigore dal 1° luglio 2020) .
- Legge 31 agosto 2022 n. 130: Riforma della giustizia tributaria – ha previsto nuove Corti di Giustizia Tributarie professionali, giudice monocratico per cause < €5.000, principio della soccombenza per le spese , ammissibilità della prova testimoniale scritta , ecc. (attuata con D.Lgs. nn. 119-120-121-218/2023 e D.Lgs. 156/2023).
- D.Lgs. 8 ottobre 2021 n. 156: Modifiche alla riscossione in pendenza di giudizio – ha portato dall’1/3 al 50% la quota di imposta riscuotibile dopo la sentenza di primo grado (adeguando l’art. 68 D.Lgs. 546/92).
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149: (Riforma processo civile) – ha introdotto nel processo tributario l’istituto della testimonianza scritta (modifica all’art. 7 D.Lgs. 546/92) .
- D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 119: Inserimento dell’art. 6-bis nello Statuto contribuente – obbligo generale di contraddittorio per tutti gli atti impositivi impugnabili (dal 2024), salvo atti automatizzati e casi di motivata urgenza .
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74: Reati tributari – si vedano art. 13 (cause di non punibilità in caso di pagamento del debito tributario) e le soglie di punibilità per omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, frode fiscale, ecc.
Giurisprudenza principale:
- Cass., Sez. Un., 09/12/2015 n. 24823: In tema di verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale generalizzato solo per i tributi “armonizzati” (IVA); per quelli “non armonizzati” (es. IRES, IRAP) non sussiste un analogo obbligo generale, salvo specifica previsione normativa . Di conseguenza, la violazione del contraddittorio comporta invalidità dell’atto esclusivamente se il contribuente indica concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere (principio della “prova di resistenza”) .
- Cass., Sez. Un., 17/02/2010 n. 3676: La mancata convocazione del contribuente a seguito di istanza di accertamento con adesione (art. 6, co. 4, D.Lgs. 218/97) non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge .
- Cass., Sez. V, 25/10/2024 n. 27692: Per legittimare un accertamento induttivo (ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/73) è necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino incongruenze o irregolarità nella contabilità del contribuente. La ricostruzione del reddito basata su presunzioni deve rispettare requisiti di certezza e univocità dei fatti noti, non essendo sufficiente un calcolo induttivo generico o non supportato da riscontri oggettivi; inoltre gli elementi utilizzati devono essere comunicati e adeguatamente motivati nell’avviso, pena l’illegittimità dell’atto .
- Cass., Sez. V, 11/09/2018 n. 22109: L’avviso di accertamento è nullo se non risulta allegato (né previamente notificato) il PVC redatto nei confronti di un terzo e richiamato quale fondamento della pretesa. Il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell’atto impositivo e, di conseguenza, anche gli atti istruttori essenziali su cui si basa .
- Cass., Sez. V, 05/05/2017 n. 10701: In tema di indagini finanziarie, l’art. 32 DPR 600/73 pone una presunzione legale relativa: i versamenti su conti del contribuente si presumono redditi evasivi, salvo prova contraria analitica fornita dal contribuente; i prelevamenti ingiustificati (oltre soglie) si presumono utilizzati per spese non dichiarate (acquisti in nero) e quindi generatori di ricavi evasi . Tali presunzioni, secondo la Corte Cost. 228/2014, sono compatibili con i principi costituzionali purché il contribuente sia posto in grado di vincerle fornendo giustificazioni idonee.
- Cass., Sez. V, 20/04/2018 n. 9851: In materia di enti non commerciali, l’Amministrazione può disconoscere la qualifica de iure di ente non commerciale se accerta che, de facto, l’attività svolta è di natura commerciale e l’ente opera come un normale operatore economico. In tal caso, i proventi “istituzionali” sono tassati e le agevolazioni (esenzioni ex art. 143 TUIR) non spettano .
- Corte Cost., 07/03/2018 n. 42: Ha dichiarato illegittimo l’art. 92, c.2, c.p.c. (applicabile al processo tributario) nella parte in cui consentiva la compensazione delle spese di giudizio senza adeguata motivazione. Ciò ha spianato la strada al principio per cui nel contenzioso tributario la compensazione è ammessa solo in casi eccezionali e la regola è la condanna alle spese della parte soccombente .
- Corte Cost., 23/06/2015 n. 132: Ha affermato che l’art. 12, c.7, L. 212/2000 (termine 60 giorni post-PVC) non è costituzionalmente necessario per i tributi “non armonizzati”: la sua violazione non comporta ex se nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa, salvo che il legislatore disponga diversamente. (Dopo tale pronuncia, sono intervenute Cass. SS.UU. 24823/2015 e la riforma del 2023 con l’art. 6-bis Statuto, che hanno in parte superato la distinzione).
Hai ricevuto un avviso di accertamento IRES da parte dell’Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento IRES da parte dell’Agenzia delle Entrate?
👉 Si tratta di un controllo fiscale che riguarda le imposte sui redditi delle società e può avere conseguenze economiche molto pesanti.
In questa guida ti spiego cos’è l’accertamento IRES, quando è legittimo, e soprattutto come difenderti subito e in modo efficace con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario.
💥 Cos’è l’Accertamento IRES
L’accertamento IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica il reddito imponibile dichiarato da una società di capitali, come S.r.l., S.p.A., S.a.p.a. o enti equiparati.
📌 L’obiettivo dell’Amministrazione è verificare se il reddito dichiarato corrisponde a quello effettivo, e recuperare eventuali imposte non versate, deduzioni non spettanti o costi fittizi.
Le cause più comuni di accertamento IRES sono:
- costi o fatture ritenuti inesistenti o non documentati;
- ricavi non dichiarati o contabilizzati parzialmente;
- operazioni con società collegate o estere;
- compensi non congrui agli amministratori o soci;
- utili extracontabili o movimentazioni bancarie sospette.
⚖️ Quando l’Accertamento IRES è Legittimo
L’Agenzia delle Entrate può emettere un accertamento IRES solo se:
- possiede prove certe o presunzioni gravi, precise e concordanti;
- ha rispettato il contraddittorio obbligatorio con la società (art. 12, L. 212/2000);
- l’atto è motivato in modo chiaro e completo;
- viene notificato entro i termini di decadenza (di norma 5 anni).
📌 Se manca uno di questi requisiti, l’accertamento è nullo per vizio formale o sostanziale e può essere impugnato.
💠 Tipologie di Accertamento IRES
🔹 Accertamento Analitico
Si basa sulla revisione dei dati contabili e dei bilanci.
L’Agenzia rettifica singole voci di reddito o di costo.
🔹 Accertamento Analitico-Induttivo
Usato quando la contabilità è formalmente regolare, ma ritenuta inattendibile.
L’Agenzia integra i dati con presunzioni e analisi comparate.
🔹 Accertamento Induttivo Puro
Applicato nei casi più gravi, quando la contabilità è omessa o falsificata.
L’Ufficio ricostruisce il reddito societario in base a indagini bancarie o dati extracontabili.
📌 In ogni caso, l’accertamento deve essere specificamente motivato e supportato da prove reali, non solo da statistiche o sospetti.
⚠️ Le Conseguenze per la Società e gli Amministratori
Un accertamento IRES può avere conseguenze molto rilevanti:
- 💰 Recupero di imposte evase o non versate;
- ⚖️ Sanzioni fiscali fino al 240% dell’imposta accertata;
- 📈 Interessi e aggi fiscali;
- 🏦 Cartelle esattoriali, fermi o pignoramenti;
- 🚫 Possibile responsabilità personale dell’amministratore o del socio, in caso di dolo o distrazione di fondi.
📌 Tuttavia, con una difesa tempestiva e documentata è possibile bloccare la riscossione e ridurre drasticamente le somme richieste.
🧩 Le Strategie di Difesa Possibili
1️⃣ Controllare la Legittimità dell’Atto
L’avvocato verifica se l’avviso:
- rispetta i termini di legge e la procedura;
- contiene una motivazione adeguata e dettagliata;
- è stato firmato da un funzionario legittimato;
- si basa su prove effettive e non su presunzioni arbitrarie.
📌 Anche un piccolo vizio formale può determinare l’annullamento integrale dell’accertamento.
2️⃣ Dimostrare la Correttezza della Contabilità
La società può difendersi dimostrando che:
- i costi contestati sono effettivi e documentati;
- le operazioni sono reali e regolarmente fatturate;
- eventuali scostamenti sono dovuti a errori materiali o a crisi di settore.
📌 Una contabilità coerente e completa è la migliore prova contro le presunzioni del Fisco.
3️⃣ Contestare gli Errori di Calcolo e le Presunzioni
Spesso gli accertamenti IRES si basano su:
- analisi di margini medi del settore;
- studi di settore o indici ISA non aggiornati;
- incroci bancari mal interpretati.
📌 L’avvocato può contestare questi dati e dimostrare che non riflettono la reale situazione economica della società.
4️⃣ Impugnare l’Avviso di Accertamento
Puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo:
- la sospensione immediata della riscossione;
- l’annullamento totale o parziale dell’avviso;
- la condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio.
📌 In casi urgenti, il giudice può sospendere l’esecuzione entro 48 ore.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Copia dell’avviso di accertamento IRES ricevuto;
- Bilanci e scritture contabili;
- Fatture e contratti relativi ai costi contestati;
- Estratti conto bancari e giustificativi dei movimenti;
- Comunicazioni e verbali di verifica dell’Agenzia o della Guardia di Finanza.
📌 Una difesa efficace parte da un’analisi completa e documentata di tutti gli elementi contabili e fiscali.
⏱️ Tempi della Procedura
- Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: decisione in 48 ore nei casi urgenti;
- Udienza di merito: entro 6–12 mesi circa;
- Appello o Cassazione: per vizi di diritto o errori procedurali.
📌 Durante la sospensione cautelare, l’Agenzia non può riscuotere né avviare pignoramenti.
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✅ Blocco immediato della riscossione e delle sanzioni.
✅ Riduzione o annullamento dell’imposta accertata.
✅ Tutela del patrimonio aziendale e personale.
✅ Difesa tecnica in ogni grado di giudizio.
✅ Protezione della società da ulteriori controlli e danni d’immagine.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare l’avviso o confidare in una successiva “autotutela”.
❌ Non fornire prove contabili precise e documentate.
❌ Affrontare l’accertamento senza un avvocato specializzato.
❌ Presentare il ricorso fuori termine.
📌 L’accertamento IRES è una materia complessa: una difesa legale tempestiva e tecnica può cambiare completamente l’esito del procedimento.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la legittimità dell’accertamento e la coerenza dei rilievi fiscali.
📌 Ti assiste nella fase di contraddittorio e nella raccolta delle prove difensive.
✍️ Redige e deposita il ricorso con richiesta di sospensione immediata.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in ogni grado.
🔁 Ti segue fino all’annullamento definitivo dell’atto o alla chiusura della procedura.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e contenzioso societario.
✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti IRES, IVA e IRAP.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di società, amministratori e professionisti contro l’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Un accertamento IRES non è una condanna: con un’azione legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, contestare le presunzioni infondate e ottenere l’annullamento dell’atto.
La chiave è agire subito, con una strategia tecnica basata su prove contabili solide e difesa specializzata.
⏱️ Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso: ogni giorno è prezioso.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro l’accertamento IRES può partire oggi stesso.