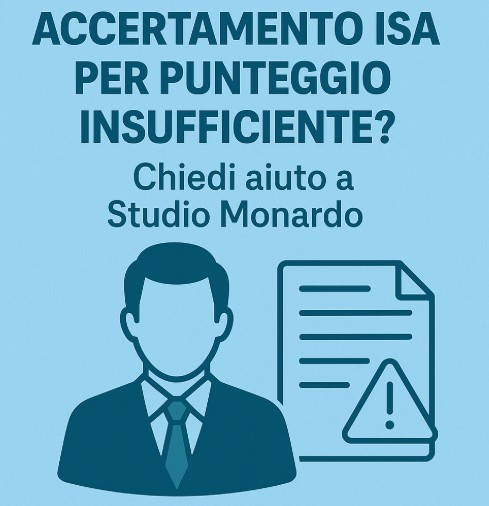Hai ricevuto un avviso di accertamento ISA dall’Agenzia delle Entrate a causa di un punteggio di affidabilità fiscale basso? Si tratta di un controllo basato sugli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il sistema che ha sostituito gli studi di settore, con cui il Fisco valuta la coerenza e la veridicità dei dati dichiarati da imprese e professionisti.
In pratica, se il tuo punteggio ISA risulta troppo basso (inferiore a 6), l’Agenzia presume che la tua attività non sia fiscalmente affidabile e può procedere a un accertamento per maggiori redditi o ricavi. Tuttavia, un punteggio basso non è una prova di evasione, ma solo un indizio statistico, e può essere contestato e neutralizzato con una difesa tecnica efficace e l’assistenza di un avvocato esperto in diritto tributario.
Cos’è l’accertamento ISA e cosa significa un punteggio basso
Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate per valutare il livello di affidabilità fiscale dei contribuenti.
Ogni anno, le imprese e i professionisti compilano il modello ISA, che restituisce un punteggio da 1 a 10, in base alla coerenza dei dati contabili, economici e strutturali dichiarati.
Un punteggio alto (da 8 a 10) indica affidabilità e può garantire benefici fiscali (meno controlli, priorità nei rimborsi, esclusione da alcuni accertamenti).
Un punteggio basso (da 1 a 5) invece segnala possibili incongruenze e può attivare un accertamento induttivo o analitico da parte dell’Agenzia.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che gli ISA non costituiscono prova certa di evasione, ma solo presunzioni semplici, e il contribuente ha pieno diritto di dimostrare la correttezza dei propri redditi dichiarati.
Quando scatta l’accertamento ISA per punteggio insufficiente
L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento se:
- il punteggio ISA è costantemente basso per due o più anni;
- ci sono scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e quello stimato dal modello;
- emergono incongruenze nei dati contabili o tra diverse annualità;
- risultano anomalie negli indicatori di affidabilità e coerenza (es. margini, ricarichi, costi anomali).
In questi casi, l’Ufficio può convocarti per fornire spiegazioni o emettere direttamente un avviso di accertamento fondato sulle risultanze ISA.
Come funziona la procedura di accertamento ISA
- Analisi dei punteggi e degli indicatori: l’Agenzia individua i contribuenti con punteggio ISA basso o incoerente.
- Eventuale invito al contraddittorio: il Fisco ti invita a spiegare le anomalie o a giustificare le differenze tra reddito dichiarato e stimato.
- Valutazione delle giustificazioni: puoi dimostrare, con documenti o relazioni tecniche, che il tuo punteggio basso dipende da fattori reali.
- Emissione dell’avviso di accertamento: se l’Ufficio non accoglie le tue spiegazioni, emette l’atto di accertamento.
- Ricorso entro 60 giorni: puoi impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e chiedere la sospensione della riscossione.
Quando l’accertamento ISA è legittimo
Un accertamento basato sugli ISA è legittimo solo se:
- è preceduto da contraddittorio preventivo con il contribuente;
- l’Ufficio motiva chiaramente le ragioni per cui il punteggio basso giustifica l’accertamento;
- l’atto si fonda su elementi concreti e individualizzati, non solo su medie statistiche;
- vengono considerate le spiegazioni e le prove contrarie fornite dal contribuente;
- sono rispettati i termini di decadenza per l’accertamento.
Se l’avviso si basa unicamente sul punteggio ISA senza altri riscontri oggettivi, è illegittimo e annullabile.
Quando l’accertamento ISA è nullo o impugnabile
Puoi impugnare l’avviso se presenta uno dei seguenti vizi:
- assenza di contraddittorio preventivo;
- mancanza di motivazione sull’origine e il significato del punteggio basso;
- utilizzo di dati errati, incoerenti o riferiti a modelli non aggiornati;
- mancata valutazione delle prove fornite;
- applicazione automatica degli ISA senza considerare la specificità dell’attività;
- superamento dei termini di notifica o decadenza.
La Corte di Cassazione ha stabilito che un punteggio ISA basso non può da solo giustificare un accertamento, se non è accompagnato da ulteriori elementi concreti di incoerenza o evasione.
Le conseguenze di un accertamento ISA
Un accertamento basato su punteggio insufficiente può comportare:
- maggiori imposte da versare (IRPEF, IRES, IVA, IRAP);
- sanzioni amministrative fino al 240% dell’imposta accertata;
- interessi di mora e iscrizione a ruolo;
- cartelle esattoriali e pignoramenti;
- segnalazioni al sistema di rischio fiscale per future verifiche.
Difendersi subito è essenziale per bloccare la riscossione e contestare la legittimità dell’atto.
Come difendersi da un accertamento ISA
Un avvocato tributarista può predisporre una difesa personalizzata ed efficace, basata su:
- Verifica della procedura: controllo della regolarità del contraddittorio e della motivazione dell’atto.
- Analisi tecnica del modello ISA: verifica della correttezza dei dati utilizzati e dell’applicazione del modello.
- Dimostrazione di circostanze specifiche: crisi di mercato, perdita di clienti, lavori stagionali, pandemia, malattia, eventi straordinari.
- Contestazione delle presunzioni statistiche: gli ISA si basano su modelli medi, non sulla realtà del singolo contribuente.
- Richiesta di sospensione della riscossione: per evitare pagamenti o pignoramenti durante il ricorso.
Le strategie difensive più efficaci
- Dimostrare che il punteggio basso deriva da fattori temporanei o non imputabili al contribuente;
- Evidenziare errori o incoerenze nei dati ISA utilizzati;
- Contestare la violazione del contraddittorio preventivo;
- Produrre documenti contabili e relazioni tecniche che giustifichino i risultati economici;
- Invocare la giurisprudenza che nega valore probatorio autonomo agli ISA;
- Richiedere la sospensione cautelare per bloccare la riscossione.
Come scegliere l’avvocato giusto per difendersi
Per affrontare un accertamento ISA è fondamentale affidarsi a un legale con:
- specializzazione in diritto tributario e contenzioso fiscale;
- esperienza nei ricorsi contro accertamenti basati su studi di settore o ISA;
- capacità di analisi economico-finanziaria e collaborazione con commercialisti;
- conoscenza aggiornata della giurisprudenza tributaria;
- competenze negoziali per eventuali definizioni agevolate o adesioni.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un accertamento ISA comporta:
- formazione del ruolo esecutivo e cartelle esattoriali;
- pignoramenti e ipoteche;
- perdita del diritto di ricorso entro 60 giorni;
- sanzioni e interessi crescenti;
- peggioramento del profilo di rischio fiscale per gli anni successivi.
Una difesa tempestiva consente invece di contestare l’illegittimità dell’atto, bloccare la riscossione e dimostrare la correttezza della tua posizione.
Quando rivolgersi a un avvocato
Devi contattare un avvocato se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento basato su punteggio ISA basso;
- sei stato convocato per contraddittorio su anomalie ISA;
- vuoi dimostrare che il tuo reddito è coerente con l’attività reale;
- devi sospendere la riscossione o impugnare l’avviso entro 60 giorni.
Un avvocato esperto in diritto tributario può:
- impugnare l’avviso e chiedere la sospensione cautelare;
- dimostrare che il punteggio ISA non riflette la realtà economica della tua impresa;
- ottenere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento;
- tutelarti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione.
⚠️ Attenzione: un punteggio ISA basso non equivale a evasione. È solo un indicatore statistico che non può giustificare un accertamento se privo di riscontri concreti. Agisci subito: con una difesa tecnica mirata puoi annullare l’avviso e proteggere il tuo patrimonio.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e difesa contro accertamenti ISA – spiega cos’è l’accertamento per punteggio insufficiente, quando è illegittimo e come difendersi efficacemente con l’assistenza di un avvocato specializzato.
👉 Hai ricevuto un avviso di accertamento per punteggio ISA basso?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo i punteggi, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia personalizzata per impugnare l’atto, sospendere la riscossione e difendere i tuoi diritti fiscali.
Introduzione
Gli studi di settore sono stati introdotti in Italia negli anni ’90 come strumenti statistico-predittivi per stimare il reddito “normale” di imprese e lavoratori autonomi sulla base delle caratteristiche dell’attività esercitata (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997). A partire dal periodo d’imposta 2018, tuttavia, i tradizionali studi di settore sono stati sostituiti dai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 . Gli ISA attribuiscono a ciascun contribuente un punteggio da 1 a 10 in base a molteplici indicatori economici e contabili, indicativo del grado di affidabilità fiscale. Di fatto, studi di settore e ISA operano come presunzioni semplici sul reddito: se il reddito dichiarato da un contribuente si discosta significativamente dal reddito “standard” atteso per il suo profilo, l’Agenzia delle Entrate può attivare una verifica. In particolare, l’Ufficio invierà normalmente un invito al contraddittorio (cioè a un confronto) indicando gli esiti dell’applicazione dello studio di settore o dell’ISA, e – qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute sufficienti – potrà emettere un avviso di accertamento che ridetermina il reddito imponibile secondo quei parametri presuntivi .
Dal punto di vista del contribuente (sia esso imprenditore, professionista o altro soggetto economico), difendersi bene e subito di fronte a un accertamento fondato su studi di settore/ISA significa innanzitutto attivarsi prontamente fin dal contraddittorio preventivo con l’Amministrazione finanziaria. È in quella fase, infatti, che il contribuente ha la prima – e fondamentale – opportunità di far valere le proprie ragioni prima che l’accertamento diventi definitivo. Fornire tempestivamente all’Ufficio tutte le spiegazioni, i dati e i documenti che giustificano lo scostamento dai parametri standard è cruciale per evitare o ridurre sul nascere la pretesa fiscale. Se, nonostante le spiegazioni, l’atto impositivo viene comunque notificato, il contribuente dovrà poi valutare le strategie di impugnazione davanti alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) entro i termini di legge, al fine di far valere l’illegittimità o l’infondatezza dell’accertamento.
Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – analizza in modo approfondito la disciplina vigente in materia di accertamenti “standardizzati” basati su studi di settore e ISA, con un taglio avanzato ma di taglio pratico-divulgativo. Verranno esaminati i riferimenti normativi italiani rilevanti, il funzionamento degli ISA e il loro rapporto con gli accertamenti analitico-induttivi, nonché i più recenti orientamenti giurisprudenziali (dalla Corte di Cassazione alle Corti di giustizia tributaria di merito) fino alle novità del 2024–2025. Ampio spazio sarà dedicato alle strategie difensive, sia nella fase del contraddittorio amministrativo sia in sede di contenzioso, sempre dal punto di vista del contribuente (il “debitore” dell’obbligazione tributaria). Completano l’opera esempi pratici, tabelle riepilogative, una sezione di Domande e Risposte sui quesiti più frequenti e un elenco delle fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli e aggiornate (comprese le ultime sentenze) per ulteriori approfondimenti. L’obiettivo è offrire a professionisti (avvocati tributaristi, dottori commercialisti) e contribuenti esperti uno strumento completo per comprendere come difendersi al meglio e tempestivamente di fronte a un accertamento basato su studi di settore o ISA, sfruttando tutte le garanzie previste dall’ordinamento.
Normativa di riferimento
- Fonti legislative principali: La disciplina degli accertamenti tributari è contenuta nel D.P.R. 600/1973. In particolare, l’art. 39 di tale decreto autorizza l’Amministrazione finanziaria a determinare il reddito in via induttiva (anche presuntiva) quando ricorrono certe condizioni. Gli studi di settore furono introdotti con la legge n. 549/1995 (art. 3, commi 181–189) e attuati tramite decreti (es. DPCM 27/3/1997) per stimare i ricavi o compensi attesi in base a modelli statistici per ogni settore economico. Successivamente, dal 2018 gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA per i medesimi contribuenti (imprese e lavoratori autonomi esercenti attività in regime di contabilità ordinaria o semplificata, ad eccezione di alcune categorie escluse). L’ISA è stato introdotto dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 (conv. in L. 96/2017) e viene annualmente applicato tramite decreti ministeriali che individuano gli indici per ciascun settore economico. Sul piano delle garanzie procedurali, va menzionato lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000): l’art. 7 garantiva già il diritto del contribuente ad essere ascoltato prima di un accertamento (in specifici casi previsti dalla legge), e soprattutto – novità recente – la Legge 30 dicembre 2023 n. 228 ha rafforzato in via generale questo principio introducendo nellStatuto il nuovo art. 6-bis, in vigore dal 2024, che rende obbligatorio il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impositivi (salvo eccezioni specifiche) a pena di annullabilità . Ciò significa che, per gli accertamenti emanati dal 30 aprile 2024 in poi, l’Amministrazione finanziaria deve sempre attivare un contraddittorio prima di emettere l’atto, pena la possibile invalidità dello stesso in giudizio, senza più la necessità per il contribuente di dimostrare quale pregiudizio abbia subito (come vedremo, questo supera il previgente meccanismo della “prova di resistenza”).
- Definizioni essenziali: In materia di accertamenti, è utile chiarire alcuni termini:
- Accertamento analitico: è il metodo ordinario di rettifica, che interviene voce per voce sui dati di bilancio o dichiarazione del contribuente (ad esempio contestando singoli costi indebiti o ricavi non dichiarati ma documentalmente accertati). Si fonda sulle scritture contabili, presupponendo che queste siano tenute regolarmente e attendibili (cfr. art. 38 DPR 600/1973) .
- Accertamento analitico-induttivo: è un metodo misto in cui l’Ufficio, pur partendo da una contabilità formalmente regolare, individua indizi di anomalie (es. incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività, oppure passività fittizie) e procede a rettifiche basate su presunzioni qualificate, cioè indizi gravi, precisi e concordanti (art. 39, co.1, lett. d, DPR 600/1973) . In sostanza, colma le lacune o discrepanze dei conti con ragionamenti presuntivi robusti.
- Accertamento induttivo puro: è il metodo più radicale (art. 39, co.2, DPR 600/1973), applicabile quando le scritture contabili del contribuente sono del tutto inaffidabili o inesistenti (ad es. perché non tenute, o perché talmente irregolari da non consentire alcuna ricostruzione attendibile). In tal caso l’Ufficio può ignorare i dati contabili e determinare il reddito con qualsiasi elemento indiziario, anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità-precisione-concordanza . È un accertamento “extracontabile” basato sulla libera stima di ricavi e componenti reddituali.
- Accertamento standardizzato (da studi di settore o ISA): è il meccanismo presuntivo basato su modelli statistici settoriali. In pratica, il reddito o volume d’affari del contribuente viene confrontato con quello atteso secondo lo studio di settore applicabile (per gli anni fino al 2017) o secondo l’indice ISA (dal 2018 in poi) . Se i dati dichiarati risultano significativamente inferiori agli standard, l’Ufficio può procedere ad accertamento presuntivo, ma con alcuni vincoli: la presunzione derivante dallo studio/ISA è infatti “semplice” e non autosufficiente, quindi l’Amministrazione deve comunque motivare adeguatamente l’atto e soprattutto deve attivare il contraddittorio preventivo, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata (vedremo tra poco i dettagli) . In sostanza gli studi di settore/ISA forniscono indizi statistici di possibili ricavi non dichiarati, che vanno però calati nel caso concreto e verificati insieme al contribuente prima di diventare un atto impositivo.
- Cause di esclusione/inapplicabilità: la normativa prevede che in alcune situazioni particolari gli studi di settore e gli ISA non si applichino. Ad esempio, se l’attività è iniziata o cessata nel corso dell’anno, oppure se il contribuente ha cambiato radicalmente attività, o ancora se si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’impresa (crisi temporanea, eventi eccezionali, ecc.) . Sono esclusi inoltre i contribuenti che applicano regimi fiscali forfetari o di vantaggio (es. regime forfettario, ex “minimi”), poiché in quei casi non si rientra nell’ambito degli studi/ISA. L’art. 10 della L. 146/1998 elenca per gli studi di settore varie cause di esclusione (nuova attività, pluriattività, ecc.), molte delle quali sono riprese dall’art. 9-bis, co.6 D.L. 50/2017 per gli ISA. È sempre importante verificare se il proprio caso rientra in una causa di inapplicabilità, poiché ciò può invalidare l’accertamento standardizzato: ad esempio, se un contribuente era in regime forfettario o ha iniziato l’attività quell’anno, l’accertamento basato sullo studio/ISA non può essere legittimamente effettuato.
- Termini di decadenza: Il Fisco, per legge, deve notificare gli avvisi di accertamento entro un certo termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno contestato. In generale, il termine ordinario di decadenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo (art. 43 DPR 600/1973): ad esempio, per una dichiarazione presentata nel 2021 (redditi 2020) il termine è il 31/12/2026. Tuttavia, esiste un regime premiale per chi risulta in regola con gli studi di settore/ISA: l’art. 10, comma 9 del D.L. 201/2011 ha previsto che per i contribuenti che dichiarano ricavi/compensi almeno pari a quelli risultanti dallo studio (o dall’ISA) i termini siano ridotti di un anno. Dunque il termine di decadenza scende da 5 a 4 anni (nell’esempio precedente, 31/12/2025) . Attenzione: questo beneficio si applica solo se i dati dichiarati ai fini degli studi/ISA sono completi e veritieri. In caso di dati infedeli, infatti, il contribuente perde il vantaggio del termine ridotto, anche se inizialmente era risultato “congruo” o con punteggio elevato. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito espressamente che la riduzione del termine di accertamento si intende subordinata alla correttezza dei dati forniti: se successivamente emerge che alcuni dati erano falsi o incompleti, l’Amministrazione può beneficiare comunque del termine pieno quinquennale . È quindi essenziale che il contribuente compili con estrema accuratezza i modelli ISA: dichiarare il falso per risultare congrui si rivela un pessimo affare, perché oltre alle sanzioni si perde anche ogni scudo sui termini di accertamento .
Procedura di accertamento basato su studi di settore/ISA
Vediamo ora come avviene concretamente un accertamento fondato su studi di settore o ISA, e quali sono i diritti del contribuente in ciascuna fase.
1. Invito al contraddittorio. In base alla normativa – già prima resa obbligatoria dall’art. 10, comma 3-bis L. 146/1998 per gli studi di settore, ed oggi generalizzata dall’art. 6-bis L. 212/2000 – l’Ufficio, prima di emettere un accertamento basato su queste presunzioni standardizzate, deve invitare il contribuente a un contraddittorio endoprocedimentale. In pratica, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 218/1997, norma sul cosiddetto accertamento con adesione) contenente l’esito dell’applicazione dello studio di settore o dell’ISA al caso specifico . Ad esempio, la lettera potrà indicare che, secondo lo studio di settore X, dato il tipo di attività, i ricavi dichiarati di €50.000 risultano inferiori di €20.000 rispetto ai ricavi “standard” stimati dal software ministeriale; oppure, nel caso di ISA, che il contribuente ha ottenuto un punteggio di affidabilità basso (ad es. 5 su 10) rispetto alla media attesa del settore. Nella stessa comunicazione, il contribuente viene invitato a presentarsi (o comunque a interloquire) entro una certa data per fornire chiarimenti e controdeduzioni. Questa fase è preventiva e obbligatoria: serve proprio ad evitare accertamenti ingiusti basati su situazioni anomale solo apparenti. Il mancato riscontro all’invito o l’esito negativo del contraddittorio apre la strada all’emissione dell’avviso di accertamento.
2. Svolgimento del contraddittorio: Il contraddittorio è il momento in cui il contribuente può “mettere in discussione” i risultati dello studio o dell’ISA, portando all’attenzione dell’Ufficio tutte le circostanze particolari che spiegano lo scostamento. È importante affrontare questa fase in modo attivo e documentato. In genere, il contribuente (spesso assistito dal proprio commercialista o avvocato tributarista) può sia inviare memorie scritte sia presentarsi di persona presso l’Ufficio per un colloquio. Cosa fare durante il contraddittorio? Alcune mosse fondamentali includono: – Verificare i dati di base: controllare attentamente che i calcoli dello studio/ISA siano stati fatti sui dati corretti. A volte possono esservi errori materiali (es. ricavi indicati erroneamente, codice attività Ateco sbagliato, numero di addetti calcolato male, ecc.). Se si individuano errori del genere nell’invito al contraddittorio, vanno subito segnalati all’Ufficio, perché potrebbero invalidare l’intero risultato statistico. – Far valere le cause di esclusione o inapplicabilità: ad esempio, se nell’anno in questione l’attività era appena iniziata, o c’è stata un’interruzione significativa (es. cessazione temporanea, lavori di ristrutturazione, cambi di assetto), occorre evidenziarlo. Dimostrare che il periodo non era “normale” per la gestione dell’impresa è una giustificazione potente per ridurre il peso dello studio di settore. Molte di queste situazioni sono elencate nelle note tecniche degli studi e degli ISA stessi. – Evidenziare fattori particolari (generali o specifici): ogni attività economica può presentare variabili che gli schemi standard non colgono. Ad esempio, potrebbero esservi state patologie aziendali o eventi straordinari: un’azienda commerciale con un calo di vendite perché il titolare è stato malato per vari mesi; un professionista che, in quell’anno, ha lavorato part-time perché prossimo alla pensione; un esercizio in una zona colpita da una crisi locale o da lavori stradali che hanno ridotto il traffico di clienti, ecc. Tutte queste circostanze vanno rappresentate con dovizia di particolari. Meglio ancora se supportate da documenti: es. certificati medici per le malattie, documentazione sulla crisi di settore, rassegna stampa locale su eventi che hanno inciso sull’attività, ecc. – Portare documentazione contabile e extra-contabile: è opportuno presentarsi al contraddittorio muniti di documenti. Oltre alle dichiarazioni dei redditi e ai bilanci, possono essere utili fatture, ricevute, estratti conto, contratti, libri IVA, documenti INPS (per attestare periodi di inattività per malattia o maternità), e qualsiasi altra prova. Se ad esempio l’azienda ha sostenuto costi straordinari (es. campagne pubblicitarie, spese di adeguamento normativo) che hanno abbattuto il margine di profitto, presentare le relative fatture può giustificare perché il reddito è inferiore allo standard. – Chiedere spiegazioni sul calcolo: il contribuente ha il diritto di capire come l’Ufficio è arrivato a quei risultati. Si può dunque chiedere formalmente quali variabili dello studio hanno inciso di più, o se sono state fatte delle stime specifiche. Ottenere informazioni dettagliate può aiutare a individuare eventuali incongruenze nel modello applicato al caso concreto. – Proporre una ricostruzione alternativa: se possibile, il contribuente può presentare una propria simulazione di reddito. Ad esempio, ricalcolando i ricavi attesi inserendo i propri dati effettivi e mostrando che – tenuto conto delle peculiarità – il reddito dichiarato era in linea con la realtà. Questo può essere fatto anche tramite prospetti o tabelle: ad esempio, elencando tutti i lavori effettuati nell’anno con relativi corrispettivi, per dimostrare che i ricavi dichiarati corrispondono al massimo fatturabile data la capacità produttiva individuale.
Durante il contraddittorio, l’Ufficio è tenuto ad ascoltare e valutare le osservazioni. Nella pratica, può accadere che l’Ufficio proponga una sorta di “mediazione”: ad esempio, riconosce alcune giustificazioni e riduce parzialmente la pretesa rispetto allo scostamento iniziale, invitando però il contribuente a adeguarsi (magari dichiarando spontaneamente un certo maggiore ricavo per chiudere la questione). Questa fase rientra nel cosiddetto accertamento con adesione, una procedura deflattiva che consente di raggiungere un accordo transattivo prima dell’emissione dell’avviso, con benefici sanzionatori. Il contribuente dovrà valutare caso per caso se aderire a una proposta di questo tipo conviene (dipende dall’entità dell’importo in gioco e dalla solidità delle proprie contro-deduzioni).
3. Emissione dell’avviso di accertamento. Se il contraddittorio non ha risolto la divergenza – cioè se non si trova un accordo o se l’Ufficio ritiene comunque non sufficienti le spiegazioni – l’Agenzia delle Entrate procederà a emettere formalmente l’avviso di accertamento. In tale atto, l’Ufficio ridetermina il reddito imponibile del contribuente in base allo studio di settore/ISA, calcolando le maggiori imposte dovute (tipicamente IRPEF/IRES, addizionali, IRAP) e la relativa IVA su eventuali ricavi non contabilizzati, oltre alle sanzioni e agli interessi. È importante sottolineare che, per giurisprudenza costante, un avviso di accertamento di questo tipo non può limitarsi a richiamare lo scostamento dallo studio, ma deve contenere una motivazione accurata. In particolare, deve dare conto sia del perché il modello standard utilizzato è stato ritenuto applicabile in concreto a quel contribuente, sia del perché le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio sono state rigettate . Su questo aspetto torneremo nel prossimo paragrafo dedicato alla motivazione e all’onere della prova, perché rappresenta uno snodo cruciale della difesa: spesso, infatti, gli accertamenti vengono annullati in giudizio proprio per carenze di motivazione o per omesso esame delle deduzioni difensive presentate dal contribuente.
Prima di passare alle strategie difensive e al contenzioso, ribadiamo un principio fondamentale confermato dalla Cassazione: poiché lo scostamento dagli studi di settore costituisce solo una presunzione semplice, l’intero impianto dell’accertamento nasce e acquista forza solo grazie al contraddittorio preventivo. Se tale contraddittorio non viene svolto, oppure viene condotto in modo fittizio, l’accertamento è viziato. In una recente ordinanza la Suprema Corte ha riaffermato che l’applicazione degli studi di settore “costituisce un sistema di presunzioni semplici […] che nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento” . Questo significa che il contraddittorio endoprocedimentale non è una mera formalità, ma un passaggio sostanziale e imprescindibile: senza di esso, un accertamento basato esclusivamente su studi di settore o ISA non supera il vaglio di legittimità, in quanto viene meno quel dialogo che può conferire gravità e precisione alla presunzione statistica iniziale.
Motivazione dell’avviso di accertamento e onere della prova
Una volta notificato l’avviso di accertamento fondato su studi di settore/ISA, la battaglia difensiva si sposta sul piano della motivazione e della prova. Da un lato, l’Amministrazione finanziaria deve aver fatto bene i compiti in termini di motivazione dell’atto; dall’altro, il contribuente avrà la possibilità – in sede contenziosa – di smontare le pretese con ogni mezzo di prova contraria.
Motivazione “rafforzata” dell’avviso: La giurisprudenza insiste molto sul fatto che, in questi accertamenti da studi di settore, il Fisco non può limitarsi a scrivere nell’atto che “il contribuente ha dichiarato meno del congruo secondo lo studio, quindi si accertano X maggiori ricavi”. Una motivazione del genere sarebbe considerata generica e insufficiente, e porterebbe all’annullamento dell’atto per difetto di motivazione . La Cassazione ha chiarito che l’ufficio deve invece dare conto nel dettaglio di come ha applicato lo studio di settore al caso concreto e perché ritiene di disattendere le spiegazioni del contribuente. Ad esempio, nella recente ord. n. 19669/2024, la Corte ha affermato che l’avviso deve “integrare l’atto con argomentazioni concrete (anche di tipo probatorio) per cui le deduzioni difensive sono state disattese” . In pratica, se il contribuente ha prodotto documenti e osservazioni nel contraddittorio (esibendo fatture, ricevute, perizie di parte, ecc. a supporto delle proprie ragioni), l’Ufficio ha l’obbligo di rispondere puntualmente: deve spiegare, punto per punto, perché quei documenti non sono stati ritenuti risolutivi o attendibili. Ad esempio, se il contribuente giustifica il basso reddito con una lunga malattia comprovata da certificati medici, l’Ufficio – per confermare l’accertamento – dovrà magari replicare sostenendo che nonostante la malattia l’azienda ha continuato a produrre ricavi grazie a dipendenti o sostituti, oppure che la durata dell’assenza non giustifica tutto lo scostamento riscontrato, ecc. Ciò che conta è che nell’atto finale resti traccia di questa valutazione. In mancanza, l’avviso risulterebbe viziato da motivazione carente. La stessa Cassazione, già con sentenze del 2018, ha censurato quelle motivazioni “apparente” o “incolore” in cui l’Ufficio si limita a riportare i calcoli statistici senza confrontarsi con le particolarità emerse . In sintesi, un avviso di accertamento “standardizzato” deve contenere una motivazione rinforzata: non basta indicare il delta tra dichiarato e stimato, ma occorre dimostrare che si è valutato il caso concreto e che la presunzione rimane valida nonostante le contestazioni del contribuente.
Riparto dell’onere della prova: In materia di accertamenti da studi di settore e ISA, l’onere probatorio è ripartito tra Amministrazione e contribuente in fasi successive . Inizialmente è l’Amministrazione finanziaria che deve fornire gli elementi minimi per fondare la propria pretesa: applicare correttamente lo studio di settore/ISA e motivare l’atto come detto sopra, esplicitando le ragioni per cui ritiene attendibile quel risultato presuntivo. Superato questo primo gradino (ossia, ammesso che l’Ufficio abbia motivato in modo adeguato l’avviso integrando i risultati statistici con considerazioni sul caso concreto), il pallino passa al contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l’accertamento con ogni mezzo di prova. La Corte di Cassazione ha spesso ribadito che, trattandosi di presunzioni semplici, il contribuente può contraddirle presentando sia prove documentali dirette sia presunzioni semplici di segno contrario (deduzioni logiche, dati di comune esperienza, ecc.) . Ad esempio, può provare che la propria impresa opera in un mercato geografico ristretto dove i margini sono più bassi rispetto alla media nazionale considerata dallo studio; oppure che ha volutamente mantenuto i prezzi bassi per strategie commerciali (la cosiddetta antieconomicità apparente, che non configura evasione). Da parte sua, l’Ufficio non è dispensato dall’onere di approfondire: se il contribuente solleva eccezioni plausibili, spetta comunque all’Amministrazione dimostrare – anche tramite ulteriori elementi istruttori – che quelle eccezioni non inficiano la validità del modello applicato. In giudizio, il giudice tributario valuterà liberamente le prove fornite da entrambe le parti. L’accertamento verrà confermato solo se il giudice riterrà che la presunzione (modello statistico) risulta grave, precisa e concordante nel caso concreto, e che le prove contrarie del contribuente non la scalzano. Al contrario, se il contribuente riesce a convincere il giudice che la propria situazione reale non rientra nei parametri standard – o perché i parametri sono stati applicati male, o perché c’erano fattori eccezionali – allora l’accertamento dovrà essere annullato (in tutto o in parte). In altre parole, nel processo tributario sul punto il giudice deve ricostruire il reddito reale del contribuente, valutando se quello dichiarato poteva effettivamente essere così basso considerati tutti i fattori del caso, oppure se l’Ufficio ha ragione a pretendere di più.
Vale la pena ricordare un aspetto ulteriore evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2009 (sent. n. 26635/2009) e più volte richiamato: spetta sempre all’Amministrazione provare l’applicabilità dello standard. Se il contribuente, ad esempio, dimostra che lo studio di settore utilizzato non era adatto alla sua realtà (perché magari l’attività svolta era peculiare rispetto alla categoria generale), l’accertamento non può reggere. Questo principio è ormai pacifico: gli studi di settore e gli ISA non creano una presunzione legale, ma soltanto una base di partenza. Di conseguenza, ogni elemento concreto portato dal contribuente in grado di spiegare la difformità deve essere seriamente considerato, pena la sconfitta dell’Amministrazione in giudizio .
Strategie difensive: dal contraddittorio al ricorso
Dopo aver esaminato il quadro normativo e procedurale, passiamo alle strategie difensive che il contribuente può adottare praticamente per difendersi da un accertamento basato su studi di settore o ISA. Le strategie si sviluppano su due fronti temporali: in fase di contraddittorio (cioè prima che l’atto diventi definitivo) e in fase contenziosa (una volta impugnato l’accertamento davanti al giudice).
In sede di contraddittorio (fase amministrativa preventiva)
Come già sottolineato, la fase del contraddittorio è fondamentale: è l’occasione per prevenire l’accertamento o limitarne la portata. Ecco alcuni suggerimenti operativi per “giocare al meglio” questa carta: – Preparazione accurata: Appena si riceve l’invito al contraddittorio, il contribuente deve attivarsi subito. È bene rivolgersi al proprio consulente (commercialista o avvocato) e iniziare a raccogliere tutta la documentazione potenzialmente utile. Bisogna analizzare voce per voce i dati che l’Ufficio ha utilizzato e verificare se corrispondono al vero e se esistono giustificazioni per eventuali scostamenti. Ad esempio, controllare i ricavi e i volumi dichiarati rispetto a quelli presunti dallo studio; controllare i coefficienti applicati (come percentuali di ricarico, costi fissi presumibili, ecc.) e capire da dove derivano. – Memoria difensiva scritta: È consigliabile predisporre una memoria da consegnare all’Ufficio durante o dopo il contraddittorio orale. Nella memoria si riassumeranno per iscritto tutte le proprie argomentazioni difensive, allegando in copia la documentazione probatoria (fatture, contratti, estratti conti, perizie, ecc.). Ciò serve sia a chiarire in modo strutturato le proprie ragioni sia a cristallizzare agli atti le proprie deduzioni, cosa utile in caso di successivo ricorso (il giudice vedrà quali argomenti erano stati già sollevati). – Dialogo e domande all’Ufficio: Durante l’incontro, mantenere un atteggiamento collaborativo ma fermo. Chiedere eventualmente ai funzionari spiegazioni su aspetti poco chiari del calcolo, o sugli elementi specifici che hanno portato allo scostamento. Mostrarsi proattivi nel risolvere dubbi può aiutare a far comprendere che non si ha nulla da nascondere e che le divergenze possono derivare da equivoci o situazioni particolari. – Offrire una “quadra” alternativa: Se si intuisce che l’Ufficio è disposto a negoziare (attraverso l’accertamento con adesione), si può anche proporre una soluzione intermedia. Ad esempio: “riconosco che forse ho sottovalutato alcuni ricavi, sono disposto ad adeguarmi fino a X euro di maggior reddito” – in cambio magari della rinuncia alle sanzioni o di una riduzione delle stesse. È una strada delicata, da percorrere solo se si ritiene che le proprie difese non basterebbero a evitare l’atto: in tal caso, ottenere un compromesso può convenire, perché evita il contenzioso e riduce l’esborso (ricordiamo che con l’adesione le sanzioni sono dimezzate). Se invece si è convinti di avere solide giustificazioni per l’intero scostamento, meglio non accettare compromessi al ribasso. – Farsi rilasciare il verbale: Al termine del contraddittorio, è importante che venga redatto un verbale o una sintetica relazione in cui risultino le posizioni di entrambe le parti. Se l’Ufficio non ne redige uno, si può depositare una propria istanza chiedendo che vengano acquisite al protocollo le memorie e i documenti consegnati. Questo per evitare, in seguito, che l’Amministrazione neghi di aver ricevuto certe prove o affermazioni.
Se il contraddittorio conduce a un accordo (adesione), la vicenda si conclude lì con il pagamento concordato. Se invece non si trova un accordo e l’Ufficio emette l’accertamento, il contribuente dovrà passare al piano B: il ricorso in Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado).
In sede di impugnazione (ricorso e giudizio tributario)
Quando arriva l’avviso di accertamento, occorre anzitutto verificare le tempistiche: il termine per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (estesi a 90 giorni se si è presentata istanza di accertamento con adesione, che sospende per 90 giorni; inoltre il termine è sospeso nel mese di agosto). Il ricorso va depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria provinciale competente. Dal punto di vista dei contenuti, il ricorso introduttivo dovrà riprendere tutti i motivi di illegittimità e infondatezza già evidenziati in sede di contraddittorio (se fatto), nonché aggiungere eventuali ulteriori argomentazioni emerse dopo. Alcune strategie difensive in giudizio includono:
- Vizi formali e procedurali: Verificare sempre se l’atto presenta difetti di forma: ad esempio notifica tardiva oltre i termini, mancata indicazione del responsabile del procedimento, violazione del diritto al contraddittorio (se per assurdo l’Ufficio avesse saltato il contraddittorio obbligatorio). L’omessa attivazione del contraddittorio è un motivo di ricorso immediato: come già detto, in caso di accertamenti “a tavolino” come questi, oggi costituisce causa di annullabilità dell’atto ipso facto . Fino agli atti notificati prima del 2024 si discuteva di dover provare la concretezza delle proprie difese (prova di resistenza), ma con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis Statuto e la pronuncia delle Sezioni Unite 21271/2025, non è più necessario dimostrare il pregiudizio: la semplice mancanza del contraddittorio preventivo rende l’accertamento annullabile . Questo va eccepito subito nel ricorso, perché è un vizio “fondamentale”.
- Vizi di motivazione: Se l’avviso di accertamento non contiene quella motivazione rafforzata di cui sopra (ovvero non spiega perché ha ignorato le prove del contribuente, oppure si basa solo sullo scostamento matematico), occorre evidenziarlo nel ricorso. La carenza di motivazione è anch’essa vizio di legittimità dell’atto.
- Merito – inesistenza del maggior reddito: Entrando nel merito, il contribuente deve cercare di convincere il giudice che l’accertamento è sostanzialmente infondato. Ciò significa dimostrare con i fatti e i numeri che non c’erano in realtà ricavi occulti. Questo può richiedere un lavoro di ricostruzione contabile parallela. Ad esempio, presentare una perizia di parte in cui un consulente tecnico rifà i conti tenendo conto dei fattori trascurati dallo studio di settore e conclude che il reddito dichiarato era congruo. Oppure portare testimoni (ammissibili nel processo tributario) che attestino circostanze di fatto – es. clienti che confermano di non aver fatto acquisti oltre un certo importo, fornitori che testimoniano di aver concesso particolari sconti quell’anno abbassando i margini, ecc. Ogni elemento è utile per smontare la presunzione.
- Uso delle sentenze favorevoli: Nel ricorso è bene citare la giurisprudenza di Cassazione più recente che supporta la posizione del contribuente. Ad esempio, pronunce che rimarcano la natura di presunzione semplice degli studi di settore (Cass. 26357/2024) , l’obbligo del contraddittorio (Cass. 9554/2024) , la necessità di motivazione puntuale (Cass. 19669/2024) , la condizione sui dati veritieri per il regime premiale (Cass. 28457/2024) , ecc. Queste sentenze mostrano al giudice che la linea difensiva del contribuente non è isolata, ma anzi è avallata dalla Suprema Corte.
- Richiesta di CTU: In casi molto tecnici, si può anche chiedere al giudice di nominare un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per riesaminare i dati aziendali e verificare se effettivamente il contribuente ha nascosto ricavi oppure no. Ad esempio, una CTU contabile potrebbe ricostruire i flussi finanziari dell’azienda e confrontarli con i ricavi dichiarati. Se ne emergesse coerenza, ciò avvalorerebbe la tesi difensiva. La CTU non è automatica nel processo tributario, ma il giudice può disporla se ritiene la questione complessa.
In giudizio, in definitiva, il contribuente ha diritto di dispiegare l’intero arsenale probatorio per far valere la realtà effettiva contro la presunzione statistica. Il giudice tributario dal canto suo deve valutare tutti gli elementi e decidere se la ricostruzione dell’Ufficio fosse o meno fondata. L’esperienza mostra che molti accertamenti da studi di settore vengono annullati o ridotti in contenzioso quando il contribuente riesce a dimostrare in modo credibile una specificità della propria situazione non colta dallo standard. Naturalmente molto dipende anche dalla qualità della difesa: per questo è importante, specialmente in casi di importi elevati o situazioni complesse, farsi assistere da professionisti esperti in contenzioso tributario.
Tempi, prevenzione e benefici premiali degli ISA
Abbiamo accennato al fatto che ottenere un buon punteggio ISA può portare benefici premiali per il contribuente virtuoso. È utile riepilogarli, anche in un’ottica di prevenzione di futuri accertamenti.
- Riduzione dei termini di accertamento: Come già detto, chi risulta “congruo” agli studi di settore o con un elevato indice ISA ha diritto a termini di decadenza ridotti di un anno. Per gli ISA, in particolare, il punteggio che garantisce questo beneficio è stato fissato – almeno per i primi anni di applicazione – intorno a 8 su 10 (il legislatore delegato aveva parlato di “punteggio almeno pari a 8” e l’Agenzia delle Entrate ha poi dettagliato la soglia a seconda dei periodi). Con un punteggio sufficiente, l’anno successivo viene “scontato”: ad esempio, se per il 2022 un contribuente ottiene ISA 8 o più, il Fisco avrà tempo fino al 31/12/2027 (e non 2028) per eventuali controlli su quell’anno. Ricordiamo tuttavia il paletto fondamentale: i dati dichiarati negli ISA devono essere fedeli, altrimenti la riduzione non opera .
- Esonero da alcuni controlli presuntivi: Un contribuente con punteggio ISA molto alto può essere escluso da certi tipi di accertamento. Ad esempio, è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici per chi supera una soglia di affidabilità (sperimentata ad esempio a 8,5/10 per il periodo d’imposta 2018) . In pratica, l’Agenzia si impegna a non effettuare accertamenti da studi di settore/ISA nei confronti dei soggetti più affidabili, riservando le sue energie di controllo a chi presenta indici bassi. Ciò è coerente con l’idea alla base degli ISA: premiare chi risulta fiscalmente virtuoso, anche con una riduzione del “fastidio fiscale”. Viceversa, i livelli minimi di affidabilità (punteggi molto bassi, ad es. 4 o 5) vengono presi in considerazione dall’Agenzia per costruire liste selettive di contribuenti a rischio da sottoporre a controllo . Dunque avere un punteggio basso non determina automaticamente un accertamento, ma sicuramente aumenta la probabilità di essere scelti per verifiche approfondite (es. controlli formali, ispezioni o accertamenti induttivi).
- Altri vantaggi amministrativi: Il regime premiale degli ISA, fissato dal legislatore (art. 9-bis D.L. 50/2017, comma 11), prevede ulteriori incentivi per chi raggiunge alte pagelle fiscali . Tra questi: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensare crediti fiscali fino a determinate soglie (50.000 € per IVA, 20.000 € per imposte dirette) ; la non applicazione della disciplina delle società di comodo; l’esonero dall’accertamento sintetico del reddito (redditometro) per le persone fisiche, a patto che il reddito dichiarato non sia superiore di oltre 2/3 a quello accertabile; ecc. In sostanza, chi ha un buon ISA gode di un rapporto più “disteso” col Fisco: meno chance di accertamenti automatici e alcuni adempimenti in meno.
In un’ottica di compliance, è quindi consigliabile per i contribuenti impegnarsi ad ottenere un punteggio ISA elevato ove possibile – ovviamente senza falsare i dati, ma ad esempio sfruttando tutti gli elementi positivi a disposizione (deduzioni, adeguamenti spontanei in dichiarazione se i ricavi sono lievemente sotto soglia, ecc.). Prevenire un accertamento è sempre meglio che doverlo combattere dopo. Detto ciò, è chiaro che non sempre è possibile risultare congrui: situazioni economiche difficili o andamenti atipici possono abbassare il punteggio. In tal caso, l’importante è essere preparati: conservare documentazione dettagliata di tutto ciò che può spiegare eventuali anomalie e, come abbiamo illustrato, agire tempestivamente non appena si viene interpellati dal Fisco.
Domande e risposte
- Che cos’è l’accertamento fondato su studi di settore (o ISA)?
È un tipo di accertamento tributario basato su presunzioni statistiche anziché su prove puntuali. In pratica, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito imponibile di un contribuente utilizzando modelli matematici settoriali: confronta i dati dichiarati (ricavi, compensi, margini, ecc.) con quelli “standard” attesi per attività simili. Se dai calcoli risulta che avresti “dovuto” dichiarare di più, l’Ufficio presume che tu abbia nascosto dell’imponibile e procede con un accertamento presuntivo. È standardizzato perché segue formule uguali per tutti i contribuenti di un certo settore. Gli studi di settore (previsti sin dal D.L. 331/1993, art. 62-sexies) ne sono un esempio storico; dal 2019 essi sono stati sostituiti dagli ISA (art. 9-bis D.L. 50/2017) come strumento principale di questo tipo . In entrambi i casi si tratta di metodologie statistiche: la differenza è che gli ISA danno un punteggio di affidabilità complessivo e aggregato, mentre gli studi di settore fornivano direttamente un ricavo “congruo” di riferimento. - Che differenza c’è tra una presunzione semplice e una presunzione qualificata in questo contesto?
Le presunzioni semplici sono congetture prive di forza probatoria autonoma, che necessitano di essere corroborate da altri elementi e sono sempre contestabili con qualsiasi mezzo di prova contraria. Gli studi di settore e gli ISA sono presunzioni semplici: il loro esito non ha, di per sé, la gravità, precisione e concordanza richieste invece per le cosiddette presunzioni qualificate. Le presunzioni qualificate (dette anche “gravi, precise e concordanti”) sono quelle che la legge considera idonee a fondare un accertamento anche in assenza di prova diretta – tipicamente quelle usate negli accertamenti analitico-induttivi. Ad esempio, trovare movimenti bancari non giustificati a fronte di basse vendite può essere una presunzione qualificata di vendite in nero. Viceversa, dire “secondo lo studio di settore avresti dovuto guadagnare 100, hai dichiarato 60” è una presunzione semplice, perché è un ragionamento per analogia statistica, non una prova concreta. La differenza pratica sta nel fatto che nel caso delle presunzioni semplici il contribuente ha ampio margine per contestare, introducendo qualunque prova contraria ritenga utile . In sintesi: l’accertamento da studi di settore/ISA è basato su presunzioni semplici (e per questo richiede contraddittorio e motivazione rafforzata); l’accertamento analitico-induttivo utilizza presunzioni qualificate (che di per sé, se non confutate, possono reggere l’accertamento). - Quando e come si instaura il contraddittorio con il contribuente?
Nel caso di accertamenti standardizzati da studi di settore o ISA, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio prima dell’emissione dell’avviso. In genere, come visto, si instaura con la notifica di un invito a comparire da parte dell’Ufficio, che espone i rilievi (scostamento dallo studio, punteggio ISA basso, ecc.) e fissa un termine per la risposta . Il contribuente di solito ha 15 o 30 giorni per presentare osservazioni e documenti, e può richiedere un incontro. Il contraddittorio deve avvenire prima dell’atto formale: se l’Ufficio emette l’accertamento senza aver dato questa possibilità, l’atto è viziato. Durante il contraddittorio – che si può svolgere attraverso scambio di memorie e riunioni – il contribuente e i suoi consulenti discutono con i funzionari dell’Agenzia, spiegando le proprie ragioni e producendo documentazione a supporto. Questo confronto può portare a tre esiti: l’archiviazione della posizione (se le spiegazioni convincono pienamente il Fisco), una proposta di adesione (se si trovano punti d’incontro parziali) oppure, se non c’è accordo, l’emissione dell’avviso. In ogni caso è fondamentale partecipare attivamente al contraddittorio: non rispondere all’invito significa precludersi la chance di chiarire e porta quasi certamente all’accertamento . Inoltre, presentarsi e presentare documenti fa sì che, se l’Ufficio andrà avanti lo stesso, dovrà poi motivare perché ha ignorato quelle prove (il che rafforza la nostra posizione in ricorso). - Cosa fare se ricevo effettivamente l’avviso di accertamento basato sullo studio/ISA?
In questo caso, significa che il contraddittorio non ha risolto la questione. Appena notificato l’atto (che arriva tramite raccomandata o PEC), la prima cosa da fare è segnarsi la scadenza dei 60 giorni per il ricorso e consultare subito un esperto (se già non lo si è fatto prima) . Entro 60 giorni, infatti, occorre decidere se: - Avviare un accertamento con adesione post-avviso: è ancora possibile, entro 15 giorni dalla notifica, presentare istanza di adesione ex D.Lgs. 218/97 anche dopo l’emissione dell’avviso. Questo sospende i termini di ricorso per 90 giorni e apre una nuova fase di negoziazione con l’ufficio per tentare un accordo. Può essere utile se nel frattempo si sono trovati elementi per trattare o se si punta a ottenere sconti sulle sanzioni.
- Impugnare l’atto in Commissione Tributaria: se non si intende aderire, si deve preparare il ricorso e depositarlo entro 60 giorni (o entro il termine prorogato di legge se applicabile). Nel ricorso bisogna inserire tutti i motivi di contestazione, sia procedurali (es. mancato contraddittorio, vizi formali) che di merito (errata applicazione dello studio, incongruenze non considerate, ecc.), allegando copia dell’avviso e dei documenti utili . Nel frattempo, è possibile – ma non obbligatorio – pagare un terzo delle imposte accertate per evitare l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio (è la cosiddetta “sospensione frazionata” prevista dall’art. 15 del D.P.R. 602/73). Se si ritiene l’accertamento totalmente infondato e si vuole chiedere sospensione al giudice, si può anche decidere di non pagare nulla e presentare contestualmente un’istanza di sospensione cautelare delle somme, che il giudice valuterà (in presenza di fumus del ricorso e rischio di danno grave dalla riscossione). In ogni caso, dopo aver ricevuto l’avviso è consigliabile non perdere tempo: la preparazione del ricorso richiede un’attenta analisi tecnica e giuridica. È opportuno inoltre reperire eventuali ulteriori prove a sostegno (es. una perizia di un commercialista, testimonianze, ecc.) da depositare poi in giudizio. Infine, ricordiamo che una volta presentato il ricorso, la legge oggi prevede anche il tentativo obbligatorio di mediazione tributaria se il valore in contestazione è entro €50.000: si tratta di un ulteriore confronto con l’ufficio, tramite l’organo di mediazione, per vedere se si può trovare un accordo prima della sentenza. Spesso, però, in materia di studi di settore la mediazione va a vuoto se non c’è stata apertura in precedenza.
- Come si distribuisce l’onere della prova tra Fisco e contribuente in giudizio?
Come spiegato, inizialmente è il Fisco che deve provare la sua pretesa, almeno nei suoi elementi essenziali. In un accertamento da studi di settore ciò significa che l’Agenzia deve aver applicato correttamente lo studio e dimostrato in motivazione perché ritiene che il contribuente abbia nascosto ricavi (ad esempio perché le spiegazioni fornite non erano convincenti). Se questa soglia minima è superata (ossia l’accertamento è motivato e non manifestamente arbitrario), allora in giudizio l’onere della prova si sposta in capo al contribuente . Sarà quest’ultimo a dover convincere il giudice, con documenti, perizie, testimoni e deduzioni logiche, che il reddito reale era proprio quello dichiarato e non quello più alto presunto dall’Ufficio. In altre parole, il contribuente deve fornire una prova contraria alla presunzione fiscale. È importante sottolineare che non esistono limitazioni sui mezzi di prova ammessi al contribuente (può utilizzare qualunque elemento, data la natura semplice della presunzione) . Di converso, l’Amministrazione, per vincere la causa, dovrà convincere il giudice che la propria presunzione è rimasta valida e non superata. In pratica il giudice si trova a valutare due tesi: quella del Fisco basata sul modello standard e quella del contribuente basata sulla realtà effettiva. Se la seconda risulta credibile e documentata, prevarrà quella, portando all’annullamento (anche parziale, volendo, se ad esempio il giudice ritenesse che qualcosa in più andava dichiarato ma non tanto quanto sostenuto dall’ufficio). - Quali sono i vantaggi di risultare “congrui” agli studi di settore o con un alto indice ISA?
Il vantaggio principale è evitare i controlli o quantomeno ridurli. Chi è risultato congruo (cioè ha dichiarato almeno il minimo secondo lo studio di settore) oppure chi ha un ISA alto, gode come visto di termini di decadenza ridotti di 1 anno per gli accertamenti . Inoltre, per i periodi recenti, punteggi ISA elevati danno accesso ai regimi premiali: ad esempio, esonero dal visto di conformità su compensazioni fiscali e rimborsi IVA entro certi importi; esclusione dell’applicazione del redditometro; esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (quindi in pratica una sorta di “scudo” verso studi di settore e simili) . In generale, l’Agenzia delle Entrate considera i contribuenti con ISA alto come affidabili, per cui li inserisce in liste a basso rischio: ciò significa minori probabilità di verifiche e un rapporto più semplice (ad esempio possono ottenere rimborsi fiscali più veloci). Di contro, però, ottenere un ISA alto spesso implica dichiarare tutti i dati con estrema trasparenza e – talvolta – adeguare spontaneamente i ricavi: insomma, è un premio per chi ha un profilo fiscale regolare e non “tirato”. E va ricordato che tali benefici valgono finché i dati sono veritieri: se poi si scopre che per raggiungere la congruità qualcuno ha inserito informazioni false, quei benefici decadono (come ha ribadito Cass. 28457/2024) . - Quali sentenze recenti sono particolarmente rilevanti in materia di accertamenti da studi di settore/ISA?
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso varie pronunce che hanno consolidato i principi a tutela dei contribuenti in questo ambito. Possiamo citare, ad esempio: - Cass. Sez. Trib. ord. 9 ottobre 2024 n. 26357: ha ribadito che gli studi di settore (anche “post-ISA”) costituiscono presunzioni semplici e che il contraddittorio preventivo con il contribuente è sempre obbligatorio, pena la nullità dell’atto . Questa ordinanza ha richiamato anche le novità introdotte dall’art. 6-bis Statuto, a conferma dell’orientamento ormai univoco sulla necessità del contraddittorio in ogni accertamento standardizzato.
- Cass. Sez. Trib. ord. 9 aprile 2024 n. 9554: ha sottolineato con forza l’obbligo del contraddittorio per gli accertamenti basati su studi di settore, sancendo che la sua omissione comporta la nullità dell’atto . Inoltre, ha precisato che nell’avviso definitivo l’Ufficio deve dare conto delle ragioni per cui ha eventualmente rigettato le osservazioni del contribuente.
- Cass. Sez. Trib. ord. 17 luglio 2024 n. 19669: ha richiesto la cosiddetta motivazione “rafforzata” dell’accertamento . In particolare, ha stabilito che l’Ufficio deve integrare l’atto con le argomentazioni concrete per cui non ha ritenuto valide le giustificazioni del contribuente, e non limitarsi al mero calcolo dello scostamento.
- Cass. Sez. Trib. ord. 5 novembre 2024 n. 28457: ha affrontato il tema dei benefici premiali, chiarendo che la riduzione di un anno dei termini di accertamento spetta solo se i dati utilizzati nello studio di settore o ISA sono fedeli . Se successivamente si scopre che quei dati erano inesatti (ad es. ricavi occultati), il contribuente perde il diritto allo sconto temporale, anche se formalmente era risultato congruo.
- Cass. Sez. Unite 25 luglio 2025 n. 21271: (decisione a Sezioni Unite) ha sancito un principio generale in materia di contraddittorio endoprocedimentale, destinato a incidere profondamente anche sugli accertamenti da studi di settore/ISA. Le SS.UU. hanno stabilito che tutti gli accertamenti a tavolino devono essere preceduti da contraddittorio obbligatorio e che non è più richiesta alcuna prova di resistenza da parte del contribuente . In altri termini, se l’Ufficio notifica un accertamento standard senza aver attivato il contraddittorio, il contribuente può ottenerne l’annullamento in giudizio senza dover dimostrare quale concreta difesa avrebbe potuto svolgere se fosse stato sentito. Questa sentenza, in linea con il nuovo art. 6-bis Statuto, uniforma la tutela del contraddittorio per tutti i tributi e supera definitivamente vecchie incertezze.
- Cass. Sez. Unite 20 ottobre 2009 n. 26635: è una sentenza storica (ancorché risalente) che per prima ha fissato i paletti sull’uso degli studi di settore. Le SS.UU. nel 2009 affermarono che l’accertamento standardizzato è legittimo solo se c’è stato contraddittorio e se l’ufficio ha considerato le osservazioni del contribuente, e che in giudizio l’onere della prova è ripartito come descritto sopra (prima spetta al Fisco dimostrare la applicabilità dello studio, poi al contribuente provare i fatti contrari) . Questi principi, ulteriormente sviluppati negli anni successivi (ad es. da Cass. 12558/2010), sono tuttora validi e vengono costantemente richiamati nelle pronunce più recenti.
- Come viene valutato un accertamento da studi di settore/ISA davanti alla Corte di Giustizia Tributaria?
Il giudice tributario (ex Commissione Tributaria) quando esamina un ricorso su questo tipo di accertamento adotta un approccio simile a quello su qualsiasi accertamento, ma con particolare attenzione ai profili presuntivi. In pratica, verifica prima di tutto il rispetto delle regole procedurali: ad es. se l’atto è stato notificato entro i termini, se è stato garantito il contraddittorio, se la motivazione è sufficiente . Qualora riscontri vizi (ad esempio contraddittorio mancante, motivazione inadeguata), può annullare l’atto senza nemmeno entrare nel merito. Se invece il procedimento è stato regolare, passa al merito, cioè valuta se effettivamente quel contribuente poteva avere il reddito presunto. In questa valutazione, il giudice ha ampi poteri istruttori: può accettare nuovi documenti portati dal contribuente, può ammettere testimoni, può disporre consulenze tecniche. L’importante è che il giudice formi il suo convincimento sulla base completa delle prove. Egli dovrà valutare criticamente la presunzione statistica: se la ritiene plausibile e non confutata, darà ragione al Fisco; se invece emerge che il modello standard mal si adattava al caso concreto, dovrà disapplicarlo. In altre parole, il giudice deve verificare se la realtà dei fatti (come provata in giudizio) corrisponde o meno a quella fotografata dallo studio di settore. Se non corrisponde – ossia se il contribuente dimostra che lo scostamento era giustificato da cause reali – l’accertamento verrà annullato o ridotto di conseguenza .
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Studi di Settore | Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) |
|---|---|---|
| Normativa di riferimento | Art. 39 D.P.R. 600/73; D.L. 331/1993 (art. 62-sexies); L. 146/1998 (disciplina contraddittorio); DPCM attuativi per singoli studi. | Art. 9-bis D.L. 50/2017 (introduzione ISA); Decreti MEF annuali di approvazione indici; Provv. AE 2019 e seguenti per regole applicative. |
| Periodo di applicazione | Introdotti negli anni ’90, applicati fino al 2017 (ultimi studi in vigore per periodo d’imposta 2017). Dal 2018 non più utilizzati ai fini accertativi (abrogati e sostituiti dagli ISA). | In vigore dal 2018 per tutti i settori economici ex studi di settore (ogni anno vengono emanati indici ISA aggiornati). Si applicano ai contribuenti con caratteristiche simili a quelle previste per gli studi (imprese e professionisti in regime ordinario/semplificato). |
| Natura giuridica | Presunzioni semplici basate su medie e parametri statistici settoriali (“accertamenti a tavolino”). Non costituiscono di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti senza il contraddittorio . | Presunzioni semplici composite, fondate su una pluralità di indicatori statistici e economici. Ogni contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 che riassume la sua affidabilità fiscale. La logica rimane quella delle presunzioni semplici (non gravi ex se). |
| Cause di esclusione | Inapplicabili in casi di non normalità della gestione: inizio o cessazione attività nell’anno, periodo di attività molto ridotto, esercizio di più attività diverse, ecc. (art. 10 L. 146/1998). | Analoghe cause di esclusione previste dal D.L. 50/2017, art. 9-bis c.6: nuovo avvio o cessazione attività, situazioni di non normale svolgimento, ecc. Inoltre gli ISA non si applicano ai contribuenti in regimi forfetari o agevolati (minimi). |
| Benefici premiali | Previsto (dal 2011) un regime premiale per chi risultava congruo: riduzione di 1 anno dei termini di accertamento (da 5 a 4 anni) e altre agevolazioni minori (esonero da alcuni adempimenti). Necessaria la veridicità dei dati dichiarati per non perdere il beneficio . | Ampio regime premiale per punteggi alti: riduzione di 1 anno dei termini se affidabilità almeno pari alla soglia (es. ≥8); esonero da visto di conformità per compensazioni/rimborsi entro 50.000 € ; esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (per i più affidabili) ; esclusione da redditometro; altri vantaggi previsti da provvedimenti AE. |
| Contraddittorio preventivo | Obbligatorio per legge (art. 10, c.3-bis L. 146/1998) pena nullità dell’accertamento. La giurisprudenza consolidata conferma che l’atto è illegittimo se emesso senza preventiva convocazione del contribuente . | Obbligatorio in via generalizzata per tutti gli accertamenti dal 2024 (art. 6-bis Statuto introdotto da L. 228/2023). Già prima la Cassazione assimilava gli ISA agli studi di settore quanto a necessità del contraddittorio. Oggi l’omissione comporta l’annullabilità dell’atto senza bisogno di prova di resistenza . |
| Onere della prova | In giudizio, dopo che l’Ufficio ha applicato lo studio e motivato l’atto, spetta al contribuente provare che la propria situazione esce dagli schemi standard (onere della prova a carico contribuente, ma libero nei mezzi: ammesse tutte le prove contrarie) . Se il contribuente fornisce spiegazioni credibili non confutate, l’accertamento va annullato. | Identico approccio: il punteggio ISA è un elemento iniziale. L’Ufficio deve motivare l’accertamento spiegando il perché del basso punteggio e perché lo considera sintomo di evasione; il contribuente può provare che invece il punteggio basso era dovuto a fattori leciti particolari. Giudice decide caso per caso sulla base delle prove. |
| Esito in caso di soccombenza | Se l’accertamento viene confermato (contribuente perde il ricorso), il reddito viene rideterminato al livello dello studio/ISA con recupero di imposte e sanzioni. Possibile poi appellare in secondo grado e in Cassazione. | Analogamente, se il giudice ritiene valido l’accertamento da ISA, il punteggio basso “condanna” il contribuente a maggiori imposte secondo calcolo dell’Ufficio. In caso contrario (vittoria contribuente), l’atto viene annullato. |
Simulazione pratica
Vediamo ora un esempio concreto di come potrebbe svolgersi un accertamento da studi di settore/ISA e la relativa difesa, così da mettere insieme tutti i pezzi del discorso.
Esempio: Mario è titolare di una ditta individuale che svolge servizi di assistenza tecnica (codice Ateco di artigiano). Per l’anno d’imposta 2023, Mario ha dichiarato un reddito di €30.000, mentre secondo l’Indice ISA di categoria risulterebbe un reddito “normale” di circa €45.000 per un’attività con le sue caratteristiche. Il punteggio ISA di Mario per il 2023 è 6, abbastanza basso. Nel mese di luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate invia a Mario un invito al contraddittorio, allegando il risultato dell’elaborazione ISA: c’è una differenza di 15.000 € di ricavi non giustificati secondo l’algoritmo, e si prospetta un possibile recupero a tassazione di tale importo (oltre a IVA e contributi). Mario, ricevuta la lettera, si rivolge subito al suo commercialista e all’avvocato tributarista per preparare la difesa.
- Contraddittorio: A fine luglio Mario si presenta all’incontro presso l’Ufficio. Porta con sé una corposa documentazione: in particolare, esibisce certificati medici e documenti INPS che attestano che nei mesi di marzo e aprile 2023 ha dovuto sospendere quasi del tutto l’attività a causa di un infortunio (ha subito un intervento chirurgico e un lungo recupero). Inoltre, porta estratti conto bancari e le fatture emesse nel 2024 che mostrano come alcuni lavori iniziati nel 2023 siano stati fatturati a cavallo d’anno (nei primi mesi del 2024), spiegando che questo è uno dei motivi per cui il 2023 appare sottotono. Mario consegna anche copia di un contratto importante annullato da un cliente a metà 2023 (del valore di €10.000) a causa di problemi del cliente stesso: questo contratto sfumato ha inciso molto sul risultato annuale. Tutti questi elementi vengono discussi: i funzionari dell’Agenzia prendono atto delle spiegazioni. Esito del contraddittorio: l’Ufficio riconosce in parte le ragioni di Mario (in particolare, ritiene plausibile che la malattia abbia inciso sul fatturato e “sconta” dal calcolo i giorni di inattività) ma ritiene comunque che resti un gap non giustificato, seppur inferiore (ad esempio €8.000 invece di €15.000 iniziali). Propone a Mario di “chiudere” pagando le imposte su questi €8.000. Mario, però, convinto di aver agito correttamente, non accetta l’adesione su tale importo.
- Avviso di accertamento: Ad ottobre 2025, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento nei confronti di Mario, ritenendo non giustificati €8.000 di ricavi. Nell’atto, l’Ufficio motiva di aver tenuto conto parzialmente delle giustificazioni (malattia, lavori fatturati nel 2024) ma di aver comunque ricalcolato un reddito maggiore di €8.000 basandosi sugli ISA. Mario, tramite il suo legale, presenta ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria. Nel ricorso si evidenzia che: (a) la differenza residua è dovuta a un errore nel modello, perché l’ISA non considerava che Mario opera in una zona rurale con meno domanda rispetto alla media nazionale; (b) l’Ufficio, pur avendo ridotto la pretesa, non ha spiegato perché €8.000 sarebbero ancora dovuti nonostante le prove presentate; (c) in ogni caso la malattia e il contratto annullato giustificavano interamente lo scostamento. Viene allegata una perizia economica di parte che confronta il fatturato di Mario con quello medio della sua provincia, mostrando che in realtà il suo reddito è in linea con gli operatori locali e che lo standard nazionale utilizzato dall’ISA sovrastima le possibilità in quella zona. Si deposita anche una richiesta di accesso agli atti dell’Agenzia, per ottenere le note tecniche del software ISA e verificare eventuali ulteriori elementi.
- Giudizio: Nel corso del processo, il giudice ammette la perizia e ascolta un testimone (il cliente che aveva annullato il contratto, il quale conferma di aver dovuto disdire l’ordine causando la perdita di ricavo per Mario). Dall’istruttoria emerge effettivamente che l’algoritmo ISA non teneva conto di fattori geografici importanti e che la zona di Mario nel 2023 ha avuto un calo generale di domanda. Alla luce di ciò, la Corte ritiene che lo standard utilizzato dall’ufficio non fosse adeguato alla realtà del contribuente e che gli €8.000 aggiunti siano privi di reale fondamento. Di conseguenza, con sentenza, il giudice annulla integralmente l’accertamento, dando ragione a Mario. L’Agenzia dovrà anche rifondere le spese legali.
Questo esempio, pur semplificato, mostra come una situazione inizialmente sfavorevole (punteggio ISA basso) possa essere ribaltata grazie a una difesa ben costruata che evidenzia le specificità del caso concreto. Naturalmente non sempre l’esito è positivo al 100%: in altri casi, se le giustificazioni non coprono tutto lo scostamento, il giudice potrebbe confermare parzialmente l’accertamento (ad esempio per una quota di ricavi non spiegati). Ma l’importante è capire che il contribuente non è indifeso di fronte a questi strumenti statistici: al contrario, ha diritti chiari (come il contraddittorio) e può far valere la propria realtà sostanziale per evitare pretese arbitrarie.
Checklist procedurale difensiva: per riassumere, ecco i passi da compiere “bene e subito” quando si è destinatari di un accertamento da studi di settore/ISA:
- Alla ricezione dell’invito al contraddittorio: verificare immediatamente la correttezza dei dati e delle informazioni indicate dall’ufficio (ricavi, codice attività, numero di addetti, percentuali, etc.). Segnare la data entro cui si deve rispondere.
- Preparare la difesa preliminare: raccogliere il prima possibile tutti i documenti che possono spiegare lo scostamento (bilanci, registri IVA, fatture, estratti conto, documenti extra-contabili, certificati, contratti, perizie). Contattare consulenti esperti se necessario per analizzare il caso.
- Partecipare al contraddittorio: non ignorare l’invito! Presentarsi (di persona o tramite professionista delegato) all’Ufficio, esporre con chiarezza tutte le ragioni e consegnare copia della documentazione raccolta. Eventualmente, depositare una memoria scritta riassuntiva. Chiedere all’ufficio di mettere a verbale le vostre osservazioni o protocollare i documenti consegnati.
- Valutare eventuali proposte di adesione: se l’ufficio durante o dopo il contraddittorio propone un “compromesso” (ad esempio riconoscere una parte di ricavi in cambio di chiudere la pratica con sanzioni ridotte), valutare con lucidità la convenienza. Accettare solo se la pretesa residua è modesta e si vuole evitare il rischio e i costi del contenzioso; altrimenti, mantenere la propria posizione e prepararsi al ricorso.
- Alla notifica dell’avviso di accertamento: segnare il termine dei 60 giorni per il ricorso. In tale finestra, decidere se presentare istanza di accertamento con adesione (per guadagnare tempo o provare un’ultima trattativa) oppure procedere direttamente col ricorso. Redigere il ricorso con l’aiuto di un legale, inserendo tutti i motivi (procedurali e di merito) e allegando la documentazione. Depositare il ricorso entro i termini presso la Corte tributaria e notificare copia all’Agenzia delle Entrate. Valutare se chiedere la sospensione dell’atto in caso di importi elevati e rischio per l’azienda.
- Durante il giudizio: continuare a raccogliere elementi a favore (anche dopo il ricorso si possono produrre documenti fino a 20 giorni prima dell’udienza). Preparare eventuali testimoni. Se necessario, depositare memorie illustrative prima dell’udienza per replicare alle difese dell’ufficio. Presentarsi all’udienza ben preparati sui punti chiave (o assicurarsi che il proprio difensore lo sia).
- Dopo la decisione di primo grado: se è favorevole al contribuente, l’incubo è finito (salvo appello dell’Ufficio); se è sfavorevole o parzialmente sfavorevole, valutare con il difensore l’opportunità di appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Seguendo questa scaletta e mantenendo sempre un atteggiamento proattivo, si massimizzano le chance di difendersi con successo. La chiave è agire subito, con competenza e documentazione alla mano.
Fonti
- Normativa: D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (artt. 38 e 39 – accertamenti analitici e induttivi); D.L. 30 agosto 1993 n. 331, art. 62-sexies (introduzione parametri e studi di settore); Legge 8 maggio 1998 n. 146 (art. 10 – garanzie del contraddittorio per accertamenti da studi di settore); D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 9-bis (introduzione degli ISA); D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 (in materia di cooperazione fiscale preventiva); Legge 30 dicembre 2023 n. 228 (art. 1, comma 10 – introduzione art. 6-bis L.212/2000 sul contraddittorio generalizzato); Decreto MEF 24 aprile 2024 (G.U. 30/4/2024 – individuazione atti esclusi dall’obbligo di contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis); Statuto del Contribuente (L. 212/2000), artt. 7, 6-bis e 12 c.7 (quest’ultimo abrogato nel 2024); D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (accertamento con adesione), art. 5 e 5-ter (quest’ultimo introdotto nel 2019 e poi abrogato nel 2024 con l’entrata in vigore dell’art. 6-bis cit.).
- Prassi amministrativa: Provvedimento Agenzia Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019 (applicazione ISA periodo d’imposta 2018 – soglie regime premiale) ; Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 (chiarimenti su ISA e regime premiale, inclusa condizione di veridicità dei dati dichiarati); Circolare Agenzia Entrate n. 17/E del 2 agosto 2019 (prime istruzioni applicative sugli ISA); vari Decreti Ministeriali annuali di approvazione degli indici ISA per ciascun periodo d’imposta (es. DM 28 dicembre 2020 per ISA 2021, etc.); Dossier Camera dei Deputati – Servizio Studi – “La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” (luglio 2017) .
- Giurisprudenza recente (Corte di Cassazione): Sez. Unite Civili – Sent. 25 luglio 2025 n. 21271 (contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio generalizzato, superamento della prova di resistenza) ; Sez. Tributaria – Ord. 9 ottobre 2024 n. 26357 (obbligo contraddittorio negli accertamenti standardizzati; natura di presunzione semplice degli studi di settore) ; Ord. 17 luglio 2024 n. 19669 (necessità di motivazione puntuale sull’inutilizzabilità delle prove contrarie del contribuente) ; Ord. 9 aprile 2024 n. 9554 (omessa convocazione al contraddittorio comporta nullità dell’atto; obbligo di motivare sul perché delle divergenze) ; Ord. 5 novembre 2024 n. 28457 (termine di accertamento ridotto di un anno solo con dati veritieri: perdita del beneficio se emergono dati falsi) ; Ord. 1 marzo 2023 n. 6133 (conferma principio: studi di settore = presunzioni semplici, accertamento nullo senza contraddittorio) ; Sent. 18 dicembre 2009 n. 26635 (SS.UU. 2009, principi generali su contraddittorio e onere della prova negli accertamenti da studi di settore).
- Giurisprudenza di merito: Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II grado (già CTR) Lombardia n. 400/2022 (esempio di annullamento accertamento ISA per difetto di motivazione); Sentenza CGT I grado di Padova n. 2380/2023 (sul valore prevalente del fatto concreto nel contraddittorio preventivo) . (Le sentenze di merito variano, ma quelle di legittimità sopra elencate rappresentano la linea guida uniforme a livello nazionale.)
Hai ricevuto un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore o sugli indici ISA? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore o sugli indici ISA?
👉 Non sottovalutarlo: l’Agenzia delle Entrate può contestarti ricavi o compensi maggiori rispetto a quelli dichiarati, ma puoi difenderti efficacemente.
In questa guida ti spiego cos’è l’accertamento da studi di settore, quando è legittimo e come reagire subito con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto.
💥 Cos’è l’Accertamento da Studi di Settore
L’accertamento da studi di settore è un procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate stima i ricavi o i compensi di un’impresa o di un professionista sulla base di parametri statistici e modelli economici.
📌 Se i ricavi dichiarati risultano inferiori a quelli “presunti” dagli studi di settore o dagli indici ISA, l’Agenzia può emettere un avviso di accertamento per incongruenza.
Questo tipo di accertamento si applica principalmente a:
- imprese individuali e società di persone;
- professionisti con partita IVA;
- artigiani e commercianti;
- studi associati e piccole attività economiche.
⚖️ Quando l’Accertamento è Legittimo
L’accertamento da studi di settore non può basarsi solo su dati statistici:
deve essere supportato da ulteriori elementi concreti, e preceduto da un contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
È legittimo solo se:
- l’Agenzia dimostra gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli stimati;
- i dati contabili risultano inattendibili o incompleti;
- è stato instaurato il contraddittorio preventivo;
- la motivazione dell’atto spiega perché le tue giustificazioni non sono state accolte.
📌 Se manca il contraddittorio o la motivazione è generica, l’accertamento è nullo per violazione del diritto di difesa.
💠 Differenza tra Studi di Settore e Indici ISA
| Caratteristica | Studi di Settore (fino al 2018) | Indici ISA (dal 2019) |
|---|---|---|
| Finalità | Stimare ricavi e compensi attesi | Valutare l’affidabilità fiscale |
| Metodo | Analisi statistica basata su cluster economici | Punteggio da 1 a 10 su più indicatori |
| Effetto | Accertamento induttivo in caso di scostamento | Segnalazione di rischio fiscale |
| Difesa | Contraddittorio obbligatorio | Contraddittorio e revisione del punteggio |
📌 In entrambi i casi, l’Agenzia deve dimostrare che i dati standardizzati riflettono davvero la tua realtà economica, cosa spesso molto difficile.
⚠️ Le Conseguenze per il Contribuente
Un accertamento da studi di settore può comportare:
- 💰 Recupero di imposte IRPEF, IRES, IVA e IRAP;
- ⚖️ Sanzioni elevate per infedele dichiarazione;
- 📈 Interessi di mora su più annualità;
- 🏦 Cartella esattoriale o pignoramento se non si ricorre;
- 🚫 Segnalazione di rischio fiscale per le annualità successive.
📌 Ma se l’accertamento è basato su dati errati, medie statistiche o mancanza di contraddittorio, può essere annullato in sede tributaria.
🧩 Le Strategie di Difesa Possibili
1️⃣ Dimostrare la Specificità della Tua Attività
Puoi contestare che l’Agenzia abbia applicato parametri economici non rappresentativi del tuo settore o del tuo territorio.
📌 Ogni impresa è diversa: uno scostamento dallo “standard” non basta per accertare un maggior reddito.
2️⃣ Contestare la Mancanza di Contraddittorio
La Cassazione ha chiarito che il contraddittorio è obbligatorio negli accertamenti da studi di settore.
Se non ti è stata data la possibilità di spiegarti, l’atto è nullo per violazione dello Statuto del Contribuente (art. 12, L. 212/2000).
3️⃣ Fornire Prove Concrete
Puoi presentare:
- documenti che giustificano ricavi inferiori (crisi di settore, riduzione dei clienti, stagionalità);
- fatture, bilanci, contratti e estratti conto;
- elementi che dimostrano situazioni straordinarie (malattia, chiusura temporanea, eventi climatici, pandemia).
📌 Se le tue prove sono coerenti, il giudice può annullare integralmente l’accertamento.
4️⃣ Impugnare l’Avviso di Accertamento
Puoi presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo:
- la sospensione dell’esecuzione;
- la dichiarazione di nullità dell’atto;
- la cancellazione o riduzione delle somme accertate.
📌 Il giudice può sospendere l’avviso entro 48 ore, se sussistono vizi evidenti.
🧾 I Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato
- Copia dell’avviso di accertamento;
- Comunicazioni o inviti al contraddittorio ricevuti;
- Modelli ISA o studi di settore utilizzati;
- Documenti contabili e fiscali (bilanci, registri IVA, fatture);
- Prove delle circostanze straordinarie o dei cali di reddito.
📌 Con questi documenti, l’avvocato può dimostrare la non attendibilità del modello applicato e difendere la tua posizione.
⏱️ Tempi della Procedura
- Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: anche in 48 ore;
- Udienza di merito: entro 6–12 mesi circa;
- Eventuale appello o Cassazione: solo per vizi di diritto.
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può riscuotere né procedere con pignoramenti.
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✅ Annullamento dell’accertamento per mancanza di contraddittorio.
✅ Riduzione o cancellazione delle somme accertate.
✅ Blocco immediato della riscossione.
✅ Tutela completa dei redditi e del patrimonio aziendale.
✅ Assistenza tecnica in ogni grado di giudizio.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare l’invito al contraddittorio o la notifica dell’avviso.
❌ Accettare passivamente i calcoli dell’Agenzia.
❌ Non raccogliere prove e documentazione difensiva.
❌ Rivolgersi tardi a un avvocato tributarista.
📌 Gli studi di settore non rappresentano la realtà economica di ogni contribuente: una difesa tempestiva può annullare l’intero accertamento.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la legittimità dell’accertamento e dei modelli applicati.
📌 Ti assiste nel contraddittorio e nella presentazione delle prove difensive.
✍️ Redige e deposita ricorsi fondati su vizi procedurali e sostanziali.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria in ogni grado.
🔁 Ti segue fino alla sospensione o all’annullamento definitivo dell’atto.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti basati su studi di settore e ISA.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di professionisti, imprese e artigiani contro l’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Un accertamento da studi di settore non è una condanna: i dati statistici non possono sostituire la realtà economica della tua attività.
Con una difesa legale tempestiva puoi contestare gli errori dell’Agenzia, bloccare la riscossione e ottenere l’annullamento dell’atto.
⏱️ Hai 60 giorni dalla notifica per agire: non aspettare.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro l’accertamento da studi di settore può partire oggi stesso.