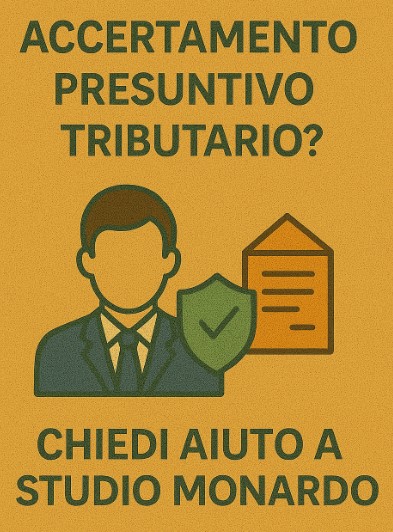Hai ricevuto un accertamento presuntivo dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza? Si tratta di una delle forme di accertamento più frequenti e, al tempo stesso, più insidiose, perché il Fisco non si basa su prove dirette, ma su presunzioni e indizi per ricostruire un reddito o un fatturato superiore a quello dichiarato.
In altre parole, l’Agenzia ritiene che tu abbia guadagnato di più di quanto dichiarato e lo deduce da comportamenti, spese o movimentazioni bancarie. Ma attenzione: la presunzione non è una prova assoluta, e con una difesa tempestiva e ben documentata puoi contestare l’accertamento e dimostrarne l’infondatezza.
Cos’è un accertamento presuntivo tributario
L’accertamento presuntivo è una procedura prevista dall’art. 39 del DPR 600/1973 (per le imposte sui redditi) e dall’art. 54 del DPR 633/1972 (per l’IVA).
Permette all’Agenzia delle Entrate di ricostruire i redditi o i ricavi di un contribuente in base a presunzioni semplici, cioè a indizi che, secondo il Fisco, fanno presumere un maggiore volume d’affari o reddito imponibile.
Le presunzioni possono derivare, ad esempio, da:
- movimenti bancari non giustificati;
- spese personali o aziendali incoerenti con i redditi dichiarati;
- acquisti di beni di lusso, immobili o auto;
- margini anomali rispetto alla media del settore (indici ISA o studi di settore);
- differenze tra rimanenze dichiarate e dati contabili;
- prelievi in contanti non documentati.
Come funziona l’accertamento presuntivo
L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento presuntivo in caso di incoerenze o anomalie rilevate nei dati fiscali, contabili o bancari.
Il procedimento si articola in varie fasi:
- Accesso o verifica presso la sede dell’impresa o presso la banca dati dell’Agenzia;
- Raccolta degli elementi indiziari (spese, conti, flussi finanziari);
- Invito al contraddittorio, in cui il contribuente può fornire chiarimenti o giustificazioni;
- Emissione dell’avviso di accertamento, se il Fisco ritiene insufficienti le spiegazioni.
L’accertamento diventa quindi una presunzione di maggiore reddito, che il contribuente deve contestare dimostrando con prove contrarie la reale entità delle entrate.
Quando un accertamento presuntivo è legittimo
L’Agenzia delle Entrate può utilizzare presunzioni solo se sono:
- gravi (cioè attendibili e rilevanti),
- precise (non generiche o astratte),
- concordanti (più indizi che portano alla stessa conclusione).
Se anche uno di questi requisiti manca, l’accertamento è illegittimo e impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Quando invece è nullo o infondato
L’accertamento presuntivo è nullo se:
- si basa su presunzioni generiche o contraddittorie;
- l’Agenzia non ha invitato il contribuente al contraddittorio preventivo;
- mancano prove documentali a supporto delle presunzioni;
- non è motivato in modo chiaro e dettagliato;
- le presunzioni si fondano su elementi non verificabili o incongruenti (es. spese di un familiare non fiscalmente a carico).
La Cassazione ha stabilito che un accertamento “a presunzioni semplici” non può sostituire la prova diretta, ma deve sempre essere logicamente motivato e supportato da dati verificabili.
Le conseguenze di un accertamento presuntivo
Un accertamento di questo tipo può comportare:
- maggiori imposte da pagare (IRPEF, IVA, IRAP, IRES);
- sanzioni fino al 240% dell’imposta accertata;
- interessi di mora e iscrizione a ruolo immediata;
- successiva notifica di cartelle esattoriali o pignoramenti;
- segnalazioni alla Procura della Repubblica nei casi più gravi (evasione o dichiarazione infedele).
Agire subito con un legale esperto consente di bloccare la riscossione e contestare la pretesa prima che diventi definitiva.
Come difendersi da un accertamento presuntivo
Un avvocato esperto in diritto tributario può impostare una difesa efficace basata su prove documentali e giuridiche concrete. In particolare può:
- Verificare la legittimità della procedura (esistenza dell’invito al contraddittorio e rispetto dei termini);
- Contestare le presunzioni come generiche, infondate o prive di correlazione con il reddito effettivo;
- Fornire giustificazioni alternative (es. spese sostenute con risparmi, donazioni, prestiti o redditi esenti);
- Richiedere la sospensione della riscossione per evitare pignoramenti o fermi;
- Impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica;
- Proporre un accertamento con adesione per ridurre imposta e sanzioni in caso di parziale fondatezza.
Le strategie difensive più efficaci
- Dimostrare la provenienza delle somme contestate.
Presentare documenti bancari, scritture contabili o dichiarazioni di terzi che provano l’origine lecita delle somme. - Contestare la genericità delle presunzioni.
Le spese o i prelievi non giustificano automaticamente un reddito occulto. - Evidenziare errori di calcolo o di metodo.
Gli accertamenti presuntivi spesso utilizzano medie statistiche errate o dati non aggiornati. - Invocare la giurisprudenza della Cassazione.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che le presunzioni devono essere “gravi, precise e concordanti”, altrimenti l’accertamento è nullo. - Richiedere la sospensione cautelare.
In presenza di un ricorso, si può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia dell’avviso fino alla decisione definitiva.
Come scegliere l’avvocato giusto per un accertamento presuntivo
Ecco le caratteristiche del professionista ideale:
- Specializzazione in diritto tributario e contenzioso fiscale;
- Esperienza diretta in accertamenti basati su presunzioni e indagini finanziarie;
- Collaborazione con commercialisti o periti contabili, per fornire prove documentali efficaci;
- Aggiornamento costante sulla giurisprudenza tributaria, per sfruttare i più recenti orientamenti della Cassazione;
- Capacità di mediazione con l’Agenzia delle Entrate per soluzioni agevolate o definizioni.
Cosa succede se non ti difendi
Ignorare un accertamento presuntivo o rispondere senza l’assistenza di un legale può portare a:
- iscrizione a ruolo delle somme e cartelle esattoriali esecutive;
- pignoramenti e ipoteche su conti e beni;
- sanzioni elevate e interessi di mora;
- perdita del diritto di contestare la pretesa entro i termini di legge.
Quando rivolgersi a un avvocato
Devi contattare un avvocato se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento basato su presunzioni o spese anomale;
- l’Agenzia ti chiede di giustificare movimenti bancari o spese personali;
- vuoi impugnare un atto fondato su dati indiziari o statistici;
- hai bisogno di bloccare la riscossione e difendere il tuo patrimonio.
Un avvocato esperto in accertamenti presuntivi e contenzioso tributario può:
- impugnare l’avviso per vizi formali e sostanziali;
- dimostrare la non imponibilità delle somme contestate;
- ottenere la sospensione o la riduzione del debito fiscale;
- tutelarti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se necessario, in Cassazione.
⚠️ Attenzione: l’accertamento presuntivo non è una condanna automatica. Se l’Agenzia delle Entrate non dimostra la gravità e precisione delle presunzioni, l’atto è illegittimo e annullabile. Agire tempestivamente con un avvocato esperto è l’unico modo per ribaltare la pretesa e proteggere il tuo reddito e i tuoi beni.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e difesa da accertamenti presuntivi – spiega come funziona l’accertamento presuntivo, quando è nullo e quali strategie legali adottare per difendersi con successo.
👉 Hai ricevuto un accertamento presuntivo basato su spese o movimenti bancari?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo l’avviso, verificheremo la solidità delle presunzioni e costruiremo una strategia legale personalizzata per impugnare l’accertamento, sospendere la riscossione e tutelare la tua posizione fiscale.
Introduzione all’accertamento presuntivo tributario
In ambito fiscale italiano l’accertamento presuntivo (detto anche accertamento induttivo o extracontabile) è un metodo attraverso cui l’Amministrazione finanziaria determina maggiori imposte basandosi su indizi e presunzioni anziché su prove dirette. In pratica, il Fisco deduce l’esistenza di redditi non dichiarati partendo da fatti noti o anomalie riscontrate, colmando così la mancanza di prove certe di evasione . Ad esempio, versamenti bancari ingiustificati inducono a presumere incassi “in nero” sottratti a tassazione; uno stile di vita lussuoso a fronte di redditi dichiarati modesti fa presumere entrate occulte; irregolarità contabili significative fanno presumere vendite non dichiarate o costi fittizi, e così via .
Questa tipologia di accertamento è prevista dalla legge per contrastare l’evasione quando la contabilità del contribuente risulta inattendibile, incompleta o mancante. Diversamente dall’accertamento “analitico” basato esclusivamente sulle scritture contabili, nell’accertamento presuntivo l’Ufficio finanziario può prescindere dai dati contabili ufficiali e fondare la pretesa fiscale su elementi indiretti o extracontabili. Ciò avviene tipicamente in alcuni scenari ricorrenti:
- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi: se il contribuente non presenta la dichiarazione annuale, l’Amministrazione procede d’ufficio a ricostruire il reddito imponibile usando qualsiasi informazione disponibile, anche con metodi approssimativi (parametri medi di settore, percentuali forfettarie, etc.) . In tali casi estremi è ammesso l’uso di presunzioni anche non “gravi, precise e concordanti”, come vedremo meglio, trattandosi di evasione conclamata.
- Contabilità inattendibile o irregolare: se emergono dagli accertamenti contabili omissioni o falsificazioni tali da inficiare la veridicità dei registri (ad es. duplicazioni di fatture, passività fittizie, margini di profitto illogici), il Fisco può rettificare il reddito dichiarato integrando i dati contabili con presunzioni semplici tratte da indizi concreti .
- Manifestazioni di ricchezza sproporzionate (accertamento sintetico): se una persona fisica sostiene spese ingenti incompatibili col reddito dichiarato, scatta il cosiddetto redditometro (accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973). Ad esempio, l’acquisto o il possesso di beni di lusso (auto di grossa cilindrata, barche, immobili prestigiosi) o elevati movimenti finanziari sul conto, in assenza di adeguata copertura reddituale, possono far presumere un maggior reddito occulto .
- Indagini finanziarie sui conti correnti: l’Agenzia delle Entrate può ottenere i dati dei conti bancari e postali del contribuente (previa autorizzazione interna) e presumere che ogni accredito non giustificato sia un ricavo non dichiarato, e che ogni prelievo ingente non giustificato costituisca impiego in nero di denaro (quindi che corrisponda a costi in nero e relativi ricavi occulti) . Questa è una presunzione legale molto incisiva: l’art. 32 del DPR 600/1973 stabilisce infatti che i versamenti bancari non giustificati si presumono redditi tassabili iure legis, spostando sul contribuente l’onere di provare il contrario .
È importante chiarire che l’accertamento presuntivo non può basarsi su mere illazioni arbitrarie: anche le presunzioni devono rispettare certe regole di logicità e legalità. Nel contesto tributario italiano distinguiamo vari tipi di presunzioni e metodi di accertamento induttivo, ciascuno con presupposti e forza probatoria diversa. Prima di approfondire le norme e le tipologie di accertamento presuntivo (analitico-induttivo, induttivo puro, sintetico), vedremo brevemente cosa sono le presunzioni legali e semplici e come incidono sul riparto dell’onere della prova.
Presunzioni tributarie: legali, semplici e “supersemplici”
Nel diritto probatorio si distingue tra presunzioni legali (stabilite direttamente dalla legge) e presunzioni semplici (lasciate al prudente apprezzamento di giudice o Amministrazione finanziaria) . Comprendere questa distinzione è fondamentale, poiché dal tipo di presunzione impiegato derivano conseguenze diverse sul piano della difesa.
- Presunzioni legali (iuris tantum o iuris et de iure): sono fissate da norme di legge tributaria, che attribuiscono a determinati fatti noti un preciso valore probatorio ai fini fiscali. Ad esempio, l’art. 32 DPR 600/1973 dispone che i movimenti su conti bancari non giustificati si presumono ricavi imponibili, così come l’art. 33 DPR 600/73 presume ricavi occulti in presenza di determinate scritture extra-contabili (i cosiddetti “brogliacci”) ritrovate presso l’imprenditore . Queste presunzioni legali sono generalmente relative (iuris tantum): ammettono prova contraria da parte del contribuente. Significa che il fatto presunto (p.es. un ricavo non dichiarato) è considerato vero fino a prova contraria, e spetta al contribuente fornire tale prova contraria per vincere la presunzione . In rarissimi casi la legge prevede presunzioni legali assolute (iuris et de iure) che non ammettono prova contraria – ma nel diritto tributario sono eccezioni teoriche (ad esempio, prima di una riforma, i brogliacci extracontabili erano considerati prova assoluta di ricavi in nero). Dunque nella prassi quasi tutte le presunzioni legali tributarie sono relative. Un effetto cruciale della presunzione legale è il ribaltamento dell’onere della prova: l’Ufficio non deve dimostrare ulteriormente il fatto ignoto (il maggior reddito), che è “provato per legge” dal fatto noto, mentre il contribuente deve attivarsi per dimostrare che la realtà è diversa da quella presumibile ex lege .
- Presunzioni semplici: non sono previste da una norma specifica, ma vengono costruite caso per caso dal Fisco (e poi valutate dal giudice) sulla base di indizi di fatto. La loro ammissibilità richiede per legge che gli indizi utilizzati siano gravi, precisi e concordanti (GPC), secondo il disposto dell’art. 2729 del Codice Civile . In sostanza, una presunzione semplice permette di ritenere provato un fatto sconosciuto (es: esistenza di vendite “in nero”) a partire da uno o più fatti noti, purché questi convergano univocamente verso quella conclusione e abbiano un peso logico significativo . Ad esempio, se un ristorante dichiara un margine di ricarico medio del 10% sui prodotti, mentre la media di settore è 200%, e dagli acquisti risultano quantità di materie prime incompatibili col fatturato dichiarato, il Fisco può inferire che parte dei ricavi non siano stati contabilizzati (presunzione semplice) . Naturalmente gli indizi devono essere numerosi o robusti: la Cassazione ha chiarito che anche un solo elemento può sorreggere un accertamento induttivo, ma solo se ha di per sé carattere di assoluta precisione e gravità (es: consumo di materia prima strettamente correlato ai ricavi) . In giudizio, a differenza delle presunzioni legali, l’onere iniziale della prova resta a carico del Fisco: spetta all’Amministrazione finanziare dimostrare al giudice che gli indizi raccolti sono attendibili e rispettano i requisiti di legge . Solo se il giudice ritiene validi tali indizi (grave-precisi-concordanti), il fatto presunto viene considerato provato, e diventa onere del contribuente fornire una controprova specifica per smentirlo . In pratica quindi, quando l’accertamento si fonda su presunzioni semplici, il contribuente deve comunque attivarsi energicamente per confutare punto per punto le ricostruzioni del Fisco (ad es. dimostrando con documenti che i margini bassi avevano giustificazioni economiche, che determinate spese non potevano generare ricavi, ecc.).
- Presunzioni “supersemplici” (ultra-semplificate): è un termine dottrinale per indicare quelle presunzioni ancora più deboli delle semplici, che la legge consente al Fisco in situazioni eccezionali di evasione conclamata. Si verifica principalmente nei casi di omessa dichiarazione o di contabilità totalmente inattendibile. In tali frangenti, alcune norme speciali (come l’art. 39 comma 2 DPR 600/1973, che disciplina l’accertamento d’ufficio) permettono al Fisco di prescindere da ogni requisito di gravità e precisione degli indizi, potendo determinare il reddito con metodi induttivi puri anche basati su meri dati medi o ipotesi . In altre parole, quando il contribuente non presenta dichiarazione o mantiene scritture del tutto inaffidabili, l’Ufficio può ricostruire “a tavolino” il reddito utilizzando qualsiasi appiglio logico, anche presunzioni semplici prive dei requisiti normalmente richiesti . Ad esempio, in caso di evasione totale, l’ufficio potrebbe applicare direttamente coefficienti presuntivi di redditività medi per quel settore (ricavi = tot% degli acquisti, ecc.), senza dover produrre specifici indizi gravi. Ciò non significa che il Fisco abbia carta bianca assoluta: resta ferma la possibilità per il contribuente di difendersi contestando l’entità esagerata della ricostruzione. Tuttavia, la posizione del contribuente è molto più difficile, perché manca una base contabile ufficiale su cui fare leva e le stime del Fisco godono di ampio margine discrezionale . In giudizio, spetterà al contribuente cercare di dimostrare – anche tramite presunzioni contrarie o dati esterni – che il reddito stimato dal Fisco è irragionevole (ad es. provando che nell’anno in questione l’attività ha subito eventi eccezionali che giustificano il calo di fatturato). Anticipiamo sin d’ora che la Corte Costituzionale e la Cassazione sono intervenute per bilanciare queste situazioni, imponendo comunque il rispetto del principio di capacità contributiva: in particolare si è sancito che anche in accertamenti induttivi puri il Fisco non può tassare ricavi lordi senza considerare alcun costo, dovendone stimare l’ammontare sia pure in via forfettaria . Su questo aspetto torneremo dettagliatamente più avanti.
Di seguito una tabella riepilogativa che confronta i tre tipi di presunzione descritti e il diverso impatto sul contribuente:
| Tipologia di presunzione | Definizione e caratteri | Effetti sul piano probatorio |
|---|---|---|
| Legale (iuris tantum) | Prevista da una norma tributaria. Attribuisce al fatto noto indicato dalla legge (es. versamento bancario ingiustificato) il valore di prova del fatto ignoto (maggior reddito). Quasi sempre relativa (confutabile), raramente assoluta . | Inverte l’onere della prova: il fatto presunto è dato per vero fino a prova contraria. Il Fisco è dispensato dal provarlo, spetta al contribuente fornire prova analitica contraria per smentirlo . Se assoluta, nessuna prova contraria è ammessa. |
| Semplice | Non fissata per legge, ma dedotta logicamente da indizi di fatto. Ammessa solo se gli indizi sono gravi, precisi, concordanti (art. 2729 c.c.). Esempio: ricostruzione di ricavi basata su consumi di materie prime o su medie di settore . | Non sposta l’onere iniziale della prova: il Fisco deve convincere il giudice della solidità degli indizi . Se il giudice li ritiene validi, scatta una sorta di presunzione di veridicità e il contribuente deve presentare controprove specifiche per confutarli . In pratica, l’onere probatorio si “trasla” sul contribuente solo dopo che gli indizi del Fisco hanno superato il vaglio del giudice. |
| “Supersemplice” | Presunzione ultra-semplificata ammessa da norme speciali in situazioni estreme (omessa dichiarazione, scritture assenti o inattendibili totali). Consente al Fisco di stimare il reddito anche senza indizi GPC, usando parametri medi o dati comunque noti . Esempi: applicazione diretta di studi di settore/ISA, percentuali di ricarico standard, ecc. | L’Ufficio può determinare la base imponibile d’ufficio, senza dover apportare solidi elementi indiziari a supporto . L’onere della prova in giudizio grava fortemente sul contribuente, che dovrà dimostrare l’eccesso della pretesa pur senza disporre di dati contabili attendibili a suo favore. Rimane però il limite della ragionevolezza: ricostruzioni grossolanamente arbitrarie possono essere annullate dal giudice per violazione del principio di capacità contributiva . |
Legenda: GPC = gravi, precisi e concordanti.
Come si evince dalla tabella, all’aumentare della gravità delle irregolarità riscontrate aumenta il grado di invasività dell’accertamento: si passa dalla rettifica analitica puntuale (quando la contabilità è affidabile salvo piccoli errori), all’accertamento analitico-induttivo con presunzioni semplici (quando vi sono alcune incongruenze significative), fino all’accertamento induttivo puro in caso di totale inattendibilità delle scritture, e infine all’accertamento sintetico per le persone fisiche con spese sproporzionate . Nel prossimo paragrafo analizzeremo proprio le varie tipologie di accertamento basate su presunzioni, indicando per ciascuna i riferimenti normativi (disposizioni del DPR 600/1973 e DPR 633/1972) e i presupposti di applicabilità.
Norme e tipologie di accertamento basate su presunzioni
Accertamento analitico-contabile (rettifica puntuale, senza presunzioni)
Prima di tutto, è utile inquadrare l’accertamento analitico tradizionale, per capire quando si esula da esso. L’accertamento analitico-contabile è il metodo “ordinario” di controllo, utilizzato quando la contabilità è regolare e attendibile. In tal caso l’Ufficio si limita a rettificare singole poste della dichiarazione basandosi su dati certi: ad esempio recupera a tassazione costi indeducibili (non documentati da fatture valide) oppure ricavi non dichiarati ma risultanti da documenti certi (come movimentazioni di magazzino non registrate, fatture emesse non inserite in contabilità, ecc.). Non vengono introdotti elementi extracontabili né ipotesi presuntive, ma si opera sulle risultanze contabili correggendo eventuali errori o omissioni con calcoli esatti .
Sul piano normativo, l’accertamento analitico è previsto dall’art. 39, co.1 del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi (e dagli artt. 40 e 41 per il reddito di società di persone e enti, collegati al reddito dei soci) e dall’art. 54 del DPR 633/1972 per l’IVA . Tali disposizioni autorizzano l’ufficio a “rettificare” la dichiarazione del contribuente quando risultino elementi dichiarati inesatti o violazioni delle norme tributarie, sulla base di documenti e dati certi (verbali di ispezione, riscontri bancari documentalmente provati, ecc.) . Ad esempio, se un verbale della Guardia di Finanza accerta fatture per operazioni inesistenti, l’Ufficio può disconoscere quel costo nella dichiarazione dei redditi (aumentando il reddito imponibile) secondo l’art. 39, co.1, lett. a) DPR 600/73, senza bisogno di presunzioni ma con prova diretta dell’irregolarità. Analogamente, se un fornitore ha dichiarato vendite al contribuente per importi superiori a quelli che il contribuente ha contabilizzato come acquisti, questo elemento certo consente di rettificare i ricavi dichiarati.
In sintesi: l’accertamento analitico puro non mette in discussione la contabilità nel suo complesso, ma solo voci specifiche, e non consente l’uso di presunzioni: ogni maggior imponibile contestato deve risultare da un riscontro documentale concreto o dal semplice ricalcolo matematico di imposte dovute.
Tuttavia, qualora emergano incongruenze più ampie – pur in presenza di una contabilità formalmente regolare – si esce dall’ambito del controllo analitico semplice e si entra nel campo delle ricostruzioni per presunzioni. È qui che trovano spazio l’accertamento analitico-induttivo e l’accertamento induttivo puro, disciplinati rispettivamente dall’art. 39, comma 1, lett. d) e dall’art. 39, comma 2 del DPR 600/1973 (nonché dalle corrispondenti norme IVA, art. 54 co.2 e art. 55 DPR 633/1972).
Accertamento analitico-induttivo (rettifica extracontabile parziale)
L’accertamento analitico-induttivo – anche detto accertamento analitico presuntivo – è un metodo ibrido: in parte analitico, in quanto parte dalle scritture contabili esistenti, ma al tempo stesso induttivo perché integra o corregge i dati contabili tramite presunzioni semplici. Si applica quando la contabilità presenta sì una formale regolarità, ma emergono indizi di inattendibilità sostanziale limitata ad alcune aree. In altre parole, non si hanno irregolarità così pervasive da inficiare l’intera contabilità, ma esistono elementi che ne minano la credibilità in parte .
Presupposti tipici di accertamento analitico-induttivo (art. 39, co.1, lett. d) DPR 600/1973) sono, ad esempio:
– Omissioni o falsità circoscritte: scoperte di passività fittizie (debiti o costi inesistenti registrati in bilancio), ricavi non dichiarati documentati però da appunti extracontabili (come un secondo registro vendite parallelo), ecc.
– Comportamenti antieconomici anomali: margini di profitto troppo bassi rispetto a quelli normali del settore, sproporzione tra consumi e fatturato, incongruenze tra dati dichiarati e dati provenienti da terzi (es. fornitori o banche dati) .
In tali casi l’Ufficio non ignora completamente le risultanze contabili, ma le mette in dubbio e le rielabora con l’ausilio di presunzioni. La base normativa, come detto, è l’art. 39 co.1 lett. d) DPR 600/1973, il quale consente di presumere “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate” quando i dati contabili risultino inattendibili per incompletezza o falsità, basandosi su presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti . Analoga facoltà è prevista in ambito IVA dall’art. 54, co. 2 del DPR 633/1972 .
In pratica, nell’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio parte dai numeri dichiarati dal contribuente ma li rettifica per inferenza logica, ad esempio:
– Se durante un controllo si scopre che un’impresa ha inserito a bilancio costi fittizi (es. fatture false per operazioni mai avvenute), il Fisco può presumere che il reddito effettivo sia maggiore di quello dichiarato eliminando quei costi e aggiungendo le relative imposte evase.
– Se un negozio al dettaglio dichiara un ricarico medio del 10% sulle merci vendute, mentre i listini e i dati di settore indicano normalmente ricarichi del 150-200%, l’Ufficio può ritenere inattendibili i ricavi dichiarati. Basandosi su quell’indizio di antieconomicità (margine anomalo) e magari su altri elementi (inventario inconsistente, consumi elettrici sproporzionati, etc.), potrà ricostruire i ricavi applicando un ricarico più congruo e accertando maggiori vendite non contabilizzate .
Onere della prova: poiché qui si utilizzano presunzioni semplici, rimane la possibilità di prova contraria per il contribuente. Anzi, sarà fondamentale: nel caso del negozio con margine anomalo, il contribuente potrà difendersi dimostrando le ragioni specifiche di quel margine basso (es. merci obsolete svendute, liquidazione totale per cessazione attività, errori di registrazione poi corretti) . Se riesce a provare che il basso profitto aveva cause giustificative concrete, la presunzione del Fisco perde consistenza.
È bene evidenziare che, secondo giurisprudenza recente, anche nell’accertamento analitico-induttivo (quindi pur quando la contabilità non è del tutto affidabile) vige il principio della tassazione del reddito netto: ciò significa che, se l’Ufficio ricostruisce maggiori ricavi, deve contestualmente considerare o stimare anche i relativi costi necessari per produrre quei ricavi . In passato si riteneva che, se il contribuente aveva tenuto una contabilità scorretta, per i costi non dichiarati non vi fosse alcun riconoscimento; ma la Corte Costituzionale con sent. n. 225/2005 e n. 10/2023 ha chiarito che non si può tassare un ricavo presunto senza dedurre almeno forfettariamente i costi ad esso connessi, altrimenti si violerebbe il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. . La Cassazione ha fatto proprio questo principio: per esempio, con l’ordinanza n. 10192/2023 ha annullato un accertamento induttivo perché il Fisco non aveva riconosciuto neppure in via presuntiva le fatture di subappalto che l’azienda aveva sostenuto, finendo per tassare l’intero importo dei ricavi recuperati senza alcun costo . Dunque anche nelle rettifiche presuntive parziali il giudice si aspetta di vedere considerati i costi correlati: se l’Ufficio non lo fa, la difesa del contribuente potrà far leva su tale mancanza per ottenere l’annullamento parziale dell’atto (vedi anche Corte Cost. n.10/2023, che ha esteso questa tutela).
Accertamento induttivo puro (accertamento d’ufficio extracontabile totale)
L’accertamento induttivo “puro” rappresenta la forma più radicale di accertamento basato su presunzioni. Qui l’Amministrazione disconosce integralmente la contabilità del contribuente, ritenendola gravemente inattendibile o inesistente, e procede a ricostruire ex novo il reddito e il volume d’affari usando qualsiasi elemento disponibile. I casi in cui si può legittimamente ricorrere all’induttivo puro sono tassativamente indicati dalla legge (art. 39, co.2 DPR 600/1973 e art. 55 DPR 633/1972 per l’IVA) e coincidono con le ipotesi più gravi, ad esempio :
- Omessa dichiarazione annuale dei redditi (evasione totale).
- Mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie o sottrazione delle stesse a controlli (contabilità “in nero”).
- Irregolarità contabili gravissime, numerosissime e ripetute che rendono nel complesso inaffidabile l’intero bilancio (registri tenuti in modo caotico, errori sistematici, mancanza del libro inventari, ecc.).
- Omissione di allegati obbligatori alla dichiarazione (es. omessa presentazione del bilancio di esercizio quando dovuto).
- Mancata risposta a questionari o inviti a comparire da parte dell’ufficio (ex art. 32 DPR 600/73, che sanziona la mancata collaborazione precludendo poi di esibire i documenti in giudizio) .
- Grave scostamento dai parametri/studi di settore dovuto a dichiarazione infedele: ad esempio nelle annualità in cui vigevano gli studi di settore, uno scostamento rilevante (oltre il 15% o €50.000) tra ricavi dichiarati e ricavi “congrui” di settore, unito magari a infedele compilazione dei modelli, era presupposto per l’accertamento induttivo . (N.B.: Oggi gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici ISA, meno aggressivi sul piano accertativo, ma in passato il semplice scostamento grave dal profilo medio di settore poteva essere indice di inattendibilità globale).
In presenza di almeno una di queste condizioni, l’Ufficio è autorizzato a procedere in deroga alle normali regole di accertamento . L’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 recita infatti: “in deroga alle disposizioni del comma precedente, l’ufficio determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti [di gravità, precisione e concordanza]” . Tradotto: il Fisco può ignorare i dati contabili (ritenuti inaffidabili) e utilizzare qualsiasi informazione disponibile, anche presunzioni “libere” non dotate dei requisiti normalmente richiesti, per ricostruire imponibili e imposte evase.
Esempi pratici di come opera l’induttivo puro:
– Se un’azienda non ha tenuto alcuna contabilità o l’ha distrutta, l’Ufficio potrà stimare i ricavi sulla base di elementi indiretti come i consumi di materie prime risultanti dalle fatture d’acquisto, applicando un coefficiente di ricarico ragionevole per arrivare ai ricavi presunti .
– Se su conti bancari intestati all’imprenditore compaiono versamenti ingenti in contanti non spiegati, la legge (art. 32 citato) presume che siano ricavi non dichiarati: l’ufficio li sommerebbe al reddito tassabile .
– Se una società di costruzioni non presenta bilanci ma il Fisco acquisisce dati su vendite di immobili effettuate, potrà ricostruire i ricavi in base ai rogiti notarili noti e magari stimare ulteriori ricavi in nero confrontando i costi di costruzione con i prezzi medi di mercato degli immobili venduti (accertamento per parametri edili).
È chiaro che l’accertamento induttivo puro conferisce al Fisco un potere molto ampio, ma non illimitato. Rimangono comunque principi generali di logicità e proporzionalità che l’Amministrazione deve rispettare. La Cassazione ha più volte affermato che, pur essendo l’ufficio libero di prescindere dalle scritture in caso di contabilità inattendibile, ogni ricostruzione induttiva deve conservare un fondamento logico e non tradursi in una tassazione arbitraria, altrimenti viola l’art. 53 Cost. (capacità contributiva) . Ad esempio, se l’Ufficio stima i ricavi di un’azienda solo sulla base degli acquisti, dovrà applicare un ricarico plausibile e tener conto di circostanze note che limitano l’attività (periodi di chiusura, eventi straordinari, etc.) . Se le stime risultano palesemente irragionevoli (ad es. pretendere un reddito netto superiore al totale dei ricavi dichiarati, o un utile netto sproporzionato rispetto a costi noti), il giudice tributario può annullare o ridurre l’accertamento per eccesso di potere. In effetti, pronunce come Cass. n. 20897/2019 hanno annullato accertamenti induttivi in cui il reddito ricostruito era “impossibile” in base ai dati di mercato disponibili .
Va poi ribadito anche per l’induttivo puro il concetto richiamato sopra: principio del reddito netto. Se l’Ufficio ricostruisce completamente i ricavi di un’impresa omettente, la giurisprudenza impone che stimi anche i costi relativi, pena tassare ricchezza inesistente. La Cassazione (Sez. V) ha fissato la regola che “in caso di omessa dichiarazione (fondamento art. 41 DPR 600/73), l’Amministrazione può usare presunzioni supersemplici ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, al fine di evitare che venga tassato il profitto lordo anziché quello netto” . Questo orientamento deriva dalla sentenza della Corte Cost. n. 225/2005 e, da ultimo, è stato rafforzato dalla Corte Cost. n. 10/2023 che ha richiamato il dovere di deduzione forfettaria dei costi anche per accertamenti bancari analitico-induttivi .
Riepilogando l’induttivo puro: si applica in casi eccezionali di contabilità inutilizzabile; il Fisco ricostruisce da zero reddito e IVA con ogni mezzo; l’onere della prova si sposta in modo drastico sul contribuente, che per difendersi deve cercare di demolire la ricostruzione del Fisco presentando elementi contrari (documenti, perizie, circostanze che ridimensionano il reddito). Il Fisco ha mano libera nell’uso di presunzioni semplici “libere”, ma non può essere del tutto arbitrario: se le sue stime sono incoerenti o infondate, l’accertamento sarà annullabile . Ad esempio, il mero scostamento da studi di settore o medie di settore non basta da solo a giustificare un induttivo puro se mancano altre anomalie sostanziali – lo ha chiarito la Cassazione escludendo che l’Ufficio possa fare accertamenti extrapolando solo dai parametri medi in assenza di ulteriori riscontri .
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (il “redditometro”)
Accanto alle forme di accertamento induttivo sopra descritte (che riguardano principalmente redditi d’impresa e di lavoro autonomo, basandosi su contabilità), esiste uno strumento presuntivo rivolto alle persone fisiche in quanto tali: l’accertamento sintetico del reddito complessivo, meglio noto come redditometro. Disciplinato dall’art. 38 del DPR 600/1973 (commi 4-7), consente al Fisco di determinare il reddito del contribuente “da fuori”, ossia basandosi sulle spese sostenute e sul tenore di vita, anziché sui dati dichiarati ufficialmente . In altre parole, se un individuo spende molto più di quanto dichiara di guadagnare, l’Agenzia delle Entrate può presumere che disponga di redditi non dichiarati sufficienti a finanziare quelle spese.
L’accertamento sintetico si sviluppa tradizionalmente secondo due modalità:
– Metodo sintetico “puro” (spese effettive): somma tutte le spese certe sostenute dal contribuente in un dato anno (acquisti di beni, case, auto, spese per viaggi, rette scolastiche, mutui pagati, investimenti, ecc.) e presume che il reddito dichiarato debba essere almeno pari a tale ammontare di uscite. Se il reddito ufficiale è troppo basso per coprire quelle spese, la differenza viene considerata reddito non dichiarato .
– Metodo redditometrico classico (indicatori di spesa): basato su indicatori e coefficienti di spesa predisposti per legge. In passato (redditometro varato nel 2010) esistevano tabelle ministeriali che associavano al possesso di determinati beni o al sostenimento di determinate spese un reddito presunto. Ad esempio, il possesso di un’auto di lusso di cilindrata X “indicava” un certo reddito minimo presunto, il possesso di uno yacht indicava Y, e così via . Questi coefficienti standard venivano utilizzati per calcolare un reddito sintetico familiare.
Evoluzione recente: Il redditometro “vecchia maniera”, basato su parametri predefiniti per tipologia di famiglia e area geografica, è stato molto criticato e sostanzialmente sospeso negli ultimi anni (dal 2015 in poi) . Una riforma del 2017/2018 aveva previsto un nuovo DM con il “redditometro 2.0”, mai entrato effettivamente in vigore per problemi di privacy e ricorsi giudiziari. Nel 2023-2024 il legislatore ha rivisto la normativa dell’art. 38 DPR 600/73 per rendere più mirato e garantito l’accertamento sintetico. In particolare, con il D.Lgs. 29 dicembre 2023 n. 219 (attuativo della delega fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2024) sono stati introdotti due importanti filtri: uno percentuale e uno assoluto, che devono essere superati contemporaneamente perché scatti l’accertamento redditometrico :
- Scostamento percentuale minimo: il reddito complessivo accertato deve eccedere di almeno il 20% quello dichiarato. Questa soglia (1/5 in più) esisteva già in passato.
- Scostamento assoluto minimo: il reddito sinteticamente determinato deve superare di almeno 10 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Dato che l’assegno sociale è circa €6.400 annui, questa soglia equivale a circa €64.000 – €70.000 (10×) di reddito .
Significa che d’ora in poi il Fisco non potrà emettere accertamenti sintetici se la differenza tra il reddito “sintetico” (basato sulle spese) e quello dichiarato è inferiore al 20% o comunque inferiore a circa 70 mila euro in valore assoluto. Devono essere superati entrambi i requisiti. Questo per evitare accertamenti redditometrici per scostamenti minimi o dovuti magari solo a piccole spese . Ad esempio, un contribuente che dichiara €10.000 e ne spende €12.500 ha uno scostamento del +25%, ma in valore assoluto parliamo di €2.500, sotto la soglia assoluta: quindi oggi un accertamento sintetico non partirebbe per una differenza così bassa.
Inoltre, la nuova normativa ha rafforzato le garanzie procedurali a favore del contribuente: è stato ribadito l’obbligo di contraddittorio preventivo (l’Ufficio deve sempre invitare il contribuente a fornire spiegazioni prima di emettere l’accertamento sintetico) e sono state codificate le tipologie di prova contraria che il contribuente può addurre . In particolare, la legge ora prevede espressamente che il contribuente può giustificare lo scostamento tra spese e redditi dichiarati dimostrando, ad esempio:
- che le spese sono state finanziate con redditi di anni precedenti (risparmi accumulati) o con redditi esenti/non imponibili, o con somme ricevute da terzi (donazioni, vincite) ;
- che l’ammontare delle spese attribuitegli dall’ufficio è in realtà sovrastimato (contestando i calcoli dell’ufficio) ;
- che ha utilizzato patrimonio pre-esistente (vendita di beni, disinvestimenti) per coprire le spese.
Queste difese, già ammesse dalla giurisprudenza in passato, ora sono scritte nero su bianco nella legge e vincolano l’ufficio: significa che se il contribuente, chiamato al contraddittorio, fornisce tali spiegazioni con documenti, l’ufficio dovrà tenerne conto e non potrà ignorarle . Prima di emettere l’avviso, inoltre, deve obbligatoriamente attivare la procedura di invito all’adesione (accertamento con adesione): questo meccanismo consente di discutere con il contribuente e trovare un eventuale accordo, ma serve anche a garantire formalmente il contraddittorio endoprocedimentale .
Facciamo un esempio per capire come funziona il redditometro: il sig. Rossi dichiara €30.000 di reddito annuo, ma nel 2025 acquista una barca da €200.000 e una nuova auto da €50.000. Queste spese sono eclatanti rispetto al suo reddito dichiarato; l’Agenzia, se ne viene a conoscenza (es. tramite registri nautici e PRA), può attivare l’accertamento sintetico presupponendo che Rossi abbia avuto un reddito reale molto superiore a €30.000, quantomeno sufficiente a giustificare quei €250.000 di uscite. Rossi verrà invitato a spiegare come ha finanziato tali acquisti: se non fornisce spiegazioni convincenti, l’ufficio emetterà avviso di accertamento presumendo (per differenza) un reddito non dichiarato magari di €200.000 aggiuntivi nell’anno. Tuttavia, Rossi potrà difendersi provando per esempio che la barca è stata pagata attingendo a risparmi accumulati negli anni precedenti (non tassabili nell’anno corrente) o con denaro ricevuto in donazione dal padre, e che l’auto è aziendale o pagata da un familiare. Se tali prove sono documentate, il giudice potrà annullare l’accertamento sintetico, poiché la legge gli impone di considerare queste giustificazioni come idonee a superare la presunzione .
Stato attuale (2025): il redditometro classico è stato “umanizzato”. Dopo anni di stasi, il legislatore ha voluto limitarlo ai casi davvero eclatanti di evasione (differenze oltre €70k e 20%) ed evitare automatismi basati su tabelle rigide . Di fatto, il vecchio redditometro parametrico per ora è accantonato: il DM attuativo del 2018 non è mai entrato in vigore, e si attende un eventuale nuovo redditometro 2.0 coerente con i criteri fissati nel 2023. Ciò non significa che il Fisco ignori chi ostenta ricchezza e dichiara poco; significa però che l’accertamento sintetico sarà usato col contagocce, solo quando le anomalie sono macroscopiche e dopo aver dato piena possibilità al contribuente di spiegare la provenienza dei fondi . In pratica oggi un contribuente con spese elevate ma che può giustificarle con risparmi o aiuti familiari probabilmente non vedrà neppure emesso l’accertamento (l’istruttoria si fermerà al contraddittorio). Se invece qualcuno spende decisamente oltre i propri redditi senza giustificazioni credibili, potrà diventare un target del redditometro, ma con le cautele procedurali dette.
Procedura di accertamento e garanzie del contribuente
Dopo aver delineato i vari tipi di accertamento presuntivo, è fondamentale capire come si svolge il procedimento di accertamento fiscale e quali garanzie sono riconosciute al contribuente lungo questo percorso. Conoscere la procedura è importante anche perché eventuali vizi procedurali (come la mancata attivazione del contraddittorio, un difetto di motivazione dell’atto, ecc.) possono costituire motivi di ricorso validi per far annullare l’accertamento. Vediamo dunque sinteticamente le fasi principali:
- Controllo e verifica fiscale: l’accertamento nasce da un controllo fiscale, che può avvenire “a tavolino” negli uffici (esame incrociato delle dichiarazioni, dei dati disponibili, invio di questionari al contribuente) oppure tramite accesso, ispezione o verifica presso la sede del contribuente (spesso svolta dalla Guardia di Finanza) . Nel caso di controlli in loco, gli organi verificatori redigono al termine un Processo Verbale di Constatazione (PVC) dove elencano tutte le violazioni riscontrate e le ipotesi di evasione. Il PVC viene consegnato al contribuente, il quale da quel momento ha la possibilità di reagire e fornire chiarimenti.
- Contraddittorio endoprocedimentale (preventivo): è il dialogo tra contribuente e Amministrazione prima dell’emissione dell’atto finale (avviso di accertamento). Rappresenta una garanzia fondamentale per il contribuente. In generale, dopo la chiusura di una verifica sul campo, lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000, art. 12, c.7) prevedeva che il contribuente avesse 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e richieste prima che l’ufficio potesse emettere l’avviso . Durante questo periodo il contribuente può inviare una memoria difensiva dettagliata in cui confuta le risultanze del PVC e fornisce prove a suo discarico: è molto importante sfruttare questa finestra per far valere le proprie ragioni, perché l’ufficio è tenuto a valutare le memorie presentate . Inoltre, per specifiche tipologie di accertamento (ad es. studi di settore, nuovo redditometro, ecc.) la legge imponeva un invito obbligatorio al contribuente prima di emettere l’atto, per discutere le posizioni (un “invito a comparire”) .
- Evoluzione recente: Tradizionalmente in Italia non esisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio per tutti gli accertamenti, salvo alcune ipotesi. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2015 avevano stabilito che per i tributi “non armonizzati” (IRPEF, IRES, ecc.) il contraddittorio non era obbligatorio a pena di nullità, mentre per i tributi armonizzati (IVA) bisognava valutare caso per caso l’eventuale lesione del diritto di difesa (c.d. prova di resistenza richiesta dalla Corte di Giustizia UE) . Fino al 2023 la giurisprudenza oscillava, ma un recente orientamento (Cass. n. 16574/2023) ha iniziato a sostenere che l’Amministrazione dovrebbe sempre attivare il contraddittorio prima di emettere un accertamento fondato su elementi rispetto ai quali il contribuente non si sia potuto esprimere, anche per tributi non armonizzati .
- Nel frattempo, il legislatore ha preso posizione: con la riforma del 2023 (D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219) è stato introdotto nello Statuto un nuovo art. 6-bis che estende in maniera generalizzata l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima di ogni avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza o irreperibilità del contribuente . Contestualmente è stato abrogato il vecchio art. 12 c.7 Statuto, unificando la disciplina . Dunque oggi (2024) l’ufficio è tenuto in via generale a comunicare al contribuente le risultanze del controllo e ad invitarlo a fornire chiarimenti entro un certo termine (tipicamente 60 giorni), prima di emettere l’atto impositivo, a pena di nullità dell’atto stesso se l’omissione del contraddittorio lede il diritto di difesa . Questa novità è di enorme rilievo per le presunzioni: ad esempio, se l’ufficio intende presumere maggiori ricavi in base ai conti correnti, dovrà avvisare il contribuente e dargli modo di giustificare quei movimenti prima di notificare l’accertamento; se non lo fa, il contribuente potrà eccepire la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio preventivo (in particolare per l’IVA, dove è diritto UE, la nullità è quasi certa, per gli altri tributi bisognerà valutare caso per caso la “prova di resistenza” ossia se il contraddittorio avrebbe potuto portare a un esito diverso) .
- Emissione dell’Avviso di accertamento: dopo la fase istruttoria e di contraddittorio, l’Ufficio forma l’atto finale, l’avviso di accertamento, che contiene l’indicazione dei maggiori imponibili accertati, delle imposte e sanzioni dovute, e la motivazione ossia la descrizione dei fatti, degli elementi raccolti e delle norme applicate. La motivazione è un requisito essenziale: deve spiegare in modo chiaro l’iter logico e le prove (o presunzioni) su cui si fonda la pretesa . Negli accertamenti presuntivi, l’avviso dovrà specificare quali indizi o calcoli presuntivi sono stati utilizzati (es: “applicazione di ricarico medio del settore X sui costi contabilizzati”; “presunzione ex art.32 DPR 600 su versamenti bancari non giustificati”; “spesa per acquisto immobile finanziata con redditi non dichiarati”, ecc.). Una motivazione inadeguata (ad es. generica o apodittica) costituisce vizio dell’atto. Se l’Ufficio ha ignorato le difese presentate nel contraddittorio senza confutarle puntualmente, ciò può configurare un difetto di motivazione e rendere annullabile l’accertamento .
- L’avviso di accertamento viene notificato al contribuente (di solito a mezzo PEC o tramite raccomandata/ufficiale giudiziario). Da quel momento decorrono i termini per eventuali rimedi: adesione, acquiescenza o ricorso (come vedremo infra). Va sottolineato che l’avviso indica anche il termine per il pagamento (di norma 60 giorni) e che, se non viene impugnato, diventa definitivo e le somme vengono iscritte a ruolo per la riscossione coattiva. Tuttavia, la presentazione di un ricorso sospende automaticamente la riscossione per 1/3 delle imposte accertate fino alla sentenza di primo grado, mentre per i 2/3 residui l’iscrizione a ruolo è sospesa fino alla sentenza di secondo grado (meccanismo di “sospensione frazionata” ex art. 15 del DPR 602/73). Il contribuente può comunque chiedere una sospensione giudiziale totale se l’esecuzione immediata dell’atto gli causerebbe danno grave.
In sintesi, le garanzie procedurali principali a favore del contribuente nel percorso accertativo sono: il contraddittorio (divenuto regola generale dal 2024), il diritto di accesso agli atti (si può chiedere copia dei documenti raccolti dal Fisco per verificare che siano stati ottenuti legittimamente), il diritto alla motivazione dell’atto, e i tempi “di riflessione” come i 60 giorni post-verifica prima dell’emissione dell’avviso. Ogni violazione di questi aspetti può e deve essere valutata in ottica difensiva.
Nel prossimo capitolo, esamineremo proprio le strategie difensive e gli strumenti di tutela che il contribuente può adottare per difendersi da un accertamento presuntivo, sia prima (fase amministrativa) sia dopo la notifica dell’atto (fase giudiziale).
Come difendersi: strategie e strumenti di tutela del contribuente
Affrontare efficacemente un accertamento fondato su presunzioni richiede sia conoscenza tecnica (norme e sentenze di riferimento) sia capacità strategica nel far valere i propri diritti. Di seguito analizziamo le principali leve difensive a disposizione del contribuente, in ordine cronologico dal momento in cui riceve (o sta per ricevere) l’avviso di accertamento fino all’eventuale contenzioso tributario.
Fase pre-contenziosa: difesa durante la verifica e l’accertamento
La difesa inizia già prima che l’accertamento diventi definitivo. Molto si gioca nella fase di verifica e di interlocuzione con l’ufficio, quando è ancora possibile orientare o ridimensionare la pretesa fiscale.
- Collaborare durante la verifica: se è in corso un’ispezione della Guardia di Finanza o un controllo dell’Agenzia, il contribuente dovrebbe mantenere un atteggiamento collaborativo, fornendo al più presto spiegazioni e documenti giustificativi agli accertatori. Ad esempio, se durante un controllo emergono movimenti bancari anomali, è saggio spiegare subito la loro natura (bonus, prestiti, trasferimenti interni…) e possibilmente far inserire tali spiegazioni a verbale nel PVC . Ciò perché le osservazioni a verbale restano agli atti e potranno indurre l’ufficio a rivedere le proprie conclusioni (o almeno testimoniare la buona fede del contribuente). Dopo il rilascio del PVC, come detto, c’è un termine (60 giorni) per presentare una memoria: è cruciale sfruttarlo preparando una memoria difensiva dettagliata con tutte le prove e argomentazioni a proprio favore . L’ufficio ha l’obbligo di valutarla prima di emettere l’accertamento, e spesso la presentazione di prove convincenti in questa fase può evitare del tutto l’emissione dell’avviso o portare a una sua notevole riduzione.
- Esercitare il diritto al contraddittorio: come visto, in alcuni accertamenti il contraddittorio preventivo è (ora era, prima della generalizzazione) obbligatorio per legge – ad esempio per gli studi di settore e per il redditometro l’ufficio doveva convocare il contribuente a un incontro . Se arriva una convocazione, è essenziale presentarsi (magari assistiti dal proprio commercialista o avvocato), portando con sé tutti i documenti utili a giustificare le anomalie riscontrate. Durante il colloquio, è bene consegnare una memoria scritta che riassuma le proprie difese : ciò crea un riscontro formale di quanto spiegato. Se poi l’ufficio ignora completamente queste spiegazioni nell’avviso, ciò potrà essere eccepito in ricorso come carenza di motivazione dell’atto. Viceversa, se in un caso dove il contraddittorio è obbligatorio l’ufficio non lo attiva affatto, l’atto è viziato ab origine e il ricorso potrà chiederne l’annullamento immediato per violazione di legge.
- Rispondere ai questionari e inviti dell’Agenzia: spesso, prima di un accertamento, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente questionari informativi (ex art. 32 DPR 600) per chiedere chiarimenti su determinate operazioni o di esibire specifici documenti. Non ignorare mai questi inviti! La mancata risposta non solo comporta una sanzione, ma soprattutto fa scattare una previsione di legge per cui i documenti non esibiti al Fisco non potranno poi essere prodotti in giudizio dal contribuente . È un aspetto molto importante: ad esempio, se l’ufficio chiede di vedere i contratti relativi a certi versamenti sul conto corrente e il contribuente non li fornisce, poi non potrà esibirli in Commissione Tributaria a propria difesa (art. 32, co.4, DPR 600/73). Dunque va sempre data risposta, entro 60 giorni, fornendo tutto il materiale richiesto o spiegazioni dettagliate. Inoltre, una risposta puntuale e convincente può persuadere l’ufficio a non procedere con l’accertamento. In caso di impossibilità a rispondere entro il termine, è preferibile chiedere una proroga motivata, piuttosto che non rispondere affatto.
- Istanza di autotutela: prima che scadano i termini per ricorrere (60 giorni dalla notifica dell’avviso), il contribuente può presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’ufficio, evidenziando eventuali errori palesi o elementi nuovi e chiedendo l’annullamento (totale o parziale) dell’atto. L’autotutela è una procedura amministrativa interna, discrezionale per l’Amministrazione (non c’è obbligo di accoglimento), ma tentarla può essere utile soprattutto se ci sono errori di fatto evidenti nell’accertamento. Ad esempio, se il Fisco ha conteggiato due volte lo stesso reddito, oppure ha applicato una presunzione fuori dai casi consentiti dalla legge, segnalarlo in autotutela potrebbe portare l’ufficio a riconoscere l’errore e annullare o correggere l’atto. Attenzione però: l’istanza di autotutela non sospende i termini per fare ricorso . Quindi va fatta tempestivamente e parallelamente ci si deve preparare a presentare comunque il ricorso entro 60 giorni, per sicurezza, qualora l’ufficio non risponda in tempo o rigetti l’istanza.
In generale, in questa fase pre-contenziosa il contribuente dovrebbe costruire un fascicolo difensivo il più completo possibile . Ciò significa raccogliere: documenti contabili, contratti, estratti conto, perizie tecniche, eventualmente dichiarazioni di terzi (anche sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio) che possano confermare la sua versione, e naturalmente riferimenti normativi e di prassi a favore. Tutto questo materiale servirà sia per convincere l’ufficio in sede di contraddittorio o adesione, sia – se necessario – in giudizio. Ad esempio, se l’accertamento riguarda versamenti bancari su cui il Fisco presume ricavi in nero, il contribuente dovrà cercare per ciascun versamento contestato di raccogliere la prova della sua natura non imponibile (es. bonifico “giroconto” da un proprio conto, documenti che attestano trattarsi di prestito ricevuto, vendita di un bene personale esente, ecc.) e presentare il tutto ordinatamente già in fase di adesione.
Un cenno sulla discussa questione del contraddittorio generalizzato: prima della riforma 2023, se l’ufficio non attivava il contraddittorio e non era obbligato a farlo per legge, al contribuente restava comunque la possibilità di chiedere spontaneamente un incontro o di inviare una richiesta di chiarimenti. Era (ed è) buona pratica chiedere sempre un confronto all’ufficio se si ritiene di avere spiegazioni risolutive, anche quando la legge non lo prevede espressamente . Lo si può fare ad es. inviando un’istanza di audizione ex art. 5 L.212/2000, invocando i principi di collaborazione e buona fede. Se l’ufficio rifiuta il confronto e poi emette un atto magari infondato, si potrà sottolineare nel ricorso che negare il contraddittorio ha violato tali principi dello Statuto del Contribuente (artt. 5 e 10 L.212/2000). Non è una nullità automatica (salvo i nuovi sviluppi normativi), ma può influire sull’esito. In ogni caso, dal 2024 con l’obbligo generalizzato, questa iniziativa del contribuente sarà formalmente superflua perché dovrebbe essere l’ufficio a farsi avanti; se non lo fa dove avrebbe dovuto, sarà un vizio dell’atto stesso.
Accertamento con adesione e altri istituti deflativi
Quando l’avviso di accertamento viene notificato, il contribuente deve rapidamente valutare se imboccare la strada del ricorso oppure tentare prima qualche soluzione deflativa (cioè che evita la lite giudiziaria). Esistono infatti strumenti che consentono di chiudere la partita senza processo, spesso con un compromesso col Fisco o con benefici sulle sanzioni. I principali istituti deflativi sono:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): è probabilmente lo strumento più utile. Consente al contribuente, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso (termine prorogabile di altri 60 giorni su richiesta), di presentare un’istanza di adesione e avviare un confronto negoziale con l’ufficio . Si terrà uno (o più) incontri in cui il contribuente, eventualmente coadiuvato dal proprio professionista, esporrà le proprie ragioni e l’ufficio rivedrà le pretese alla luce di quanto emerso. Se si trova un accordo, viene redatto un atto di adesione con il nuovo importo di imposta concordato e sanzioni ridotte a 1/3 (un terzo) del minimo . I vantaggi: l’adesione evita l’incertezza e i costi del giudizio e sospende i termini per il ricorso (90 giorni di sospensione, utili per trattare con calma) . Nel contesto presuntivo, l’adesione è spesso l’occasione per convincere il Fisco a riconoscere alcune prove contrarie e ad abbassare le pretese. Ad esempio, in un accertamento basato su presunzioni di ricavi occulti, il contribuente in adesione può documentare che una parte di quei ricavi in realtà ha già giustificazione: l’ufficio potrebbe allora accettare di ridurre l’imponibile presunto (es. togliere quei versamenti che risultano essere prestiti, o riconoscere una percentuale di costi) . Si giunge così a un importo condiviso, con notevole risparmio sulle sanzioni (1/3 del minimo, contro il 100% o 200% in caso di giudizio perso) e pagamento rateizzabile. L’adesione è quindi fortemente consigliata quando l’accertamento è ragionevolmente fondato ma eccessivo, o quando ci sono incertezze interpretative: in questi casi cercare un compromesso può portare a soluzioni eque (spesso, l’ufficio preferisce “portare a casa” subito qualcosa con sanzioni ridotte, piuttosto che rischiare l’esito del processo).
- Acquiescenza agevolata: qualora il contribuente ritenga di non avere possibilità di difesa – magari perché la presunzione è difficilmente contestabile o perché effettivamente ha omesso redditi e non ha prove contrarie – può valutare di prestare acquiescenza all’accertamento entro 60 giorni. L’acquiescenza consiste nel pagare quanto richiesto, beneficiando però in cambio della riduzione delle sanzioni a 1/3 (un terzo) del minimo , analoga all’adesione. Di fatto è una “resa” incentivata: paga e chiudi la questione con sanzioni ridotte. Tuttavia, se c’è qualche margine di contestazione, è quasi sempre preferibile tentare l’adesione piuttosto che fare subito acquiescenza. Infatti, con l’adesione c’è la possibilità di ridurre anche la base imponibile, mentre l’acquiescenza comporta il pagamento integrale di quanto accertato (con lo sconto solo sulle sanzioni) . L’acquiescenza conviene quindi solo se si è certi che un ricorso sarebbe perdente e se l’ufficio in adesione non concederebbe nulla di più. Va formalizzata entro 60 giorni dalla notifica, versando (o rateizzando) le somme dovute con sanzioni ridotte.
- Reclamo-mediazione tributaria: fino al 2023, per le controversie di valore fino a €50.000 era obbligatorio, prima di poter fare ricorso, presentare un reclamo all’ufficio, che valeva anche come proposta di mediazione . L’idea era tentare un accordo direttamente con l’Ente impositore, eventualmente con l’intervento di un mediatore interno all’Agenzia. Dal 2023 questa procedura è stata abolita per i nuovi atti: la riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha eliminato l’obbligatorietà del reclamo per snellire i tempi . Oggi dunque, ricevuto un accertamento, si può depositare direttamente il ricorso in Commissione senza passare dalla mediazione (per atti notificati dal 2023 in poi). Rimane però la possibilità di una conciliazione in corso di causa (vedi più avanti), che è simile a una mediazione ma avviene davanti al giudice.
- Ravvedimento operoso: va menzionato per completezza che, se durante il contraddittorio il contribuente di fatto ammette alcune violazioni (magari riconosce di avere incassato di più), prima che l’atto venga emesso potrebbe tentare di fare un ravvedimento operoso su quei maggiori imponibili, per usufruire di sanzioni ultra-ridotte. Tuttavia, in materia di accertamenti presuntivi questo scenario è raro: difficilmente un contribuente confessa in anticipo. Nella pratica, il ravvedimento operoso (pagare spontaneamente prima dell’accertamento) è utile in contesti diversi, mentre qui di solito si nega di aver evaso e si cerca di difendersi.
In conclusione, l’accertamento con adesione è la principale opzione da considerare quando ci si trova di fronte a un accertamento presuntivo. Spesso consente di raggiungere un compromesso ragionevole: ad esempio, in un accertamento bancario basato su 10 versamenti sospetti per €100.000 totali, il contribuente in adesione può documentare che 5 di essi avevano causa non imponibile; l’ufficio, senza ammettere ufficialmente l’errore, potrebbe accogliere bonariamente queste spiegazioni e ridurre l’imponibile accertato magari a €50.000, con sanzioni ridotte al 1/3 . In giudizio, invece, il contribuente sarebbe esposto al “tutto o niente” (o riesce a far annullare tutti i €100.000, o se perde anche solo in parte paga sanzioni piene). In adesione c’è flessibilità: l’ufficio può fare sconti anche dove il giudice non potrebbe (il giudice deve applicare la legge, mentre l’ufficio può transigere). Quindi, un buon consulente di solito tenta l’adesione, cercando di strappare il miglior accordo, e tiene pronto il ricorso solo se la trattativa fallisce.
Il ricorso in Commissione Tributaria (ora Corte di Giustizia Tributaria)
Se non si arriva a un accordo o se lo si ritiene insoddisfacente, non rimane che la strada del contenzioso tributario. Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado) a seguito della riforma della giustizia tributaria, ma la sostanza del processo non è cambiata molto. Ecco i punti chiave pratici per il ricorso:
- Termine per impugnare: 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (al netto di sospensioni per adesione, vedi oltre) . Se è stata presentata un’istanza di adesione, il termine di 60 giorni resta sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; qualora l’ufficio comunichi prima un esito negativo, i 60 giorni riprendono da quel momento . Bisogna fare attenzione a rispettare queste scadenze, altrimenti l’atto diventa definitivo.
- Forma e contenuto del ricorso: il ricorso è un atto scritto (telematico) da notificare all’ente impositore. Deve contenere i motivi per cui si chiede l’annullamento o la riforma dell’atto. Nel caso di accertamenti presuntivi, i motivi di ricorso tipici saranno: violazione di legge (ad esempio, se l’ufficio ha applicato una presunzione al di fuori dei casi consentiti o senza contraddittorio obbligatorio), eccesso di potere / difetto di motivazione (se l’avviso è motivato in modo inadeguato o non considera affatto le controdeduzioni presentate), e ovviamente infondatezza nel merito (contestazione puntuale delle ricostruzioni presuntive con produzione di controprove) . È molto importante che il ricorso citi con precisione le norme rilevanti (es: art. 39 DPR 600/73, art. 2729 c.c., art. 53 Cost., Statuto del contribuente) e se possibile anche precedenti giurisprudenziali favorevoli (sentenze di Cassazione, Commissioni superiori) . Questo dà forza alle argomentazioni: es. si può scrivere “Violazione dell’art. 39, co.1, lett.d) DPR 600/73 – Mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti – Inattendibilità parziale della contabilità non dimostrata dall’Ufficio”, e poi argomentare citando sentenze che hanno annullato accertamenti in casi simili.
- Notifica e deposito del ricorso: oggi il processo tributario è interamente telematico. Il ricorso va notificato a mezzo PEC all’ufficio che ha emanato l’atto (ad es. Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate) entro i 60 giorni . Poi, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso (con la prova di avvenuta notifica) va depositato telematicamente presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (tramite apposito portale SIGIT o analoghi). Nel ricorso si può già chiedere un’eventuale sospensione dell’atto impugnato.
- Sospensione dell’atto impugnato: come accennato, la notifica del ricorso blocca automaticamente la riscossione oltre 1/3 delle imposte, ma per evitare anche quell’1/3 (o se l’ufficio stesse procedendo comunque a iscrivere a ruolo) si può presentare un’istanza di sospensione cautelare al giudice . Bisogna motivare l’istanza dimostrando che l’esecuzione dell’atto causerebbe un danno grave e irreparabile (esempio tipico: l’importo elevato da pagare metterebbe a rischio la continuità aziendale o il patrimonio familiare). Il giudice fissa in tempi brevi (qualche settimana) la camera di consiglio per decidere sulla sospensione. Nel contesto di accertamenti presuntivi, se il ricorso appare sorretto da buone ragioni (ad es. c’è un errore evidente nell’atto, oppure il contribuente ha già prodotto forti prove contrarie), il giudice tende a concedere la sospensione . Se invece il caso è dubbio, talvolta i giudici concedono sospensioni parziali (ad es. sospendono per il 50% dell’importo). In ogni caso, ottenere la sospensiva è importante per guadagnare tranquillità durante il processo.
- Valore della controversia e spese di giudizio: il valore della causa è dato dall’importo dell’imposta (esclusi sanzioni e interessi). Se è sotto €3.000, oggi la causa è decisa da giudice monocratico e con rito semplificato; sopra, da un collegio . In caso di vittoria, in genere le spese legali vengono poste a carico della parte soccombente (il Fisco), ma capita spesso che i giudici compensino le spese se entrambi hanno avuto parzialmente torto/ragione. Le spese legali di primo grado variano con il valore della lite, ma per cause piccole sono contenute.
Va evidenziato che, con la riforma 2022/2023, il processo tributario è divenuto in parte più simile al processo civile: i giudici tributari ora sono a tempo pieno (non più professionisti part-time) e sono stati introdotti mezzi di prova aggiuntivi (come le testimonianze scritte di cui diremo sotto). Inoltre, l’appello è ora un “novum iudicium” più ampio rispetto al passato (il giudice d’appello può riesaminare anche i fatti, non solo gli errori di diritto). Questo significa che anche in secondo grado si può sperare di ribaltare l’esito, ma al contempo se il contribuente vince in primo grado l’Agenzia potrebbe essere più incentivata di prima ad appellare, sapendo che in appello i giudici rivedono tutto. In pratica, oggi il primo grado resta fondamentale (è il momento in cui si formano le prove), ma il secondo grado non è più limitato alle questioni strette impugnate: c’è una nuova valutazione complessiva.
La difesa nel processo tributario: prove, testimonianze e tecniche difensive
Nella fase processuale vera e propria, il contribuente deve mettere in campo una difesa organizzata e completa. Vediamo alcuni aspetti e strumenti chiave:
- Produzione documentale: è la base della difesa. Bisogna depositare tutti i documenti utili a supportare i motivi di ricorso. Nel caso di accertamenti presuntivi, ciò include: estratti conto bancari completi (per dimostrare ad esempio che a certi versamenti corrispondono prelievi equivalenti o trasferimenti intra-soggettivi), contratti e scritture private (prestiti, finanziamenti ricevuti, donazioni), fatture e ricevute (per provare costi e spese reali, utili magari a spiegare margini ridotti), perizie di parte (se necessarie per questioni tecniche, ad es. un perito contabile che attesti che i calcoli del Fisco sono errati), normativa e prassi (circolari dell’Agenzia, se favorevoli, e ovviamente le leggi di riferimento). Inoltre, è buona prassi allegare copia delle principali sentenze di Cassazione rilevanti che si intendono citare, per facilitarne la conoscenza al giudice . Attenzione: tutti questi documenti devono essere prodotti subito nel ricorso o entro la prima udienza di trattazione. In appello, la produzione di nuovi documenti è fortemente limitata (ammessa solo se si prova che non erano acquisibili prima). Quindi, è fondamentale giocare tutte le carte sin dal primo grado e non tenerne in serbo.
- Testimonianza scritta: tradizionalmente, nel processo tributario non era ammessa la testimonianza. La riforma (L. 130/2022) ha introdotto la possibilità, in casi eccezionali, di una testimonianza per iscritto (art. 7, co.4-bis, D.Lgs. 546/92) . Non è una testimonianza libera come nel civile: serve che entrambe le parti consentano, oppure che il giudice la ritenga assolutamente indispensabile. Se ammessa, il giudice formula per iscritto dei quesiti e il testimone (persona terza a conoscenza dei fatti) risponde per iscritto, con dichiarazione autenticata da notaio . È uno strumento nuovo e per ora poco usato, ma potenzialmente molto utile negli accertamenti presuntivi: ad esempio, un contribuente può voler far testimoniare un terzo (non parente stretto) che confermi la provenienza di certe somme – il classico caso, un amico che dichiara “sì, gli ho prestato io quei 20.000 euro poi versati sul suo conto” oppure un cliente che confermi di aver pagato esattamente l’importo fatturato e non di più (smontando la tesi di ricavi in nero) . Oppure, come visto nell’esempio del redditometro, un fratello può testimoniare di aver pagato lui le vacanze del contribuente. Per ottenere ciò, occorre chiedere l’ammissione della testimonianza già nel ricorso introduttivo o al più tardi nella prima memoria. Se la controparte (Agenzia) non acconsente, sarà difficile che il giudice la autorizzi, a meno che davvero la ritenga decisiva. Ma vale la pena provarci quando si ha un testimone credibile. Intanto, nulla vieta di allegare già al ricorso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal terzo (magari autenticata), che pur non avendo valore di prova piena, può orientare il giudice a ritenere opportuno formalizzare la testimonianza . Ricordiamo che testimoniare il falso in sede di risposta scritta costituirebbe reato di falso, come avvertirà il giudice, quindi se qualcuno si presta a testimoniare a nostro favore assume anche una responsabilità.
- Consulenza tecnica di parte (CTP): nel processo tributario non è prevista la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) di routine, anche se con la riforma ora potrebbe essere ammessa in appello in casi particolari. In generale, però, le parti possono depositare perizie di parte su questioni complesse . Ciò può essere utile in casi come: contestazione di studi di settore/ISA – si può far redigere a un esperto economico un’analisi che dimostri le peculiarità dell’azienda tali da renderla non allineata agli standard; contestazione di ricavi presunti su base tecnica (consumi, produzioni) – ad esempio un perito ingegnere può attestare che, date le macchine possedute, l’azienda non poteva fisicamente produrre più di X pezzi, quindi i ricavi in nero ipotizzati dal Fisco sono irrealistici. O ancora, in un redditometro, un perito finanziario può calcolare con esattezza che – dati i risparmi iniziali del contribuente – le spese contestate rientravano in ciò che poteva essere finanziato senza nuovi redditi. Queste perizie non sono vincolanti per il giudice, ma possono essere molto persuasive se fatte da esperti qualificati e non facilmente smontabili dall’ufficio .
- Discussione in udienza: se la controversia non viene decisa solo sui documenti (spesso i giudici tributari decidono “in camera di consiglio” senza discussione orale, ma su richiesta di parte può esserci pubblica udienza), la discussione orale è un momento importante per sintetizzare e dare risalto agli aspetti più favorevoli. Nel caso di accertamenti presuntivi complessi, è utile preparare magari uno schema riassuntivo o una breve presentazione grafica dei punti chiave . Ad esempio, in un caso di accertamento bancario con decine di operazioni contestate, l’avvocato potrà esibire una tabella che elenca tutti i versamenti contestati e, a fianco, la giustificazione provata per ciascuno (prestito X, rimborso Y, fattura n.Z, ecc.), mostrando magari che 90% dei movimenti hanno spiegazione e solo uno rimane dubbio . Una visualizzazione chiara di questo tipo può essere estremamente efficace per convincere il collegio che l’accertamento è largamente infondato. Idem per altri casi: grafici e tabelle aiutano a far capire subito eventuali errori del Fisco.
- Vizi formali e di notifica: è sempre importante verificare se l’atto ha vizi formali (ad es. è stato notificato oltre i termini decadenziali, o notificato in modo nullo, o la delega di firma del funzionario non era regolare, ecc.). Questi sono motivi di ricorso validi, ma in generale i giudici tributari odierni tendono, se possibile, a decidere nel merito piuttosto che annullare per formalità . Ciò anche perché la riforma mira a ridurre l’eccesso di formalismo. Dunque conviene sempre sì segnalare i vizi formali, ma non puntare tutto solo su quelli: è prudente sviluppare anche le difese di merito, nel caso in cui il giudice decida di superare l’eccezione formale per esaminare la sostanza (cosa che capita, talvolta con forzature, ma capita).
- Uso della giurisprudenza: come già accennato, citare sentenze di Cassazione pertinenti è molto utile . Ad esempio, se abbiamo un accertamento basato su un unico elemento indiziario di dubbia solidità, citeremo Cass. n. 11162/2021 o Cass. n. 656/2014 che ribadiscono che un solo elemento può bastare solo se di “valore concludente” (unico grave e preciso). Se l’ufficio non ha attivato il contraddittorio in una situazione dovuta, potremmo citare Cass. n. 701/2020 o Cass. SS.UU. 24823/2015 (a seconda dei tributi) per sostenere la nullità. Se siamo in presenza di soci di società a ristretta base che vengono tassati per utili extra-contabili, citeremo magari Cass. n. 21953/2007 e segg. ma anche la recentissima Cass. n. 5529/2025 che ha chiarito che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci è solo semplice e può essere vinta da prove contrarie . Insomma, far vedere al giudice che la nostra tesi è supportata da precedenti autorevoli aumenta notevolmente la credibilità della difesa . D’altra parte, è prevedibile che anche l’Agenzia nelle controdeduzioni citerà le sentenze a sé favorevoli (e ce ne sono per ogni questione): ad esempio, se noi difendiamo un socio minoritario, loro citeranno Cass. n. 26473/2024 dove un socio ha perso ; sta a noi distinguere il caso e convincere che nel nostro la situazione è diversa. La conoscenza della giurisprudenza “di settore” è dunque indispensabile per una difesa avanzata.
- Chiamata in causa di terzi: nel processo tributario non c’è un vero meccanismo di chiamata in causa di terzi come nel civile. Tuttavia, a volte può esserci interesse ad avere più soggetti nel giudizio. Ad esempio, nei casi di accertamento a società di persone con imputazione ai soci, oppure accertamenti IVA a società con recupero IRPEF ai soci per utili extra, è opportuno che i giudizi del socio e della società vengano trattati insieme. Ciò spesso avviene d’ufficio se pendenti davanti alla stessa Commissione, tramite riunione. Il contribuente può segnalare l’esistenza di giudizi connessi e chiederne la riunione. Se, poniamo, un socio impugna l’avviso e la società anche, idealmente i due ricorsi verranno riuniti: questo evita decisioni contrastanti. Se invece il terzo non ha fatto ricorso, la chiamata non è possibile; ma la sua posizione potrà emergere come fatto (es: nel nostro ricorso possiamo evidenziare “Tizio, amministratore, ha confessato nell’altro procedimento penale di essersi appropriato di tutte le somme, come da documento allegato…”).
- Conciliazione giudiziale: anche una volta arrivati in giudizio, rimane aperta la possibilità di chiudere la lite con un accordo tra le parti, chiamato conciliazione. Può essere totale o parziale (magari si transige su alcune annualità e su altre no). La conciliazione è possibile fino all’udienza di discussione (in primo grado) e addirittura anche in appello . I vantaggi: se si concilia, le sanzioni vengono ridotte (1/3 del minimo se conciliazione in primo grado, 1/2 in appello). La riforma 2022 ha introdotto la conciliazione su impulso del giudice: il giudice può formulare una proposta di conciliazione alle parti, cercando di guidarle a un compromesso . In materia di presunzioni, la conciliazione può essere saggia se dal dibattimento emergono elementi tali che entrambe le parti hanno un rischio in giudizio: ad esempio, se il giudice sembra orientato a riconoscere alcuni punti al contribuente e altri al Fisco, le parti potrebbero accordarsi su una via di mezzo (riduzione dell’imponibile contestato, sanzioni ridotte e pagamento rateale) chiudendo la partita lì.
In generale, la difesa in giudizio deve mantenere il focus sul punto cruciale: la tenuta o meno delle presunzioni del Fisco. Bisogna evidenziare al giudice che manca la prova convincente dei maggiori redditi e che, anzi, la ricostruzione fiscale è contraddetta dalle nostre evidenze. In questo senso, la riforma del processo tributario ha introdotto una norma (art. 7, co.5-bis D.Lgs. 546/92) che chiarisce formalmente un principio già implicito: spetta all’Amministrazione provare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa, anche se basati su presunzioni, e il giudice deve verificare che tali presunzioni abbiano i requisiti di legge. Se ciò non avviene, il ricorso del contribuente va accolto . Questo comma 5-bis è entrato in vigore nel settembre 2021, ma riflette un trend pro-contribuente: non è più accettabile dare per scontata l’evasione e scaricare tutto sul contribuente; l’ufficio deve fare la sua parte nel dimostrare la fondatezza delle proprie pretese. Il difensore dovrebbe invocare espressamente questa norma (art. 7, co.5-bis) e incardinarvi la propria linea: se il Fisco ha solo ipotizzato senza prove solide, il giudice non può che annullare l’atto.
Esempi pratici di accertamenti presuntivi e relative difese
Per calare quanto detto in situazioni concrete, presentiamo alcuni casi pratici simulati di accertamenti basati su presunzioni, con le possibili strategie difensive dal punto di vista del contribuente. Gli esempi riguardano contesti tipici: ricostruzione da conti bancari, redditometro, utili societari ai soci. Ciascun caso evidenzia come una difesa ben costruita possa ribaltare la presunzione iniziale del Fisco.
Caso 1: Accertamento bancario basato su movimenti non giustificati
Scenario: Il sig. Rossi, imprenditore edile, riceve un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2022. L’Agenzia delle Entrate contesta ricavi non dichiarati per €200.000. La base dell’accertamento sono le indagini finanziarie sui suoi conti correnti (aziendali e personali): sono stati individuati nel 2022 circa €150.000 di versamenti in contanti e assegni sul conto non giustificati e €100.000 di prelevamenti ritenuti anomali rispetto alle spese dichiarate. L’Ufficio, applicando la presunzione legale ex art. 32 DPR 600/73, considera quei €250.000 (150k + 100k) come ricavi in nero. Deduce forfettariamente alcuni costi (pari a €50k, supponiamo) e determina un maggior reddito imponibile di €200.000 su cui calcolare imposte IRPEF, IVA e IRAP evase.
Inoltre commina sanzioni per infedele dichiarazione (120% dell’imposta) e omessa fatturazione IVA.
Difesa: Rossi, tramite il suo avvocato tributarista, predispone innanzitutto un prospetto analitico di tutti i movimenti bancari contestati (questo già al momento dell’istanza di accertamento con adesione e poi come allegato al ricorso). Per ciascun versamento o prelievo, indica la spiegazione e le eventuali prove:
- Versamento in contanti di €20.000 il 10/03/2022: provenienza spiegata: incassi di lavori di ristrutturazione già dichiarati e fatturati regolarmente. Rossi mostra infatti che il 9/3/2022 aveva emesso fatture per €22.000 (pagate in contanti) – allega copie delle fatture e registro dei corrispettivi. Dunque quei €20.000 non sono affatto ricavi “in nero”, ma semplicemente l’incasso di ricavi già tassati (li aveva dichiarati, e li stava solo depositando in banca). → Prova contraria: fatture e registri contabili ufficiali .
- Versamento assegno €15.000 il 5/05/2022: spiegazione: finanziamento soci. Rossi era socio unico della sua Srl, e aveva versato liquidità propria in azienda. Allegato estratto del libro verbali assemblea dove in data 4/5/2022 Rossi deliberava un finanziamento soci di €15.000 alla società, poi eseguito con assegno sul conto aziendale – e registrato a bilancio come debito verso soci. → Prova contraria: verbale e bilancio societario (dimostrano che quel versamento non è un ricavo di vendita, ma un apporto di capitale personale).
- Versamento bonifico €30.000 il 10/07/2022: spiegazione: vendita di un immobile personale, non tassabile. Rossi allega il rogito notarile del 1/7/2022 di vendita di un terreno di sua proprietà personale (fuori dall’impresa) per €30.000, somma accreditata sul conto il 10/7. Trattandosi di cessione di bene detenuto da oltre 5 anni, è esente da tassazione IRPEF. → Prova: atto notarile di vendita e estratto conto che evidenzia l’accredito con causale.
- Prelevamenti di €50.000 (vari prelievi in contanti in 6 mesi): l’ufficio presume fossero destinati a pagare operai “in nero” e dunque indice di ricavi in nero corrispondenti. Rossi replica: quei prelievi servivano per pagare fornitori e spese minute non documentate (l’impresa è di piccole dimensioni). Inoltre, essendo una ditta individuale, l’art. 32 prevede la presunzione sui prelievi oltre soglia; ma Rossi nota che molti prelievi singoli erano sotto €1.000 e dunque non cumulabili ai fini della soglia (€1.000 giornalieri, €5.000 mensili). Egli comunque allega dichiarazioni firmate da alcuni fornitori/artigiani che confermano di aver ricevuto pagamenti in contanti da Rossi (per lavori subappaltati in economia) e di averli inclusi nelle loro dichiarazioni. In sostanza, dimostra che quei contanti prelevati sono usciti per pagare costi deducibili (anche se non tutti fatturati formalmente). Chiede inoltre di applicare la giurisprudenza che impone di dedurre i costi a fronte dei prelievi presunti ricavi: la Corte Cost. 225/2005 consente di forfettizzare i costi sui ricavi in nero ipotizzati dai prelievi . → Argomento difensivo: i prelievi non possono generare imponibile se non si prova che hanno finanziato spese occulte e, in ogni caso, vanno dedotti i costi corrispondenti.
Rossi presenta dunque un quadro dove di €250.000 contestati: €20k erano ricavi già tassati, €15k finanziamento, €30k vendita esente, €50k prelievi per costi, ecc. In totale riesce a dare spiegazione documentale a, poniamo, €200k su €250k. Rimangono €50k di movimenti meno chiari, su cui però insiste che l’ufficio ha già applicato un forfait costi.
Nel procedimento di adesione, l’ufficio inizialmente non accetta tutte queste giustificazioni (spesso in adesione tendono a non discostarsi troppo). Propone uno sconto di 20% sull’imponibile. Rossi ritiene che sia poco e decide di andare avanti con il ricorso.
In giudizio: Rossi impugna l’atto sostenendo: (1) Violazione art. 32 DPR 600/73 – i versamenti contestati sono già tassati o di natura non reddituale, quindi l’ufficio ha male applicato la presunzione legale; (2) Inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti per eventuali importi residui (ex art. 39, c.1 lett.d): se rimane qualche scostamento, è troppo esiguo e isolato per fondare un accertamento; (3) Violazione art. 53 Cost. – l’ufficio non ha tenuto conto compiutamente dei costi correlati ai ricavi presunti, tassando di fatto importi lordi; (4) Difetto di motivazione – l’atto non spiega perché rigetta le spiegazioni fornite in contraddittorio (nel frattempo Rossi aveva inviato quelle memorie in fase pre-accertamento).
La Commissione Tributaria (Corte Giust. Trib.) valuta il materiale. Risulta effettivamente che l’ufficio, nell’atto, si è limitato a dire “non si ritengono documentate le spiegazioni”, senza confutare le prove specifiche (fatture, rogito, ecc.) presentate. Il giudice, mettendo a confronto le prove di Rossi con la posizione dell’ufficio, rileva che il 90% dei movimenti contestati trovano effettivamente giustificazione in vicende non imponibili. Inoltre, per i residui movimenti non spiegati, il giudice osserva che manca la gravità e concordanza: su 50k dubbi, non ci sono altri elementi (ad es. non risultano acquisti in nero né incrementi patrimoniali ingiustificati). Applica dunque il principio che la presunzione legale ex art. 32 è iuris tantum e risulta vinta dalle prove contrarie prodotte per ciascun movimento . Richiama anche Cass. n. 18596/2024 che ha sottolineato il dovere del giudice di valutare con rigore ogni prova contraria offerta dal contribuente in tema di indagini bancarie . Di conseguenza, la Commissione annulla l’accertamento per la quasi totalità, confermando solo una piccola parte (ipotizziamo €20k) su cui non c’era prova e che comunque, essendo coperta dai costi forfettari riconosciuti, non generava imponibile ulteriore.
Lezione: negli accertamenti bancari la chiave è la documentazione puntuale di ogni singolo movimento. Il contribuente deve farsi trovare pronto con pezze giustificative, contratti, appunti e qualsiasi elemento che permetta di collegare i soldi entrati/usciti a cause note e non reddituali. Più del 70-80% dei casi di successo in giudizio su indagini finanziarie dipende dal lavoro meticoloso di riconciliazione tra movimenti e causali reali. Inoltre, non dimentichiamo i prelievi: per gli imprenditori restano presuntivamente ricavi (sopra soglia), ma la difesa può attaccare sotto due profili: a) se il contribuente è un professionista o privato, oggi non valgono (grazie a Corte Cost. 228/2014, i prelievi non giustificati non sono reddito per professionisti) ; b) anche per gli imprenditori, si deve comunque dedurre i costi come visto. In questo esempio, Rossi ha avuto buon gioco perché la maggior parte delle somme non era affatto “nero” e lo ha dimostrato. Se invece i movimenti fossero stati realmente incassi in nero senza alcun documento a supporto, avrebbe dovuto quantomeno puntare a ottenere la deduzione forfettaria dei costi (in base a Cass. 10192/2023 e Corte Cost. 10/2023) per ridurre il danno.
Caso 2: Accertamento sintetico redditometrico vs. reale tenore di vita
Scenario: La sig.ra Bianchi, lavoratrice dipendente con stipendio annuo di €25.000, riceve nel 2025 un accertamento sintetico per il triennio 2019-2021. L’Agenzia delle Entrate ha riscontrato che Bianchi possiede: un appartamento di proprietà dove vive (acquistato nel 2018 per €200.000), un’auto Mercedes acquistata nuova nel 2020 (€50.000), e risultano a suo carico spese per viaggi all’estero di circa €10.000 annui (emerse dai movimenti della carta di credito). In base a questi elementi patrimoniali e di spesa, l’ufficio ha stimato un reddito “sintetico” di circa €60.000 annui, contro i €25.000 dichiarati. Superando sia il 20% che la soglia assoluta, l’ufficio – dopo aver inviato invito al contraddittorio (cui però Bianchi non si è presentata) – emette tre avvisi di accertamento, aggiungendo ~€35.000 di imponibile IRPEF per ciascuno dei tre anni, più le relative imposte e sanzioni.
Difesa: La sig.ra Bianchi decide di impugnare gli atti, sostenendo di aver potuto sostenere quelle spese attingendo a risparmi di famiglia e aiuti di terzi, senza disporre di redditi occulti. Nella memoria difensiva e poi nel ricorso dettaglia e documenta quanto segue:
- Acquisto della casa (€200.000 nel 2018): Bianchi spiega che l’appartamento è stato pagato in gran parte con il ricavato della vendita della casa dei genitori ricevuta in eredità . Allegati: copia della dichiarazione di successione del 2017 dove risulta che ha ereditato €150.000 e un immobile dai genitori defunti; atto notarile di vendita di detto immobile ereditato per €140.000 nel 2018; estratto conto che mostra il deposito di quella somma sul conto. Inoltre, la differenza è stata finanziata con un mutuo bancario di €50.000, di cui allega contratto e piani di ammortamento . Quindi, per la casa: €150k provenivano da capitale preesistente (eredità) e €50k da mutuo – nessun reddito occulto necessario.
- Acquisto auto Mercedes (€50.000 nel 2020): l’auto è intestata a Bianchi ma in realtà è stata pagata dal marito. Bianchi è in separazione dei beni e il marito ha un reddito alto da imprenditore. Viene allegato il bonifico di pagamento dell’auto effettuato dal conto corrente del marito, nonché una dichiarazione del concessionario che l’acquirente di fatto è il marito (che per ragioni assicurative ha intestato l’auto alla moglie) . Ci sono anche fatture di manutenzione pagate dal marito. Dunque, il possesso dell’auto di per sé non indica reddito di Bianchi: era un regalo/beneficio proveniente dal coniuge, la cui capacità reddituale non è in discussione.
- Viaggi all’estero (€10.000/anno): Bianchi chiarisce che quei viaggi (soprattutto voli e hotel in Australia) sono stati in gran parte regalati dal fratello residente in Australia. Ogni anno il fratello invita lei e la sua famiglia a trovarlo e paga lui le spese principali. A supporto, produce copie di email in cui il fratello le invia biglietti aerei come regalo, e – ancora più importante – gli estratti conto dove si vedono bonifici in entrata di €10.000/anno dal fratello (con causali tipo “gift for travel”) . Quindi, i €10k l’anno per viaggi non provenivano da reddito di Bianchi ma da soldi inviati dal fratello dall’estero (donazione, peraltro esente).
- Altre fonti di finanziamento: Bianchi evidenzia che negli anni ha fatto uso dei risparmi accumulati in passato. Allegati estratti di un conto titoli da cui nel 2019 ha venduto azioni per €30.000 e nel 2020 altre per €20.000, cifre poi utilizzate per spese generali . La vendita di investimenti finanziari non genera reddito tassabile (o comunque, se anche avesse generato plusvalenze, sono redditi a parte già tassati alla fonte). Ciò mostra che aveva liquidità propria accumulata.
In sintesi, Bianchi argomenta che tutte le voci di spesa patrimoniali evidenziate dal Fisco trovano copertura in entrate di natura non imponibile:
– Eredità + mutuo -> acquisto casa.
– Denaro del marito -> acquisto auto.
– Regali del fratello -> viaggi.
– Disinvestimento risparmi -> spese varie supplementari.
L’ufficio, costituendosi in giudizio, insiste nel dire che comunque il tenore di vita è elevato e la contribuente non ha documentato ogni aspetto al 100%. Solleva dubbi su chi paghi le spese correnti di mantenimento della casa (bollette, condominio) e sulle spese familiari. Bianchi replica che col suo stipendio da €25k copre le spese ordinarie di vita, e che su quelle nulla da eccepire (difatti un reddito di 25k può pagare bollette e spese quotidiane tranquillamente).
Esito ipotetico: La Corte Tributaria accoglie il ricorso di Bianchi. Nella sentenza si legge che l’Agenzia non ha adeguatamente considerato le prove presentate dalla contribuente : in base all’art. 38, co.6, DPR 600/73 (norma sul redditometro), la contribuente ha dimostrato che le spese sostenute nel triennio sono state finanziate con redditi di annualità diverse (risparmi, eredità) o con liberalità di terzi . Inoltre, il giudice evidenzia che l’Ufficio non ha fornito ulteriori elementi oltre alle spese-indice: non risultano, ad esempio, investimenti occulti o incrementi patrimoniali non spiegati (la casa stessa è giustificata). Pertanto manca la gravità degli indizi necessaria per confermare la presunzione di maggior reddito . Il giudice richiama anche il nuovo art. 7, co.5-bis D.Lgs. 546/92: poiché le presunzioni dell’ufficio sono state neutralizzate dalle spiegazioni e non c’è prova puntuale di un maggior reddito effettivo, la pretesa va annullata .
Lezione: Negli accertamenti sintetici, tutto ruota attorno alla prova delle fonti di finanziamento. Un contribuente che ostenta ricchezza ma può documentare che stava spendendo soldi non derivanti da reddito attuale (ma da risparmi, dismissioni patrimoniali o aiuti familiari) ha un’arma potentissima per vincere. La normativa gli dà pieno diritto di giustificare così lo scostamento . Questo caso mostra che un impiegato con stipendio modesto può comunque fare spese grandi usando capitali ricevuti da altri o accumulati: non è detto affatto che stia evadendo. L’importante è provare con carte tutto ciò: dichiarazioni di successione, rogiti, estratti conto, bonifici da parenti, ecc. Il Fisco oggi non può ignorare tali prove. Se Bianchi non avesse avuto documentazione (es. niente traccia dei soldi del fratello), sarebbe stata più dura far valere solo una dichiarazione del fratello: ecco perché è essenziale far passare i trasferimenti di denaro tramite canali tracciati (nel nostro esempio c’erano i bonifici dal fratello, provvidenziali). In mancanza, almeno una dichiarazione giurata del fratello avrebbe dovuto essere prodotta.
Questo esempio sottolinea anche l’importanza di partecipare al contraddittorio: Bianchi non andò all’invito. Se lo avesse fatto, forse l’ufficio avrebbe archiviato l’accertamento già in fase pre-contenziosa, vedendo tutte quelle prove. Quindi mai sottovalutare l’invito a comparire: ignorarlo è un errore, specie se si hanno buone spiegazioni (lo stesso Statuto ora impone di considerarle seriamente).
Caso 3: Presunta distribuzione di utili occulti ai soci di una piccola società
Scenario: La S.r.l. Alfa (4 soci, cosiddetta “ristretta base societaria”) subisce un accertamento per ricavi non contabilizzati pari a €500.000 nell’anno 2021. L’Agenzia accerta maggiori ricavi e recupera IRES e IVA alla società. Contestualmente, in base al noto orientamento giurisprudenziale sulla ristretta base, notifica ai 4 soci persone fisiche avvisi di accertamento IRPEF, imputando a ciascuno un utile extracontabile presunto distribuito di €125.000 (500k ÷ 4) nell’anno 2021. In altre parole, presume che i €500k di ricavi in nero siano stati distribuiti fra i soci in proporzione alle quote. Uno dei soci, il sig. Verdi, possiede il 20% ed è un socio di capitale non amministratore (non ha ruoli gestionali) e per di più nel 2021 lavorava stabilmente all’estero. Verdi impugna il suo avviso da €125k, sostenendo di non aver mai ricevuto utili in nero e di essere stato del tutto all’oscuro dell’eventuale evasione commessa dall’amministratore.
Difesa del socio Verdi: Nel ricorso, Verdi enfatizza diversi aspetti e allega prove:
– Egli era un socio di puro capitale, senza deleghe amministrative, e nel 2021 risiedeva all’estero per lavoro . Allega certificati di residenza temporanea estera e contratto di lavoro estero che dimostrano la sua assenza dalla gestione quotidiana . Quindi non partecipava alle decisioni operative della S.r.l. né aveva contezza delle vendite in nero.
– Nel 2022 la società Alfa è fallita (segno di difficoltà finanziarie). Dalle carte del fallimento risulta che eventuali fondi extracontabili sono stati utilizzati dall’amministratore per pagare maestranze in nero e tangenti varie. Verdi allega copia di dichiarazioni rese dallo stesso amministratore nell’ambito di un procedimento penale, in cui questi ha ammesso di aver distratto somme aziendali per pagamenti illeciti, senza distribuirle ai soci .
– Verdi mostra l’estratto conto personale del 2021, dal quale non risultano affatto entrate di rilievo: la movimentazione è modesta (solo il suo stipendio estero di importo coerente) e non vi sono bonifici o versamenti significativi riconducibili a utili occulti .
In base a questi elementi, Verdi sostiene che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci – che la Cassazione in passato ha applicato per le società a ristretta base – nel suo caso è smentita dai fatti: se c’erano utili in nero, lui non ne ha beneficiato.
Possibile esito: Il giudice tributario accoglie la tesi di Verdi. Nella sentenza sottolinea che la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è una presunzione semplice, non una presunzione legale assoluta . Di conseguenza, può essere vinta con prova contraria concreta. In questo caso, il socio ha provato: la sua estraneità gestionale e l’assenza di arricchimento personale (conto corrente pulito) . L’Ufficio invece non ha fornito alcuna prova specifica che Verdi abbia effettivamente percepito denaro (si è basato su un mero automatismo). Applicando anche qui l’art. 7, co.5-bis D.Lgs. 546/92, il giudice rileva che l’onere probatorio spettava al Fisco e non è stato assolto, mentre la presunzione “jurisprudenziale” su cui si basava l’atto è stata recessa dalle evidenze portate dal socio . Dunque annulla l’avviso per Verdi. (Ovviamente, la situazione potrebbe essere diversa per altri soci: se ad esempio l’amministratore socio al 60% ha effettivamente drenato lui tutti i fondi neri, per lui la presunzione reggerebbe eccome, e il suo ricorso verrebbe respinto. Ma per il socio minoritario inconsapevole, la presunzione cade).
Lezione: In passato, la giurisprudenza era molto rigida con le società a base familiare o ristretta: “ci sono utili extra? Li consideriamo automaticamente distribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria difficilissima”. Il socio spesso veniva tassato due volte: prima la società (IRES) e poi lui (IRPEF su utili non censiti formalmente). Ora, grazie anche all’evoluzione normativa (art. 7, co.5-bis) e a pronunce più recenti, si sta riconoscendo che quella non è una presunzione legale, ma solo un indirizzo giurisprudenziale da applicare con cautela . Un socio minoritario può salvarsi se dimostra concretamente di non aver ricevuto nulla. Nel caso di Verdi, la difesa ha mostrato: vita modesta, conti puliti, e persino dove sono finiti i soldi (l’amministratore se li era “fumati”). Questa è praticamente la prova migliore: non solo “io non li ho”, ma anche “ecco chi li ha presi al posto mio”. In assenza di una prova così forte, il socio può comunque difendersi mostrando di non aver avuto benefici (es. 730 personali senza dividendi, nessun incremento patrimoniale in quell’anno, ecc.) e magari sottolineando di essere solo un investitore passivo.
Il messaggio per i soci “innocenti” è: non subite passivamente la doppia presunzione (ricavi in nero -> utili ai soci). Citate le sentenze a favore (Cass. 13546/2016; Cass. 27366/2018; Cass. 5529/2025) che mostrano come la presunzione di distribuzione non è assoluta e soprattutto come “l’aver pochi soci non significa che tutti siano coinvolti nell’evasione”. Con la giusta impostazione, oggi un giudice può essere sensibile a queste argomentazioni e decidere in modo più equo caso per caso.
Questi esempi ovviamente non coprono tutte le situazioni possibili, ma riflettono alcuni problemi comuni negli accertamenti presuntivi e mostrano come, in ognuno, il punto decisivo sia la prova: chi riesce a portare la prova più convincente vince sulla presunzione. Il Fisco parte spesso da una posizione di vantaggio (basta un indizio serio per emettere l’atto), ma il contribuente ben preparato può ribaltare l’esito. I casi mostrano anche come le riforme recenti abbiano leggermente spostato l’ago della bilancia: il contribuente non è più sempre “colpevole fino a prova contraria”, ma ha strumenti per far valere le proprie ragioni e giudici più attenti a valutarle .
Domande frequenti (FAQ)
D: Cosa significa in pratica “accertamento fondato su presunzioni”?
R: Significa che il Fisco determina maggiori imposte da pagare deducendo l’esistenza di redditi non dichiarati a partire da indizi o circostanze indirette, invece che basarsi su prove dirette . In altre parole, l’ufficio non ha trovato una fattura nascosta o un registro segreto (prova diretta di evasione), ma ha elementi che suggeriscono incongruenze: per esempio movimenti bancari inspiegati, beni di lusso non compatibili col reddito dichiarato, contabilità irregolare, ecc. Usando questi elementi come base, presume che il contribuente abbia evaso e quantifica le imposte dovute. È dunque un accertamento “indiretto” che si basa sul ragionamento presuntivo: dal fatto noto (l’indizio) si risale al fatto ignoto (il reddito evaso) .
D: Quali tipi di presunzioni usa il Fisco e come si differenziano?
R: In sintesi: le presunzioni legali sono previste da leggi tributarie e attribuiscono a certi fatti un significato di evasione ex lege (es: per legge un versamento bancario inspiegato è reddito tassabile) . Di solito queste presunzioni ribaltano l’onere della prova sul contribuente: valgono fino a prova contraria (iuris tantum). Le presunzioni semplici, invece, non sono stabilite da leggi specifiche ma costruite dal Fisco su base indiziaria: valgono solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti . In tal caso, formalmente resta il Fisco a dover convincere il giudice della validità di quegli indizi; dopodiché il contribuente deve portarvi controprove. Infine, le presunzioni “supersemplici” sono quelle presunzioni ultra-semplificate che la legge consente in casi estremi (omessa dichiarazione, scritture inesistenti): qui il Fisco può stimare arbitrariamente, anche senza forti indizi a supporto . La differenza tra queste categorie sta nella forza probatoria e in chi deve provare il contrario. Se è legale, l’onere è sul contribuente; se è semplice, l’onere iniziale è sul Fisco (ma poi di fatto si sposta); se è supersemplice, il contribuente è in maggiore difficoltà perché il Fisco ha potuto agire quasi senza dover provare nulla all’inizio.
D: Se ricevo un accertamento basato su presunzioni, devo provare la mia innocenza?
R: Dipende dal tipo di presunzione utilizzata. Se l’atto si basa su una presunzione legale (ad esempio i movimenti bancari non giustificati), sì, in gran parte l’onere è tuo: dovrai tu fornire la prova contraria per ogni elemento contestato . Invece, se l’accertamento si basa su presunzioni semplici (ricostruzioni induttive da indizi vari, studi di settore, redditometro), formalmente l’onere di provare che gli indizi sono validi spetta all’ufficio. Tuttavia, in pratica, una volta che il Fisco porta elementi che convincono il giudice, automaticamente si richiede a te di contrastarli con controprove . Dunque, al di là delle finezze giuridiche sull’onere della prova, conviene sempre prepararsi a dimostrare la correttezza della tua posizione fiscale. In altre parole, sì, devi “provare la tua innocenza” portando quante più evidenze possibili a tuo favore, specie quando le presunzioni sono semplici (dove hai comunque modo di intervenire). Nota: la riforma del processo tributario del 2022 ha introdotto qualche tutela in più per il contribuente sulle presunzioni semplici (con il famoso art. 7, co.5-bis, che impone al giudice di valutare bene il soddisfacimento dell’onere probatorio da parte del Fisco) , ma questo non significa affatto che tu possa restare passivo. È sempre consigliabile contestare punto per punto, perché un giudice potrebbe altrimenti ritenere adeguata la presunzione dell’ufficio e a quel punto – in assenza di tue prove contrarie – confermarla.
D: Possono farmi un accertamento solo in base ai versamenti sul mio conto corrente?
R: Sì, se non riesci a giustificarli adeguatamente, possono. La legge (art. 32 DPR 600) permette di presumere che tutti i versamenti sul conto bancario, se non spiegati, siano ricavi in nero . È una delle presunzioni legali più comuni e temute. Quindi, se ti trovano €50.000 di versamenti non giustificati, il Fisco li considererà redditi non dichiarati a meno che tu provi, ad esempio, che si tratta di trasferimenti da altri tuoi conti, o di un prestito ricevuto, o della restituzione di un finanziamento, ecc. . Lo stesso (fino a un certo punto) per i prelievi: per gli imprenditori, prelievi in contanti ingenti e non spiegati si presumono utilizzati per spese in nero e quindi indicano ricavi non dichiarati di pari importo . Questa presunzione sui prelievi però non si applica ai privati e ai professionisti (dopo una sentenza della Corte Costituzionale, è stata limitata ai soli imprenditori) . In sintesi: i movimenti bancari sono spesso sufficienti da soli a motivare un accertamento – costituiscono prova presuntiva legale – e poi sta a te chiarirli voce per voce. Ecco perché è fondamentale tenere traccia di tutti i movimenti bancari significativi e poter fornire giustificazione (causali, documenti) all’occorrenza.
D: Ho un’attività con contabilità in ordine; possono comunque contestarmi ricavi non dichiarati?
R: Se la tua contabilità è formalmente regolare e non emergono incongruenze sostanziali, in linea teorica no – l’ufficio non può ignorarla senza motivo. Però attenzione: se vengono trovati elementi esterni che contraddicono i dati contabili, il Fisco può intervenire con un accertamento analitico-induttivo. Ad esempio, se alcuni clienti dichiarano di averti pagato più di quanto risulta dalle fatture che hai emesso, oppure se i tuoi margini di guadagno sono sistematicamente ben al di sotto di quelli normali e ciò appare ingiustificato, l’ufficio potrebbe dire: “la contabilità, pur regolare, non riflette la realtà economica” e presumere ricavi occulti . Detto ciò, la Cassazione ha spesso annullato accertamenti basati su un’unica anomalia lieve. Quindi, se la tua contabilità è davvero solida e c’è solo qualche scostamento occasionale, hai buone chance di difenderti e far valere l’attendibilità delle scritture . Diverso è se, pur con i conti formalmente in ordine, spuntano prove esterne di evasione (il classico “brogliaccio” con doppia contabilità, o versamenti bancari strani): in tal caso l’ufficio userà quelle prove per costruire una presunzione semplice e rettificare i tuoi dati . In sintesi: una contabilità ordinata è la prima linea di difesa, ma non ti rende immune al 100% se emergono indizi contrari nel tuo ambiente economico. Devi sempre essere pronto a spiegare eventuali anomalie con argomenti e prove.
D: I “redditometri” sono ancora in uso? Devo preoccuparmi se ho spese alte rispetto al mio reddito?
R: L’accertamento sintetico (redditometro) esiste ancora sulla carta (art. 38 DPR 600/73), ma va detto che dopo il 2015 è stato applicato molto poco . Il “nuovo redditometro” elaborato nel 2018 non è mai decollato ed è stato di fatto accantonato dal MEF per ulteriori revisioni . Oggi (2025) il Fisco può comunque farti un accertamento sintetico mirato se vede spese platealmente superiori al dichiarato, ma, come spiegato, ci sono soglie precise (20% e circa €70.000) da superare e soprattutto dovrà prima ascoltarti. Dunque, se tu stai spendendo tanto più di ciò che dichiari, la situazione è a rischio – ma se hai fonti non tassabili (risparmi, eredità, donazioni) che finanziano il tuo tenore di vita, potrai spiegarlo e documentarlo e l’accertamento non dovrebbe partire . Se invece stai effettivamente spendendo molto oltre il dichiarato e senza giustificazioni, allora sì, potresti essere un bersaglio per il redditometro (soprattutto ora che pare ne stiano reintroducendo uno “2.0”, anche se calibrato per i casi più grossi). In pratica: preoccupati fino a un certo punto. L’importante è avere traccia di dove prendi i soldi che spendi. Se arrivano da redditi leciti e tassati (tuoi di altri anni o di altre persone), conservali. Se arrivano da redditi in nero… beh, quello è proprio ciò che il redditometro vuole scovare.
D: In un processo tributario posso portare testimoni?
R: Questa è una novità recente. Fino al 2022 la testimonianza era vietata. Oggi, grazie alla riforma, è ammessa la “testimonianza scritta” in casi eccezionali . Non aspettarti di poter chiamare liberamente testi in udienza: funziona così – se il giudice lo ritiene necessario (o se entrambe le parti lo chiedono, cosa che l’Agenzia raramente farà), può far formulare delle domande a un testimone, il quale risponderà con dichiarazione scritta giurata . Quindi sì, in teoria puoi avere testimonianze di terzi a tuo favore (es: un cliente che conferma di averti pagato solo quanto fatturato e non di più; un parente che attesta di averti donato soldi con cui hai fatto certe spese) . Ma devi proporre questa prova già nel ricorso e convincere il giudice che è davvero indispensabile. Diciamo che è uno strumento da usarsi quando manca la prova documentale e solo un terzo può chiarire i fatti. Per esempio, se ti contestano un versamento e solo il tuo amico che ti ha dato cash può confermare la causale, puoi chiedere la sua testimonianza. Ricorda però: il giudice potrebbe anche accontentarsi di una tua dichiarazione scritta del terzo allegata agli atti, senza attivare la procedura formale. In ogni caso, adesso c’è questa chance che prima non c’era affatto . Se hai testimoni chiave, menzionali e chiedi formalmente che vengano sentiti per iscritto (sapendo che l’Agenzia potrebbe opporsi). È una frontiera nuova, molti giudici sono ancora restii, ma tentar non nuoce quando può fare la differenza.
D: Cosa succede se il Fisco basa l’accertamento su documenti che ha ottenuto in modo illegale?
R: Dipende dall’illegittimità. In linea generale, nel processo tributario non c’è un chiaro principio di inutilizzabilità delle prove irrituali come nel penale . La Cassazione ha affermato che non esiste un divieto generale di usare prove acquisite irregolarmente in ambito tributario, a meno che non vengano violati diritti fondamentali del contribuente (inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza, ecc.) . Quindi, se ad esempio il Fisco ottiene informazioni su conti esteri tramite una fuga di notizie o elenchi rubati (tipo Lista Falciani), potrebbe comunque usarle e sta a te contestare la fonte; ma spesso i giudici tributari le ammettono lo stesso, in nome della “ricerca della verità fiscale”. Solo se la prova è stata raccolta violando un tuo diritto costituzionale potresti ottenerne l’esclusione (ad esempio, se ti hanno fatto un accesso domiciliare senza autorizzazione e hanno sequestrato documenti, quello potrebbe essere un vizio grave) . In sostanza: se pensi “hanno preso quei dati senza autorizzazione!”, sicuramente solleva la questione (va sempre sollevata, non si sa mai), ma sappi che spesso non basta per annullare l’atto. Una eccezione comune riguarda le indagini bancarie: qui la legge richiede un’apposita autorizzazione interna; se l’ufficio non la allega all’atto, alcuni hanno tentato di far dichiarare inutilizzabili i dati. La Cassazione però ha detto che se comunque il contribuente è venuto a conoscenza dei dati e non ha subito un reale pregiudizio difensivo, l’atto rimane valido . Quindi, su questo tema, la giurisprudenza è piuttosto indulgente col Fisco. Il consiglio è: eccepisci sempre eventuali vizi nella raccolta prove (violazioni dello Statuto del Contribuente, ecc.), potrebbe essere un argomento a tuo favore in combinazione con altri, ma non farci totale affidamento. Preparati soprattutto a difenderti nel merito, perché raramente si vince solo sul “questa prova è irrituale”.
D: Ho ricevuto un avviso basato su presunzioni; mi conviene fare ricorso o trattare col Fisco?
R: Dipende dalla situazione concreta. Se hai buone prove e la pretesa ti sembra chiaramente infondata o esagerata, fare ricorso ha senso: oggi i giudici tributari sono più professionalizzati e attenti, e se la presunzione è davvero azzardata hai buone chance di vittoria piena (magari annullamento totale) . Se invece la presunzione dell’ufficio è eccessiva ma un fondo di verità c’è (diciamolo: qualcosa non hai dichiarato davvero, anche se meno di quanto dicono), spesso conviene trattare. L’accertamento con adesione può ridurre notevolmente sia l’imponibile sia le sanzioni, trovando un compromesso . In adesione puoi ottenere uno “sconto” che in giudizio magari non avresti, perché il giudice deve applicare la legge alla lettera: se per legge un elemento è reddito, il giudice lo confermerà. L’ufficio, in adesione, può invece chiudere a metà strada anche se la legge sarebbe completamente a suo favore, per evitarsi la causa . Quindi la strategia è: se puoi dimostrare tutto o gran parte -> ricorso; se la situazione è “grigia” -> prova prima un’adesione per spuntare il risultato migliore; se l’ufficio però è sordo o offre poca riduzione, allora ricorso. Considera anche i costi/tempi: il ricorso può durare anni e ha costi (anche se, vincendo, puoi farti rifondere le spese), mentre l’adesione risolve in pochi mesi e con minori tensioni . Ogni caso è a sé, ovviamente da valutare con un professionista. Spesso la tattica migliore è: presentare istanza di adesione (così intanto sospendi i termini e vedi l’atteggiamento dell’ufficio), trattare seriamente, ma preparare in parallelo il ricorso se la trattativa non soddisfa.
D: In caso di presunzioni, quali sono le prove migliori che dovrei presentare?
R: Sicuramente le prove documentali oggettive sono quelle che pesano di più: contratti, estratti conto, fatture, quietanze, atti notarili, registri contabili, bilanci, visure, ecc. Qualunque documento ufficiale che dimostri la vera natura dei fatti contestati è oro colato . Ad esempio: ti contestano un versamento come ricavo in nero – prova migliore è un documento che mostri che era un trasferimento da altro tuo conto o un prestito formalizzato. Oppure ti contestano margini troppo bassi – una perizia di un consulente che attesti che nel tuo settore i margini medi sono effettivamente bassi per determinate ragioni. Le dichiarazioni di terzi (clienti, fornitori, parenti) possono aiutare, ma meglio se corroborate da riscontri documentali . Ora abbiamo anche le testimonianze scritte: se hai qualcuno disposto a confermare per iscritto determinati fatti, raccogli quelle dichiarazioni, magari facendole autenticare da un notaio per dare più peso . Includile già nel ricorso. Inoltre, non dimenticare la normativa e la prassi: a volte esistono circolari dell’Agenzia che interpretano certe presunzioni in modo più favorevole al contribuente – se ne hai, allegale e sottoponile al giudice (non sono legge, ma spesso i giudici le tengono in considerazione). E naturalmente porta la giurisprudenza a te favorevole. Infine, usa anche la logica e l’aritmetica: spesso schemi e calcoli sono prove di per sé. Esempio: se il Fisco ti contesta ricavi non dichiarati che implicherebbero un volume di affari impossibile (tipo avresti dovuto lavorare 28 ore al giorno), questo ragionamento logico-numerico è una “prova” indiretta che la pretesa è assurda – presentala con chiarezza. Il giudice va guidato: non dare per scontato che conosca le dinamiche della tua attività, devi spiegargliele tu con elementi concreti .
D: Se perdo in primo grado, posso far valere le stesse ragioni in appello?
R: Certo, puoi fare appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. In appello riproporrai i tuoi argomenti di primo grado e potrai controbattere alle motivazioni con cui hai perso. Però attenzione: non potrai presentare nuove prove che già avevi e non hai prodotto in primo grado . La regola generale è che in appello si valutano le stesse prove del primo grado, salvo casi eccezionali (documenti scoperti dopo, o non presentabili prima per cause di forza maggiore). Quindi, come dicevamo, è fondamentale giocarsi tutto subito. Detto questo, dal 2023 il giudizio d’appello tributario è diventato un novum iudicium quasi completo: ciò significa che il giudice d’appello può riesaminare nel merito sia i fatti sia il diritto, senza essere vincolato dai motivi specifici di gravame come avveniva prima (ora può valutare l’intera causa) . Puoi anche chiedere in appello cose come una CTU tecnica se ritieni serva un perito indipendente: oggi è leggermente più frequente ottenerla rispetto al passato . Se perdi anche in appello, rimane la Cassazione, ma lì si discute solo di questioni di diritto (errori di diritto commessi dai giudici di merito, non si rivedono i fatti). Quindi, per le presunzioni (che sono molto fatto-centriche), la partita decisiva si gioca in primo e secondo grado. Vincere in primo grado è l’ideale (spesso l’Agenzia non appella se la questione è prevalentemente fattuale, temendo un’altra sconfitta), ma se perdi e sei convinto delle tue ragioni, l’appello ti dà un’altra chance con giudici diversi . In Cassazione, invece, si può solo far valere se la sentenza d’appello ha violato norme o illogicità gravi di motivazione – è più difficile ribaltare l’esito solo sul diritto, specie in materia di presunzioni dove conta molto la valutazione del fatto fatta dal giudice di merito.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni comuni accertamento imposte sui redditi: art. 32 (presunzioni da conti bancari), art. 38 (accertamento sintetico redditometrico), art. 39 (accertamenti analitici e induttivi), art. 40 (rettifiche per società di persone e imputazione ai soci), art. 41 (accertamento d’ufficio in caso di omessa dichiarazione).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – IVA: art. 54 (accertamento basato su scritture e presunzioni semplici), art. 55 (accertamento d’ufficio IVA).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) – Principi garantisti: art. 5 (collaborazione e buona fede), art. 6 (chiarezza e motivazione atti, diritto al contraddittorio – v. nuovo art. 6-bis introdotto nel 2023), art. 7 (motivazione degli atti e allegazione documenti), art. 10 (tutela affidamento, circolari). Art. 12, c.2-7 (diritti del contribuente in caso di verifiche: contraddittorio entro 60 gg dal PVC, ora abrogato e sostituito da obbligo generalizzato ex D.Lgs. 219/2023) .
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Definizioni agevolate: disciplina dell’Accertamento con adesione (artt. 5-11), Acquiescenza (art. 15), sanzioni ridotte 1/3.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Processo tributario: art. 7 (poteri delle Commissioni, comma 4-bis su testimonianza scritta, comma 5-bis su onere della prova a carico AF) ; art. 58 (appello, nova in appello ammessi in modo limitato); art. 68 (sospensione riscossione 1/3); art. 48 (conciliazione giudiziale, sanzioni 1/3 primo grado, 1/2 appello).
- D.Lgs. 30 settembre 2021, n. 149 (riforma processo civile) e Legge 31 agosto 2022, n. 130 (riforma giustizia tributaria) – Introduzione giudici tributari professionali, novità su prova testimoniale scritta, estensione conciliazione su impulso giudice, eliminazione reclamo obbligatorio dal 2023 .
- D.Lgs. 29 dicembre 2023, n. 219 – Attuazione delega fiscale 2022-23: obbligo generalizzato di contraddittorio (inserimento art. 6-bis Statuto, abrogazione art. 12 c.7) ; modifiche all’accertamento sintetico art. 38 DPR 600 (soglie 20%+10×ASS, prove contrarie codificate, ecc.) .
- Costituzione della Repubblica Italiana: art. 53 (capacità contributiva, base dei principi su reddito netto e proporzionalità accertamenti) e art. 3 (uguaglianza e ragionevolezza, base per contestare presunzioni irragionevoli).
- Corte Costituzionale: Sent. n. 225/2005 (deducibilità costi in accertamento d’ufficio: impone di considerare costi sui ricavi presunti da prelevamenti) ; Sent. n. 228/2014 (illegittimità presunzione prelievi per professionisti: art. 32 va disapplicato ai prof.) ; Sent. n. 132/2015 (obbligo contraddittorio preventivo in IVA, principio del “diritto di difesa UE”); Sent. n. 10/2023 (respinge questione su art. 32 prelievi imprenditori, ma “nei sensi di motivazione”: conferma la linea deduzione costi e onere della prova in capo a AF) .
- Cassazione – Principali sentenze di riferimento (Sez. V salvo indicato):
- Accertamenti bancari: Cass. 17408/2010 – Legittimo ricostruire ricavi ristorante dal consumo di acqua minerale (anche un solo elemento, se grave e preciso, può sorreggere presunzione) . Cass. 4017/2010 – Legittimo per hotel stimare presenze dai tovaglioli lavati (unico indicatore sufficiente se logico) . Cass. 11162/2021 – Anche un unico elemento può bastare, purché valutato logicamente (conferma orientamento univoco) . Cass. 18596/2024 – In indagini finanziarie, movimenti non giustificati = redditi occulti, ma giudice deve valutare con rigore le prove contrarie del contribuente . Cass. 8452/2025 – Non esiste un principio generale di inutilizzabilità di prove irrituali nel tributario: un documento irritualmente acquisito è utilizzabile se nessuna norma ne vieta l’uso ai fini fiscali .
- Accertamento induttivo e onere della prova: Cass. 20897/2019 – Anche nell’induttivo puro vale un criterio di ragionevolezza: ricostruzioni palesemente illogiche o sproporzionate sono illegittime . Cass. 10192/2023 – Necessario riconoscere costi in caso di induttivo puro da omessa dichiarazione, pena violazione art. 53 Cost.; conferma obbligo di deduzione forfettaria costi in base a Corte Cost. 225/2005 . Cass. 13205/2025 – (Ordinanza 19/05/2025) Legittimo induttivo su base consumo di acqua in ristorante; ribadisce uso di presunzioni semplici GPC anche uniche . Cass. 5881/2025 – Ricorda principio “doppia conforme”: se sentenze CTP e CTR sono allineate sui fatti, il ricorso in Cassazione deve indicare differenze di fatti tra le due decisioni per poter essere ammissibile (rilevante per chi perde in appello). Cass. 5529/2025 – Chiarisce il divieto di doppia presunzione: non impedisce al Fisco di trarre conseguenze da una presunzione legale; vale solo per catene di presunzioni semplici (es: non puoi presupporre un fatto ignoto basandoti su un altro fatto ignoto presunto) .
- Contraddittorio e presunzioni: Cass. SS.UU. 24823/2015 – Niente obbligo generalizzato di contraddittorio per tributi non armonizzati; prova di resistenza per IVA (principio poi in parte superato dalla legge 219/2023). Cass. 701/2020 e 21800/2020 – Ribadiscono, ante riforma, inesistenza obbligo contraddittorio se non previsto espressamente (non armonizzati). Cass. 16574/2023 – Svolta: afferma un principio di obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale se l’accertamento si fonda su elementi rispetto a cui il contribuente non sia stato sentito, anche per tributi interni (innovativo, da confermare consolidamento) . Cass. SS.UU. 21271/2025 – (ipotetica, in attesa conferma) Dovrebbe aver risolto alcuni dubbi sulla prova di resistenza dopo obbligo generalizzato; presumibilmente ha reso più stringente la necessità di indicare cosa si sarebbe dedotto nel contraddittorio mancato.
- Studi di settore / ISA: Cass. 9765/2014 – Lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore di per sé solo non legittima l’accertamento se il contribuente fornisce cause specifiche giustificative (principio di necessità di GPC ulteriori) . Cass. 1505/2017 – (post Corte Cost. 228/2014) Conferma che per professionisti la presunzione sui prelievi non vale più.
- Utili extra-contabili ai soci: Cass. 18065/2013 – Presunzione distribuzione utili ai soci di ristretta base è iuris tantum: ammette prova contraria rigorosa. Cass. 21953/2007 – Stesso principio originario. Cass. 26473/2024 – Esempio di caso in cui socio perde: conferma validità presunzione in mancanza di prove contrarie (socio amministratore considerato aver percepito utili occulti) . Cass. 5529/2025 – V. supra: ridimensiona portata doppia presunzione, implica che la presunzione di distribuzione va valutata caso per caso, specie dopo nuova normativa onere prova .
- Giurisprudenza di merito e prassi: Circolare AE n. 1/2008 (es.) – forniva linee guida su redditometro vecchio; Circ. AE n. 19/E 2012 – su studi di settore, valore indiziario e necessità contraddittorio; Circ. AE n. 9/E 2015 – recepisce Corte Cost. 225/2005: invita uffici a determinare costi presuntivi nelle indagini finanziarie (forfettariamente) . Sentenze di Commissioni Tributarie varie che recepiscono recente art. 7 co.5-bis, es. CTR Lombardia 2023 ha annullato accertamento studi di settore perché ufficio non ha fornito prova concreta a supporto di scostamenti (citando 7(5-bis)).
Nota: Le sentenze sopra citate possono essere invocate secondo la pertinenza del caso concreto, tenendo presente che la giurisprudenza tributaria è in continua evoluzione. Dal 2023-2024 si osserva un trend normativo-giurisprudenziale verso un maggiore equilibrio: viene richiesto al Fisco più rigore nel motivare e provare le proprie presunzioni, riconoscendo maggiormente i diritti del contribuente . Ciò non elimina l’uso delle presunzioni (strumento necessario di contrasto all’evasione), ma implica che il contribuente ben assistito ha oggi più possibilità di difesa rispetto al passato.
Hai ricevuto un avviso di accertamento basato su presunzioni o “indizi” di maggior reddito? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento basato su presunzioni o “indizi” di maggior reddito?
👉 Attenzione: l’accertamento presuntivo tributario è uno degli strumenti più usati (e spesso abusati) dall’Agenzia delle Entrate per contestare redditi non dichiarati o ricavi occulti.
In questa guida scoprirai cos’è un accertamento presuntivo, quando è legittimo, e soprattutto come difenderti in modo efficace per farlo annullare o ridimensionare.
💥 Cos’è l’Accertamento Presuntivo
L’accertamento presuntivo è un procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito o il volume d’affari di un contribuente sulla base di presunzioni, senza prove dirette.
Si basa su elementi indiziari che fanno “presumere” l’esistenza di redditi non dichiarati, come:
- movimenti bancari non giustificati;
- spese personali o aziendali sproporzionate ai redditi;
- margini di guadagno incoerenti con il settore;
- scostamenti dagli studi di settore o dagli indici ISA;
- rapporti economici con fornitori o clienti non dichiarati.
📌 In questi casi l’Agenzia non ha bisogno di prove certe, ma deve usare presunzioni gravi, precise e concordanti.
⚖️ Quando un Accertamento Presuntivo è Legittimo
Secondo la legge e la giurisprudenza, l’accertamento presuntivo è legittimo solo se:
- si fonda su fatti certi e verificabili;
- le presunzioni sono gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.);
- il contribuente è stato messo in condizione di difendersi nel contraddittorio;
- la motivazione spiega come si arriva al reddito presunto;
- le presunzioni non sono in contrasto con i dati contabili reali.
📌 Se l’Agenzia usa presunzioni vaghe o contraddittorie, l’atto può essere annullato dal giudice tributario.
💠 Tipologie di Accertamento Presuntivo
🔹 Accertamento Analitico-Induttivo
Si applica quando la contabilità è formalmente regolare, ma emergono incongruenze o anomalie (art. 39, DPR 600/73).
Esempio: ricavi troppo bassi rispetto ai costi, margini irrealistici, prelievi o versamenti bancari non giustificati.
🔹 Accertamento Induttivo Puro
Si usa quando la contabilità è inesistente, inattendibile o omessa.
L’Agenzia può stimare i redditi anche solo in base a elementi esterni (movimenti bancari, spese, tenore di vita).
🔹 Accertamento Sintetico (Redditometro)
Riguarda le persone fisiche e si basa sulle spese e sul tenore di vita del contribuente.
È una forma particolare di accertamento presuntivo “per consumi”.
📌 In tutti i casi, il contribuente può e deve dimostrare la reale provenienza delle somme e la non imponibilità dei redditi contestati.
⚠️ Le Conseguenze di un Accertamento Presuntivo
Se non impugnato, un accertamento presuntivo comporta:
- 💰 Recupero di imposte (IRPEF, IVA, IRAP) e sanzioni fino al 240%;
- 📈 Interessi di mora su tutte le somme accertate;
- ⚖️ Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale;
- 🏦 Pignoramento del conto, fermo o ipoteca;
- 🚫 Segnalazione alla banca dati per rischio fiscale.
📌 Ma se le presunzioni sono infondate o contraddittorie, l’intero accertamento può essere annullato per difetto di motivazione.
🧩 Le Strategie di Difesa Possibili
1️⃣ Contestare la Mancanza dei Requisiti delle Presunzioni
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
Se sono generiche o basate su semplici sospetti, l’atto è illegittimo.
📌 Esempio: non basta un “versamento bancario sospetto” senza prova che sia reddito imponibile.
2️⃣ Dimostrare la Provenienza delle Somme
Puoi provare che le somme accertate derivano da:
- risparmi personali o familiari;
- donazioni o prestiti;
- rimborsi, indennità o disinvestimenti;
- operazioni fuori campo IVA o non imponibili.
📌 L’onere della prova passa al contribuente, ma documenti e tracciabilità possono ribaltare l’accertamento.
3️⃣ Eccepire la Mancanza di Contraddittorio
Se l’Agenzia non ti ha convocato prima di emettere l’avviso, l’atto è nullo per violazione del diritto di difesa (art. 12, comma 7, L. 212/2000).
4️⃣ Impugnare l’Avviso di Accertamento
Puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo:
- sospensione immediata della riscossione;
- annullamento totale o parziale dell’accertamento;
- condanna dell’Agenzia alle spese.
📌 Nei casi urgenti, la sospensione può essere concessa in 48 ore.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Copia dell’avviso di accertamento;
- Estratti conto bancari contestati;
- Documenti che provano l’origine delle somme (prestiti, disinvestimenti, ecc.);
- Dichiarazioni dei redditi e bilanci;
- Comunicazioni e verbali dell’Agenzia o della Guardia di Finanza.
📌 Questi elementi sono fondamentali per smontare le presunzioni e ricostruire la reale situazione fiscale.
⏱️ Tempi della Procedura
- Accesso agli atti o contraddittorio: 30–60 giorni;
- Ricorso tributario: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: anche in 48 ore;
- Sentenza: da 6 a 12 mesi circa.
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può riscuotere né avviare pignoramenti.
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✅ Annullamento dell’accertamento presuntivo.
✅ Riduzione drastica delle somme accertate.
✅ Blocco della riscossione e dei pignoramenti.
✅ Tutela completa del conto e del patrimonio.
✅ Assistenza tecnica in ogni grado di giudizio.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare l’avviso di accertamento.
❌ Rispondere senza documenti o prove tracciabili.
❌ Confondere presunzioni con prove certe.
❌ Agire fuori termine o senza assistenza legale.
📌 Ricorda: la presunzione è solo un’ipotesi, non una prova. Con una difesa solida, può essere facilmente ribaltata.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza le presunzioni utilizzate e verifica la legittimità dell’accertamento.
📌 Ti assiste nel contraddittorio e nell’accesso agli atti fiscali.
✍️ Redige e deposita ricorsi fondati su prove concrete e giurisprudenza aggiornata.
⚖️ Ti rappresenta davanti alle Corti di Giustizia Tributarie in ogni grado.
🔁 Ti segue fino alla sospensione o all’annullamento definitivo dell’atto.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e contenzioso fiscale.
✔️ Specializzato in difesa contro accertamenti presuntivi e induttivi.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di imprese, professionisti e privati contro l’Agenzia delle Entrate.
Conclusione
Un accertamento presuntivo tributario può sembrare fondato, ma spesso si basa su ipotesi fragili o dati parziali.
Con la giusta difesa legale puoi contestare le presunzioni, bloccare la riscossione e ottenere l’annullamento dell’atto.
⏱️ Ricorda: hai solo 60 giorni dalla notifica per impugnare l’accertamento.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro l’accertamento presuntivo può partire oggi stesso.