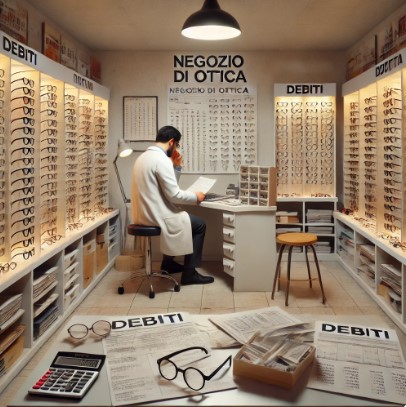Gestisci un negozio di ottica o un centro specializzato nella vendita di occhiali e lenti a contatto e ti trovi in difficoltà economica a causa di debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche? È una condizione sempre più frequente nel settore ottico, dove l’aumento dei costi di gestione, la concorrenza dei grandi franchising e la pressione fiscale mettono in crisi molti professionisti indipendenti. Quando si accumulano cartelle esattoriali, rate non pagate o contributi arretrati, il rischio di pignoramenti e blocchi dell’attività è concreto. La buona notizia è che la legge prevede soluzioni legali efficaci per gestire, rateizzare o cancellare i debiti, proteggendo la tua attività e il tuo patrimonio personale.
Perché molti negozi di ottica si indebitano
Le spese per gestire un negozio di ottica sono molto elevate: affitto dei locali, tasse, contributi, forniture di lenti e montature, attrezzature di laboratorio e costi di marketing. A queste si aggiungono i ritardi nei pagamenti da parte dei clienti e la difficoltà di competere con grandi catene o negozi online. I margini di guadagno si sono ridotti e molti titolari, per far fronte alle spese, posticipano i pagamenti fiscali o bancari, accumulando sanzioni e interessi che nel tempo diventano difficili da sostenere.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Quando le imposte o i contributi non vengono versati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono attivare rapidamente procedure di recupero. Tra queste figurano la notifica di cartelle esattoriali, i pignoramenti dei conti correnti o degli incassi POS, i fermi amministrativi sui veicoli aziendali, le ipoteche sugli immobili e i sequestri dei crediti verso clienti o assicurazioni sanitarie. Gli importi aumentano rapidamente per effetto di interessi e sanzioni, aggravando la situazione finanziaria. Se la tua è una ditta individuale o una società di persone, rispondi personalmente dei debiti, rischiando anche i beni familiari.
Cosa fare subito se il tuo negozio di ottica ha debiti
Il primo passo è avere un quadro completo della tua posizione debitoria. Richiedi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo aggiornato per conoscere importi, annualità e creditori coinvolti. Poi verifica la validità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica o somme prescritte che un avvocato può impugnare. Se i debiti sono legittimi, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo nel frattempo le azioni di riscossione. È anche utile verificare se è disponibile una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o ipoteche, puoi ottenere la sospensione immediata delle procedure presentando un ricorso o un’istanza di autotutela.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Quando il debito è diventato troppo alto o la tua attività non riesce più a sostenere i costi, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È una procedura legale pensata per piccole imprese, artigiani e lavoratori autonomi che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residui (esdebitazione). È uno strumento riconosciuto dai tribunali italiani e rappresenta una via concreta per salvare l’attività o chiuderla in modo ordinato, senza lasciare pendenze fiscali o bancarie.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molti negozi di ottica hanno anche debiti con banche o fornitori di lenti, montature e strumenti ottici. In questi casi puoi chiedere la rinegoziazione dei finanziamenti, la sospensione temporanea delle rate o proporre un saldo e stralcio per chiudere le posizioni a un importo ridotto. È anche possibile contestare clausole abusive o tassi usurari nei contratti e impugnare decreti ingiuntivi o pignoramenti entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nelle trattative con banche e creditori, proteggendo i beni aziendali e garantendo la continuità della tua attività commerciale.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Una strategia legale tempestiva ti consente di sospendere pignoramenti e riscossioni, ottenere la rateizzazione o cancellazione dei debiti, proteggere la casa e i beni personali, mantenere il negozio aperto e ristrutturare la posizione finanziaria. In molti casi è possibile salvare l’attività e ricominciare con una gestione più solida e sostenibile.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto cartelle o intimazioni di pagamento, se i debiti fiscali o bancari sono diventati insostenibili o se rischi il blocco dei conti o la chiusura del negozio. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa può bloccare la riscossione, contestare le cartelle illegittime e guidarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire in tempo è fondamentale per salvare la tua attività e tutelare il tuo futuro professionale.
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, blocchi dei conti e sequestro dei beni. Intervenire subito è l’unico modo per salvare il tuo negozio di ottica e proteggere il tuo patrimonio personale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle attività commerciali e professionali – spiega cosa fare se gestisci un negozio di ottica con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che mettono a rischio la tua attività di ottica?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Molti negozi di ottica – tipicamente piccole imprese a conduzione familiare o società di dimensioni ridotte – possono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento a causa di una combinazione di fattori: calo delle vendite dovuto alla concorrenza (ad esempio delle vendite online), investimenti iniziali elevati per l’acquisto di attrezzature e stock di montature/lenti, costi fissi significativi (affitti di locali commerciali in zone centrali, personale specializzato) e imprevisti economici generali (crisi di liquidità, ritardi nei pagamenti da parte di enti convenzionati, ecc.). Quando i debiti si accumulano – verso il Fisco, l’INPS, le banche, i fornitori o altri soggetti – il titolare di un negozio di ottica deve muoversi con tempestività per difendere il proprio patrimonio ed evitare conseguenze irreparabili.
A partire dagli anni 2010, l’ordinamento italiano ha introdotto e poi riformato profondamente gli strumenti per la gestione delle crisi da debiti anche per i piccoli imprenditori commerciali (come i dettaglianti di ottica) non assoggettabili alle procedure fallimentari tradizionali. In particolare, con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019, CCII), pienamente in vigore dal 15 luglio 2022, sono state ridisegnate le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento già previste dalla Legge 3/2012 . Al settembre 2025 il quadro normativo offre a un debitore “meritevole” (cioè onesto e collaborativo) la possibilità di ristrutturare o liquidare i debiti salvaguardando in parte il proprio patrimonio essenziale e, in certi casi, di ottenere l’esdebitazione (cancellazione delle pendenze residue) .
In questa guida analizzeremo, dal punto di vista del debitore (titolare o legale rappresentante del negozio di ottica indebitato), come affrontare le principali categorie di debito (fiscale, previdenziale, bancario, commerciale, ecc.), quali sono le conseguenze legali del mancato pagamento e quali strumenti di difesa e soluzione possono essere attivati. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto sia a imprenditori e privati. Troverete anche tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte che riassume i punti chiave. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo sono riportate per esteso in fondo alla guida.
1. Panorama normativo e principi generali
1.1 Fonti legislative principali
Per comprendere i diritti e gli obblighi di un imprenditore indebitato e le possibili soluzioni legali, è utile richiamare le principali fonti normative italiane in materia di debiti d’impresa e insolvenza:
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.lgs. 14/2019) – Entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022, rappresenta la disciplina organica aggiornata delle procedure concorsuali e di sovraindebitamento . Ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, introducendo nuove terminologie (ad es. liquidazione giudiziale al posto di fallimento) e procedure come il concordato minore e la liquidazione controllata dedicate ai debitori “minori” non soggetti al fallimento . Il Codice è stato oggetto di modifiche successive, tra cui il D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e, di recente, il D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 che ha ulteriormente perfezionato le norme (semplificando le procedure e potenziando le tutele per i debitori in buona fede, anche in attuazione della Direttiva UE 2019/1023) .
- Legge 3/2012 (composizione delle crisi da sovraindebitamento) – È la legge che per prima, nel 2012, ha introdotto in Italia procedure per liberare dai debiti i soggetti “non fallibili” (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori). Molti concetti della Legge 3/2012 (ad es. la figura dell’Organismo di Composizione della Crisi, la nozione di debitore meritevole, ecc.) sono confluiti nel nuovo Codice della Crisi . Anche se la legge 3/2012 è stata abrogata e sostituita dal CCII, la giurisprudenza formatasi su di essa rimane un riferimento interpretativo utile .
- Codice Civile, in particolare le disposizioni su obbligazioni e garanzie – Il Codice Civile (artt. 2740–2741 c.c. in primis) stabilisce che ogni debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (obbligazione patrimoniale universale). Fanno eccezione solo i beni dichiarati impignorabili o le limitazioni di responsabilità previste per certe forme giuridiche (es. soci di S.r.l. per i debiti sociali) . Il Codice Civile disciplina inoltre il contratto di transazione (art. 1965 c.c.), rilevante per eventuali accordi stragiudiziali con i creditori (vedi §2.2), e le cause di responsabilità civile verso creditori e terzi (ad es. l’azione di responsabilità contro amministratori di società che aggravino il dissesto).
- Leggi tributarie e previdenziali – Comprendono il DPR 602/1973 (riscossione coattiva delle imposte), il DPR 600/1973 (accertamento tributi), il D.lgs. 46/1999 (riscossione tramite ruolo dei crediti pubblici), il D.lgs. 241/1997 (versamenti unificati e compensazioni), la Legge 335/1995 (contributi pensionistici obbligatori) e altre norme speciali. Queste leggi regolano le cartelle esattoriali, le sanzioni e interessi per omessi pagamenti, le possibilità di rateizzazione e i provvedimenti occasionali di condono o definizione agevolata dei debiti (come le cosiddette rottamazioni delle cartelle esattoriali introdotte dalle leggi di bilancio) .
- Norme penali tributarie e fallimentari – In sottofondo, bisogna ricordare che alcuni comportamenti del debitore insolvente integrano reati. Ad esempio, la sottrazione fraudolenta di beni al Fisco per evitare il pagamento dei debiti è punita dall’art. 11 D.lgs. 74/2000; il mancato versamento di IVA per importi superiori a €250.000 per periodo d’imposta costituisce reato tributario (art. 10-ter D.lgs. 74/2000) così come l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre €10.000 annui (art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983) . Inoltre, in caso di dissesto di società, determinate condotte possono configurare reati di bancarotta (ad es. distrazione di beni, preferenze illegittime date a taluni creditori, ecc.). Questi profili penali saranno accennati in seguito (§2.5) giacché influenzano le strategie difensive (il debitore deve evitare di incorrere in violazioni penali mentre gestisce la crisi).
1.2 Definizione di sovraindebitamento e finalità delle procedure
Il termine sovraindebitamento indica la condizione in cui una persona o impresa non è più in grado di far fronte regolarmente ai propri debiti con il patrimonio disponibile. Il Codice della Crisi lo definisce come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la significativa e prevedibile incapacità di adempiere regolarmente” ai propri obblighi finanziari (art. 2, co.1, lett. c CCII) .
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (o procedure di regolazione della crisi secondo la terminologia del CCII) hanno la finalità di consentire al debitore meritevole di:
- Risanare o regolare i debiti secondo un piano sostenibile, soddisfacendo i creditori in misura congrua rispetto alle proprie possibilità;
- Preservare una vita dignitosa e, se possibile, la continuità della propria attività imprenditoriale o professionale;
- Ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non pagati, una volta concluso il percorso, così da poter ripartire senza il “fardello” delle vecchie insolvenze.
Il concetto di meritevolezza è centrale: significa che il debitore deve aver mantenuto un comportamento onesto e collaborativo, senza frodi o colpe gravi nella formazione del debito. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’esdebitazione non può essere negata soltanto perché nel piano è previsto un pagamento minimale ai creditori; ciò che conta è l’atteggiamento corretto e trasparente del debitore nel gestire la crisi . In altre parole, anche se i creditori recuperano poco (in termini percentuali) attraverso la procedura, al debitore meritevole deve essere concessa la cancellazione del debito residuo, purché abbia messo a disposizione tutto il possibile in base alle sue capacità .
Di contro, i casi di abuso o dolo vengono sanzionati con la revoca dei benefici: ad esempio, se si scopre che il debitore ha nascosto attivi o ha aumentato i debiti con colpa grave, il tribunale può negare o revocare l’omologazione del piano o l’esdebitazione. Su questo aspetto la giurisprudenza recente è molto attenta. In un caso del Tribunale di Bergamo (2025) relativo a un imprenditore indebitato, il giudice ha osservato che anche le eventuali negligenze delle banche nel concedere credito (cioè aver fatto prestiti imprudenti) possono essere considerate nel valutare la meritevolezza del debitore, ma non bastano da sole a giustificare la cancellazione del debito: l’esdebitazione resta un beneficio personale del debitore onesto, che non si estende ad eventuali coobbligati o garanti del debitore stesso . Ciò significa, ad esempio, che se il titolare del negozio ha un fideiussore o coobbligato (come un familiare che ha garantito un prestito), la sua esdebitazione non libera il garante dall’obbligo verso il creditore, a meno che anche il garante acceda a sua volta a una procedura di sovraindebitamento.
1.3 Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono rivolte a tutti i debitori civili che non rientrano nell’ambito delle procedure concorsuali maggiori (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, amministrazione straordinaria). In pratica possono accedervi :
- Persone fisiche “consumatrici”, ossia non imprenditori, con debiti personali contratti per scopi estranei ad attività professionale o d’impresa. (Esempio: un privato che abbia accumulato debiti da carte di credito, finanziarie, bollette, ecc.) In questo caso la procedura tipica è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”).
- Imprenditori minori e professionisti, compresi i titolari di ditte individuali commerciali o artigiane, le società di persone e le società tra professionisti (STP), purché non superino le soglie dimensionali previste dall’art. 2 CCII che farebbero scattare l’assoggettabilità a liquidazione giudiziale . Questi debitori “non consumatori” possono accedere alle procedure di concordato minore o di liquidazione controllata (vedi §2.3), ma non al piano del consumatore.
- Società di capitali sotto-soglia e imprese agricole: anche le S.r.l., S.p.A. o cooperative che, per dimensioni, non superano i parametri di legge possono utilizzare il concordato minore o la liquidazione controllata . Le imprese agricole, escluse dal fallimento per legge, rientrano anche loro tra i debitori “non fallibili” e quindi accedono a queste procedure semplificate.
Le soglie dimensionali attualmente in vigore (art. 2 CCII) identificano come “piccolo” l’imprenditore che, nei tre esercizi antecedenti la procedura, non abbia superato contemporaneamente almeno due dei seguenti parametri: attivo di bilancio €300.000, ricavi €200.000, debiti €500.000. In altri termini, se il negozio di ottica ha volumi inferiori a tali limiti, sarà considerato imprenditore minore; se li supera in modo significativo, sarà soggetto alle procedure concorsuali ordinarie (liquidazione giudiziale, concordato preventivo). Ad ogni modo, nella pratica molti negozi di ottica rientrano per dimensione nella categoria dei non fallibili, specie se ditte individuali o piccole società.
✧ Nota: La distinzione tra consumatore e debitore non consumatore è fondamentale. Solo il consumatore (debitore persona fisica con debiti personali) può presentare il piano del consumatore che non richiede il voto dei creditori ed è omologato dal giudice se soddisfa i requisiti di legge . L’imprenditore invece deve ricorrere al concordato minore, che richiede l’approvazione dei creditori (a maggioranza dei crediti) o, in alternativa, alla liquidazione controllata qualora non vi sia un piano fattibile . Ad esempio, il titolare di un negozio di ottica con debiti di natura commerciale non potrà aggirare i creditori proponendo un piano senza voto: dovrà affrontare il giudizio dei creditori (o liquidare i beni sotto controllo del tribunale). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che possa qualificarsi “consumatore” chi, pur persona fisica, abbia agito come imprenditore o abbia garantito debiti di società commerciali: in un caso, la Cassazione ha negato lo status di consumatore a un soggetto che era stato amministratore e fideiussore di una società, dovendo questi accedere semmai alle procedure da imprenditore .
1.4 Forma giuridica dell’attività di ottica e responsabilità patrimoniale
La forma giuridica sotto cui è esercitata l’attività di vendita di articoli ottici incide molto sul regime di responsabilità per i debiti contratti e sulle strategie difensive disponibili. Un negozio di ottica può essere gestito in proprio dal titolare (impresa individuale) oppure tramite una società; ciascun modello comporta differenti estensioni di responsabilità, come sintetizzato nella seguente tabella:
| Forma giuridica | Caratteristiche | Responsabilità per i debiti |
|---|---|---|
| Ditta individuale (impresa commerciale a titolo personale) | L’ottico opera con partita IVA personale, senza separazione tra patrimonio aziendale e personale. Molto comune per piccoli negozi indipendenti. | Illimitata: il titolare risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dei debiti dell’attività (art. 2740 c.c.) . Non c’è distinzione tra debiti “aziendali” e “personali”: ad esempio, un debito fiscale o verso un fornitore del negozio può portare a pignorare anche il conto corrente personale o l’auto privata del titolare. |
| Società di persone (S.n.c. o S.a.s.) | Due o più soci gestiscono l’attività in forma societaria senza autonoma personalità giuridica. La S.n.c. prevede responsabilità solidale di tutti i soci; la S.a.s. distingue tra soci accomandatari (illimitatamente responsabili) e accomandanti (limitati al conferimento). | Illimitata (per almeno alcuni soci): nei confronti dei creditori sociali, i soci della S.n.c. rispondono solidalmente e senza limiti con il loro patrimonio personale; nella S.a.s., i soci accomandatari rispondono come sopra, mentre gli accomandanti sono limitati alla quota conferita (ma perdono la limitazione se ingeriscono nell’amministrazione). I creditori possono aggredire sia i beni sociali sia (previa escussione del patrimonio sociale) i beni personali dei soci illimitatamente responsabili . |
| Società a responsabilità limitata (S.r.l.) | La forma più comune per attività commerciali strutturate. Ha personalità giuridica e patrimonio separato. Può essere unipersonale (un solo socio) o con più soci. Richiede il rispetto di obblighi contabili e patrimoniali (capitale minimo, bilanci). | Limitata al capitale conferito, in linea di principio: per i debiti sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio. I soci non rischiano i beni personali, tuttavia: (a) spesso le banche o fornitori esigono fideiussioni personali dai soci/amministratori, che li rendono garanti personali del debito ; (b) gli amministratori possono essere responsabili con il proprio patrimonio se violano i doveri gestionali causando danni (azione di responsabilità); (c) in caso di insolvenza, la società può essere soggetta a liquidazione giudiziale (ex fallimento) se supera le soglie. In sintesi, la S.r.l. protegge i soci passivi, ma non protegge il socio garante né l’amministratore colpevole di mala gestio . |
| Società di capitali maggiori (S.p.A., S.a.p.a.) | Raramente utilizzate per singoli negozi, se non in caso di catene. Struttura complessa con ampia separazione tra soci (azionisti) e gestione. | Limitata al patrimonio sociale per gli azionisti. Gli amministratori possono avere responsabilità per gestione scorretta. La S.a.p.a. (società in accomandita per azioni) ha accomandatari illimitatamente responsabili, ma è caso raro nel commercio al dettaglio. |
🔍 Implicazioni pratiche: La forma giuridica incide anche sulle procedure attivabili. Le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) e le STP che rispettano i limiti dimensionali sono considerate “debitrici non assoggettabili a liquidazione giudiziale” e possono accedere al concordato minore; se però l’attività non è più proseguibile in continuità, si dovrà optare per la liquidazione controllata . L’imprenditore individuale (ditta individuale) o il socio illimitatamente responsabile di società di persone, oltre al concordato minore e alla liquidazione controllata, può in alcuni casi accedere anche alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente (si veda §2.3), prevista per le persone fisiche senza beni sufficienti a soddisfare i creditori .
Infine, è importante sottolineare che la scelta di operare tramite società di per sé non evita le azioni esecutive sui beni personali, soprattutto se il titolare ha fornito garanzie personali. Ad esempio, se un negozio di ottica è gestito da una S.r.l. ma il socio ha firmato una fideiussione bancaria per il fido di cassa, in caso di insolvenza della società la banca potrà escutere direttamente il socio garante senza dover attendere i tempi della procedura concorsuale . Vedremo più avanti come difendersi in simili situazioni (ad es. contestando le fideiussioni eventualmente nulle o rinegoziando il debito con la banca).
1.5 Tipologie di debito comuni per un negozio di ottica
Un negozio di ottica può accumulare diversi tipi di debiti, ciascuno con caratteristiche proprie sia quanto a cause sia quanto a conseguenze legali. Analizziamo le categorie più frequenti:
- Debiti fiscali: includono le imposte dovute allo Stato o agli enti locali. Tipicamente per un piccolo negozio si tratta di IRPEF sul reddito individuale del titolare (o IRES se società), relative addizionali regionali/comunali, IRAP (tassa regionale sulle attività produttive), IVA sugli incassi e tributi comunali come la tassa rifiuti sull’esercizio commerciale. L’omesso o insufficiente versamento di imposte porta, in genere, all’iscrizione a ruolo dei relativi importi e alla notifica di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) . Se il debito permane insoluto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) può attivare varie misure cautelari ed esecutive senza bisogno di autorizzazione giudiziaria: ad esempio il fermo amministrativo sui veicoli aziendali o personali, l’ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore (ad es. sulla casa o su un fondo commerciale) e il pignoramento di beni o crediti (conti correnti, pignoramento presso terzi, ecc.) . Inoltre l’Agente della Riscossione invia spesso avvisi come l’intimazione di pagamento (ingiunzione a saldare entro 5 giorni) preludio all’esecuzione forzata. Strumenti di tutela: per i debiti fiscali esistono varie possibilità: (i) richiedere una rateizzazione amministrativa del debito; (ii) aderire, se previste dalla legge, a misure di definizione agevolata (es. rottamazione delle cartelle, che consente di pagare solo l’imposta senza sanzioni né interessi) ; (iii) presentare ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria se il debito deriva da un accertamento fiscale ritenuto errato o illegittimo, ottenendo in tal caso la sospensione della riscossione; (iv) includere il debito fiscale in un eventuale piano di ristrutturazione o concordato minore (oggi è ammesso anche il stralcio parziale dell’IVA e di altri tributi all’interno di tali procedure, purché l’Erario riceva almeno quanto otterrebbe in una liquidazione ). Nota: In passato l’IVA doveva essere pagata integralmente nei concordati, ma a seguito della Direttiva UE 2019/1023 e della riforma 2022 è stato chiarito che anche l’IVA può essere falcidiata, a condizione del rispetto del trattamento non deteriore (ossia che allo Stato sia offerto almeno l’equivalente del realizzo in caso di fallimento) . Infine, va ricordato che lo Stato negli ultimi anni ha introdotto frequenti misure di sollievo per i debiti fiscali: ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti affidati all’Agenzia Riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a €1.000, nonché la rottamazione-quater per cartelle dal 2000 al 2017 con pagamento del solo capitale e interesse ridotto. Un negoziante indebitato deve quindi sempre verificare se possa beneficiare di qualche condono fiscale o sanatoria in vigore al momento .
- Debiti contributivi e previdenziali: includono i contributi obbligatori dovuti agli enti previdenziali. Per un negozio di ottica le principali posizioni sono: (i) INPS commerciale per il titolare (gestione commercianti, obbligatoria per chi esercita attività di commercio al dettaglio); (ii) INPS dipendenti (contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o parasubordinati impiegati in negozio, commessi, ottici, etc.); (iii) eventuali Casse di previdenza professionali se l’ottico è anche optometrista iscritto a un albo professionale (in genere però la figura di ottico non ha una cassa separata come i medici, quindi questo caso è raro). L’omesso versamento dei contributi genera interessi di mora e sanzioni, e il credito viene normalmente affidato all’Agente della Riscossione tramite avviso di addebito immediatamente esecutivo, equiparato a una cartella esattoriale. Segue la medesima trafila esecutiva: ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi, salvo che il debitore non regolarizzi tramite domanda di rateizzazione o aderisca a eventuali rottamazioni/sanatorie (ad esempio, spesso le rottamazioni fiscali includono anche i contributi INPS) . Occorre evidenziare che per i contributi previdenziali vige un termine di prescrizione quinquennale: trascorsi 5 anni dalla scadenza senza atti interruttivi validi, il debito contributivo si estingue . La Cassazione ha confermato nel 2021 che la mancata impugnazione di una cartella INPS non “allunga” la prescrizione a 10 anni: il termine resta 5 anni, poiché la cartella è un atto amministrativo, non un giudicato . Ciò significa che il titolare del negozio deve sempre controllare le notifiche e gli atti ricevuti: se l’INPS o l’Agenzia Riscossione non hanno sollecitato un vecchio debito per oltre 5 anni, potrebbe essersi prescritto e può opporsi al pagamento per decorso del termine. In caso di crisi grave, anche i debiti contributivi possono essere ridotti in sede di procedure concorsuali minori: un concordato minore o un piano del consumatore (se il debitore è un ex imprenditore cessato e qualificabile consumatore) può prevedere il pagamento parziale dei contributi, fermo restando che resta intoccabile l’eventuale parte di contributi già trattenuti ai lavoratori (che sono assimilati a ritenute non versate). In estrema ipotesi, la liquidazione controllata può azzerare i debiti contributivi non soddisfatti, con esdebitazione finale del debitore . Attenzione: Sul piano penale, il mancato versamento di contributi previdenziali dovuti per i dipendenti oltre la soglia di €10.000 annui costituisce reato (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983) , anche se il reato si estingue se si paga integralmente quanto dovuto entro il termine di legge (attualmente entro 3 mesi dalla contestazione). Pertanto, se il vostro negozio ha dipendenti e avete omesso dei contributi significativi, è prioritario valutare il pagamento almeno fino a sotto tale soglia per evitare conseguenze penali.
- Debiti bancari e finanziari: riguardano i rapporti di credito con banche o altri finanziatori. Un negozio di ottica spesso accede a finanziamenti per avviare o sostenere l’attività, ad esempio: un mutuo ipotecario per l’acquisto o ristrutturazione del locale; un leasing per macchinari (es. strumenti di misurazione della vista, mole per lenti); un affidamento in conto corrente o fido di cassa per integrare la liquidità; contratti di finanziamento a breve termine per l’acquisto di stock di occhiali; oppure l’utilizzo di carte di credito aziendali o scoperti. Se l’impresa entra in difficoltà e non ripaga regolarmente le rate o gli interessi, la banca potrà in primo luogo revocare gli affidamenti (ad esempio chiudere il fido e richiedere l’immediato rientro) e segnalare l’inadempimento nelle banche dati (Centrale Rischi di Bankitalia), peggiorando l’accesso al credito . Successivamente, per recuperare il dovuto la banca può agire in via giudiziale: spesso il contratto di mutuo o di fido prevede la decadenza dal beneficio del termine e consente di ottenere un decreto ingiuntivo immediato per l’intero importo residuo. Se il credito è garantito da ipoteca, la banca potrà promuovere un’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato (ad esempio, se avete dato in garanzia la vostra casa o il locale commerciale di proprietà, quel bene può essere messo all’asta) . Se il credito è garantito da fideiussione personale di un socio o di un terzo, la banca potrà escutere direttamente il garante sul suo patrimonio personale . Se non ci sono garanzie reali o personali, la banca rimane un creditore chirografario e dovrà agire come un normale creditore: decreto ingiuntivo e, dopo 40 giorni, pignoramenti (conti, beni mobili, crediti verso terzi). Strumenti di tutela: in caso di debito bancario, una via preferibile è la negoziazione con l’istituto prima che si arrivi al contenzioso (vedi anche §2.2). Le banche spesso sono disponibili a rinegoziare i piani di rientro (ad esempio concedendo una moratoria di alcuni mesi, un allungamento del piano di ammortamento, o trasformando lo scoperto in un mutuo rateale) soprattutto se il debitore offre delle garanzie aggiuntive o coinvolge un Organismo di composizione della crisi. Se il debito è già in sofferenza, si può proporre un saldo e stralcio (pagamento parziale a definizione totale) magari con l’intervento di un terzo investitore. Nel contesto delle procedure di sovraindebitamento, i debiti bancari possono essere ristrutturati: ad esempio in un concordato minore si potrebbe prevedere di pagare una percentuale del dovuto, salvo che la banca abbia ipoteca (in tal caso è un creditore privilegiato e va soddisfatto almeno per il valore di realizzo del bene). È importante verificare anche la presenza di eventuali irregolarità nei contratti bancari (tassi usurari, anatocismo, clausole invalide): in certi casi contestare queste voci in giudizio può ridurre l’importo dovuto o quantomeno guadagnare tempo. Da ultimo, ricordiamo che un mutuo non pagato con ipoteca su un immobile destinato ad abitazione del debitore, se si apre una procedura concorsuale, vede la banca come creditore privilegiato: se il piano di concordato o liquidazione non soddisfa integralmente la quota garantita, la banca può escutere l’ipoteca separatamente, salvo accordi diversi. È quindi cruciale, nelle strategie di risanamento, gestire con attenzione i crediti bancari garantiti.
- Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali: riguardano le fatture non pagate per l’acquisto di beni e servizi necessari all’attività. Un negozio di ottica acquista tipicamente le montature, le lenti oftalmiche, liquidi e accessori da fornitori all’ingrosso (spesso con pagamento a 30-60-90 giorni), oltre a servizi professionali (es. commercialista, manutenzione macchinari) e utenze aziendali (luce, acqua, ecc.). Se la crisi di liquidità porta a ritardi nei pagamenti, il rischio immediato è di compromettere i rapporti con i fornitori stessi (i quali potrebbero sospendere ulteriori forniture o pretendere pagamento anticipato). Inoltre, i fornitori insoluti possono attivarsi legalmente: nella maggior parte dei casi, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, il fornitore può ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo basato sulle fatture non pagate, che diventa esecutivo in 40 giorni se il negoziante non paga né propone opposizione . Decorso tale termine, il creditore potrà procedere a pignorare i beni aziendali (ad esempio l’arredo, l’attrezzatura o il magazzino del negozio) oppure i conti correnti aziendali. In mancanza di beni intestati all’azienda, se il debitore è una ditta individuale o un socio illimitatamente responsabile, i fornitori potranno colpire i beni personali (casa, auto, ecc., compatibilmente con le norme sulla impignorabilità della prima casa di cui diremo più avanti). Strumenti di tutela: se non vi sono contestazioni reali sul credito (merce consegnata e fattura corretta), fare opposizione al decreto ingiuntivo serve solo a guadagnare qualche mese di tempo – e, come osservato nella sezione FAQ, un’opposizione pretestuosa è sconsigliabile perché genera ulteriori spese legali . È più produttivo negoziare col fornitore un accordo transattivo: ad esempio offrendo un pagamento immediato parziale (es. il 30-50% del dovuto) e una rateazione sul residuo, in cambio della rinuncia alle azioni legali. Tale accordo transattivo è disciplinato dall’art. 1965 c.c. come contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono o pongono fine a una lite . Una volta perfezionato l’accordo e pagato quanto concordato, il debito originario si intende estinto per saldo e stralcio . Attenzione però: il condono di una parte del debito commerciale potrebbe comportare per l’azienda debitrice una sopravvenienza attiva tassabile (cioè un componente positivo di reddito) pari alla quota di debito cancellata , a meno che ciò avvenga all’interno di una procedura concorsuale giudiziale (nei concordati, infatti, le riduzioni di debito non sono imponibili ai fini fiscali, ex art. 88 co.4-ter TUIR). In ogni caso, l’accordo stragiudiziale va formalizzato per iscritto e condizionato al puntuale pagamento della parte concordata. Se la trattativa non è fattibile e il debito è ingente, i fornitori (essendo di norma creditori chirografari, cioè senza garanzie) potrebbero vedersi soddisfatti solo parzialmente in un’eventuale procedura di sovraindebitamento: nei concordati minori i crediti chirografari spesso vengono falcidiati (pagati in percentuale), mentre nella liquidazione controllata saranno pagati pro quota con ciò che residua dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati .
- Debiti verso il personale dipendente: se il negozio impiega dipendenti (commessi, ottici abilitati, ecc.), può maturare debiti per retribuzioni non corrisposte, per TFR (trattamento di fine rapporto) e ferie non godute o altri crediti di lavoro. Questi debiti hanno una disciplina particolare: innanzitutto il lavoratore ha diritto a ottenere un decreto ingiuntivo immediato per le somme risultanti dalle buste paga non pagate (che fanno piena prova) e a procedere al pignoramento, ad esempio del conto corrente aziendale, in tempi molto rapidi . Inoltre i crediti di lavoro dipendente godono di privilegio generale mobiliare sui beni mobili del datore (vengono soddisfatti con precedenza sui crediti chirografari) e, per gli ultimi 6 mesi di stipendio, di superprivilegio che li colloca addirittura prima dei crediti fiscali . Se l’azienda viene sottoposta a liquidazione concorsuale, i dipendenti hanno diritto di insinuarsi e vengono pagati in prededuzione/privilegio entro i limiti indicati. Inoltre, in caso di insolvenza conclamata dell’azienda, i lavoratori dipendenti possono accedere al Fondo di Garanzia INPS che anticipa loro il TFR maturato e le ultime mensilità impagate (fino a un massimale), surrogandosi poi allo stesso posto del lavoratore nella procedura concorsuale . Strumenti di tutela: il consiglio, per evitare tensioni e vertenze, è di comunicare tempestivamente con il personale in caso di ritardo nei pagamenti, eventualmente concordando piani di rientro (rate sui salari arretrati) se possibile. Dal punto di vista legale, i debiti verso dipendenti (salvo quelli per risarcimento danni da fatti illeciti, es. infortuni per colpa grave) possono essere inclusi nei piani di sovraindebitamento, ma data la loro natura privilegiata dovranno essere soddisfatti al 100% o in altissima percentuale, a meno che i lavoratori stessi acconsentano a una riduzione. Sul piano penale, ricordiamo che il mancato pagamento della retribuzione in sé non costituisce reato (configura un illecito amministrativo e civile), tuttavia: se tra le somme non pagate ci sono ritenute fiscali sulle buste paga (IRPEF trattenuta ai dipendenti) e l’omissione supera €150.000 annui, scatta il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.lgs. 74/2000) . Parimenti, il mancato versamento delle retenute previdenziali operate al dipendente oltre €10.000 annui costituisce reato (come già visto sopra). Inoltre, il protrarsi di mancati pagamenti ai dipendenti può comportare sanzioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Dunque, i debiti verso il personale vanno gestiti con priorità assoluta, sia per ragioni etiche sia per evitare ulteriori problemi legali.
- Altre passività e debiti vari: ulteriori potenziali debiti includono: canoni di locazione commerciale arretrati (il proprietario dei locali può agire con sfratto per morosità e decreto ingiuntivo per i canoni dovuti; inoltre la legge garantisce al locatore un privilegio sui beni mobili posti nei locali affittati, ex art. 2764 c.c.); utenze (bollette luce, gas, telefono non pagate, per cui però il rischio immediato è l’interruzione del servizio più che il recupero coattivo, anche se le società di utilities possono cedere il credito a società di recupero); debiti verso soci o familiari finanziatori (ad esempio anticipazioni di cassa fatte dal titolare stesso o dai parenti alla ditta in crisi, formalmente debiti della ditta verso di loro – attenzione che in caso di procedure concorsuali questi crediti dei soci vengono postergati, ossia soddisfatti dopo gli altri chirografari, salvo specifiche circostanze); debiti da risarcimenti danni o controversie legali (ad es. un cliente che cita il negozio per un occhiale difettoso che ha causato un danno, oppure un ex dipendente che vince una causa per licenziamento illegittimo con conseguente obbligo di indennizzo). In particolare, se derivano da fatti illeciti commessi con dolo o colpa grave, taluni debiti potrebbero non essere cancellabili con l’esdebitazione finale (l’art. 278 CCII esclude dall’esdebitazione, ad esempio, le obbligazioni derivanti da danni per fatto illecito extracontrattuale se commesso con dolo o colpa grave, nonché le multe e ammende e i debiti alimentari) . Dunque, se il vostro debito deriva da una condanna per un illecito intenzionale (es. una frode, oppure – ipotesi più rara per un ottico – sanzioni penali pecuniarie), esso resterà comunque a vostro carico anche dopo la procedura concorsuale.
1.6 Conseguenze del mancato pagamento: rischi e poteri dei creditori
La mancata soddisfazione dei debiti comporta per i creditori la facoltà di attivare vari strumenti di tutela e coercizione del pagamento. Riassumiamo i principali rischi legali a cui va incontro un negozio di ottica sovraindebitato se non prende provvedimenti:
1) Esecuzione forzata individuale (pignoramenti e altre misure): ogni creditore, munito di un titolo esecutivo (es. una cartella esattoriale definitiva, un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza, ecc.), può promuovere azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Nel concreto, i creditori possono colpire:
– Conti correnti e crediti verso terzi: il classico pignoramento presso terzi. Il creditore notifica un atto a una banca dove il negozio o il titolare ha il conto, bloccando le somme fino a concorrenza del credito dovuto. Oppure può notificare l’atto a un debitore del nostro debitore (ad esempio, se il negozio di ottica vanta crediti verso qualche convenzione sanitaria o cliente, cosa in verità poco comune nel commercio al dettaglio). Il pignoramento presso terzi è molto usato dal Fisco e dai fornitori: blocca immediatamente la liquidità aziendale e, se non ci si oppone, porta l’istituto bancario a versare le somme pignorate al creditore.
– Beni mobili e macchinari: un ufficiale giudiziario può accedere al negozio (o ai locali dove sono i beni del debitore) e procedere a pignoramento mobiliare, inventariando merci (montature, lenti) e attrezzature (computer, strumenti, arredamento) da vendere all’asta. Nella pratica, però, i pignoramenti mobiliari presso i locali dell’azienda sono meno frequenti, specie se i beni hanno modesto valore di realizzo. Esistono inoltre tutele: per legge alcuni beni sono impignorabili o relativamente pignorabili, ad esempio gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa del debitore. Ai sensi dell’art. 515 c.p.c., gli strumenti e oggetti necessari al lavoro dell’imprenditore individuale sono pignorabili solo per la parte eventualmente eccedente il minimo indispensabile e, comunque, nei limiti di 1/5 del loro valore complessivo . Quindi, un eventuale pignoramento nel negozio di ottica dovrebbe lasciare all’ottico gli strumenti base per continuare l’attività (per permettere la prosecuzione e quindi la possibilità di pagare i creditori): ad esempio, si potrà pignorare parte del magazzino di montature di ricambio di valore elevato, ma non tutti i macchinari essenziali per lavorare.
– Beni immobili: se il titolare possiede immobili (un negozio di proprietà, la casa, ecc.), un creditore con titolo può iscrivere ipoteca giudiziale e avviare un pignoramento immobiliare. Nel caso del Fisco, come visto, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca legale per debiti sopra €20.000 anche senza passare dal giudice . Tuttavia, importante, la legge protegge la prima casa del debitore dai pignoramenti fiscali: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere alla vendita forzata dell’unico immobile ad uso abitativo in cui il debitore risiede anagraficamente, purché non di lusso (categorie A/8, A/9 escluse) . Questa impignorabilità della prima casa vale solo per i crediti esattoriali; un fornitore o una banca invece – ottenuto un titolo esecutivo – potrebbe in teoria pignorare anche la prima casa (non esistendo divieti generali in sede civile), anche se nella pratica è evento raro per crediti di modesta entità, per via dei costi e tempi delle esecuzioni immobiliari. Oltre al vincolo della prima casa, la legge prevede che l’Agenzia delle Entrate non possa pignorare nessun immobile (prima o seconda casa) se il debito totale è inferiore a €120.000 . Sopra tale soglia, può pignorare gli ulteriori immobili (es. seconde case, locali commerciali, terreni) ma, come detto, non la prima casa se unica. I creditori privati invece non hanno soglie minime di importo per avviare un pignoramento immobiliare, anche se difficilmente procedono per somme ridotte.
- Veicoli: i veicoli (auto, furgoni) intestati al debitore sono aggredibili. L’Agente della Riscossione utilizza soprattutto il fermo amministrativo: iscrive un provvedimento al PRA che impedisce di utilizzare e vendere l’auto finché non si paga il debito . Trascorsi 30 giorni dal preavviso di fermo non adempiuto, il fermo è eseguito e l’auto non può circolare (pena sanzioni). Il fermo non estingue il debito (è una misura coercitiva) e non prevede vendita forzata, anche se in teoria, per crediti rilevanti, il Fisco potrebbe successivamente pignorare l’auto e farla vendere all’asta (casistica limitata). I creditori privati invece di norma pignorano direttamente l’auto tramite ufficiale giudiziario (pignoramento mobiliare di bene mobile registrato).
In generale, subire pignoramenti ha effetti gravi sulla continuatività aziendale: ad esempio, un pignoramento del conto corrente aziendale blocca le somme giacenti e impedisce al negozio di effettuare pagamenti (fornitori, dipendenti, utenze), paralizzando l’attività quotidiana . Un pignoramento dei macchinari può fermare la possibilità di fare visite optometriche o montare occhiali. È perciò essenziale, per il debitore, evitare di arrivare a questa fase o, se inevitabile, utilizzare gli strumenti legali per contenerne gli effetti (ricorsi in tribunale, conversione del pignoramento con rateazione, accordi transattivi in extremis, ecc.).
2) Procedura concorsuale (insolvenza conclamata): se l’indebitamento è molto elevato e diffuso, vi è il rischio che si arrivi all’apertura di una procedura concorsuale giudiziale che coinvolge tutti i creditori. Per i debitori non fallibili, ciò si traduce nella liquidazione controllata (vedi dopo §2.3); per quelli di maggiori dimensioni, nella liquidazione giudiziale (ex fallimento) o nel concordato preventivo. È importante chiarire che non esiste il “fallimento d’ufficio”: nessuno viene dichiarato fallito automaticamente per il solo fatto di avere debiti, serve sempre un’iniziativa: un creditore che presenta istanza di fallimento, oppure lo stesso imprenditore o il pubblico ministero in certi casi . Nel caso di un piccolo negozio sotto soglia, la legge esclude la liquidazione giudiziale; tuttavia i creditori potrebbero comunque agire con procedure esecutive individuali reiterate, oppure spingere per una liquidazione controllata. Se invece il negozio (ad es. una S.r.l. con più punti vendita) supera i limiti dimensionali, anche un singolo grande creditore impagato (la banca, il fisco, un fornitore rilevante) può presentare ricorso per la dichiarazione di insolvenza e l’apertura della liquidazione giudiziale . Le soglie di non fallibilità viste prima sono un’eccezione: se l’impresa è davvero piccola, in teoria non potrebbe essere dichiarata fallita; ma attenzione, perché la valutazione delle soglie può essere complessa e talora i creditori ci provano comunque. Dunque l’imprenditore deve tenere presente che, se non governa la crisi, qualcun altro potrebbe farlo al posto suo: il tribunale con i curatori/commissari. Le conseguenze di una procedura concorsuale sono molto impegnative: l’imprenditore perde in gran parte la disponibilità dell’azienda (nella liquidazione giudiziale c’è lo spossessamento in mano al curatore; nel concordato c’è un controllo stringente da parte del commissario e del giudice) . In liquidazione giudiziale l’obiettivo è liquidare tutti i beni per soddisfare i creditori, e l’imprenditore vede di fatto sottratta la propria impresa e i propri beni alla gestione personale . Anche nel migliore dei casi, un concordato preventivo, il titolare deve sottostare alle decisioni dei creditori (che votano il piano) e del tribunale che omologa, il tutto con costi procedurali non trascurabili. Per questo, una regola fondamentale della gestione del rischio di insolvenza è: agire prima che i creditori perdano la pazienza e che si arrivi a soluzioni giudiziali eterodirette. Ove possibile, meglio che sia l’imprenditore a prendere l’iniziativa (attivando volontariamente un concordato minore, o una composizione negoziata della crisi – vedi §2.3 – per trovare accordi) piuttosto che attendere passivamente di subire un fallimento richiesto da terzi .
3) Costi aggiuntivi, interessi e sanzioni: più a lungo si protrae lo stato di insolvenza, più i debiti tendono ad aumentare. Questo avviene per varie ragioni: gli interessi di mora sui debiti scaduti (specie quelli bancari e fiscali) sono spesso elevati; si accumulano sanzioni per omessi versamenti fiscali e contributivi; l’Agente di Riscossione aggiunge gli aggi esattoriali (oneri di riscossione) e le spese di notifica su ogni cartella e atto. Così un debito iniziale di €50.000 può lievitare, nel giro di pochi anni, anche del 30-50%. Ad esempio, sulle cartelle fiscali attualmente gli interessi di mora sono ~3,5% annuo e le sanzioni per omesso versamento vanno dal 15% al 30% dell’imposta . Anche sui contributi previdenziali maturano sanzioni civili. Il risultato è un circolo vizioso: il debito aumenta, rendendo ancora più difficile il pagamento e aggravando l’esposizione . Inoltre, scadendo i termini, certi illeciti da amministrativi possono divenire penali (es. il superamento delle soglie penali per IVA/contributi come detto). È dunque evidente l’importanza di fermare la crescita del debito: mediante accordi per congelare interessi, definizioni agevolate che eliminino sanzioni, o il blocco delle maturazioni con l’apertura di una procedura concorsuale (dal decreto di apertura del concordato o liquidazione, infatti, gli interessi sui debiti chirografari cessano di maturare). Nella sezione successiva vedremo come le rateizzazioni e le rottamazioni possano mitigare questo problema, riducendo sanzioni e interessi .
4) Reputazione e rapporti commerciali compromessi: un altro danno meno tangibile ma reale è la perdita di credibilità sul mercato. Se in piazza (o nei circuiti di credito) si diffonde la notizia che il vostro negozio “non paga”, i fornitori inizieranno a richiedere pagamento anticipato o rifiuteranno nuove forniture, tagliando il rifornimento di merce . Le banche, come già detto, possono revocare i fidi e segnalare la vostra posizione a centrale rischi, impedendovi di ottenere nuovi finanziamenti. I clienti stessi potrebbero perdere fiducia – ad esempio, temendo che l’attività chiuda e non garantisca più l’assistenza post-vendita su occhiali e lenti, alcuni potrebbero rivolgersi altrove. Inoltre, le informazioni negative come protesti (se ad esempio avete emesso assegni scoperti), pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti iscritti nei pubblici registri) e sentenze, diventano pubbliche e consultabili, rendendo più difficile trovare partner commerciali o investitori per un eventuale rilancio. Questo effetto reputazionale spesso anticipa l’irreversibilità della crisi: una volta isolata sul mercato, l’azienda entra in una spirale di impossibilità di risanarsi . Per questo motivo, è vitale affrontare i problemi di debito alla luce del sole con i partner: molti fornitori preferiscono trattare un piano di rientro ragionevole piuttosto che vedere fallire un cliente. Mantenere la comunicazione aperta e proporre soluzioni (anche temporanee) può salvaguardare i rapporti in vista di tempi migliori.
5) Responsabilità personali dell’imprenditore: infine, l’insolvenza può travolgere personalmente il titolare o gli amministratori sul piano giuridico. Abbiamo accennato alla responsabilità illimitata per i debiti d’impresa (per ditte individuali e soci di persone): ciò significa che, ad esempio, se un negozio di ottica individuale chiude con debiti insoluti, i creditori continueranno a perseguire l’ex titolare in quanto persona fisica. Ma vi sono anche altre responsabilità: in una società di capitali, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere se hanno aggravato il dissesto (si pensi all’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro gli amministratori colpevoli di aver procrastinato la crisi aumentando i debiti) . Addirittura, recenti riforme (D.lgs. 14/2019) impongono agli amministratori l’obbligo di adottare adeguati assetti aziendali e di attivarsi tempestivamente in caso di crisi: chi non lo fa e lascia lievitare i debiti può essere considerato responsabile verso i creditori per aggravamento del dissesto. Sul piano penale, come già evidenziato, l’imprenditore in dissesto rischia incriminazioni per reati fallimentari (se la sua impresa viene dichiarata insolvente e si riscontra, ad esempio, che ha distratto beni: bancarotta fraudolenta; o che ha pagato preferenzialmente un creditore a discapito di altri prima della procedura: bancarotta preferenziale; o che ha aggravato il crack: ricorso abusivo al credito, ecc.) e reati tributari se ha omesso di versare imposte dovute o ha commesso frodi fiscali . Questi profili esulano dallo scopo principale di questa guida, ma meritano menzione perché influenzano la strategia: un debitore avveduto, una volta in difficoltà, non deve peggiorare la propria posizione compiendo atti illegali (occultare incassi, distrarre merce, sottrarre beni alle garanzie, falsificare documenti contabili, ecc.), sperando magari di salvare il salvabile: così facendo rischierebbe di trasformare un problema economico in un problema penale. Al contrario, è opportuno operare con trasparenza, tutelandosi entro i margini leciti e pianificando con i consulenti le mosse migliori per la composizione della crisi. Come riconosciuto anche a livello normativo e UE, l’ordinamento oggi incoraggia l’imprenditore che affronta le difficoltà in modo tempestivo e ordinato, mentre punisce chi persevera in gestioni disfunzionali o tenta di frodare i creditori .
Riassumendo, ignorare i debiti e attendere passivamente è la scelta peggiore. Bisogna invece: conoscere i propri rischi (cosa può succedere e quando) e agire per tempo. Nel prossimo capitolo vedremo gli strumenti pratici a disposizione di un negozio di ottica indebitato per gestire o risolvere la situazione debitoria, dalle soluzioni stragiudiziali (rateizzazioni, accordi, ristrutturazioni “private”) alle procedure giudiziali di sovraindebitamento. Anticipare gli eventi consente spesso di evitare le conseguenze più gravi ed eventualmente ripartire dopo la crisi.
2. Soluzioni e strategie per gestire i debiti di un negozio di ottica
Dopo aver esaminato i problemi, passiamo alle soluzioni. Ci sono diversi livelli di intervento, che vanno dal piano stragiudiziale (accordi privati con i creditori, piani di rientro, ecc.) agli strumenti legali giudiziari veri e propri (procedure concorsuali minori, esdebitazione). Un approccio efficace spesso combina più strategie. Vediamole in ordine:
2.1 Valutazione iniziale e prevenzione (check-up dei debiti)
Il primo passo è fotografare la situazione debitoria e capire se vi siano rimedi “semplici” a portata di mano. È consigliabile rivolgersi a un professionista (commercialista o avvocato specializzato in crisi d’impresa) per fare un check-up completo dei debiti del negozio, verificando per ciascuno:
- Importo, natura e anzianità del debito: quali sono i debiti più urgenti? (Es. cartelle esattoriali già scadute da 60 giorni, decreti ingiuntivi non opposti in scadenza termine, rate di mutuo scadute da oltre 90 giorni che potrebbero portare alla revoca del fido, ecc.). Prioritizzare i debiti più sensibili consente di evitare le conseguenze immediate (pignoramenti imminenti, decadenze da benefici).
- Titoli esecutivi e stato delle procedure: per ogni posizione, verificare se il creditore ha già un titolo esecutivo (cartella, decreto ingiuntivo, sentenza) o se si è ancora nella fase bonaria/contrattuale. Ad esempio, se c’è un decreto ingiuntivo notificato, segnarsi la scadenza dei 40 giorni per l’eventuale opposizione o pagamento, per evitare che diventi definitivo . Se sono arrivate intimazioni di pagamento da Agenzia Riscossione, controllare i 5 giorni per la sospensione. Se c’è uno sfratto in corso, considerare i termini per saldare o rilasciare il locale. Sapere cosa sta per succedere è metà della difesa.
- Prescrizioni e vizi degli atti: un esame legale può rivelare che alcuni debiti sono inesigibili perché troppo vecchi o perché gli atti sono nulli. Ad esempio, come detto, molti debiti tributari e contributivi cadono in prescrizione breve (5 anni) se l’ente creditore non notifica atti interruttivi validi . Spesso accade che arrivino cartelle “dimenticate” per 6-7 anni e quindi contestabili. Oppure che alcune notifiche non siano state fatte correttamente (errori formali che rendono l’atto impugnabile). O ancora, il creditore potrebbe aver perso un termine di decadenza (es. l’Agenzia Entrate non può emettere cartelle IRPEF relative a un certo anno se è decorso il termine di legge). Impugnare in tempo questi atti con i vizi giusti può annullare o ridurre il debito e bloccare le azioni esecutive. Anche in sede civile: un eventuale decreto ingiuntivo si può opporre se, ad esempio, il fornitore ha addebitato merce mai consegnata o interessi non concordati, ecc. L’opposizione, se fondata, evita che il creditore proceda. Conclusione: non dare per scontato che “se c’è la cartella devo pagare”: farla esaminare da un esperto è doveroso. Ad esempio, la Cassazione del 2021 (sent. n.14690/2021) ha confermato che la cartella INPS non opposta non trasforma la prescrizione in 10 anni: se sono passati 5 anni senza ulteriori atti, quel debito è estinto . È un’eccezione che il debitore deve sollevare, altrimenti paga indebitamente. Lo stesso vale per molte cartelle esattoriali di tributi: in generale, oggi l’orientamento è verso la prescrizione quinquennale anche dei tributi dopo la notifica della cartella (fa eccezione l’IVA e pochi altri considerati decennali, ma su interessi e sanzioni la prescrizione è 5 anni) .
- Situazione patrimoniale attuale del negozio: elencare i beni e le risorse disponibili per eventualmente far fronte ai debiti. Ad esempio: quanto incasso medio mensile fa il negozio attualmente? Ci sono scorte di magazzino vendibili? Beni non strumentali cedibili (un secondo automezzo, attrezzature non indispensabili)? Ci sono proprietà immobiliari su cui si può attingere liquidità (vendita o ipoteca volontaria)? Familiari disposti ad aiutare finanziariamente? Questa analisi serve a capire quali leve attivare: se c’è ancora flusso di cassa positivo (il negozio è in crisi per i debiti pregressi ma è tornato in utile), forse conviene chiedere dilazioni per pagare col tempo; se invece l’attività è in perdita strutturale, forse va valutata la chiusura o la cessione, abbinata a una procedura di esdebitazione (fresh start).
- Eventuali profili penali incombenti: come già evidenziato, se il titolare intravede che sta commettendo fatti che potrebbero avere rilievo penale (omesso versamento IVA oltre soglia, ecc.), deve segnalarlo subito al suo consulente per prendere contromisure. Ad esempio, se il 2023 chiude con IVA non versata di €280.000, significa che a fine aprile 2024, se non riuscirà a pagare almeno €30.000 per scendere sotto €250.000, rischierà un procedimento penale (art. 10-ter) . Conoscendo ciò a priori, può decidere di destinare risorse prima di altre cose per abbattere l’IVA sotto soglia entro la scadenza. Analogamente per i contributi: se possibile, mantenere sempre i debiti contributivi sotto €10.000 annui per non sconfinare nel penale (nota: i €10.000 valgono per contributi trattenuti ai dipendenti; per i contributi propri, ometterli non è reato ma solo illecito amministrativo). Per le retribuzioni: mai trattenere dal dipendente contributi o ritenute senza versarli, oltre le soglie, come detto. Evitare inoltre qualsiasi tentativo di “far sparire” beni aziendali mentre si hanno cartelle esattoriali in sospeso: vendere macchinari sottoprezzo a un parente per non farli pignorare, ad esempio, può costituire reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000). Un’azione prudente e rispettosa della legge durante la crisi non solo preserva dalle sanzioni, ma in caso di successiva procedura concorsuale favorisce la meritevolezza (il giudice vedrà che il debitore non ha fatto il furbo e sarà più propenso a concedere l’esdebitazione).
In sintesi, la fase di analisi iniziale permette di individuare la strada da seguire: se il debito è affrontabile con qualche misura stragiudiziale (es. rateazioni fiscali, accordi con banche e fornitori) o se è necessario ricorrere a procedure giudiziali più drastiche. Non di rado, la strategia include più livelli: ad esempio, chiedere una rateizzazione delle cartelle per bloccare i pignoramenti nell’immediato, e contestualmente preparare un piano di concordato da presentare in tribunale per tagliare l’intero indebitamento in modo ordinato. L’importante è non isolarsi: coinvolgere i consulenti di fiducia e, se il caso, anche i creditori principali in colloqui franco-costruttivi. Nel prossimo paragrafo, ci focalizziamo sulle soluzioni stragiudiziali negoziate e sulle opportunità offerte dalla legge per alleggerire il carico (rateizzazioni, rottamazioni, ecc.).
2.2 Accordi stragiudiziali e negoziazione con i creditori
Prima di intraprendere un percorso giudiziario, è spesso opportuno tentare di negoziare direttamente con i creditori delle soluzioni di comune accordo. Le soluzioni stragiudiziali hanno il vantaggio di essere più rapide, flessibili e meno pubbliche rispetto a un fallimento o concordato. Ecco alcune delle principali modalità:
– Rateizzazioni e dilazioni di pagamento: quasi tutti i creditori preferiscono incassare gradualmente piuttosto che non incassare nulla. Se il problema del negozio di ottica è essenzialmente di liquidità temporanea, proporre un piano di rientro rateale ai creditori può risolvere la situazione. Ad esempio, contattare i fornitori non pagati e concordare che i €20.000 di fatture arretrate verranno saldati in 10 rate mensili da €2.000 ciascuna, magari contestualmente agli ordini correnti per non interrompere il rapporto. Spesso i fornitori applicheranno interessi di dilazione, ma moderati, pur di evitare spese legali. Per i debiti bancari, si può chiedere alla banca una moratoria (sospensione per 6-12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, pagando solo interessi) oppure una rischedulazione del debito (allungamento del piano per abbassare l’importo delle rate). Le banche italiane in passato (specie in occasione di crisi sistemiche, ad es. Covid-19) hanno aderito a protocolli ABI per la sospensione mutui alle PMI; oggi le moratorie automatiche sono cessate, ma la banca può valutare caso per caso. Nel caso di fidi di conto corrente: se la banca minaccia la revoca, si può cercare di negoziare un rientro scaglionato (ad es. rientro di 1/10 al mese per 10 mesi) invece della chiusura immediata. È fondamentale non aspettare l’ultimo giorno: contattare la banca appena emergono segnali di tensione. Spesso le banche apprezzano la proattività del cliente e, se intravedono possibilità di recupero, preferiscono concordare un piano piuttosto che avviare un contenzioso che potrebbe portare a perdita maggiore.
– Saldo e stralcio (transazione a saldo): quando appare chiaro che non si riuscirà a pagare l’intero debito, si può proporre al creditore di chiudere la posizione con un pagamento forfettario inferiore al totale, ma immediato e garantito. Questo approccio funziona se si riesce a reperire una somma immediata (es. un familiare vi presta dei soldi, oppure vendete un bene non essenziale). Ad esempio, se il negozio deve €50.000 a un fornitore e non ha liquidità per pagare, potrebbe offrire “€20.000 subito a saldo e chiusura completa del debito”. Molti creditori accettano, specialmente se temono che altrimenti incasseranno zero (magari perché il debitore minaccia il fallimento o la liquidazione). È sempre bene formalizzare il saldo e stralcio per iscritto, specificando che il pagamento parziale avviene in via transattiva e che, una volta corrisposta la somma, nulla più sarà dovuto (ottenere quietanza a saldo). Un rischio del saldo e stralcio, come già menzionato, è la possibile tassazione della quota stralciata come sopravvenienza attiva per il debitore : tuttavia, l’art. 88 del TUIR esenta da imposizione le riduzioni di debito concordate nell’ambito di procedure concorsuali omologate. Quindi, se temete una tassazione rilevante, valutate se inserire il saldo e stralcio dentro una transazione fiscale in un concordato o in un accordo di ristrutturazione (strumento riservato a imprese fallibili). In molti casi pratici comunque il fisco non colpisce piccole transazioni, ma la prudenza è d’obbligo.
– Interventi di terzi e garanzie aggiuntive: nella contrattazione privata col creditore potete spendere a vostro favore eventuali supporti terzi. Ad esempio, se un parente o socio è disposto a garantire il piano di rientro (fideiussione aggiuntiva) o a mettere un’ipoteca volontaria su un immobile a garanzia della dilazione, il creditore avrà più fiducia nell’accordo. Oppure, se un investitore è interessato a entrare in società e ad apportare capitali freschi per pagare i debiti, si può prospettare al creditore che accetti un stralcio perché tanto subentrerà un nuovo socio e bisogna “pulire” la situazione (queste sono dinamiche comuni nelle ristrutturazioni aziendali). Tutto ciò rientra nella libertà negoziale: qualsiasi intesa che soddisfi le parti e non sia contraria a norme imperative è ammessa.
– Stralcio di sanzioni e interessi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: per i debiti fiscali e contributivi, la legge offre strumenti di definizione agevolata che in sostanza sono accordi erga omnes stabiliti per legge. Ad esempio, la rottamazione delle cartelle (ultima in ordine di tempo, la “rottamazione-quater” del 2023) consente di pagare i ruoli esattoriali senza le sanzioni e senza gli interessi di mora, in forma rateale fino a 18 rate. Si tratta di un grande vantaggio economico: in media un debito rottamato viene ridotto del 30-50%. Se siete in tempo per aderire a una definizione agevolata (sono previste finestre temporali specifiche dalle normative), questa è di solito la strada preferibile per i debiti fiscali, perché bloccate immediatamente le azioni esecutive e sapete esattamente quanto dovrete pagare. Attenzione: bisogna presentare la domanda entro la scadenza prevista dalla legge e poi rispettare scrupolosamente le rate, pena la decadenza dai benefici. Altra misura “automatica” è lo stralcio dei mini-debiti: come accennato, la L. 197/2022 ha disposto la cancellazione automatica delle cartelle fino a €1.000 degli anni antecedenti il 2015, e talora i Comuni hanno deliberato stralci di interessi su tributi locali non pagati. È sempre bene informarsi presso l’Agenzia Riscossione o il proprio consulente sulle sanatorie vigenti.
– Rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi (strumento amministrativo): l’Agente della Riscossione consente al contribuente in difficoltà di rateizzare le somme iscritte a ruolo. Questa è una procedura non discrezionale: se rientrate nei requisiti, AdeR deve concedervi la dilazione. Attualmente (dopo le novità introdotte in attuazione del PNRR) esistono due regimi: la rateizzazione “ordinaria” e la rateizzazione “straordinaria”. In breve:
– Rateizzazione ordinaria: per debiti fino a €120.000 (importo per singola richiesta). Non è richiesto dimostrare lo stato di difficoltà (basta una semplice richiesta anche online). Fino al 2024 il piano poteva essere al massimo di 72 rate mensili (6 anni); dal 1° gennaio 2025, grazie al D.lgs. 110/2024, la durata massima è stata elevata a 84 rate (7 anni) per le richieste presentate nel biennio 2025-2026 . Tale massimale crescerà poi a 96 rate per richieste nel 2027-2028 e a 108 rate (9 anni) dal 2029 in poi . Ciò significa che un negoziante che nel 2025 chieda la dilazione di, ad esempio, €50.000 di cartelle, può ottenerla in max 84 rate mensili (7 anni) . Il tasso di interesse sulle rateazioni fiscali dal 2025 è stato ridotto al 2,5% annuo (era circa 4% fino al 2024) , rendendo la dilazione meno onerosa. Importante: se si rispetta il pagamento delle rate, l’Agenzia Entrate-Riscossione sospende ogni azione esecutiva: niente fermi, pignoramenti o ipoteche su quei debiti rateizzati. Inoltre, la richiesta di rateazione presentata prima che parta un pignoramento blocca l’esecuzione (tranne che per pignoramenti già compiuti, che però spesso possono essere liberati pagando le prime rate e facendo istanza).
– Rateizzazione straordinaria: per debiti oltre €120.000 o per contribuenti che, pur avendo debiti sotto 120k, necessitano di più rate del normale. In questo caso occorre provare una grave e comprovata difficoltà economica. Per le imprese, si forniscono i bilanci e si calcola un indice di sostenibilità finanziaria; per persone fisiche, si può produrre l’ISEE. Se la verifica dell’ente conferma la situazione di crisi, viene concesso un piano fino a 120 rate mensili (10 anni) . Anche qui, con la riforma 2024, la normativa prevede un incremento progressivo: ad esempio nel 2025-2026 potrebbero concedere inizialmente 85-90 rate e riservare le 120 rate piene ai casi gravissimi, ampliando nel 2027-28 la possibilità di 120 rate a più soggetti . La regola generale comunque è: sopra 120k di debito, la dilazione è sempre possibile fino a 10 anni, previa documentazione. Sotto 120k, se vuoi più rate di quante concesse ordinariamente (84 nel 2025-26), devi motivare con dati economici. In caso di accoglimento, il tasso è sempre 2,5% e valgono le stesse tutele (stop a esecuzioni).
– Decadenza e riammissione: attenzione che se si saltano 5 rate anche non consecutive si decade dalla dilazione (per le rateizzazioni concesse dal 2022 in poi; erano 10 rate per piani più vecchi). La decadenza fa tornare il debito immediatamente riscuotibile e impedisce di ottenere una nuova rateizzazione a meno che non si paghi tutto. Tuttavia, proprio a settembre 2023 è stata introdotta una facoltà di riammissione ai piani per chi era decaduto prima, pagando una piccola quota iniziale. Informatevi se siete decaduti: a volte normative transitorie consentono di riattivare il beneficio.
In pratica, la rateizzazione delle cartelle è uno strumento fondamentale per dare respiro al debitore fiscale . Nel nostro contesto, un negozio di ottica che abbia, ad esempio, €30.000 di debiti tra IVA e INPS, può ottenere senza troppe formalità un piano in 6-7 anni con rate sui €400 mensili, stoppando sul nascere qualunque azione esecutiva del Fisco. Questo permette di guadagnare tempo e pianificare meglio il risanamento. Si noti che anche le nuove cartelle in arrivo possono essere subito rateizzate: se ogni anno faticate a pagare, potreste decidere di rateizzare costantemente il carico fiscale corrente per diluirlo (ad esempio, le somme dichiarate a luglio con la dichiarazione dei redditi si possono rateizzare in 8-10 rate entro novembre). Utilizzare le dilazioni è preferibile al non pagare affatto: preserva dall’accumulo di sanzioni maggiori e tiene lontano l’esattore.
– Composizione negoziata della crisi d’impresa: una recente introduzione (D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021) è la composizione negoziata – procedura volontaria e riservata attivabile da qualsiasi imprenditore commerciale (anche piccolo) in stato di crisi o insolvenza reversibile. Consiste nella nomina, da parte della Camera di Commercio, di un esperto indipendente che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori un accordo stragiudiziale di ristrutturazione. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive (uno stay delle azioni esecutive, autorizzato dal tribunale) per condurre le trattative in tranquillità . Se le trattative riescono, si può concludere un contratto di risanamento con i creditori (che non ha gli effetti vincolanti erga omnes di un concordato, ma se ben orchestrato può risolvere la crisi). Se falliscono, l’imprenditore può ripiegare su una procedura concorsuale semplificata (come il concordato semplificato per cessione di beni, introdotto nel 2021). La composizione negoziata è quindi uno strumento ibrido: stragiudiziale ma sotto egida di un esperto terzo. Può essere utile per negoziare ad esempio con le banche una ristrutturazione del debito fuori dal tribunale, magari ottenendo nuova finanza per rilanciare il negozio. Va tuttavia detto che, ad oggi, la composizione negoziata è stata utilizzata principalmente da imprese medio-grandi; per un micro-negozio i costi di consulenza e la complessità potrebbero essere eccessivi, a meno che non vi siano molti creditori da mettere d’accordo.
Riassumendo la sezione stragiudiziale, il messaggio è: comunicare e contrattare. Nascondersi dai creditori porta solo ad azioni aggressive; instaurare un dialogo, magari con l’aiuto di un legale che tratti per voi, può portare a dilazioni, riduzioni o transazioni vantaggiose. Nella trattativa privata c’è ampia flessibilità: si può ad esempio concordare di restituire solo il capitale dovuto a un fornitore tagliando tutti gli interessi (cosa che in tribunale forse non otterreste se il fornitore vota contro). Oppure convincere la banca a rinunciare alla causa in cambio del coinvolgimento di un nuovo socio finanziatore. Ogni caso fa storia a sé, ma in generale molti creditori – soprattutto quelli commerciali che hanno interesse a mantenere il cliente – saranno disponibili a compromessi. L’importante è presentare piani credibili e concreti: se proponete una rateazione a un fornitore, assicuratevi di poterla rispettare; se offrite un saldo stralcio a fine mese, assicuratevi di avere quei soldi. L’affidabilità negoziale in questa fase è cruciale: bruciare un accordo stragiudiziale fallendo nel rispetto può rendere i creditori molto più ostili in seguito.
2.3 Procedure giudiziali di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata)
Se l’esposizione debitoria è tale da non poter essere risolta con meri accordi privati – ad esempio, se i debiti superano di gran lunga la capacità di rimborso, o se alcuni creditori (come l’Erario) non accettano transazioni extragiudiziali significative – occorre valutare le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi. Queste procedure offrono vantaggi importanti: il cram-down (ossia l’imposizione ai creditori dissenzienti di un accordo approvato a maggioranza o valutato equo dal giudice) e soprattutto la possibilità di una esdebitazione finale dei debiti non pagati . Di contro, sono processi formali, con tempi e costi, e richiedono l’intervento dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e del tribunale. Vediamo le tre opzioni principali applicabili al nostro caso:
• Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): è l’evoluzione del vecchio “piano del consumatore” della L.3/2012. Questa procedura, però, è riservata alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale . Dunque, non è utilizzabile per risolvere direttamente i debiti di un’attività commerciale in esercizio. Potrebbe venire in rilievo solo in una situazione particolare: se il titolare del negozio di ottica ha chiuso l’attività (cancellandosi come impresa) e vuole gestire i residui debiti personali come consumatore oppure se parte dei suoi debiti non riguardano l’attività (es. debiti personali, finanziamenti al consumo intestati a lui come privato). In tal caso, egli può presentare un piano del consumatore al tribunale della sua residenza, con l’assistenza di un OCC, offrendo di pagare una certa quota dei debiti (in base al suo reddito/patrimonio) ed eventualmente chiedendo l’esdebitazione del resto. Il grande vantaggio del piano del consumatore è che non richiede l’approvazione dei creditori: è sufficiente l’omologazione del giudice, il quale valuta fattibilità e meritevolezza . Ciò permette, se il giudice è convinto della buona fede del debitore e della correttezza del piano, di imporlo anche a creditori contrari. Tuttavia, va ribadito che se i debiti sono principalmente d’impresa e l’attività prosegue, il piano del consumatore non è la via appropriata – il soggetto è un imprenditore e come tale deve utilizzare il concordato minore. Un eventuale escamotage in passato era chiudere la partita IVA e attendere un anno per perdere la qualifica imprenditoriale e poi presentarsi come consumatore, ma oggi i tribunali sono molto attenti a queste manovre e potrebbero dichiarare inammissibile il piano se ritengono che i debiti fossero d’impresa. Dunque, nel contesto “negozio di ottica”, il piano del consumatore sarà applicabile solo se il negozio ha già cessato l’attività e il debitore non intende più proseguire come imprenditore. In tal caso, il piano può includere tutti i debiti personali (compresi quelli fiscali e contributivi legati alla ex-attività) e prevede la figura del Gestore della crisi nominato dall’OCC che aiuta a predisporre la proposta. Se omologato, il piano vincola tutti i creditori. Durante la pendenza della domanda, il debitore può chiedere la sospensione delle azioni esecutive in corso. Al termine dell’esecuzione del piano (ovvero dopo aver pagato la percentuale proposta ai creditori con le risorse promesse) ottiene l’esdebitazione del residuo. Questa soluzione è quindi l’equivalente di un “mini-concordato” su misura della persona fisica consumatore.
• Concordato minore (artt. 74-83 CCII): è lo strumento introdotto dal CCII per i debitori non fallibili che svolgono attività d’impresa o professionale (imprenditori “minori”, professionisti, start-up innovative fuori da fallimento, ecc.) . In sostanza, è l’omologo del concordato preventivo per le piccole realtà. Nel nostro caso, il titolare di un negozio di ottica in attività, oppure la società di gestione del negozio, potranno presentare al tribunale un concordato minore. Questo consiste in una proposta di accordo ai creditori che può assumere diverse forme: pagamento parziale dei debiti in un certo periodo, eventualmente con suddivisione in classi e trattamenti differenziati, possibilità di continuare a gestire l’azienda durante e dopo la procedura (concordato in continuità) oppure cessione/liquidazione di tutti i beni (concordato liquidatorio). Vediamo i punti salienti:
– Presupposti: deve sussistere uno stato di crisi o insolvenza del debitore non consumatore. Il debitore propone il concordato minore con ricorso al tribunale competente, allegando un piano dettagliato e la documentazione contabile, oltre a una relazione redatta da un OCC (gestore) che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano . Ad esempio, l’ottico potrebbe proporre: “Pago il 40% dei debiti chirografari in 5 anni, integralmente i privilegiati, continuando a gestire il negozio i cui utili futuri finanzieranno il piano, con apporto di €10.000 da parte di un familiare”. Il gestore dovrà attestare che il 40% offerto ai chirografari è non inferiore a ciò che essi otterrebbero dalla liquidazione dell’attività (principio del best interest of creditors) e che il piano è realistico.
– Voto dei creditori: diversamente dal piano del consumatore, qui i creditori votano. Viene convocata un’adunanza e i creditori ammessi al voto (tutti i chirografari e gli eventuali privilegiati che subiscono qualche trattamento nel piano) esprimono il loro assenso o dissenso. Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto perché il concordato sia approvato . Se ci sono classi, serve la maggioranza in valore e il voto favorevole della maggioranza delle classi (o il tribunale può imporlo con cram-down se la classe dissenziente non è trattata peggio delle altre) . Nel concordato minore è obbligatorio suddividere in classi i creditori garantiti da fideiussioni di terzi (es. la banca con fideiussione del socio va in una classe separata). Questo perché il legislatore vuole tutelare anche i garanti: la deliberazione di quella classe avrà effetti particolari sui coobbligati.
– Possibilità di continuità aziendale: il concordato minore può essere in continuità o liquidatorio. Se l’ottico intende proseguire l’attività, il piano deve dimostrare che la soddisfazione offerta ai creditori è non inferiore a quella ottenibile liquidando tutto (quindi che ha senso continuare). Se invece chiude l’attività, il concordato minore liquidatorio richiede un apporto di risorse esterne “significative” . Questo è un punto importante: non è ammesso un concordato liquidatorio che paghi poco senza nessun sacrificio da parte del debitore o di terzi. Ad esempio, se l’ottico propone di liquidare tutto e pagare solo il 5% ai chirografari, il tribunale vorrà vedere che egli apporta magari denaro di famiglia o la vendita volontaria di un bene personale per innalzare quella percentuale – altrimenti sarebbe più appropriata la liquidazione controllata. Ad esempio, Tribunale di Reggio Emilia 2024: ha rigettato un concordato minore proposto da un ex amministratore perché offriva solo il 7% ai creditori chirografari senza alcuna risorsa aggiuntiva, giudicandolo non meritevole . Il giudice ha sottolineato che nei concordati minori liquidatori l’intervento di terzi (soci, familiari) è spesso indispensabile per raggiungere un esito equo .
– Effetti dell’omologazione: una volta approvato dai creditori e omologato dal tribunale, il concordato minore diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti . Il debitore deve poi eseguire il piano sotto la vigilanza di un liquidatore/attestatore nominato (spesso lo stesso OCC). Al termine, se il debitore adempie correttamente, ha diritto all’esdebitazione per i debiti concorsuali residui . Ovvero, dopo aver pagato quanto promesso (es. quel 40% in 5 anni dell’esempio), il restante 60% gli viene cancellato dal tribunale. L’esdebitazione nel concordato minore scatta dopo l’esecuzione integrale del piano (diversamente dalla liquidazione controllata, dove può arrivare subito dopo la chiusura). Va notato che l’esdebitazione non libera gli eventuali garanti (come i fideiussori) né tocca i debiti esclusi per legge (multe, debiti per dolo, alimenti) .
Proceduralmente, il concordato minore richiede solitamente qualche mese per l’ammissione e l’organizzazione del voto, e poi l’omologa. Durante questo periodo, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive per sospendere le azioni esecutive dei creditori (anche qui, come nella comp. negoziata, è previsto uno stay temporaneo). Dunque è un mezzo per congelare i pignoramenti e guadagnare tempo negoziale con la forza della legge. È essenziale presentare la domanda prima che la situazione degeneri troppo (ad es. prima di subire un fallimento o di veder pignorati tutti i conti, perché poi sarebbe arduo proseguire l’attività per rispettare un eventuale piano). In conclusione, il concordato minore è uno strumento potente che consente al negozio di ottica indebitato di ristrutturare i debiti in modo vincolante, pagando solo una parte secondo le possibilità. Il contraltare è la necessità di convincere la maggioranza dei creditori e di sottoporsi al controllo del tribunale e di un OCC. Ma rispetto alla liquidazione, consente di salvare l’attività (se c’è prospettiva di redditività futura) oppure di chiuderla in modo ordinato con un accordo sui debiti.
• Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): rappresenta la soluzione ultima quando non è possibile né un piano del consumatore né un concordato minore fattibile. Equivale concettualmente al “fallimento” per i soggetti non fallibili. Si tratta di mettere a disposizione tutto il patrimonio del debitore, liquidarlo sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale (di solito un professionista gestore della crisi), e distribuire il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione . Al termine, se il debitore è persona fisica, può chiedere l’esdebitazione per essere liberato dai debiti residui non soddisfatti . La liquidazione controllata si apre su ricorso del debitore (o anche di un creditore o del P.M. in alcuni casi limite) e richiede sostanzialmente gli stessi presupposti di un fallimento: insolvenza. La differenza è che qui siamo in ambito “non fallibili”, quindi è uno strumento pensato per dare anche al piccolo imprenditore una via d’uscita ordinata dalla crisi, pur comportando la perdita del patrimonio.
Effetti e procedura: con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il tribunale: nomina un Giudice Delegato e un Liquidatore (che tipicamente sarà l’OCC designato) ; dispone il blocco delle azioni esecutive individuali (tutti i creditori devono concorrere nella procedura); e ordina al debitore di consegnare i beni e le scritture contabili al liquidatore. Il liquidatore avvia la formazione dell’inventario e dello stato passivo (l’elenco dei crediti ammessi) . I creditori vengono avvisati e presentano domanda di ammissione al passivo entro un termine (non meno di 90 giorni) . Dopodiché si verificano i crediti, si stabiliscono quali sono privilegiati, quali chirografari, ecc., anche tramite eventuali contestazioni decise dal giudice delegato. Una volta formato lo stato passivo, il liquidatore procede a realizzare i beni: può proseguire o sciogliere i contratti pendenti (es. decidere se continuare la locazione del negozio per vendere l’avviamento, o scioglierla) ; può vendere i beni mobili e immobili (di solito con procedure competitive simili alle aste fallimentari, ma con maggiore snellezza possibile). La legge, anche qui, prevede alcune tutele: ad esempio, se certi beni sono indispensabili per la vita dignitosa del debitore e della sua famiglia, il giudice può escluderli dalla liquidazione (in analogia a quanto accadeva nella L.3/2012 col cosiddetto piano del consumatore di salvaguardia della prima casa, ora abrogato, ma di fatto il principio di conservare i beni essenziali è stato recepito in parte) . In particolare, la prima casa del debitore persona fisica sovraindebitato oggi gode di maggior protezione: se vendendola i creditori ricaverebbero ben poco e ciò comprometterebbe eccessivamente la vita del debitore, i giudici cercano soluzioni (ad es. consentire al debitore di tenerla pagando ai creditori l’equivalente del suo valore di mercato in più anni). All’esito delle vendite, il liquidatore predispone un piano di riparto delle somme: paga prima i creditori con privilegio (es. dipendenti, fisco per la parte privilegiata), poi, se avanza qualcosa, i chirografari in percentuale. Il tribunale emette decreto di chiusura approvando il riparto .
Esdebitazione e debitore incapiente: dopo la chiusura, se il debitore è una persona fisica, egli può ottenere l’esdebitazione di tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti (tranne poche eccezioni come i debiti alimentari, multe e obblighi di risarcimento per dolo). L’esdebitazione viene concessa dal tribunale con decreto, valutata la condotta del debitore (che non deve aver ostacolato la procedura, ad esempio). In alternativa, se il debitore non possedeva alcun patrimonio significativo sin dall’inizio, il CCII prevede una speciale procedura abbreviata detta esdebitazione del debitore incapiente . Questo istituto consente al debitore persona fisica privo di beni e che non sia in grado di offrire niente ai creditori, di chiedere comunque la cancellazione dei debiti in cambio di una piccola somma simbolica (se riesce a versarla) e della dimostrazione di avere tenuto un comportamento diligente e meritevole . È una sorta di “fresh start puro” per chi è nullatenente e senza reddito, per non condannarlo a debiti impagabili a vita. Nel contesto del nostro negozio di ottica, questa figura potrebbe applicarsi – poniamo – se il titolare ha chiuso il negozio, venduto all’asta coattivamente tutto, e rimane disoccupato senza beni: allora può chiedere l’esdebitazione da incapiente per liberarsi degli eventuali debiti residui (viene concessa una sola volta nella vita).
Differenze dal fallimento: la liquidazione controllata assomiglia molto, come iter, a un piccolo fallimento. Tuttavia ha alcune differenze di spirito: è pensata per essere più rapida e semplificata, c’è meno formalità nelle vendite (il liquidatore ha poteri più elastici), e c’è maggiore attenzione al profilo umano del debitore. Ad esempio, come detto, la prima casa e gli strumenti di lavoro possono in alcuni casi essere esclusi in tutto o in parte per garantire la “sopravvivenza” del debitore . Inoltre, l’esdebitazione è quasi automatica se non ci sono abusi (nel fallimento era più limitata e solo a fine procedura su domanda). Lo scopo della liquidazione controllata è sì soddisfare i creditori, ma anche dare una via d’uscita al debitore sfortunato. Non a caso si chiama “controllata” e non giudiziale, a indicare che c’è un controllo ma è la sua procedura.
Quando conviene la liquidazione controllata? Se il negozio è ormai decotto, i debiti superano ampiamente i beni, e non vi è speranza di accordo né volontà/possibilità di proseguire l’attività, la liquidazione può essere la scelta giusta: chiude formalmente la vicenda, fa sì che tutti i creditori siano trattati equamente secondo la legge (senza cause individuali sparse), e dopo qualche tempo consente al debitore di ripartire senza debiti. Ad esempio, un ottico che abbia accumulato €300.000 di debiti e possiede solo la casa di abitazione e un negozietto in affitto può dire: “mi arrendo, e chiedo la liquidazione”. Il liquidatore cercherà di pagare i creditori magari vendendo qualche bene accessorio (ma la casa se è prima casa probabilmente non sarà toccata se non ci sono ipoteche, grazie alla legge), e poi lui otterrà l’esdebitazione di ciò che non sarà pagato. Certo, questo significa per lui perdere tutto l’eventuale patrimonio eccetto quello essenziale, ma se è già in mano ai creditori di fatto, la procedura porta ordine e fine alla vicenda entro qualche anno, anziché trascinarsi per decenni con pignoramenti infruttuosi.
Considerazione finale sulle procedure: la scelta tra concordato minore e liquidazione controllata spesso dipende dalla sostenibilità di un piano di ristrutturazione. Se c’è ancora un core business valido (il negozio ha clientela e può generare reddito se alleggerito dai debiti), allora conviene tentare il concordato minore in continuità, magari offrendo ai creditori una percentuale decente e tenendo aperta l’attività. Se invece il modello di business non regge o il mercato locale è compromesso (ad es. troppa concorrenza, costi fissi non comprimibili), allora sacrificare tutto in liquidazione ed eventualmente ripartire ex novo in altra forma può essere sensato. Un bravo consulente vi aiuterà a simulare gli scenari: “Se tengo aperto e faccio concordato, pago il 30% in 5 anni e poi torno libero con il negozio salvo”; “Se liquido, vendo le attrezzature e chiudo, i creditori prendono il 10% ma io mi libero in 1 anno e posso magari aprire un’attività altrove da zero”. Queste valutazioni strategiche sono delicate e vanno personalizzate.
2.4 Chiusura dell’attività e conseguenze sui debiti
Un tema frequente per i piccoli imprenditori indebitati è: “E se chiudo bottega? I debiti spariscono?”. La risposta, in generale, è no: la chiusura dell’attività commerciale (cessazione della partita IVA, cancellazione dal Registro Imprese) non estingue automaticamente i debiti. I debiti permangono in capo al soggetto giuridico che li aveva contratti, sia esso la persona fisica titolare o la società, e i creditori potranno ancora agire.
Vediamo caso per caso:
- Ditta individuale: la chiusura della partita IVA equivale a cessare l’attività, ma il titolare rimane debitore personalmente di tutti i debiti accumulati. Egli rimane tale fino a quando i debiti non sono pagati o prescritti o esdebitati tramite procedure. Quindi, se un ottico individuale chiude il negozio sperando di “far perdere le tracce”, in realtà i creditori (banche, fisco, fornitori) potranno comunque continuare il recupero sul suo patrimonio personale (pignorare stipendio futuro se si impiega come dipendente altrove, pignorare casa, ecc.). Certo, la cessazione dell’attività potrebbe ridurre l’attenzione di alcuni creditori (un fornitore che vede che l’attività è cessata potrebbe mettere il debito a perdita se di modesta entità); ma i crediti maggiori (es. Agenzia Entrate, banca) resteranno e verranno perseguiti.
- Società di persone (S.n.c./S.a.s.): la chiusura avviene mediante liquidazione e cancellazione della società dal Registro Imprese. Ma attenzione: i creditori sociali, se non soddisfatti nella liquidazione, possono rivolgersi ai soci illimitatamente responsabili anche dopo la cancellazione, senza limiti di tempo (salvo prescrizione dei singoli crediti). I soci accomandanti rispondono solo se hanno avuto somme in liquidazione che avrebbero dovuto essere destinate ai creditori. In pratica, chiudere una S.n.c. lasciando debiti insoddisfatti è inutile ai fini dell’integrale liberazione: i creditori continueranno contro i soci personalmente. Quindi la mossa corretta, se si liquida una S.n.c., è eventualmente concordare coi creditori un saldo prima della cancellazione, oppure passare per una procedura concorsuale di sovraindebitamento (anche le società di persone possono adire concordato minore/liquidazione controllata prima della cancellazione).
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): qui la situazione differisce. Se si liquida volontariamente una S.r.l. e la si cancella ma restano debiti non pagati, questi in linea di principio si estinguono con la società stessa, poiché la società cessa di esistere. I creditori insoddisfatti possono però entro 1 anno dalla cancellazione chiedere la revoca della cancellazione se scoprono attività non liquidate, oppure possono tentare di far valere la responsabilità dei liquidatori (se hanno mal distribuito l’attivo) o dei soci (ma i soci rispondono solo entro il limite di quanto hanno ricevuto in sede di distribuzione finale del patrimonio sociale) . Inoltre, spesso come già detto i creditori forti (banche) dispongono di fideiussioni personali dei soci o amministratori: quelle restano valide a prescindere dalla chiusura della società. In sintesi, chiudere una S.r.l. con debiti impagati può “spegnere” formalmente i debiti della società, ma lascerà i garanti esposti e rischia di far sorgere cause di responsabilità se la liquidazione non ha rispettato l’ordine dei pagamenti. In genere, se una S.r.l. è insolvente, sarebbe opportuno seguire un iter concorsuale (concordato preventivo, se dimensioni grandi, o concordato minore/liquidazione controllata se piccola) invece di una liquidazione volontaria disordinata, per evitare accuse di aver chiuso per frodare i creditori.
Cosa comporta “chiudere e riaprire altrove”? Alcuni pensano di chiudere la società o ditta indebitata e aprire una nuova attività pulita a nome di un prestanome o di un familiare. Questa pratica però è rischiosa: i creditori potrebbero sostenere che si tratta di una continuità aziendale e cercare di dimostrare che la nuova impresa è una mera prosecuzione della vecchia, aggredendo comunque beni e fatturato (ad es. se la nuova ditta occupa lo stesso locale, stesso nome, stesso titolare di fatto). In alcuni casi il Fisco ha strumenti per recuperare i crediti anche sui successori dell’azienda (ad es. l’art. 14 D.lgs. 472/97 sulla responsabilità d’azienda per imposte se viene ceduta l’azienda senza aver pagato). Quindi tentare di sfuggire ai debiti spostando l’attività è una strategia borderline e può configurare perfino reati (bancarotta prefallimentare, sottrazione fraudolenta). Molto meglio è affrontare i debiti a viso aperto: se l’attività nuova è valida, la si può eventualmente costituire in forma nuova ma trattando prima i debiti passati con un accordo (anche parziale) o una procedura concorsuale che li definisca.
Chiusura e accesso alle procedure: talvolta, chiudere l’attività può essere condizione per accedere a certe procedure. Ad esempio, come abbiamo detto, solo dopo la cessazione si può provare a qualificarsi come consumatore e fare un piano del consumatore (anche se la Cassazione sta stringendo su questo escamotage). Oppure può essere necessario cessare per avviare la liquidazione controllata. In pratica: se decidete di liquidare il negozio, fatelo preferibilmente all’interno di una procedura concorsuale (concordato o liquidazione controllata). Chiudere fuori da procedure è pericoloso perché poi i creditori possono tentare azioni spossessatorie o istanze tardive.
Considerate la continuità parziale: prima di gettare la spugna e chiudere del tutto, valutate se l’attività possa essere snellita o ridimensionata per tornare sostenibile. Ad esempio, se il negozio ha due sedi, chiuderne una per tagliare costi e concentrare risorse sull’altra; se ha troppi dipendenti rispetto al calo di vendite, valutare ammortizzatori sociali o riduzione organico; se l’affitto è troppo caro, provare a rinegoziarlo con il proprietario minacciando altrimenti la disdetta (spesso accettano una riduzione pur di non perdere l’inquilino commerciale). Ogni euro risparmiato è un euro che può andare ai creditori per evitare la chiusura totale. Le procedure concorsuali come il concordato minore permettono anche di risolvere contratti onerosi: ad esempio, il tribunale può autorizzare lo scioglimento di contratti di locazione o fornitura non più sostenibili, pagando solo un indennizzo minimo, liberando il debitore da quell’obbligo e magari consentendogli di trasferirsi in un locale meno caro . Quindi chiudere sì, ma forse non tutto: a volte si può salvare una parte del business.
In conclusione, chiudere l’attività di per sé non tutela dal recupero dei debiti, ma può essere un passo all’interno di una strategia di regolazione della crisi. Se l’attività non è più economicamente valida, è onesto e saggio cessarla per non creare nuovi debiti (stop the bleeding) e concentrare le energie sul come smaltire quelli esistenti e/o ripartire in altra forma. L’importante è farlo legalmente e strategicamente: una cessazione nell’alveo delle soluzioni offerte dalla legge (concordato, liquidazione controllata, accordi transattivi) è il modo corretto per “spegnere” i debiti residui senza lasciare strascichi.
2.5 Aspetti fiscali e penali connessi alle soluzioni adottate
Ogni scelta di gestione dei debiti ha anche conseguenze fiscali e penali che vanno tenute presenti, per evitare sorprese.
Profilo fiscale delle riduzioni di debito: se riuscite a ottenere dai creditori uno sconto sul dovuto (sia in via privata sia per effetto di procedure concorsuali), dovrete considerare il trattamento fiscale di questa remissione. In linea generale, secondo l’art. 88 TUIR, la rinuncia o riduzione di un debito comporta per il debitore una sopravvenienza attiva tassabile pari all’importo condonato . Tuttavia, la norma esenta espressamente le sopravvenienze derivanti da procedure concorsuali omologate (fallimenti, concordati, accordi di ristrutturazione omologati) e da accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con tutti i creditori. Ciò significa che se, ad esempio, in un concordato minore vi viene cancellato il 70% dei debiti, quella parte non sarà tassata. Viceversa, se ottenete uno stralcio informale di €50.000 su un debito bancario, l’Agenzia Entrate potrebbe considerarli un ricavo straordinario tassabile nell’anno in cui l’accordo ha effetto . Per le imprese in contabilità semplificata può esserci margine interpretativo (spesso non si registra affatto la sopravvenienza attiva se è concomitante alla cessazione, sostenendo che non c’è continuazione d’impresa), ma è materia delicata. Il consiglio è di farsi seguire da un commercialista nel contabilizzare correttamente ogni accordo di remissione di debito. In alcuni casi si può modulare l’accordo per minimizzare il peso fiscale: ad esempio qualificando uno sconto come “nota di credito per merce difettosa” piuttosto che come remissione pura, se vi è un minimo appiglio commerciale – ciò per spostarlo dall’area sopravvenienze a quella dei costi di acquisto (non sempre fattibile, va detto, e bisogna essere genuini nelle causali). In sede di liquidazione controllata o fallimento, attenzione: se vengono venduti beni aziendali, la liquidazione potrebbe generare plusvalenze tassabili per la società/debitore. Ma se poi c’è esdebitazione, probabilmente l’Erario non riuscirà a riscuotere tali imposte “concorsuali” aggiuntive (che diventano crediti chirografari nella procedura stessa). Mentre se fate un accordo stragiudiziale e continuate l’attività, il Fisco può arrivare a chiedere le imposte su quella “vincita” contabile.
Profilo penale: lo abbiamo disseminato lungo il testo, ma giova ricapitolarlo sistematicamente in chiave soluzioni: – Omessi versamenti tributari: se avete arretrati IVA oltre soglia o ritenute non versate oltre soglia penale, regolarizzateli entro le scadenze penalmente rilevanti. Ad esempio, l’omesso versamento IVA 2023 diventa reato il 18 maggio 2024 (tre mesi dopo scadenza pagamento saldo dichiarazione) se supera €250k . Quindi potreste decidere di destinare parte di eventuali incassi o finanziamenti a pagare quell’IVA critica anziché altri debiti, perché il resto dei creditori potrete sistemarlo magari in concordato, ma il penale no. Oppure, se state presentando un concordato, valutate di inserire il pagamento integrale delle ritenute o contributi penalmente rilevanti nel piano, così da ottenere la causa di non punibilità (ad es. art. 10-bis e 10-ter prevedono che il reato è estinto se prima del dibattimento il debito è estinto). In altre parole, prioritizzate i debiti “penali” nel risanamento. – Operazioni distrattive prima/durante la procedura: se optate per un concordato minore o liquidazione, non sottraete beni dal patrimonio. Ad esempio, non prelevate tutta la cassa prima di presentare la domanda, o non vendete sottocosto l’auto di proprietà alla moglie durante la procedura: sono tipici atti che configurano bancarotta (se fallimento) o comunque possono portare a istanze di revoca dell’esdebitazione per comportamento in malafede. La parola d’ordine è trasparenza: durante la procedura ogni spesa extra ordinaria va concordata col gestore/giudice. Se, invece, state gestendo stragiudizialmente, vale la stessa morale: non spostate soldi su conti segreti all’estero pensando di salvarteli. Oltre a possibili reati (riciclaggio, sottrazione a creditori), compromettete la meritevolezza e rischiate di perdere il beneficio dell’esdebitazione se in futuro venisse fuori. – False attestazioni e documenti: nelle procedure di sovraindebitamento, non falsificate i dati. L’attestazione dell’OCC e le dichiarazioni del debitore al giudice devono essere veritiere. Se venite scoperti ad aver occultato passività o attività, si rischia il rinvio a giudizio per vari reati (falso in attestazioni al giudice, ecc.) e ovviamente il rigetto del piano. Meglio ammettere tutto subito: se avete un debito in discussione, includetelo; se possedete un bene all’estero, ditelo (magari potete sostenere che è in comproprietà, ecc., ma la trasparenza è fondamentale). – Reati fallimentari in senso lato: se la vostra società rischia la liquidazione giudiziale (fallimento), allora tenete a mente che dovrete giustificare la vostra gestione in un eventuale procedimento penale di bancarotta. Mantenete quindi i documenti contabili in ordine fino alla fine, conservate le pezze giustificative, non fate prelievi di cassa ingiustificati, non pagate “sotto banco” qualche creditore a preferenza di altri. Tutto ciò potrebbe venire esaminato. Se presentate un concordato minore e poi finite in liquidazione giudiziale perché non omologato, gli atti compiuti nei 6 mesi prima del deposito concordato sono esenti revocatoria fallimentare (art. 69 CCII) ma restano sindacabili penalmente se erano fraudolenti. Quindi comportatevi come se un curatore potesse domani leggere gli estratti conto: nessuna furbata. – Responsabilità personali post-crisi: se, ad esempio, ottenete la esdebitazione in liquidazione controllata, state attenti a non ricadere subito in comportamenti censurabili. La legge punisce il debitore esdebitato che entro 5 anni ottiene nuovi crediti con false attestazioni sulla propria solvibilità. Inoltre, un eventuale fallimento entro 5 anni dall’esdebitazione può revocare la precedente esdebitazione.
In sostanza, la gestione dei debiti deve essere legally compliant: seguire la legge non solo evita guai giudiziari, ma è anche un requisito per ottenere i benefici di protezione. La “ratio” delle norme attuali è favorire l’imprenditore onesto ma sfortunato (fresh start), e colpire invece chi maliziosamente cerca di approfittare o defraudare. Come sancito dall’UE, nessuno dev’essere tenuto in una “prigione dei debiti” a vita se ha agito correttamente . La buona fede paga: un esempio, la Cassazione 2024 n.27562 ha detto che anche se un piano paga poco i creditori, va omologato se il debitore è meritevole . Ciò incoraggia a essere trasparenti e collaborativi.
3. Esempi pratici di gestione dei debiti per un negozio di ottica
Di seguito presentiamo alcuni scenari ipotetici basati su casi reali, per illustrare come le strategie descritte possano applicarsi nella pratica a un negozio di ottica indebitato.
Esempio 1: Ditta individuale di ottica con debiti fiscali e verso fornitori
Situazione: Marco è titolare di un negozio di ottica in forma di ditta individuale. Negli ultimi anni ha accumulato debiti con l’Agenzia Entrate-Riscossione per €60.000 (IVA non versata e IRPEF) e debiti con due fornitori di occhiali per complessivi €25.000. Non ha dipendenti. Possiede un’auto e la casa di abitazione (senza mutuo), e il negozio è in affitto. L’attività è ancora moderatamente redditizia (produce un reddito netto di circa €2.000 al mese prima delle rate dei debiti). Marco teme pignoramenti da parte del fisco (ha già ricevuto intimazioni) e i fornitori minacciano azioni legali.
Strategia: Assistito da un professionista, Marco decide di non chiudere il negozio (che è ancora profittevole) ma di risanare i debiti nel tempo. Per prima cosa presenta all’Agenzia Riscossione una domanda di rateizzazione ordinaria per i €60.000: ottiene un piano in 84 rate mensili da circa €750 ciascuna (7 anni) . Ciò blocca immediatamente qualunque azione esecutiva del fisco e rimuove il rischio di fermo auto. Sapendo però di dover pagare queste rate per lungo tempo, Marco contatta anche i fornitori: negozia con ciascuno un accordo transattivo. Con il primo (credito €15.000) ottiene un saldo e stralcio a €9.000 (gli viene condonato il 40%), finanziato grazie a un prestito familiare e pagato subito . Con il secondo (credito €10.000) concorda un pagamento integrale ma in 10 mesi da €1.000 l’uno, senza interessi. I fornitori preferiscono queste soluzioni piuttosto che intraprendere decreti ingiuntivi e rischiare di non vedere nulla. L’accordo viene formalizzato per iscritto. Per evitare la tassazione della remissione avuta dal primo fornitore (€6.000 scontati), il consulente di Marco predispone nella contabilità una documentazione che qualifica parte di quello sconto come storno di merce difettosa (che effettivamente c’era stata) e il resto come sopravvenienza attiva, ma essendo Marco in regime forfettario, quell’anno non subirà comunque imposizione aggiuntiva significativa. Grazie a queste mosse, Marco riduce il debito fornitori da €25.000 a €19.000 effettivamente da pagare, e li diluisce nel tempo. Ogni mese ora Marco paga ~€750 di rate fiscali e €1.000 di rate fornitore, per un totale di €1.750, che riesce a coprire con i flussi dell’attività (rimodulando alcune spese e l’emolumento che preleva per sé). I creditori sono soddisfatti e nessuno intraprende azioni legali. Nessun bene è stato pignorato e l’attività continua regolarmente. Marco, su consiglio legale, ha inoltre subito regolarizzato l’IVA corrente: continua a versare puntualmente l’IVA anno per anno per non ingigantire il problema (ha anche ridotto l’esposizione offrendo sconti a chi paga con metodi tracciabili che generano credito d’imposta, per ridurre l’IVA a debito). Dopo 7 anni, avrà saldato tutto e il negozio sarà pulito. Se per caso dovesse avere difficoltà in futuro sulle rate, sa che potrebbe chiedere una rateizzazione straordinaria ulteriore o, come ultima spiaggia, avviare un concordato minore; ma ciò non è stato necessario perché la soluzione diluita ha funzionato.
Esempio 2: Società S.r.l. con più debiti e rischio insolvenza
Situazione: “Ottica Visione Chiara S.r.l.” gestisce 3 negozi in città diverse. A causa di una crisi (lockdown pandemico e calo vendite) la società è fortemente indebitata: €120.000 con banche (fidi e mutuo), €80.000 con fornitori, €50.000 di debiti fiscali e €20.000 verso il personale (stipendi arretrati di 2 mesi a 5 dipendenti). In totale €270.000. L’attivo della società consiste in scorte di magazzino per €100.000 (valore di costo), arredi e strumenti (valore usato stimato €30.000) e le licenze dei negozi (avviamento commerciale). I soci (due fratelli) hanno già dato in garanzia le proprie case per il mutuo bancario (ipoteca) e firmato fideiussioni omnibus per €50.000 ciascuno sui fidi. La società non riesce più a far fronte a tutti i pagamenti: alcuni fornitori hanno ottenuto decreti ingiuntivi e uno ha pignorato il conto corrente di una filiale; la banca ha revocato i fidi; i dipendenti minacciano cause. Formalmente la S.r.l. è insolvente. I soci vogliono evitare il fallimento (liquidazione giudiziale) che comporterebbe la perdita totale del controllo e possibili responsabilità.
Strategia: la società, tramite un legale, presenta ricorso per concordato preventivo in continuità (essendo probabilmente sopra soglia fallimentare) oppure, se i parametri dimensionali lo permettono, per concordato minore. Supponiamo che sia concordato minore, data la dimensione relativamente contenuta (anche se è al limite). Nel piano, la S.r.l. propone di proseguire l’attività in 2 negozi chiudendo il terzo meno profittevole, e di soddisfare i creditori in questo modo: integralmente i debiti verso dipendenti (anche utilizzando il TFR garantito dal Fondo INPS per coprire parte), integralmente il debito bancario garantito da ipoteca fino a concorrenza del valore dell’immobile ipotecato (la casa dei soci vale €80.000, quindi la banca ipotecaria viene rimborsata almeno per €80.000 su 100.000, il resto diventa chirografo), parzialmente (30%) fornitori e Fisco. Il piano finanziario prevede che i due negozi rimanenti generino utili per €10.000 annui da destinare ai creditori e che i soci conferiscano nuova finanza per €30.000 (raccolti vendendo un terreno di famiglia) da usare subito come acconto ai creditori. Inoltre la società chiede un periodo di moratoria di 6 mesi per ristrutturare il business (anche attraverso la composizione negoziata cui era già ricorsa qualche mese prima ottenendo lo stay). I creditori votano: la banca (privilegiata per €80k) è in classe separata ma otterrà un soddisfacimento pari al valore dell’ipoteca e vota a favore; i dipendenti sono anch’essi privilegiati (salari ultimi 6 mesi superprivilegiati) e saranno pagati dal Fondo di Garanzia quasi integralmente, quindi non ostacolano; i fornitori chirografari e l’Erario (chirografo per la parte non privilegiata) accettano il 30% preferendo qualcosa al rischio fallimento (dove stimano che sul libero mercato la società varrebbe anche meno). Il concordato minore viene approvato a larga maggioranza e omologato dal tribunale . Durante la procedura, le azioni esecutive individuali sono state sospese (ciò ha impedito ulteriori pignoramenti ai danni della società, permettendole di operare), e la società ha potuto sciogliersi dal contratto di affitto del negozio chiuso con semplice autorizzazione (pagando un’indennità minima al locatore, molto inferiore alla penale contrattuale che avrebbe dovuto pagare senza concordato). A piano omologato, la società esegue quanto promesso: i soci versano i €30.000 che il liquidatore/commissario utilizza per pagare una prima quota ai creditori chirografi; gli esercizi superstiti versano mensilmente parte degli utili su un conto dedicato ai creditori per 5 anni. Al termine dei 5 anni, i fornitori e lo Stato hanno ricevuto, poniamo, il 35% del loro credito (un po’ in più del 30% inizialmente ipotizzato, grazie a utili leggermente maggiori) e la banca ha recuperato, tra acconti e ipoteca, l’85%. La società viene liberata dai debiti residui (esdebitazione), i soci mantengono il controllo dei due negozi attivi e le loro case non vengono espropriate (la banca, soddisfatta nel concordato per la quota ipotecaria, rinuncia ad escutere le ipoteche per il residuo, anche perché i soci garanti avrebbero diritto all’esdebitazione personale del residuo ex art. 280 CCII se la società fosse liquidata). Questo scenario mostra come un intervento concorsuale ben congegnato può evitare il collasso completo: i creditori hanno preso una perdita, ma concordata e migliore di uno scenario liquidatorio disordinato; l’azienda, pur ridimensionata, è salva e continua a produrre reddito e impiego.
Esempio 3: Liquidazione controllata di ex imprenditore ottico
Situazione: Luigi gestiva come impresa individuale un negozio di ottica, ma la concorrenza spietata lo ha messo fuori mercato. Dopo aver accumulato €100.000 di debiti vari (fisco, fornitori, un prestito bancario personale), nel 2024 Luigi ha chiuso l’attività e anche venduto le attrezzature rimaste per pagare alcuni debiti urgenti. Gli resta la casa in cui vive (prima casa modesta) e un’auto di 10 anni. Non ha un lavoro stabile e i debiti residui ammontano ancora a €70.000, con varie azioni esecutive in corso. Luigi si rende conto che non riuscirà mai a pagarli.
Soluzione: sotto consiglio legale, Luigi decide di ricorrere alla liquidazione controllata da sovraindebitamento. Il tribunale ammette la procedura: viene nominato un liquidatore che raccoglie i pochi asset di Luigi (c’è rimasto poco: l’auto che viene venduta a €3.000 e un conto corrente con €2.000). La prima casa di Luigi non viene toccata poiché rispetta i requisiti di impignorabilità del fisco (unico immobile, residenza sua, non di lusso) e i creditori privati non avevano ipoteche né conviene loro pignorarla, quindi il liquidatore – constatando che venderla renderebbe Luigi e famiglia indigenti e genererebbe forse €20.000 netti per i creditori – propone di lasciarla fuori dal patrimonio liquidando invece l’auto e quei pochi risparmi . I creditori insinuati (principalmente Agenzia Entrate e alcuni fornitori) ricevono un riparto di soli €4.000 (circa il 5%). La procedura si chiude in un anno. Luigi, avendo collaborato pienamente e non avendo beni nascosti, chiede e ottiene l’esdebitazione: il tribunale lo libera dai €66.000 rimasti impagati . Luigi può così ricominciare senza quel fardello – troverà un impiego come dipendente in un negozio di ottica altrui. I creditori hanno incassato poco, ma probabilmente se avessero inseguito Luigi per vie esecutive per anni avrebbero ottenuto anche meno, dato che il suo stipendio da dipendente sarebbe pignorabile al massimo per 1/5. Questa via si è rivelata efficace per dare a Luigi un “fresh start” onesto. Uno dei creditori ha provato a opporsi all’esdebitazione sostenendo che Luigi aveva chiuso l’attività in modo “disinvolto”, ma il giudice ha verificato che non vi erano atti in frode (Luigi aveva anche usato i €10.000 ricavati dalla vendita delle attrezzature per pagare alcuni debiti previdenziali, mostrando buona fede). Dunque l’opposizione è stata respinta e l’esdebitazione confermata. Adesso Luigi è libero e, se volesse in futuro riaprire un’attività (cosa che per ora esclude), potrebbe farlo senza debiti pregressi.
Questi esempi dimostrano come, a seconda della situazione specifica (attività ancora in piedi o meno, beni disponibili, prospettive di continuità, ecc.), si possano applicare diversi strumenti. Nel Caso 1 bastava riorganizzare e rateizzare; nel Caso 2 serviva una ristrutturazione giudiziale complessa ma con prosecuzione dell’impresa; nel Caso 3 si è dovuto liquidare tutto e dare sollievo al debitore persona fisica.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo a una serie di domande comuni che un imprenditore indebitato (o il suo consulente) potrebbe porsi, riepilogando molti punti trattati sopra in forma di Q&A.
❓ D: Ho molti debiti scaduti e non riesco più a pagarli; rischio il fallimento automatico della mia attività?
✔️ R: No, nessuno dichiara fallito un imprenditore automaticamente per il solo fatto di avere debiti insoluti. Il fallimento (tecnicamente oggi liquidazione giudiziale) può avvenire solo con una sentenza del tribunale su istanza di un creditore, del debitore stesso o del pubblico ministero . Dunque, se hai molti debiti non pagati, quello che concretamente può succedere è che qualche creditore insoddisfatto decida di presentare un’istanza di fallimento in tribunale (ammesso che tu sia soggetto fallibile). Peraltro non esiste un importo minimo di debito oltre il quale “si fallisce”: in teoria anche un singolo debito importante e certo può portare all’insolvenza giudiziale . L’eccezione sono i piccoli imprenditori sotto soglia: se rientri nei parametri di non fallibilità (art. 2 CCII, vedi §1.3), i creditori non potrebbero far aprire una liquidazione giudiziale, ma rimarrebbero le altre azioni contro di te. Quindi, ricapitolando: non c’è fallimento senza una richiesta e un giudice che lo dichiari, ma se la tua situazione non migliora e i creditori perdono la pazienza, qualcuno prima o poi potrebbe attivarsi per una procedura concorsuale. Per prevenire uno scenario del genere, la mossa migliore è giocare d’anticipo: valutare tu stesso di avviare un concordato preventivo o minore, o altra procedura, così da governare la crisi invece di subirla . In un concordato sei tu a proporre il piano, in un fallimento subìsci passivamente la liquidazione.
❓ D: Un fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo di €50.000 contro di me. Devo oppormi anche se effettivamente gli devo quei soldi?
✔️ R: L’opposizione a decreto ingiuntivo ha senso solo se hai motivi validi di contestazione sul credito. Se riconosci che il debito è dovuto (merce consegnata, fattura corretta, nessuna eccezione contrattuale), fare un’opposizione in tribunale solo per prendere tempo è generalmente sconsigliato . Rischi infatti di aggravare il debito con spese legali e interessi, e alla fine il giudice confermerà il decreto e ti condannerà alle spese. Un’opposizione pretestuosa potrebbe farti guadagnare qualche mese (il tempo del giudizio di opposizione) ma non risolve il problema di fondo: allo scadere di quel termine dovrai comunque pagare o subire l’esecuzione forzata. Meglio allora usare quel tempo in modo utile: se non hai nulla da eccepire sul merito del credito, anziché spendere soldi in un’opposizione destinata a soccombere, contatta subito il fornitore e cerca un accordo (ad esempio offrigli un pagamento parziale immediato e il resto a rate) . Molti fornitori preferiranno questa via a un lungo pignoramento incerto. Se proprio non puoi pagare nulla, l’opposizione può essere un mezzo tattico per ritardare un pignoramento di qualche mese (nel frattempo magari attivi altre soluzioni), ma dev’essere valutata attentamente col tuo avvocato perché, come detto, comporta costi e potenziali condanne. In generale, opporsi senza seri motivi è controproducente. Usa invece le procedure concorsuali se hai bisogno di bloccare le azioni dei creditori: con la domanda di concordato o ristrutturazione presentata, tutte le cause esecutive (compreso quell’ingiunzione) vengono sospese automaticamente o su richiesta .
❓ D: Ho una S.r.l. e pensavo che i miei beni personali fossero al sicuro, ma la banca ora minaccia di escutere la fideiussione che ho firmato per i debiti della società. Cosa posso fare?
✔️ R: La fideiussione personale purtroppo annulla di fatto la tua protezione da socio di S.r.l.: hai garantito con il tuo patrimonio il debito sociale, quindi la banca ha tutto il diritto di chiedere a te personalmente il pagamento integrale se la società non paga . Non deve prima escutere la S.r.l. fino in fondo (a meno che nel contratto di fideiussione sia prevista la “escussione preventiva”, ma di solito non c’è); può agire parallelamente o subito contro di te. Dunque, se la società non paga, tu garante sei giuridicamente un coobbligato solidale. Come difendersi? Le strade sono: (i) verificare la validità della fideiussione: ci sono state in passato pronunce (antitrust, Cassazione) che hanno dichiarato nulle le fideiussioni bancarie standard (quelle su schema ABI) perché anticoncorrenziali. Se la tua fideiussione risale a prima del 2018 e ricalca esattamente lo schema ABI di quegli anni, potrebbe essere contestabile per nullità parziale . Devi farla esaminare da un legale esperto: se contiene le clausole “a prima richiesta”, “reviviscenza” e “deroga art. 1957 c.c.” in forma identica allo schema censurato, potresti opporre che è nulla. Non è una difesa semplicissima, ma a volte funziona e costringe la banca a trattare. (ii) Negoziare con la banca una soluzione: prima che ti pignori la casa o lo stipendio, prova a concordare una dilazione o un saldo e stralcio. Ad esempio, offrile il pagamento del 50% subito se ti libera dalla garanzia sul resto. Oppure proponi nuove garanzie (un’ipoteca su un immobile di un familiare) in cambio di un piano di rientro lungo. Le banche, di fronte a un garante in difficoltà ma collaborativo, spesso preferiscono un accordo sensato piuttosto che lunghi recuperi coattivi. (iii) Valutare il sovraindebitamento personale: se anche tu, come persona fisica, entri in uno stato di insolvenza perché la banca ti chiede più di quanto puoi, sappi che anche tu puoi ricorrere alle procedure di composizione (piano del consumatore o liquidazione). Ad esempio, potresti chiudere la S.r.l., far partire una liquidazione controllata per la società (che libererà i soci dalle fideiussioni residuamente) e parallelamente avviare per te un piano del consumatore per gestire i debiti personali inclusa la fideiussione residua. È complicato, ma possibile. In prima battuta, comunque, il consiglio è: trattare con la banca prima che passi ai legali. Se aspetti, la banca potrebbe procedere con decreto ingiuntivo e ipoteca giudiziale sui tuoi beni e a quel punto la tua leva contrattuale cala. In sintesi: la fideiussione ti mette allo scoperto, dunque reagisci attivamente. Verifica con un avvocato se quel contratto ha vizi di nullità , e intanto prova a raggiungere un accordo di rientro. Se poi proprio non hai modo di pagare e l’importo è enorme, considera la protezione della procedura da sovraindebitamento (anche come persona fisica è un tuo diritto).
❓ D: Ho un debito IVA non versata di €300.000. Posso includerlo in un concordato e pagare solo ad esempio il 20% come agli altri creditori?
✔️ R: Sì, oggi è possibile falcidiare (ossia ridurre parzialmente) i debiti IVA all’interno di concordati preventivi, concordati minori o accordi di ristrutturazione, purché sia rispettato il principio del trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione . Mi spiego: in passato c’era un dibattito giuridico perché l’IVA è un tributo comunitario e si riteneva “intoccabile” (doveva essere pagata sempre al 100%). La Direttiva UE 2019/1023 e la riforma italiana del 2022 hanno chiarito che anche l’IVA può essere falcidiata, a patto che l’Erario riceva almeno quanto prenderebbe in caso di fallimento . In pratica, se nel tuo concordato offri al Fisco (inclusa IVA) una certa percentuale e dimostri che, stimando una liquidazione dei tuoi beni, il Fisco in quella liquidazione prenderebbe uguale o meno, allora il tribunale può omologare il concordato anche senza l’approvazione dell’Agenzia Entrate . Esempio: debito IVA €300k; stimi che se tu fallissi, i creditori privilegiati saturerebbero tutto e l’Erario (che sull’IVA è anch’esso privilegiato solo se c’è capienza sull’attivo) vedrebbe, mettiamo, il 10%. Allora nel concordato proponi di pagare all’IVA il 20% (€60k) : questa offerta è migliore del 10% che avrebbe dal fallimento, quindi il giudice può confermarla anche se l’Agenzia votasse no. Difatti, con l’entrata in vigore del CCII, la normativa (art. 84 co.6) consente espressamente di trattare i crediti erariali anche con falcidia del capitale, cosa prima non ammessa. Nota bene però: devi comunque inserire nel piano una transazione fiscale (una sorta di proposta motivata al fisco) e confrontarti con loro; spesso l’Agenzia Entrate richiede almeno il valore di realizzo integrale dei beni su cui ha privilegio. In altre parole, se quell’IVA è coperta da ipoteca su un immobile, allora devi darle almeno il valore di vendita stimato di quell’immobile. Ma se è in concorso con altri privilegiati, la puoi ridurre proporzionalmente. Discorso diverso per le ritenute non versate (art. 10-bis D.lgs.74/2000): anch’esse tecnicamente oggi possono essere falcidiate (non c’è più divieto normativo), ma sono più delicate perché il Fisco tende a volerle intere in quanto trattenute a dipendenti. Tuttavia, se rispetti sempre il criterio del non deteriore, anche quelle potresti teoricamente ridurre. In sintesi, l’IVA non è più intoccabile, ma devi motivare economicamente la proposta e prepararti a convincere (o superare col cram-down) l’Agenzia . E ricorda: se prevedi falcidia di IVA o ritenute nel piano, ci vuole il voto dei creditori su una classe separata e l’adesione alla transazione fiscale nel piano perché il tribunale possa omologare anche in caso di voto contrario.
❓ D: Ho 5 dipendenti a cui non riesco a pagare gli ultimi stipendi. Rischio qualcosa a livello penale?
✔️ R: Il mancato pagamento degli stipendi di per sé non è un reato (costituisce inadempimento contrattuale e può portare a vertenze di lavoro e sanzioni amministrative, ma non ti mettono in galera solo per questo). Tuttavia, ci sono profili penali collegati da tenere in considerazione : se in quelle retribuzioni non pagate erano comprese ritenute IRPEF operate in busta paga (cioè la tassa trattenuta al dipendente) per un importo annuo oltre €150.000, scatta il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.lgs. 74/2000) . Difficile nel tuo caso di 5 dipendenti arrivare a 150k di ritenute annue non versate (sarebbero stipendi altissimi). Più rilevante: il mancato versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti oltre la soglia di €10.000 annui è reato (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983) . Come funziona: se, sommando tutti i contributi INPS trattenuti e non versati in un anno, superi 10k, l’INPS può denunciarti. Questo reato però si estingue se versi i contributi dovuti entro 3 mesi dalla contestazione o dall’invito a regolarizzare. Quindi hai una finestra per rimediare. Oltre ai reati fiscali/previdenziali, considera che se il mancato pagamento si protrae e i lavoratori fanno denuncia, l’Ispettorato del Lavoro può sanzionarti amministrativamente (ad esempio c’è una sanzione pecuniaria per omesso versamento retribuzione prevista dal Dlgs 104/2022). E, caso estremo, se il protrarsi è segno di dissesto aziendale occultato, in caso di fallimento si potrebbe ipotizzare una bancarotta preferenziale (se hai pagato altri trascurando i dipendenti volutamente). Ma restiamo sul pratico: cosa fare? Innanzitutto, cerca di pagare almeno una parte degli stipendi (magari le retribuzioni nette senza contributi) per contenere il danno ai lavoratori. Comunica con loro, spiega la situazione e magari concorda un piano di rientro dei salari arretrati. Molti preferiscono attendere un po’ piuttosto che farti fallire subito, specie se vedono impegno. Se prevedi di attivare un concordato, sappi che i crediti dei dipendenti per gli ultimi 6 mesi godono di super privilegio (prioritari su tutto) e che in caso di procedura potranno accedere al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità : quindi loro comunque tutelati in parte lo sono. Penalmente, assicurati di versare le ritenute IRPEF e i contributi entro fine anno se puoi, oppure di non superare la soglia dei 10k contributi: magari versa almeno i contributi dei mesi iniziali cosicché l’omissione scenda sotto soglia. Potresti anche decidere di mettere subito i dipendenti in cassa integrazione o licenziarli se l’attività è insostenibile, così da non accumulare ulteriori mensilità impagate. È duro, ma a volte necessario per non aggravare la loro posizione (più mesi li fai lavorare senza pagarli, peggio è per tutti). In sintesi: nessuno ti arresta solo perché non hai pagato gli stipendi, ma occhio alle ritenute e contributi connessi: quelli sì che possono portare a conseguenze penali se ignori le soglie . Intervieni selettivamente: ad esempio, se sei a €12.000 di contributi non versati, trova il modo di pagarne almeno €2.001 per scendere a 9.999 ed evitare il reato. Queste finezze contano.
❓ D: Se chiudo il mio negozio di ottica e apro un’altra attività altrove, i vecchi debiti si cancellano?
✔️ R: No, la chiusura semplice dell’attività non cancella i debiti pregressi. I debiti seguono il soggetto debitore. Se eri ditta individuale, rimarrai personalmente obbligato per tutti i debiti anche dopo la cessazione della partita IVA (i creditori potranno perseguiti sul patrimonio personale per anni). Se eri società di persone, analogamente i soci restano responsabili. Se eri società di capitali e la liquidi/cancelli, i debiti residui si estinguono verso la società (che non esiste più) ma i creditori potranno aggredire eventuali garanti o, in certi casi, chiedere la revocazione della cancellazione entro 1 anno se c’erano attivi non liquidati. Quindi chiudere da sola non è una soluzione magica. Aprire poi un’altra attività intestata a un prestanome o a un nuovo soggetto giuridico non mette automaticamente al riparo: se tu rimani di fatto l’imprenditore, i creditori potrebbero sostenere che la nuova azienda è una continuità o successore economico della precedente e provare ad aggredire anche quella (ad es. succede in ambito fiscale: l’AdE può ritenere responsabile la nuova ditta per i debiti tributari se c’è stato passaggio d’azienda senza pagamento imposte, cfr. art.14 D.lgs.472/97). Inoltre, aprire e chiudere per sfuggire ai debiti può integrare reati (bancarotta fraudolenta se c’è fallimento di mezzo, sottrazione fraudolenta a riscossione se vendi beni a terzi per non farli pignorare) . Quindi la strada corretta per liberarti dei debiti non è chiudere e basta, ma eventualmente chiudere l’attività e utilizzare le procedure di composizione della crisi (concordato, liquidazione controllata, ecc.) per ottenere l’esdebitazione. Solo quelle ti danno l’effetto legale di cancellazione dei debiti residui. Se invece chiudi e basta, i creditori inseguiranno te in quanto persona (o i soci). In pratica: chiudere l’attività ha senso per non aggravare la posizione (smetti di fare debiti nuovi), ma i debiti vecchi rimangono finché non li affronti con un accordo o una procedura. Dunque, se decidi di chiudere, fallo all’interno di un percorso di risoluzione: ad esempio, cessa la tua impresa e poi fai un piano del consumatore come ex imprenditore per eliminare i debiti; oppure liquida la società tramite liquidazione controllata. In quel modo sì che i debiti saranno risolti e potrai aprire altrove senza code. Se invece semplicemente riapri “pulito” a nome di tua moglie, i debiti resteranno comunque attaccati a te e, oltre ai rischi legali, moralmente e commercialmente i fornitori lo scopriranno e non te la faranno passare liscia. Conviene molto di più trattare i debiti in modo trasparente, anche offrendo percentuali, piuttosto che sparire. L’ordinamento oggi ti offre modi legali per liberarti dei debiti (vedi tutta la guida sopra): sfruttali, perché funzionano e dopo potrai veramente ricominciare con la fedina pulita.
❓ D: Qual è la differenza tra un concordato minore e un piano del consumatore, e come capisco quale posso fare io?
✔️ R: La differenza sta nel tipo di debitore e di debiti: il piano del consumatore (oggi chiamato “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è riservato alla persona fisica consumatore, cioè non imprenditore, con debiti di natura personale . Non richiede il voto dei creditori ed è basato solo sull’omologa del giudice in base alla meritevolezza e fattibilità . Il concordato minore invece è per il debitore non fallibile che esercita attività d’impresa o professionale (imprenditori piccoli, professionisti, start-up, società sotto soglia). Richiede il voto dei creditori a maggioranza ed è simile a un concordato preventivo semplificato. Quindi, se tu sei (o fino a poco fa eri) un imprenditore commerciale – come nel caso del negozio di ottica – non sei un consumatore per quei debiti. Dovrai quindi fare un concordato minore (se vuoi tenere aperta l’attività) o una liquidazione controllata. Il piano del consumatore ti sarebbe precluso perché i debiti originano dall’attività imprenditoriale. Potresti però usarlo se hai chiuso l’attività e i tuoi debiti residui sono principalmente personali: c’è qualche rara pronuncia che ha ammesso l’ex imprenditore come consumatore se l’attività era cessata da anni e i debiti rimanenti non erano di natura imprenditoriale. Ma generalmente, se i debiti derivano dall’aver gestito un’impresa, i giudici ti considereranno debitore non consumatore . Quindi: – Se hai ancora il negozio attivo o lo hai chiuso da poco e la maggior parte dei debiti sono verso fornitori, fisco, banche per l’attività, dovrai orientarti verso concordato minore o liquidazione controllata. – Il piano del consumatore è pensato per chi ha debiti come privato cittadino (prestiti personali, carte di credito, mutuo casa, ecc.) . Non richiede coinvolgere i creditori nelle decisioni ed è a volte più veloce, ma ripeto: non è per debiti d’impresa. Un altro aspetto: nel piano del consumatore devi dimostrare che hai avuto cause esterne che ti hanno portato all’insolvenza (o comunque che non hai colpe gravi); nel concordato minore conta di più la sostenibilità economica del piano e l’approvazione dei creditori, anche se pure lì la meritevolezza è considerata in sede di esdebitazione . Riassumendo: se sei un ottico con debiti del negozio, concordato minore è lo strumento giusto per ristrutturare mantenendo magari aperto, oppure liquidazione controllata se vuoi chiudere e liquidare tutto. Il piano del consumatore potrà forse servirti solo se, chiusa l’attività, vieni considerato un semplice cittadino con bollette e prestiti da sistemare. Ma nella maggior parte dei casi, le procedure “da impresa” sono quelle in cui rientri.
❓ D: Ho sentito parlare di esdebitazione del debitore incapiente. In cosa consiste e potrei accedervi?
✔️ R: L’esdebitazione del debitore incapiente è una misura introdotta dal CCII (art. 283) pensata per dare un fresh start anche a chi non ha nulla da offrire ai creditori. In pratica, se sei una persona fisica che non possiede alcun patrimonio liquidabile e non riesci a proporre neppure un mini-piano di rientro, puoi chiedere al tribunale di essere ugualmente liberato dai debiti, a condizione di: essere meritevole (non aver frodato i creditori, non aver assunto debiti con colpa grave), non aver accesso ad altre procedure (cioè la liquidazione controllata risulterebbe inutile perché non hai beni da liquidare) e di versare ai creditori, se riesci, una somma simbolica (anche minima) nel quadriennio successivo . Se il giudice accoglie, ottieni l’esdebitazione senza pagare nulla o quasi. È una sorta di “grazia” per il debitore onesto ma sfortunato che proprio non può dare nulla. Tuttavia, è prevista che: se nei 4 anni successivi a questa esdebitazione “a zero” tu migliori la tua condizione (vinci alla lotteria, ricevi un’eredità, o comunque puoi pagare almeno il 10% dei debiti esdebitati), allora quell’esdebitazione può essere revocata e i creditori tornano alla carica. Insomma, è una liberazione condizionata alla tua persistente indigenza. Puoi chiederla una volta sola nella vita. E il tribunale spesso vuole vedere che almeno uno sforzino lo fai: ad esempio, se hai un reddito, magari ti chiede di versare ai creditori quel poco per alcuni anni. Nel contesto di un negozio di ottica, potresti pensarci se: hai chiuso l’attività, non hai casa di proprietà, non hai beni, e magari pure disoccupato – insomma sei nullatenente. Se hai anche solo qualcosa (un’auto, un piccolo immobile, ecc.) ti diranno: fai la liquidazione controllata e vendi quelli. Se invece davvero non c’è nulla da prendere e i creditori inseguono il nulla, allora sì, quella procedura potrebbe calzare. Devi comunque passare dal giudice, non è automatica. Non molti l’hanno usata finora (è nuova); prima c’era qualcosa di simile nella L.3/2012 chiamata esdebitazione “senza utilità” e pochissimi casi furono accolti. Ma ora la norma è più esplicita. In sintesi: se sei “incapiente” (termine tecnico per dire che non puoi dare soddisfazione ai creditori), hai un’ultima spiaggia per ottenere la pace dai debiti. Attenzione però: sono esclusi dall’esdebitazione alcuni debiti come alimenti, risarcimenti per illecito, multe, ecc. Quelli restano comunque. E ricordati che se, dichiarato incapiente, vinci poi 500mila euro, i creditori potrebbero rifarsi sotto. Per concludere, valuta con il legale se il tuo profilo risponde ai criteri, e predisponi bene la domanda (va dimostrato di aver provato a risanare in altri modi, che non stai facendo il furbo, ecc.). È l’ultima tappa di solito: si tenta un piano o liquidazione; se neanche quella frutta nulla, si va di esdebitazione incapiente.
❓ D: Quanto dura e quanto costa all’incirca una procedura di sovraindebitamento?
✔️ R: La durata dipende dal tipo di procedura e dalla complessità del caso: – Un piano del consumatore può concludersi in pochi mesi per l’omologazione (diciamo 4-6 mesi tipici), dopodiché dura per tutto il tempo di esecuzione (es. se prevede pagamenti per 5 anni, quello è l’arco, ma formalmente l’esdebitazione arriva dopo aver eseguito il piano). – Un concordato minore necessita anch’esso di qualche mese per arrivare al voto e omologa (forse un po’ di più, diciamo 6-12 mesi, perché c’è la fase di adunanza creditori). Poi anche questo ha un periodo di esecuzione che può essere pluriennale (di solito 3-5 anni di pagamento). L’esdebitazione qui arriva dopo l’esecuzione completa. – Una liquidazione controllata può essere relativamente veloce se ci sono pochi beni da liquidare (1-2 anni ad esempio), oppure più lunga se ci sono immobili da vendere all’asta (allora 2-4 anni non sono inusuali). L’esdebitazione la chiedi alla fine quindi dipende da quanto rapidamente il liquidatore converte in denaro i beni e distribuisce ai creditori. In generale, comunque, queste procedure sono più rapide di un fallimento tradizionale medio (che spesso dura anche 5-7 anni). La riforma ha puntato a semplificare e sveltire: ad esempio, meno adempimenti burocratici e più digitale . Sul fronte costi: certamente c’è il compenso dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o del professionista nominato, che è stabilito dal giudice e di solito proporzionato all’attivo o alla complessità. Per piccoli casi a volte viene contenuto su poche migliaia di euro. Ci sono poi le spese di procedura (diritti di cancelleria, eventuali perizie se servono). E naturalmente le spese legali del tuo avvocato e consulenti che ti assistono. Molti OCC chiedono un anticipo spese all’inizio (ad es. 200-500 euro per aprire la pratica). Se la massa attiva è capiente, i compensi finali dell’OCC possono essere anche di alcune migliaia di euro (in genere sempre inferiori a quelli di un curatore fallimentare, perché i patrimoni coinvolti sono minori). Ad esempio, in un concordato minore con debiti €200k e attivo €100k, il commissario potrebbe prendere forse €5-10k di compenso. In una liquidazione senza attivo, il compenso è minimale (c’è un fondo statale che potrebbe coprire in parte se tu proprio non puoi). Per l’avvocato, alcuni fanno tariffe forfettarie per seguire tutta la procedura. Come ordine di grandezza, può variare da €2-3k per un piano semplice fino a €10-15k per concordati complessi, più eventualmente successo. Va discusso caso per caso. È importante capire che, se non hai soldi, spesso i professionisti modulano i pagamenti: magari l’OCC accetta di essere pagato a fine procedura con parte dei fondi recuperati. Anche l’avvocato può dilazionare onorari. Insomma, non devi spaventarti: se sei in crisi, lo sanno tutti che non puoi pagare subito cifre esorbitanti. Ad esempio, potresti concordare di versare X al mese per la procedura. Alcuni OCC pubblici (presso le Camere di Commercio) offrono anche un primo orientamento gratuito. In conclusione, la durata tipica di un intero processo di esdebitazione può essere attorno a 3-5 anni (tenendo conto sia della fase giudiziale iniziale sia dell’esecuzione dei pagamenti), ma con variabili. I costi ci sono, ma sostenibili rispetto al beneficio di togliersi magari centinaia di migliaia di debiti. E c’è sempre la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato per la difesa legale se si hanno i requisiti di reddito.
In sintesi, affrontare una situazione di debiti importanti come quella di un negozio di ottica richiede una combinazione di realismo (riconoscere la crisi e non negarla), competenza (farsi aiutare da esperti) e tempestività (agire prima che i problemi degenerino in azioni irreversibili). La legge italiana, specialmente dopo le riforme del 2022-2024, mette a disposizione strumenti avanzati per il risanamento o l’uscita ordinata dal mercato, anche per i piccoli imprenditori. Dal punto di vista di chi è debitore, è fondamentale sapere di avere diritti e possibilità di difesa: nessuna posizione è disperata finché non si valutano tutte le opzioni – dalla semplice rateazione a finanche la liberazione integrale dai debiti tramite esdebitazione. I creditori hanno i loro mezzi di tutela (pignoramenti, istanze di fallimento), ma il debitore ben consigliato può anticiparli e trovare soluzioni equilibrate. Come abbiamo visto, a volte basta un accordo stragiudiziale per mettere in sicurezza l’attività; in altri casi serve l’intervento del tribunale per tagliare i debiti e salvare l’azienda; in altri ancora, l’azienda va chiusa ma il debitore persona può ricominciare pulito grazie alla procedura. Ogni caso è a sé, ma la conoscenza di questi strumenti è potere: non isolarsi e non ignorare il problema sono passi cruciali. Un negozio di ottica può tornare a guardare con chiarezza al futuro se affronta con metodo e supporto adeguato le zone d’ombra dei debiti.
Gestisci un’ottica o una catena di negozi di occhiali e lenti a contatto, e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci un’ottica o una catena di negozi di occhiali e lenti a contatto, e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate?
Hai cartelle esattoriali, mutui o leasing per attrezzature ottiche, contributi INPS arretrati o affitti in ritardo, e temi pignoramenti, blocchi bancari o la chiusura del negozio?
👉 Non è la fine: anche le attività commerciali del settore ottico possono difendersi legalmente, bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti e ripartire in modo regolare e protetto, senza fallire.
In questa guida scoprirai perché molti negozi di ottica finiscono in crisi, quali strumenti legali puoi utilizzare, e come salvare o chiudere la tua attività senza rischiare tutto ciò che hai costruito.
👓 Perché i negozi di ottica si indebitano
Il settore dell’ottica è competitivo e soggetto a forti oscillazioni economiche. Le principali cause di indebitamento sono:
- Aumento dei costi delle lenti, montature e materiali di laboratorio;
- Mutui o leasing per strumenti ottici, macchinari e sistemi digitali di misurazione;
- Affitti elevati per i locali commerciali;
- Concorrenza di catene low-cost e vendite online;
- Calo dei margini e ritardi nei pagamenti dei clienti;
- Tassazione e contributi previdenziali difficili da sostenere;
- Errori contabili o fiscali che generano cartelle e sanzioni.
📌 Tutti questi fattori possono portare rapidamente a debiti fiscali, bancari e commerciali, minacciando la stabilità dell’impresa e del titolare.
🧾 I debiti più comuni nei negozi di ottica
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IVA, IRPEF, INPS, INAIL, TARI, cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Mutui o leasing per arredi, attrezzature ottiche, laboratori e strumenti digitali.
- Scoperti di conto, prestiti e fidi bancari.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori di lenti, montature, accessori e software gestionali.
✅ Debiti verso dipendenti e collaboratori
- Stipendi arretrati, TFR e contributi non versati.
✅ Debiti personali o fideiussioni
- Garanzie firmate dal titolare o soci per mutui o finanziamenti aziendali.
⚠️ Cosa rischia un negozio di ottica indebitato
Se la situazione non viene gestita tempestivamente, i creditori possono:
- pignorare conti correnti, attrezzature e incassi;
- revocare fidi e leasing bancari, fermando la produzione;
- bloccare i rapporti con i fornitori di lenti e montature;
- emettere cartelle, decreti ingiuntivi o ipoteche;
- compromettere la reputazione commerciale dell’attività.
👉 Tuttavia, la legge oggi consente di bloccare tutto legalmente, ristrutturare i debiti e salvare la tua ottica, oppure chiuderla in modo protetto e senza fallire.
🧩 Le soluzioni legali per negozi di ottica con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Un avvocato esperto può aiutarti a ottenere:
- riduzione delle somme dovute (saldo e stralcio);
- rateizzazioni sostenibili in base agli incassi reali;
- sospensioni temporanee dei pagamenti.
👉 È la scelta migliore per chi ha ancora clienti e vuole continuare a lavorare senza interruzioni.
💠 2. Procedura di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa)
È la procedura principale per microimprese, ditte individuali e negozi al dettaglio.
Permette di:
- bloccare pignoramenti, cartelle e azioni dei creditori;
- presentare un piano di rientro parziale e realistico;
- ottenere la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).
📌 Perfetta per negozi di ottica a gestione familiare o indipendente.
💠 3. Concordato minore (per SRL o società di commercio)
È una procedura giudiziale approvata dal Tribunale che consente di:
- bloccare tutte le azioni esecutive e fiscali;
- ridurre legalmente i debiti fiscali, bancari e commerciali;
- preservare la continuità dell’attività e i rapporti con i fornitori.
📌 È la soluzione ideale per catene o negozi strutturati con più sedi e personale.
💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)
Se l’attività non è più sostenibile, puoi chiudere legalmente e senza rischi, mettendo a disposizione solo i beni non indispensabili (macchinari, arredi, merce).
Alla fine della procedura, il Tribunale cancella tutti i debiti residui, consentendoti di ripartire senza pendenze fiscali o bancarie.
💠 5. Verifica e contestazione di cartelle e accertamenti fiscali
Molte cartelle contengono errori o importi prescritti.
Un avvocato può:
- verificare la prescrizione (5 o 10 anni);
- eccepire errori di calcolo o notifiche irregolari;
- chiedere la sospensione o l’annullamento del debito.
👁️ Cosa fare subito
✅ 1. Analizza la tua situazione economica e i debiti
Prepara bilanci, cartelle, leasing, mutui, fatture e documentazione bancaria.
✅ 2. Blocca immediatamente i creditori
Con il deposito di una procedura di sovraindebitamento o concordato, tutte le azioni di recupero vengono sospese per legge.
✅ 3. Evita nuovi prestiti o accordi non sostenibili
Serve una strategia legale completa, elaborata da un avvocato esperto in diritto commerciale e crisi d’impresa.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale del titolare o amministratore.
- Visura camerale e bilanci aziendali.
- Dichiarazioni fiscali e posizione INPS/INAIL.
- Contratti di leasing, mutui e finanziamenti.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori, clienti e dipendenti.
- Estratti conto bancari e documentazione contabile.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e strategia legale: 1–3 settimane.
- Deposito della procedura: 1–2 mesi.
- Blocco dei creditori: immediato con il deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Stop a pignoramenti, cartelle e sequestri.
- Riduzione o cancellazione dei debiti residui.
- Tutela della licenza, del negozio e dei macchinari.
- Ripartenza economica e professionale serena.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato di tutte le azioni dei creditori.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Tutela della licenza e del punto vendita.
✅ Possibilità di continuare o chiudere in modo protetto.
✅ Ripartenza economica e reputazionale pulita.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o notifiche fiscali.
- Accumulare nuovi debiti o prestiti “ponte”.
- Pagare solo alcuni creditori peggiorando la posizione.
- Vendere strumenti o merce senza consulenza legale.
- Aspettare troppo prima di agire.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la situazione economica e fiscale del tuo negozio di ottica.
📌 Ti consiglia la soluzione più adatta: rinegoziazione, sovraindebitamento, concordato o liquidazione controllata.
✍️ Redige e deposita il piano legale per bloccare subito i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche, leasing e fornitori.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione definitiva dei debiti o alla ristrutturazione completa dell’attività.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di negozi di ottica, farmacie e attività sanitarie con debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere un negozio di ottica con debiti non significa essere destinati alla chiusura.
Con una difesa legale tempestiva e mirata, puoi bloccare i creditori, ridurre drasticamente i debiti fiscali e bancari, e continuare a lavorare in modo regolare e sereno, oppure chiudere in modo ordinato e senza rischi.
La legge oggi tutela chi agisce in buona fede e vuole davvero ripartire.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova visione professionale senza debiti comincia oggi.