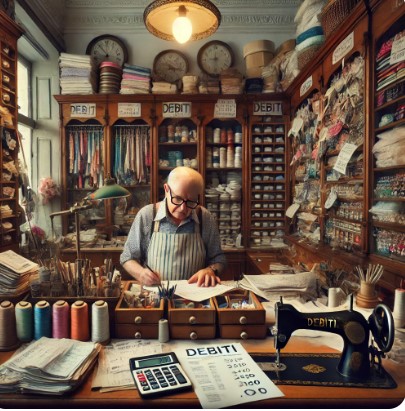Gestisci una merceria o un negozio di articoli per il cucito, tessuti e accessori e ti trovi in difficoltà economica a causa di debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche? È una situazione che purtroppo oggi riguarda molti piccoli commercianti, stretti tra la pressione fiscale, la riduzione dei consumi e la concorrenza delle vendite online. Quando si accumulano cartelle esattoriali, contributi arretrati o finanziamenti non pagati, la sopravvivenza dell’attività può essere messa in serio pericolo. La buona notizia è che la legge prevede strumenti concreti per rateizzare, ridurre o cancellare i debiti, salvaguardando la tua attività e il tuo patrimonio personale.
Perché molte mercerie si indebitano
Le mercerie, spesso a conduzione familiare, devono affrontare costi di gestione elevati e margini sempre più ridotti. Gli affitti, le utenze, le tasse e i contributi incidono pesantemente, mentre la concorrenza dei grandi centri commerciali e dei negozi online ha ridotto il volume delle vendite. Anche i ritardi nei pagamenti da parte dei clienti o la stagionalità della domanda possono compromettere la liquidità. Per far fronte alle spese quotidiane, molti titolari rinviano il pagamento delle imposte o dei contributi, accumulando interessi e sanzioni che nel tempo rendono la situazione debitoria difficile da sostenere.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Quando le imposte o i contributi non vengono versati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono avviare procedure di recupero forzato. Le più frequenti sono la notifica di cartelle esattoriali, i pignoramenti dei conti correnti o degli incassi POS, i fermi amministrativi sui veicoli, le ipoteche sugli immobili e i sequestri dei crediti verso clienti o fornitori. Gli importi aumentano progressivamente a causa di sanzioni e interessi, aggravando ulteriormente la situazione economica. Se gestisci la merceria come ditta individuale o società di persone, rispondi personalmente dei debiti, rischiando anche i beni familiari.
Cosa fare subito se la tua merceria ha debiti
Il primo passo è fare chiarezza sulla tua posizione debitoria. Richiedi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo aggiornato per sapere quanto devi e verso quali enti. Poi verifica la validità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica, somme prescritte o importi non dovuti che un avvocato può impugnare. Se i debiti sono legittimi, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo nel frattempo le procedure di riscossione. È anche utile controllare se è disponibile una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o ipoteche, puoi ottenere la sospensione immediata con un ricorso o un’istanza di autotutela.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se la situazione debitoria è troppo pesante o la tua merceria non riesce più a sostenere le spese, puoi ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È una procedura legale destinata a piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui (esdebitazione). È uno strumento riconosciuto dai tribunali italiani e rappresenta una via concreta per salvare la tua attività o chiuderla in modo ordinato, senza lasciare pendenze fiscali o bancarie.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molte mercerie si trovano anche con debiti verso banche o fornitori di tessuti, accessori e materiali. In questi casi puoi chiedere la rinegoziazione dei finanziamenti, la sospensione temporanea delle rate o proporre un saldo e stralcio per chiudere la posizione a un importo ridotto. È possibile inoltre contestare clausole abusive o tassi usurari nei contratti e impugnare decreti ingiuntivi o pignoramenti entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nelle trattative con banche e creditori, difendendo i beni aziendali e mantenendo la continuità del negozio.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Una difesa legale tempestiva e ben organizzata può permetterti di sospendere pignoramenti e riscossioni, ottenere la rateizzazione o cancellazione dei debiti, proteggere la casa e i beni personali, mantenere l’attività aperta e ripartire con un piano di rientro sostenibile. In molti casi è possibile rilanciare la merceria e recuperare stabilità finanziaria senza chiudere definitivamente.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto cartelle o intimazioni di pagamento, se i debiti fiscali o bancari sono diventati insostenibili o se rischi il blocco dei conti o la chiusura del negozio. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa può bloccare la riscossione, impugnare gli atti illegittimi e accompagnarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire in tempo è fondamentale per salvare la tua attività e difendere il tuo patrimonio.
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, ipoteche e blocchi dei conti. Intervenire subito è l’unico modo per salvare la tua merceria e proteggere i tuoi beni personali.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle attività artigianali e commerciali – spiega cosa fare se gestisci una merceria con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che mettono a rischio la tua merceria?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Gestire una merceria in difficoltà economica può diventare un incubo: fatture arretrate, rate di mutuo scadute, cartelle esattoriali, dipendenti non pagati. In Italia esistono però strumenti giuridici avanzati per affrontare la crisi debitoria senza soccombere definitivamente. Questa guida – aggiornata a settembre 2025 – analizza in dettaglio cosa può fare il titolare di una merceria indebitata per difendersi. Adotteremo un taglio tecnico (normativa vigente e ultime sentenze), ma con linguaggio comprensibile, rivolgendoci sia a professionisti (avvocati, commercialisti) sia agli stessi imprenditori e privati cittadini interessati. L’obiettivo è fornire un quadro completo: dalle tipologie di debiti tipiche di una merceria alle possibili azioni dei creditori, dalla responsabilità personale dell’imprenditore individuale agli strumenti di risanamento extragiudiziali e giudiziali (sovraindebitamento, concordato, ecc.), fino alle strategie difensive contro pignoramenti ed esecuzioni. Troverete anche tabelle riepilogative, una sezione domande e risposte (FAQ) e alcune simulazioni pratiche basate su casi realistici.
Contesto Normativo: Il diritto italiano, soprattutto negli ultimi anni, ha visto una profonda riforma della disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. La Legge n.3/2012 (cosiddetta “salva-suicidi”) ha introdotto procedure dedicate ai debitori civili e piccoli imprenditori, poi confluite nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) entrato in vigore dal 15 luglio 2022 e successivamente modificato (da D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024). Il nuovo impianto normativo è ispirato a un principio di favor debitoris, cioè di dare al debitore onesto in difficoltà una “seconda opportunità” (il c.d. fresh start), bilanciando tale beneficio con la tutela dei creditori. Questa guida si pone dal punto di vista del debitore (titolare della merceria), illustrando come operare entro i confini di legge per ridurre l’esposizione debitoria, evitare sanzioni peggiori e ripartire.
Di seguito esamineremo: (1) le principali tipologie di debito che una merceria può accumulare e i relativi rischi; (2) le conseguenze del mancato pagamento e la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore; (3) gli strumenti extragiudiziali per gestire o ridurre i debiti (accordi con creditori, piani di rientro, composizione negoziata, ecc.); (4) le procedure giudiziali formali (sovraindebitamento, concordato preventivo, fallimento/liquidazione giudiziale) e come funzionano; (5) come difendersi dalle azioni esecutive dei creditori (opposizioni, limiti ai pignoramenti, ecc.); (6) una serie di domande e risposte frequenti; (7) alcuni casi pratici simulati con strategie possibili; infine, (8) l’elenco delle fonti normative e giurisprudenziali utilizzate.
Nota: Per “merceria” intendiamo una piccola impresa commerciale (tipicamente individuale o a conduzione familiare) operante nel settore della vendita al dettaglio di articoli di merceria (fili, bottoni, tessuti, ecc.). Molte considerazioni valgono però anche per altre micro-imprese commerciali. Quando opportuno, distingueremo se il titolare è un imprenditore individuale (che risponde con il proprio patrimonio) oppure una società (es. una S.n.c. o S.r.l.), poiché il regime di responsabilità e le procedure possono differire. In ogni caso, l’attenzione principale sarà rivolta alle soluzioni legali disponibili in Italia nel 2025 per chi si trova “con l’acqua alla gola” a causa dei debiti della propria attività.
Tipologie di debiti di una merceria
Una merceria può accumulare debiti di diversa natura. Identificare la tipologia di ciascun debito è fondamentale, perché ogni creditore ha strumenti di recupero diversi e specifiche tutele legali. Esaminiamo le categorie più comuni:
Debiti fiscali e tributari
Sono i debiti verso l’Erario, cioè tasse e imposte non pagate. Per una merceria, i principali debiti fiscali possono includere: IVA non versata sulle vendite, IRPEF o IRES (imposte sui redditi) non pagate, IRAP (tassa regionale sulle attività produttive), nonché eventuali imposte locali (es. TARI sui rifiuti) se non saldate. Un caso particolare sono le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei dipendenti o sui compensi dei professionisti: se il titolare le trattiene in busta paga ma non le versa al Fisco, si genera un debito erariale (con possibili profili anche penali per omesso versamento oltre soglie rilevanti).
I debiti fiscali vengono normalmente accertati e poi iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate. L’Agente della Riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia Entrate – Riscossione, AER) notifica quindi una cartella esattoriale (cartella di pagamento) al contribuente moroso. La cartella è un atto esecutivo che intima il pagamento entro 60 giorni; se non si paga, la riscossione coattiva può scattare senza bisogno di un giudice. Approfondiremo più avanti le azioni specifiche che AER può attuare (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti, ecc.). Va segnalato che il legislatore ha spesso introdotto misure di “definizione agevolata” dei debiti fiscali: ad esempio la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha previsto la Rottamazione-quater, che consente di pagare solo capitale e spese, con stralcio di sanzioni e interessi di mora. Queste possibilità – se attive – possono ridurre significativamente l’importo dovuto. Tuttavia, restano debiti molto delicati perché assistiti da privilegi e poteri di riscossione speciale.
Debiti bancari e finanziari
Molte mercerie fanno affidamento su banche o finanziarie per avere liquidità: ad esempio uno scoperto di conto corrente (fido bancario per l’acquisto scorte), un mutuo commerciale (per acquistare o ristrutturare il negozio), o un prestito chirografario per investimenti. Il debito bancario nasce quando l’imprenditore non riesce a rimborsare queste esposizioni secondo il piano previsto. Si pensi a rate di mutuo impagate, utilizzo extra-fido non rientrato, interessi moratori accumulati, leasing finanziari per macchinari non pagati.
Tali debiti sono generalmente regolati da contratti privati. Le banche in caso di insolvenza possono revocare gli affidamenti e agire per il recupero: ad esempio inviare una lettera di decadenza dal beneficio del termine (che rende immediatamente esigibile tutto il residuo del mutuo) e poi agire giudizialmente. Spesso i crediti bancari sono garantiti: ad esempio un mutuo ipotecario sulla casa o un pegno su titoli. In altri casi vi sono fideiussioni personali (garanzie di terzi o dello stesso imprenditore su debiti della società). Se la merceria è una società di capitali (es. S.r.l.), gli istituti di credito chiedono quasi sempre al socio/amministratore una fideiussione: ciò significa che anche se la società ha responsabilità limitata, la banca potrà rivalersi sul patrimonio personale del garante se il debito non viene pagato. Il mancato rimborso di debiti finanziari comporta inoltre la segnalazione nelle banche dati creditizie: ad esempio Centrale Rischi Bankitalia e CRIF, con conseguente difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti.
Debiti verso fornitori e affitti
La gestione ordinaria di una merceria comporta acquisti continui di merce (fili, bottoni, tessuti, etc.) dai fornitori. Spesso viene accordata una dilazione (es. pagamento a 60/90 giorni). Se le fatture restano non pagate, i fornitori vantano crediti commerciali chirografari (non garantiti da privilegio) ma pur sempre esigibili. Dopo solleciti infruttuosi, molti fornitori ricorrono a legali per un decreto ingiuntivo: trattandosi di credito fondato su fatture o su contratto, il fornitore può ottenere in tempi brevi un’ingiunzione di pagamento dal giudice. Trascorsi 40 giorni senza opposizione né pagamento, il decreto diventa esecutivo e il fornitore potrà procedere con pignoramenti ai danni dell’impresa debitrice.
Un’altra voce di esposizione può essere l’affitto del locale commerciale. Se la merceria è in locazione e il titolare accumula ritardi nel pagamento dei canoni, il proprietario (locatore) può intimare lo sfratto per morosità. Entro termini brevi il tribunale convalida lo sfratto salvo che il conduttore paghi le somme dovute (cosiddetto termine di grazia). Oltre alla perdita del locale (col rischio di dover chiudere l’attività per mancanza di sede), il locatore può agire per recuperare i canoni arretrati. Il credito da locazione è assistito da un particolare privilegio sui beni mobili del conduttore che si trovano nei locali affittati (art. 2764 c.c.): ciò significa che, ad esempio, l’arredamento e le merci presenti in negozio possono essere pignorate con preferenza del locatore su altri creditori (entro il limite di due annualità di affitto). Va notato che la merce in vendita può essere anche acquistata con riserva di proprietà (alcuni fornitori forniscono beni concordando che la proprietà resti loro finché il dettagliante non paga interamente il prezzo): in tal caso, se la merceria non paga, il fornitore può rivendicare la restituzione delle merci fornite ancora invendute.
Debiti verso dipendenti
Se la merceria ha dipendenti o collaboratori, può incorrere in debiti per retribuzioni non pagate, tredicesime/quattordicesime arretrate, Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non accantonato o liquidato, ed eventualmente indennità varie (ferie maturate, straordinari, ecc.). Il mancato pagamento dei dipendenti è particolarmente grave: i lavoratori possono agire rapidamente con decreto ingiuntivo di pagamento (il credito da lavoro è di norma provato tramite busta paga e contratto). Inoltre, i crediti di lavoro godono di privilegio generale mobiliare sui beni mobili del datore (art. 2751-bis n.1 c.c.) e di un privilegio speciale immobiliare sulle immobilizzazioni dell’azienda (art. 2767 c.c. per salari degli ultimi 2 anni). Questo significa che, in caso di esecuzione forzata o concorsuale, i dipendenti saranno soddisfatti con precedenza su gran parte degli altri creditori.
In caso di insolvenza conclamata dell’impresa, i dipendenti hanno diritto di accedere al Fondo di Garanzia INPS per ottenere il TFR e alcune mensilità impagate (ma ciò richiede l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento o un’accertata cessazione attività con insufficienza attivo). I lavoratori possono anche presentare istanza di fallimento/improcedibilità (se l’azienda è fallibile) per tutelare i propri crediti. Inoltre, la mancata corresponsione degli stipendi può configurare violazioni amministrative e, se accompagnata da altri illeciti (ad es. “paghe in nero” o sfruttamento), può attirare accertamenti ispettivi e sanzioni.
Debiti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL)
Connessi ai dipendenti (o al lavoro autonomo del titolare) sono i debiti verso gli enti previdenziali: principalmente INPS (contributi pensionistici) e INAIL (premi assicurativi contro gli infortuni). Per i dipendenti, ogni mese la merceria deve versare i contributi: una quota a carico del lavoratore (trattenuta in busta paga) e una quota a carico del datore. Analogamente, l’imprenditore individuale è tenuto ai contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) commercianti sul proprio reddito minimale, e all’iscrizione INAIL se ha lavoranti. Il mancato versamento dei contributi genera debiti previdenziali che vengono poi notificati tramite avvisi di addebito INPS (titoli esecutivi analoghi alle cartelle) o iscritti a ruolo per la riscossione da parte di AER.
Questi debiti godono di privilegi similmente ai tributi (contributi previdenziali hanno privilegio generale sui mobili ex art. 2753 c.c. e anche uno speciale su immobili aziendali per gli ultimi 2 anni, art. 2778 c.c.). Inoltre, se il datore omette di versare le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti (ossia la quota a carico del lavoratore) per oltre €10.000 annui, commette un reato (punito dall’art. 2 D.Lgs. 8/2016 con la reclusione fino a 3 anni). Attualmente somme inferiori sono depenalizzate (illecito amministrativo), ma resta l’obbligo di pagamento. INPS e INAIL hanno strumenti simili al Fisco per il recupero: iscrizioni a ruolo, ingiunzioni e pignoramenti. Possono anche opporsi a richieste di DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), impedendo all’azienda di ottenere certificati di regolarità necessari per appalti o altri benefici.
Altre possibili passività
Oltre ai casi principali sopra elencati, una merceria potrebbe avere altri debiti, ad esempio: utenze commerciali (bollette luce, gas, telefono non pagate, che portano a sospensione dei servizi e affidamento a società di recupero crediti), eventuali sanzioni amministrative (multe per violazioni varie, es. mancato scontrino fiscale, violazioni norme sanitarie o di sicurezza) o debiti verso soci/familiari (finanziamenti infruttiferi fatti alla ditta). In uno scenario di crisi, spesso il titolare ricorre a prestiti personali (da familiari, amici, o usuraio in casi limite): questi generano ulteriori obbligazioni da onorare. I debiti di natura personale del titolare (come finanziamenti al consumo, carte di credito o mutui personali) possono aggravare la situazione complessiva se l’imprenditore confonde cassa dell’azienda e cassa familiare.
In sintesi, mappare tutti i debiti (fiscali, bancari, commerciali, del personale, previdenziali, ecc.) è il primo passo per affrontare la crisi. Ogni categoria di credito, infatti, segue regole proprie quanto a priorità di pagamento e rimedi legali. La tabella seguente riepiloga le principali tipologie di creditori di una merceria, con le loro caratteristiche e tutele:
| Tipo di creditore | Esempi di debito | Privilegi/Garanzie | Azioni tipiche di recupero |
|---|---|---|---|
| Erario (Fisco) | IVA, imposte su redditi, ritenute | Privilegio generale sui mobili; possibile ipoteca legale su immobili | Cartella esattoriale; fermo amministrativo su veicoli; ipoteca; pignoramento beni e conti; divieto di prima casa se unica abitazione |
| Enti previdenziali | Contributi INPS, premi INAIL | Privilegi analoghi al Fisco (generale e speciale ultimi 2 anni) | Avviso di addebito esecutivo; cartella; azioni esecutive tramite AER; diniego DURC |
| Banca (garantito) | Mutuo ipotecario, leasing | Ipoteca su immobili; riserva proprietà/locazione su beni; pegno titoli | Decadenza dal termine e risoluzione contratto; precetto e esecuzione immobiliare (es. pignoramento e vendita immobile ipotecato) |
| Banca (chirografo) | Fido scoperto, prestito non garantito | — (chirografo, salvo fideiussione) | Decreto ingiuntivo; pignoramento conti, arredi, ecc.; segnalazione sofferenza in Centrale Rischi |
| Fornitore | Forniture di merci non pagate | In genere chirografo; se patto riserva, può rivendicare merce fornita; locatore ha privilegio su beni in locali affittati | Decreto ingiuntivo rapido (credito commerciale documentato); se insolvenza grave può chiedere fallimento (se soglia debiti >30k) |
| Dipendenti | Stipendi, TFR, contributi a carico dip. | Privilegio generale (ultimi 6 mesi retrib.) e TFR; privilegio speciale su beni impresa (ultimi 2 anni); prededuzione Fondo Garanzia INPS | Decreto ingiuntivo (titolo esecutivo veloce); istanza di fallimento se dovuto; accesso Fondo di Garanzia (in concorso); insinuazione privilegiata in procedure |
| Locatore | Canoni di affitto locali | Privilegio su beni mobili del conduttore nei locali (per 2 anni canoni) | Sfratto per morosità (rilascio immobile); precetto per somme; pignoramento beni presenti nel locale affittato |
| Altri (privati, familiari) | Prestiti personali, fornitori minori | Di regola chirografo (nessuna garanzia) | Solleciti bonari; eventuale decreto ingiuntivo se riconoscibile; azioni esecutive possibili come per altri crediti |
Legenda: Privilegio = diritto di precedenza nel pagamento; chirografo = creditore senza garanzie, pagato solo dopo privilegiati; prededuzione = credito da soddisfare prima di altri (es. spese procedura); AER = Agenzia Entrate Riscossione.
Conseguenze del mancato pagamento
Vediamo ora cosa succede se la merceria non paga i propri debiti, analizzando le azioni legali che i creditori possono intraprendere e gli effetti sul patrimonio dell’imprenditore.
Azioni legali ed esecutive dei creditori
Ogni creditore, a seconda della natura del credito, può attivare specifiche procedure per recuperare coattivamente le somme dovute:
- Decreto ingiuntivo e pignoramento: Come anticipato, fornitori, banche e altri creditori privati di norma ricorrono al decreto ingiuntivo. Ottenuto il decreto ed esperiti eventuali opposizioni, il passo successivo è il pignoramento dei beni del debitore. Il pignoramento è l’atto con cui l’ufficiale giudiziario vincola i beni (mobili, immobili o crediti presso terzi) per destinarli alla soddisfazione forzata. Ad esempio, un fornitore non pagato può far pignorare la merce sugli scaffali o i macchinari della merceria; oppure i saldi attivi del conto corrente bancario del titolare; o ancora le somme dovute al negozio dai suoi clienti (pignoramento presso terzi). Segue la vendita forzata dei beni pignorati (asta giudiziaria) o l’assegnazione delle somme pignorate al creditore procedente.
- Cartella esattoriale e riscossione coattiva: L’Agenzia Entrate Riscossione, senza passare dal giudice, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, può avviare direttamente misure esecutive. In particolare può disporre il fermo amministrativo sui veicoli intestati al debitore (iscrizione al PRA che impedisce di circolare e vendere l’auto); può iscrivere ipoteca su beni immobili (ad esempio sulla casa di proprietà, se il debito supera €20.000); infine può procedere a pignoramenti dei beni. Un importante limite oggi vigente: AER non può pignorare l’abitazione principale del debitore se questi vi risiede anagraficamente, non è di lusso e costituisce l’unico immobile di proprietà – in tal caso, pur potendo iscrivere ipoteca, è preclusa l’espropriazione forzata (art. 76 del DPR 602/1973, introdotto nel 2013). Al di fuori di questa ipotesi protetta, il Fisco può pignorare immobili (es. una seconda casa, un negozio di proprietà) e metterli all’asta per recuperare le imposte dovute. Può anche pignorare i conti correnti (con una procedura più celere: invia un ordine diretto alla banca di blocco delle somme fino a concorrenza del debito) e stipendi/pensioni presso terzi (nei limiti di un quinto, o di un decimo se trattamenti minimi).
- Azioni conservative: In attesa di esecuzione, un creditore timoroso di perdere garanzie può chiedere al giudice misure come il sequestro conservativo dei beni del debitore (blocco cautelare di beni in attesa di sentenza). Ad esempio, se la banca ha motivo di credere che l’imprenditore stia distraendo attivo, può ottenere un sequestro sui conti o su un immobile per evitare che venga venduto prima del pignoramento.
- Interessi moratori e sanzioni: Il mancato pagamento porta anche all’aumento del debito per interessi di mora. Tra privati commerciali si applica il D.Lgs. 231/2002, che prevede interessi moratori elevati sulle transazioni commerciali oltre i termini pattuiti (tasso BCE + 8%, salve diverse pattuizioni). Il Fisco applica interessi legali di dilazione e sanzioni amministrative per omesso versamento (di regola 30% dell’imposta non pagata, ridotta se pagata tardivamente con ravvedimento operoso). INPS e INAIL similmente applicano sanzioni civili per omesso versamento contributivo, che possono crescere col protrarsi del ritardo (fino al 40% circa del dovuto, oltre interessi). Questi oneri aggiuntivi fanno lievitare rapidamente l’esposizione complessiva.
- Segnalazioni e conseguenze indirette: Abbiamo accennato alla segnalazione nelle banche dati creditizie (Centrale Rischi) per debiti bancari insoluti. Anche la pubblicazione di protesti (assegni o cambiali non pagate) è un tipico effetto: se il titolare emette un assegno e va in scoperto, verrà protestato e iscritto al Registro Informatico Protesti, con danno reputazionale e impossibilità di emettere assegni per almeno 6 mesi. Inoltre, un fornitore insoddisfatto potrebbe interrompere le forniture (“blocco fornitori”), aggravando la crisi di liquidità dell’esercizio.
In generale, quando un creditore ottiene un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cartella scaduta, ecc.), può aggredire qualunque bene del debitore salvo quelli dichiarati impignorabili dalla legge. Per un imprenditore individuale questo include i beni personali e familiari, dato che non c’è distinzione netta tra patrimonio dell’impresa e patrimonio proprio (approfondiremo nel prossimo paragrafo). In caso di società, invece, i beni aggredibili sono in primis quelli intestati alla società; tuttavia, se il socio ha prestato garanzie personali o se si tratta di società di persone (come la S.n.c. o S.a.s.), anche il patrimonio personale dei soci può essere coinvolto.
Responsabilità patrimoniale e rischio fallimento
Il perdurare dell’insolvenza può portare, per le imprese che superano certe dimensioni, all’apertura di una procedura concorsuale (fallimento o altre). Un creditore (o l’imprenditore stesso) può chiedere al tribunale la dichiarazione di liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento) se l’impresa è insolvente e non è “minore” ai sensi di legge. In base all’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi (CCII), sono considerati “imprenditori minori” – e quindi non fallibili – quelli che nei tre esercizi precedenti non hanno superato congiuntamente tre soglie dimensionali: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi lordi ≤ €200.000, debiti totali ≤ €500.000. Se la merceria rientra in tutti questi parametri, non potrà essere assoggettata a fallimento (liquidazione giudiziale); diversamente, se anche in un solo anno uno di tali limiti è stato superato, l’impresa è potenzialmente fallibile. Oltre a ciò, esiste un’ulteriore soglia: almeno €30.000 di debiti scaduti e non pagati in totale. La legge infatti stabilisce che non si può aprire una procedura concorsuale se il totale dei debiti scaduti è inferiore a 30mila euro (per evitare fallimenti “per piccole somme”). Tale importo va considerato nel complesso, sommando tutte le esposizioni scadute: ad esempio, 5 debiti da €10.000 ciascuno formano €50.000 scaduti, quindi sopra soglia; viceversa €25.000 totali di debiti scaduti non consentono il fallimento. Lo ha chiarito anche la Cassazione, affermando che la soglia si riferisce all’ammontare complessivo delle obbligazioni scadute, indipendentemente dal singolo creditore istante. Inoltre, trucchetti come rateizzare all’ultimo momento un debito fiscale non eludono la soglia: secondo Cass. civ. n. 4201/2025, un debito tributario rateizzato conta comunque come importo scaduto ai fini del limite di €30.000, perché la rateazione non estingue il debito originario (lo rende solo dilazionato).
Se la merceria è fallibile e la crisi non viene risolta, uno o più creditori possono quindi presentare istanza di fallimento al tribunale competente. L’imprenditore potrebbe trovarsi spogliato della gestione, con un curatore nominato a liquidare i suoi beni per pagare i creditori (vedremo in seguito i dettagli della liquidazione giudiziale). Anche l’imprenditore individuale è soggetto a fallimento personale: tutti i suoi beni (presenti e futuri) diventano parte della procedura, salvo i beni impignorabili per legge. La dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale) comporta altresì l’interdizione dell’imprenditore da attività commerciali (non potrà amministrare altre società finché dura la procedura) e, in caso di condotte irregolari, può sfociare in imputazioni penali (ad esempio bancarotta semplice o fraudolenta, se ha aggravato la situazione con azioni dolose, distratto beni, falsificato le scritture contabili, ecc.).
Riassumendo: il mancato pagamento persistente espone la merceria a azioni esecutive mirate (pignoramenti, ipoteche, fermi) da parte dei vari creditori, e se il debito complessivo è ingente e l’impresa non è microscopica, può condurre a una procedura concorsuale che centralizza la crisi (concordato preventivo o liquidazione fallimentare). Nel prossimo paragrafo analizziamo nel dettaglio la responsabilità patrimoniale dell’imprenditore individuale, ossia fino a che punto i creditori possono aggredire i suoi beni personali per i debiti dell’attività.
Responsabilità patrimoniale dell’imprenditore individuale
Uno snodo cruciale è comprendere che, se la merceria è esercitata in forma individuale, non c’è distinzione giuridica tra patrimonio dell’impresa e patrimonio personale del titolare. L’art. 2740 del Codice Civile sancisce il principio generale di responsabilità patrimoniale: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Nel caso dell’imprenditore individuale, ciò significa che tutti i beni personali (la casa, l’auto, il conto bancario personale, ecc.) possono essere aggrediti dai creditori dell’attività. Questo comporta un rischio elevato: le difficoltà economiche dell’azienda mettono in pericolo l’intero patrimonio familiare dell’imprenditore.
Di contro, se la merceria fosse esercitata tramite una società di capitali a responsabilità limitata (ad esempio una S.r.l.), varrebbe la separazione patrimoniale: i debiti della società si possono soddisfare solo sul patrimonio sociale, e i beni personali dei soci sarebbero protetti – a meno che i soci abbiano prestato garanzie personali (fideiussioni) o che abbiano tenuto condotte tali da far loro perdere la protezione (es. pagamenti preferenziali o confusione patrimoni, che in fallimento potrebbero portare ad azioni di responsabilità verso gli amministratori). Tuttavia, nel tessuto commerciale italiano molte mercerie sono ditte individuali o società di persone, dove la responsabilità è illimitata: nelle S.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente, nelle S.a.s. i soci accomandatari rispondono illimitatamente. Dunque in tali casi i creditori professionali possono facilmente colpire i beni personali dell’imprenditore o dei soci.
Quali beni personali sono aggredibili? In linea di massima tutti, salvo eccezioni previste dalla legge come impignorabili. Ad esempio: gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione del debitore sono impignorabili nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento (art. 515 c.p.c.); alcuni beni di uso quotidiano (letto, cucina, vestiti, elettrodomestici base) sono impignorabili (art. 514 c.p.c.). La prima casa – come visto – è protetta solo nei confronti del Fisco (se unica e residenza del debitore) ma non verso gli altri creditori: una banca o un fornitore munito di titolo può ipotecare e pignorare anche la casa di abitazione dell’imprenditore individuale. Ci sono, però, strumenti giuridici di tutela del patrimonio che l’imprenditore accorto può attivare prima o durante la crisi per limitare i danni:
- Fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.): È un vincolo che i coniugi (o un singolo in regime di unione civile/famiglia) possono costituire su beni immobili, mobili registrati o titoli, destinandoli ai bisogni della famiglia. I beni conferiti nel fondo rispondono solo dei debiti contratti per bisogni familiari; non possono essere aggrediti per obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). La Cassazione ha chiarito che i debiti dell’attività imprenditoriale sono normalmente estranei ai bisogni familiari, salvo prova contraria. Ciò significa che, ad esempio, se l’imprenditore aveva costituito un fondo patrimoniale con la casa coniugale, i creditori derivanti dall’attività (fornitori, banche, Fisco per imposte dell’azienda, ecc.) in linea generale non potranno pignorare tale casa. Far valere questa tutela richiede un’opposizione all’azione esecutiva, ove il debitore dimostri la regolare costituzione del fondo e la natura estranea del debito ai bisogni familiari. Il creditore può solo tentare di provare che quel debito specifico era eccezionalmente contratto nell’interesse della famiglia (evenienza rara, ad esempio se dimostrasse che il prestito bancario aziendale fu utilizzato per spese famigliari). Attenzione però: il fondo patrimoniale deve essere costituito “in tempi non sospetti e per finalità lecite” – se viene creato quando già ci sono debiti in sofferenza, rischia di essere revocato come atto in frode ai creditori (azione revocatoria ex art. 2901 c.c., esercitabile dai creditori entro 5 anni). Inoltre, dal 2015 l’art. 2929-bis c.c. consente ai creditori, in alcuni casi, di aggredire direttamente beni conferiti in un fondo o trust senza attendere l’esito di una revocatoria formale, se l’atto di costituzione è successivo al sorgere del credito e a titolo gratuito. Quindi il fondo offre protezione preventiva, ma non può essere usato all’ultimo momento per sottrarre beni ai creditori: il tribunale annullerebbe l’operazione in caso di malafede.
- Trust e altri strumenti di asset protection: Similmente al fondo, un trust interno può segregare beni (es. l’imprenditore trasferisce un immobile a un trustee da gestire per i figli). Se istituito molto prima e con scopi legittimi, i creditori non potranno colpire quei beni, perché non sono più nel patrimonio del debitore. La Cassazione riconosce la validità del trust come strumento di protezione “familiare” purché non sia fraudolento. Tuttavia anche il trust è vulnerabile ad azione revocatoria fallimentare se creato in pregiudizio dei creditori: il curatore può impugnare sia il conferimento dei beni sia l’atto istitutivo stesso. Ed esiste la citata scorciatoia di legge (art. 2929-bis c.c.) per pignorare beni donati o messi in trust dal debitore insolvente senza dover fare causa, quando certi requisiti sono soddisfatti. Altri strumenti come l’intestazione fiduciaria (far risultare un terzo proprietario fiduciario dei beni) o la holding (conferire i beni in una società) possono offrire schermi, ma se l’intento è frodare i creditori, vengono smontati dal giudice. Insomma, la pianificazione patrimoniale deve avvenire in bonis (quando l’azienda è ancora sana) e in modo lecito per essere efficace. Fatto ciò, durante la crisi è troppo tardi per salvare beni con artifici: trasferimenti simulati o fittizi peggiorano solo la posizione dell’imprenditore, esponendolo a possibili sanzioni penali (bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte se riguarda debiti fiscali, ecc.) e comunque risultano inefficaci verso i creditori.
- Regime patrimoniale coniugale: Un breve cenno al fatto che se l’imprenditore è sposato in regime di separazione dei beni, i beni intestati esclusivamente all’altro coniuge non dovrebbero essere toccati dai creditori dell’imprenditore. In regime di comunione dei beni, invece, i creditori dell’impresa individuale possono far valere le ragioni anche sui beni comuni fino al valore corrispondente alla quota del coniuge debitore (di regola metà). Ad ogni modo, i debiti contratti per bisogni familiari obbligano solidalmente entrambi i coniugi ex art. 186 c.c. – ma i debiti d’impresa, come detto, non rientrano in questi se non provato diversamente. Quindi la moglie/marito dell’imprenditore non è direttamente responsabile dei debiti di merceria (salvo abbia co-firmato impegni, es. come garante).
In conclusione, l’imprenditore individuale risponde con tutto il suo patrimonio dei debiti dell’azienda. Questa responsabilità illimitata è il rovescio della medaglia della facilità di gestione della ditta individuale. Ci sono strumenti per tutelare i beni personali, ma devono essere adottati per tempo e correttamente (fondo patrimoniale, trust, assicurazioni vita impignorabili, ecc.), e comunque non garantiscono scudo assoluto in situazioni di insolvenza conclamata. Nell’ottica di difendersi, il titolare di merceria indebitata dovrà piuttosto puntare su strumenti di risanamento del debito, ossia modalità per ridurre o ristrutturare l’esposizione (che vedremo tra poco), oppure procedure concorsuali di composizione della crisi che permettono di gestire tutti i crediti in modo unitario. Queste vie, oltre a proteggere il debitore (ad esempio con il blocco delle azioni esecutive), possono condurre all’esdebitazione, ovvero alla liberazione dai debiti residui al termine della procedura, come previsto oggi dalla legge. Prima di illustrare tali procedure giudiziali, analizziamo quali soluzioni extragiudiziali ha a disposizione l’imprenditore per uscire dalla crisi o alleviarne gli effetti, senza ricorrere immediatamente ai tribunali.
Strumenti extragiudiziali di gestione del debito
Di fronte a una situazione di debito divenuta ingovernabile, la prima strada da tentare è spesso quella extragiudiziale, ovvero cercare soluzioni tramite accordi privati o piani di rientro senza attivare subito una procedura concorsuale. Questo approccio ha il vantaggio di evitare la pubblicità di un fallimento o il costo/complessità di un procedimento giudiziario, e può permettere di mantenere in vita l’attività. Tuttavia, richiede la collaborazione dei creditori e la sostenibilità delle proposte. Ecco i principali strumenti extragiudiziali:
Negoziazione diretta e accordi stragiudiziali
Parlare con i creditori è spesso il primo passo. Molti creditori preferiscono evitare le vie legali lunghe e costose, soprattutto se intravedono la possibilità di recuperare il dovuto (anche solo in parte) attraverso un accordo. Il titolare della merceria, magari assistito dal proprio consulente o legale, può proporre a ciascun creditore un piano di rientro stragiudiziale, ad esempio: – Dilazione di pagamento: pagare il dovuto a rate mensili/trimestrali. Questa opzione è frequente con i fornitori: si stila un piano (magari garantito da cambiali per dare sicurezza al creditore) in cui la merceria si impegna a saldare l’arretrato su un periodo concordato. Il fornitore potrebbe condizionare ciò a pagamenti correnti regolari per le forniture future (per non continuare ad accumulare debiti). – Saldo e stralcio: il debitore offre un pagamento immediato parziale a chiusura totale del debito. Ad esempio, deve €10.000 e propone “ti pago subito €6.000 e ci consideriamo pari”. Molti creditori potrebbero accettare un taglio del debito se dubitano di recuperarlo per intero o se ciò evita tempi lunghi. Il “saldo-stralcio” è comune soprattutto con società di recupero crediti o banche su posizioni incagliate: spesso i crediti deteriorati vengono ceduti e il nuovo creditore, avendoli acquistati a prezzo ridotto, può essere interessato a chiudere rapidamente con un importo inferiore al nominale. – Transazione su importi contestati: se ci sono contestazioni (es. il fornitore A chiede €5.000 ma il negoziante contesta parte della fornitura difettosa), le parti possono accordarsi per una cifra di compromesso, evitando la causa. – Rinegoziazione di contratti in corso: ad esempio, col proprietario dei locali si può rinegoziare il canone d’affitto (una riduzione temporanea) per permettere al negozio di restare aperto e non costringere al rilascio. Col fornitore abituale si può rinegoziare il listino o i termini di pagamento futuri. Con la banca si può provare a ristrutturare il mutuo (allungando la durata per abbassare le rate) o a convertire lo scoperto di conto in un finanziamento rateale. – Moratorie consensuali plurilaterali: Se la crisi è conosciuta, talvolta più creditori concordano informalmente di concedere tempo (moratoria) senza agire legalmente, magari monitorando la situazione. Questo succede soprattutto se intravedono che un’aggressione immediata porterebbe al fallimento e minor soddisfazione per tutti. Una comunicazione chiara sull’intenzione di risanare può favorire tali intese.
Importante: ogni accordo stragiudiziale conviene sia formalizzato per iscritto, così da essere opponibile (ad es. un piano di rientro firmato interrompe la prescrizione e fa da prova dell’intesa). In taluni casi, si può ricorrere a un mediatore civile o un esperto per facilitare l’accordo, specie se ci sono molti creditori (mediazione o assistenza di associazioni di categoria, ecc.). Tuttavia, va detto che gli accordi volontari non vincolano i creditori dissenzienti: basta un creditore aggressivo per far saltare la pace. Per questo, in presenza di più creditori, può rendersi necessario passare a strumenti omologati dall’autorità (vedi oltre accordi ex art.182-bis L.F. o procedure di sovraindebitamento), che possono imporre la soluzione anche alle minoranze contrarie.
Dilazioni e definizioni agevolate con il Fisco
I debiti fiscali e contributivi, come visto, vengono riscossi tramite AER con poteri speciali. Tuttavia, anche qui c’è spazio per soluzioni extragiudiziali: – Rateizzazione ordinaria delle cartelle: Ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973, il debitore può chiedere all’Agenzia Riscossione un piano fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000, o fino a 120 rate (10 anni) se prova grave e comprovata difficoltà economica per importi superiori (o a prescindere dall’importo in caso di comprovata temporanea situazione di obiettiva difficoltà). Attualmente (dopo modifiche recenti) per debiti sotto €120.000 la dilazione è concessa con semplice istanza senza dover dare prova di difficoltà; per importi maggiori serve documentazione della situazione di crisi. La rateazione blocca le azioni esecutive di AER: finché il piano è rispettato, non partono nuovi fermi/ipoteche/pignoramenti e quelli in essere possono essere sospesi. Attenzione: se si saltano più di 5 rate, la rateazione decade e l’intero importo torna riscuotibile immediatamente. – Definizione agevolata (Rottamazione): Negli ultimi anni più volte il legislatore ha introdotto misure di condono parziale dei debiti fiscali iscritti a ruolo. L’ultima in ordine di tempo è la Rottamazione-quater 2023 prevista dalla L. 197/2022: essa consente di estinguere i debiti affidati all’Agente Riscossione dal 2000 al 30/6/2022 pagando solo il capitale, gli interessi legali e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora. Il pagamento può avvenire anche a rate (fino a 18 rate in 5 anni) con interesse ridotto al 2%. Chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2023 ha ottenuto la sospensione delle azioni di recupero e il beneficio di poter sanare a costi ridotti. Altre misure della “tregua fiscale 2023” includono lo stralcio automatico dei debiti minori (<€1.000 affidati fino al 2015, cancellati ex lege) e la riduzione delle sanzioni su avvisi bonari. Bisogna monitorare eventuali nuove definizioni agevolate in finanziarie future: in periodi di difficoltà diffusa, è frequente che lo Stato offra queste vie di sanatoria. – Transazione fiscale e contributiva (strumento misto): Fuori da condoni generalizzati, esiste la possibilità di trattare con Fisco e INPS all’interno di una procedura concorsuale (concordato preventivo o sovraindebitamento). Nella sede extragiudiziale pura, invece, l’unica via per abbattere il carico tributario sarebbe pagare e poi presentare istanze di sgravio o contenzioso per eventuali importi non dovuti. In generale, l’Agenzia difficilmente accetta stralci extragiudiziali volontari delle imposte: la riduzione la si ottiene solo in sede di concordato preventivo (dove il voto del Fisco implica accettazione del trattamento proposto) o di accordo di ristrutturazione omologato. Tuttavia, l’INPS ha uno strumento di transazione dei contributi previsto dall’art. 116, comma 5, L. 388/2000, che può essere richiesto dalle aziende in crisi anche in via stragiudiziale per ottenere dilazioni e riduzioni su sanzioni civili: è una sorta di “concordato contributivo” amministrativo, ma in pratica viene poco utilizzato al di fuori di procedure concorsuali vere e proprie.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021) e ora disciplinata nel Codice della Crisi agli artt. 12-25 CCII, la composizione negoziata è una procedura stragiudiziale assistita destinata alle imprese (anche piccole) in situazione di crisi o insolvenza reversibile. Si tratta di un percorso volontario: l’imprenditore, tramite una piattaforma telematica nazionale, richiede la nomina di un Esperto indipendente (di regola un commercialista o professionista della crisi) il quale ha il compito di facilitare le trattative con i creditori e ricercare una soluzione per il risanamento. La procedura è riservata (non viene pubblicata finché non si raggiunge o meno un accordo) e mira a evitare l’insolvenza conclamata.
Vantaggi della composizione negoziata: – L’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda, affiancato però dall’Esperto che monitora e indirizza. – Si possono chiedere al tribunale delle misure protettive durante le trattative: ad esempio la sospensione per 120 giorni (prorogabili fino a 240) delle azioni esecutive dei creditori. Questo stay tutela dal pignoramento mentre si cerca l’accordo. – Si possono anche ottenere autorizzazioni urgenti dal giudice per finanziamenti prededucibili o cessione di beni non core, allo scopo di sostenere l’attività nel frattempo. – Entro 180 giorni si cerca di raggiungere un accordo con i creditori: può trattarsi di un contratto di ristrutturazione del debito, di una modifica delle scadenze, di un aumento di capitale o cessione azienda a terzi, etc., a seconda dei casi.
Se la negoziazione ha successo, il risultato resta extragiudiziale: l’accordo raggiunto può essere omologato come accordo di ristrutturazione (se hanno aderito le percentuali richieste) oppure eseguito privatamente (es. nuovi contratti). Se la negoziazione fallisce, l’imprenditore ha comunque alcune vie di uscita: – Può accedere a un concordato semplificato per la liquidazione: strumento introdotto dall’art. 25-sexies CCII (D.L. 118/2021) che consente, in caso di esito negativo della composizione negoziata, di chiedere al tribunale l’omologa di un concordato liquidatorio anche senza voto dei creditori. È di fatto una scorciatoia per liquidare l’azienda sotto controllo giudiziario evitando la normale procedura di concordato preventivo (richiede che l’esperto attesti che gli accordi negoziati non sono stati raggiunti e che la proposta liquidatoria sia vantaggiosa per i creditori). – In alternativa, l’imprenditore può comunque optare per le procedure ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) se la negoziazione non ha risolto.
Per una piccola merceria, la composizione negoziata è uno strumento innovativo e potenzialmente utile se si vuole tentare di salvare l’attività con l’accordo dei principali creditori. Ad esempio, potrebbe permettere di contrattare con la banca una moratoria sui debiti finanziari e con il Fisco una dilazione ulteriore, il tutto tenendo a bada nel frattempo i fornitori aggressivi tramite la protezione del tribunale. È però un procedimento che richiede la redazione di un piano di risanamento credibile e la presenza di almeno qualche prospettiva di inversione di tendenza (non funziona se la situazione è irrecuperabile).
Piani attestati di risanamento
Il piano attestato di risanamento (disciplinato dall’art. 56 CCII, già art. 67 LF) è uno strumento negoziale puro: consiste in un accordo privatistico tra il debitore e alcuni o tutti i creditori, inserito in un piano economico-finanziario volto a risanare l’impresa, il cui buon esito viene attestato da un professionista indipendente. La caratteristica principale è che il piano attestato, se formalizzato secondo la legge, non è soggetto ad azioni revocatorie fallimentari (art. 67, co.3, lett. d) L.F.): in caso di successivo fallimento, gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano non potranno essere revocati dal curatore. Questo safe harbor serve a incentivare creditori e terzi a sostenere l’impresa in crisi (es. concedere nuova finanza o continuare forniture) senza temere che, se poi il debitore fallisce, quanto fatto venga annullato.
In pratica, un piano attestato funziona così: la merceria elabora con l’aiuto di consulenti un piano di rilancio (ad esempio riduzione costi, apporto di capitali, dismissione beni, ecc.) e un accordo con eventuali creditori disponibili (es. banche che estendono scadenze, fornitori che accettano acconti). Un attestatore (commercialista o revisore) verifica i dati e certifica che “il piano è idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria” e a garantire l’equilibrio finanziario. Il piano e l’attestazione vengono poi pubblicati nel registro delle imprese. Da quel momento, gli atti esecutivi del piano sono protetti dalla revocatoria. Il piano attestato non richiede il consenso di tutti i creditori (è sufficiente accordarsi con quelli strategici) e non necessita omologazione del tribunale: è un contratto privato, benché pubblicizzato.
Per una micro-impresa come la merceria, il piano attestato può essere oneroso in proporzione (bisogna pagare un attestatore e preparare documentazione dettagliata). È più indicato per aziende un po’ più grandi. Nel contesto di questa guida avanzata, basti sapere che è uno strumento disponibile, utile se vi sono creditori fondamentali disposti a supportare la continuità aziendale. Ad esempio, la merceria potrebbe avere una banca che, di fronte a un piano serio (magari con la vendita di un immobile di famiglia per ridurre il debito), accetta di rifinanziare l’esposizione residua; l’attestatore convalida che così l’attività torna sostenibile; l’accordo viene pubblicato e vincolerà solo la banca e i soggetti coinvolti (gli altri creditori non aderenti restano fuori e vanno comunque soddisfatti regolarmente). In caso di successivo default, almeno gli atti compiuti in base a quel piano (pagamenti fatti, beni dati in garanzia) saranno salvi da contestazioni.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Salendo di livello, esiste la possibilità di concludere un accordo di ristrutturazione con i creditori, avente efficacia anche per i dissenzienti, purché omologato dal tribunale. Questo strumento, erede dell’istituto dell’art. 182-bis della vecchia legge fallimentare, si pone a metà strada tra l’extragiudiziale e il concorsuale: è negoziato privatamente ma viene “benedetto” dal giudice che lo rende vincolante erga omnes (o quasi). I requisiti sono: – L’accordo deve essere sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti totali (salvo accordi speciali “agevolati” introdotti dal 2022 che consentono percentuali minori in certi casi). – Deve accompagnarsi a un piano industriale che assicuri l’equilibrio e il pagamento integrale dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza o omologa. – Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e l’attuabilità dell’accordo.
Se queste condizioni ci sono, il debitore deposita l’accordo in tribunale chiedendone l’omologazione. I creditori che hanno aderito saranno vincolati secondo i termini pattuiti (che possono prevedere dilazioni, stralci, conversione di crediti in quote, ecc.). I creditori non aderenti restano fuori: devono essere pagati integralmente, ma l’omologazione impedisce azioni individuali in contrasto con l’accordo e consente di ottenere, ad esempio, la moratoria delle azioni esecutive dai giudici. Esistono varianti di accordo: – Accordo ad efficacia estesa: se mancano all’appello alcune categorie di creditori finanziari (banche) dissenzienti, in certi casi il tribunale può estendere loro gli effetti dell’accordo se quelli aderenti nella stessa categoria superano il 75% (principio di cram-down settoriale). – Accordo agevolato al 30%: dopo il recepimento direttiva UE, è stato introdotto un accordo possibile anche con soli creditori pari al 30% dei debiti, ma deve prevedere l’apporto di risorse esterne che aumentino soddisfazione creditori di almeno il 10% e l’esperto indipendente deve attestare che l’accordo è più conveniente del fallimento per i creditori. Questo rende più accessibile lo strumento in crisi severe.
Per la nostra merceria, un accordo di ristrutturazione “classico” è probabilmente poco pratico a meno di debiti molto consistenti e presenza di pochi creditori principali. Infatti serve il 60% di adesioni: nel caso tipico di una merceria con molti piccoli fornitori, difficilmente si raggiunge quella maggioranza in valore se non includendo il Fisco e la banca. Questi di solito preferiscono il concordato preventivo (più formale) se devono accettare decurtazioni. Tuttavia, se per ipotesi i debiti fossero concentrati in uno-due soggetti (es. una banca e un grosso fornitore), l’accordo potrebbe essere uno strumento di soluzione rapida, con costi minori di un concordato. È da notare che l’accordo non comporta necessariamente un blocco generale delle azioni (il tribunale può dare misure protettive, ma non c’è automatic stay come nel concordato). Spesso lo si usa come strumento per ristrutturare debiti bancari di medie imprese.
Transazioni su singoli debiti specifici
Non va poi dimenticato che, su singoli fronti, ci sono spazi di trattativa peculiari: – Con la banca, oltre a rinegoziare il piano del mutuo come detto, si può esplorare la via del “piano di rientro assistito da garanzia dello Stato” (se esistono normative al momento, ad es. finanziamenti Covid garantiti – che se non si riescono a pagare possono essere rinegoziati con il Fondo centrale). – Con i dipendenti, se c’è un buon rapporto, si può chiedere di dilazionare il pagamento degli arretrati o concordare una risoluzione del rapporto con corresponsione del TFR a rate. Serve il loro consenso informato (magari firmando transazioni in sede sindacale). Questo può prevenire cause di lavoro immediatissime. Va però ponderato: non pagare i dipendenti è ultima ratio, e solo con un dialogo e trasparenza si può sperare nella loro pazienza. – Con i nuovi creditori: se la merceria continua ad operare, è cruciale non accumulare altri debiti. Meglio gestire in “codice cassa” (pagare alla consegna) i nuovi fornitori e magari ottenere dai vecchi fornitori forniture in conto vendita (pagamento solo sul venduto, così non incrementa esposizione). – Associazioni di categoria e organismi di mediazione: talvolta, camere di commercio o associazioni (Confesercenti, Confcommercio) offrono servizi di composizione bonaria tra associati e creditori, o convenzioni con banche per consolidare debiti a tassi agevolati. Vale la pena informarsi in loco.
In sintesi, sul piano extragiudiziale l’imprenditore ha diverse frecce al suo arco: accordi individuali, dilazioni e saldo e stralcio (giocando sulla convenienza reciproca), strumenti istituzionali come la composizione negoziata (con un esperto terzo), e meccanismi legali come piani attestati e accordi di ristrutturazione che, pur essendo formalizzati, restano basati sul consenso. Spesso la soluzione migliore è combinare più strumenti: ad esempio, negoziare con la banca un rifinanziamento e con il fisco una rateazione, mentre si fa un piano di rientro coi fornitori. Se però il quadro è troppo compromesso – ossia i debiti superano di gran lunga la capacità di rimborso, e qualche creditore si oppone agli accordi – occorre valutare le procedure giudiziali previste dalla legge, che permettono di imporre un trattamento anche ai dissenzienti e di gestire la crisi in modo organico, come vedremo ora.
Strumenti giudiziali: sovraindebitamento e procedure concorsuali
Quando l’accordo bonario non è sufficiente o non percorribile, l’ordinamento offre una serie di procedure giudiziarie per regolare la crisi debitoria. Tali procedure presentano regole più rigide ma garantiscono alcuni benefici al debitore onesto: in primis il blocco delle azioni esecutive individuali (una sorta di “tregua legale” durante la procedura) e, una volta completate, la possibile esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Bisogna distinguere a seconda della qualifica del debitore: – Se la merceria è un imprenditore non fallibile (imprenditore “minore” sotto soglia, oppure un privato consumatore), allora le procedure applicabili rientrano nell’ambito del sovraindebitamento (disciplinato dal Titolo IV, Capo II CCII). Queste procedure discendono dalla Legge 3/2012 – integrata nel Codice della Crisi dal 2022 – e sono pensate per piccoli debitori. – Se invece l’impresa è soggetta a fallimento (supera le soglie dimensionali o è una società di capitali senza i requisiti di non fallibilità), allora si applicano le procedure concorsuali tradizionali: concordato preventivo o liquidazione giudiziale (ex fallimento), regolate dal Codice della Crisi e, per le parti non innovate, dalla vecchia giurisprudenza fallimentare.
Esaminiamo separatamente i due ambiti.
Procedure da sovraindebitamento (per debitori non fallibili)
Il sovraindebitamento è definito dalla legge come lo stato di crisi o insolvenza di un soggetto non fallibile (consumatore, piccolissima impresa, professionista, ecc.) che non è in grado di pagare i propri debiti regolarmente. Le procedure di sovraindebitamento sono nate con la L.3/2012 e oggi, come detto, sono incorporate nel Codice della Crisi (artt. 65-83 CCII), mantenendo lo spirito originario: offrire una via d’uscita anche a chi prima era escluso dal fallimento (il c.d. “legge salvasuicidi” indicava proprio l’intento sociale di dare speranza ai debitori civili strangolati dai debiti). Il nuovo quadro normativo è orientato al favor debitoris, cioè a favorire l’accesso alle procedure per i debitori meritevoli, consentendo loro di liberarsi dai debiti insostenibili e ripartire onestamente.
Le procedure disponibili sono attualmente tre principali più una speciale: (1) la ristrutturazione dei debiti del consumatore, (2) il concordato minore, (3) la liquidazione controllata, e (4) la speciale esdebitazione del debitore incapiente. Vediamole nel dettaglio:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è la procedura riservata ai consumatori persone fisiche con debiti contratti per scopi estranei all’attività d’impresa. Ha sostituito il vecchio “piano del consumatore” della L.3/2012. La nostra merceria può usufruirne solo se il titolare ha prevalentemente debiti personali e non d’impresa. In linea di principio, se i debiti riguardano l’attività commerciale (fornitori, banca per finanziamento aziendale, IVA, etc.), il titolare non è considerato “consumatore” per quelle esposizioni. Esiste tuttavia la possibilità di gestire debiti misti qualora quelli di natura privata siano prevalenti: recenti pronunce, come il Tribunale di Napoli nel 2025, hanno confermato che un consumatore sovraindebitato può includere anche debiti di origine imprenditoriale nel piano, purché la parte consumeristica sia prevalente in valore. Questo ha riaperto la porta a piani del consumatore “misti”, dopo che un correttivo nel 2024 sembrava volerli escludere, allineando così la giurisprudenza a un principio di sostanza: guardare alla composizione dei debiti e non solo alla qualifica formale del debitore. Nella ristrutturazione del consumatore, il debitore elabora – con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o professionista nominato – un piano di pagamento dei debiti sostenibile, eventualmente con falcidie (riduzioni) e dilazioni, offrendo ai creditori tutto ciò che è ragionevolmente ottenibile dal suo patrimonio e reddito. Il piano viene sottoposto al giudice per l’omologazione, senza bisogno del voto dei creditori. Essi possono fare osservazioni, ma la decisione spetta al tribunale: se il piano appare fattibile e il debitore è meritevole (concetto di “meritevolezza” rivisto di recente, ora inteso come assenza di dolo o colpa grave nell’aver creato il sovraindebitamento), il giudice omologa il piano, rendendolo vincolante per tutti i creditori (anche dissenzienti). Da notare: con la riforma, il parametro di meritevolezza è divenuto meno stringente – non si valuta più la “colpa generica” per aver fatto troppi debiti rispetto alle capacità, ma solo eventuale colpa grave, malafede o frode del debitore. Se tali condotte mancano, il piano è ammissibile. Una volta omologato, il piano del consumatore impone ai creditori la falcidia proposta: per esempio, si può prevedere di pagare il 30% a tutti i chirografari in 5 anni, e al termine ottenere l’esdebitazione (discarico) del residuo non pagato. È uno strumento potente perché non richiede accordo dei creditori e consente di imporre la ristrutturazione, ma chiaramente il tribunale vigilerà che il sacrificio imposto sia il massimo equo possibile data la situazione del debitore.
- Concordato minore: è la procedura destinata ai debitori non fallibili che non siano consumatori (piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, imprenditori agricoli, o anche persone fisiche ex imprenditori con debiti misti). Corrisponde all’ex “accordo di composizione della crisi” della L.3/2012, ma con meccanismi più simili a un piccolo concordato preventivo. A differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano il piano proposto. In concreto, il debitore presenta al tribunale una proposta di concordato minore con un piano suddiviso eventualmente in classi di creditori e con l’indicazione delle percentuali di pagamento offerte. Ad esempio, il titolare della merceria potrebbe proporre: liquidazione dell’immobile di proprietà e pagamento del 40% ai chirografari, integrale ai privilegiati, in 2 anni. I creditori vengono convocati e esprimono il loro voto (il codice richiede maggioranze calcolate sul valore dei crediti: di regola serve il sì di almeno il 60% dei crediti ammessi al voto, salvo diverse maggioranze se classi). Se la maggioranza approva, il tribunale omologa il concordato minore, rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti. Se la maggioranza non si raggiunge, il concordato minore non viene omologato (ma il debitore potrebbe ripiegare sulla liquidazione controllata). Durante la procedura, il debitore rimane in possesso dei beni ma sotto supervisione dell’OCC e con misure protettive attivate (moratoria dei creditori similmente al concordato preventivo). Il vantaggio del concordato minore è che consente di coinvolgere anche i crediti d’impresa in una soluzione unica, senza dover pagarli integralmente (cosa che invece il piano del consumatore imponeva per i crediti esclusi). È dunque la via naturale per una merceria individuale che voglia evitare il fallimento: offre qualcosa ai creditori e chiede l’approvazione. Un aspetto positivo introdotto dalla riforma è la possibilità di cram-down fiscale: il tribunale può omologare il concordato minore anche senza il voto favorevole del Fisco o dell’INPS sui crediti tributari/contributivi, purché la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (valutata con il parere dell’attestatore). Ciò evita che un singolo no del Fisco blocchi tutto (problema emerso spesso in passato).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la procedura liquidatoria applicabile a qualsiasi debitore civile non fallibile. Equivale all’ex “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012. Può accedervi sia il debitore volontariamente, sia può essere richiesta dai creditori o disposta dal tribunale in taluni casi (ad es. conversione di un concordato minore non approvato). In sostanza, è un fallimento in miniatura: viene nominato un liquidatore giudiziale, si forma l’inventario di tutti i beni del debitore (inclusi i beni personali se è un individuo) e si procede a venderli in modo ordinato, distribuendo il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. Il debitore deve collaborare e ha obblighi informativi, ma perde la disponibilità dei beni. Anche qui valgono alcune esenzioni: non si toccano i beni impignorabili (es. gli oggetti personali di poco valore, stipendi nei limiti di legge, ecc.), e il giudice può lasciare al debitore somme necessarie al sostentamento proprio e della famiglia. La liquidazione controllata è meno stigmatizzante del fallimento classico e più snella, ma di fatto l’effetto è simile: il patrimonio del debitore viene azzerato per pagare i creditori. L’aspetto cruciale è che, a fine procedura, se il debitore è persona fisica, egli ottiene l’esdebitazione automatica dei debiti residui (salvo eccezioni per debiti alimentari, da dolo, etc.). Nel CCII, diversamente dalla vecchia legge fallimentare, l’esdebitazione è concessa di diritto dal tribunale nel provvedimento che chiude la liquidazione, a meno che vi siano opposizioni di creditori o il debitore abbia violato obblighi di lealtà. Ciò significa che, pur perdendo i beni, l’ex debitore può ripartire senza più zavorra di debiti: questo incentivo spinge molti a scegliere la liquidazione controllata volontaria quando non vi sia fattibilità di un piano di ristrutturazione. Ad esempio, un piccolo imprenditore che non vede prospettive di salvare l’attività potrebbe chiedere egli stesso la liquidazione controllata: il liquidatore venderà magari il magazzino, l’auto e altri beni, soddisferà parzialmente i creditori privilegiati, e alla fine il tribunale lo libererà dai debiti non pagati. I creditori chirografari non soddisfatti purtroppo dovranno abbandonare la pretesa (fresh start del debitore). La procedura ha tempi variabili (dipende dal tipo di beni da liquidare, potrebbe durare 1-2 anni se pochi beni mobili, più a lungo se ci sono immobili da vendere). Durante la liquidazione, le azioni esecutive individuali sono bloccate e i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo.
- Esdebitazione del debitore incapiente: questa è la novità più “forte”, introdotta a fine 2020 (D.L. 137/2020) e ora regolata dall’art. 283 CCII. Rappresenta un meccanismo straordinario: il debitore persona fisica, sovraindebitato, che non ha alcun patrimonio né capacità reddituale per soddisfare i creditori, può chiedere al tribunale di essere liberato da tutti i debiti subito, senza alcuna soddisfazione dei creditori. In altre parole, un fresh start totale “a costo zero” per il debitore. È una misura limite, con ovvie cautele:
- Può essere utilizzata una sola volta nella vita.
- Il debitore deve dimostrare la propria incapienza assoluta: né beni né redditi presenti o futuri ragionevolmente aggredibili.
- Deve aver tenuto un comportamento onesto e collaborativo: nessuna frode, nessun atto in malafede per sottrarre beni ai creditori, adempimento degli obblighi informativi e di cooperazione nelle eventuali procedure precedenti.
- Non deve aver già beneficiato di altre procedure di insolvenza con esdebitazione (non si può abbuonare i debiti a ripetizione).
- Restano comunque esclusi dall’esdebitazione alcuni debiti non “cancellabili” per legge: obblighi di mantenimento famigliare, debiti da risarcimento di danni da fatto illecito (es. risarcimento per morte o lesioni causate), sanzioni penali e amministrative pecuniarie. Questi debiti “personalissimi” restano dovuti.
L’esdebitazione dell’incapiente non richiede il consenso dei creditori (come ovvio, difficilmente lo darebbero a non ricevere nulla): è il giudice a valutare, caso per caso, se il debitore meriti questo provvedimento di clemenza. La giurisprudenza recente è stata piuttosto rigorosa: ad esempio la Cassazione n. 5678/2024 ha chiarito che l’esdebitazione non può mai essere automatica ma va concessa solo dopo un’analisi scrupolosa della condotta del debitore e delle sue prospettive, verificando soprattutto la buona fede e l’assenza di alternative concrete anche future. Alcune pronunce di merito: Tribunale di Torino 345/2025 ha concesso l’esdebitazione a un soggetto totalmente incapiente riconoscendone la piena buona fede; Corte d’Appello di Firenze 678/2025 ha invece sottolineato che se esistono prospettive future non trascurabili di miglioramento reddituale, l’esdebitazione può essere negata (non deve essere un escamotage per chi potrebbe pagare in futuro); Tribunale di Napoli 1122/2024 ha negato l’esdebitazione a chi aveva nascosto beni durante la procedura. Insomma, viene premiato solo il debitore “onestamente sfortunato” e privo di qualunque chance. Da notare: per evitare che a rimetterci siano i creditori vittime di reati (usura, estorsione), la legge di Bilancio 2024 ha previsto l’istituzione di un Fondo statale che indennizzi parzialmente tali creditori nelle procedure di esdebitazione incapienti (un dettaglio tecnico a riprova dell’attenzione del legislatore su questo punto).
In conclusione su questo blocco, per la merceria individuale sovraindebitata esistono queste vie di uscita giudiziali: – Presentare un piano se vi è reddito e patrimonio sufficiente a offrire una percentuale decente ai creditori (piano del consumatore se la natura del debito lo consente, altrimenti concordato minore se è impresa sotto soglia). – Se non si raggiunge accordo coi creditori sul piano o non è sostenibile, optare per la liquidazione controllata, sacrificando il patrimonio ma ottenendo la liberazione dai debiti. – In casi disperati (niente patrimonio proprio né prospettive), chiedere l’esdebitazione incapiente per cancellare i debiti e ricominciare da capo.
Tutto ciò mantenendo ben presente che la chiave di accesso è la meritevolezza: chi ha colpe gravi o ha frodato i creditori ne viene escluso, per evitare abusi. Ricordiamo che l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è l’ente/figura (spesso istituito presso le Camere di Commercio o Ordini professionali) a cui ci si rivolge per avviare queste procedure: assiste il debitore, verifica documenti, e in molti casi svolge funzioni paragonabili al curatore/commissario (ad es. sovrintende all’esecuzione del piano, redige l’elenco creditori, ecc.). Dunque, un imprenditore in difficoltà dovrebbe rivolgersi quanto prima a un OCC o a un professionista esperto in sovraindebitamento per valutare questa strada.
Procedure concorsuali maggiori (per imprese fallibili)
Nel caso in cui la merceria abbia dimensioni tali da essere soggetta a fallimento, oppure operi in forma societaria sopra soglia, le procedure applicabili sono quelle previste per le imprese in generale nel Codice della Crisi. Le principali sono il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento). Menzioneremo anche l’accordo di ristrutturazione che, pur essendo extragiudiziale, in contesto di grande impresa si affianca a queste, ma di fatto lo abbiamo già trattato sopra.
- Concordato preventivo: È una procedura concorsuale che consente all’imprenditore insolvente (o in stato di crisi) di evitare la liquidazione giudiziale proponendo un accordo ai creditori sotto supervisione del tribunale. Può essere “in continuità” (se prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente dal debitore o indirettamente tramite cessione/affitto a terzi) oppure “liquidatorio” (se prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio per pagare i creditori). Il concordato preventivo lo chiede l’imprenditore stesso depositando una proposta, un piano dettagliato e una relazione di un attestatore indipendente. Segue una fase in cui il tribunale, verificati i requisiti iniziali, ammette la procedura e convoca i creditori al voto. I creditori votano divisi in classi se previste, e la maggioranza richiesta è (salvo classi) almeno il 50% dei crediti ammessi al voto (diverse dal concordato minore, qui la soglia è in generale più bassa). Se ci sono classi, serve la maggioranza in valore dei crediti in almeno la metà più una delle classi votanti. Dopo l’approvazione dei creditori, la proposta passa al giudice per l’omologazione. Il giudice omologa se il concordato è stato approvato e non viola norme imperative (es. trattamento non corretto di qualche creditore). Se i creditori non approvano, il concordato viene dichiarato inammissibile e si apre di solito la strada al fallimento (salvo il debitore chieda misure alternative come amministrazione straordinaria se ne ha titolo).
Alcune regole sostanziali del concordato preventivo: – Deve garantire un pagamento minimo ai creditori chirografari nel caso di concordato liquidatorio: attualmente la legge impone almeno il 20% ai chirografari (mentre in continuità aziendale si può offrire anche meno, purché i creditori non ricevano meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione e vi sia appunto continuità dell’attività). – I creditori privilegiati vanno soddisfatti integralmente salvo che rinuncino in parte (o salvo falcidia dimostrando che quel privilegio è incapiente sui beni, tecnica nota come cram down dei privilegiati). – È possibile anche prevedere soddisfazione non integrale di creditori pubblici (Fisco/INPS), purché almeno pari al valore di liquidazione dei loro crediti o con adesione da parte loro (transazione fiscale in concordato). – Durante la procedura, dal deposito del ricorso di concordato, opera l’automatic stay: i creditori chirografari non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari; i privilegiati possono farlo solo con autorizzazione del tribunale in casi urgenti. Questo consente all’impresa di respirare. Inoltre, non si pagano i debiti anteriori (c’è divieto di pagamento dei crediti anteriori per par condicio, salvo autorizzazioni per fornitori essenziali). – L’imprenditore conserva l’amministrazione sotto la vigilanza di un commissario giudiziale nominato dal tribunale. In caso di abusi o atti di frode, può essergli revocata (con passaggio a liquidazione giudiziale).
Per la merceria, un concordato preventivo avrebbe senso solo se è una società con passività rilevanti e prospettive di ristrutturazione credibile (ad esempio, un franchising di mercerie su più punti vendita). Difficile che una microimpresa entri in concordato preventivo – spesso è sproporzionato. In ogni caso, l’obiettivo del concordato è evitare il fallimento con un accordo votato: se omologato, i creditori devono accontentarsi di quanto stabilito e non possono pretendere oltre né agire singolarmente. Se il debitore esegue correttamente il concordato, poi i debiti residui vengono cancellati (in realtà nel concordato preventivo non si parla di esdebitazione perché è implicita: l’omologazione e l’adempimento estinguono le obbligazioni pregresse secondo i termini stabiliti).
- Liquidazione giudiziale (fallimento): È la procedura concorsuale “terminale”, avviata dal tribunale su istanza di creditori, del debitore stesso o d’ufficio (PM) in presenza di insolvenza. Effetti principali: spossessamento dell’imprenditore dai suoi beni (che passano sotto il controllo del curatore nominato), cristallizzazione dei debiti (i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo, e gli interessi cessano di maturare salvo privilegiati nei limiti di legge), scioglimento o sospensione dei contratti in corso (secondo regole specifiche), interruzione delle azioni esecutive individuali (tutti i creditori concorrono nel fallimento e non possono più agire da soli). Il curatore predispone il programma di liquidazione, liquida l’attivo (vende beni, anche l’azienda se possibile esercitandola provvisoriamente per venderla come going-concern), e distribuisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima le spese di procedura (prededucibili), poi i creditori privilegiati (ipotecari, pignoratizi, privilegiati generali nell’ordine di legge) e infine gli eventuali chirografari ripartendosi quel poco che resta (spesso nulla). Al termine, il tribunale chiude la procedura dichiarando cessato il fallimento.
Per l’imprenditore individuale dichiarato fallito, la chiusura del fallimento non lo libera automaticamente dai debiti non soddisfatti, a meno che non ottenga la esdebitazione. La legge prevede che il fallito persona fisica possa chiedere entro 1 anno dalla chiusura il beneficio dell’esdebitazione, dimostrando di aver collaborato e di non aver violato la legge fallimentare. Con il Codice della Crisi, pare che l’esdebitazione del fallito persona fisica tenda a diventare quasi automatica, simile a quanto avviene nella liquidazione controllata: il tribunale contestualmente alla chiusura concede la liberazione dai debiti residui al debitore meritevole, salvo opposizione di creditori. Questa evoluzione – in linea con la direttiva UE 2019/1023 – è volta a evitare l’ostracizzazione a vita dell’ex fallito e a favorirne il reinserimento economico.
La liquidazione giudiziale comporta inoltre, per le società, la loro estinzione una volta terminata (sparisce la società se non resta attivo da distribuire). Per l’imprenditore individuale, comportava un tempo anche la restrizione della libertà personale (divieto di espatrio, oggi abolito) e comunque uno stigma. Oggi molti effetti personali del fallimento (come l’incapacità a esercitare attività d’impresa, la sospensione dei titoli) cessano con la chiusura o con l’esdebitazione concessa, in modo da permettere al soggetto di tornare attivo.
Conseguenze penali: Nel corso della procedura fallimentare, se emergono fatti di distrazione di beni, documentazione contabile irregolare o altre condotte illecite dell’imprenditore antecedenti alla dichiarazione di fallimento, il curatore e il tribunale possono segnalarle alla Procura. Si aprirebbe allora un procedimento penale per reati fallimentari (come la bancarotta fraudolenta documentale o patrimoniale). Queste fattispecie puniscono chi, prima del fallimento, ha volontariamente aggravato il dissesto o ha favorito taluni creditori a danno di altri o ha falsificato i libri. Va quindi evidenziato che agire in modo poco trasparente durante la crisi può portare non solo a sanzioni civili ma anche penali. Invece, un comportamento corretto (ad esempio non nascondere incassi, non fare pagamenti preferenziali indebiti nelle fasi a ridosso del fallimento) mette al riparo da accuse di bancarotta.
In definitiva, se la merceria “grande” non riesce a salvarsi, il fallimento è l’esito ultimo: i beni vengono liquidati e l’imprenditore potrà successivamente ottenere la clean slate attraverso l’esdebitazione. Se c’è ancora una chance di soddisfare parzialmente i creditori e continuare, il concordato preventivo può essere la soluzione: ad esempio vendere il negozio a un concorrente nell’ambito di un concordato in continuità indiretta, e usare il ricavato per pagare i creditori in percentuale.
Riassumiamo in una tabella comparativa le principali procedure giudiziali concorsuali rilevanti:
| Procedura | Destinatari | Meccanismo | Esiti per il debitore | Quando è indicata |
|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (Ristrutt. debiti consumatore) | Persona fisica consumatore sovraindebitata (debiti privati) | Proposta unilaterale di pagamento parziale dei debiti, omologata dal tribunale senza voto creditori se fattibile e debitore meritevole | Debitore tiene i beni previsti dal piano, paga la quota stabilita e ottiene esdebitazione del residuo a fine piano | Debiti personali (es. carte credito, prestiti familiari, bollette) insostenibili; redditi moderati per pagare almeno parte. Non applicabile a debiti d’impresa (salvo misti prevalentemente privati) |
| Concordato minore (ex accordo sovraindebit.) | Piccolo imprenditore, professionista o soggetto non fallibile con debiti anche d’impresa | Piano di ristrutturazione con eventuali classi, soggetto a voto dei creditori (maggioranza qualificata). Omologa se approvato | Se esegue il piano concordatario, paga la percentuale concordata ai creditori e il resto dei debiti viene cancellato (esdebitazione implicita). Mantiene azienda se piano in continuità, altrimenti liquida beni secondo piano | Crisi grave ma con possibilità di accordo con creditori. Si usa quando c’è patrimonio/reddito per offrire >0 e numerosi creditori (imprenditore sotto soglia). Evita la liquidazione totale coinvolgendo creditori nel decidere. |
| Liquidazione controllata (sovraindebitamento) | Qualunque debitore non fallibile insolvente | Procedura giudiziale: nominato liquidatore che vende tutti i beni. Creditori presentano domande e sono soddisfatti per quanto possibile | Debitore perde beni (liquidati); al termine è liberato da tutti i debiti residui (esdebitazione concessa salvo eccezioni) | Situazione compromessa, nessuna via di risanamento. Il debitore vuole chiudere con i debiti consegnando il patrimonio. Spesso scelta volontaria per avere esdebitazione subito (fresh start) |
| Esdebitazione incapiente | Persona fisica nullatenente e senza reddito, una tantum | Istanza al tribunale di cancellare debiti senza attivo. Valutazione rigorosa su buona fede e prospettive | Debiti cancellati con decreto del giudice. Se situazione migliora entro 4 anni, può essere revocata parzialmente (debitor riacquista capacità pagare) | Ultima spiaggia – quando il debitore non possiede davvero nulla e non ha senso neppure aprire una liquidazione. Concede immediata liberazione dal peso debitorio |
| Concordato preventivo | Impresa fallibile in crisi o insolvenza (società o ditte oltre soglia) | Procedura giudiziale con controllo tribunale: il debitore propone un piano di pagamento (in continuità o liquidatorio), creditori votano, poi omologa. Protezione durante procedura (stay) | Se omologato e adempiuto, l’impresa evita fallimento. Debiti estinti secondo quanto pagato, residui non più esigibili. Possibile continuare attività (se concordato in continuità). | Imprese medio-grandi con prospettive di risanamento o possibilità di cedere l’azienda salvando valore. Richiede un piano sostenibile e consenso dei creditori. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Impresa fallibile insolvente (o cessata ma con debiti) | Procedura pubblica: tribunale dichiara aperta la liquidazione, curatore amministra beni, li vende e distribuisce proventi. Impresa cessata. | L’imprenditore individuale perde i beni. A fine procedura, se persona fisica, può ottenere esdebitazione dei debiti non pagati. La società si estingue. | Quando l’insolvenza è conclamata e nessun concordato è stato presentato o approvato. Ultimo rimedio per soddisfare i creditori con le risorse residue, secondo legge. |
Questa tabella evidenzia come, a seconda della forma e dimensione della merceria, vi siano procedure diverse ma con analogie: in tutti i casi si tende a privilegiare la via negoziale (piani e concordati) se c’è speranza, altrimenti si ricorre alla liquidazione (fallimentare o controllata) per chiudere la situazione. Sempre, tuttavia, con l’orizzonte di dare al debitore onesto la liberazione dai debiti e la possibilità di ricominciare – ciò è oggi considerato un valore ordinamentale, tanto che il Codice della Crisi e la giurisprudenza spingono verso interpretazioni che non aggravino inutilmente la posizione del debitore meritevole.
Nei prossimi paragrafi vedremo come il debitore può difendersi concretamente nelle singole azioni esecutive e risponderemo a qualche domanda frequente in materia, prima di proporre alcune simulazioni di casi pratici.
Come difendersi dalle azioni esecutive
Quando un creditore passa alle vie di fatto – ad esempio notifica un atto di pignoramento – il debitore non è affatto privo di tutele. L’ordinamento prevede varie forme di opposizione e limitazione dell’esecuzione forzata, volte a garantire un equilibrio tra le ragioni del creditore e i diritti fondamentali del debitore. Di seguito passeremo in rassegna le principali strategie difensive che un imprenditore (o ex imprenditore) indebitato può adottare per proteggere sé stesso e i propri beni, nei limiti del lecito.
Opposizione agli atti esecutivi e alla esecuzione
Se un creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) e inizia il pignoramento, il debitore può reagire per vie legali con: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Ad esempio, si può opporre sostenendo che il debito in realtà è già stato pagato (quietanza non considerata), o che si è formato un accordo transattivo che il creditore sta violando, o ancora che manca una condizione necessaria (ad es. il creditore agisce ma il titolo non è definitivo). Nel caso della cartella esattoriale, l’opposizione all’esecuzione può fondarsi su errori come prescrizione del debito (se il tributo è di molti anni prima e non è più esigibile) o vizi di notifica degli atti precedenti (se la cartella o l’atto prodromico non furono notificati regolarmente, l’intera esecuzione è viziata). L’opposizione si propone con ricorso al giudice competente per l’esecuzione, e se vi sono motivi gravi si può chiedere la sospensione dell’esecuzione in corso. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è mirata a censurare i vizi formali degli atti della procedura esecutiva. Ad esempio, se il pignoramento è notificato in modo irregolare, o l’atto di precetto (intimazione di pagamento) contiene errori tali da renderlo nullo, si può proporre opposizione agli atti per far dichiarare la nullità e interrompere o regolarizzare il procedimento. Sono termini brevi (5 giorni o 20 giorni dalla notifica dell’atto, a seconda del caso) quindi bisogna agire prontamente. – Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): nel caso in cui vengano pignorati beni di proprietà di un terzo (ad esempio, il magazzino è in affitto e la merce appartiene a un fornitore in conto vendita, oppure l’auto pignorata risulta intestata alla moglie), quel terzo estraneo può fare opposizione per sentir dichiarare l’impignorabilità di quei beni poiché appartenenti a lui e non al debitore. Per la riuscita, deve provare efficacemente il proprio diritto (proprietà) su quei beni.
Queste opposizioni sono vere e proprie cause da intentare di fronte al giudice dell’esecuzione (tipicamente il tribunale). Richiedono l’assistenza di un avvocato e la sussistenza di validi motivi di contestazione. Non servono a “prendere tempo” e basta: se pretestuose, vengono rigettate rapidamente e possono aggravare le spese. Tuttavia, se il debitore ha ragione (es. il creditore agiva nonostante accordi di dilazione, o su un debito caduto in prescrizione), allora l’opposizione può bloccare l’esecuzione e inibirla stabilmente.
Limitare l’estensione del pignoramento
Anche quando l’azione esecutiva è legittima in sé, il debitore può chiedere di limitarne gli effetti per ridurre il danno: – Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.): se sono stati pignorati beni di valore superiore all’importo del debito (compresi interessi e spese), il debitore può istanza al giudice per ridurre il pignoramento ai beni sufficienti a coprire il credito. Ad esempio, se per un debito di €10.000 vengono pignorati sia un’auto di valore €8.000 sia arredi per €10.000, chiaramente è eccessivo: si può chiedere che alcuni beni vengano liberati. Ciò evita che si mettano all’asta più beni del necessario. – Scelta dei beni da pignorare (art. 493 c.p.c.): in certi casi, il debitore può indicare egli stesso al creditore e all’ufficiale giudiziario quali beni pignorare per primi, in modo da soddisfare il credito con minore impatto. Ad esempio, potrebbe offrire spontaneamente un conto bancario o un credito verso un cliente, invece di subire il pignoramento del magazzino. Questa “indicazione del debitore” per avere efficacia deve avvenire tempestivamente e comunque il creditore può non accettarla, ma tentare non nuoce. – Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): questo strumento consente al debitore di evitare la vendita forzata dei beni depositando una somma pari al credito pignorato (capitale, interessi e spese) presso la cancelleria. In pratica, se viene pignorata la casa o altro bene, il debitore può – prima che si tenga l’asta – presentare istanza di conversione offrendo un pagamento rateale al tribunale: versa una cauzione iniziale (di solito il 20% del dovuto) e il giudice può concedere fino a 18 rate mensili per saldare il resto. Se il debitore paga tutte le rate, il pignoramento viene revocato e i beni liberati; se non paga, l’esecuzione riprende. La conversione è un’ottima via per guadagnare tempo e preservare beni di valore (es. la casa), trasformando l’obbligo di dare il bene in obbligo di pagare per contanti. Ovviamente richiede che il debitore riesca a reperire le somme da versare (spesso con aiuto familiari o vendite private di altri asset non pignorati). – Sospensione volontaria e piani del debitore: a volte, il debitore può persuadere lo stesso creditore procedente a sospendere l’esecuzione proponendo un piano di pagamento serio. Ad esempio, se un fornitore ha avviato un pignoramento ma il debitore offre garanzie (cambiali, fideiussioni di terzi) e un calendario di pagamento concordato, il creditore può rinunciare alla procedura esecutiva in corso (magari tenendola pendente ma senza incanto) in attesa di vedere adempiuto l’accordo. Questa è una soluzione di negoziazione in extremis: molti creditori, se vedono collaborazione e qualcosa in mano, preferiscono non incorrere nei costi e nelle incertezze di un’asta pubblica.
Beni impignorabili e limiti di legge
Il debitore ha diritto di far valere le eccezioni di impignorabilità previste dalla legge. Ne abbiamo già citate alcune, ricapitoliamo: – Beni di uso quotidiano e affetti personali: mobili indispensabili nella casa (letti, tavoli da pranzo, armadi, frigorifero, stufa per riscaldarsi, ecc.), abbigliamento, oggetti sacri, onorificenze, animali da compagnia o da affezione, alimenti e scorte di famiglia per un mese – tutti questi beni non possono essere pignorati (art. 514 c.p.c.). – Strumenti di lavoro: gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione del debitore possono essere pignorati soltanto se il giudice lo autorizza e nei limiti di 1/5 del loro valore complessivo (art. 515 c.p.c.), e purché l’esecuzione non li privi del tutto dei mezzi di sostentamento. Nel caso di una merceria, il registratore di cassa, gli scaffali, il PC gestionale, ecc. potrebbero rientrare in questa protezione parziale come strumenti di impresa individuale, ma spesso l’interpretazione è restrittiva per le imprese commerciali (si applica più che altro a professionisti tipo artigiani, medici, avvocati per i loro strumenti di lavoro). In ogni caso, un pignoramento dell’intero laboratorio o negozio dovrebbe lasciare al debitore l’indispensabile per vivere. – Stipendi e pensioni: le somme derivanti da lavoro dipendente o pensione possono essere pignorate solo in parte. La regola generale (art. 545 c.p.c.) è che al massimo un quinto dello stipendio netto mensile è pignorabile (salvo concorso di cause diverse: se ci sono più pignoramenti per alimenti, tributi o crediti ordinari, comunque la somma totale trattenuta non può superare il 50%). Per stipendi molto bassi (fino a circa 2.700 € mensili lordi nel 2025) si pignora al più 1/10; per quelli medi (fino a circa 5.000 €) 1/7; oltre, 1/5. Le pensioni hanno un ulteriore scudo: c’è una quota impignorabile pari all’assegno sociale aumentato della metà (circa €1.000 nel 2025); solo l’eccedenza su tale importo può essere pignorata e comunque nei limiti di 1/5. – Depositi bancari: se sul conto del debitore affluisce uno stipendio o pensione, le somme su di esso depositate sono pignorabili nei limiti di 1/5 per la mensilità corrente e quelle future. Quanto al saldo pregresso sul conto al momento del pignoramento, invece, l’intera giacenza eccedente l’ultimo accredito mensile può essere bloccata (norma introdotta nel 2015): in pratica, sul conto resta libero solo l’importo dell’ultimo stipendio/pensione, il resto viene vincolato. Pertanto, per i lavoratori dipendenti/pensionati c’è questa tutela parziale. – Prima casa: come già detto, nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione l’abitazione principale del debitore non ipotecata e priva di lusso è impignorabile. Verso creditori privati, invece, non esiste un divieto generale di pignorare la prima casa (una banca può farlo). Tuttavia, se la casa è cointestata col coniuge non debitore o altri, la procedura è più complessa e spesso costringe a vendere solo la quota del debitore (poco appetibile sul mercato). Inoltre, de facto i creditori chirografari raramente pignorano case abitate perché il procedimento è lungo e costoso (servono anticipi per custodia, perizia, ecc.). Nel caso invece di mutuo fondiario con la banca, c’è un titolo esecutivo già (contratto di mutuo e atto di precetto) e la banca ipotecaria potrà espropriare. Il debitore può in tali casi far leva su strumenti come la rinegoziazione o, in giudizio, chiedere al giudice dell’esecuzione la concessione del termine di grazia (art. 41 TUB) per sanare la morosità entro 6-12 mesi ed evitare la risoluzione del mutuo, applicabile una sola volta. – Beni in fondo patrimoniale/trust: se il debitore ha un fondo patrimoniale valido e il debito è estraneo ai bisogni familiari (come la maggior parte dei debiti d’impresa), egli può opporsi all’esecuzione su quei beni eccependo l’art. 170 c.c.. Il giudice dell’esecuzione sospenderà l’azione per quei beni se risulta la destinazione a fondo e l’estraneità dello scopo. Il creditore potrà replicare solo con l’argomento che quel debito era invece contratto per la famiglia (difficile, come visto) o che il fondo è fraudolento (ma per questo deve agire con revocatoria in separato giudizio). Quindi, ribadiamo, il fondo offre una buona difesa se istituito regolarmente in anticipo. Analoga difesa per beni conferiti in trust: il debitore/trustee potrà opporsi dicendo che i beni non sono di proprietà del debitore esecutato ma del trustee per finalità distinte. Però attenzione: se il creditore ha un titolo esecutivo e ricade nell’art. 2929-bis c.c. (bene donato o messo in trust successivamente al sorgere del credito), può pignorarlo lo stesso entro breve tempo dal trasferimento, senza aspettare cause.
- Prescrizione e decadenza: Un’altra linea di difesa è contestare che il diritto del creditore si è estinto per decorso del tempo. Molti debiti infatti non possono essere riscossi legalmente dopo un certo numero di anni di inattività del creditore. Ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in 5 anni (salvo atti interruttivi come la cartella), le cartelle esattoriali di tributi solitamente in 5 o 10 anni a seconda del tributo, le fatture commerciali in 5 anni, i canoni d’affitto in 5 anni, e così via. Se un creditore “dorme” troppo a lungo, il debitore può opporsi all’esecuzione eccependo la prescrizione compiuta. È un tema tecnico (il calcolo dei termini e delle interruzioni non è banale), ma fondamentale da far valutare: spesso capita che Equitalia riprenda a riscuotere vecchi ruoli notificati 15 anni prima e mai seguiti da atti successivi, trovando però creditori ormai decaduti dal diritto. In giudizio, la prescrizione va eccepita: il giudice non la rileva d’ufficio. Quindi è onere del debitore attivarsi per far valere questo scudo temporale.
Uso delle procedure concorsuali come difesa
Può sembrare paradossale, ma a volte attivare una procedura concorsuale è la migliore difesa contro le esecuzioni frammentarie dei creditori: – Domanda di concordato preventivo o minore: Come detto, al deposito della domanda il tribunale può concedere misure protettive immediate e comunque, una volta ammessa la procedura, tutte le esecuzioni individuali sono sospese. Quindi un imprenditore che rischia pignoramenti multipli può “rifugiarsi” nel concordato presentando un piano. Ovviamente servono i presupposti (insolvenza attuale o prospettica) e bisogna poi gestire la procedura, ma intanto si guadagna tempo e si evita la frammentazione (tutto confluirà nel concorso). – Apertura della liquidazione controllata (sovraindebitamento): Similmente, se un piccolo imprenditore chiede la liquidazione controllata, dal momento dell’apertura (disposta con decreto tribunale) nessun creditore può iniziare o proseguire esecuzioni, dovendo partecipare alla liquidazione concorsuale. Dunque può essere un atto di “difesa attiva”: invece di subire dieci pignoramenti, il debitore preferisce attivare subito la procedura di liquidazione, centralizzare lì le pretese (con il beneficio poi dell’esdebitazione). È un po’ come issare bandiera bianca per salvare il salvabile (la pace e la dignità, se non i beni). – Fallimento richiesto dallo stesso imprenditore: anche l’istanza di autofallimento a volte è usata come extrema ratio per bloccare uno stillicidio di azioni e demandare al curatore il compito di trattare con i creditori. Va ponderata bene perché una volta falliti non si controlla più nulla direttamente, ma in situazioni ingestibili può essere l’unica via.
In altre parole, le procedure concorsuali fungono da ombrello protettivo collettivo. Finché i creditori agiscono ognuno per conto proprio, il patrimonio del debitore viene eroso in modo disordinato e con preferenze casuali (chi arriva prima prende). Con la procedura, si fa tabula rasa delle iniziative individuali e si procede in modo ordinato e par condicio. Dal lato del debitore, ciò può risultare in un trattamento più equo e – ripetiamo – nella liberazione finale dai debiti residui che altrimenti resterebbero.
Evitare condotte pregiudizievoli
Un aspetto di “difesa” è anche sapere cosa NON fare per non aggravare la propria posizione: – Non tentare di nascondere o distrarre beni durante l’esecuzione (ad es. smontare macchinari prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario). Tali atti oltre ad essere facilmente vanificati (il custode può chiederne la restituzione, il giudice può revocare atti post-pignoramento) integrano reati (sottrazione di cose pignorate, art. 388 c.p.). – Non falsificare documenti o simularne: presentare all’ufficiale giudiziario una falsa fattura di vendita dei beni a terzi per evitarne il pignoramento è reato. – Non spostare la residenza o la sede solo per complicare le notifiche: i creditori possono ottenere ricerche anagrafiche e il giudice può autorizzare pignoramenti anche in altre sedi se c’è sospetto di spostamento di beni. – Non continuare ad indebitarsi ulteriormente nella speranza di coprire buchi (classico: prendere nuovi prestiti usurai per pagare debiti esistenti). Questo di solito peggiora la situazione e può configurare altre responsabilità.
Molto meglio è affrontare la situazione a viso aperto con i creditori, usare gli strumenti legali per congelare il contenzioso e ristrutturare – oppure, in caso estremo, consegnare il patrimonio residuo in modo controllato, cercando di salvaguardare almeno i beni essenziali. In quest’ottica, un buon avvocato è fondamentale: saprà individuare eventuali vizi di forma negli atti dei creditori (non di rado la fretta porta a errori di notifiche, ecc. che possono invalidare un pignoramento); saprà consigliare se avviare un’opposizione o se invece negoziare; conoscerà i tempi tecnici (talvolta, far passare tempo è utile: es. se un creditore non rinnova un’ipoteca nei 20 anni, quella si estingue; se l’atto di precetto scade dopo 90 giorni senza pignoramento, va notificato di nuovo, ecc.).
Concludendo, difendersi dalle azioni esecutive è possibile con diverse armi: giuridiche (opposizioni, eccezioni, istanze al giudice) e strategiche (accordi, conversioni, procedure concorsuali). L’importante è agire con tempestività, onestà e con assistenza qualificata. Il punto di vista del debitore è stato considerato sempre più dalla legge negli ultimi anni, evitando approcci punitivi e riconoscendo che chi fa impresa può incappare in fallimenti senza essere un criminale – pertanto merita la chance di risollevarsi. Dopo aver esaminato le difese tecniche, passiamo ora a chiarire alcuni dubbi frequenti in materia sotto forma di domande e risposte.
Domande frequenti (FAQ)
D: La mia merceria è sommersa dai debiti. Quali di questi possono portare al fallimento dell’attività?
R: Se la merceria è individuale o comunque “sotto soglia” (piccoli ricavi e debiti < €500.000), non può essere dichiarata fallita in senso tecnico. I creditori potranno pignorare beni ma non avviare una liquidazione giudiziale collettiva. Viceversa, se l’attività supera anche uno solo dei limiti dimensionali (attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k), i creditori possono chiederne il fallimento in tribunale purché i debiti scaduti in totale superino €30.000. Non conta il tipo di debito in sé: qualsiasi debito commerciale, bancario o fiscale rilevante può determinare l’insolvenza e spingere un creditore (anche un fornitore piccolo in teoria) a presentare istanza di fallimento se percepisce uno stato di insolvenza irreversibile. In pratica, spesso sono le banche o l’Erario/INPS (per crediti contributivi o IVA ingenti) o i dipendenti (per stipendi non pagati) a provocare la procedura concorsuale, perché hanno importi più alti e meccanismi attivi. Ma anche un gruppo di fornitori potrebbe agire. Quindi, per rispondere: tutti i debiti potenzialmente possono portare alla fine coattiva dell’attività se sommandosi creano insolvenza; gli unici esclusi dal concorso fallimentare sono i debiti entro i €30.000 totali (al di sotto di quella soglia di sicurezza il fallimento non si apre).
D: Possono portarmi via la casa per i debiti della merceria?
R: Purtroppo sì, è possibile in diversi casi. Se la merceria è una ditta individuale, i creditori possono aggredire tutti i beni personali del titolare, inclusa la casa di abitazione. Ci sono però importanti eccezioni:
– Se la casa è l’abitazione principale e il creditore è l’Agente di Riscossione per debiti fiscali/contributivi, la legge vieta la sua espropriazione (a condizione che sia l’unico immobile di proprietà, non di lusso). Quindi Equitalia/AER non può vendere all’asta la prima casa del contribuente, anche se può mettere un’ipoteca come garanzia (che di fatto impedisce di venderla spontaneamente finché non si paga il debito).
– Se la casa è stata inserita in un fondo patrimoniale prima dei debiti, i creditori dell’attività non dovrebbero poterla pignorare perché il debito è estraneo ai bisogni familiari. In caso tentassero, il debitore può opporsi in tribunale invocando tale vincolo. Attenzione però: se il debito risale a prima della costituzione del fondo, potrebbero annullare il fondo per frode con azione revocatoria.
– Se la casa è in comunione dei beni col coniuge non debitore, il creditore potrebbe pignorare solo la quota parte del debitore (di solito metà immobile), il che spesso è poco efficiente e può scoraggiare l’azione (chi compra metà casa?).
– Un creditore ipotecario (es. la banca per mutuo) ha comunque diritto di esecuzione: se le rate del mutuo non vengono pagate, la banca può procedere al pignoramento e vendita, anche se casa principale. Qui l’unica via è negoziare con la banca, chiedere un piano di rientro o usufruire delle norme come il “fondo di garanzia prima casa” (se attivabile per sospendere mutuo in caso di difficoltà temporanee) o il termine di grazia dal giudice (max 12 mesi per sanare arretrato se si riesce).
In definitiva, la casa è protetta completamente solo verso debiti fiscali (nei limiti detti). Per altri debiti, può essere aggredita. Vale la pena considerare misure preventive (fondo patrimoniale, polizze vita, trust) per tutelare l’abitazione, ma se già i debiti ci sono, tali mosse tardive possono essere vanificate per legge.
D: Cosa succede ai dipendenti se la merceria chiude per debiti?
R: I dipendenti sono considerati “creditori privilegiati” e godono di alcune protezioni speciali. Se la merceria cessa l’attività senza risorse per pagarli, essi potranno insinuare i loro crediti in un’eventuale procedura concorsuale (fallimento, liquidazione controllata) venendo soddisfatti con precedenza. Inoltre possono accedere al Fondo di Garanzia INPS, che interviene in caso di insolvenza del datore per pagare:
– il TFR maturato (per intero, entro massimali di legge);
– le ultime tre mensilità di retribuzione non pagate (fino a un certo importo mensile massimo).
Tale Fondo paga i lavoratori, poi si surroga verso il datore insolvente (diventando creditore di regresso, spesso irrilevante se l’azienda è vuota). I dipendenti possono richiederlo se c’è stata una procedura concorsuale o almeno un tentativo di esecuzione infruttuoso. Se l’azienda fallisce, il curatore di solito licenzia il personale e il Fondo di Garanzia interviene in tempi rapidi dopo l’accertamento del credito in tribunale. Se l’azienda semplicemente chiude (senza fallimento perché non fallibile), i lavoratori possono intimare il pagamento, farsi rilasciare un decreto ingiuntivo e tentare pignoramenti. Se questi falliscono per incapienza, allora presentare domanda al Fondo (documentando l’escussione senza esito).
In tutti i casi, i dipendenti hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) se perdono il posto involontariamente, quindi percepiranno un assegno mensile per un periodo (in proporzione agli anni lavorati).
Quindi, per riassumere: i dipendenti vengono licenziati (di fatto, perché l’azienda non prosegue), ma non perdono completamente i loro crediti, poiché una parte significativa – TFR e ultime retribuzioni – è garantita dall’intervento pubblico (INPS). Certo, eventuali altre spettanze (tredicesime remote, premi) se il Fondo non le copre rimangono a carico del datore e spesso irrecuperate se non ci sono beni. Ma lo “zoccolo duro” è tutelato.
D: Cos’è esattamente la “legge salva-suicidi”? A chi si rivolge?
R: “Legge salva-suicidi” è il nome popolare dato alla Legge 3/2012, che per la prima volta in Italia ha introdotto procedure per la gestione del sovraindebitamento di soggetti esclusi dal fallimento (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti). Si chiama così perché mira a offrire una via d’uscita legale a persone sopraffatte dai debiti, che in passato non avevano strumenti giuridici e spesso cadevano nella disperazione (da cui il riferimento ai suicidi per debiti, tragicamente frequenti). Oggi quella legge confluisce nel Codice della Crisi (Titolo IV), ma le sue procedure base restano: il piano del consumatore (ridenominato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”) per le persone fisiche non imprenditrici, l’accordo di composizione (ora “concordato minore”) per piccoli imprenditori e simili, e la liquidazione del patrimonio (ora “liquidazione controllata”). In più c’è l’esdebitazione dell’incapiente (introdotta dopo). Si rivolge dunque ai debitori civili o economici “minori”: la tipica famiglia sommersa dai debiti, il negoziante sotto soglia, l’artigiano, l’agricoltore, il professionista libero. Non si applica invece alle società e imprenditori grandi (per cui c’è il fallimento/ concordato). Il principio cardine della legge salva-suicidi è il favor debitoris: aiutare il debitore meritevole a ripagare quanto può e a cancellare il resto, per tornare attivo nella società (principio della seconda opportunità, previsto anche dalla normativa UE).
D: Qual è la differenza tra concordato preventivo e concordato minore?
R: Entrambi sono procedure in cui il debitore propone ai creditori un accordo per evitare la liquidazione fallimentare, ma differiscono per soggetti e modalità:
– Il concordato preventivo è riservato alle imprese soggette a fallimento (tipicamente società di medie/grandi dimensioni o ditte sopra soglia). Si svolge dinanzi al tribunale fallimentare, con un commissario giudiziale e coinvolge spesso centinaia di creditori. La proposta può includere ristrutturazioni complesse, continuità aziendale, ecc. I creditori votano e serve almeno la maggioranza dei crediti. È una procedura più articolata (ad esempio, è obbligatoria la suddivisione in classi omogenee se ci sono creditori con posizioni giuridiche differenziate, c’è l’udienza di omologa con eventuali opposizioni, ecc.). Inoltre nel concordato preventivo classico c’è il requisito di soddisfare i chirografari con almeno il 20% in caso di liquidatorio (norma che nel concordato minore non è espressa, essendo per definizione minore, anche se in pratica pure lì si punta a dare qualcosa).
– Il concordato minore è dedicato ai debitori “non fallibili” (sovraindebitati): perciò ha soglie di ingresso basse. È pensato su misura di realtà semplificate: ad esempio, si può evitare la costituzione di classi se non necessario, le maggioranze sono leggermente diverse (richiede il 60% dei crediti votanti), e opera sotto l’egida di un OCC/gestore della crisi piuttosto che di un commissario giudiziale. Anche le formalità sono ridotte: piani meno complessi, rapporto più diretto con il giudice. In breve, è un concordato “light” adatto a pochi creditori e importi relativamente modesti.
Proceduralmente, concordato minore e preventivo sono simili (deposito proposta, voto creditori, omologa) ma nel concordato minore c’è più flessibilità e soprattutto è accessibile a soggetti che nel concordato preventivo non entrerebbero proprio. Un imprenditore individuale di piccola taglia userà il concordato minore; una S.r.l. con milioni di debito il concordato preventivo.
Va aggiunto che i due istituti rispondono a logiche normative affini ma separate: il concordato minore è figlio della legge sul sovraindebitamento, quindi privilegia la semplicità e il debitor-centred approach; il concordato preventivo sta nel solco del vecchio diritto fallimentare, con maggior enfasi sul controllo dei creditori e l’intervento giudiziale per imprese di rilevanza.
D: Quanto dura una procedura di fallimento o di liquidazione controllata?
R: La durata può variare moltissimo. In media un fallimento in Italia dura tra i 5 e i 7 anni, ma ci sono casi di chiusura in 2-3 anni e altri che restano aperti oltre 10, specie se ci sono contenziosi pendenti (azioni legali per recuperare crediti, cause revocatorie, ecc.) o patrimoni immobiliari difficili da liquidare. Il Codice della Crisi pone obiettivi di durata più breve (tendere a chiudere in 3 anni), ma nella prassi contano fattori come: numero di creditori, complessità dell’attivo, pendenze giudiziarie.
La liquidazione controllata (ex sovraindebitamento) di solito è più rapida perché riguarda debitori più piccoli e meno litigiosi. Può concludersi in 1-2 anni se l’attivo è modesto (es: solo pochi beni da vendere). Alcuni tribunali sono riusciti a chiudere procedure di sovraindebitamento addirittura in pochi mesi, specie se il debitore non aveva beni (in tal caso si passava direttamente all’esdebitazione incapiente nei nuovi casi). Diciamo come range indicativo: liquidazione controllata 1-3 anni, fallimento classico 3-6 anni.
Le procedure di concordato invece sono più brevi: un concordato preventivo può completarsi (dall’ammissione all’omologa) in 6-12 mesi circa, poi se si tratta di concordato liquidatorio l’esecuzione del piano (vendite e pagamenti) magari dura altri 1-2 anni. Un concordato in continuità potrebbe durare per tutta la durata del piano (anche 5 anni di esecuzione), ma formalmente la procedura concorsuale si chiude con l’omologa, e poi c’è solo il controllo sull’adempimento.
In sintesi, le procedure concorsuali non sono lampo – servono tempo e pazienza. Il vantaggio è che nel frattempo il debitore è protetto e la posizione congelata (non aumentano interessi, non subisce azioni). Quindi spesso meglio sopportare 2-3 anni di procedura che anni infiniti di inseguimento da parte di creditori senza soluzione.
D: Dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione, dovrò comunque pagare i debiti rimasti?
R: No, se ottieni l’esdebitazione. Nelle procedure concorsuali attuali, l’esdebitazione del debitore persona fisica è quasi sempre prevista:
– Nel fallimento (liquidazione giudiziale), il debitore può chiedere di essere esdebitato una volta chiusa la procedura e distribuito l’attivo. Se ha cooperato lealmente e non ci sono stati illeciti gravi, il tribunale cancella tutti i debiti residui non soddisfatti. Ciò significa che i creditori non pagati non potranno più agire.
– Nella liquidazione controllata sovraindebitamento, l’esdebitazione è concessa di diritto a chi ha rispettato obblighi, senza neanche dover fare istanza specifica (a meno di eccezioni). Quindi a fine liquidazione, pulito.
– Nel concordato preventivo o minore, se il debitore esegue integralmente quanto promesso dal piano, i creditori hanno già accettato di rinunciare alla parte eccedente: quindi di fatto i debiti residui restano inesigibili. Non c’è un formale “decreto di esdebitazione” perché è implicito nell’omologa (il creditore è obbligato a considerarsi soddisfatto con quanto ricevuto). L’importante è adempiere al piano concordatario: se il debitore, poniamo, doveva pagare il 40% e paga davvero quel 40%, il restante 60% è giuridicamente inesigibile (il concordato omologato fa stato di giudicato).
– Nell’accordo di ristrutturazione, simile: i creditori firmatari rinunciano alla quota eccedente, i non aderenti li paghi per intero o come da accordo se efficacia estesa, quindi non restano pendenti.
– Ovviamente, restano esclusi dal beneficio alcuni debiti peculiari che la legge non fa cancellare: ad esempio, le multe penali o i debiti per obblighi di mantenimento non si cancellano nemmeno con il fallimento o il sovraindebitamento (il creditore potrà agire anche post-esdebitazione per quelli). Ma parliamo di situazioni particolari.
In conclusione: dopo la chiusura di una procedura concorsuale, un debitore onesto persona fisica esce liberato dal peso dei debiti non pagati (fresh start). Se invece non ricorre a nessuna procedura e i debiti restano insoddisfatti, essi (finché non prescritti) potrebbero teoricamente tormentarlo vita natural durante, con interessi e nuove azioni. Questo è proprio uno dei motivi per cui le procedure sono consigliabili: spezzare la spirale infinita.
D: Posso trovare un accordo con il Fisco per pagare meno tasse rispetto al dovuto?
R: Sì, ma principalmente all’interno di procedure o mediante gli strumenti straordinari dettati dalle leggi di bilancio. Mi spiego:
– Definizioni agevolate (rottamazioni, condoni): se il legislatore le prevede, approfittane. Ad esempio la Rottamazione-quater 2023 ha permesso di pagare le cartelle eliminando sanzioni e interessi – un risparmio enorme per chi aveva multe, IVA, IRPEF arretrate. Queste opportunità però sono episodiche e fissate per legge (non è discrezionale del singolo funzionario concedertele: devi rientrare nei requisiti e presentare domanda nei termini).
– Rateazioni normali: dilazionare non riduce l’importo, ma almeno evita misure aggressive e spalma il peso.
– Transazione fiscale e contributiva nel concordato o accordo: ecco il caso in cui si può pagare meno di quanto dovuto a Fisco e INPS, previo ok del giudice. Se proponi un concordato preventivo, puoi includere la proposta di stralcio parziale dei debiti tributari e contributivi. Le condizioni sono: per IVA e ritenute fiscali si può solo dilazionare, non stralciare il capitale (quelle per legge vanno pagate almeno al 100% del capitale, ma si può tagliare sanzioni e interessi); per altre imposte si può offrire una percentuale. Serve il voto favorevole dell’erario, oppure il tribunale può omologare anche senza se comunque offri loro almeno quanto otterrebbero da fallimento. Nel concordato minore, similmente, serve un trattamento non inferiore al loro realizzo in liquidazione. Quindi non c’è una libertà totale, ma uno sconto condizionato alla situazione oggettiva: se il tuo patrimonio farebbe ricavare 10 in fallimento al Fisco, puoi proporre di pagare 10 (o magari 11-12 per incentivare il sì), ma difficilmente 2 – a meno che pure in fallimento prenderebbero 2.
– Accordi extragiudiziali diretti col Fisco: non davvero possibili. L’Agenzia Entrate Riscossione non può per legge farti uno sconto “personalizzato” sul carico fiscale. La transazione la può fare solo dentro un quadro concorsuale approvato dal giudice. Fuori da lì, o paghi o rateizzi o sfrutti rottamazioni.
C’è un istituto chiamato “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà economica (ISEE < €20.000) introdotto nel 2019 per alcune cartelle: quello permetteva di pagare il 16% – 35% del dovuto a seconda dell’ISEE. Ma è anch’esso creato per legge e limitato a certe categorie di debiti.
In sintesi: sì, è possibile pagare meno al Fisco ma non tramite trattativa privata diretta, bensì usando le finestre normative di favore (rottamazioni, saldo e stralcio per persone disagiate) oppure inserendo il Fisco in un piano concordatario dove, in funzione del concorso con gli altri creditori, anche lo Stato accetta un pagamento parziale perché comunque è il meglio che può ottenere. Naturalmente, conviene farsi assistere da un fiscalista/avvocato in queste situazioni, perché ci sono tecnicismi e interlocuzioni specifiche (ad esempio, predisporre una proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII ben motivata per convincere l’Erario).
D: Ho sentito parlare di “saldo e stralcio” dei debiti: in cosa consiste?
R: Saldo e stralcio è un termine informale che indica un accordo transattivo con cui un creditore accetta di chiudere (stralciare) il debito a fronte di un pagamento immediato e inferiore al totale dovuto (saldo parziale). In pratica, il creditore fa uno sconto pur di incassare subito. Esempio: devo €10.000 a un fornitore, gli propongo di pagargliene €6.000 entro 10 giorni e di considerarci pari. Se accetta, firmiamo un accordo transattivo e poi io pago €6.000, e lui rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.
Questo è molto comune con banche o finanziarie per prestiti non garantiti: magari vendono il credito a una società di recupero per il 20% del valore, quindi quella società se ne incassa anche il 30-40% è contenta. O con i fornitori quando temono di non vedere nulla se continuano col legale.
Attenzione però: il “saldo e stralcio” conviene al debitore perché risparmia soldi ed evita procedure, ma richiede che abbia liquidità disponibile subito. Spesso paradossalmente chi è in crisi non ha tot migliaia di euro liquidi per aderire a un saldo e stralcio, anche se sarebbe vantaggioso. A volte ci si fa aiutare da parenti o si vende qualcosa per racimolare la somma transattiva.
Inoltre, conviene anche al creditore se: dubita dell’effettiva solvibilità futura del debitore e preferisce il proverbiale “meglio l’uovo oggi…”; oppure se vuole evitare spese legali e tempi incerti.
Formalmente è una transazione extragiudiziale (artt. 1965 e segg. c.c.). È bene formalizzarla per iscritto dove il creditore dichiara che, a fronte del pagamento pattuito, nulla più avrà a pretendere (così in caso di eventuale cessione futura del suo credito o errori, avete la quietanza e accordo liberatorio in mano).
Per il debitore, chiudere a saldo e stralcio migliora anche la posizione nelle banche dati (il debito risulterà estinto, magari con dicitura “pagato a saldo” ma comunque meglio di “insoluto” permanente).
Quindi, in sintesi: il saldo e stralcio è pagare meno per chiudere il debito subito, ottimo se si dispone di un po’ di denaro liquido e se il creditore è disponibile a rinunciare a una parte. Con i privati è negoziabile liberamente; con il Fisco esiste solo se previsto per legge in certe situazioni (come la misura del 2019 per persone disagiate).
D: Se la situazione è disperata, mi conviene chiudere la partita IVA e aprirne un’altra altrove, ricominciando da zero?
R: No, non è così semplice. Chiudere la partita IVA (quindi cessare formalmente l’attività) non cancella affatto i debiti accumulati. Essi restano a carico dell’imprenditore individuale finché non vengono pagati o non interviene una procedura di esdebitazione. Quindi, se Mario Rossi chiude la sua merceria “Filo&Bottoni di Rossi Mario” oggi, domani potrà anche aprire una nuova partita IVA “Merceria Nuovo Inizio di Rossi Mario”, ma i creditori del vecchio negozio potranno comunque aggredirlo (perché lui personalmente rimane obbligato). Al limite, può cambiare città, insegna, ma se è lo stesso soggetto i debiti lo seguono.
Se invece intende aprire una società nuova di zecca e farla intestare magari a un familiare, stiamo entrando in schemi che potrebbero configurare frode ai creditori. Ad esempio, trasferire l’avviamento e le merci dal vecchio negozio alla nuova società di un prestanome per sottrarli ai creditori può essere impugnato come atto in frode (revocatoria fallimentare se poi c’è fallimento, o ordinaria se no) e anche come reato (bancarotta fraudolenta se c’è fallimento, o sottrazione fraudolenta art. 388 c.p. se no, specie per debiti fiscali).
Quindi attenzione: “scappare” dai debiti non è una soluzione legale. Meglio affrontarli con le procedure adatte (concordati, ecc.) che non cercare un escapismo con altra partita IVA. Tra l’altro, se uno è pieno di debiti e apre altra ditta a nome proprio, i creditori gliela pignoreranno subito appena individuata. E se la mette a nome altrui ma lui di fatto amministra, rischia azioni giudiziarie per simulazione.
Diverso è il caso di chi, dopo aver risolto – legalmente – la propria situazione debitoria (ad esempio con un fallimento chiuso con esdebitazione), decide di ripartire con una nuova attività: questo è lecito e anzi incoraggiato dal concetto di fresh start. Ma “nuova vita” senza chiudere i conti col passato è difficilmente attuabile senza conseguenze legali.
D: Se vendo l’unico immobile che ho (o lo regalo a un parente) per evitare che i creditori me lo prendano, funziona?
R: No, anzi è pericoloso. Qualunque atto di alienazione del patrimonio compiuto dal debitore a titolo gratuito o anche a prezzo ridotto, con il fine di sottrarre i beni ai creditori, può essere annullato tramite azione revocatoria. Ad esempio, se vendo la casa a mio cugino per un importo fittizio basso, il creditore può avviare una causa revocatoria (entro 5 anni) e far dichiarare l’atto inefficace verso di lui, come se la casa fosse ancora mia, e quindi pignorarla lo stesso. Se addirittura la regalo (donazione), la revocatoria è quasi automatica se c’erano già debiti insorti. Anche costituire una società e conferire i beni dentro può essere revocato. E come detto, esiste l’art. 2929-bis c.c. che se, ad esempio, ho donato un immobile dopo che c’era già un creditore, questi può pignorarla direttamente al donatario (il parente), senza neppure dover fare causa, se iscrive pignoramento entro 1 anno dalla donazione.
Inoltre, tali comportamenti configurano la “fraus creditoris” e se poi la situazione sfocia in fallimento, integrano bancarotta. Anche senza fallimento, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000 art.11) punisce chi aliena beni al fine di evitare il pagamento di imposte, con soglie basse (€50k). Quindi vendere/regalare per frodare il Fisco è penalmente rilevante, e in generale verso altri creditori è civilmente annullabile.
L’unico modo in cui “funziona” è se lo fai con larghissimo anticipo, in bonis e per giusta causa (non per frode): es., 10 anni prima costituisco un fondo patrimoniale, poi arrivano debiti imprevedibili – allora il fondo può reggere. Ma farlo quando i creditori sono dietro la porta, no: non salva i beni.
Quindi sconsigliatissimo improvvisare vendite o donazioni a parenti pensando di far perdere le tracce. Molto meglio trattare con i creditori o utilizzare i rimedi legali ammessi.
D: Se la merceria fallisce, non potrò mai più aprire un’attività o avere un conto in banca?
R: Questo era quasi vero decenni fa, ma oggi non è più così. Il fallimento portava con sé alcune incapacità (ad es. l’interdizione dall’esercizio di impresa commerciale durante la procedura – il cosiddetto “fallito civile” – e la segnalazione alla Centrale Rischi come protestato ecc.). Tuttavia:
– La durata delle limitazioni è circoscritta alla procedura: dopo la chiusura del fallimento, l’ex fallito riacquista la capacità di avviare imprese. Può aprire una nuova partita IVA e nessuna legge glielo vieta, soprattutto se ha ottenuto l’esdebitazione.
– Certo, alcune conseguenze reputazionali rimangono: il nome del fallito è pubblicato nel Registro delle Imprese (anche se con la chiusura la posizione viene archiviata). Ci sono banche o partner commerciali diffidenti a dare credito a chi è passato per un fallimento. Ma legalmente, a parte alcuni ruoli (non può fare l’amministratore di condominio finché non riabilitato, cose minori), non ci sono preclusioni permanenti.
– Con l’esdebitazione e il tempo, anche le segnalazioni negative decadono: i dati di fallimento restano in archivio pubblico per 5 anni. I protesti per assegni a loro volta dopo 5 anni si cancellano.
– Può però risultare difficile avere credito bancario subito dopo: la Centrale Rischi segnalerà i “sofferti” e le procedure subite, e la banca valuta il merito creditizio. Ma nel tempo, ricostruendo uno storico pulito, è possibile riottenere fiducia (soprattutto se si documenta che il fallimento è stato sfortunato e non fraudolento).
In generale, la filosofia moderna è di non marchiare a vita chi ha fallito ma anzi favorirne il rientro nel circuito economico. Quindi, una volta chiusa la vecchia vicenda e saldati/stralciati i debiti, sarà possibile aprire un’altra attività. Potrebbe essere utile, per prudenza, all’inizio farlo con soci o in forma di società di capitali per non esporsi subito di nuovo, ma la legge non glielo impedisce.
D: Come posso proteggere i beni della mia famiglia dai miei debiti senza violare la legge?
R: L’approccio corretto è fare pianificazione patrimoniale preventiva quando ancora non ci sono situazioni debitorie critiche. Esempi leciti:
– Regime di separazione dei beni con il coniuge: così i beni intestati al coniuge restano fuori dal perimetro dell’imprenditore.
– Fondo patrimoniale: se la tua impresa è rischiosa, potresti costituire un fondo su casa e risparmi destinato alla famiglia. Come spiegato, ciò li vincola per bisogni familiari e li sottrae a futuri debiti estranei, salvo tu faccia debiti specificamente per la famiglia. Importante farlo in bonis, cioè prima di accumulare debiti, altrimenti è attaccabile.
– Polizze vita e forme previdenziali: somme investite in polizze vita a beneficiari familiari sono insequestrabili e impignorabili (fintanto che restano in forma di assicurazione e non decadono in riscatto, art. 1923 c.c.). È un modo per accantonare denaro al sicuro da pretese future, a patto che non ecceda la figura dell’elusione (ad es. versare cifre enormi all’ultimo momento può essere visto come distrazione). Ma come risparmio graduale è ok.
– Trust familiare: istituire un trust dove conferire alcuni beni a beneficio dei figli può isolare quel patrimonio; dev’essere fatto correttamente (atto notarile, trustee affidabile) e non in vista di default.
– Intestare beni ai figli o alla moglie quando li compri: se compri una casa con i soldi di entrambi, magari intestarla al coniuge non imprenditore riduce il rischio (fermo restando il dovere morale di fiducia perché legalmente poi è sua).
– In caso di indebitamento già in corso ma volendo evitare il peggio, l’unica via sicura è negoziare una soluzione concorsuale: ad esempio, in un concordato minore puoi pattuire di pagare i creditori con certe risorse ma tenerti la casa se la legge lo consente (a volte è fattibile offrendo ai creditori un valore equivalente in altra forma). Oppure vendere tu la casa e usare provento parziale per transare con creditori, salvando una parte per la famiglia (questo è borderline ma se trasparente – cioè i creditori accettano di stralciare a fronte di quella somma e quindi implicitamente ti lasciano la parte residua – diventa lecito per accordo).
In sintesi: giocare d’anticipo è la chiave. Una volta dentro la crisi, le opzioni lecite si restringono.
D: Cosa devo fare se ricevo un precetto o un pignoramento?
R: Prima di tutto, non ignorarlo! Il precetto è l’ultimo avviso prima dell’azione esecutiva: hai 10 giorni per pagare o vedere pignorato qualcosa. Appena arriva:
1. Controlla con un legale la validità: il precetto fa riferimento a un titolo (es. decreto ingiuntivo) – è stato notificato regolarmente? Il precetto contiene tutti i dati (somme, intimazione chiara)? Se c’è qualche vizio, l’avvocato potrà proporre opposizione agli atti per sospenderlo.
2. Valuta se il debito è esatto: magari nel frattempo hai pagato una parte, o hai contestazioni in corso; comunica subito al creditore eventuali errori (es. “mi intimi 10.000 ma ne ho pagati 3.000, eccone la prova”). Se il creditore è onesto, ricalcolerà; altrimenti quell’argomento va portato in un’opposizione all’esecuzione (parziale).
3. Se il debito è dovuto e puoi pagare entro 10 giorni, pagalo (il precetto include già spese legali minime, pagando eviti il pignoramento e ulteriori costi). Fatti rilasciare quietanza e comunica formalmente l’adempimento così non procedono oltre.
4. Se non puoi pagare subito, contatta immediatamente il creditore (o il suo avvocato) proponendo un piano: magari riesci ad evitare il pignoramento se mostri buona volontà. Molti creditori concedono qualche settimana in più se vedono che stai cercando risorse o vendendo beni per pagarli. Formalizza eventuali accordi di proroga.
5. Preparati al pignoramento: individua quali beni potrebbero attaccare. Se è un credito bancario, aspetta un possibile pignoramento del conto: valuta di mantenere sul conto solo il minimo, spostando liquidità altrove (legalmente puoi farlo prima che arrivi l’ordine, non è vietato mettere i soldi su un conto intestato al coniuge ad es., ma occhio a non svuotare per frode; spostare liquidità non è revocatorio di solito). Se hai il timore per l’auto, potresti tenerla lontana o in un luogo non accessibile (ma l’ufficiale può comunque fare fermo al PRA). Se hai beni in casa di valore, potresti depositarli altrove in custodia a terzi prima (non durante) per evitare di farli trovare, ma attenzione a non farti scoprire in flagrante perché sarebbe frode.
6. Valuta difese legali: se la somma è cospicua e ingiusta, il tuo avvocato può presentare opposizione al pignoramento e chiedere una sospensione, ma va fatto tempestivamente (spesso prima o subito dopo l’atto di pignoramento) e con solide ragioni.
7. All’atto pratico del pignoramento: collabora con l’ufficiale giudiziario, non opporre resistenza (commetteresti reato). Puoi però evidenziare cosa è impignorabile (es. “quello è il letto dei miei figli, non potete toccarlo”), e l’ufficiale deve lasciarlo. Fai verbalizzare se qualcosa è di terzi (“questo macchinario è in leasing, ecco il contratto”). Ogni elemento utile a ridurre il danno, dillo. L’ufficiale spesso non pignora cose di dubbia utilità (p.es. mobili vecchi senza mercato).
8. Dopo il pignoramento: hai ancora opportunità come la conversione (versare per riottenere i beni) o la riduzione se eccessivo. Quindi verifica con il tuo legale l’inventario pignorato e agisci di conseguenza (es. chiedere di liberare beni non necessari perché il debito si copre già vendendone una parte).
Insomma, la parola d’ordine è reattività: non subire passivamente ma gestire anche l’esecuzione, usando tutti i mezzi legali e di trattativa per limitarla.
Abbiamo coperto molte domande tipiche. Passiamo ora a degli esempi pratici simulati, che possono aiutare a capire come applicare questi concetti in situazioni reali analoghe a quelle che può vivere un titolare di merceria indebitata.
Esempi pratici e casi simulati
Di seguito descriviamo alcuni casi ipotetici, ispirati a situazioni ricorrenti, e vediamo quali strategie potrebbe adottare il debitore (la merceria) in ciascuno scenario per difendersi e risolvere la crisi.
Caso 1: Sovraindebitamento di una merceria individuale e concordato minore
Scenario: Marco gestisce una merceria individuale a conduzione familiare. Negli ultimi anni, complici la concorrenza dei grandi store e il calo di clientela, accumula debiti: €20.000 con fornitori di tessuti, €15.000 di affitto arretrato del locale, €10.000 di IVA non versata e €25.000 di scoperto di conto con la banca. In totale €70.000 circa. Marco ha già venduto l’auto per pagare stipendi (aveva due dipendenti, poi licenziati) e possiede come beni rilevanti solo metà della casa coniugale (del valore di €120.000 totali, cointestata con la moglie). Il negozio purtroppo non genera abbastanza utili per coprire tutte le rate promesse nei piani di rientro presi in modo disordinato. Arrivano un decreto ingiuntivo dal proprietario dei muri e intimazioni dalla banca.
Problema: Marco è insolvente ma vorrebbe evitare sia di perdere la casa sia di venire perseguitato a vita dai creditori. Vuole chiudere dignitosamente l’attività pagando il possibile.
Soluzione: Marco si rivolge all’Organismo di Composizione Crisi locale e apre una procedura di concordato minore (sovraindebitamento). Con l’aiuto dell’OCC, predispone una proposta: offrirà ai creditori il ricavato della vendita del magazzino (valutato €5.000) e di alcuni macchinari (€3.000), più metterà a disposizione una parte della casa coniugale. Poiché la casa è in comunione con la moglie, per non perderla completamente propone di venderla e trasferirsi in affitto: un parente è disponibile ad acquistarla per €120.000, di cui metà (€60.000) spetta a Marco. Detratte le spese e tenuto conto di un piccolo mutuo residuo sul immobile (€10.000), Marco può destinare ai creditori circa €50.000. Propone di ripartirli così: pagare integralmente il Fisco (€10.000 IVA) e il locatore privilegiato (€5.000 canoni ultimi con privilegio), e il restante ~€35.000 andrà ai chirografari (fornitori, banca) che vantano circa €55.000 di crediti, realizzando quindi circa il 65% per loro. Il piano prevede la vendita immediata dei beni e il pagamento ai creditori in un’unica soluzione entro 6 mesi dall’omologa. I creditori votano: tutti i chirografari sono favorevoli (meglio il 65% subito che rischiare un fallimento con esito incerto), anche la banca (che è soddisfatta dal fatto che la sua perdita è contenuta e incassa subito senza spese legali). L’erario e il locatore non votano perché sono privilegiati pagati al 100%. La maggioranza richiesta si raggiunge facilmente.
Il Tribunale omologa il concordato minore. A questo punto Marco procede a vendere casa (l’atto viene autorizzato dal giudice all’interno del concordato) e a liquidare le merci. Entro pochi mesi, effettua i pagamenti concordati ai creditori. La procedura si chiude con un decreto che accerta l’avvenuto adempimento. Risultato: Marco ha perso la casa, vero, ma i creditori sono stati soddisfatti parzialmente e il residuo debito di €20.000 circa (la parte non pagata ai chirografari) viene cancellato definitivamente per effetto dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato. Marco e la sua famiglia si trasferiscono in affitto; lui chiude la partita IVA della merceria ormai liquidata. Grazie all’esdebitazione implicita, potrà cercarsi un lavoro o un’altra iniziativa senza i vecchi debiti sul groppone. I fornitori hanno incassato buona parte e non possono più pretendere altro, la banca ha chiuso la posizione (e magari toglierà la segnalazione in sofferenza).
Analisi: In questo caso, la procedura di sovraindebitamento (concordato minore) ha consentito di salvaguardare la dignità del debitore: ha dovuto sacrificare dei beni (anche la casa), ma lo ha fatto in modo controllato, ottenendo in cambio la liberazione dai debiti restanti. Se non avesse seguito questa strada, probabilmente banca e locatore avrebbero fatto istanza di fallimento; la casa sarebbe stata pignorata lo stesso e venduta all’asta a prezzo magari inferiore, i creditori forse avrebbero ottenuto ancora meno e Marco sarebbe rimasto debitore del residuo non coperto. Così invece la situazione si è risolta in circa 1 anno e lui può ripartire, seppur ridimensionato.
Caso 2: Liquidazione giudiziale di una società e responsabilità del socio
Scenario: La “Mercerie Sorriso S.a.s.”, gestita dai fratelli Luigi (accomandatario) e Anna (accomandante), ha operato per 15 anni con successo moderato. Negli ultimi tempi però accumula perdite per concorrenza di e-commerce. Ha debiti totali per €300.000: con le banche (€100k mutuo + €50k scoperto), fornitori (€80k), Erario (€50k IVA, IRAP) e altri €20k vari. Attivi pochi: merce invenduta €30k, arredi negozio €10k, cassa €5k. Luigi aveva fatto da garante personale sul mutuo bancario. La società nel 2025 cessa l’attività per impossibilità a proseguire. Restano insoluti molti debiti, i creditori fanno cause.
Problema: La S.a.s. supera le soglie di fallibilità (ricavi medi €400k, debiti €300k > €500k no, ma attivo €200k e ricavi €400k fanno presumere soglia superata in due parametri). Inoltre, più creditori premono. Un fornitore presenta istanza di fallimento.
Soluzione: Il tribunale dichiara lo stato di liquidazione giudiziale (fallimento) della S.a.s. Luigi come socio accomandatario è soggetto a fallimento personale esteso (i soci illimitatamente responsabili falliscono insieme alla società). Anna essendo accomandante no. Viene nominato un curatore. Questi inventaria i beni: il magazzino e gli arredi verranno venduti ricavando forse €20k netti. Il curatore rileva che Luigi prima del fallimento ha pagato furtivamente un fornitore amico preferendolo agli altri per €5k: ciò costituisce pagamento preferenziale revocabile entro 6 mesi dal fallimento, quindi fa causa revocatoria e recupera quei €5k nel fallimento (il fornitore dovrà restituirli). Luigi inoltre aveva venduto 1 anno prima un furgone a suo cugino a metà del valore di mercato: anche questo atto è revocabile (entro 2 anni come atto a titolo oneroso con contrapparte parente): il curatore ottiene risoluzione e il cugino versa la differenza di €3k. Si forma quindi un attivo di cassa di circa €28k. I crediti di Anna (socia accomandante) verso la società per finanziamenti infruttiferi sono postergati, quindi non avranno niente.
Il curatore redige il piano di riparto: prima paga le spese (procedura costata €8k tra curatore e giustizia), rimangono €20k per i creditori. Distribuisce: i dipendenti (avevano €5k TFR, un lavorante part-time) prendono tutto (privilegio lavoro); il Fisco con privilegio per IVA preferita prende i suoi €5k (mettiamo ne aveva 10k privilegiati, prende pro quota 50% = 5k); altri privilegiati (nessuno in esempio) nulla; i chirografari banche/fornitori divideranno eventuale residuo (in effetti qui dopo preferiti non resta quasi nulla, ipotizziamo €2k totali: su €200k di crediti chirografi è l’1%). Finito ciò, la società viene cancellata. Luigi in quanto ex socio accomandatario rimane debitore per le somme non soddisfatte (in teoria). Tuttavia Luigi può chiedere al tribunale di essere esdebitato dai debiti residui personali. Il tribunale, constatato che Luigi ha cooperato (ha consegnato contabilità, ecc.), e malgrado qualche anomalia (quei pagamenti preferenziali) però non fraudolenta intenzionale, decide di concedere l’esdebitazione. Così Luigi viene liberato da tutte le obbligazioni residue verso i creditori sociali (banche, fornitori, Fisco per la parte scoperta).
La banca cercherà di recuperare il suo mutuo non pagato escutendo la garanzia di Luigi (che è persona fisica illimitatamente responsabile e garante): ma con la sentenza di esdebitazione, Luigi è protetto e la banca non può agire ulteriormente su di lui oltre quel poco che ha preso in fallimento. Idem gli altri. Luigi però perde la sua quota di proprietà di casa coniugale? In questo caso, la casa di Luigi e di sua moglie non era in fondo patrimoniale e poteva essere ipotecata/pignorata. Fortunatamente non c’era ipoteca, e per pignorarla i creditori dovevano farlo prima del fallimento. Con il fallimento, la quota di Luigi (50%) entra nell’attivo fallimentare. Se la moglie vuole tenere casa, dovrà riscattare la quota del marito da curatore (magari paga €50k al fallimento e la ottiene). Nel nostro scenario però non abbiamo dettagli su questo. Diciamo che se la moglie ha fatto ciò, quell’importo ha alimentato l’attivo distribuibile. Luigi poi, da persona esdebitata, può ricominciare come commesso in un altro negozio.
Analisi: Qui la difesa del debitore è stata minima, subendo il fallimento. Tuttavia anche nel fallimento c’è salvezza tramite esdebitazione. Notare come la differenza tra società e persona abbia giocato: Anna accomandante perde i soldi investiti ma non risponde oltre, Luigi invece sì ma poi viene liberato. Dal punto di vista dei creditori, hanno ottenuto molto poco (come in molti fallimenti), ma è la fine della vicenda e possono almeno dedurre fiscalmente il credito inesigibile.
Il caso insegna che se Luigi e Anna avessero agito prima (es. componendo negozialmente con la banca e vendendo la merce per conto proprio) forse avrebbero potuto fare un concordato minore offrendo magari 15-20% e salvando la casa. Non avendolo fatto, il fallimento ha portato a risultati modesti per tutti.
Caso 3: Debiti fiscali e difesa della prima casa tramite rateazione e rottamazione
Scenario: “Merceria Filocolore di Paola” è in crisi ma continua l’attività sperando in ripresa. Paola però ha accumulato debiti con il fisco per €40.000 (IVA di 2 anni e IRPEF personale) e con INPS €10.000 (contributi dipendenti). L’Agenzia Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca sulla casa di Paola (un appartamento dove vive, unica proprietà, ipoteca per sicurezza) perché il debito supera €20k. Non può per legge espropriarla (prima casa), ma l’ipoteca c’è. Inoltre, Equitalia ha già bloccato l’auto con fermo amministrativo per quei debiti. Paola rischia anche sanzioni penali perché l’IVA evasa di un anno supera €250k? (Nel nostro esempio no, €40k totali non integrano soglia penale, quindi ok amministrativo).
Problema: Come risolvere i debiti fiscali per liberare la casa e l’auto, senza far chiudere la merceria?
Soluzione: Nel 2023 il governo ha varato la “Definizione agevolata 2023 – Rottamazione-quater”. Paola presenta domanda entro il termine (30 aprile 2023) inserendo tutte le sue cartelle esattoriali. La rottamazione le consente di pagare solo il capitale dovuto (e le spese vive) senza sanzioni né interessi di mora. Nei conteggi, dei €40k di cartelle, almeno €8k erano sanzioni e €5k interessi: questi vengono annullati. Resta da pagare circa €27.000, che Paola sceglie di dilazionare in 18 rate (5 anni). Le prime due rate del 2023 le paga grazie a un piccolo prestito familiare. Dal 2024 al 2028 pagherà 4 rate l’anno di circa €3.000. Nel frattempo, appena accolta l’istanza di rottamazione, le misure esecutive sono sospese : Equitalia sospende i fermi e non attiva nuovi pignoramenti; il DURC di Paola torna regolare .
Paola quindi può nuovamente usare l’auto (il fermo viene revocato una volta pagata la prima rata) e, cosa importante, la casa rimane ipotecata ma non verrà espropriata – e se Paola completa i pagamenti, a fine 2028 potrà chiedere la cancellazione dell’ipoteca. I contributi INPS di €10k: anche quelli rientrano nella rottamazione (perché l’INPS affida ruoli a Equitalia). Paola li include: su €10k forse €3k erano sanzioni aggiuntive, quindi risparmio pure lì e li paga nel piano.
Risultato: Paola riesce a mettere in sicurezza i beni personali (auto e casa) grazie alla definizione agevolata, e ha ridotto il debito fiscale di circa un 30%. Certo, dovrà rispettare le rate per 5 anni. Per farlo, riduce le spese, lavora lei senza dipendenti (così niente contributi futuri), e ogni trimestre versa puntuale. Così facendo, evita il tracollo: senza rottamazione forse sarebbero partiti pignoramenti di conto e stipendio del marito (coobbligato se avesse firmato), e lei sarebbe stata esclusa da gare o forniture per mancanza di DURC. Invece, con il piano approvato, è considerata temporaneamente regolare e può proseguire.
Analisi: Questo caso mostra l’importanza di sfruttare gli strumenti normativi come la rottamazione. Paola avrebbe potuto anche chiedere una rateazione ordinaria se non ci fosse stata rottamazione: in tal caso su €50k poteva ottenere 72 rate (6 anni) ma pagando tutto più interessi. La rottamazione è stata più vantaggiosa. In generale, per i debiti fiscali, mai ignorare le cartelle: sempre valutare se c’è possibilità di rate o definizione. Ora Paola deve essere diligente: se salta una rata > 5 giorni, perde i benefici e le sanzioni tornano tutte. Ma l’impegno vale la candela.
Caso 4: Ristrutturazione debito bancario e salvaguardia dell’attività
Scenario: Davide ha una merceria avviata, ma ha anticipato troppi soldi per rinnovare l’arredamento e ora fatica sulle rate di un mutuo chirografario di €80.000 fatto 3 anni fa (rata €1.500/mese). Inoltre la banca gli ha ridotto il fido di conto, mettendolo in crisi di liquidità. Davide però ha prospettive di miglioramento: un e-commerce in partenza, e prevede più incassi a breve. Vorrebbe evitare di finire in default con la banca (che altrimenti segnalerebbe sofferenza e magari pignorerebbe il magazzino in pegno).
Problema: Serve ridurre l’esborso mensile verso la banca per un periodo, senza romperci i rapporti.
Soluzione: Davide si reca in banca con il suo commercialista e spiega la situazione con trasparenza, presentando un mini-piano di risanamento: chiede una ristrutturazione del mutuo, ovvero di allungarne la durata da 5 anni residui a 10 anni, così da dimezzare la rata. In più, chiede 6 mesi di solo interesse (pre-ammortamento) per riprendersi. La banca valuta: Davide è un cliente di lungo corso, mai insolvente finora, e il settore merceria ha margini ma sta modernizzandosi con online come sta facendo lui. Inoltre Davide propone di dare a garanzia ipotecaria un piccolo terreno che possiede (che la banca prima non aveva). La banca accetta di rinegoziare il mutuo (strumento privato extragiudiziale), formalizzando un accordo ex art. 121 TUB: nuovo piano decennale, interessi magari un po’ aumentati per il maggior rischio, ma sostenibile per Davide (rata scende a €800). In compenso, viene iscritta un’ipoteca sul terreno di Davide come garanzia aggiuntiva. La banca inoltre ripristina parzialmente il fido di conto (€10k) per dargli respiro sui fornitori.
Risultato: Davide riesce a evitare il default bancario e quindi nessuna segnalazione negativa. Con la rata ridotta, continua l’attività, nel frattempo il nuovo canale e-commerce migliora i ricavi. Dopo 2 anni, può tornare a rate normali e anzi paga qualche importo extra per ridurre il debito. La relazione con la banca è salva e la merceria non ha subito né esecuzioni né procedure concorsuali.
Analisi: Questo caso evidenzia che la comunicazione tempestiva e la negoziazione personalizzata con i creditori (specie banche) può portare a soluzioni win-win fuori dai tribunali. La banca preferisce allungare e avere garanzie piuttosto che classificare come sofferenza un cliente e dover svalutare il credito. Dal canto suo, Davide ha evitato interventi più drastici (non ha dovuto vendere nulla né farsi pignorare). Chiaramente ciò funziona se il problema è temporaneo e il debitore mantiene credibilità agli occhi del creditore.
Caso 5: Uso improprio di strumenti di protezione patrimoniale e revoca
Scenario: Francesca, titolare di una merceria, percepisce di non farcela più a pagare i debiti. Temendo per la casa di proprietà (valore €200k, cointestata col marito, ma lei è debitrice principale di €100k verso vari creditori), decide di costituire all’ultimo un fondo patrimoniale su casa e conto bancario per “blindarli”. Dopo 1 anno, i creditori ottengono la liquidazione controllata di Francesca (sovraindebitamento) e scoprono il fondo.
Problema: Il fondo è stato istituito quando già c’erano i debiti e con l’intento di sfuggire ai creditori.
Esito: Il Liquidatore attiva un’azione revocatoria contro il fondo patrimoniale entro 2 anni dall’apertura liquidazione: il giudice rileva la fraudolenza (essendo atto a titolo gratuito successivo ai debiti, la malafede si presume) e dichiara inefficace il fondo verso i creditori. Pertanto la casa rientra nella liquidazione e verrà venduta per soddisfare i creditori. Francesca perde la casa, e per di più il giudice le nega l’esdebitazione piena per mala fede (avendo tentato di frodare i creditori). Dovrà aspettare anni per riprovare a chiedere esdebitazione (nel frattempo rimarranno eventuali debiti non soddisfatti pendenti).
Analisi: Questo mostra il rovescio: tentare furbate last-minute come fondi, trust o vendite simulate non solo non protegge i beni, ma peggiora la posizione del debitore rendendolo non meritevole e allungando i suoi guai. Se Francesca avesse agito onestamente – magari concordando un piano con i creditori o consegnando i beni volontariamente – avrebbe ottenuto forse l’esdebitazione e chiuso il capitolo. Così invece ha perso ugualmente i beni e pure la liberazione dai debiti. La morale è: usare strumenti di protezione solo in tempi non sospetti e per scopi leciti, e non affidarsi a escamotage quando i buoi sono scappati.
Questi esempi pratici confermano in concreto molte regole discusse: la vantaggiosità delle procedure di composizione, l’utilità di sfruttare definizioni agevolate, il valore del dialogo con i creditori, e il rischio di comportamenti scorretti. Ogni situazione chiaramente va valutata nelle sue specificità, preferibilmente con l’aiuto di professionisti (avvocati, commercialisti esperti in crisi d’impresa) che possano consigliare la strategia migliore.
Conclusioni
Trovarsi con una merceria indebitata è una circostanza difficile ma, come abbiamo visto, non senza vie d’uscita legali. L’ordinamento italiano mette a disposizione strumenti diversificati per gestire il debito, modulati secondo la gravità della situazione e la tipologia del debitore.
Dal punto di vista pratico, ecco alcuni consigli finali per l’imprenditore (o ex imprenditore) in crisi debitoria: – Non isolarsi e agire per tempo: appena ci si rende conto che i debiti stanno sfuggendo di mano, è fondamentale rivolgersi a consulenti qualificati (commercialisti, avvocati) e studiare un piano. Più si aspetta, più i creditori perderanno fiducia e adotteranno misure coercitive. – Mappare tutti i debiti e le priorità: occorre sapere con certezza chi sono i creditori, quali importi, se ci sono garanzie. Distinguere debiti prioritari (es. stipendi, imposte con rischio penale) da quelli negoziabili (fornitori, banche). Così si può definire una scala di pagamenti o proposte. – Comunicare con i creditori: la trasparenza paga. Molti fornitori o banche preferiscono concordare piani di rientro se il debitore li informa onestamente delle difficoltà ma anche delle prospettive. Al contrario, sparire o fare promesse non mantenute li spingerà subito dal giudice. – Valutare gli strumenti concorsuali adeguati: se i debiti superano la capacità di rimborso, non ostinarsi a inseguire una coperta corta. Meglio utilizzare procedure come il sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore) che congelano gli interessi, bloccano le esecuzioni e permettono di tagliare legalmente i debiti. L’orgoglio di “non fallire” è cattivo consigliere: spesso si finisce per perdere comunque tutto, ma senza l’esdebitazione. Meglio un concordato con il 30% pagato e chiudere dignitosamente, che restare inseguiti al 100% a vita. – Salvaguardare il necessario alla vita: la legge già prevede di lasciare al debitore i mezzi minimi. Se possibile, accordarsi con i creditori/curatore per conservare ad esempio l’automobile indispensabile al lavoro (magari proponendo di compensare col valore in altro modo), o l’attrezzatura base. In un piano del consumatore, si può prevedere che il debitore mantenga la casa se offre ai creditori altre utilità equivalenti (non sempre fattibile, ma da esplorare). – Evitare favoritismi e gesti di panico: fare pagamenti preferenziali a qualche creditore nascondendoli agli altri, o vendere sottobanco beni a parenti, sono azioni che poi vengono generalmente scoperte e sanzionate. Meglio agire sotto l’egida del tribunale (che ha strumenti per regolare la par condicio in modo equo). – Nuova chance: una volta affrontata la crisi e ottenuta l’esdebitazione, imparare dagli errori e ripartire con basi più solide (ad esempio, tenendo separato il patrimonio personale tramite una società di capitali, accantonando fondo rischi, assicurandosi contro imprevisti). L’esperienza, per quanto dura, può diventare un insegnamento.
In definitiva, “cosa fare e come difendersi” per una merceria con debiti si traduce in un mix di strategie legali e di buon senso imprenditoriale: usare tutti gli strumenti normativi a disposizione (dalle dilazioni alle procedure concorsuali) e mantenere un atteggiamento proattivo, documentato e collaborativo. Il sistema giuridico italiano, pur complesso, offre oggi varie opportunità di risanamento e perdono dei debiti per chi dimostra impegno e onestà. Dal punto di vista del debitore, conoscere i propri diritti – e i doveri – è la prima forma di difesa.
Questa guida, con fonti normative e sentenze aggiornate al 2025, ha cercato di fornire un quadro completo ed avanzato, utile sia a professionisti del settore (avvocati, consulenti) sia agli stessi imprenditori e privati coinvolti, affinché possano orientarsi nelle scelte critiche e, auspicabilmente, trovare una via d’uscita sostenibile dal peso dei debiti.
Gestisci una merceria, un negozio di filati, bottoni e articoli per il cucito, e ti ritrovi con debiti verso fornitori, banche o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci una merceria, un negozio di filati, bottoni e articoli per il cucito, e ti ritrovi con debiti verso fornitori, banche o Agenzia delle Entrate?
Hai cartelle esattoriali, affitti arretrati, leasing o mutui non pagati, contributi INPS o IVA scaduti, e temi pignoramenti, blocchi bancari o la chiusura dell’attività?
👉 Non disperare: anche le piccole attività artigianali e commerciali come le mercerie possono difendersi legalmente, bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti, e ripartire in modo regolare e protetto, senza fallire.
In questa guida scoprirai perché molte mercerie finiscono in difficoltà, quali strumenti legali puoi utilizzare, e come salvare o chiudere la tua attività senza perdere tutto ciò che hai costruito.
🧵 Perché le mercerie si indebitano
Le mercerie, simbolo dell’artigianato e del commercio locale, soffrono da anni a causa di costi e concorrenza crescenti. Le principali cause di crisi sono:
- Aumento dei costi di gestione (affitti, energia, forniture);
- Concorrenza dei negozi online e delle grandi catene di hobbistica;
- Margini di guadagno ridotti e flussi di cassa instabili;
- Tassazione e contributi difficili da sostenere per piccole imprese;
- Errori di contabilità o ritardi nei versamenti fiscali;
- Calo della clientela e della spesa media per prodotti tradizionali.
📌 Tutto ciò può rapidamente generare debiti fiscali, bancari e commerciali, mettendo a rischio la continuità del negozio e il reddito familiare.
🧾 Tipologie di debiti più comuni nelle mercerie
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IVA, IRPEF, INPS, INAIL, TARI, cartelle esattoriali e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Mutui e leasing per arredi, registratori di cassa, vetrine o sistemi POS.
- Scoperti di conto e prestiti per liquidità.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori di filati, tessuti, bottoni, accessori e merceria varia.
✅ Debiti verso dipendenti e collaboratori
- Stipendi arretrati, contributi non versati, TFR e spese di gestione.
✅ Debiti personali o fideiussioni
- Garanzie firmate dal titolare o dai soci per mutui e prestiti aziendali.
⚠️ Cosa rischia una merceria indebitata
Se la situazione non viene affrontata tempestivamente, i creditori possono:
- pignorare conti correnti, incassi e merce;
- bloccare i rapporti con i fornitori;
- revocare fidi e finanziamenti;
- emettere cartelle, ipoteche o decreti ingiuntivi;
- costringerti alla chiusura dell’attività.
👉 Tuttavia, la legge oggi ti permette di bloccare immediatamente i creditori, ristrutturare i debiti e salvare o chiudere in modo protetto la tua merceria, senza fallimento.
🧩 Le soluzioni legali per mercerie con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Con l’assistenza di un avvocato puoi ottenere:
- riduzioni del debito (saldo e stralcio);
- rateizzazioni più lunghe e compatibili con le entrate;
- sospensioni temporanee dei pagamenti per riprendere liquidità.
👉 È la scelta ideale per chi vuole continuare a lavorare e mantenere rapporti con i fornitori.
💠 2. Procedura di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa)
È la procedura più utilizzata da microimprese e attività familiari.
Permette di:
- bloccare pignoramenti, cartelle e azioni dei creditori;
- presentare un piano di pagamento parziale, proporzionato al reddito;
- ottenere la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).
📌 Perfetta per mercerie individuali o a conduzione familiare.
💠 3. Concordato minore (per SRL o società di commercio)
È la procedura omologata dal Tribunale che consente di:
- bloccare tutte le azioni esecutive e fiscali;
- ridurre legalmente i debiti fiscali, bancari e commerciali;
- preservare la continuità aziendale e i contratti in corso.
📌 È la soluzione giusta per negozi più strutturati con dipendenti o più sedi.
💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)
Se l’attività non è più sostenibile, puoi chiudere in modo legale e protetto, mettendo a disposizione solo i beni non indispensabili (attrezzature, scorte, arredi).
Al termine della procedura, il Tribunale cancella tutti i debiti residui, permettendoti di ricominciare senza pendenze.
💠 5. Verifica e contestazione delle cartelle esattoriali
Molte cartelle contengono errori o importi prescritti.
Un avvocato può:
- controllare la prescrizione (5 o 10 anni);
- eccepire errori di calcolo o notifiche irregolari;
- chiedere la sospensione o l’annullamento delle somme non dovute.
🪡 Cosa fare subito
✅ 1. Raccogli tutta la documentazione
Prepara bilanci, cartelle, mutui, leasing, fatture, contratti di affitto e spese fisse.
✅ 2. Blocca i creditori immediatamente
Con il deposito in Tribunale di una procedura legale (sovraindebitamento o concordato), tutti i creditori vengono sospesi per legge.
✅ 3. Evita nuovi debiti o rateizzazioni improvvisate
Serve una strategia legale completa, studiata da un avvocato esperto in diritto commerciale e crisi d’impresa.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale del titolare o amministratore.
- Visura camerale e bilanci aziendali.
- Dichiarazioni fiscali e posizione INPS/INAIL.
- Contratti di leasing, mutui e finanziamenti.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori, clienti e dipendenti.
- Estratti conto bancari e documentazione contabile.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e strategia legale: 1–3 settimane.
- Deposito della procedura: 1–2 mesi.
- Blocco dei creditori: immediato con il deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Stop a pignoramenti e cartelle.
- Riduzione o cancellazione legale dei debiti.
- Tutela del negozio e del reddito familiare.
- Ripartenza economica e professionale serena.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni dei creditori.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Continuità operativa o chiusura protetta senza fallimento.
✅ Tutela delle scorte, del locale e del reddito personale.
✅ Ripartenza economica pulita e sostenibile.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o notifiche fiscali.
- Accumulare nuovi debiti per coprire quelli vecchi.
- Pagare solo alcuni creditori peggiorando la posizione complessiva.
- Vendere beni o merce senza tutela legale.
- Attendere troppo prima di agire.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione economica e debitoria nel dettaglio.
📌 Ti consiglia la soluzione migliore: rinegoziazione, sovraindebitamento, concordato o liquidazione controllata.
✍️ Redige e deposita il piano legale per bloccare subito i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche, leasing e fornitori.
🔁 Ti accompagna fino alla cancellazione totale dei debiti o alla ristrutturazione completa della tua merceria.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di negozi, botteghe e attività artigianali con debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere una merceria con debiti non significa dover chiudere o fallire.
Con una difesa legale mirata e tempestiva, puoi bloccare i creditori, ridurre drasticamente i debiti fiscali e bancari, e continuare a lavorare in modo sereno e legale, oppure chiudere l’attività in modo ordinato e senza rischi.
La legge oggi tutela chi agisce con trasparenza e vuole davvero ripartire.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova impresa artigianale senza debiti comincia oggi.