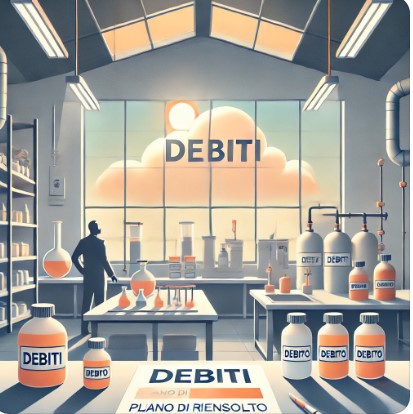Gestisci un’impresa di produzione di prodotti chimici, detergenti o soluzioni per la pulizia industriale e domestica e ti trovi in difficoltà economica a causa di debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche? È una situazione che molte aziende del settore stanno affrontando. L’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia e del trasporto, unito alla forte concorrenza e alla riduzione dei margini di profitto, ha messo in crisi numerose imprese del comparto chimico. Quando si accumulano cartelle esattoriali, rate di finanziamenti non pagate o contributi arretrati, il rischio di blocchi produttivi e pignoramenti diventa concreto. La buona notizia è che la legge prevede soluzioni concrete per gestire, rateizzare o cancellare i debiti, tutelando la tua impresa e il tuo patrimonio personale.
Perché molte aziende del settore chimico si indebitano
Le imprese che producono detergenti, disinfettanti o altri prodotti chimici devono sostenere costi fissi elevati per materie prime, attrezzature, certificazioni, personale specializzato e adempimenti ambientali. I continui aumenti dei costi energetici e logistici, insieme ai ritardi nei pagamenti di clienti o distributori, possono compromettere la liquidità aziendale. A ciò si aggiungono le difficoltà nel reperire credito bancario e la pressione fiscale e contributiva che grava sulle piccole e medie imprese. Molti imprenditori, per mantenere la produzione e onorare gli ordini, rinviano il pagamento delle imposte e dei contributi, accumulando interessi e sanzioni che aggravano ulteriormente la situazione.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Quando le tasse o i contributi non vengono versati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono attivare procedure di recupero forzato. Tra queste figurano la notifica di cartelle esattoriali, i pignoramenti dei conti correnti, i fermi amministrativi sui veicoli aziendali, le ipoteche sugli immobili e i sequestri dei crediti verso clienti o distributori. Gli importi aumentano rapidamente per effetto di sanzioni e interessi, mettendo in seria difficoltà la continuità dell’attività. Se l’impresa è una ditta individuale o una società di persone, l’imprenditore o i soci rispondono personalmente dei debiti, mettendo a rischio anche il patrimonio familiare.
Cosa fare subito se la tua azienda ha debiti
Il primo passo è conoscere nel dettaglio la tua posizione debitoria. Richiedi l’estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare l’entità del debito, gli anni di riferimento e gli enti coinvolti. Poi verifica la validità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica, importi prescritti o somme non dovute che un avvocato può contestare. Se i debiti sono corretti, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le azioni esecutive. È utile anche controllare se è disponibile una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o ipoteche, puoi ottenere la sospensione immediata presentando un ricorso o un’istanza di autotutela.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Quando il debito diventa insostenibile o l’impresa non riesce più a sostenere le spese di produzione, è possibile ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È una procedura legale rivolta a piccole e medie imprese che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residui (esdebitazione). È una soluzione riconosciuta dai tribunali italiani e rappresenta una possibilità concreta per risanare l’azienda o chiuderla in modo ordinato, senza trascinarsi dietro le pendenze fiscali o bancarie.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molte aziende del settore chimico e dei detergenti hanno debiti con banche, finanziarie o fornitori di materie prime, imballaggi e macchinari. In questi casi puoi chiedere la rinegoziazione dei finanziamenti, la sospensione temporanea delle rate o proporre un saldo e stralcio per chiudere la posizione a importo ridotto. È anche possibile contestare clausole abusive o tassi usurari nei contratti di credito e impugnare decreti ingiuntivi o pignoramenti entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nella trattativa con banche e fornitori, proteggendo la produzione e i beni aziendali indispensabili per l’attività.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Con una strategia legale tempestiva e ben strutturata puoi sospendere pignoramenti e procedure di riscossione, ottenere la rateizzazione o la cancellazione dei debiti, proteggere i macchinari e i beni aziendali, evitare la chiusura dell’attività e ripartire con un piano finanziario sostenibile. In molti casi è possibile salvare l’azienda, mantenendo i rapporti con i clienti e ricostruendo la stabilità economica.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto cartelle, intimazioni di pagamento o pignoramenti, se i debiti fiscali o bancari sono diventati ingestibili o se rischi la chiusura dell’attività. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa può bloccare la riscossione, contestare gli atti illegittimi e accompagnarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire subito è essenziale per proteggere la tua azienda, i tuoi beni e i posti di lavoro dei dipendenti.
⚠️ Attenzione: ignorare cartelle o avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, blocchi dei conti e sospensione dell’attività produttiva. Intervenire subito è l’unico modo per salvare la tua impresa e difendere il tuo patrimonio.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle imprese manifatturiere – spiega cosa fare se gestisci un’impresa di fabbricazione di prodotti chimici e detergenti con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che stanno mettendo a rischio la tua azienda chimica o di detergenti?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Un’impresa di produzione di prodotti chimici e detergenti in difficoltà finanziaria si trova ad affrontare una serie di problemi complessi: debiti verso fornitori di materie prime, esposizioni bancarie, scadenze fiscali e contributive non onorate, ecc. Questo settore, in particolare, può presentare ulteriori criticità legate a obblighi ambientali e di sicurezza – ad esempio la gestione di sostanze chimiche pericolose e rifiuti industriali – che non vengono meno nemmeno in caso di crisi o insolvenza. La legge ambientale italiana prevede infatti che, se un’azienda fallisce lasciando un sito inquinato, l’obbligo di bonifica ricade comunque sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa dei creditori . Ciò significa che, anche in stato di dissesto, l’impresa (o chi ne gestisce il patrimonio in procedura concorsuale) deve farsi carico di mettere in sicurezza e ripristinare eventuali danni ambientali, con possibili ripercussioni sul piano economico della crisi.
In questo contesto, “cosa fare e come difendersi” dal punto di vista di un imprenditore debitore significa attivarsi tempestivamente per gestire la crisi d’impresa, sfruttando gli strumenti offerti dall’ordinamento per risanare l’azienda o, se il salvataggio non è possibile, limitare i danni e le responsabilità personali. Negli ultimi anni la normativa italiana in materia di crisi e insolvenza è stata completamente rinnovata con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto dal D.Lgs. 14/2019 . Questo nuovo Codice ha sostituito integralmente la vecchia Legge Fallimentare del 1942, segnando il passaggio da un’impostazione focalizzata principalmente sulla liquidazione (fallimento) ad un sistema che privilegia l’emersione precoce della crisi e il risanamento aziendale ove possibile . L’entrata in vigore del Codice, inizialmente prevista per il 2020, è slittata al 15 luglio 2022 per effetto della pandemia e per recepire la Direttiva UE 2019/1023 sull’insolvency . Contestualmente, sono state apportate numerose modifiche correttive per adeguare la disciplina ai princìpi europei e alle mutate esigenze economiche . In particolare, tre decreti correttivi hanno affinato la normativa: il D.Lgs. 83/2022 (cosiddetto correttivo-bis, attuativo della direttiva europea) ha introdotto nuovi strumenti di regolazione della crisi e rafforzato quelli esistenti, mentre il più recente D.Lgs. 136/2024 (pubblicato a settembre 2024, detto correttivo-ter) ha ulteriormente modificato in modo sostanziale il Codice, risolvendo dubbi applicativi emersi nella prima fase e introducendo novità attese dagli operatori . Questa guida è aggiornata a settembre 2025, tenendo conto delle ultime riforme legislative e delle pronunce giurisprudenziali più autorevoli.
L’obiettivo del nuovo CCII è chiaro: prevenire la crisi d’impresa e favorire il risanamento quando possibile, anziché arrivare tardi alla sola soluzione liquidatoria. I princìpi ispiratori includono: (a) la tempestiva emersione delle difficoltà attraverso meccanismi di allerta e incentivi all’attivazione volontaria dell’imprenditore; (b) la valorizzazione dell’autonomia privata nelle soluzioni negoziali della crisi, con procedure meno invasive da parte dell’autorità giudiziaria; (c) la tutela della continuità aziendale come valore da preservare ove l’impresa sia risanabile, così da salvaguardare posti di lavoro e il valore economico prodotto . In sintesi, il legislatore ha cercato di costruire un sistema in cui l’insolvenza non venga gestita soltanto a posteriori (ossia con il fallimento – ora denominato liquidazione giudiziale), ma anche a priori tramite una serie di strumenti preventivi e negoziali atti ad evitare gli esiti distruttivi e massimizzare la soddisfazione dei creditori .
Questa guida, dal taglio tecnico-giuridico ma con linguaggio quanto più possibile chiaro e divulgativo, è rivolta sia agli imprenditori e ai loro consulenti (commercialisti, avvocati), sia ai privati cittadini eventualmente coinvolti come soci o garanti dell’impresa indebitata. Adottiamo il punto di vista del debitore: analizzeremo le soluzioni legali a disposizione di un’impresa in crisi per difendersi dalle azioni dei creditori, ristrutturare i debiti ed evitare, ove possibile, la fine dell’attività. Per ogni strumento previsto dalla normativa – dagli accordi stragiudiziali “di fatto” ai piani attestati di risanamento, dagli accordi di ristrutturazione dei debiti alle nuove procedure di composizione negoziata, fino ai concordati preventivi (anche nelle varianti più recenti, come il concordato semplificato) e all’eventuale liquidazione giudiziale finale – vedremo i presupposti, le finalità, i vantaggi e svantaggi pratici, nonché gli obblighi e responsabilità che gravano sull’imprenditore e sugli altri soggetti coinvolti (organi sociali, creditori, garanti, organi di controllo) . Troverete inoltre esempi concreti, casi pratici simulati, tabelle riepilogative e una sezione di domande e risposte frequenti, per facilitare la comprensione operativa di temi così complessi. Le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti utilizzate sono elencate in fondo alla guida, così da consentire ulteriori approfondimenti autorevoli.
Prima di entrare nel dettaglio dei singoli strumenti, è opportuno chiarire alcuni concetti generali introdotti dal Codice della Crisi: cosa si intende oggi per “stato di crisi” e “stato di insolvenza”, quali sono i doveri legali degli amministratori e dei soci nella fase di difficoltà economica e quali novità ha portato la riforma in termini di ruolo proattivo dell’imprenditore nella gestione della propria crisi.
Stato di crisi vs insolvenza: il CCII distingue chiaramente i due termini. Per crisi d’impresa si intende una situazione di difficoltà economico-finanziaria reversibile, in cui l’azienda presenta segnali di squilibrio patrimoniale o di liquidità che rendono probabile l’insolvenza futura se non si interviene . In altre parole, la crisi è uno stadio anticipatorio dell’insolvenza: l’impresa magari paga ancora i propri debiti alle scadenze presenti, ma “lancia dei campanelli d’allarme” – perdite di esercizio significative, flussi di cassa negativi, erosione del patrimonio netto oltre certi limiti, ecc. – che non devono essere ignorati. L’insolvenza invece è lo stadio conclamato e irreversibile in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con i mezzi ordinari (tipicamente, perché c’è carenza cronica di liquidità e il patrimonio non basta a far fronte ai debiti) . Per legge, l’insolvenza di per sé legittima l’apertura di una procedura concorsuale giudiziale (liquidazione), mentre lo stato di crisi iniziale consente di accedere a strumenti di allerta e composizione assistita per evitare di arrivare al punto di non ritorno.
Doveri di gestione prudenti: già prima della riforma, gli amministratori di società avevano l’obbligo di monitorare la situazione finanziaria dell’ente e, in caso di perdite rilevanti, di adottare provvedimenti (ricapitalizzazione o messa in liquidazione) secondo il Codice Civile. Il nuovo Codice della Crisi ha rafforzato questi obblighi: ha modificato l’art. 2086 c.c. imponendo a tutti gli imprenditori societari o collettivi di dotarsi di “assetti organizzativi adeguati” per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi per la sua soluzione. In pratica, l’azienda deve tenere sotto controllo indicatori di liquidità, sostenibilità dei debiti e continuità aziendale; se emergono segnali d’allarme (ad esempio indici di bilancio in deterioramento, o esposizioni verso il fisco e fornitori oltre certi limiti), gli amministratori devono attivarsi senza indugio, pena incorrere in responsabilità per gestione negligente. Su questi profili torneremo più avanti quando tratteremo le responsabilità dell’imprenditore e dei soci.
Nei capitoli successivi esamineremo uno ad uno i vari strumenti a disposizione di un’impresa indebitata per affrontare la crisi, partendo da quelli stragiudiziali (ovvero utilizzabili fuori dalle aule di tribunale, su base volontaria e negoziale) fino a quelli giudiziali (ossia le procedure concorsuali vere e proprie, attivate con l’intervento del tribunale). Anticipiamo qui l’elenco delle opzioni che verranno approfondite:
- Accordi stragiudiziali semplici (accordi privatistici con i creditori senza omologazione).
- Piani attestati di risanamento (accordi privati basati su un piano asseverato da un professionista indipendente, con effetti protettivi in caso di successivo fallimento).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (accordi con una maggioranza qualificata di creditori, omologati dal tribunale, con effetti di esenzione da revocatoria e possibili estensioni ai dissenzienti).
- Composizione negoziata della crisi (procedura innovativa e stragiudiziale, introdotta nel 2021, in cui un esperto indipendente affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori per trovare una soluzione concordata, beneficiando all’occorrenza di misure protettive temporanee).
- Concordato preventivo (procedura concorsuale tradizionale in cui l’azienda propone ai creditori un piano – di ristrutturazione con continuità aziendale o di liquidazione del patrimonio – da votare sotto supervisione del tribunale).
- Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio (nuova variante concorsuale, riservata ai casi in cui la composizione negoziata sia fallita: consente di liquidare i beni sotto controllo del tribunale, senza voto dei creditori).
- Liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento: procedura di liquidazione totale dell’impresa insolvente, avviata dal tribunale, con spossessamento dell’imprenditore e nomina di un curatore).
Per ciascuno di questi strumenti vedremo cosa comporta per l’imprenditore di un’impresa produttrice di detergenti e prodotti chimici in crisi, come attivarli, quali effetti producono (anche sui debiti tributari e verso i lavoratori) e come difendersi da iniziative aggressive dei creditori durante il percorso. Dedicheremo infine un focus alle responsabilità legali in capo all’imprenditore, agli amministratori e agli eventuali soci, e a come tutelarsi da azioni di responsabilità o, peggio, da conseguenze penali. Procediamo dunque con l’analisi degli strumenti disponibili, iniziando dalle soluzioni di natura stragiudiziale e negoziale.
Soluzioni stragiudiziali: accordi privati e piani di risanamento
Il primo percorso da valutare, per un’azienda indebitata ma ancora viva, è quello delle soluzioni stragiudiziali, ovvero accordi e strategie di risanamento fuori dal contesto formale di una procedura concorsuale. Queste soluzioni presentano il grande vantaggio di evitare la pubblicità e la rigidità di un processo davanti al tribunale, mantenendo la gestione in mano all’imprenditore. Di contro, richiedono un elevato grado di consenso da parte dei creditori chiave e, talora, sacrifici personali da parte dei soci o garanti (ad esempio immissione di nuova finanza o concessione di garanzie aggiuntive) per convincere i creditori ad accettare la ristrutturazione del debito. Vediamo le principali opzioni in questa categoria, in ordine crescente di formalità.
Accordi stragiudiziali informali (piani “di fatto” e moratorie)
Spesso la prima via tentata dall’imprenditore in difficoltà è negoziare direttamente con i propri creditori, al di fuori di qualsiasi procedura codificata. In pratica si tratta di raggiungere accordi individuali o plurilaterali con i creditori – ad esempio con le banche finanziatrici, con i fornitori strategici, con il fisco – per rimodulare il debito. Le forme che può assumere un accordo stragiudiziale sono varie: una dilazione nei pagamenti (rateizzazioni extra piano), una moratoria sugli interessi, un concordato “saldo e stralcio” (cioè l’accordo di accettare un pagamento parziale a fronte di stralciare il resto del credito), oppure un misto di queste soluzioni. L’accordo può essere formalizzato per iscritto (spesso tramite scritture private come i “piani di rientro” sottoscritti dalle banche) oppure restare su base di impegni verbali, sebbene quest’ultima ipotesi sia sconsigliabile.
Vantaggi: Questi accordi sono rapidi, flessibili e riservati. Non richiedono alcuna comunicazione al tribunale o iscrizione nei pubblici registri, quindi l’azienda evita lo stigma di una procedura concorsuale aperta. In un settore come quello chimico, mantenere la fiducia di fornitori e clienti è fondamentale: un accordo privato non pubblicizzato può consentire all’impresa di continuare a operare senza allarmare il mercato. Inoltre, l’imprenditore mantiene il pieno controllo della sua azienda durante le trattative, senza l’affiancamento di organi esterni. C’è ampia libertà contrattuale: ciascun creditore può accordare condizioni diverse (ad esempio un fornitore strategico potrebbe accettare di allungare le scadenze pur di non perdere il cliente, mentre la banca potrebbe essere disposta a convertire parte dell’esposizione a breve in un finanziamento a medio termine).
Svantaggi e limiti: Di contro, un accordo stragiudiziale non vincola i creditori dissenzienti o estranei. Ciò significa che basta un creditore “fuori dal coro” – magari un fornitore che non intende attendere oltre, o l’Agenzia delle Entrate che avvia un pignoramento – per mandare all’aria l’intera operazione. Non esistono, in questa fase, automatic stay o blocchi delle azioni esecutive: un creditore che non partecipa all’accordo può continuare a pretendere il pagamento integrale e attivare procedure di recupero crediti (ingiunzioni, pignoramenti) contro l’azienda. Un ulteriore limite è l’assenza di effetti “protettivi” di lungo termine: se anche l’impresa adempie puntualmente al piano di rientro concordato, ma poi dopo qualche anno finisce comunque in fallimento, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo stragiudiziale non omologato potrebbero essere contestati dai futuri organi concorsuali. Ad esempio, un creditore che ha accettato un pagamento parziale fuori dalle procedure formali potrebbe vedersi accusare di aver ricevuto un pagamento preferenziale pre-fallimentare (con i rischi della revocatoria). Per questi motivi, gli accordi stragiudiziali “puri” sono consigliabili solo in situazioni relativamente semplici e gestibili, ad esempio quando i creditori sono pochi e tutti cooperativi, e la crisi non è troppo profonda. In caso contrario, conviene passare a strumenti più strutturati che offrano maggiori garanzie legali.
(Nota: la legge non prevede un particolare regime agevolato per i meri accordi privati, ma è bene ricordare che alcuni provvedimenti normativi temporanei – come i vari decreti “salva imprese” emanati durante la pandemia – hanno introdotto moratorie generalizzate per certi debiti, ad esempio la possibilità di sospendere mutui o leasing. Tali misure però sono straordinarie e non sostituiscono la necessità di trovare un accordo con i creditori.)*
Suggerimento pratico: Prima di sedersi al tavolo con i creditori, l’imprenditore dovrebbe predisporre con l’aiuto di un consulente un mini-piano finanziario che mostri come intende ripagare i debiti ristrutturati e con quali tempi. Essere proattivi e presentare ai creditori una bozza di piano di rientro credibile aumenta le chance di successo. Inoltre, è prudente inserire negli accordi stragiudiziali clausole di standstill (impegno dei creditori a non intraprendere azioni esecutive per un certo periodo) e di adesione collettiva (l’accordo vale solo se vi aderiscono almeno i principali creditori): in questo modo l’imprenditore si tutela dal rischio che uno solo dei creditori “tradisca” l’intesa mettendo in pericolo l’intera operazione.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Quando la situazione è più complessa – ad esempio l’azienda ha debiti significativi con diverse banche e fornitori – e soprattutto quando si vuole ottenere una protezione legale più forte per le operazioni di risanamento, diventa utile ricorrere al piano attestato di risanamento disciplinato dall’art. 56 del Codice della Crisi (che ricalca la vecchia figura prevista dall’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.). Il piano attestato è, in sostanza, un accordo privato di ristrutturazione dei debiti supportato però da un documento formale – il piano di risanamento vero e proprio – che viene asseverato da un professionista indipendente riguardo alla sua veridicità e fattibilità. Questo tipo di operazione resta fuori dal tribunale (non è prevista omologa o approvazione giudiziaria), ma offre comunque al debitore un “ombrello” protettivo in caso di successivo fallimento, poiché gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato idoneo e corretto sono esentati dall’azione revocatoria fallimentare . In altri termini, se l’imprenditore paga dei creditori o concede garanzie seguendo un piano attestato ben fatto e l’azienda purtroppo fallisce lo stesso in seguito, il curatore fallimentare non potrà far annullare quei pagamenti o garanzie come avrebbe potuto fare in assenza di piano (salvo casi di frode). Ciò fornisce ai creditori aderenti maggiore tranquillità nel concedere dilazioni o stralci, e al debitore la serenità di poter tentare il risanamento senza paura che, se andasse male, gli sforzi fatti vengano azzerati da una revocatoria.
Elementi chiave: Il fulcro del piano attestato è il documento di piano e la relazione dell’attestatore indipendente. L’imprenditore, con l’ausilio dei suoi advisor finanziari, deve preparare un piano dettagliato in cui analizza le cause della crisi, la situazione debitoria e soprattutto le strategie di risanamento proposte (es. ricapitalizzazione da parte dei soci, vendita di rami d’azienda non strategici, rinegoziazione dei debiti bancari, nuove linee di credito, riduzione dei costi operativi, ecc.). Il piano deve dimostrare che, una volta attuate queste misure, l’impresa tornerà in equilibrio e sarà in grado di sostenere i debiti residui. Su questo documento interviene un professionista indipendente (di regola un commercialista o revisore esperto in ristrutturazioni, scelto dall’azienda) il quale redige una relazione di attestazione in cui dichiara: (1) che i dati aziendali posti a base del piano sono veri e attendibili; (2) che il piano è fattibile e idoneo a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa entro un tempo ragionevole . L’attestatore deve essere indipendente e imparziale (nessun conflitto di interessi col debitore o i creditori) e assume una responsabilità significativa: se attesta il falso o omette controlli dovuti, può risponderne civilmente e penalmente. La Cassazione ha più volte ricordato che il giudice, chiamato a valutare ex post la correttezza di un piano attestato ai fini della protezione anti-revocatoria, deve verificare che il piano non fosse “manifestamente inetto” al risanamento e che l’attestazione fosse completa e seria . In una pronuncia del 2023, ad esempio, la Suprema Corte ha ribadito che la semplice presenza formale di un piano e di una relazione non basta: occorre che ex ante quel piano fosse ragionevolmente idoneo a risanare l’impresa, altrimenti gli atti eseguiti andranno comunque considerati anormali e revocabili . Insomma, il piano attestato è uno strumento potente, ma richiede estrema professionalità e buona fede nella sua predisposizione.
Procedura: Non essendo prevista omologazione, il piano attestato non “parte” formalmente in una data specifica come accade per un concordato. Tipicamente, però, l’iter è il seguente: l’imprenditore incarica l’attestatore e nel frattempo negozia con i creditori chiave i contenuti del piano (es: la banca A accetta di allungare i mutui di 5 anni, il fornitore B accetta un pagamento parziale del 50% del suo credito, ecc.). Una volta ottenuto il consenso informale dei principali creditori e predisposto il piano scritto, l’attestatore elabora la relazione finale. A questo punto i creditori aderenti sottoscrivono l’accordo di ristrutturazione (che può consistere in uno o più contratti bilaterali o un unico documento plurilaterale) e si dà esecuzione al piano. Non è richiesta alcuna pubblicazione ufficiale; tuttavia, a fini probatori, di solito si dà data certa sia al piano sia alla relazione (ad esempio con autentica notarile delle firme) e spesso l’attestatore richiede che l’accordo venga almeno depositato presso un notaio o “auto-pubblicato” nel Registro delle Imprese per usufruire appieno delle esenzioni di legge.
Vantaggi: Rispetto al mero accordo stragiudiziale, il piano attestato offre maggiori garanzie legali. Come detto, gli atti esecutivi del piano (pagamenti, garanzie concesse, ecc.) non potranno essere revocati in un successivo fallimento, il che incentiva i creditori a partecipare senza timore di dover restituire tutto se la cosa va male . Inoltre, pur non essendoci una “protezione generalizzata” verso i creditori estranei, in alcuni casi si può ottenere un effetto simile: poiché l’azienda, grazie al piano, torna solvibile e paga regolarmente i creditori rimasti fuori, questi ultimi non avranno motivo o titolo per agire esecutivamente. La procedura è rapida e confidenziale, e non richiede la maggioranza dei creditori: si può fare un piano attestato coinvolgendo anche solo alcuni creditori (quelli necessari a sistemare la situazione) e continuare a pagare normalmente gli altri. Ad esempio, se l’impresa di detergenti ha principalmente un problema con le banche, potrà fare un piano attestato focalizzato sulla ristrutturazione dei debiti bancari, mentre i fornitori commerciali verranno pagati a scadenza normale per non destabilizzare l’attività. Ciò rende lo strumento molto flessibile. Anche i costi sono inferiori a quelli di una procedura giudiziale: si paga il compenso dell’attestatore e dei consulenti, ma non ci sono spese di giustizia né organi della procedura da mantenere.
Svantaggi: Il rovescio della medaglia è che il piano attestato non “blinda” l’azienda da iniziative individuali dei creditori non aderenti. Se c’è un creditore che resta fuori e decide comunque di procedere con un pignoramento o un’istanza di fallimento, il debitore non ha, in sede di piano attestato, uno scudo automatico (mentre in concordato o accordo omologato sì, come vedremo). Per ovviare in parte a ciò, la legge prevede la possibilità di depositare il piano attestato presso il registro delle imprese: questo non ne comporta l’omologazione, ma serve a dare pubblicità e opponibilità ai terzi del piano stesso e può, in certi casi, scoraggiare azioni esecutive (una banca che sappia dell’esistenza di un serio piano di risanamento attestato potrebbe essere più incline ad aspettare che affrettarsi a fare causa). Un altro limite è che tutta l’operazione si regge sul buon esito del piano: non c’è un tribunale che “chiude” la procedura. Se dopo l’attuazione del piano l’azienda purtroppo ricade in difficoltà, ci si può trovare punto e a capo (sebbene i creditori avranno comunque beneficiato di quanto incassato). In sintesi, il piano attestato funziona bene per crisi in cui la ripresa è concreta e credibile, con l’apporto magari di nuovi capitali o con un mercato che torna a tirare; se la crisi è strutturale e il piano rischia di fallire, forse conviene optare direttamente per strumenti più incisivi o per una procedura concorsuale ordinaria.
Caso pratico 1: “Alfa S.r.l.” produce detergenti industriali e ha accumulato 2 milioni di debiti, soprattutto verso banche e alcuni fornitori chimici, a causa di un calo di vendite e investimenti errati. I soci però credono nella ripresa grazie a un nuovo brevetto “verde” per detergenti ecologici. Con l’aiuto di un advisor finanziario, Alfa S.r.l. elabora un piano triennale: i soci versano €500.000 di nuovi capitali freschi, la Banca X proroga i mutui di 5 anni riducendo il tasso d’interesse, la Banca Y converte metà del suo credito in una partecipazione al capitale sociale (diventando socia di minoranza), i fornitori principali accettano di tagliare del 20% i loro crediti e di essere pagati in 12 mesi. Il piano finanziario prevede che, con il nuovo prodotto ecologico, il fatturato tornerà a crescere e permetterà di sostenere i debiti ristrutturati. Un commercialista indipendente viene incaricato di attestare il piano: verifica i bilanci, i contratti e i forecast di vendita di Alfa S.r.l., e conclude che i dati sono veritieri e le proiezioni ragionevoli (pur con qualche rischio legato al lancio del nuovo prodotto). L’attestatore firma dunque la relazione positiva. Alfa S.r.l. deposita il piano e la relazione dall’attestatore presso un notaio, quindi tutti i creditori aderenti sottoscrivono l’accordo di ristrutturazione allegato al piano. Nei mesi seguenti, l’azienda esegue fedelmente il piano: i nuovi capitali arrivano, le banche allungano i finanziamenti e ottengono le prime rate, i fornitori vengono pagati secondo gli accordi. Dopo 6 mesi, Alfa S.r.l. torna in attivo grazie alle vendite del nuovo prodotto. La crisi è superata e nessun creditore residuale ha intrapreso azioni esecutive nel frattempo.
Caso pratico 2: “Beta S.p.A.” è una società chimica più grande, indebitata per 10 milioni con vari istituti di credito e obbligazionisti. I ricavi sono in calo da anni per via di cambiamenti normativi che penalizzano alcuni suoi prodotti. Beta elabora un piano attestato simile al caso precedente, ma qui il mercato non dà segnali di ripresa e i risparmi di costi previsti dal piano non si realizzano del tutto. Dopo due anni, Beta S.p.A. si trova ancora in difficoltà e un creditore non aderente (un fondo obbligazionario che non aveva accettato l’offerta) presenta istanza di fallimento. Il tribunale dichiara il fallimento di Beta. Tuttavia, grazie al piano attestato, i pagamenti fatti e le garanzie date a banche e fornitori durante il piano non possono essere revocati dal curatore. Inoltre, Beta S.p.A. avendo agito in buona fede tentando il risanamento, può chiedere di essere ammessa all’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) trascorso il periodo di liquidazione. Resta comunque la delusione per il fallimento non evitato: col senno di poi, forse Beta avrebbe dovuto adottare misure più drastiche oppure ricorrere per tempo a una procedura concorsuale con coinvolgimento di tutti i creditori.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) – art. 57 CCII e ss.
Quando i debiti sono troppo elevati o diffusi perché un semplice piano privatistico possa funzionare, l’ordinamento prevede un strumento ibrido a metà strada tra l’accordo privato e il concordato preventivo: l’accordo di ristrutturazione dei debiti, spesso abbreviato in ARD. Introdotto originariamente come art. 182-bis L.F. e ora disciplinato dagli artt. 57-64 CCII, l’accordo di ristrutturazione è un accordo contrattuale tra l’imprenditore e una parte significativa dei suoi creditori (almeno il 60% dei crediti in valore) finalizzato a ristrutturare l’esposizione debitoria e superare la crisi . La sua peculiarità è che, pur essendo fondato sul consenso dei creditori, viene sottoposto all’omologazione del tribunale: ciò conferisce all’accordo efficacia legale vincolante e alcuni effetti protettivi tipici delle procedure concorsuali. In pratica, l’imprenditore elabora un piano di risanamento (anche qui di solito con l’ausilio di un attestatore che ne verifica la fattibilità), raccoglie le adesioni formali di almeno il 60% dei creditori (calcolati sul totale dei crediti) e poi chiede al tribunale l’omologa dell’accordo. Il tribunale, verificati i requisiti (percentuale di adesioni, fattibilità del piano, corretto trattamento dei creditori, ecc.), omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes secondo il suo contenuto .
Effetti principali: I creditori che hanno aderito sono ovviamente vincolati alle nuove condizioni pattuite (dilazioni, stralci, ecc.). I creditori non aderenti, invece, per impostazione generale restano estranei: il principio è che l’accordo vincola solo chi l’ha firmato, mentre chi non ha dato consenso conserva i suoi diritti per intero . Ciò significa che il debitore dovrà comunque pagare integralmente i dissenzienti alle loro scadenze originarie, salvo trovarsi un diverso accordo individuale. Proprio per questo, in sede di strutturazione di un ARD, di solito l’azienda cerca di “selezionare” i creditori da includere: spesso si coinvolgono i grandi creditori finanziari (banche, obbligazionisti) e magari alcuni fornitori maggiori, mentre si lasciano fuori i piccoli fornitori o altri creditori minori pagandoli regolarmente (in modo che non abbiano nulla da obiettare) . Il Codice della Crisi, però, prevede anche delle eccezioni alla regola suindicata, tramite le cosiddette “estensioni degli effetti” o accordi ad efficacia estesa. Ad esempio, se l’accordo riguarda i debiti finanziari e ha ottenuto l’adesione di almeno il 75% dei creditori finanziari di quella categoria, il debitore può chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche ai finanziatori dissenzienti rimasti (purché siano stati informati e abbiano possibilità di adesione alle medesime condizioni) . Questa regola, ereditata dall’art. 182-septies L.F., evita che poche banche dissenzienti facciano fallire una ristrutturazione approvata dalla maggioranza: il tribunale, su richiesta, impone l’accordo anche al 25% contrario, a condizione che non ricevano un trattamento deteriore rispetto a quello dei colleghi aderenti. Analogamente, è prevista la possibilità di estendere l’accordo ai creditori erariali o previdenziali dissenzienti (Agenzia Entrate, INPS), se all’accordo ha aderito la maggioranza di essi e la proposta che era stata fatta a tali enti era conveniente e conforme alla legge . Questa è una sorta di “cram-down” fiscale: in pratica, se la maggior parte dei creditori approva il piano e il Fisco è l’unico che si oppone irragionevolmente, il tribunale può omologare comunque l’accordo anche senza il voto favorevole del Fisco, purché il trattamento dei crediti tributari nel piano rispetti le soglie minime di legge (ad esempio pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute per legge, oppure il massimo realizzo possibile) . Va sottolineato che queste estensioni operano solo in specifiche categorie e condizioni; la regola generale resta che i creditori estranei non sono toccati dall’accordo.
L’omologazione da parte del tribunale comporta inoltre altri benefici importanti: – Innanzitutto, già dal momento del deposito dell’accordo per l’omologa, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive analoghe a quelle del concordato preventivo: in pratica un blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori durante le trattative e fino all’omologazione (di regola per 60 giorni, prorogabili) . Ciò impedisce ai creditori, aderenti o meno, di aggredire il patrimonio mentre si attende la formalizzazione dell’accordo, creando una zona franca temporanea per lavorare al risanamento senza l’assillo di pignoramenti.
– In secondo luogo, l’accordo omologato diventa un titolo esecutivo: significa che se un creditore aderente, dopo l’omologa, non rispetta i patti (es. la banca ha promesso nuovi fondi ma si tira indietro, oppure il debitore non paga una rata ristrutturata), la parte lesa può agire forzosamente invocando l’accordo stesso. Inoltre i creditori non possono revocare il loro consenso dopo l’omologa.
– Terzo, e molto rilevante, gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria fallimentare come per i piani attestati . Dunque, se pure l’impresa più avanti finisse in liquidazione giudiziale, i pagamenti fatti e le garanzie concesse durante l’accordo non potranno essere dichiarati nulli dal curatore (salvo eccezioni di legge per malafede). Allo stesso modo, eventuali nuovi finanziamenti ottenuti durante l’accordo – se autorizzati dal tribunale – sono protetti e prededucibili (cioè privilegiati) in caso di procedura successiva . Questa protezione giuridica aiuta molto a convincere banche e investitori a supportare il piano, sapendo di avere un “paracadute” qualora le cose vadano male.
Differenze rispetto al concordato preventivo: L’accordo di ristrutturazione, pur richiedendo un passaggio omologativo, è più snello del concordato. Non c’è un voto formale in assemblea di tutti i creditori: conta solo raccogliere le firme del 60%. Non c’è nemmeno un commissario giudiziale di default (può essere nominato un ausiliario dal giudice in caso di necessità, ma non è obbligatorio), e i costi di procedura sono minori. L’accordo è in gran parte negoziato in autonomia dall’imprenditore e i suoi creditori, e il giudice si limita a un controllo di legalità e fattibilità. Inoltre, nell’accordo si possono “stravolgere” le regole di prelazione con il consenso: ad esempio, una banca ipotecaria può volontariamente accettare un pagamento parziale e perdere parte della garanzia – cosa che in un concordato sarebbe possibile solo a certe condizioni – perché qui tutto si basa sul consenso negoziale dei coinvolti . D’altra parte, proprio la necessità di consenso iniziale è il lato debole: se i creditori sono molti e di categorie diverse, potrebbe essere difficile arrivare a quel 60% richiesto o convincere tutti i grandi player a firmare. In tal caso, il concordato (dove decide la maggioranza dei votanti per classi) potrebbe essere uno strumento più adatto.
Varianti introdotte dal CCII: La riforma ha arricchito gli ARD di alcune varianti (alcune già menzionate): – l’accordo di ristrutturazione “agevolato”: se il debitore ha già il consenso di almeno il 30% dei crediti, può chiedere al tribunale di applicare subito le misure protettive (il blocco dei creditori) mentre continua a trattare per raggiungere il 60% . Questo consente di “congelare” la situazione temporaneamente pur non avendo ancora il quorum completo, dando respiro all’azienda; è una novità introdotta per incentivare l’uso degli accordi.
– l’accordo ad efficacia estesa (già spiegato: vincolo per dissenzienti finanziari o erariali nelle condizioni di legge) ;
– la possibilità di coinvolgere un esperto facilitatore anche negli accordi (figura simile a quella della composizione negoziata, per assistere le trattative) , anche se in pratica questa possibilità confluisce nella composizione negoziata stessa quando si utilizza prima quella;
– l’esplicita previsione della “transazione fiscale” dentro l’accordo: il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di IVA, contributi e altre imposte e, se l’ente pubblico aderisce, l’accordo lo vincola come qualsiasi altro creditore. Se invece l’ente rifiuta ma l’accordo ha il placet degli altri creditori, come visto il tribunale può omologare lo stesso con cram-down fiscale .
In sintesi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono uno strumento potente per imprese che riescono a coinvolgere attivamente i propri creditori principali nel piano di risanamento, senza passare attraverso le formalità (e la pubblicità negativa) di un concordato preventivo . Hanno costi inferiori e lasciano maggiore libertà contrattuale. Tuttavia richiedono, di fatto, che già ex ante vi sia un sostegno molto ampio dei creditori: se il fronte dei creditori è frammentato o litigioso, potrebbe non essere praticabile. Sono particolarmente indicati quando la crisi è essenzialmente finanziaria (ad esempio troppi debiti bancari in rapporto all’EBITDA, ma l’azienda operativamente funziona) e si può trovare un accordo proprio con banche e obbligazionisti, magari lasciando indenni i fornitori e altri partner commerciali per non danneggiare la continuità aziendale .
(Esempio: un’impresa chimica con 10 milioni di debiti di cui 7 verso banche e 3 verso decine di fornitori può convenire un ARD con le banche – es. il 80% delle banche accetta di allungare e ridurre i crediti – e contestualmente pagare regolarmente i fornitori estranei con la liquidità liberata. In tal modo le banche dissenzienti (supponiamo il 20%) possono essere crammate in efficacia estesa se rispettano le condizioni, e i fornitori non subiscono alcun default perché sono stati tenuti fuori e soddisfatti normalmente .)*
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 e artt. 17-25 CCII)
Tra le innovazioni più rilevanti e recenti per la gestione anticipata della crisi c’è la composizione negoziata. Si tratta di una procedura volontaria, riservata e stragiudiziale introdotta in via d’urgenza nel 2021 (con il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021) e poi confluita nel Codice della Crisi agli artt. 17-25. La composizione negoziata è pensata per aiutare le aziende in difficoltà a negoziare con i creditori una soluzione sostenibile prima di dover ricorrere a procedure concorsuali più invasive. Non è un concorso tra creditori e non comporta spossessamento: l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria dell’impresa durante tutto il percorso . Ciò che cambia è che egli viene affiancato da un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma nazionale istituita presso le Camere di Commercio . Questo esperto (di norma un commercialista, avvocato o consulente aziendale con specifica formazione) ha il compito di facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori, aiutandoli a individuare soluzioni di ristrutturazione accettabili per entrambi.
Accesso: Può accedere alla composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, grande o piccolo, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (la “crisi”) tali da far presumere che l’azienda potrebbe diventare insolvente, ma per cui esistono ragionevoli prospettive di risanamento. L’accesso è volontario (solo l’imprenditore può attivarlo) e avviene tramite una domanda online sulla piattaforma dedicata (gestita da Unioncamere). Non vi sono più, dopo le riforme del 2022-2023, cause ostative assolute se non alcune situazioni di abuso: ad esempio l’imprenditore che abbia già fatto istanza di composizione e l’abbia fatta fallire senza cooperazione potrebbe vedersi negare un secondo tentativo immediato. In generale comunque lo strumento è aperto a tutte le imprese in difficoltà, anche agricole (tradizionalmente escluse dal fallimento) . Il correttivo del 2024 ha ulteriormente incentivato l’utilizzo dello strumento, chiarendo alcuni dubbi interpretativi e prevedendo misure promozionali, poiché nei primi due anni l’applicazione pratica era stata inferiore alle attese .
Fasi della procedura: Una volta presentata l’istanza, un’apposita commissione nomina l’esperto indipendente. L’esperto studia la situazione dell’azienda (tramite i dati caricati in piattaforma e colloqui con l’imprenditore) e convoca un primo incontro. Da quel momento parte un periodo (massimo 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 in casi eccezionali) durante il quale l’imprenditore e l’esperto portano avanti le trattative con i creditori. Tutto avviene in modo riservato: l’apertura della composizione negoziata non viene iscritta nel Registro Imprese (a meno che il debitore non richieda specifiche misure protettive, come vedremo). L’esperto svolge un ruolo mediatore, aiutando a formulare proposte, evidenziando ai creditori la convenienza di trovare un accordo rispetto allo scenario del fallimento, e redigendo con cadenza mensile delle relazioni sullo stato delle trattative.
Durante la composizione negoziata, l’imprenditore resta alla guida della sua attività, ma deve comportarsi con trasparenza e correttezza: è tenuto a aggiornare costantemente l’esperto e a non compiere atti di straordinaria amministrazione senza informarlo. Egli può anche compiere, con autorizzazione del tribunale, atti urgenti che siano necessari a continuare l’attività o a evitare pregiudizi ai creditori – ad esempio può essere autorizzato a contrarre un finanziamento prededucibile per avere liquidità (il cosiddetto finanziamento ponte).
Misure protettive e cautelari: Uno dei vantaggi principali della composizione negoziata è la possibilità, su richiesta del debitore, di ottenere dal tribunale un decreto che sospende o impedisce le azioni esecutive dei creditori durante le trattative (misure protettive). Questo scudo può riguardare tutti i creditori o alcuni di essi, e dura inizialmente fino a 4 mesi (prorogabili). Inoltre, il tribunale può adottare misure cautelari per preservare il patrimonio (ad esempio ordinare ai creditori di non modificare condizioni contrattuali essenziali, come mantenere forniture in essere). Queste misure vengono pubblicate nel Registro Imprese (dando notizia ai terzi che l’azienda è in composizione negoziata con protezione) . Durante la protezione, tutte le azioni esecutive individuali sono bloccate e non si possono acquisire nuove ipoteche sul patrimonio del debitore. Ciò equivale a un moratorium simile a quello del concordato preventivo, ma ottenuto in sede di composizione stragiudiziale. È fondamentale notare che tali misure non sono automatiche: vanno appunto chieste e il tribunale le concede se ritiene che vi sia una concreta possibilità di successo delle trattative e che la protezione non danneggi eccessivamente i creditori. Il correttivo-ter del 2024 ha delineato meglio i criteri per la concessione e conferma di queste misure, uniformando le prassi dei tribunali.
Esiti della composizione negoziata: Idealmente, al termine delle trattative viene raggiunto un accordo tra l’imprenditore e i creditori. Tale accordo non ha una forma predeterminata: può essere un contratto di ristrutturazione del debito firmato da tutti o la maggior parte dei creditori (sostanzialmente un accordo stragiudiziale “rafforzato”), oppure la presentazione di uno degli strumenti visti sopra: ad esempio le parti possono convenire un piano attestato di risanamento, oppure l’imprenditore può decidere di proporre un vero accordo di ristrutturazione omologato (60%) o addirittura un concordato preventivo. La composizione negoziata può quindi fungere da “trampolino” verso una procedura concorsuale concordataria formalizzata. In alternativa, se l’accordo trovato è sufficientemente onnicomprensivo, può restare a livello privato: si chiude la composizione negoziata e l’impresa esegue quanto convenuto (ad es. i creditori firmano tutti un accordo stragiudiziale di moratoria).
Ma cosa succede se le trattative falliscono? Il legislatore, conscio che non sempre si riuscirà a salvare l’azienda, ha introdotto nel 2021 un’innovativa via d’uscita: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). In caso di esito negativo della composizione negoziata, l’esperto indipendente redige una relazione finale attestando che non sono state trovate soluzioni per la continuità aziendale. A quel punto l’imprenditore, entro 60 giorni, può presentare al tribunale domanda di concordato semplificato, proponendo la liquidazione di tutti i beni ai creditori . Si tratta di una procedura concorsuale abbreviata e senza voto dei creditori: il tribunale, valutata la proposta, può omologarla se la ritiene più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (fallimento) . I creditori hanno solo diritto di fare osservazioni e opposizione, ma non votano. In sostanza, è un “piano B” per chi ha tentato la composizione: l’azienda viene liquidata sotto controllo del tribunale, però evitando i tempi lunghi di un fallimento e distribuendo il ricavato secondo le priorità di legge . Il concordato semplificato è riservato ai casi in cui l’esperto attesta che non c’erano percorribili soluzioni in continuità . Ad esempio, se la nostra impresa di detergenti non trova investitori né accordi e l’unica soluzione è vendere gli impianti e cessare l’attività, col semplificato potrà farlo rapidamente e chiudere i debiti residui, evitando il fallimento. Nel 2023-2024 sono già diversi i casi in Italia in cui si è percorso il concordato semplificato post-composizione . Ciò consente comunque al debitore onesto di chiudere la vicenda con una procedura più snella e con la possibilità, una volta liquidato tutto, di ottenere l’esdebitazione dei debiti rimasti insoddisfatti (come vedremo più avanti).
In sintesi, la composizione negoziata offre all’imprenditore in crisi un percorso guidato ma volontario per esplorare ogni chance di risanamento con l’aiuto di un esperto, beneficiando all’occorrenza di protezioni dalle azioni dei creditori, senza immediatamente attivare una procedura concorsuale ufficiale. È uno strumento ancora giovane, ma sulla cui efficacia il legislatore sta puntando molto, tanto da averlo reso centrale nel nuovo Codice. Dal punto di vista del debitore, rappresenta un’opportunità di giocare d’anticipo sulla crisi: cercare un accordo prima di precipitare nell’insolvenza conclamata. Bisogna però avere l’umiltà e la lucidità di attivarla per tempo: se ci si arriva con l’acqua alla gola (casse vuote, creditori già all’esecuzione), anche l’esperto avrà le mani legate. Inoltre, l’imprenditore deve essere disposto a una totale trasparenza: dovrà fornire all’esperto e ai creditori tutte le informazioni necessarie. Ogni tentativo di nascondere la reale situazione (magari per paura di perdere la “faccia”) è controproducente e può far naufragare la fiducia indispensabile per ottenere concessioni dai creditori.
Confronto tra composizione negoziata e strumenti tradizionali: vale la pena sottolineare alcune differenze chiave. A differenza del concordato preventivo, la composizione negoziata non è di per sé una procedura concorsuale: non comporta spossessamento né l’intervento autoritativo di un giudice su come ristrutturare i debiti. Tutto si basa sull’accordo volontario. I creditori non sono obbligati ad accettare nulla che non vogliano. Questo è un punto di forza (massima flessibilità) ma anche di debolezza: se uno o più creditori adottano un atteggiamento ostile e non si fanno convincere, la composizione da sola non può imporre loro un sacrificio . Negli strumenti concorsuali invece (concordato, ecc.) c’è la regola di maggioranza e il cram-down sulle classi dissenzienti: quindi si può arrivare a una soluzione anche senza l’unanimità. Per questo, molti osservatori dicono che la composizione negoziata funziona soprattutto con creditori razionali e organizzati (banche, grandi fornitori), mentre potrebbe essere meno efficace se i debiti sono frammentati tra tanti piccoli creditori magari non in grado di valutare la convenienza di un accordo rispetto a un fallimento. L’imprenditore deve quindi valutare, con i consulenti, la “sociologia” del proprio debito: se la maggior parte è verso banche o soggetti istituzionali, la composizione negoziata ha buone chance; se invece i creditori sono centinaia di piccoli, potrebbe convenire saltare direttamente a un concordato preventivo (dove sarà il giudice a decidere in caso di dissensi, una volta raccolto il voto delle maggioranze). In ogni caso, nulla vieta di provare la strada negoziata e, se non va, ripiegare poi su concordato preventivo o accordo ex art. 57 (anzi, il legislatore l’ha previsto espressamente come possibilità) . Importante: il periodo di composizione negoziata non aggrava le responsabilità dell’imprenditore, anzi viene considerato segno di diligenza. L’art. 23 CCII precisa che il tempo trascorso in composizione negoziata non viene conteggiato come “ritardo colpevole” in un eventuale fallimento successivo . Al contrario, aver tentato onestamente la composizione potrebbe giovare al debitore, ad esempio in sede di valutare la sua meritevolezza per la concessione dell’esdebitazione finale.
Passiamo ora ad esaminare le soluzioni concorsuali giudiziali, cioè quelle che comportano l’apertura di una procedura davanti al tribunale. Queste entrano in gioco o quando le soluzioni negoziali non siano praticabili, oppure quando per vari motivi risulta preferibile avere un intervento dell’autorità giudiziaria e un effetto vincolante verso tutti i creditori.
Procedure concorsuali giudiziali: concordato preventivo e liquidazione giudiziale
Le procedure concorsuali sono i procedimenti formali disciplinati dalla legge in cui la crisi o insolvenza dell’impresa viene gestita con l’intervento del tribunale, a tutela paritaria di tutti i creditori. Il Codice della Crisi ne contempla diverse tipologie, ma qui ci focalizzeremo sulle principali due che riguardano un’impresa commerciale come la nostra: il concordato preventivo (nelle sue varianti, incluso il concordato “semplificato” post-composizione negoziata) e la liquidazione giudiziale (che ha preso il posto del fallimento). Cenneremo anche al concordato minore e alla liquidazione controllata, procedure riservate alle piccole imprese non fallibili e ai debitori civili, per completezza, sebbene per un’impresa di detergenti di dimensioni medio-grandi queste ultime non siano applicabili.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è la tradizionale procedura concorsuale di ristrutturazione dei debiti che l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza può proporre ai creditori, sotto la supervisione e con l’approvazione del tribunale. Si chiama “preventivo” perché interviene prima (o in vece) del fallimento, come tentativo di sistemazione concordata della crisi. Nel concordato, a differenza delle soluzioni negoziali viste prima, vige la regola della maggioranza: i creditori vengono raggruppati in classi e hanno diritto di voto sul piano proposto, e se la maggioranza lo approva (secondo le soglie di legge) il concordato diventa vincolante anche per le minoranze dissenzienti. È quindi uno strumento più coercitivo (in senso tecnico) ma permette di superare situazioni in cui l’unanimità sarebbe irraggiungibile.
Tipologie di concordato: Il Codice distingue essenzialmente due grandi categorie: il concordato in continuità aziendale e il concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità l’impresa prosegue l’attività, utilizzando il concordato per ristrutturare i debiti e magari effettuare riorganizzazioni (cessione di rami d’azienda, intervento di nuovi investitori, ecc.), ma mantenendosi operativa. Può essere “diretta” (l’azienda continua in mano allo stesso debitore) oppure “indiretta” (ad esempio l’azienda viene affittata o venduta a un terzo che la prosegue, ma la continuità occupazionale e di business è garantita) – entrambe sono considerate continuità ai fini di legge. Nel concordato liquidatorio, invece, l’imprenditore propone di liquidare tutto il patrimonio e distribuire il ricavato ai creditori, chiudendo l’attività. Per evitare concordati meramente dilatori, la legge richiede che nel concordato liquidatorio ci sia un apporto di risorse esterne tali da aumentare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, oppure in ogni caso che ai chirografari venga garantito almeno il 20% di recupero sui loro crediti (questi parametri sono soggetti a modifiche: la riforma 2022 ha fissato il 20% come soglia minima, salvo casi particolari). Ci sono poi forme particolari come il concordato con riserva (deposito di una domanda “in bianco” per ottenere subito le protezioni e poi presentare il piano entro termini) e, come già menzionato, il concordato semplificato (che però è un caso speciale post-composizione negoziata, fuori dal voto dei creditori).
Fasi del concordato: in estrema sintesi: 1. L’imprenditore deposita una domanda di concordato in tribunale, completa di piano, proposta ai creditori e documentazione (bilanci, elenco creditori, relazione di un attestatore indipendente che certifica veridicità dei dati e fattibilità del piano). Può anche depositare una domanda incompleta (concordato in bianco) riservandosi di presentare il piano entro un termine fissato dal giudice. 2. Dalla data del deposito, l’azienda entra in una fase protetta: il tribunale emette un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e sospende le prescrizioni e decadenze (il classico “automatic stay” concorsuale) . Viene nominato un Commissario Giudiziale, figura terza che vigila sull’operato del debitore durante la procedura e redige una relazione per i creditori. L’imprenditore rimane amministratore dell’azienda, ma sotto osservazione: ogni atto di straordinaria amministrazione necessita di autorizzazione del tribunale, e il debitore non può pagare i debiti anteriori né aggravare la propria esposizione. 3. Il tribunale, esaminata la domanda, dichiara aperta la procedura di concordato se ritiene la proposta ammissibile. Si fissano quindi i termini per il voto. I creditori vengono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (ad es. classe banche, classe fornitori chirografari, classe subordinati, ecc.). Entro un certo termine, i creditori votano – oggi il voto può essere espresso anche per corrispondenza telematica o in adunanza – sull’accettazione della proposta di concordato. Per l’approvazione serve, in ogni classe, la maggioranza dei crediti ammessi al voto (e ulteriori regole se qualche classe boccia e altre approvano – il CCII consente un cram-down interclasse in certi casi, attuando la direttiva europea, ma semplifichiamo qui). 4. Se il concordato viene approvato dalle maggioranze richieste, il tribunale passa alla fase di omologazione: verifica la legalità e fattibilità del piano, e giudica eventuali opposizioni di creditori dissenzienti. Se tutto è regolare, omologa il concordato con decreto. Da quel momento la proposta concordataria diviene vincolante per tutti i creditori antecedenti (anche quelli che hanno votato contro). Se invece i creditori non approvano il piano, il concordato viene dichiarato non approvato e normalmente il tribunale contestualmente dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda.
5. Durante l’esecuzione del concordato omologato, l’imprenditore (o un liquidatore nominato, in caso di piano liquidatorio) attua le misure previste: paga le percentuali offerte ai creditori secondo i tempi del piano, eventualmente cede beni, effettua ristrutturazioni aziendali. A fine esecuzione, il tribunale dichiara chiuso il concordato. Se però l’impresa non rispetta gli impegni (inadempimento), i creditori possono chiederne la risoluzione e si aprirà la via del fallimento.
Vantaggi (dal lato del debitore): Il concordato preventivo permette di gestire la crisi con un effetto globale e vincolante: una volta omologato, costituisce la “legge” per tutti i creditori concorsuali, il che dà certezza di liberarsi dai debiti in eccesso secondo le percentuali promesse. Durante la procedura, l’azienda è protetta da azioni esecutive e precauzioni dei singoli creditori, potendo così operare e attuare eventuali ristrutturazioni. Inoltre, il concordato consente variazioni anche forzose dei diritti dei creditori: ad esempio si possono abbattere i crediti chirografari a una certa percentuale senza il consenso individuale di ciascuno, basta la maggioranza (cosa impossibile in sede puramente stragiudiziale). Il tribunale può anche, come detto, imporre il concordato ad alcune classi dissenzienti se ritiene che la proposta sia migliore per loro rispetto alla liquidazione, applicando meccanismi di cram-down previsti dalla legge (questa è una novità di recepimento della direttiva europea). In pratica, un buon piano concordatario offre al debitore la chance di ristrutturare pesantemente il debito salvando l’impresa, con l’accordo della maggioranza dei creditori. Per l’imprenditore onesto vi è anche il beneficio dell’esdebitazione a fine procedura: nelle società, l’esdebitazione riguarda i soci garanti o gli ex imprenditori personali; nelle imprese individuali coincide con la liberazione dai debiti insoddisfatti. Con il nuovo Codice, l’esdebitazione è divenuta quasi un diritto per il fallito che abbia collaborato, ottenibile dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione (nel concordato questo tema è meno rilevante perché l’obiettivo è evitare il fallimento stesso) .
Svantaggi: Il concordato è però una procedura complessa, costosa e pubblica. Richiede tempi non brevi (qualche mese per l’ammissione, poi alcuni mesi per il voto e l’omologa: in media 6-12 mesi se tutto fila liscio). I costi includono il compenso del commissario, le spese legali e dell’attestatore, e vari oneri di procedura. Inoltre, l’apertura del concordato è resa pubblica e può avere un impatto reputazionale: clienti e fornitori vengono a sapere che l’azienda è in concordato, con possibili ricadute commerciali (anche se oggi il concordato non è più visto come uno stigma assoluto, può comunque destabilizzare i rapporti contrattuali in corso). Durante la procedura la gestione dell’impresa è limitata e ogni mossa straordinaria richiede il via libera del giudice: questo può rallentare operazioni che magari sarebbero urgenti. Ancora, l’intervento del tribunale e le regole imperative significano meno flessibilità: ad esempio, nel concordato bisogna rispettare l’ordine delle cause di prelazione (non si può pagare meno di quanto spetterebbe legalmente a un creditore privilegiato senza il suo consenso o senza compensazioni offerte ad altri) – contrariamente a un accordo privato dove, se tutti son d’accordo, si può fare qualsiasi concessione atipica. Nel concordato ci sono anche soglie minime di soddisfazione: come detto, i chirografari in un liquidatorio devono avere almeno il 20% salvo apporti esterni; ciò vincola la libertà di proposta del debitore.
Concordato “semplificato”: Abbiamo già illustrato questa particolare versione riservata ai post-composizione negoziata . Vale la pena ribadire qui, come sottosezione del concordato preventivo, che il concordato semplificato per la liquidazione non prevede voto dei creditori: è il tribunale, a seguito di eventuale reclamo, che decide se omologarlo valutando la convenienza per i creditori rispetto al fallimento . I creditori possono opporsi ma non hanno potere deliberativo. Questo strumento è stato pensato per evitare che, dopo aver perso tempo nelle trattative, un’azienda senza prospettive di continuità debba comunque passare per un lungo concordato ordinario prima di liquidare: con il semplificato, in ~60-90 giorni si può ottenere un decreto di omologa e procedere con la vendita dei beni. Chiaramente, è meno garantista per i creditori (che subiscono la decisione senza voto) e perciò la legge lo limita ai casi in cui si è almeno tentato di trovare soluzioni alternative tramite composizione negoziata . Per il nostro imprenditore, il semplificato è l’ultima spiaggia onorevole: consente di evitare la dichiarazione di fallimento e chiudere la partita in modo relativamente più controllato.
Concordato “minore”: Una breve menzione va fatta per il concordato minore, disciplina prevista per i debitori non fallibili (piccole imprese sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli, professionisti, ecc.), che riprende l’istituto del vecchio “accordo del consumatore” o “concordato dei sovraindebitati” della L.3/2012. In sostanza è simile a un concordato preventivo ma semplificato in alcune regole (ad esempio, non c’è la percentuale minima del 20% per i chirografari) e gestito con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) anziché di un commissario giudiziale. Nel nostro caso, se l’impresa produttrice di detergenti fosse stata, poniamo, una ditta individuale sotto le soglie dimensionali di fallibilità, avrebbe potuto ricorrere al concordato minore invece che al preventivo ordinario. I meccanismi di voto e omologa sono analoghi, con la differenza che viene coinvolto l’OCC (un organismo apposito iscritto in registri pubblici, destinato ad assistere i piccoli debitori). Siccome la nostra trattazione è tarata su un’impresa commerciale fallibile, non approfondiremo oltre; basti sapere che il Codice oggi offre procedure ad hoc anche per i “piccoli”, evitando di lasciarli senza strumenti come avveniva un tempo.
Liquidazione giudiziale (ex “fallimento”)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale di carattere liquidatorio che interviene quando l’insolvenza dell’impresa è conclamata e non vi sono soluzioni idonee di risanamento. In pratica, è l’erede del vecchio fallimento. Viene aperta dal tribunale su ricorso del debitore stesso, di uno o più creditori, o su istanza del Pubblico Ministero (in casi particolari), qualora l’impresa si trovi in stato di insolvenza attuale. Per le società, può essere dichiarata anche dopo la cessazione dell’attività (entro un anno dalla cancellazione dal Registro Imprese).
Effetti dell’apertura: Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, l’imprenditore perde la gestione dei suoi beni: si verifica il cosiddetto spossessamento, per cui l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio passa al Curatore nominato dal tribunale . Viene nominato anche un Giudice Delegato alla procedura, che sovrintende agli atti di giustizia durante la liquidazione . Tutti i creditori anteriori alla data di apertura (detti concorsuali) devono far valere i propri crediti nell’ambito della procedura – presentando domanda di insinuazione al passivo – e non possono più agire individualmente: le eventuali cause esecutive pendenti vengono bloccate e nessun creditore può iniziarne di nuove . Questo automatic stay concorsuale garantisce la parità di trattamento tra i creditori. I debiti cessano di maturare interessi (salvo i privilegiati entro il limite di capienza della garanzia). Insomma, si fotografa la situazione patrimoniale e debitoria dell’impresa a quella data, e tutto viene gestito in modo collettivo nella procedura.
Svolgimento: Il Curatore, appena nominato, compie un inventario dei beni e predispone lo stato passivo, ossia l’elenco dei crediti ammessi e delle relative cause di prelazione, dopo aver esaminato le domande presentate dai creditori . Lo stato passivo è soggetto a verifica avanti al Giudice Delegato e possono esservi impugnazioni se alcuni crediti vengono esclusi o ridotti. Nel frattempo, se l’azienda aveva ancora un’attività, il curatore può valutare se esercitarla provvisoriamente per non deteriorare l’avviamento, oppure se cederla. In ogni caso, la finalità principale è liquidare i beni del debitore (vendere immobili, macchinari, riscuotere crediti, ecc.) trasformandoli in denaro. Il Codice della Crisi incoraggia soluzioni efficienti: ad esempio il curatore può cedere l’azienda in blocco o rami di essa, se ciò massimizza il ricavato (in un’impresa chimica, potrebbe vendere l’intero stabilimento con i macchinari a un concorrente interessato, piuttosto che rottamare tutto a pezzi). Una volta realizzato l’attivo, il curatore procede a ripartire il ricavato tra i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima si pagano le spese di procedura (prededucibili), poi i creditori privilegiati (ipotecari, pignoratizi, privilegi generali come dipendenti e fisco, ecc.) nell’ordine e nei limiti delle rispettive garanzie, e infine ciò che resta viene distribuito proporzionalmente ai creditori chirografari.
La procedura si chiude con un decreto di chiusura quando tutto l’attivo è stato liquidato e ripartito. Nelle società, la chiusura della liquidazione comporta l’estinzione della società stessa (il codice prevede la cancellazione d’ufficio). Negli imprenditori individuali, la chiusura segna l’avvio eventualmente dell’iter di esdebitazione personale.
Conseguenze per l’imprenditore: Dal punto di vista patrimoniale, in una società di capitali (es. S.r.l.), i soci non perdono nulla oltre il capitale investito – salvo diverse responsabilità di cui diremo tra poco. L’imprenditore individuale o i soci di società di persone, invece, vedranno coinvolto anche il loro patrimonio personale nella liquidazione giudiziale, essendo responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali. Inoltre, vi sono conseguenze di tipo personale e reputazionale: un tempo il fallimento comportava automaticamente l’interdizione dell’imprenditore dall’attività commerciale e altre incapacità civili (perdita del diritto di elettorato, etc.), oltre alla stigmatizzazione sociale. Oggi molte di queste conseguenze sono attenuate: la parola “fallito” è stata volutamente eliminata e non esistono più interdizioni automatiche lunghe, se non temporanee incompatibilità (durante la procedura, l’imprenditore non può ricoprire cariche in altre società senza autorizzazione). Resta però la possibilità di incorrere in responsabilità civili e penali: in sede penale, se l’imprenditore ha commesso reati di bancarotta (fraudolenta o semplice) prima o durante il fallimento, subirà un processo con possibili pene detentive e interdittive. In sede civile, il curatore può promuovere azioni di responsabilità verso gli amministratori e i soci per atti di mala gestio che abbiano causato danni ai creditori.
Esdebitazione: Una volta chiusa la liquidazione giudiziale, il debitore persona fisica ha diritto di chiedere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti nella procedura. Il nuovo Codice ha reso questo meccanismo ancor più favorevole al debitore meritevole: oggi decorso 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata (procedura equivalente al fallimento per i non fallibili) il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto, salvo poche eccezioni, senza nemmeno dover attendere la chiusura formale . Nel caso di fallimento tradizionale, rimane il termine di un anno dalla chiusura per fare istanza, ma la giurisprudenza ha chiarito che i presupposti per negarla sono tassativi e vanno interpretati restrittivamente in favore del debitore . Dunque, anche l’imprenditore “sfortunato” che abbia visto la propria impresa liquidata potrà ripartire pulito dai debiti pregressi, purché abbia cooperato lealmente. Attenzione: l’esdebitazione vale per la persona, non per la società (che essendo estinta non ne ha bisogno). Inoltre, non copre le eventuali sanzioni penali o amministrative personali, né i debiti per risarcimenti da fatti illeciti non pagati.
In sintesi, la liquidazione giudiziale è la soluzione di ultima istanza: dolorosa ma a volte inevitabile. Dal punto di vista del debitore, “difendersi” in questa fase significa soprattutto collaborare col curatore, evitare condotte che possano sfociare in reati e prepararsi a chiedere l’esdebitazione. Non ci sono molte altre leve di difesa, se non verificare che il proprio fallimento sia stato dichiarato correttamente (in passato si vedevano talvolta opposizioni alla dichiarazione di fallimento per guadagnare tempo, ma con l’entrata in vigore del codice le soglie di non fallibilità e i presupposti sono chiari). Va segnalato che, qualora il debitore ritenga di avere ancora una chance di concordato anche dopo l’apertura della liquidazione, può proporre un concordato nella fase di fallimento (cd. concordato fallimentare) offrendo ai creditori una soluzione migliore rispetto alla liquidazione pura: ciò però esula da questa trattazione ed è raro nel contesto di PMI.
Responsabilità dell’imprenditore, degli amministratori e dei soci nella crisi d’impresa
Dal punto di vista giuridico, uno degli aspetti più delicati per chi si trova a gestire un’impresa indebitata è comprendere quali responsabilità (civili, e talvolta penali) possano derivare dalla gestione della crisi stessa. In altri termini: se l’azienda non riesce a pagare i debiti, in quali casi i creditori (o il curatore in loro vece) possono rivalersi sul patrimonio personale degli amministratori o dei soci? E quando il comportamento dell’imprenditore in crisi può essere oggetto di sanzione?
Occorre distinguere tra le figure coinvolte:
- Imprenditore individuale: qui non c’è separazione patrimoniale tra impresa e persona fisica. Dunque tutti i debiti d’impresa sono anche debiti personali dell’imprenditore. Non c’è bisogno di “responsabilità” specifica: il creditore può direttamente aggredire beni personali (casa, conto bancario privato, ecc.) e in caso di fallimento sia l’azienda che il patrimonio personale confluiscono nella procedura. L’unica difesa per l’imprenditore individuale in crisi è usufruire degli strumenti concorsuali (concordato minore, liquidazione controllata) per contenere i danni ed eventualmente arrivare a esdebitazione.
- Società di persone (SNC, SAS): i soci hanno responsabilità illimitata (tutti i soci nella SNC, i soci accomandatari nella SAS). Ciò significa che i creditori sociali possono chiedere i pagamenti ai soci se la società non paga. In caso di fallimento, fallisce anche ogni socio illimitatamente responsabile. L’aspetto rilevante è che il socio illimitatamente responsabile, analogamente all’imprenditore individuale, non risponde solo per colpa: risponde sempre e comunque dei debiti sociali con tutto il suo patrimonio, salvo poi il suo diritto di regresso interno verso la società o gli altri soci. Non c’è quindi una “colpa” richiesta: è responsabilità oggettiva di status. Pertanto, per i soci di persone l’unica salvezza è anch’essa l’esdebitazione post-fallimento (introdotta nel 2006, prima neppure disponibile). In un contesto come il nostro, se l’impresa chimica fosse stata esercitata in forma di SNC, i soci devono essere consapevoli di questo: il fallimento societario li travolgerebbe personalmente.
- Società di capitali (S.r.l., S.p.A.): qui vale il principio della autonomia patrimoniale perfetta. I soci non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale conferito. Dunque, se un’impresa di detergenti è una S.r.l., i creditori ordinari non possono pretendere il pagamento dai soci (a meno che un socio abbia prestato fideiussioni personali o garanzie specifiche – circostanza molto frequente in pratica con le banche, ma che è un’obbligazione contratta privatamente dal socio, non una responsabilità legale “automatica”). Attenzione però: l’autonomia patrimoniale protegge i soci in assenza di atti illeciti. Se i soci utilizzano la società in modo abusivo o fraudolento, la giurisprudenza ammette azioni per “superare lo schermo” societario. Ad esempio, in caso di sovrapposizione tra patrimonio della società e personale (commistione di conti, uso personale di beni sociali, ecc.), il curatore può far valere l’azione di responsabilità verso i soci o anche, in casi estremi, i creditori potrebbero ottenere una rivalsa diretta (teoria del “piercing the corporate veil”, usata raramente in Italia e solo in presenza di abusi gravi). Un altro caso: se la società è sotto-capitalizzata in modo evidente e i soci l’hanno spolpata a beneficio proprio, si potrebbe configurare un abuso della personalità giuridica e far rispondere i soci ex art. 2043 c.c. per condotta dolosa ai danni dei creditori. Tuttavia, sono ipotesi limite. In generale, il socio di una S.r.l. o S.p.A. di per sé non rischia il patrimonio personale per i debiti della società insolvente. Rischia tuttavia di perdere il valore della propria partecipazione (che in caso di insolvenza spesso diventa azzerata) e eventuali finanziamenti soci non restituiti (che saranno postergati nel fallimento).
- Amministratori di società: discorso diverso dai soci. Gli amministratori (o il singolo amministratore unico) di una società di capitali hanno doveri gestori e possono incorrere in responsabilità civile verso la società, i creditori sociali e i terzi, nonché in responsabilità penale in caso di reati fallimentari o societari. La legge distingue vari tipi di azione:
- L’azione di responsabilità sociale (ex art. 2476 c.c. per S.r.l. o 2393 c.c. per S.p.A.) per danni cagionati al patrimonio della società da atti di mala gestio. Ad esempio, se gli amministratori hanno sperperato risorse in investimenti incauti o si sono assegnati compensi sproporzionati aggravando la crisi, la società (o il curatore fallimentare ex art. 146 L.F.) può citarli per risarcire i danni.
- L’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c., ora trasfusa nell’art. 2476 terzo comma c.c. per le S.r.l.) che scatta quando, per inosservanza dei doveri di conservazione del patrimonio sociale, questo risulta insufficiente a soddisfare i creditori. In sostanza, se la gestione colposa o dolosa degli amministratori ha causato un buco tale per cui i creditori rimangono insoddisfatti, questi ultimi (o il curatore in loro vece) possono chiedere agli amministratori il ristoro del deficit. Un caso tipico è il ritardato adempimento degli obblighi ex art. 2482-bis c.c.: se gli amministratori non convocano l’assemblea e non prendono provvedimenti quando il capitale è azzerato dalle perdite, e continuano l’attività aggravando il dissesto, essi possono dover rispondere dei debiti incrementali. Il Codice della Crisi ha aggiunto a tal riguardo una norma cruciale: il nuovo art. 2486 c.c., terzo comma (introdotto dall’art. 378 CCII), stabilisce criteri presuntivi di quantificazione del danno da gestione irregolare in caso di scioglimento della società . In particolare, se gli amministratori proseguono l’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (come la perdita integrale del capitale) senza attivare la liquidazione, il danno verso i creditori si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento in cui avrebbero dovuto interrompere e il patrimonio netto alla data del fallimento, oppure – se maggiore – all’aumento dell’indebitamento nell’arco della prosecuzione abusiva. Questa previsione facilita molto le cause di responsabilità, perché il curatore non deve più provare in dettaglio ogni singolo atto dannoso: basta dimostrare il ritardo e il peggioramento del deficit. La giurisprudenza recente (Cass. civ. Sez. I, n. 2127/2023) ha applicato tali criteri, condannando amministratori di S.r.l. a risarcire il delta negativo creatosi per aver tardato la dichiarazione di fallimento .
- Responsabilità verso terzi: al di fuori del fallimento, anche terzi possono citare gli amministratori se hanno subito un danno diretto da atti illeciti di questi ultimi (ipotesi residuale, come false comunicazioni che inducano un investitore a perdere denaro, ecc.).
In parole povere, per l’amministratore “difendersi” significa agire con la massima diligenza e trasparenza nella crisi: non aggravare il dissesto, non preferire arbitrariamente un creditore a scapito di altri (pagare “fuori sacco” qualcuno a insolvenza già conclamata può essere sia un atto di mala gestio che addirittura reato di bancarotta preferenziale), non occultare o dissipare beni della società. Al contrario, gli amministratori diligenti dovrebbero, ai primi segnali di crisi, predisporre un piano di risanamento o attivare la composizione negoziata, oppure – se non vi sono speranze – depositare istanza di concordato o di liquidazione tempestivamente. Così facendo, non solo si tutela meglio il valore aziendale, ma si previene l’accusa di aver aggravato il buco ai danni dei creditori. Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 7157/2023) è esemplare: ha condannato per danni da aggravamento del dissesto l’amministratore unico di una società il quale, invece di chiedere il fallimento appena emersa l’insolvenza, ha provato uno strumento inadeguato (un concordato preventivo in continuità poi convertito in accordo di ristrutturazione) che non poteva risolvere la crisi, tanto da portare solo a perdere tempo; nonostante quell’accordo sia stato persino omologato, l’amministratore è stato ritenuto responsabile perché così facendo ha procrastinato la resa, causando ulteriori perdite, e insieme a lui è stato ritenuto responsabile anche il professionista attestatore che aveva avallato un piano irrealistico . Il messaggio è chiaro: tentennare e scegliere soluzioni tampone solo per evitare il fallimento, quando la situazione è irrimediabile, può costare caro a chi gestisce. Meglio allora essere onesti e affrontare la realtà, anche chiedendo la liquidazione giudiziale in proprio se serve.
- Organi di controllo (sindaci, revisori, ecc.): anch’essi hanno doveri nella crisi. La legge (art. 2403 c.c. per i sindaci, art. 14 CCII per il revisore) impone di vigilare sull’adeguatezza degli assetti e segnalare tempestivamente agli amministratori i segnali di allerta. Se costoro non si attivano, gli organi di controllo devono informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi, oggi integrato nella composizione negoziata) o l’autorità giudiziaria. Se i sindaci/revisori omettono queste segnalazioni e il ritardo causa aggravamento del dissesto, anche loro possono essere chiamati a risponderne in solido con gli amministratori. Inoltre, in caso di fallimento, il curatore spesso esercita l’azione di responsabilità pure contro i sindaci, accusandoli di non aver impedito o denunciato per tempo gli atti pregiudizievoli degli amministratori. Dunque, per i controllori la miglior difesa è l’attenzione e la puntualità: se vedono segnali di crisi (indicatori negativi, capitali ridotti sotto soglia, ecc.), devono spronare l’organo amministrativo a intervenire e mettere a verbale le sollecitazioni. In mancanza di reazione, procedere con le segnalazioni esterne previste.
- Attestatori, esperti e altri professionisti: chi interviene a vario titolo nei processi di crisi ha proprie responsabilità. L’attestatore di un piano o concordato può incorrere in responsabilità civile verso i creditori danneggiati da una sua relazione negligente o infedele, e anche in responsabilità penale per falso in attestazioni (art. 236-bis L.F., ora art. 324 CCII). Cassazione penale ha recentemente affermato che l’attestatore risponde per concorso in bancarotta fraudolenta se sforna attestazioni compiacenti che permettono di frodare i creditori (Cass. pen. 36401/2023) . Nel caso citato prima del Tribunale di Roma, addirittura l’attestatore è stato condannato a risarcire insieme all’amministratore per aver asseverato con leggerezza un piano inattuabile . Gli esperti della composizione negoziata, dal canto loro, hanno una posizione peculiare: non decidono nulla, ma devono agire con imparzialità e accuratezza. Se un esperto incorre in conflitti di interesse gravi o favorisce indebitamente una parte, può essere revocato e potrebbe rispondere di danni se il suo operato scorretto pregiudica la riuscita delle trattative. Tuttavia, essendo una figura nuova, la giurisprudenza su eventuali responsabilità degli esperti è in divenire. Possiamo ragionevolmente immaginare che un creditore potrebbe lamentare un danno se l’esperto, per negligenza, non segnalasse un comportamento distrattivo del debitore (ad esempio, il debitore distrae beni durante la composizione e l’esperto non fa nulla: in tal caso quell’omissione potrebbe essere censurata). In generale comunque l’esperto è più un facilitatore e i suoi doveri sono di mezzo pubblico ufficiale quando redige determinati atti: si applicano quindi sanzioni penali in caso di false attestazioni nelle sue relazioni.
- Debitore in concordato o altri procedimenti: vale infine menzionare che l’imprenditore che intraprende una procedura concorsuale ha l’obbligo di leale collaborazione con gli organi della procedura. Nel concordato, ad esempio, presentare documentazione falsa o occultare atti in frode ai creditori comporta l’inammissibilità/rigetto del concordato e possibili responsabilità penali. Il CCII punisce con la reclusione le falsità o le frodi compiute durante le procedure (artt. 322 e seguenti CCII, che ricalcano i reati di bancarotta impropria, falsa attestazione, etc.). Quindi “difendersi” legalmente significa anche non commettere passi falsi: se si sceglie la via concorsuale, farlo in modo limpido, perché ogni bugia potrebbe non solo far fallire la procedura, ma anche aprire le porte a incriminazioni.
Riassumendo, dal punto di vista del debitore/gestore: la crisi d’impresa non è un “porto franco” in cui vale tutto per salvare il salvabile. Al contrario, è il momento in cui la condotta degli amministratori e soci viene scrutinata con lente d’ingrandimento dai futuri organi concorsuali e dai creditori. La miglior strategia difensiva è la trasparenza e l’attivazione tempestiva degli strumenti di composizione. Agire presto può evitare l’aggravamento del dissesto e ridurre l’esposizione a contestazioni. Se invece ci si chiude negando la realtà, continuando magari ad accumulare debiti sperando in un miracolo, si rischia di finire imputati di “bankruptcy misconduct”. Esempio classico: continuare ad acquistare merci a credito da fornitori quando si sa di non poterle pagare configura, in caso di fallimento, una bancarotta semplice per aggravamento di insolvenza (art. 323 CCII, già art. 217 L.F.) o persino una truffa ai creditori. Allo stesso modo, vendere sottocosto beni della società per fare cassa all’ultimo momento può essere considerato bancarotta fraudolenta per distrazione. La legge (art. 330 CCII) prevede addirittura una specifica figura di reato per gli amministratori che, violando gli obblighi imposti dal codice civile o dalla legge fallimentare, cagionano con colpa grave il dissesto (è la cosiddetta “bancarotta semplice impropria” riferita alle violazioni degli obblighi gestori) . Ad esempio, l’amministratore che non tiene la contabilità in ordine e ciò rende impossibile ricostruire il patrimonio fallimentare, commette bancarotta documentale (reato) .
In conclusione su questo punto, il punto di vista del debitore deve essere: come posso limitare i danni e proteggermi legalmente quando la mia azienda è in crisi? La risposta è: agendo con correttezza, adottando gli strumenti offerti dalla legge per gestire la crisi e coinvolgendo in modo ordinato i creditori, piuttosto che tentare furbizie o nascondere problemi. Il Codice della Crisi in fondo spinge a questo: “play it fair”, e avrai accesso a misure di sollievo (come l’esdebitazione, la protezione, ecc.); gioca d’azzardo o in malafede, e ne pagherai le conseguenze.
Domande frequenti (FAQ) su debiti d’impresa e soluzioni di crisi
D: La mia azienda manifatturiera è oberata dai debiti ma credo sia ancora recuperabile. Qual è la prima cosa da fare?
R: La prima cosa è fare una diagnosi chiara della situazione finanziaria con l’aiuto di un professionista (commercialista/esperto di crisi). Bisogna quantificare esattamente l’ammontare dei debiti (verso banche, fornitori, fisco, dipendenti, ecc.), verificare la presenza di eventuali insoluti o procedure in corso e valutare obiettivamente se l’azienda genera flussi di cassa sufficienti (o prospettive di mercato) per poter sostenere un piano di risanamento. Contestualmente, è fondamentale interloquire subito con i creditori principali: spesso, ad esempio, con la banca si può negoziare una moratoria temporanea sul rientro del fido, o con i fornitori critici si può concordare una consegna a fronte di pagamenti parziali. Mostrare ai creditori che l’imprenditore non sta scappando, ma anzi sta cercando attivamente soluzioni, può evitare che precipitino la crisi (ad esempio evitando che portino subito i libri in tribunale). In sintesi: analisi + dialogo. E, sullo sfondo, studiare quale strumento formale adottare se la situazione lo richiede (piano attestato, accordo, composizione, ecc.). Se l’impresa ha cassa insufficiente persino per le spese quotidiane, occorre valutare l’opportunità di richiedere misure protettive immediate (ad esempio depositando un’istanza di composizione negoziata con richiesta di stay, o un concordato “in bianco”) per congelare i creditori e guadagnare tempo.
D: Quando conviene usare un piano attestato invece di andare direttamente in concordato preventivo?
R: Un piano attestato di risanamento conviene se l’azienda ha buone chance di ripresa e relazioni positive con i principali creditori, tali per cui si può ragionevolmente ottenere il loro consenso fuori dalle aule giudiziarie. Conviene in particolare quando i creditori coinvolti sono pochi o omogenei (es. solo le banche) e magari uno o due di loro sono determinanti: in questi casi si preferisce una soluzione discreta e rapida come il piano attestato, evitando la pubblicità e i costi di un concordato. Se invece abbiamo a che fare con tanti piccoli creditori o con alcuni creditori ostili che non collaborerebbero mai spontaneamente, il concordato offre il meccanismo del voto a maggioranza che permette di superare il dissenso. Inoltre, il piano attestato è adatto se non serve falcidiare pesantemente i crediti: ad esempio, le banche potrebbero accettare di spostare le scadenze o ridurre tassi, i fornitori di aspettare qualche mese in più, ma tutti vengono pagati integralmente (magari solo con qualche stralcio marginale). Se invece occorre abbattere significativamente il debito (ad esempio proporre ai chirografari di prendere il 30% del credito), è difficile che lo accettino informalmente uno per uno; il concordato qui è più indicato perché vincola anche i dissenzienti con l’ok della maggioranza. In termini di costi e tempi: il piano attestato è più economico e veloce del concordato, quindi se fattibile è preferibile. Il concordato va visto come uno strumento da usare quando il “consenso spontaneo” non è sufficiente a risolvere.
D: Ho sentito parlare di accordo di ristrutturazione e di piano di ristrutturazione omologato (PRO). Sono la stessa cosa? Cosa cambia rispetto al concordato?
R: Non sono la stessa cosa, anche se hanno caratteristiche simili. L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) è, come detto, un accordo negoziato col almeno il 60% dei creditori, poi omologato dal tribunale, che consente una ristrutturazione del debito mantenendo l’azienda fuori dal fallimento . Il PRO – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è una nuova figura introdotta nel 2022 in attuazione della direttiva UE . In pratica, il PRO consente al debitore anche senza avere il 60% di adesioni di presentare un piano di ristrutturazione al tribunale e chiederne l’omologazione, a patto che il piano sia approvato da ogni singola classe di creditori appositamente formata con una maggioranza qualificata . È un po’ una via di mezzo tra l’accordo e il concordato: c’è un accordo con i creditori, ma organizzato in classi come nel concordato, e se ogni classe rilevante approva il piano, il tribunale può omologarlo rendendolo vincolante per tutti . La differenza dal concordato è che nel PRO si possono derogare le priorità legali di pagamento con il consenso delle classi (esempio: i chirografari potrebbero ricevere qualcosa mentre un ipotecario è soddisfatto solo parzialmente, purché la classe degli ipotecari approvi quella distribuzione anomala) . In un concordato classico, invece, ai creditori privilegiati dissenzienti devi comunque garantire il 100% del loro credito salvo degradazione per incapienza. Il PRO permette maggiore flessibilità negoziale, ma richiede di portare almeno ogni classe al voto favorevole (non serve il 60% sull’intero, però serve la maggioranza in ciascuna classe). Se una classe vota contro, il PRO – a differenza del concordato che potrebbe ugualmente essere omologato se rispetta certe condizioni – di regola non può essere omologato (salvo meccanismi di cram-down interclasse che il giudice potrebbe applicare se il piano rispetta comunque la fairness per la classe dissenziente, ma entriamo in tecnicismi). In pratica, il PRO è uno strumento pensato per imprese medio-grandi che magari hanno diverse classi di creditori (banche senior, obbligazionisti subordinati, fornitori, ecc.) e vogliono raggiungere un accordo globale senza passare per tutte le formalità del concordato, ma beneficiando di una omologazione giudiziale. È molto innovativo e finora non è stato ancora utilizzatissimo, ma rappresenta una opzione in più. Per una PMI, comunque, l’accordo di ristrutturazione tradizionale (60%) o il concordato restano gli strumenti più concreti. Il PRO potrebbe servire se, ad esempio, l’impresa ha una struttura di debito molto finanziaria e vuole coinvolgere banche e bondholders in una ristrutturazione cram-down senza fare un concordato che spaventerebbe la clientela: in tal caso il PRO consente di ottenere l’omologa di un piano negoziato con i soli finanziatori, lasciando fuori i fornitori (che continuano a essere pagati regolarmente) .
D: I debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi in questi piani o accordi? Lo Stato accetta tagli sui propri crediti?
R: Sì, i debiti fiscali e previdenziali possono essere inclusi nei piani di risanamento, concordati, accordi, ma con regole specifiche. In passato era molto problematico ridurre IVA e ritenute, ora invece la legge consente anche allo Stato di partecipare agli accordi di ristrutturazione e ai concordati accettando transazioni fiscali, ossia parziali pagamenti. Ad esempio, in un concordato l’IVA e le ritenute non versate devono comunque essere pagate almeno al 20% (non possono essere totalmente stralciate), mentre per le altre imposte dirette o contributi si può proporre anche un pagamento parziale. Se l’Erario (Agenzia Entrate) e l’INPS aderiscono formalmente alla proposta, allora tutto ok: il loro credito viene trattato come da accordo. Se però lo Stato rifiuta la proposta nel voto, oggi sia nel concordato sia negli accordi di ristrutturazione c’è la possibilità del cram-down fiscale: il tribunale può omologare ugualmente il piano anche senza il voto favorevole del Fisco, purché la soddisfazione offerta a Erario/enti sia almeno pari a quella che otterrebbero in caso di liquidazione del debitore . In pratica, se il piano offre al Fisco il meglio possibile date le condizioni del patrimonio, il giudice può ignorare l’eventuale dissenso dell’Agenzia e rendere effettivo lo stesso la falcidia. Questo è stato introdotto proprio perché spesso il Fisco, per motivi burocratici, non aderiva alle proposte e faceva saltare tutto: ora non ha più potere di veto assoluto. È importante però che la proposta al Fisco sia seria e documentata: bisogna inserire la cosiddetta attestazione di convenienza dove si dimostra che quella percentuale è superiore a quanto l’Erario ricaverebbe dal fallimento. In sede di composizione negoziata, l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti pubblici sono invitati a partecipare alle trattative e a rispondere entro 90 giorni alle proposte del debitore. Inoltre, va detto che esistono anche procedure extra-concorsuali di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazioni, stralcio interessi, ecc. previsti dalle leggi di bilancio recenti) che il debitore può sfruttare parallelamente per alleggerire il carico fiscale senza passare dal tribunale. In definitiva: lo Stato non è più un creditore imbattibile, oggi accetta piani dilazionati (tipicamente fino a 6 anni per imposte) e a volte anche riduzioni, specie su interessi e sanzioni. Bisogna però rispettare i paletti di legge e attivarsi formalmente per includerlo.
D: Se la mia società viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale), io come amministratore o socio posso essere costretto a pagare i debiti sociali?
R: Se sei socio di S.r.l. o S.p.A., no per i debiti in sé – rispondi solo del capitale sottoscritto (già versato o da versare). Tuttavia, se hai prestato garanzie personali su debiti sociali (es. fideiussione alla banca), quella è una tua obbligazione e la banca potrà escuterti anche dopo il fallimento della società. Inoltre, se emergono responsabilità per mala gestione, il curatore o i creditori possono agire contro di te (azione di responsabilità) e, se il giudice ti condanna, dovrai pagare dei danni (che indirettamente andranno ai creditori). Se poi sei socio di una SNC o accomandatario di una SAS, allora sì: in quel caso fallisci anche tu personalmente e il tuo patrimonio viene liquidato per pagare i debiti sociali, perché avevi responsabilità illimitata. In qualità di amministratore, non rispondi automaticamente dei debiti della società, ma puoi dover risponderne se hai violato i tuoi doveri. Ad esempio, se hai continuato ad operare facendo nuovi debiti quando sapevi che l’azienda era insolvente, è probabile che il curatore ti farà causa per quell’aggravio (come visto prima, art. 2486 c.c. e affini). Anche senza una causa specifica, la legge fallimentare prevede che l’imprenditore dichiarato fallito (se persona fisica) resti obbligato verso i creditori per la parte di debiti non soddisfatta nella procedura – però, come spiegato, c’è l’esdebitazione che gli cancella queste obbligazioni residue. Quindi, se parliamo di pagamento dei debiti sociali, in linea generale l’amministratore non paga di tasca propria (salvo eccezioni di garanzie personali). Ciò non significa che sia immune: se ha compiuto atti di mala fede o ha distratto beni, oltre al penale, può subire un sequestro dei propri beni per risarcire. In pratica, i creditori sociali non possono chiederti i soldi solo perché eri amministratore, ma se diventa accertato che con la tua condotta li hai danneggiati, allora sì, pagherai quel danno.
D: Cosa succede ai contratti (di forniture, di affitto, di lavoro, ecc.) mentre è in corso un concordato o un accordo? L’azienda può continuare a operare?
R: Durante il concordato preventivo, l’azienda può continuare ad operare, ma con qualche limite. I contratti in corso di esecuzione (cioè non del tutto adempiuti da entrambe le parti) non si sciolgono automaticamente: l’imprenditore può chiedere al tribunale di autorizzare la continuazione di quei contratti se utili alla procedura, oppure in alcuni casi può anche chiedere lo scioglimento o la sospensione di contratti onerosi (pensiamo a un contratto di affitto di ramo d’azienda troppo costoso – col nuovo CCII è possibile domandare la cessazione anticipata in concordato autorizzata dal giudice). I fornitori, dal momento dell’apertura del concordato, devono continuare a rispettare i contratti e le forniture in essere, ma i loro crediti pregressi restano congelati e saranno trattati nel concordato. Ad esempio, se ho un contratto di fornitura continua di materie prime, il fornitore non può interrompere solo perché sono in concordato (salvo eccezioni contrattuali), e le consegne post-apertura saranno pagate come debiti prededucibili (prioritari). Però quanto non pagato di vecchio rimarrà concorsuale. Negli accordi di ristrutturazione, essendo tutto su base negoziale, in genere l’imprenditore e i creditori contrattualizzano come gestire i contratti in corso (es: il fornitore essenziale viene pagato per l’intero e continua a fornire, in cambio della sua adesione all’accordo per altri aspetti). La composizione negoziata prevede espressamente che i contratti essenziali (forniture di energia, acqua, telefonia…) non possano essere sospesi o revocati dai fornitori solo perché l’azienda è in trattativa o ha tardato alcuni pagamenti pregressi, se il debitore ne richiede la prosecuzione e garantisce il pagamento della correntezza. Insomma, c’è tutela per evitare che i partner interrompano le forniture e facciano collassare l’impresa in crisi. I contratti di lavoro invece proseguono regolarmente: il concordato non risolve i rapporti di lavoro (se servono licenziamenti collettivi per ristrutturare, vanno negoziati a parte con le procedure giuslavoristiche ordinarie). In fallimento, scenario diverso: il curatore può recedere dai contratti in corso se vuole (con indennizzo a carico del fallimento) oppure subentrarvi. Nel concordato in continuità, l’azienda va avanti e quindi i contratti fondamentali vanno avanti; nel liquidatorio, spesso l’attività cessa e allora i contratti vengono chiusi o eseguiti solo nella misura utile alla liquidazione.
D: La mia impresa è in crisi ma possiede un immobile industriale di valore; se attivo un accordo o un concordato, posso vendere quell’immobile per fare cassa e pagare i creditori?
R: Dipende. Fuori dalle procedure, l’impresa può vendere i propri beni in qualsiasi momento – tuttavia bisogna stare attenti: se poi fallisce entro 2 anni, quella vendita potrebbe essere revocata (se fatta sotto prezzo o a favore di qualche parte correlata) o contestata come atto di frode. Se invece fai la vendita dentro una procedura concorsuale (accordo omologato, concordato, ecc.), allora quell’atto è protetto: ad esempio la vendita di immobile autorizzata dal giudice in un concordato non sarà revocabile successivamente. Quindi, la scelta migliore se vuoi vendere un asset importante per pagare i debiti è farlo nell’ambito di un piano concordato con i creditori. Nell’accordo di ristrutturazione potresti inserire la clausola che l’immobile X verrà venduto e il ricavato destinato a loro, magari nominando già un advisor che segua la cessione; una volta omologato l’accordo, procedi e nessuno potrà impugnarlo. Nel concordato preventivo, puoi chiedere fin da subito al tribunale l’autorizzazione a vendere l’immobile (anche prima dell’omologa, se c’è urgenza e se serve per evitare un depauperamento) e il ricavato andrà poi nelle casse della procedura vincolato ai creditori. Se fossi in composizione negoziata senza misure protettive, tecnicamente potresti vendere liberamente (perché sei ancora libero di operare), ma converrebbe informarne l’esperto e farlo con trasparenza, magari depositando il denaro su un conto vincolato al piano, in modo da non destare sospetti. In generale, sì, vendere beni per pagare debiti è spesso parte integrante di un piano di risanamento (si parla di disinvestment di asset non core). Bisogna però seguire le formalità giuste per non incorrere in accuse di distrazione. Nel concordato, la legge oggi consente anche di prevedere che la vendita di beni avvenga dopo l’omologa sotto controllo del commissario/curatore, ma anche di farla prima se autorizzata. Quindi tutto si può fare, l’importante è coinvolgere creditori e/o giudice a seconda del contesto.
D: Cos’è l’esdebitazione esattamente? Riguarda anche le società?
R: L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui dopo la chiusura di una procedura liquidatoria. È rivolta alle persone fisiche (imprenditori individuali, soci illimitatamente responsabili falliti, consumatori sovraindebitati). Una società che cessa di esistere con debiti insoddisfatti in realtà non ha bisogno di esdebitazione perché, estinguendosi, quei debiti restano senza un soggetto obbligato (non possono essere chiesti ai soci se era società di capitali). Dunque, giuridicamente l’esdebitazione è il beneficio concesso al fallito persona fisica di ripartire da zero, senza la palla al piede dei debiti pregressi. Nel nostro caso, se l’impresa di detergenti è una S.r.l., la società dopo la liquidazione giudiziale si estinguerà con i debiti non pagati che diventeranno inesigibili; i soci non risponderanno (salvo responsabilità separate). L’amministratore, se aveva firmato garanzie, quelle restano ma può liberarsene per la parte eccedente quanto i creditori han recuperato, sempre tramite esdebitazione come “sovraindebitato” se del caso. Se invece parliamo di un imprenditore individuale: supponiamo Mario Rossi ditta individuale di detergenti, fallito con 500k € di debiti e il fallimento ne ha pagati solo 100k. Mario Rossi a fine procedura può chiedere di essere esdebitato, e otterrà la cancellazione legale dei rimanenti 400k € . I creditori non potranno più perseguitarlo. Questo incentivo serve a favorire il fresh start e a convincere i debitori a collaborare senza nascondere asset (perché sanno che avranno comunque una via d’uscita). Con il CCII, come ricordato, l’esdebitazione è diventata più veloce e quasi automatica dopo un certo periodo . Piccola nota: c’è un caso in cui anche una società può, indirettamente, ottenere qualcosa di simile all’esdebitazione: è il concordato preventivo liquidatorio con assunzione, dove un terzo assume l’obbligo di pagare ai creditori una certa percentuale e la società si “libera” oltre quella soglia. Ma in realtà lì c’è un terzo che paga, non è una remissione giuridica come l’esdebitazione personale. Quindi, in pratica, solo gli imprenditori individuali e i soci illimitati beneficiano di esdebitazione. E ormai è la regola, salvo che abbiano commesso irregolarità gravi (ad esempio, non merita esdebitazione chi ha distratto attivi o falsificato le scritture, oppure chi non ha cooperato affatto durante il fallimento).
D: Dopo aver superato la crisi con un concordato o un accordo, la mia azienda tornerà “affidabile”? Ci sono effetti a lungo termine da considerare (tipo difficoltà di credito, segnalazioni, etc.)?
R: Superare una procedura concorsuale sana l’indebitamento pregresso, ma lascia certamente qualche segno. Dal punto di vista legale, una volta omologato e completato un concordato o accordo, l’azienda è regolare e può continuare ad operare. Tuttavia, ci sono aspetti di reputazione e di rapporti bancari da considerare. Le banche, ad esempio, quando un cliente entra in concordato, di solito classificano a sofferenza il credito e segnalano la cosa in Centrale Rischi. Se poi il concordato va a buon fine, quell’evento storico rimane nei dati interni delle banche e potrebbe rendere più difficile ottenere nuovo credito nel breve termine. Molto dipende da come la crisi è stata gestita: un conto è un’azienda che esce da un concordato con pagamenti regolari e mantiene relazioni, un altro conto è se ha fatto default totale sui vecchi debiti. In generale, sì, c’è una sorta di “pagella” meno brillante per qualche tempo. Però non è precluso nulla: molte imprese in concordato in continuità sono poi tornate affidabili dopo aver eseguito il piano, anzi a volte con bilanci ripuliti diventano attraenti. Dal punto di vista dei fornitori, alcuni potrebbero essere cauti nell’estendere nuovi crediti commerciali sapendo del precedente, quindi l’impresa dovrà riconquistarsi la fiducia (magari pagando inizialmente a vista per un po’). Giuridicamente parlando, dopo l’omologa del concordato, l’impresa rimane la stessa entità legale ma con un piano da rispettare: se lo rispetta e viene dichiarata l’adempimento, tutto ok; se non lo rispetta, rischia la risoluzione e il fallimento. Con l’accordo di ristrutturazione, una volta omologato e eseguito, non c’è un “clearance” ufficiale, semplicemente i crediti si considerano estinti secondo l’accordo. Un altro aspetto: in caso di concordato, c’è una pubblicità sul Registro Imprese e sui registri dei protesti/CRIF che col tempo viene cancellata (mi pare dopo 5 anni dall’omologa non risulta più come pregiudizievole pubblicamente, dovrei confermare). Comunque, l’importante è che è meglio un concordato omologato che un fallimento dal punto di vista della reputazione: significa che sei riuscito a negoziare e a non cessare l’attività. Molte banche considerano un cliente post-concordato ancora meritevole di credito soprattutto se il concordato era in continuità (quindi l’impresa ha dimostrato redditività operativa). Ci sono casi di aziende famose che sono uscite da concordati o accordi e hanno ripreso a ottenere finanziamenti (magari garantiti dallo Stato per favorirne la ripresa, come previsto da norme speciali ad esempio per concordati con continuità). Quindi, nel lungo termine, un’azienda può certamente tornare affidabile, ma sarà fondamentale ricostruire un track record positivo e mantenere capitalizzazione e indicatori solidi.
D: Se vedo che la situazione è disperata, mi conviene aspettare che i creditori mi portino i libri in tribunale o devo attivarmi io?
R: Conviene attivarsi personalmente. Aspettare passivamente ha diversi svantaggi. Intanto, si perde l’opportunità di scegliere lo strumento più adatto e di preparare la procedura con calma: se un creditore presenta istanza di fallimento, l’imprenditore finisce sulla difensiva, magari non ha nemmeno predisposto un piano di concordato e rischia la dichiarazione di liquidazione giudiziale senza contropartita. Se invece l’imprenditore si muove per primo – ad esempio depositando una domanda di concordato preventivo o chiedendo la composizione negoziata – blocca sul nascere le iniziative dei creditori e dà un segnale di gestione responsabile. Inoltre, attivarsi spontaneamente è considerato un elemento di meritevolezza: ad esempio, presentare l’istanza di fallimento in proprio (autofallimento) può evitare contestazioni di bancarotta semplice per tardiva richiesta. Anche in sede penale, chi correttamente denuncia l’insolvenza tende ad essere visto meglio di chi la nasconde. Quindi, a meno che non ci siano buone ragioni tattiche per tardare (che raramente ci sono, se la situazione è già disperata), è preferibile prendere l’iniziativa. Il Codice della Crisi ha eliminato l’obbligo di legge che c’era nel vecchio art. 217 L.F. di dichiarare fallimento entro 15 giorni dall’insolvenza per non incorrere in bancarotta semplice, ma resta il fatto che più aspetti, più i debiti cresceranno (interessi, spese legali dei creditori, ecc.) e minori saranno le risorse attive. Il temporeggiare è comprensibile psicologicamente, ma per esperienza quasi mai paga. Un concordato presentato tardi, con cassa zero, ha poche possibilità; un fallimento tardivo avrà meno attivo e magari condotte discutibili nel frattempo. Dunque il motto è: “meglio un’azione tempestiva oggi che una reazione forzata domani”. Si può tentare la composizione negoziata come preludio, perché quello non è visto male nemmeno dai creditori (anzi, preferibile al fallimento puro), ma l’importante è non far finta di nulla sperando che i creditori magicamente rinuncino: ciò non accade, e quando muovono loro può essere troppo tardi per salvare qualcosa. In pratica, portare volontariamente i libri in tribunale (ossia chiedere la liquidazione giudiziale in proprio) è una scelta estrema ma spesso più dignitosa: consente all’imprenditore di dimostrare che non ha nulla da nascondere e vuole liquidare il patrimonio secondo legge. E attenzione: se il tribunale dichiara il fallimento su istanza altrui e riscontra che l’imprenditore ha aggravato il dissesto nel frattempo, potrebbe segnalare ciò al PM per valutare bancarotta. Quindi, attivarsi per tempo è anche difendersi.
Esempi pratici di gestione della crisi di un’impresa debitrice (casi simulati)
Caso A – Crisi risolta con accordo stragiudiziale e composizione negoziata: Gamma S.r.l. è un’azienda toscana di medie dimensioni che produce detergenti professionali. Negli ultimi due anni ha accumulato circa €1,5 milioni di debiti: ha 600 mila € di scoperto con la banca Alfa (garantito in parte da pegno su magazzino), 400 mila € di debiti con 50 fornitori, 200 mila € di IVA e imposte non pagate, 100 mila € di contributi INPS arretrati e 200 mila € tra TFR e mensilità dovute ai dipendenti (Gamma ha 25 dipendenti). Le vendite sono calate e i margini erosi dall’aumento dei costi chimici. Tuttavia Gamma ha un mercato fedele per alcuni suoi prodotti e prevede nuove commesse da un cliente importante. Arriva però la prima istanza di decreto ingiuntivo da un fornitore e la banca minaccia di revocare il fido. A questo punto l’amministratore di Gamma S.r.l. convoca subito il commercialista e un avvocato specializzato in crisi. Decidono di attivare la composizione negoziata della crisi. Gamma presenta istanza sulla piattaforma e ottiene la nomina di un esperto indipendente. Contestualmente, chiede e ottiene dal tribunale misure protettive: per 3 mesi nessun creditore potrà iniziare o proseguire azioni esecutive. Questo ferma l’azione del fornitore e rassicura la banca (che per ora non può revocare formalmente gli affidamenti). Inizia la trattativa guidata dall’esperto: emergono i seguenti elementi per una possibile soluzione: – I soci di Gamma sono disposti ad apportare €200.000 freschi in azienda, però a condizione di mantenere la governance e diluire il meno possibile le loro quote. – Un investitore esterno (un concorrente interessato ai prodotti di Gamma) potrebbe entrare rilevando il 30% delle quote con un apporto di €300.000, ma chiede che l’azienda abbia prima sistemato la posizione bancaria e il debito con i dipendenti. – L’esperto verifica che vendendo un capannone secondario inutilizzato, Gamma potrebbe ricavare €250.000. Con queste leve, l’esperto elabora con Gamma e i consulenti un possibile accordo stragiudiziale: la banca Alfa sarebbe ripagata interamente (€600k) utilizzando i €300k dell’investitore e €300k ricavati in parte dalla vendita del capannone; i fornitori chirografari verrebbero pagati al 50% (200k su 400k di debito) in 12 mesi utilizzando il resto del ricavato del capannone e parte dell’apporto soci; i debiti fiscali e contributivi verrebbero dilazionati su 5 anni utilizzando i futuri utili, ma beneficiando di sanzioni annullate (Gamma sfrutterebbe alcune norme di definizione agevolata per ridurre sanzioni e interessi). I dipendenti riceverebbero subito tutte le mensilità arretrate grazie a €100k dei soci e il TFR sarebbe accantonato su un fondo. Questo piano viene prospettato ai creditori. L’esperto aiuta a convincerli mostrando che, in caso di fallimento, la banca Alfa forse sì avrebbe recuperato il suo (col pegno sul magazzino e ipoteca sul capannone), ma i fornitori avrebbero preso zero o molto meno, e il fisco uguale. Tutti i grandi creditori concordano su questa impostazione. Al termine dei 3 mesi, Gamma S.r.l. raggiunge un accordo con l’80% dei creditori (in valore): viene formalizzato un accordo stragiudiziale di ristrutturazione. Formalmente è un piano attestato di risanamento (l’azienda incarica un professionista che assevera che pagando banca interamente e tagliando i debiti fornitori al 50% tornerà solvibile). Con la relazione dell’attestatore, Gamma ottiene dalle banche nuove linee a breve termine per finanziare il circolante post-accordo. I fornitori firmano l’intesa (chi non firma viene comunque pagato integralmente a parte, con risorse del circolante). La composizione negoziata viene chiusa positivamente. Entro 6 mesi Gamma vende il capannone, incassa l’apporto soci e l’investimento del nuovo socio, paga la banca e i fornitori secondo gli accordi. L’azienda è salva: ha meno debiti, un investitore in più e può concentrarsi sul rilancio commerciale. Dopo 2 anni Gamma S.r.l. è tornata in utile e ha rispettato tutte le scadenze del piano; le eventuali passività residue con fisco e INPS sono coperte da fideiussioni personali dei soci come ulteriore garanzia nell’accordo (soci che però confidano nell’aumento di fatturato per pagarle). In questo scenario, l’imprenditore ha “giocato d’anticipo” e, grazie alla composizione negoziata, è riuscito a evitare il fallimento e pure il concordato, risolvendo la crisi in via negoziale.
Caso B – Crisi aggravata e concordato preventivo in extremis: Delta S.p.A. è un’industria chimica di grandi dimensioni (150 dipendenti) specializzata in detergenti per l’industria alimentare. Dopo alcuni anni negativi, Delta accumula 10 milioni di debiti, di cui 6 milioni verso 5 banche diverse, 2 milioni verso fornitori e 2 milioni verso Erario/INPS. Invece di affrontare la situazione, il management cerca di “comprare tempo”, contraendo nuovi debiti per pagare i vecchi (classico schema ponzi interno): ottiene anticipazioni su fatture future e utilizza fidi di firma per garantirsi forniture ulteriori, sperando in una commessa importante che “salverà tutto”. Questa commessa tuttavia non arriva. I debiti intanto aumentano a 12 milioni. A questo punto le banche, vedendo gli indicatori fuori controllo, bloccano gli affidamenti e una di esse chiede il fallimento di Delta S.p.A. Solo ora l’azienda corre ai ripari e presenta una domanda di concordato preventivo “in bianco” per congelare la situazione. Il tribunale concede la protezione e un termine di 60 giorni per presentare il piano. Delta prepara in fretta e furia un piano di concordato in continuità indiretta: trovare un investitore che apporti 3 milioni in cambio di nuova emissione azioni, cedere un ramo d’azienda secondario per 1 milione, e con questi 4 milioni complessivi pagare i creditori privilegiati (per 3 milioni totali) al 100% e offrire circa il 20% ai chirografari (gli altri 9 milioni di crediti). Il piano è molto tirato e la sua fattibilità poggia su ipotesi ottimistiche (nessun investitore si è concretamente impegnato per i 3 milioni, ci sono solo “trattative in corso”). Tuttavia, per evitare il fallimento, Delta deposita questo piano insieme alla relazione di un attestatore che – sebbene con molte cautele – dichiara il piano “fattibile”. I creditori vengono convocati al voto: banche e fornitori, stante la prospettiva di prendere qualcosa anziché zero, approvano per il rotto della cuffia (si supera di poco la maggioranza richiesta). Il concordato viene quindi omologato. Ma la storia non finisce bene: l’investitore promesso non si materializza (dopo due diligence, rinuncia); la vendita del ramo d’azienda va per le lunghe e frutta meno del previsto; l’azienda fatica a stare sul mercato perché la reputazione è scesa e alcuni clienti grossi sono passati ad altri fornitori per timore di problemi di continuità. Dopo un anno, Delta S.p.A. non riesce a pagare le rate concordatarie ai chirografari. I creditori chiedono la risoluzione del concordato e il tribunale la dichiara, aprendo contestualmente la liquidazione giudiziale (fallimento) di Delta. Un disastro: l’azienda viene smembrata dal curatore; gli asset rimasti vengono venduti all’asta a valori dimezzati, i dipendenti perdono il lavoro (in parte transitano a competitors che acquistano i macchinari); e in aggiunta, il curatore avvia azioni di responsabilità contro gli amministratori di Delta, accusandoli di aver aggravato il dissesto con la loro condotta dilatoria e di aver proposto un concordato “irrealistico” solo per rinviare il fallimento. Viene anche segnalato in Procura il caso: partirà un’indagine per bancarotta semplice o fraudolenta a carico del vecchio CDA, e forse anche per il reato di falso in attestazione nei confronti dell’attestatore. In questo scenario, vediamo come un concordato fatto troppo tardi e senza basi solide non solo non salva l’azienda, ma peggiora la posizione di chi la gestiva. Probabilmente, se Delta S.p.A. avesse attivato un accordo di ristrutturazione due anni prima coinvolgendo le banche (magari convertendo parte dei loro crediti in capitale o in strumenti partecipativi) e riducendo il perimetro aziendale, avrebbe avuto più chance. Oppure, se proprio non c’erano vie di risanamento, avrebbe dovuto dichiarare fallimento prima evitando quei ulteriori 2 milioni di debiti in più: in tal caso i creditori avrebbero perso meno e forse non si sarebbe configurata una responsabilità per aggravamento. L’unica nota positiva è che – essendo Delta una società di capitali – i soci perderanno il capitale ma non risponderanno oltre (a meno che vengano trovate condotte distrattive anche a loro carico). Gli amministratori, invece, rischiano seriamente sanzioni economiche e penali.
Caso C – Liquidazione volontaria vs liquidazione giudiziale: EcoDeters S.r.l. è una piccola impresa familiare (soci marito e moglie) che produce detergenti biodegradabili. Ha debiti modesti (€200.000, principalmente mutuo bancario e fornitori), ma anche il fatturato è piccolo e in calo. I soci, vicini alla pensione, decidono di chiudere l’attività volontariamente prima di accumulare altri debiti. Nel 2025 convocano l’assemblea e mettono la società in liquidazione volontaria nominando un liquidatore (il loro commercialista). La liquidazione extra-concorsuale però non tutela dai creditori: mentre vendono i cespiti e provano a pagare tutti, un fornitore impaziente ottiene un decreto ingiuntivo e pignora il conto della società, costringendo la liquidazione a rallentare. A causa di ciò, la banca non viene pagata regolarmente e alla fine porta EcoDeters in tribunale chiedendone il fallimento. Il tribunale accerta che in effetti la società è ormai insolvente (non ha abbastanza attivo per saldare tutto) e dichiara la liquidazione giudiziale. Il liquidatore volontario viene sostituito dal curatore nominato. Questo esempio per dire: se pensate di chiudere un’azienda indebitata fuori dal contesto concorsuale, assicuratevi di poter pagare tutti i creditori, altrimenti il rischio di un fallimento successivo rimane. A volte gli imprenditori tentano la liquidazione volontaria perché sperano di evitare la “nomea” del fallimento, ma se durante la liquidazione volontaria i creditori non sono soddisfatti, essi possono comunque agire per far dichiarare il fallimento entro 1 anno dalla cancellazione dal registro (in questo caso EcoDeters era ancora attiva, dunque era lampante). Quindi, Caso C bis: se EcoDeters avesse anticipato la mossa, poteva valutare un concordato semplificato: con soli 200k di debiti, in composizione negoziata avrebbe potuto offrire, ad esempio, la vendita del piccolo capannone per 150k come soddisfazione parziale e ottenere l’ok del tribunale a liquidare la società senza formalmente fallire. Una volta che i soci hanno deciso di cessare, farlo via concordato semplificato li avrebbe portati a una chiusura più ordinata e senza azioni esecutive individuali in mezzo. Mentre la liquidazione volontaria ha lasciato il fianco scoperto. Ora EcoDeters S.r.l., fallita, vedrà il curatore gestire quelle poche vendite di asset e i soci alla fine perderanno uguale, con in più la scocciatura del fallimento e la necessità di attendere l’esdebitazione per liberarsi dell’eventuale residuo.
Questi casi illustrano alcune casistiche reali semplificate: ogni crisi ha le sue peculiarità, ma il pattern che emerge è coerente con quanto detto: attivarsi presto e in modo strutturato (Caso A) dà più probabilità di successo e limita i danni, mentre trascinare la crisi (Caso B) o affidarsi a soluzioni incomplete (Caso C) peggiora l’outcome per tutti.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Confronto tra strumenti di risanamento/insolvenza (principali caratteristiche)
| Strumento | Tipo di procedura | Chi la avvia | Coinvolgimento creditori | Autorità/Garanzie | Vantaggi per il debitore | Svantaggi/Limitazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accordo stragiudiziale informale (piano di rientro “privato”) | Nessuna procedura formale (negoziazione privata) | Il debitore su base volontaria, tramite trattative dirette | Su base consensuale: serve accordo con tutti i creditori rilevanti (anche individualmente) | Nessun intervento giudiziario. Nessuna pubblicità né costo procedurale. | – Flessibile, rapido, riservato.<br>– Nessun obbligo di percentuali minime.<br>– Gestione interamente nelle mani dell’imprenditore. | – Non vincola i creditori non aderenti.<br>– Nessuna protezione legale: i creditori possono agire individualmente (salvo accordi di standstill).<br>– Atti a rischio revocatoria in caso di fallimento successivo (nessuna esenzione). |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Procedura stragiudiziale “attestata” (no omologa) | Il debitore predispone piano + relazione attestatore; accordi con creditori chiave | Consensuale con i creditori aderenti (nessuna soglia fissa; i non aderenti restano estranei ma vanno pagati integralmente) | Nessuna omologazione, ma il piano e la relazione possono essere depositati al Registro Imprese (facoltativo). Esonero da revocatoria per atti esecutivi del piano . | – Rimane confidenziale e veloce.<br>– Esonera da revocatoria i pagamenti/garanzie eseguiti secondo il piano .<br>– Non richiede percentuali minime di adesione (basta ottenere adesione di chi serve).<br>– Nessun organo esterno imposto (attestatore scelto dal debitore). | – Nessun “cram-down”: non impone nulla ai non aderenti.<br>– Nessuna moratoria legale: possibili azioni dei creditori estranei/dissenzienti durante l’attuazione.<br>– Costo dell’attestatore e responsabilità per attestazioni mendaci (attenzione alla qualità del piano).<br>– Rischio che, se il piano fallisce, si debba comunque ricorrere a procedure concorsuali dopo (doppio passaggio). |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD, art. 57 e ss. CCII) | Procedura ibrida con omologa giudiziale | Il debitore, dopo aver raccolto adesioni ≥ 60%, chiede l’omologazione in tribunale | Coinvolgimento di creditori pari ad almeno il 60% dei crediti totali . Vincola aderenti; estranei esclusi (salvo estensioni a categorie dissenzienti al 75% finanziari o maggioranza fiscali) . | Tribunale omologa e può concedere misure protettive (stay delle azioni per max 120 gg) . Atti esecutivi protetti da revocatoria . | – Permette di bloccare i creditori durante l’omologa (tutela interinale) .<br>– Vincola i firmatari all’accordo (titolo esecutivo una volta omologato).<br>– Possibili cram-down su minoranza finanziatori (75%) e sul Fisco dissenziente .<br>– Atti e pagamenti protetti dalla revocatoria .<br>– Meno costoso e più rapido di un concordato; niente voto generale, solo adesioni mirate. | – Richiede consenso iniziale alto (60% crediti). Difficile se creditori molto numerosi/diversi.<br>– I creditori estranei devono essere soddisfatti fuori accordo (potenziale fabbisogno di cassa per pagarli integralmente).<br>– Pubblicità (registro imprese) e impatto reputazionale comunque presente, sebbene minore che in concordato.<br>– Comporta costi di attestazione e legali, sebbene minori del concordato (niente commissario, ma c’è l’attestatore e l’omologa). |
| Composizione negoziata (art. 17-25 CCII) | Procedura stragiudiziale assistita (volontaria) | Il debitore su base volontaria tramite piattaforma CCIAA. Esperto nominato. | Non c’è voto né adesioni predeterminate: è un percorso di trattativa. Eventuali accordi frutto della trattativa vanno formalizzati (piano attestato, accordo 57, concordato, ecc.) oppure restano accordi contrattuali privati. | Tribunale non coinvolto se non per misure protettive/cautelari e autorizzazioni. Procedura riservata (pubblica solo se richieste misure protettive). Linee guida ministeriali e OCC di supporto. | – Massima flessibilità: si esplorano varie soluzioni, nessuna preclusa.<br>– Riservatezza: niente iscrizione pubblica (salvo stay richiesto).<br>– Esperto indipendente aiuta a dialogare coi creditori (terzietà).<br>– Possibile ottenere stay temporaneo delle azioni (misure protettive) .<br>– Possibili autorizzazioni per finanziamenti urgenti prededucibili.<br>– Se fallisce, possibilità di concordato semplificato (liquidazione veloce senza voto). | – Non vincola i creditori dissenzienti: serve la buona volontà di tutti o quasi .<br>– L’esperto non può imporre accordi, funge solo da mediatore.<br>– I creditori potrebbero percepire l’adesione come segnale di crisi (rischio di revoca fidi se non gestita la riservatezza).<br>– Durata limitata (6 mesi +6). Se non si trova soluzione, si esce e bisogna ricorrere ad altro (concordato semplificato o fallimento).<br>– Necessita completa trasparenza del debitore: se emergono sotterfugi, l’esperto chiude la procedura. |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale (con voto creditori e omologa) | Il debitore (domanda volontaria; possibile “in bianco” con piano successivo) | Tutti i creditori concorsuali coinvolti. Votazione per classi (se previste) o per categorie legali. Approvazione se maggioranza in ogni classe (o maggioranza dei crediti ammessi se senza classi). Cram-down interclasse possibile a certe condizioni. | Tribunale supervisiona. Commissario giudiziale nominato. Misure protettive automatiche dalla domanda . Omologa con efficacia erga omnes (vincola dissenzienti). | – Blocca tutte le azioni dei creditori dalla presentazione (moratoria generale) .<br>– Debitore rimane in azienda (in continuità), sia pur vigilato, oppure cede attività in modo ordinato (liquidat.).<br>– Vincola tutti i creditori alla soluzione approvata a maggioranza (anche dissenzienti).<br>– Possibilità di trattamento differenziato per classi e stralci di crediti chirografari.<br>– Esonero da revocatorie per atti autorizzati nel concordato.<br>– Se in continuità, l’azienda può proseguire attività (salvaguardia avviamento e posti di lavoro). | – Procedura pubblica e costosa (onorari commissario, professionisti, spese di giustizia).<br>– Tempi medio-lunghi (diversi mesi per omologa).<br>– Gestione azienda soggetta a vincoli (atti straordinari autorizzati dal giudice).<br>– Requisiti legali stringenti: in liquidatorio occorre garantire almeno 20% ai chirografari (salvo apporto esterno) e soddisfare integralmente creditori privilegiati salvo degrado.<br>– Esito incerto: se il voto fallisce o l’omologa è negata, si va in liquidazione giudiziale.<br>– Impatto reputazionale significativo (clienti/fornitori possono perdere fiducia durante la procedura). |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) | Procedura concorsuale speciale post-composizione | Il debitore, entro 60 gg dall’esito negativo della composizione negoziata | Non c’è voto dei creditori. I creditori possono presentare osservazioni e opporsi all’omologa ma non decidono sul piano . | Tribunale valuta ammissibilità e convenienza per creditori. Nomina Liquidatore giudiziale (di regola il precedente esperto). Omologa con decreto (reclamabile). | – Consente una chiusura rapida della crisi liquidando i beni senza bisogno di maggioranze (utile quando la continuità non è possibile) .<br>– Niente voto: si risparmia tempo e sforzo del lobbying tra creditori.<br>– I creditori dissenzienti sono comunque vincolati se il tribunale omologa (basta dimostrare che ottengono non meno che in fallimento).<br>– Costi e tempi minori del concordato ordinario (procedura abbreviata). | – Accesso limitato: solo dopo composizione negoziata fallita e con attestazione dell’esperto che non c’erano soluzioni di continuità .<br>– Procedura liquidatoria pura: l’azienda viene venduta o cessata (niente ristrutturazione dell’attività, solo dei debiti).<br>– Creditori privati del voto possono essere molto ostili: possibili reclami e contenziosi in sede di omologa che rallentano.<br>– Sempre necessario confronto col tribunale sulla convenienza (controllo rigoroso per tutelare i creditori visto che non votano). |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria | Può essere chiesta dal debitore, creditori o d’ufficio (PM). Il tribunale la dichiara se c’è insolvenza. | N/A (creditori non decidono, ma partecipano al concorso presentando domande). Comitato creditori può dare pareri su atti di gestione. | Tribunale tramite Giudice Delegato e Curatore conduce la liquidazione. Forte tutela collettiva (par condicio). | – Debitore sollevato dalla gestione: ci pensa il Curatore (vantaggio psicologico ma non sostanziale).<br>– Tutte le azioni dei creditori sono bloccate e i debiti cristallizzati .<br>– Possibile, a fine procedura, ottenere l’esdebitazione per il debitore persona fisica (liberazione dai debiti residui) .<br>– Procedura standardizzata e gestita da professionista terzo (curatore) sotto controllo del tribunale: garantisce regolarità nelle operazioni di liquidazione. | – Spossessamento totale del debitore (perde la disponibilità dei beni).<br>– Cessazione o vendita dell’attività aziendale senza salvaguardia specifica della continuità (a meno di esercizio provvisorio deciso dal giudice, raro).<br>– Tempi lunghi spesso (anni per chiudere).<br>– Stigma e impatto reputazionale notevoli (anche se oggi un po’ mitigati rispetto al passato).<br>– Controlli e possibili azioni contro gli ex amministratori (revocatorie, azioni di responsabilità, denunce penali se emerse irregolarità).<br>– I creditori chirografari di solito recuperano percentuali minime (in media fallimenti pagano <10%). |
Tabella 2 – Obblighi e responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nella crisi d’impresa
| Soggetto | Doveri legali in situazione di crisi | Responsabilità civile potenziale | Responsabilità penale potenziale | Note difensive |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditore individuale | – Tenere contabilità regolare (registro imprese, scritture contabili) anche se piccolo imprenditore.<br>– Se emergono perdite o insolvenza, attivarsi per negoziare con creditori o presentare procedure concorsuali (non esiste obbligo formale immediato, ma il ritardo può aggravare il dissesto). | – Risponde con tutto il patrimonio personale dei debiti d’impresa.<br>– Azioni di responsabilità non previste (coincidendo l’imprenditore con l’impresa, non c’è distinzione di organi). Tuttavia, in fallimento il curatore può negare l’esdebitazione se l’imprenditore ha colposamente aggravato il danno ai creditori (giudizio di “meritevolezza”) . | – Bancarotta semplice se: aggravamento del dissesto per imprudenza o ritardo ingiustificato nell’istanza di fallimento; irregolarità nella tenuta dei libri contabili; ricorso al credito dissennato dopo insolvenza conclamata, ecc. (artt. 323-324 CCII).<br>– Bancarotta fraudolenta se: distrazione di beni, occultamento di attivo, esposizione di passivo inesistente, frode ai creditori, ecc. (artt. 322 e 330 CCII).<br>– Altri reati: false comunicazioni sociali (se impresa organizzata in forma societaria), delitti tributari per omessi versamenti, ecc. | – L’imprenditore individuale deve pensare a salvaguardare almeno i beni personali essenziali: la legge prevede che alcuni beni (es. casa coniugale se di proprietà di coniuge non fallito, stipendi futuri entro certi limiti) non siano toccati dal fallimento .<br>– Può difendersi da pretese eccessive dei creditori con la procedura di esdebitazione al termine (ottenibile anche subito se “meritevole” in caso di incapienza totale, art. 283 CCII). L’esdebitazione è un forte scudo post-chiusura: i crediti non pagati restanti vengono cancellati. |
| Socio di società di persone (SNC, SAS accomandatario) | – Rispondere illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (il socio accomandante invece ha responsabilità limitata e divieto di amministrazione attiva).<br>– In caso di perdita del capitale nelle SNC con capitale, analoghi obblighi degli amministratori di S.p.A. (anche se rara la figura del capitale sociale in SNC). | – I creditori sociali possono aggredire direttamente il patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile già durante la vita della società, dopo escussione del patrimonio sociale (art. 2268 c.c.).<br>– Se la società fallisce, falliscono anche tutti i soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F.). I soci falliti rispondono con i loro beni. | – Simile all’imprenditore individuale: bancarotta semplice o fraudolenta estese al socio fallito (che è equiparato a imprenditore per i fatti della società).<br>– Se il socio non aveva poteri gestori (es. socio non amministratore), la sua responsabilità penale è valutata caso per caso: potrebbe non rispondere di bancarotta attiva, ma risponde se ha concorso in eventuali distrazioni. | – Il socio illimitato deve considerare di separare il patrimonio familiare (es. fondo patrimoniale, trust) prima che la situazione degeneri, pur sapendo che atti in frode ai creditori possono essere revocati se troppo a ridosso.<br>– Può beneficiare dell’esdebitazione in proprio dopo il fallimento (come l’imprenditore individuale).<br>– Può evitare il fallimento personale uscendo dalla società prima dell’insolvenza e istruendo bene la pubblicità della sua cessazione di responsabilità (ma resta responsabile per le obbligazioni sorte prima). |
| Socio di società di capitali (S.r.l., S.p.A.) | – Versare integralmente i conferimenti sottoscritti (art. 2462 c.c. obbligo di conferimento).<br>– Non ingerirsi nella gestione attraverso atti di amministrazione di fatto (per non incorrere in responsabilità da amministratore di fatto).<br>– In caso di riduzione capitale sotto minimo legale, deliberare ricapitalizzazione o liquidazione (assemblea dei soci responsabile se non adempie). | – No responsabilità diretta per debiti sociali, salvo casi eccezionali (es. sottocapitalizzazione dolosa, confusione patrimonio, abuso forma societaria per frodare creditori: casi di possibile azione aquiliana ex art. 2043 c.c.).<br>– Responsabilità per conferimenti non effettuati o utili prelevati indebitamente (soci possono essere chiamati a restituire somme percepite a titolo di dividendi fittizi, finanziamenti postergati non restituiti, ecc.).<br>– Se socio ha assunto obbligazioni personali (fideiussioni, avalli): risponde su quelle secondo il titolo firmato, non in quanto socio ma come garante contrattuale. | – In genere nessuna, in quanto socio. I soci non amministratori non commettono reato fallimentare solo per il fatto di essere soci. <br>– Possibili responsabilità penali se il socio è amministratore di fatto (allora risponde come tale) o se ha concorso in reati con gli amministratori (es. ha beneficiato di distrazioni di beni sociali).<br>– Un caso particolare: se la società è usata come schermo per attività illecite, potrebbero configurarsi reati come bancarotta patrimoniale a carico dei soci che hanno svuotato l’azienda prima del fallimento (in concorso con gli amministratori). | – Il socio di S.r.l. può essere chiamato a versare i decimi non ancora versati sul capitale in caso di fallimento (il curatore li chiederà). Questo per chiudere eventuali finti crediti verso soci.<br>– Se la società fallisce, il socio perde il valore delle sue quote ma di regola non deve aggiungere altro. Quindi il socio non fallisce, ma potrebbe comunque subire danni indiretti: es. perdita di conferimenti, eventuali azioni revocatorie se ha ricevuto pagamenti dalla società (es. restituzione di finanziamenti soci entro 1 anno dalla procedura), ecc. |
| Amministratore / organo amministrativo (di S.p.A., S.r.l. o socio amministratore di fatto) | – Dovere di gestione prudente e informata nell’interesse della società (art. 2392 c.c.).<br>– Obbligo di istituzione di assetti organizzativi adeguati (art. 2086 c.c. co.2) per rilevare tempestivamente la crisi e attivare strumenti idonei.<br>– Obbligo di convocare assemblea senza indugio per deliberare provvedimenti su perdite rilevanti (artt. 2446-2447 c.c. per S.p.A., 2482-bis e ter c.c. per S.r.l.). Se capitale scende sotto minimo, proporre ricapitalizzazione o liquidazione.<br>– In caso di crisi conclamata: dovere di evitare nuova finanza distrattiva (non incrementare indebitamento se non coerente con tentativo di risanamento).<br>– Se insolvenza irreversibile: dovere (implicito) di richiedere concorsuale anziché aggravare (non c’è un termine fisso ma il ritardo espone a responsabilità). | – Azione sociale di responsabilità (art. 2476 c.c. Srl, 2393 c.c. Spa): se per atti o omissioni dolosi/colposi l’amministratore causa danni al patrimonio sociale (es. dissipazioni, gestione imprudente che riduce patrimonio), deve risarcire la società. In fallimento, la esercita il curatore ex art. 146 L.F. con approvazione del comitato creditori . <br>– Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c., ora assorbita in art. 2476 co. 3 c.c. per Srl): se per violazione degli obblighi di conservazione l’attivo risulta insufficiente, amministratori responsabili verso creditori insoddisfatti. In fallimento, la esperisce sempre il curatore (che cumula art. 146 L.F.).<br>– Criteri presuntivi art. 2486 c.c.: danno da gestione oltre causa scioglimento presumibile come differenza patrimonio netto o aumento indebitamento . <br>– Responsabilità verso terzi: es. verso un singolo creditore se, con dolo, l’amministratore lo ha leso (difficile; normalmente confluisce nell’azione del curatore). | – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: se sottrae, occulta, distrugge o distrae beni della società prima o durante fallimento (anche per favorire se stesso o altri creditori) .<br>– Bancarotta fraud. documentale: se falsa o occulta scritture contabili per ostacolare ricostruzione del patrimonio .<br>– Bancarotta semplice: se ha aggravato colposamente il dissesto (es. protraendo attività gravemente in perdita, non tenendo contabilità, non presentando tempestiva istanza fallimento, ecc.) .<br>– Ricorso abusivo al credito: amministratore che continua a fare debiti sapendo insolvente commette reato (configurato talora come bancarotta semplice, talora come truffa ai creditori; giurisprudenza punisce la condotta di chi “deteriora ulteriormente la situazione prendendo crediti ulteriori senza prospettive di rimborso” ).<br>– Altri reati societari/tributari: false comunicazioni sociali (se bilanci falsati per coprire stato dissesto), omessi versamenti IVA/contributi oltre soglie penali, ecc. | – Buona norma: appena emerse perdite rilevanti, informare organo di controllo e soci, e adottare misure (piano risanamento, aumento capitale o procedura concorsuale). I verbali e le comunicazioni sono prova di attivazione.<br>– Dotarsi di sistemi di allerta interni (indicatori di crisi) per poter dimostrare di aver fatto il possibile per rilevare tempestivamente gli squilibri . Ciò può proteggere contro accuse di negligenza.<br>– In crisi, privilegiare pagamenti che mantengono vivo il valore (stipendi, forniture essenziali) e astenersi da atti extra-ordinari non autorizzati (questo evita contestazioni di distrazione o preferenze).<br>– Documentare ogni scelta (advisor report, pareri) per provare l’intento di risanare (la Cassazione tollera tentativi di salvataggio anche se falliti, purché non manifestamente imprudenti).<br>– Se inevitabile, chiedere il fallimento in proprio invece di aspettare: storicamente attenua le colpe e può evitare imputazioni di aggravamento doloso.<br>– Ricordare che l’assicurazione D&O (responsabilità civile amministratori) può coprire in parte i danni civili (non quelli penali o per dolo). Curatore spesso cita anche per far valere la polizza. |
| Sindaco/Revisore/OdV (organi di controllo) | – Dovere di vigilanza costante sull’andamento e sugli assetti dell’ente (art. 2403 c.c. per collegio sindacale; art. 14 CCII per revisore).<br>– Se rilevano segnali di crisi, obbligo di segnalazione agli amministratori (invito a attivarsi). Devono indicare in che termini la società è a rischio e sollecitare rimedi (art. 15 CCII, temporaneamente sospeso ma principio valido).<br>– Se amministratori inerti, sindaci/revisori devono informare l’OCRI (nel previgente schema) o comunque l’autorità competente (oggi, segnalazione all’OCC/composizione negoziata se attiva). In alcuni casi possono/devono comunicare al tribunale ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità. | – Possono essere chiamati in solido con gli amministratori nella azione di responsabilità se omissivi: art. 2407 c.c. prevede che rispondano dei danni derivati dalla mancata vigilanza. In fallimento il curatore spesso cita sindaci se le condotte distrattive sono avvenute sotto il loro sguardo silente. Anche i revisori possono essere citati se non hanno segnalato tempestivamente lo stato di crisi nei loro report. Esempi: caso Cirio, condannati sindaci per non aver impedito distrazioni . | – Non hanno specifici reati fallimentari “ad personam”, ma possono rispondere per concorso in bancarotta degli amministratori se, ad esempio, erano consapevoli di frodi e le hanno coperte. O ancora, se attestano il falso (il sindaco che redige relazione ex art. 2429 c.c. infedele, il revisore che certifica bilancio falso – possibili concorsi in false comunicazioni).<br>– In generale, per configurare un reato a carico del controllore occorre provare il dolo di partecipare all’illecito (non basta l’omissione colposa). Quindi penalmente di solito rispondono solo nei casi di collusione attiva con gli amministratori infedeli. | – Per sindaci e revisori la miglior difesa è essere diligenti e verbalizzare/scrivere. Se incontrano resistenze dagli amministratori, far risultare a verbale di aver chiesto di intervenire. Se la crisi peggiora, meglio essere loro a far partire la segnalazione/composizione che essere accusati poi di inerzia.<br>– Possono anche dimettersi se vengono impediti nel loro ruolo (anche se questo non li esonera da tutte le colpe pregresse, perlomeno li sottrae a quelle future).<br>– Una volta aperta una procedura, il curatore valuterà il loro operato: sindaci e revisori dovrebbero collaborare e fornire le carte, e magari anche farsi parte attiva per proporre soluzioni (es. piani), così da dimostrare la loro buona fede. |
| Attestatore indipendente (professionista ex art. 13 CCII per piani/accordi) | – Dovere di indipendenza sostanziale dal debitore e dai creditori (no conflitti, no legami negli ultimi 5 anni) .<br>– Dovere di verifica scrupolosa dei dati aziendali e delle ipotesi del piano: applicare i Principi di attestazione (CNDCEC). In relazione, dichiarare veridicità dati e giudizio su fattibilità con spiegazione dettagliata .<br>– Segnalare nel caso il piano sia manifestamente irrealistico (in tal caso dovrebbe negare l’attestazione; se invece fornisce attestazione positiva nonostante inettitudine, è violazione). | – Responsabilità civile verso vari soggetti in caso di negligenza: può risponderne verso la società (che ha fatto affidamento su una relazione malfatta), verso i creditori (se hanno subito danno perché hanno creduto al piano asseverato che poi era infondato) e verso eventuali terzi investitori. Spesso l’azione è del curatore fallimentare che li cita per concorso nel danno da dissesto aggravato (vedi caso Trib. Roma, condannato attestatore colpevole insieme all’amministratore ).<br>– Molti attestatori sottoscrivono polizze RC professionale proprio per tutelarsi da queste azioni. | – Falso in attestazioni (art. 324 CCII, prima art. 236-bis L.F.): se l’attestatore “attesta false informazioni o omette di riferire informazioni rilevanti” nella relazione, è punibile con reclusione 2-5 anni. È un reato proprio dell’attestatore, che prescinde dall’esito (anche se poi il piano non va in porto, lui risponde per l’atto in sé).<br>– Può concorrere in bancarotta fraudolenta se con la sua relazione dolosamente favorisce gli amministratori nel portare avanti un piano che nasconde frodi. Cass. pen. 36401/2023 sottolinea che l’attestatore deve rispettare regole di diligenza professionale, altrimenti può configurarsi concorso in bancarotta (es: attestatore “compiacente” che avalla operazioni distrattive spacciandole per ordinarie) . | – L’attestatore deve curare moltissimo la relazione: evitare frasi di mero stile e sostanziare le conclusioni con analisi e test di sensitività. Una relazione robusta è anche la sua difesa in tribunale se qualcosa va storto: potrà dire “il mio giudizio era basato su X, Y, Z; l’evento imprevisto K ha mandato fuori strada il piano”.<br>– Mantenere un file di lavoro completo con evidenze di tutte le verifiche fatte (corrispondenza, check-list, calcoli) per dimostrare di aver operato professionalmente. In caso di contestazioni, poter esibire il lavoro svolto è cruciale.<br>– Non farsi “tirare per la giacchetta” dal debitore: se il piano non è credibile, rifiutare l’incarico o dare esito negativo. Meglio perdere la parcella che rischiare una causa o un’accusa penale. |
| Esperto composizione negoziata | – Dovere di imparzialità e terzietà: pur essendo nominato su istanza del debitore, deve ascoltare anche gli interessi dei creditori.<br>– Dovere di riservatezza su informazioni acquisite (salvo consentite condivisioni per le trattative).<br>– Facilitare la comunicazione: convocare le parti, proporre soluzioni creative, verificare l’attuabilità delle proposte (può chiedere al debitore eventuali aggiustamenti).<br>– Redigere relazioni periodiche sull’andamento delle trattative e una relazione finale con esito (positivo o negativo) e valutazioni. Deve segnalare se il debitore compie atti pregiudizievoli durante il periodo. | – L’esperto non prende decisioni vincolanti, quindi la sua responsabilità civile è rara. Però potrebbe rispondere di danno contrattuale verso il debitore se svolge male il compito (es. non rispetta i tempi e l’impresa perde un affare). Più concretamente potrebbe rispondere verso i creditori se per dolo o colpa grave li induce in errore – scenario limite: se certifica una situazione rosea per far guadagnare tempo al debitore e i creditori subiscono maggior danno. In tal caso potrebbero tentare un’azione per far valere la sua imperizia.<br>– Essendo nominato da commissione CAMCOM, rientra nel sistema ADR: in caso di gravi inadempimenti può essere revocato o sostituito. | – Nessun ruolo penale diretto. Se però l’esperto favorisce operazioni distrattive, potrebbe essere accusato di concorso in bancarotta (es: consiglia al debitore di vendere sottocosto a un certo soggetto, con retroscena di favore). Deve quindi stare attento a non oltrepassare il ruolo neutrale.<br>– L’esperto, se pubblico ufficiale (qualifica non esplicita ma probabile), se omette di denunciare reati di cui venga a conoscenza (es. evidenti distrazioni emerse) potrebbe rischiare l’omissione di denuncia (art. 361 c.p.). Ma il suo mandato è confidenziale, questione complessa: la legge gli impone solo di segnalare al tribunale eventualmente atti pregiudizievoli per misure protettive. | – L’esperto deve operare con trasparenza procedurale: convocare tutte le parti rilevanti, mettere a verbale le proposte, formalizzare le eventuali divergenze. Così, se le cose vanno male, potrà mostrare di aver fatto il possibile.<br>– Se il debitore non collabora o trucca le carte, l’esperto può chiudere la procedura. È meglio andarsene che essere complici di un eventuale gioco sporco. Questo lo tutela da possibili rimostranze future (“io esperto ho constatato mancanza di sincerità e ho archiviato”).<br>– L’esperto ha a disposizione linee guida e best practice: seguirle fedelmente lo mette al riparo da critiche di condotta anomala. Esempio: rispettare timeline di convocazione, non avere incontri separati non trasparenti, ecc. |
Conclusione
Affrontare una grave crisi debitoria in un’impresa di produzione chimica e detergenti – o in qualsiasi altro settore – è una sfida multidisciplinare che richiede tempestività, competenza e trasparenza. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, aggiornato alle ultime riforme del 2022-2024, mette a disposizione dei debitori onesti una gamma di strumenti che, se ben utilizzati, possono evitare gli scenari peggiori. Il filo conduttore di questo nuovo approccio normativo è la valorizzazione della gestione attiva della crisi da parte dell’imprenditore: non più aspettare passivamente il “fallimento”, ma prendere in mano la situazione – che sia attraverso un accordo stragiudiziale con i creditori chiave, un piano di risanamento attestato che dia respiro all’azienda, una composizione negoziata assistita per sondare tutte le opzioni possibili o, se necessario, un concordato preventivo per imporre una soluzione a maggioranza. In ogni caso, la legge premia il debitore diligente: colui che si attiva presto potrà beneficiare di protezioni (come il blocco delle esecuzioni), di esenzioni (come la non revocabilità degli atti in caso di piano attestato valido), di maggiori chance di conservare la propria impresa (tramite continuità aziendale nei concordati) e infine di “ripulirsi” dai debiti passati (tramite esdebitazione).
D’altro canto, l’ordinamento – supportato da una giurisprudenza sempre più attenta – sanziona il debitore o l’organo gestore che aggrava colposamente o dolosamente la situazione. Le sentenze richiamate mostrano tolleranza zero verso gli amministratori che, invece di agire responsabilmente, scelgono la strada dell’occultamento, del rinvio ingiustificato, o peggio dell’azzardo morale (continuare a fare debiti sperando in un’improbabile salvataggio). Anche i professionisti e gli organi di controllo hanno compiti cruciali e possono rispondere se mancano ai loro doveri.
Dal punto di vista pratico, per un imprenditore indebitato “difendersi” significa anzitutto conoscere i propri diritti e doveri nel contesto della crisi. Significa circondarsi di consulenti esperti, finanziari e legali, per valutare con lucidità le opzioni. Significa dialogare con i creditori in modo proattivo – spesso un creditore è più disposto a trovare un compromesso se vede dall’altra parte un debitore organizzato, con un piano credibile sul tavolo, piuttosto che se deve inseguire un debitore latitante. Significa anche saper cambiare mentalità: ad esempio accettare che un’eventuale liquidazione dell’azienda non è la “fine del mondo” ma può essere gestita in modo ordinato per poi ripartire puliti con nuove iniziative (il diritto al fallimento onesto come nuovo inizio, sancito dal Codice ). La legge oggi consente persino – con il concordato semplificato – di chiudere una partita fallimentare senza subire lo stigma del fallimento classico, a patto di aver tentato il possibile.
In definitiva, il consiglio finale per l’imprenditore debitore è: non isolarti e non ignorare la crisi. Usa gli strumenti normativi come scudo e come mezzo di negoziazione. Ogni situazione di crisi è diversa, ma le strategie di successo hanno in comune la trasparenza verso gli stakeholder, la pianificazione attenta (anche con scenari pessimistici) e l’utilizzo intelligente delle leve legali disponibili (dalle misure protettive, agli accordi parziali, ai piani attestati per mettere in sicurezza operazioni cruciali, fino alle transazioni fiscali e alle classi di voto nei concordati). Se farai ciò, avrai fatto tutto il possibile per “difenderti” – difendere la tua impresa e anche te stesso – dagli esiti più nefasti. Come recita un adagio, “Hope for the best, prepare for the worst”: spera nel meglio (un rilancio aziendale) ma prepara le mosse come se il peggio (la liquidazione) potesse arrivare domani. Così facendo, qualsiasi sia l’esito, potrai voltarti indietro e dire di aver agito con professionalità e buona fede, evitando errori che altri in passato hanno pagato cari . E grazie a ciò, potrai avere la possibilità – una volta lasciata alle spalle la crisi odierna – di rilanciare l’attività su basi sane o di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali, senza “fantasmi” di vecchi debiti ad inseguirti, in linea con lo spirito stesso delle più recenti riforme.
Gestisci un’impresa che produce detergenti, prodotti per la pulizia o sostanze chimiche industriali e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori, dipendenti o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci un’impresa che produce detergenti, prodotti per la pulizia o sostanze chimiche industriali e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori, dipendenti o Agenzia delle Entrate?
Hai mutui, leasing per macchinari o impianti, cartelle esattoriali o contributi INPS arretrati, e temi pignoramenti, blocchi bancari o la chiusura dell’attività?
👉 Non farti sopraffare: la legge oggi ti consente di bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti, e salvare o chiudere la tua azienda in modo legale, senza fallire.
In questa guida scoprirai perché le imprese chimiche e di detergenza finiscono in crisi, quali soluzioni legali puoi utilizzare, e come difenderti per ottenere una vera ripartenza economica.
🧪 Perché le imprese chimiche e dei detergenti si indebitano
Il settore chimico e della produzione di detergenti è complesso, regolamentato e ad alto investimento. Le principali cause di indebitamento sono:
- Aumento dei costi delle materie prime e dei componenti chimici;
- Incremento dei costi energetici e di smaltimento rifiuti;
- Ritardi nei pagamenti di grossisti, distributori o GDO;
- Mutui e leasing onerosi per impianti e macchinari industriali;
- Controlli fiscali o ambientali con sanzioni elevate;
- Margini ridotti a causa della concorrenza estera e dei grandi marchi;
- Errori di gestione contabile o fiscale.
📌 Questi fattori portano molte aziende del settore a non riuscire più a sostenere i costi di produzione e le imposte, generando debiti fiscali, bancari e commerciali che possono bloccare completamente l’attività.
🧾 Tipologie di debiti più comuni nel settore chimico e dei detergenti
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IVA, IRPEF, IRAP, INPS, INAIL, TARI, cartelle esattoriali e accertamenti.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Mutui e leasing per impianti di produzione, serbatoi, linee di confezionamento, veicoli o capannoni.
- Scoperti di conto o fidi bancari revocati.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori di materie prime, imballaggi, logistica o trasporto.
✅ Debiti verso dipendenti e collaboratori
- Stipendi arretrati, contributi non versati, TFR, vertenze sindacali.
✅ Debiti personali o fideiussioni
- Garanzie firmate da soci o amministratori per mutui o finanziamenti aziendali.
⚠️ Cosa rischia un’impresa chimica indebitata
Se la situazione non viene affrontata in tempo, i creditori possono:
- pignorare conti correnti, mezzi di produzione e capannoni;
- bloccare forniture essenziali di energia o materie prime;
- revocare leasing o linee di credito bancarie;
- emettere cartelle e decreti ingiuntivi;
- compromettere la licenza ambientale o di produzione.
👉 Tuttavia, la legge oggi ti permette di fermare tutto, ristrutturare i debiti, e continuare a produrre o chiudere legalmente l’attività, senza perdere tutto ciò che hai costruito.
🧩 Le soluzioni legali per imprese chimiche e di detergenza con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Con il supporto di un avvocato puoi ottenere:
- riduzioni consistenti (saldo e stralcio);
- rateizzazioni sostenibili, calibrate sui ricavi effettivi;
- sospensioni temporanee dei pagamenti.
👉 È la soluzione più immediata per chi vuole mantenere attiva la produzione e salvare i rapporti con i fornitori.
💠 2. Concordato minore (per SRL e società di produzione)
È la procedura prevista dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) per aziende strutturate.
Permette di:
- bloccare immediatamente pignoramenti e riscossioni;
- ridurre legalmente i debiti fiscali e bancari;
- continuare l’attività produttiva e i contratti commerciali.
📌 È la soluzione ideale per le società che vogliono rimettersi in carreggiata e salvaguardare i dipendenti.
💠 3. Procedura di sovraindebitamento (per ditte individuali e microimprese)
Riservata a piccole imprese e produttori artigianali.
Consente di:
- bloccare pignoramenti, cartelle e azioni dei creditori;
- proporre un piano di rientro parziale e realistico;
- ottenere la cancellazione definitiva dei debiti residui (esdebitazione).
📌 Perfetta per imprese familiari o laboratori artigiani di detergenti e prodotti per la pulizia.
💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)
Se la tua attività non è più sostenibile, puoi chiudere in modo ordinato e protetto, mettendo a disposizione solo i beni non indispensabili (impianti obsoleti, veicoli, scorte di magazzino).
Alla fine, il Tribunale concede la cancellazione di tutti i debiti residui, permettendoti di ripartire senza pendenze fiscali o bancarie.
💠 5. Verifica e contestazione di cartelle e accertamenti fiscali
Molte aziende del settore chimico ricevono cartelle esattoriali errate o prescritte.
Un avvocato può:
- controllare la prescrizione (5 o 10 anni);
- eccepire errori di calcolo o notifiche irregolari;
- chiedere la sospensione o l’annullamento del debito.
🧴 Cosa fare subito
✅ 1. Raccogli tutta la documentazione aziendale e contabile
Prepara cartelle, contratti di leasing, mutui, bilanci, fatture e contratti con fornitori e clienti.
✅ 2. Blocca subito le azioni dei creditori
Con il deposito in Tribunale di una procedura legale (concordato o sovraindebitamento), pignoramenti e riscossioni vengono sospesi immediatamente.
✅ 3. Evita di accendere nuovi finanziamenti o accordi improvvisati
Molte rateizzazioni “veloci” aggravano la crisi. Serve una strategia legale completa, approvata dal Tribunale.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale del titolare o rappresentante legale.
- Visura camerale e bilanci societari.
- Dichiarazioni fiscali e posizione INPS/INAIL.
- Contratti di leasing, mutui e finanziamenti.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori, clienti e spese di produzione.
- Estratti conto bancari e situazione patrimoniale.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e pianificazione legale: 1–3 settimane.
- Deposito della procedura: 1–2 mesi.
- Blocco dei creditori: immediato con il deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Stop a pignoramenti, cartelle e ipoteche.
- Riduzione o cancellazione legale dei debiti.
- Tutela degli impianti e della continuità produttiva.
- Ripartenza economica e reputazionale dell’impresa.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni dei creditori.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Continuità della produzione durante la procedura.
✅ Tutela di impianti, personale e contratti commerciali.
✅ Possibilità di chiudere l’attività in modo ordinato e ripartire da zero.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o notifiche fiscali.
- Accumulare nuovi debiti per coprire quelli vecchi.
- Vendere beni aziendali senza tutela legale.
- Affidarsi a “consulenti del debito” non avvocati o non qualificati.
- Rimandare troppo: agire presto è l’unico modo per evitare danni irreversibili.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la situazione economica e fiscale della tua impresa chimica.
📌 Ti guida nella scelta tra rinegoziazione, sovraindebitamento, concordato o liquidazione controllata.
✍️ Redige e deposita il piano in Tribunale per bloccare immediatamente i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche, leasing, fornitori e dipendenti.
🔁 Ti accompagna fino alla cancellazione definitiva dei debiti o alla ristrutturazione completa dell’attività produttiva.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di imprese chimiche e manifatturiere con debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere un’impresa di fabbricazione di prodotti chimici e detergenti con debiti non significa dover fermare la produzione.
Con una difesa legale mirata e tempestiva, puoi bloccare i creditori, ridurre drasticamente i debiti fiscali e finanziari, e continuare a operare in modo legale e sostenibile, oppure chiudere l’attività in modo protetto e senza rischi.
La legge oggi tutela chi agisce con trasparenza e vuole davvero ripartire.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova formula di libertà dai debiti comincia oggi.