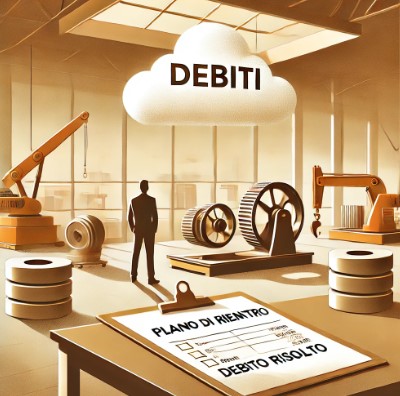Gestisci un’impresa di produzione o assemblaggio di macchinari industriali e ti trovi in difficoltà economica a causa di debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche? È una situazione diffusa nel settore manifatturiero, dove l’aumento dei costi, i ritardi nei pagamenti e le difficoltà di accesso al credito hanno messo sotto pressione anche le aziende più strutturate. Quando si accumulano cartelle esattoriali, rate di mutui o leasing non pagate, il rischio di blocchi produttivi e pignoramenti diventa concreto. La buona notizia è che la legge offre strumenti legali efficaci per rateizzare, ristrutturare o cancellare i debiti, consentendo di salvare l’impresa e proteggere il patrimonio dell’imprenditore.
Perché molte aziende del settore macchine industriali si indebitano
Le imprese che producono o assemblano macchinari per l’industria affrontano una pressione economica costante. I costi per materie prime, energia, trasporto e manodopera sono cresciuti, mentre i margini si sono ridotti. I clienti — spesso grandi aziende — impongono tempi di pagamento lunghi, creando squilibri di liquidità. A ciò si aggiungono i ritardi nella riscossione dei crediti e l’aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti. Molte imprese, per mantenere la produzione, rinviano i versamenti fiscali o previdenziali o contraggono nuovi prestiti, accumulando interessi, sanzioni e debiti che col tempo diventano insostenibili.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Quando le imposte o i contributi non vengono versati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono avviare procedure di recupero forzato. Le più frequenti sono la notifica di cartelle esattoriali, i pignoramenti dei conti correnti o dei crediti verso clienti, le ipoteche sugli immobili aziendali, i sequestri dei beni o i fermi amministrativi sui veicoli. Gli importi aumentano nel tempo per effetto di interessi e sanzioni, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria. Se la tua è una ditta individuale o una società di persone, rispondi personalmente dei debiti, con il rischio di compromettere anche i beni familiari.
Cosa fare subito se la tua impresa ha debiti
Il primo passo è ottenere un quadro completo della situazione. Richiedi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo aggiornato per conoscere l’importo totale, gli anni di riferimento e i creditori coinvolti. Poi verifica la validità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica, importi prescritti o somme non dovute che un avvocato può contestare. Se i debiti sono legittimi, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo nel frattempo eventuali azioni esecutive. È utile anche controllare se è attiva una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale eliminando sanzioni e interessi. In caso di pignoramenti o ipoteche già avviate, un ricorso o un’istanza di autotutela può portare alla sospensione immediata delle procedure.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se la situazione debitoria è diventata troppo pesante e la tua azienda non riesce più a sostenere i costi, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È una procedura legale che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui (esdebitazione). Si tratta di uno strumento riconosciuto dai tribunali italiani e pensato per piccole e medie imprese che vogliono risanarsi o chiudere in modo ordinato, senza lasciare pendenze fiscali o bancarie.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molte imprese del settore macchinari industriali hanno debiti con banche, società di leasing o fornitori di componenti e materie prime. In questi casi puoi chiedere la rinegoziazione dei contratti, la sospensione temporanea dei pagamenti o proporre un saldo e stralcio per chiudere le posizioni a importo ridotto. È anche possibile contestare clausole abusive o tassi usurari nei contratti e impugnare decreti ingiuntivi o pignoramenti entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nelle trattative con banche e creditori, proteggendo i macchinari, i capannoni e i beni indispensabili per la produzione.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Con una strategia legale tempestiva puoi sospendere pignoramenti e riscossioni, ottenere la rateizzazione o cancellazione dei debiti, proteggere gli impianti e i beni aziendali, evitare la chiusura dell’attività e ripartire con un piano sostenibile. In molti casi è possibile salvare l’impresa, mantenere i contratti in corso e garantire la continuità produttiva, senza interrompere la catena di forniture e rapporti commerciali.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
È fondamentale rivolgersi a un avvocato se hai ricevuto cartelle o intimazioni di pagamento, se i debiti fiscali, contributivi o bancari sono diventati insostenibili o se rischi il pignoramento dei conti e dei beni aziendali. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa può contestare le cartelle illegittime, bloccare la riscossione e accompagnarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire subito è l’unico modo per salvare l’azienda e tutelare la tua reputazione professionale.
⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o gli avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, blocchi dei conti e fermo della produzione. Intervenire subito è essenziale per salvare la tua impresa e difendere i tuoi beni.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle imprese manifatturiere – spiega cosa fare se gestisci un’impresa di fabbricazione di macchinari per l’industria con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che stanno mettendo a rischio la tua azienda di macchinari industriali?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Un’impresa manifatturiera nel settore della fabbricazione di macchinari industriali può trovarsi a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento o crisi finanziaria. Tale condizione – caratterizzata dall’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte – richiede interventi tempestivi e mirati. La normativa italiana, aggiornata al settembre 2025, ha introdotto strumenti avanzati per la gestione e la composizione della crisi d’impresa, nell’ottica di favorire il risanamento quando possibile e al contempo tutelare i creditori . Questa guida – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati interessati al tema – fornirà un quadro approfondito sulle opzioni disponibili per un’azienda industriale indebitata, con un linguaggio tecnico-giuridico ma di taglio divulgativo.
Esamineremo innanzitutto le diverse tipologie di debiti aziendali (fiscali, bancari, verso fornitori, previdenziali, ecc.) e le loro conseguenze. Verranno poi illustrati i principali strumenti di difesa e risanamento dal punto di vista del debitore: soluzioni stragiudiziali (ad esempio piani di risanamento attestati) e procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti, liquidazione giudiziale, ecc.), incluse le novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Saranno presentate anche le norme sull’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) e le strategie difensive per l’imprenditore che vuole proteggere il proprio patrimonio e la continuità aziendale.
All’interno della guida troverete tabelle riepilogative per una consultazione rapida, una sezione di domande e risposte frequenti (FAQ) sui dubbi più comuni, nonché casi pratici (simulazioni) di gestione della crisi applicati al contesto italiano. Tutte le fonti normative, le sentenze più aggiornate (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, ecc.) e i riferimenti utilizzati sono indicati nel testo e raccolti in fondo alla guida, in modo da garantire la massima trasparenza e consentire eventuali approfondimenti . L’obiettivo è fornire al debitore una mappa chiara di “cosa fare e come difendersi” quando i debiti diventano insostenibili, aiutandolo a prendere decisioni informate e a valutare le soluzioni legali più adatte al proprio caso.
Tipologie di debiti aziendali e relative conseguenze
Una società produttrice di macchinari per l’industria può accumulare debiti di varia natura. È fondamentale distinguere le tipologie di debito, poiché ciascuna comporta rischi e rimedi specifici. Di seguito esaminiamo le categorie principali:
- Debiti fiscali (Erario e Agenzia Entrate Riscossione) – Comprendono imposte dovute allo Stato (es. IVA, IRES, IRAP) e altre tasse. Se l’impresa omette i versamenti tributari, oltre a interessi e sanzioni amministrative, rischia l’intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), che procede alla riscossione coattiva (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) tramite le cosiddette cartelle esattoriali. La legge prevede che dopo la notifica di una cartella il debitore abbia 60 giorni per pagare o chiedere una rateizzazione; decorso tale termine senza adempimento, l’AER può attivare misure esecutive sul patrimonio aziendale. I debiti tributari sono spesso privilegiati: ciò significa che in caso di procedura concorsuale, lo Stato verrà soddisfatto con precedenza rispetto ai crediti chirografari (non garantiti). Inoltre, per alcuni debiti fiscali sono previste sanzioni penali: ad esempio, l’omesso versamento IVA superiore alla soglia di legge (oggi €75.000 per periodo d’imposta, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 ) costituisce reato punibile con la reclusione. La riforma del 2024 ha introdotto una causa di non punibilità se il contribuente dimostra di aver attivato tempestivamente un piano di rateizzazione e di non essere decaduto da esso . Tuttavia, la semplice crisi di liquidità non esonera dall’obbligo penale: la Cassazione ha ribadito che le difficoltà finanziarie d’impresa non configurano forza maggiore e non eliminano il dolo nel reato di omesso versamento IVA, poiché la scelta di pagare altri oneri (es. fornitori o stipendi) invece delle imposte è considerata una deliberata allocazione delle risorse, non una giustificazione legale . In altri termini, la crisi di liquidità è un rischio intrinseco dell’attività imprenditoriale e non esclude la responsabilità penale per il mancato pagamento di imposte dovute . È dunque fondamentale, per evitare conseguenze penali, attivarsi prontamente in caso di debiti fiscali scaduti, ad esempio chiedendo piani di rientro o aderendo a eventuali definizioni agevolate previste per legge (come le “rottamazioni” delle cartelle esattoriali). Infine, è bene ricordare che l’apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.) comporta il blocco delle azioni esecutive individuali dei creditori, inclusa l’Agenzia Riscossione, ma non cancella il debito fiscale salvo che intervenga un pagamento parziale concordato (transazione fiscale) o l’esdebitazione finale del debitore. I crediti tributari non soddisfatti integralmente nella procedura concorsuale torneranno esigibili verso il debitore una volta cessata la procedura, a meno che quest’ultimo ottenga il beneficio dell’esdebitazione .
- Debiti previdenziali e contributivi (INPS e INAIL) – Riguardano i contributi obbligatori dovuti per i lavoratori dipendenti e le altre posizioni previdenziali. Il mancato versamento dei contributi comporta sanzioni civili (maggiorazioni e interessi di mora) e può implicare conseguenze penali. In particolare, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti è sanzionato penalmente se l’importo non versato supera €10.000 annui . Al di sotto di tale soglia, la violazione costituisce illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria. Anche per i contributi, la normativa concede un breve periodo per regolarizzare: il datore di lavoro che provvede a versare le ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o notifica della violazione evita la punibilità penale. Superato tale termine, se l’omissione eccede €10.000, scatta il reato. La giurisprudenza ha chiarito che l’eventuale crisi di impresa non esime l’imprenditore da responsabilità: salvo casi eccezionali, lo stato di difficoltà economica non costituisce “forza maggiore” sufficiente ad escludere il dolo nei reati omissivi tributari o contributivi . In ogni caso, l’INPS si avvale anch’esso dell’Agenzia Entrate Riscossione per il recupero coattivo dei crediti contributivi tramite cartelle. Un aspetto pratico rilevante è il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): la presenza di debiti contributivi normalmente impedisce il rilascio del DURC, precludendo all’impresa l’accesso ad appalti pubblici, finanziamenti e agevolazioni. Tuttavia, in situazioni particolari la legge consente un’esenzione temporanea: ad esempio, la Cassazione ha confermato che durante il concordato preventivo l’azienda è dispensata dal presentare il DURC per ottenere contributi pubblici, poiché il divieto di pagamento dei debiti contributivi imposto dalla procedura la pone in una condizione di regolarità “legale” fino all’omologa .
- Debiti bancari e finanziari – Molte imprese produttrici di macchinari si finanziano tramite mutui, leasing, aperture di credito in conto corrente o altri prestiti bancari. In caso di insolvenza, le banche vantano spesso garanzie reali (ipoteche su immobili, pegni su macchinari o su beni in leasing) o personali (fideiussioni dei soci o degli amministratori). Il mancato pagamento delle rate o degli interessi porta alla decadenza dal beneficio del termine e all’immediata esigibilità dell’intero debito residuo. La banca potrà agire giudizialmente per il recupero: ad esempio, avviare un’azione esecutiva sui beni ipotecati (espropriazione immobiliare) o sui beni aziendali pignorabili. Se vi sono garanti personali, l’istituto di credito inadempiuto può escutere anche il patrimonio di tali garanti, con possibili gravi ricadute sugli imprenditori sul piano personale. Bisogna considerare inoltre che un credito bancario impagato incide sull’affidabilità creditizia dell’azienda (rating) e spesso determina la revoca degli affidamenti e delle linee di credito ancora attive, aggravando la crisi di liquidità. Le banche figurano tra i creditori che più frequentemente presentano istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) contro l’impresa insolvente: è sufficiente un credito certo, scaduto e non pagato – usualmente di importo rilevante – perché la banca richieda al tribunale la dichiarazione di insolvenza. In un tale scenario, il punto di vista del debitore impone un’azione preventiva: è spesso preferibile negoziare con la banca una moratoria o una ristrutturazione del debito (ad esempio attraverso un accordo ex art. 67 o 182-bis L.F., oggi confluiti nel Codice della Crisi) piuttosto che attendere misure unilaterali. Inoltre, la legge bancaria e fallimentare proteggono in parte le banche tramite cause di prelazione: i crediti bancari assistiti da garanzie reali godono di privilegio speciale o diritto di prelazione sul ricavato dei beni oggetto di garanzia. Dunque, in un’eventuale procedura concorsuale, tali crediti verranno soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati (es., una macchina utensile concessa in leasing potrà essere ripresa dalla società di leasing, un immobile ipotecato venduto per pagare la banca fino a concorrenza del credito garantito). Va segnalato che i tassi di interesse moratori applicati dalle banche in caso di insolvenza possono essere molto elevati, ma non devono superare i limiti dell’usura; l’imprenditore debitore ha diritto di contestare in giudizio eventuali interessi usurari o anatocistici, se presenti, per farli annullare o ridurre. In definitiva, i debiti verso banche richiedono un approccio proattivo: mantenere il dialogo aperto con l’istituto, valutare piani di rientro sostenibili o concordati preventivi, e considerare l’impatto di ogni decisione sul proprio patrimonio personale (soprattutto in presenza di garanzie personali). Un’azione tempestiva può evitare la spirale che porta alla revoca dei fidi e al default conclamato.
- Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari – Si tratta dei debiti commerciali dell’impresa: fatture non pagate a fornitori di materie prime, componenti, servizi, bollette di utenze, canoni di locazione del capannone, ecc. Questi creditori chirografari (senza garanzie) sono spesso i primi a risentire della crisi di liquidità dell’azienda, che tende a ritardare i pagamenti lungo la filiera. I fornitori possono tutelarsi sospendendo le forniture (se il contratto glielo consente, ad esempio invocando eccezione di inadempimento) o richiedendo pagamenti anticipati. Alcuni contratti di fornitura includono clausole di ritenzione della proprietà (riserva di proprietà) fino al pagamento integrale: in tali casi, se la società non paga, il fornitore può rivendicare la restituzione dei beni forniti (ad esempio macchinari o componenti) che siano ancora individuabili. In assenza di garanzie specifiche, il fornitore insoluto può agire giudizialmente per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento, eventualmente provvisoriamente esecutivo, e quindi procedere con il pignoramento dei beni sociali (beni mobili d’azienda, crediti verso clienti, ecc.) oppure istituire un’azione monitoria mirata (ad esempio il pignoramento presso terzi, colpendo cassa e conti correnti). Spesso i fornitori agiscono anche in via cautelare con il sequestro conservativo di beni del debitore, ove temano di perdere la garanzia generica del patrimonio. Un singolo creditore chirografo può inoltre presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se dimostra lo stato d’insolvenza dell’impresa: benché la legge indichi parametri dimensionali per l’accesso alle procedure concorsuali (vedi oltre), nella pratica anche fornitori medio-piccoli si sono talora consorziati per chiedere il fallimento di un cliente inadempiente. Dal lato del debitore, è cruciale gestire attivamente il rapporto con i fornitori durante la crisi: comunicare con trasparenza le difficoltà, eventualmente proporre piani di rientro rateali o accordi transattivi (ad esempio, pagamento parziale “a saldo e stralcio” del credito, se il fornitore accetta uno sconto in cambio di pronta liquidazione). Tali accordi vanno formalizzati preferibilmente per iscritto, onde evitare contestazioni future. Si consideri che un pagamento effettuato a un fornitore quando l’impresa era già insolvente potrebbe, in caso di successivo fallimento, essere soggetto ad azione revocatoria fallimentare da parte del curatore (se effettuato nel semestre antecedente la procedura, per importi significativi e al di fuori dell’ordinaria amministrazione) . Ciò rappresenta un rischio sia per il fornitore (che potrebbe dover restituire quanto ricevuto al passivo fallimentare) sia per l’amministratore dell’impresa debitrice (che potrebbe essere chiamato a rispondere per pagamenti preferenziali, anche sul piano penale, se fatti dolosamente a vantaggio di alcuni creditori a scapito di altri). Dunque, un imprenditore in crisi dovrebbe evitare di soddisfare arbitrariamente solo alcuni fornitori “amici” trascurandone altri, poiché questa disparità di trattamento viola la par condicio creditorum e può costituire reato di bancarotta preferenziale. Come difendersi? O l’azienda paga regolarmente tutti secondo i piani concordati, oppure – se la situazione è compromessa – è preferibile ricorrere a una procedura concorsuale (come il concordato), dove per legge si stabilisce un trattamento paritario dei creditori chirografari (in percentuale concordata) evitando il rischio di azioni revocatorie individuali. Nell’ambito di un concordato preventivo, per esempio, i pagamenti ai fornitori avvengono secondo il piano omologato, e i creditori chirografari ricevono la medesima percentuale salvo che acconsentano volontariamente a condizioni diverse.
- Debiti verso dipendenti – Un caso particolare di debito chirografo è quello verso i lavoratori dell’impresa (retribuzioni arretrate, trattamento di fine rapporto – TFR, ferie non pagate, ecc.). I crediti dei dipendenti godono però di uno status privilegiato: le paghe e i TFR maturati hanno privilegio generale sui mobili dell’azienda (ex art. 2751-bis c.c.) e, per alcune componenti, privilegio speciale (ad esempio sui beni prodotti dal lavoratore). Inoltre, esiste in Italia il Fondo di Garanzia INPS che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, interviene a pagare ai lavoratori i trattamenti di fine rapporto e le ultime mensilità di stipendio arretrate, salvo poi surrogarsi nel credito verso l’azienda. Questo fondo opera tipicamente a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale (fallimento o concordato preventivo liquidatorio) o di un’accertata insolvenza. Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, i debiti verso dipendenti sono molto delicati: non pagare i lavoratori può causare scioperi, dimissioni di massa o azioni legali (ingiunzioni di pagamento in sede di lavoro), ma talvolta, durante la crisi, l’azienda è costretta a scegliere quali uscite onorare. Dare priorità al pagamento degli stipendi a scapito di imposte o fornitori, pur moralmente comprensibile, può come detto esporre a responsabilità (in sede penale e concorsuale) se ciò si traduce nell’omesso versamento di imposte o in atti di favoritismo. Una difesa possibile è concordare con i dipendenti delle soluzioni temporanee – ad esempio la cassa integrazione guadagni se disponibile, o accordi individuali di dilazione nel pagamento delle spettanze – nell’attesa di un piano di rilancio o dell’attivazione del Fondo di Garanzia. È bene ricordare che, qualora l’azienda acceda a una procedura concorsuale, i dipendenti vantano comunque diritto alle prelazioni sui beni dell’attivo e ai pagamenti in prededuzione per le competenze di lavoro maturate durante la procedura. In sede di concordato preventivo in continuità aziendale, ad esempio, la legge impone che i crediti per stipendio scaduti negli ultimi mesi precedenti la domanda siano soddisfatti integralmente e subito (come crediti prededucibili), al fine di tutelare i lavoratori e consentire la prosecuzione dell’attività con forza lavoro motivata.
Oltre a queste categorie principali, vi possono essere altri debiti: verso enti pubblici locali (es. IMU non pagata al Comune), verso società di leasing (canoni leasing macchinari insoluti, con rischio di revoca del contratto e ritiro dei beni), verso partner o coobbligati (es. se l’impresa ha prestato fideiussioni a terzi o viceversa). Ciascun tipo di debito richiede un’analisi puntuale. Riassumendo in breve: i debiti fiscali e contributivi implicano l’attivazione della riscossione coattiva statale e possibili sanzioni penali; i debiti bancari attivano garanzie e il rischio di insolvenza conclamata; i debiti commerciali portano ad azioni legali diffuse e inceppano la filiera; i debiti verso lavoratori attivano tutele pubbliche e privilegi, ma anche tensioni sociali interne. Nella prossima sezione vedremo come la legge italiana affronta la crisi d’impresa in maniera unitaria attraverso un quadro normativo dedicato e quali strumenti offre al debitore per gestire o risolvere l’indebitamento eccessivo.
(Vedi Tabella 1 più avanti per un riepilogo delle tipologie di debito, effetti e possibili rimedi.)
La normativa italiana sulla crisi d’impresa (aggiornata al 2025)
La disciplina delle situazioni di insolvenza o crisi d’impresa è stata profondamente rinnovata con l’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), emanato con D.Lgs. 14/2019 (in attuazione della legge delega n. 155/2017) e definitivamente entrato in vigore dal 15 luglio 2022 . Questo Codice ha sostituito la storica legge fallimentare del 1942, armonizzando le procedure concorsuali tradizionali con le nuove esigenze di early warning (allerta tempestiva) e di composizione negoziata della crisi, in linea con le direttive europee (Direttiva UE 2019/1023). Nel 2022-2024 il CCII è stato oggetto di correttivi (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 118/2022, D.Lgs. 54/2023 e D.Lgs. 136/2024, cosiddetto “correttivo ter”) che hanno ulteriormente affinato gli strumenti a disposizione .
Principi generali: la normativa vigente si basa su alcuni principi chiave: (a) prevenzione e emersione anticipata della crisi, grazie all’adozione di assetti organizzativi adeguati e obblighi di segnalazione; (b) favor per la ristrutturazione e il risanamento dell’impresa in difficoltà, ove possibile, tramite procedure che privilegiano la continuità aziendale; (c) in caso di insolvenza irreversibile, liquidazione ordinata dell’attivo e ripartizione tra i creditori secondo la par condicio, con possibilità per l’imprenditore onesto e sfortunato di ottenere l’esdebitazione (fresh start).
Adeguati assetti e doveri di gestione: l’art. 2086 c.c., riformulato dal Codice della Crisi, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuazione del business . Ciò significa che gli amministratori devono dotarsi di sistemi di controllo di gestione, monitoraggio dei flussi finanziari e indicatori che segnalino squilibri economico-patrimoniali. In presenza di indizi di crisi (come perdite rilevanti, tensioni di cassa, indicatore di DSCR < 1, ecc.), gli amministratori hanno il dovere di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge, al fine di evitare l’aggravarsi del dissesto. L’inadempimento di tali doveri può comportare responsabilità personali: il CCII ha introdotto presunzioni di danno in caso di ritardata richiesta di procedura (art. 378 CCII che modifica l’art. 2486 c.c.), facilitando l’azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano aggravato il dissesto protraendo l’attività imprenditoriale oltre il limite della solvibilità . Anche la Cassazione ha più volte affermato che l’amministratore che non agisce con diligenza per il bene sociale, ad esempio occultando la crisi o favorendo interessi propri a danno dei creditori, compie un atto illecito e risponde dei danni causati . In sintesi, la legge oggi impone al debitore un comportamento attivo e leale: emergere presto e agire.
Soglie di fallibilità e categorie di debitori: Non tutte le imprese sono assoggettabili alle medesime procedure. Il Codice della Crisi distingue:
– i debitori maggiori (imprese commerciali sopra determinati limiti dimensionali) assoggettati alle procedure maggiori (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione);
– i debitori minori (piccoli imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori) i quali non sono soggetti a fallimento/liquidazione giudiziale ma possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata).
Le soglie dimensionali per qualificare un “piccolo imprenditore” non fallibile (ora imprenditore minore) erano in passato: attivo patrimoniale annuo non superiore a €300.000, ricavi annui non oltre €200.000, debiti totali non oltre €500.000 (criteri della legge fallimentare). Il CCII conferma che restano esclusi dalla liquidazione giudiziale gli imprenditori sotto certi limiti, ma riorganizza le procedure applicabili a costoro nell’ambito del sovraindebitamento. Pertanto, la nostra “impresa di fabbricazione macchinari” – se costituita in forma di società di capitali di dimensioni medio-grandi – ricadrà nelle procedure concorsuali ordinarie; se invece fosse una piccola ditta individuale o società sotto soglia, potrebbe utilizzare le procedure minori (si pensi all’artigiano costruttore di macchine su piccola scala, che rientra nel regime dei sovraindebitati).
Esaminiamo ora sinteticamente gli strumenti offerti dalla normativa italiana per affrontare la crisi d’impresa, distinguendoli in due macro-categorie: soluzioni stragiudiziali (negoziali) e procedure concorsuali giudiziali. Una menzione a parte merita la composizione negoziata della crisi, introdotta di recente, che pur non essendo una procedura concorsuale vera e propria, costituisce un percorso assistito da esperti per favorire il risanamento. L’ordinamento incoraggia la scelta di strumenti “morbidi” di risanamento ogniqualvolta vi siano concrete possibilità di salvataggio dell’impresa, riservando la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) al caso estremo di insolvenza irreversibile.
Soluzioni stragiudiziali (extra-giudiziali) per la gestione dei debiti
Affrontare i debiti fuori dalle aule giudiziarie, attraverso accordi volontari con i creditori, è spesso preferibile quando l’impresa ha ancora prospettive di risanamento. Le soluzioni stragiudiziali offrono flessibilità e riservatezza, evitando gli effetti stigmatizzanti di una procedura concorsuale pubblica. Di seguito, vediamo i principali strumenti negoziali a disposizione di un’impresa debitrice.
1. Rinegoziazione individuale dei debiti e accordi transattivi: La via più immediata, in caso di difficoltà temporanea, è contattare singolarmente i creditori per rinegoziare le condizioni di pagamento. Ciò può tradursi in:
– Piani di rientro rateali: ad esempio, la società propone al fornitore di saldare un insoluto di €100.000 mediante 10 rate mensili da €10.000 ciascuna, magari riconoscendo un interesse dilatorio. Tali accordi dovrebbero essere formalizzati per iscritto, preferibilmente con la previsione che la mancata puntualità di una rata comporta la decadenza dal beneficio del termine (per dare serietà all’impegno). È consigliabile indicare espressamente che l’accordo transattivo costituisce novazione del debito pregresso: così, se adempiuto, estinguerà definitivamente ogni pretesa.
– Accordi a saldo e stralcio: quando il debitore non è in grado di pagare per intero, può proporre al creditore un pagamento in misura ridotta ma immediata, ottenendo in cambio la liberazione dal residuo debito. Ad esempio, offrire €50.000 subito per chiudere un debito di €100.000 (stralcio del 50%). Molti fornitori, di fronte al rischio di perdere tutto in caso di fallimento del cliente, accettano queste soluzioni transattive, soprattutto se l’azienda mostra piani credibili di risanamento e se il settore di attività è ciclico (il fornitore spera di mantenere il rapporto commerciale una volta che il cliente si sia risollevato). È essenziale formalizzare il saldo e stralcio con una quietanza a saldo che evidenzi la rinuncia del creditore a ogni ulteriore pretesa una volta incassato l’importo concordato.
– Moratorie e standstill: con le banche in particolare, l’impresa può richiedere una moratoria sul pagamento del capitale (pagando solo interessi per un certo periodo) o un congelamento temporaneo degli obblighi (standstill agreement), magari nell’ambito di intese di più ampio respiro. Dal 2015 esiste in Italia un protocollo di moratoria ABI per le PMI, che consente di sospendere o allungare i finanziamenti bancari in presenza di determinati requisiti, evitando che scaduti improvvisi mettano in crisi la tesoreria. Accordi di moratoria possono essere raggiunti anche con fornitori strategici, i quali potrebbero concedere dilazioni extra in cambio di garanzie (es. cambiali, riconoscimento di riserva di proprietà sulla merce consegnata fino al saldo).
– Concordato stragiudiziale plurilaterale: se l’impresa ha molti creditori chirografari, può tentare un accordo collettivo extra-giudiziale. Ad esempio, convocare tutti i fornitori e proporre il pagamento del 40% dei loro crediti, in parti uguali proporzionali, entro 6 mesi, spiegando che tale percentuale è superiore a quanto otterrebbero in caso di fallimento. Questo tipo di accordo (talora chiamato moratoria di fatto) non è vincolante per i dissenzienti: richiede quindi l’adesione volontaria di tutti i creditori coinvolti. In mancanza di adesione unanime, resta solo la via di formalizzare un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis (che però è soggetto ad omologa giudiziale, vedi oltre) per ottenere l’efficacia anche verso i non aderenti. Gli accordi stragiudiziali multipli soffrono infatti del problema dell’opportunismo: se alcuni creditori non ci stanno e cercano un recupero integrale per via giudiziale, l’accordo rischia di saltare. Perciò il debitore deve valutare attentamente il numero minimo di adesioni necessario perché l’intesa funzioni, e magari incentivare la partecipazione offrendo condizioni leggermente migliori a chi aderisce entro un certo termine (takeaway: creare urgenza e fiducia).
2. Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): Si tratta di uno strumento previsto espressamente dalla legge, già presente nella vecchia legge fallimentare (art. 67, co. 3, lett. d) L.F.) e ora disciplinato dal Codice della Crisi. Il piano attestato di risanamento è un piano di risanamento aziendale, redatto dall’imprenditore in stato di crisi o insolvenza incipiente, asseverato da un esperto indipendente (attestatore) e rivolto ai creditori, finalizzato a ristrutturare l’indebitamento e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa . È uno strumento contrattuale e non giudiziale: non richiede l’intervento del tribunale né l’omologazione, ma ottiene alcuni benefici di legge se rispetta determinate condizioni. In particolare, il piano deve avere data certa e contenere una serie di informazioni dettagliate: descrizione dell’impresa, elenco dei creditori e dei relativi trattamenti proposti, cause della crisi, strategie di intervento, piano industriale e finanziario con tempi di realizzo, eventuali nuovi apporti di capitale, ecc. . Un professionista indipendente (ad esempio un commercialista o revisore esperto in crisi d’impresa, nominato dall’azienda) deve attestare per iscritto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto . L’imprenditore può decidere di pubblicare il piano, l’attestazione e gli eventuali accordi con i creditori nel Registro delle Imprese , rendendoli noti ai terzi: questa pubblicazione non è obbligatoria, ma è condizione per ottenere una protezione legale importante, cioè l’esenzione da revocatoria delle operazioni compiute in esecuzione del piano. Infatti, l’art. 166, comma 3, lett. d) CCII stabilisce che non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare né ordinaria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento idoneo a consentire il risanamento dell’impresa, a condizione che il piano e l’attestazione siano stati comunicati (pubblicati) al Registro Imprese . Ciò significa, ad esempio, che se la società Alfa Srl, in crisi, paga un fornitore strategico o concede un’ipoteca a una banca come previsto dal piano di risanamento attestato depositato, e poi malauguratamente fallisce entro 2 anni, il curatore non potrà revocare quei pagamenti o garanzie perché compiuti in attuazione di un piano certificato. Questo scudo incentiva i creditori ad accettare le misure del piano senza timore di dover restituire in caso di successivo default. Inoltre, il CCII prevede che alcuni reati fallimentari (bancarotta semplice per pagamenti o per operazioni imprudenti) non si applichino alle operazioni effettuate in esecuzione di un piano attestato regolarmente comunicato , salvo il caso di frode o dolo dell’attestatore o del debitore. In sostanza, il piano attestato è un ombrello protettivo che consente all’impresa di ristrutturare il debito su base consensuale, dando un’informativa trasparente ai creditori e ottenendo in cambio la stabilità giuridica delle operazioni di risanamento. Occorre, però, sottolineare due limiti: (a) il piano attestato richiede il consenso effettivo dei creditori coinvolti – non può imporre tagli o dilazioni senza accordo, quindi se un creditore chiave si chiama fuori, il piano potrebbe non raggiungere lo scopo; (b) durante l’attuazione del piano non vige un automatic stay generale: non essendo procedura concorsuale, i creditori non aderenti conservano il diritto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Per questo, spesso il piano attestato funziona meglio in situazioni di crisi reversibile, con numero limitato di creditori e coesione di intenti. In uno scenario di diffusa conflittualità, può essere necessario un passaggio in tribunale per ottenere protezione globale (ad esempio tramite concordato preventivo o misure protettive nella composizione negoziata, di cui diremo oltre). È comunque notevole evidenziare come il legislatore valorizzi il ruolo dell’esperto attestatore: la sua relazione, redatta con indipendenza e professionalità, è la pietra angolare che conferisce fiducia ai creditori sulla realizzabilità del risanamento. Dal punto di vista del debitore, scegliere un attestatore credibile e fornire a questi tutti i dati necessari (bilanci realistici, business plan dettagliati, ecc.) è cruciale per il successo del piano. Un piano farlocco o eccessivamente ottimistico verrebbe smontato dall’esperto o, se anche attestato, difficilmente convincerebbe i creditori a fare sacrifici. Invece, un buon piano attestato può essere la via più rapida e meno traumatica per superare una crisi temporanea, evitando di entrare in procedura concorsuale e mantenendo l’operatività ordinaria dell’impresa.
3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. CCII): Quando la situazione è più complessa e serve una maggiore efficacia vincolante, l’ordinamento offre lo strumento degli accordi di ristrutturazione omologati dal tribunale. Si tratta di accordi negoziati con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (percentuale confermata dal CCII) e poi sottoposti all’omologazione da parte del tribunale competente. Il vantaggio rispetto a un piano puramente stragiudiziale è che l’omologazione attribuisce efficacia anche nei confronti dei creditori non aderenti (dissentienti o rimasti inattivi), purché regolarmente informati e soddisfatti almeno integralmente nei termini dell’accordo. In altre parole, con gli accordi ex art. 182-bis L.F. (oggi art. 60 CCII e seguenti), se il debitore ottiene l’adesione qualificata di una larga maggioranza, può chiedere al giudice di “estendere” gli effetti dell’intesa anche alla minoranza dissenziente, scongiurando azioni individuali disordinate. Il tribunale, prima di omologare, verifica la fattibilità e convenienza dell’accordo, anche attraverso la relazione di un attestatore indipendente che accompagna l’istanza (simile a quella del piano attestato, ma qui focalizzata sul rispetto dell’interesse dei creditori e sulla regolarità delle forme). Gli accordi di ristrutturazione possono prevedere qualsiasi forma di rinegoziazione: taglio dei crediti (haircut), dilazioni di pagamento, conversione di debiti in strumenti partecipativi, cessione di asset ai creditori, ecc. Alcune varianti sono state introdotte di recente: l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) può vincolare anche i creditori finanziari dissenzienti se aderiscono il 75% delle banche; l’accordo agevolato riduce la soglia al 30% per particolari tipologie di debiti, ma limitatamente ai creditori aderenti (consente omologa anche senza raggiungere il 60%, ma non obbliga i non aderenti). Inoltre, con il recepimento della direttiva UE, è stato previsto un meccanismo di cram-down fiscale: il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione dell’Erario (o degli enti previdenziali) se ritiene che il trattamento proposto a questi crediti pubblici non sia inferiore a quello che otterrebbero in una liquidazione fallimentare . In passato, la mancanza del voto favorevole del Fisco bloccava qualunque piano che prevedesse un pagamento parziale delle imposte (c.d. transazione fiscale), ma oggi – superato il parere contrario – il giudice può procedere comunque, purché soddisfatte le condizioni di legge (ciò in attuazione del principio europeo del best interest of creditors test). Ad esempio, se l’accordo propone di pagare al Fisco il 40% dilazionato e le simulazioni mostrano che in caso di fallimento il Fisco incasserebbe solo il 20%, il giudice può omologare l’accordo anche contro il dissenso dell’ente, ritenendo il 40% migliorativo e dunque equo . L’accordo di ristrutturazione omologato è caratterizzato da pubblicità (viene iscritto nel registro imprese e pubblicato sul portale ministeriale), ed è assistito anch’esso da misure protettive: dalla data di deposito della domanda di omologa, il debitore può chiedere al tribunale la sospensione o il divieto delle azioni esecutive dei creditori per un periodo generalmente di 60-120 giorni, al fine di condurre in porto le trattative e ottenere l’omologa. Questo scudo temporaneo è simile a quello del concordato preventivo e serve a evitare che iniziative isolate di creditori frustrino gli sforzi di soluzione concordata. Dal punto di vista del debitore, l’accordo di ristrutturazione è indicato quando si ha il supporto convinto dei principali creditori (soprattutto banche) ma magari non di tutti: è un compromesso tra negoziazione privata e intervento giudiziale. Richiede tempi e costi maggiori rispetto a un semplice accordo stragiudiziale (serve un ricorso in tribunale, una fase di omologa, il coinvolgimento di un attestatore e di legali esperti), tuttavia consente di cristallizzare la posizione debitoria e procedere con la ristrutturazione in un clima di maggior certezza. Va ricordato che, similmente al concordato, gli accordi omologati danno luogo a esdebitazione del debitore persona fisica per la parte residua non pagata, purché l’accordo sia stato adempiuto: i creditori coinvolti non potranno pretendere in futuro somme eccedenti quelle concordate.
4. Composizione negoziata assistita: Un recente strumento, che si colloca a metà strada tra l’approccio puramente negoziale e l’intervento dell’autorità, è la composizione negoziata della crisi (introdotta con D.L. 118/2021 e ora parte del CCII agli artt. 17-25). Poiché si tratta di un tema di rilievo, lo esamineremo in una sezione dedicata più avanti. Basti anticipare che la composizione negoziata offre all’imprenditore in crisi la possibilità di farsi affiancare da un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione (presso la Camera di Commercio), il quale facilita le trattative con i creditori per raggiungere un accordo di risanamento, il tutto in un contesto riservato e stragiudiziale, ma con possibili misure protettive autorizzate dal tribunale (come il blocco temporaneo delle azioni esecutive). È uno strumento flessibile e volontario, utilizzabile anche in situazioni di insolvenza avanzata, che consente di esplorare soluzioni concordate (accordi, investimenti, cessioni d’azienda) senza l’immediata pubblicità di una procedura concorsuale. Nel caso in cui gli sforzi negoziali non sortiscano effetto, al termine della composizione negoziata l’imprenditore ha comunque la possibilità di accedere a strumenti concorsuali semplificati (come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII) per evitare il fallimento e liquidare in modo ordinato, su cui torneremo.
In sintesi, prima di ricorrere al tribunale, un imprenditore indebitato dovrebbe valutare attentamente queste opzioni stragiudiziali: negoziazioni private, piani attestati, accordi omologati e composizione negoziata. La scelta dipende dal grado di gravità della crisi, dal numero e tipologia dei creditori coinvolti e dal livello di fiducia che egli riesce a mantenere con loro. È fondamentale farsi assistere da consulenti esperti in crisi d’impresa in questa fase, sia per predisporre piani credibili sia per condurre le trattative in modo proficuo e nell’alveo della legalità (evitando atti che possano poi essere contestati come fraudolenti). Una gestione professionale e trasparente della crisi nella fase stragiudiziale può significare la differenza tra un risanamento di successo e un fallimento rovinoso.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Tra le novità di maggior rilievo della recente riforma vi è la composizione negoziata della crisi, una procedura “ibrida” introdotta in via d’urgenza nel 2021 (per fronteggiare l’ondata di insolvenze post-pandemia) e poi stabilizzata dal Codice della Crisi. Essa rappresenta un tentativo di favorire la ristrutturazione precoce delle imprese in difficoltà, con l’assistenza di un esperto indipendente e sotto una leggera ombra dell’autorità giudiziaria, ma senza le formalità e la pubblicità di un fallimento o concordato tradizionale.
Caratteristiche generali: la composizione negoziata è attivabile da qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo (anche di grandi dimensioni, non c’è una soglia minima né massima) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far presumere la crisi o l’insolvenza, ma ancora reversibili. È quindi un istituto di allerta facoltativa: spetta all’imprenditore decidere di accedervi, non è imposta automaticamente da soglie finanziarie (il progetto originario di allerta obbligatoria attraverso indicatori – gli OCRI – è stato abrogato e sostituito proprio dalla composizione negoziata volontaria). Per avviare la procedura, l’imprenditore presenta un’istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) fornendo informazioni sullo stato dell’impresa, i bilanci, una prospettiva di piano di risanamento e altri dati rilevanti. Entro pochi giorni, una commissione nomina un esperto indipendente, scelto da un elenco di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con formazione specifica) che darà avvio al percorso negoziale . L’esperto funge da facilitatore: convoca l’imprenditore e ascolta le sue proposte, analizza la situazione e successivamente prende contatto con i principali creditori per valutare possibili soluzioni concordate. Il tutto avviene in modo riservato: l’apertura della composizione negoziata non è pubblica nel Registro delle Imprese (salvo che l’imprenditore chieda misure protettive, come vedremo) e i creditori sono tenuti a comportarsi secondo buona fede durante le trattative.
Obiettivi e durata: l’obiettivo è duplice – da un lato evitare che i creditori intraprendano azioni distruttive del valore mentre esiste la possibilità di un accordo, dall’altro trovare una soluzione di risanamento, che può assumere diverse forme a seconda del caso concreto. La composizione negoziata ha una durata iniziale di 3 mesi, prorogabile su richiesta motivata dell’imprenditore (con il parere dell’esperto) fino a un massimo di altri 3 mesi (in totale 6 mesi). In alcuni casi, il termine può estendersi ulteriormente se ci sono trattative in corso e creditori disponibili. Durante questo periodo, l’imprenditore resta alla guida dell’azienda (non c’è spossessamento né nomina di curatore): può compiere gli atti di ordinaria amministrazione liberamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve consultare l’esperto e, se ritiene, chiedere l’autorizzazione al tribunale (soprattutto se intende ottenere protezione avverso revocatorie future).
Misure protettive e cautelari: uno strumento fondamentale è la possibilità per l’imprenditore di richiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee sul patrimonio. In pratica, può essere chiesto che, per la durata delle trattative, nessun creditore possa iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari contro l’impresa e che non possano essere acquisite cause di prelazione (es. iscrizioni ipotecarie) sui beni dell’imprenditore senza autorizzazione del giudice. Il tribunale, valutata l’istanza e sentito l’esperto, può emettere un decreto che sospende le azioni di recupero dei creditori, tipicamente per un periodo di 30 a 90 giorni, rinnovabile. Ciò crea un ambiente protetto in cui l’imprenditore non deve difendersi da pignoramenti o istanze di fallimento, e può concentrarsi sulle negoziazioni. Va notato che tali misure protettive vengono iscritte nel registro delle imprese e pubblicate, quindi in quel momento la procedura diventa conoscibile ai terzi (compromesso necessario per tutelare i creditori “congelati”). È anche possibile per l’imprenditore chiedere misure cautelari specifiche: ad esempio, la sospensione di un contratto in corso che è troppo oneroso, o l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile (c.d. finanza ponte) per gestire la continuità aziendale durante i negoziati. Il tribunale decide in camera di consiglio, velocemente, su queste richieste. Un esempio: l’impresa, in composizione negoziata, può ottenere il permesso di contrarre un nuovo mutuo necessario per pagare fornitori vitali, con la garanzia che quel mutuo sarà rimborsato in prededuzione (prioritario) qualora poi si apra una procedura concorsuale . Ciò serve a incentivare finanziatori ad aiutare un’azienda in crisi sapendo di avere tutela legale.
Esito delle trattative: la composizione negoziata non si conclude con un provvedimento giudiziale di omologa (a differenza di concordato o accordi). Essa è un contenitore nel quale possono maturare diversi esiti negoziali: – Accordo stragiudiziale semplice: l’imprenditore e uno, alcuni o tutti i creditori raggiungono un’intesa privata (es. moratoria di 6 mesi, o riduzione del 20% dei crediti con pagamento immediato). In tal caso, la composizione si chiude con la firma dell’accordo e, se l’imprenditore lo desidera, tale accordo può essere “cristallizzato” depositandolo presso il tribunale per ottenere efficacia esecutiva (in pratica diventerebbe un titolo esecutivo). Spesso, però, se l’accordo stragiudiziale ha avuto successo, non serve formalizzare oltre: basta adempiere secondo i patti. – Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis o concordato preventivo: la composizione negoziata può fungere da trampolino per accedere a una procedura concorsuale negoziata. Ad esempio, se durante le trattative l’imprenditore vede che una parte consistente di creditori è disposta ad accettare un certo piano, può decidere di formalizzarlo come accordo di ristrutturazione omologato (presentando l’istanza al tribunale, con la comfort letter dell’esperto a supporto). Oppure, se serve coinvolgere tutti i creditori in modo vincolante e ristrutturare anche le passività non coperte dall’accordo, può preparare un concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) e presentare domanda, eventualmente in concomitanza con la chiusura della composizione negoziata. Il periodo di negoziazione con l’esperto è utile per costruire la base di consenso e raccogliere le informazioni necessarie a queste procedure formali. L’esperto, al termine, redige una relazione finale che l’imprenditore allega alla domanda di concordato o di omologa dell’accordo, per attestare il percorso svolto. Questo iter è incoraggiato dalla legge, ad esempio esentando dal pagamento del tributo unificato l’imprenditore che, terminata la composizione, deposita entro un certo termine un ricorso per concordato preventivo o per omologa di accordo. – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: se le trattative falliscono e non è possibile trovare la continuità aziendale, l’imprenditore può comunque proporre ai creditori (e al tribunale) una soluzione di liquidazione controllata dei beni alternativa al fallimento. L’art. 25-sexies CCII (introdotto prima come norma transitoria e ora stabilizzato col correttivo 2024) disciplina il concordato semplificato, accessibile solo all’esito negativo di una composizione negoziata. Esso consente di presentare un piano di liquidazione di tutto il patrimonio residuo ai creditori senza dover passare per il voto degli stessi (contrariamente al concordato “normale”): decide direttamente il tribunale se omologarlo, valutando che siano rispettati il principio di non alterare l’ordine delle cause di prelazione e il merito creditizio. In pratica, se l’imprenditore non è riuscito a convincere attivamente i creditori, può comunque evitare il fallimento sottoponendo un piano di liquidazione “imposto” dall’alto, garantendo però ai creditori non meno di quanto avrebbero in fallimento. È una via d’uscita residuale ma utile: il vantaggio è che i costi e i tempi della liquidazione semplificata possono essere inferiori a quelli di un fallimento tradizionale, e il debitore persona fisica può più rapidamente accedere all’esdebitazione. Va però notato che il concordato semplificato è solo liquidatorio (non prevede prosecuzione dell’attività, se non funzionale alla migliore vendita degli asset) . Di fatto, è una forma “guidata” di liquidazione concorsuale, con nomina di un liquidatore giudiziale ma senza il rito completo del concordato preventivo (niente adunanza dei creditori, niente voto, solo eventuali osservazioni). – Liquidazione giudiziale (fallimento) o istanza di parte terza: ovviamente, se la composizione negoziata non porta ad alcun accordo e l’imprenditore non attiva nessuno strumento alternativo, i creditori riacquisteranno piena libertà di azione (se era stata sospesa) e potranno eventualmente chiedere il fallimento. Anche il pubblico ministero può intervenire se ravvisa l’insolvenza conclamata. Pertanto, la fase negoziata non garantisce di per sé un esito salvifico: tutto dipende dall’utilizzo che se ne fa e dalla fattibilità di una soluzione.
Vantaggi per il debitore: la composizione negoziata ha numerosi pregi dal punto di vista del debitore: è riservata (preserva la reputazione almeno finché non si richiedano misure protettive), è elastica (non impone uno schema rigido di soluzione, si può contrarre liberamente con i creditori), consente di guadagnare tempo prezioso senza subire assalti (grazie alle misure protettive), permette di usufruire dei consigli di un esperto terzo e imparziale (che può proporre soluzioni creative o far vedere ai creditori la situazione con occhi neutrali), e infine apre porte ad altre procedure in modo più agevole (ad esempio, un eventuale concordato successivo sarà meglio accolto se preceduto dal tentativo negoziale e corredato dalla relazione dell’esperto). Dal punto di vista dei creditori, anch’essi possono trarre beneficio: spesso una soluzione concordata nel negoziato darà loro un attivo maggiore e più rapido rispetto a un fallimento, e la loro collaborazione può salvare un cliente/fornitore con cui hanno un interesse a proseguire rapporti in futuro.
Ruolo dell’esperto e comportamento delle parti: l’esperto nominato deve agire con imparzialità e riservatezza, cercando di comporre gli interessi in gioco. Egli non ha poteri coercitivi, ma redige rapporti periodici sull’andamento delle trattative. Se l’imprenditore tiene comportamenti ostruzionistici o pregiudizievoli (ad esempio contrae nuovi debiti senza informare, o disperde attivo), l’esperto può segnalare la cosa e ciò può portare alla fine anticipata della composizione. I creditori sono tenuti per legge a collaborare lealmente alle trattative, astenendosi da azioni che possano farle naufragare e valutando seriamente le proposte di risanamento. Ovviamente, nulla li obbliga ad accettare un accordo, ma la filosofia della normativa è che un atteggiamento costruttivo sia nell’interesse reciproco. Da notare: durante la composizione negoziata, l’imprenditore non è esonerato dall’adempimento delle obbligazioni correnti; se la situazione di liquidità non consente di pagarle, di solito è segno che il negoziato dovrà sfociare in una procedura più incisiva. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità per l’imprenditore di ottenere finanziamenti prededucibili autorizzati (come detto) e di cedere beni non strategici con il benestare dell’esperto, proprio per procurarsi le risorse per la gestione corrente. In pratica, la composizione negoziata è un momento in cui si può ristrutturare l’azienda: vendere rami d’azienda, ottenere nuova finanza, modificare organici – operazioni che se fatte spontaneamente, previa comunicazione all’esperto, non costituiscono atti distrattivi. Anzi, qualora poi si andasse in concordato o liquidazione, molti di questi atti compiuti con il nulla osta dell’esperto saranno esenti da azioni revocatorie e responsabilità.
Aggiornamenti 2023-2025: l’esperienza dei primi due anni di composizione negoziata ha visto centinaia di domande presentate (oltre 500 nel primo anno) . La normativa è stata oggetto di piccoli aggiustamenti: ad esempio, il “Decreto PNRR 2” (D.L. 85/2022, conv. L. 120/2022) ha semplificato la nomina dell’esperto in caso di carenza di candidature, e il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ulteriormente integrato la disciplina, chiarendo alcuni aspetti procedurali e coordinandola con la direttiva UE Insolvency. Un importante intervento (decreto legge di febbraio 2023) ha permesso di sbloccare le nomine degli esperti pendenti: in pratica, data la carenza iniziale di esperti disponibili in alcune province e il numero di istanze, si è consentito all’imprenditore, in via transitoria, di autocertificare di aver presentato richiesta di nomina 10 giorni prima e di poter cominciare le trattative anche se l’esperto non era ancora nominato . Questo per evitare stalli. Oggi il sistema è più rodato, e vi sono portali dedicati (come composizionenegoziata.camcom.it ) con linee guida per le imprese.
Quando e perché utilizzare la composizione negoziata: dalla prospettiva del debitore, conviene attivare questo strumento quando:
– la crisi non è ancora sfociata in insolvenza irreversibile (esiste un margine per ristrutturare l’impresa);
– ci sono elementi di valore da preservare (know-how, mercato, avviamento) che giustificano uno sforzo per evitare la liquidazione pura;
– la struttura del debito è complessa (molti creditori eterogenei) e serve coordinamento, o comprende creditori strategici di cui si ha bisogno (fornitori chiave, banche per linee di credito);
– l’imprenditore è disposto a mettersi in discussione e a collaborare con un soggetto terzo (l’esperto) mostrando i “numeri” reali dell’azienda;
– c’è la necessità di un periodo di respiro protetto dalle azioni esecutive, per vendere asset o cercare investitori: ad esempio, l’imprenditore può usare la composizione negoziata per guadagnare tempo mentre cerca un socio che immetta capitali freschi o un acquirente per l’azienda, informando i creditori che una trattativa di M&A è in corso.
Qualora invece l’azienda sia ormai decotta, priva di prospettive di continuità e sostanzialmente senza accordi possibili (creditori troppo ostili), la composizione negoziata potrebbe solo ritardare l’inevitabile e consumare ulteriori risorse: in tali casi è preferibile optare subito per una soluzione liquidatoria formale, magari guadagnandosi il beneficio dell’esdebitazione. Ad ogni modo, la composizione negoziata è oggi parte integrante del toolkit legale: un bravo consulente la prenderà in considerazione non appena l’imprenditore manifesti segni di affanno finanziario. A differenza del passato, in cui bisognava attendere la quasi insolvenza per proporre un concordato, adesso è possibile “giocare d’anticipo” con questo strumento, a vantaggio sia del debitore (che può evitare danni maggiori) sia dei creditori (che possono recuperare di più e prima).
Procedure concorsuali giudiziali: dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale
Se i tentativi stragiudiziali non bastano o non sono praticabili, l’ordinamento prevede le procedure concorsuali, ossia iter formali dinanzi all’autorità giudiziaria volti a gestire la crisi o l’insolvenza in modo ordinato e imparziale. Dal punto di vista del debitore, accedere a una procedura concorsuale comporta certamente una compressione dei propri poteri e una pubblicità della situazione d’insolvenza, ma offre anche benefici: protezione dalle azioni esecutive individuali, congelamento dei debiti precedenti, possibilità di imporre una ristrutturazione alle minoranze dissenzienti, nonché – aspetto tutt’altro che secondario – opportunità di esdebitazione (la liberazione dai debiti residui una volta conclusa la procedura, ove ne ricorrano i presupposti).
Di seguito passiamo in rassegna gli strumenti concorsuali principali dal punto di vista di un’impresa industriale debitrice, evidenziando per ciascuno cosa comporta e come difende gli interessi del debitore (e dei creditori).
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura di regolazione della crisi rivolta alle imprese insolventi o in crisi, finalizzata a evitare la liquidazione giudiziale attraverso un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Rappresenta storicamente l’alternativa al fallimento: un mezzo per “concordare” con i creditori un soddisfacimento parziale o dilazionato delle loro ragioni, in cambio della continuazione dell’attività o di una liquidazione controllata.
Tipologie e contenuto del concordato: Il concordato può avere due anime: in continuità aziendale (quando prevede la prosecuzione, anche parziale, dell’attività d’impresa, magari tramite affitto o cessione dell’azienda) oppure liquidatorio (quando l’azienda cessa l’attività e si punta solo a liquidare i beni per pagare i creditori). Il CCII incoraggia la continuità laddove generi un valore superiore alla liquidazione, ma consente anche concordati liquidatori puri, purché assicurino un ritorno minimo ai creditori chirografari (nella vigenza della legge fallimentare si richiedeva almeno il 20%, ma il CCII ha modulato questa soglia e previsto eccezioni se la percentuale minore è “giustificata” dalla migliore soddisfazione possibile). In un concordato, il debitore propone un piano che deve indicare dettagliatamente come intende risanare o liquidare l’impresa e con quali risorse pagherà i creditori, e una proposta che stabilisce la misura e le condizioni di soddisfacimento dei crediti. I creditori sono suddivisi per legge in classi omogenee (o comunque in classi se vi sono trattamenti differenziati) e hanno il diritto di votare sulla proposta concordataria. Se la maggioranza (in termini di crediti ammessi al voto) approva, il concordato può essere omologato dal tribunale e diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti.
Procedura di apertura: La domanda di concordato è presentata dall’imprenditore (può anche essere richiesta dai creditori o dal PM, ma il c.d. “concordato imposto” di fatto non esiste, poiché il debitore mantiene sempre la facoltà di presentare un piano – tranne che in casi di concordato liquidatorio richiesto dal P.M. in via di conversione dal fallimento, evento raro). Spesso l’imprenditore deposita una domanda di concordato “con riserva” (detta anche concordato in bianco), ossia un ricorso iniziale con cui si chiede l’ammissione alla procedura e la fissazione di un termine (da 60 a 120 giorni) per presentare il piano dettagliato e la proposta definitiva . Questo consente di ottenere immediatamente le protezioni del concordato (lo stay delle azioni esecutive ex art. 168 L.F., ora art. 54 CCII) e nominare eventuali organi ausiliari (commissario giudiziale) mentre si finalizza la stesura del piano e si completano le trattative con i creditori. Una volta depositato il piano e la proposta, il tribunale valuta l’ammissibilità (presenza dei requisiti di legge, fattibilità giuridica) e, se supera questo vaglio, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale (un professionista indipendente che vigilerà sulla gestione e riferirà ai creditori e al giudice). Da quel momento, la gestione dell’impresa rimane all’imprenditore (non c’è spossessamento come nel fallimento), ma è in regime di autosospensione controllata: gli atti di ordinaria amministrazione proseguono, quelli di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice previa sentito il commissario. L’impresa continua l’attività (soprattutto nei concordati in continuità) sotto la supervisione del commissario.
Effetti protettivi: Dalla data di pubblicazione del ricorso di concordato nel Registro delle Imprese, nessuna azione esecutiva individuale o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore. Eventuali pignoramenti in corso sono sospesi; non possono iscriversi ipoteche giudiziali; i termini di prescrizione rimangono sospesi e le decadenze pure. Questo blocco – disciplinato dall’art. 168 L.F., di cui la Cassazione ha enfatizzato la portata generale – offre respiro al debitore e preserva la par condicio: i creditori dovranno attendere l’esito del concordato per vedere come saranno soddisfatti. Inoltre, durante il concordato, il debitore non può pagare debiti anteriori (divieto di “pagamenti anteriori non autorizzati”), altrimenti violerebbe la par condicio. Anche qui, la Cass. 9522/2024 ha chiarito che questo divieto di pagamento, pur creando una temporanea moratoria dei contributi, pone l’impresa in una condizione di regolarità contributiva legale (da cui l’esonero dal DURC per contributi pubblici, come visto sopra) .
Votazione dei creditori: Una volta verificato il passivo e depositata la relazione del commissario sul piano, i creditori sono chiamati a esprimersi sulla proposta. La maggioranza richiesta è di solito doppia: più del 50% del totale dei crediti ammessi al voto (maggioranza per testa o meglio per somme), e se vi sono classi, anche la maggioranza delle classi deve approvare (principio di maggioranza delle classi, salvo cram-down giudiziale di classe dissenziente se soddisfatta adeguatamente). I crediti privilegiati che sono soddisfatti al 100% non votano (perché non toccati), a meno rinuncino al privilegio. I creditori pubblici (Fisco, INPS) votano come classe separata se la proposta prevede per loro un trattamento falcidiato tramite transazione fiscale. Dal punto di vista del debitore, la fase di voto è cruciale: occorre aver costruito consenso prima, durante la composizione negoziata o i contatti pre-concordato, altrimenti il rischio è la bocciatura (che tipicamente porta al fallimento).
Omologazione ed effetti finali: Se il concordato viene approvato dai creditori, il tribunale tiene un’udienza e procede a omologare la proposta, verificando anch’esso la convenienza per i creditori dissenzienti (nessuno deve risultare trattato in modo peggiore di come sarebbe in caso di liquidazione giudiziale). Con il decreto di omologazione, il concordato diviene definitivo ed efficace. A questo punto, l’imprenditore deve eseguire il piano come stabilito. La procedura può prevedere che il commissario diventi liquidatore giudiziale per vendere i beni (nei concordati liquidatori) oppure che resti un monitoraggio sulla continuità (nei concordati in continuità). Compiuta l’esecuzione, il tribunale dichiara chiuso il concordato. Il debitore (persona fisica) è liberato dai debiti anteriori non soddisfatti nei termini del concordato, similmente all’esdebitazione, per effetto stesso dell’omologazione (salvo obblighi eventualmente previsti per l’esdebitazione del sovraindebitato, se fosse un consumatore, ma nel caso di impresa commerciale fallibile questo coincide con la liberazione concorsuale). Se invece il debitore è una società, i crediti insoddisfatti restano inesigibili verso la società (che se cessa l’attività verrà poi cancellata).
Vantaggi dal punto di vista del debitore: Il concordato preventivo, per un imprenditore in grave crisi ma con un piano credibile di salvataggio o di liquidazione ordinata, è uno strumento potentissimo di difesa. Esso:
– blocca immediatamente i tentativi esecutivi dei singoli creditori, preservando l’integrità del patrimonio aziendale (niente più pignoramenti né incanti improvvisi);
– consente di spezzare i contratti troppo onerosi previa autorizzazione (ad esempio sciogliersi da un contratto di leasing o da un accordo di fornitura a prezzi insostenibili, pagando eventualmente un indennizzo come credito concorsuale);
– permette di sciogliere anche contratti di lavoro se necessario al piano, con procedure semplificate rispetto all’ordinario (colloqui sindacali ma efficacia immediata per ridurre organico in un concordato in continuità);
– soprattutto, consente di ridurre il debito complessivo in maniera vincolante: il debitore può proporre di pagare solo una percentuale dei crediti chirografari (anche bassa, se è il massimo ottenibile), e una volta omologato i creditori non potranno pretendere oltre. È la via regia per l’esdebitazione nell’insolvenza: a differenza del fallimento dove il debitore subisce la liquidazione e spera poi nel perdono del residuo, nel concordato è la stessa procedura a definire ex ante la quota che il debitore pagherà e a liberarlo del resto.
– consente di salvare l’impresa in molti casi: grazie alla moratoria e alla possibilità di reperire nuova finanza (anche in prededuzione o con garanzia dello Stato, vedi norma sui finanziamenti prededucibili nel concordato), l’azienda può continuare a operare. Se il piano è di continuità, i contratti con clienti e fornitori proseguono (salvo recesso per giusta causa, che tuttavia non può basarsi solo sulla clausola di concordato, considerata inopponibile). Ci sono esempi di aziende che, mediante concordati in continuità, hanno recuperato redditività e onorato il piano, uscendo dalla procedura e tornando operative a tutti gli effetti.
Svantaggi e considerazioni: Ovviamente, il concordato non è privo di costi e rischi: è una procedura pubblica (il ricorso viene iscritto e comunicato ai creditori, la notizia spesso finisce sui giornali locali, con potenziale danno reputazionale); richiede spese di procedura (compenso del commissario, spese legali e del tribunale) che vanno considerate; inoltre, dal momento del deposito del ricorso, l’imprenditore perde la gestione libera del patrimonio e deve sottostare alle limitazioni di legge (divieto di pagare debiti pregressi, ad eccezione di quelli autorizzati in prededuzione per la continuità – es. forniture indispensabili; divieto di contrarre nuovi debiti se non autorizzati; vigilanza continua). La violazione delle regole del concordato può portare alla revoca della procedura (ad esempio se si scoprisse che il debitore ha occultato parte dell’attivo o ha aggravato il passivo durante la procedura): la Cassazione ha chiarito che la revoca dell’ammissione al concordato ha natura sanzionatoria e tutela la corretta gestione della procedura . Dunque il debitore deve mantenere condotta irreprensibile e trasparente, pena la decadenza dai benefici. Se il concordato non viene approvato dai creditori o non omologato, si apre di regola la strada alla liquidazione giudiziale (spesso il tribunale dichiara il fallimento contestualmente al decreto di diniego di omologa), a meno che il debitore non abbia già un accordo alternativo da far valere. Quindi la decisione di andare in concordato va ponderata e preparata con cura. È, in un certo senso, l’ultima carta che un imprenditore gioca per evitare la fine disordinata: va giocata bene, con il supporto di professionisti (avvocati, consulenti) capaci di predisporre un piano convincente e di mediare con i creditori.
(Tabella 2 più avanti fornirà un confronto sintetico tra concordato, accordi e liquidazione giudiziale.)
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che subentra quando l’insolvenza è conclamata e non vi sono soluzioni alternative di risanamento. Fino al 2022 era denominata “fallimento” – termine che il nuovo Codice ha abbandonato a favore di una dizione più neutra, ma la sostanza rimane: si tratta della procedura diretta a liquidare tutto il patrimonio dell’imprenditore insolvente e distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni. Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale rappresenta certamente uno scenario negativo, in quanto comporta la spoliazione della gestione e l’assoggettamento a una procedura che di fatto segna la fine dell’impresa; ciononostante, vanno conosciuti i meccanismi, perché anche nella liquidazione giudiziale esistono tutele e possibili esiti di esdebitazione per la persona del fallito.
Presupposti e dichiarazione di liquidazione: La liquidazione giudiziale viene aperta con sentenza del tribunale su ricorso di un creditore, del debitore stesso (che può “autofallire” in caso di insolvenza non gestibile) o del pubblico ministero (in presenza di certe condizioni, ad esempio debiti tributari ingenti e insoluti, o protesti, etc.). Il presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza, definito come l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (desumibile da inadempimenti od altri fattori esteriori ex art. 2 CCII). Non esiste una soglia quantitativa rigida per dichiarare l’insolvenza (a parte l’esclusione dei piccoli imprenditori sotto soglia, di cui si è detto). La giurisprudenza richiede comunque una situazione grave, non temporanea, di impotenza finanziaria. Il tribunale valuta istruttoriamente la sussistenza dello stato d’insolvenza e, se lo accerta, pronuncia la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Da quel momento, l’imprenditore perde l’amministrazione dei suoi beni: si instaura il regime di spossessamento. Viene nominato un Curatore (figura analoga al vecchio curatore fallimentare) che ha il compito di gestire e liquidare l’attivo, sotto la sorveglianza del Giudice Delegato e del Comitato dei creditori.
Effetti sul debitore: La sentenza di liquidazione giudiziale è immediatamente esecutiva e comporta per il debitore (se persona fisica) diversi effetti: non può più disporre dei beni del suo patrimonio (ogni atto compiuto dopo la dichiarazione è inefficace rispetto ai creditori), deve consegnare i beni e le scritture contabili al Curatore, subisce il blocco di eventuali procedimenti esecutivi in corso (confluiscono tutti nella procedura collettiva), e perde la capacità di stare in giudizio per le liti attinenti al patrimonio (vi subentra il Curatore). Se il debitore è una società, gli amministratori decadono dai poteri e la rappresentanza spetta al Curatore; la società prosegue la sua esistenza giuridica durante la procedura (in funzione della liquidazione) ma cessa l’attività salvo esercizio provvisorio autorizzato. Il fallito persona fisica ha inoltre alcune incapacità personali durante la procedura (perde il diritto di amministrare eventuali eredità sopravvenute, può subire limitazioni negli atti di straordinaria amministrazione anche sul patrimonio futuro, ecc.), e fino alla chiusura della procedura non può avviare nuove imprese senza informare la curatela.
Liquidazione dell’attivo: Il Curatore compie un inventario dei beni, esamina le passività (i creditori devono insinuarsi al passivo entro termini stabiliti, producendo i titoli di credito) e predispone un programma di liquidazione. I beni vengono venduti all’asta o tramite procedure competitive sotto il controllo giudiziario; i crediti vengono riscossi o ceduti; eventuali azioni di responsabilità (ad esempio contro gli amministratori per mala gestio) vengono esercitate dal Curatore, così come le azioni revocatorie per recuperare pagamenti preferenziali o atti di distrazione compiuti prima del fallimento. In pratica, l’intera gestione del patrimonio passa in mano al Curatore, che agisce nell’interesse della massa creditoria. Il debitore può collaborare o anche proporre acquirenti, ma non ha potere decisionale. Durante la procedura, l’impresa di regola cessa di operare, salvo che il Curatore, con autorizzazione del tribunale, decida per un esercizio provvisorio (ad esempio, se l’azienda ha commesse in corso che conviene completare per incrementare il valore, o se c’è la prospettiva di cedere l’azienda in funzionamento a un terzo). Tuttavia, l’esercizio provvisorio è l’eccezione, e per periodi limitati: di norma in liquidazione giudiziale i dipendenti vengono licenziati (con accesso al fondo di garanzia e alla NASpI), gli impianti venduti, i contratti sciolti.
Formazione del passivo: I creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo e il Giudice Delegato, dopo istruttoria, forma lo stato passivo, l’elenco dei crediti ammessi con l’indicazione delle cause di prelazione, che rimarrà il riferimento per i riparti. I crediti privilegiati saranno soddisfatti con priorità, i chirografari pro quota su ciò che resta.
Esdebitazione nella liquidazione giudiziale: Uno degli aspetti più importanti, dal punto di vista del debitore persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile di società fallita), è la possibilità di ottenere l’esdebitazione al termine della procedura. Introdotta nel 2006 e confermata dal CCII, l’esdebitazione consente al fallito onesto e cooperativo di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti con la liquidazione . In pratica, dopo la chiusura del fallimento, il debitore può chiedere al tribunale di cancellare tutte le obbligazioni rimaste insoddisfatte, in modo da poter ripartire senza il peso dei vecchi debiti (fresh start). I requisiti sono: che il debitore non abbia riportato condanne per bancarotta fraudolenta o altri reati gravi in materia, che abbia cooperato durante la procedura (consegnato documenti, non occultato beni, ecc.), e che non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti. Non è più un requisito aver pagato una parte minima dei debiti – su questo la giurisprudenza si è evoluta: le Sezioni Unite della Cassazione inizialmente ritenevano necessaria almeno una soddisfazione parziale non “irrisoria” dei creditori, ma orientamenti più recenti (Cass. 27562/2024) hanno chiarito che non esiste una soglia fissa di pagamento richiesta per l’esdebitazione . Anche se il dividendo finale è molto basso (es. 1% ai chirografari), il tribunale deve valutare globalmente le circostanze e la condotta del debitore: un pagamento pur minimo non preclude l’esdebitazione, purché vi sia stata una liquidazione trasparente e il debitore sia meritevole . Solo nel caso estremo di zero assoluto recuperato – nessun attivo distribuito – la legge (art. 279 CCII) lascia intendere che l’esdebitazione potrebbe non spettare, salvo l’ipotesi particolare dell’“incapiente” di cui diremo. In concreto, oggi un imprenditore persona fisica fallito ha buone chances di liberarsi dai debiti post-fallimento se ha agito correttamente. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14835/2025 ha anche specificato che, per i fallimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e chiusi dopo tale data, si continua ad applicare la disciplina dell’esdebitazione della vecchia legge fallimentare (art. 142 L.F.), non quella del CCII – questo per questioni di diritto transitorio, ma il principio di fondo della liberazione resta.
Un caso particolare introdotto dal CCII è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): una novità assoluta che consente al debitore persona fisica meritevole ma privo di qualunque capacità di soddisfare i creditori di ottenere la cancellazione dei debiti residui anche se nel fallimento non è stato soddisfatto nulla . È un meccanismo pensato per dare speranza a chi davvero non ha più nulla – ad esempio, il piccolo imprenditore artigiano che, fallito, non riesce a dare alcun ritorno ai creditori perché il suo attivo era inesistente o esiguo. In tali casi, il debitore può chiedere l’esdebitazione immediata a fine procedura, con l’impegno morale che, se nei 4 anni successivi dovesse migliorare la sua condizione reddituale (oltre una certa soglia), parte di quei nuovi guadagni andranno ai vecchi creditori fino al 10% dei loro crediti. Questa è una misura di clemenza legislativa per evitare i cosiddetti “debiti perpetui” che disincentivano qualsiasi attività futura del fallito. La Cassazione sta gradualmente affrontando anche questi temi: ad esempio, l’ordinanza 15359/2023 ha ribadito la tassatività dei presupposti dell’esdebitazione e l’importanza di valutare la meritevolezza caso per caso .
Impatti per gli organi sociali: Nel caso di società, la liquidazione giudiziale può estendersi ai soci illimitatamente responsabili (come i soci di S.n.c. o accomandatari di S.a.s.) per estensione automatica ex art. 147 L.F. / art. 256 CCII. La Corte Costituzionale nel 2025 ha affrontato proprio un tema relativo al fallimento in estensione dei soci non coinvolti inizialmente , stabilendo (sent. 87/2025) che l’art. 147 L.F. – come interpretato dalla giurisprudenza – non è incostituzionale nella parte in cui non imponeva la convocazione dei soci illimitati nel procedimento prefallimentare della società (ha rigettato la questione di legittimità) . Ciò significa che ancora oggi un socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato fallito in estensione dopo che è fallita la società, anche se inizialmente non era stato sentito, purché gli siano poi concessi spazi di difesa nel procedimento a lui relativo. Questo per dire che per i soci di società di persone la dichiarazione di insolvenza li colpisce personalmente, mettendo a repentaglio il loro patrimonio privato. Tali soci potranno anch’essi chiedere l’esdebitazione come persone fisiche una volta conclusa la procedura.
Azioni di responsabilità e aspetti penali: Con la liquidazione giudiziale scattano frequentemente azioni di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (ex art. 2394 c.c. per danno a creditori, o 2476 c.c. per S.r.l.). Il Curatore, su autorizzazione del GD, può citarli in giudizio per atti di mala gestione che abbiano aggravato il dissesto. Ad esempio, la Cassazione (ord. 23963/2025) ha confermato la condanna di un amministratore che aveva effettuato pagamenti preferenziali a società a lui collegate e operazioni in conflitto di interessi, a risarcire il danno al fallimento . Questo rientra nelle difese indirette dei creditori: il Curatore agisce per recuperare attivo da chi ha causato la crisi. Sul fronte penale, l’apertura della liquidazione giudiziale comporta per il debitore l’eventuale instaurazione di un procedimento per reati fallimentari: se vi sono indizi di bancarotta fraudolenta (distrazione di beni, scritture falsificate, pagamenti preferenziali intenzionali) il Curatore li segnala al PM. L’imprenditore deve quindi essere consapevole che comportamenti illeciti tenuti prima del fallimento possono emergere e portare a conseguenze penali severe (la bancarotta fraudolenta patrimoniale è punita con reclusione fino a 6-10 anni, e quella documentale pure). Un debitore diligente che abbia evitato atti distrattivi e tenuto una contabilità regolare invece non avrà problemi sul piano penale, limitandosi a subire la procedura in sede civile. Da notare: l’esdebitazione non copre eventuali sanzioni penali o debiti per multe; inoltre non estingue debiti di natura personale come alimenti, oppure debiti verso il Fisco derivanti da sanzioni tributarie (questi ultimi in parte no, anche se c’è dibattito su come considerarli nella massa fallimentare, ma in linea di principio le sanzioni pecuniarie amministrative non pagate non vengono esdebitate perché non “civili”). Tuttavia, i debiti tributari per imposte e contributi sono oggetto di esdebitazione (la legge prevede espressamente che l’esdebitazione riguarda anche l’Erario, che quindi non può più pretendere le imposte rimaste insoddisfatte dal fallito esdebitato).
Chiusura della procedura: La liquidazione giudiziale si chiude con decreto del tribunale quando: o tutto l’attivo è stato liquidato e ripartito, oppure (evento comune) quando si constata che non vi sono più beni realizzabili sufficienti a proseguire (c.d. chiusura per insufficienza dell’attivo). La chiusura per insufficienza attivo non libera il fallito dai debiti (salvo esdebitazione): i creditori potrebbero teoricamente tornare ad agire verso di lui su sopravvenienze (ad esempio, se eredita un bene). La Cassazione ha sottolineato che la chiusura del fallimento non estingue i debiti insoddisfatti – essi rimangono ma non possono essere perseguiti durante la procedura; terminata questa, i creditori riacquistano il diritto di agire per la parte non soddisfatta (il che giustifica l’importanza dell’esdebitazione per porre fine davvero all’incubo debitorio).
In definitiva, la liquidazione giudiziale va vista come l’extrema ratio. Dal punto di vista del debitore/imprenditore, dichiarare fallimento significa perdere l’azienda e i beni, ma non è la fine della vita economica: grazie alle norme sull’esdebitazione, può diventare un nuovo inizio privo dei debiti passati. C’è persino un detto: “meglio un fallimento oggi che una schiavitù dei debiti per sempre”. Naturalmente, se vi sono alternative praticabili (concordato, accordi) conviene perseguirle; ma se ogni tentativo fallisce, affrontare con dignità la liquidazione giudiziale, collaborare col Curatore, evitare condotte che possano portare a accuse di bancarotta, e puntare alla riabilitazione personale tramite esdebitazione è la strategia corretta per “difendersi” anche in questa fase. In tal modo, l’imprenditore – specie se individuale – potrà a distanza di qualche anno tornare ad operare pulito, avendo pagato il prezzo del fallimento ma non essendo condannato a vita dai creditori.
(Segue una sezione di Domande & Risposte, tabelle riepilogative e casi pratici per chiarire ulteriormente quanto esposto.)
Domande frequenti (FAQ) sulla difesa del debitore in crisi
D: La mia società è piena di debiti: verrà dichiarata fallita automaticamente?
R: No. Il fallimento (ora liquidazione giudiziale) non è automatico, ma richiede una pronuncia del tribunale su istanza di un creditore, del debitore stesso o del pubblico ministero. Se l’azienda è insolvente (incapace di pagare regolarmente i debiti) e non adotta altre soluzioni (es. concordato), i creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale. Tuttavia, esistono soglie di non fallibilità per i piccoli imprenditori: se la sua impresa rientra nei limiti dimensionali previsti (attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k, come riferimento usuale), potrebbe essere qualificata come imprenditore minore e dunque non soggetta a fallimento ma semmai alle procedure di sovraindebitamento . In ogni caso, anche sopra soglia, il fallimento può essere evitato attivando in tempo strumenti di risanamento (concordato preventivo, accordi, composizione negoziata). Se la società ha prospettive di continuità o di miglior soddisfacimento creditori fuori dal fallimento, il tribunale può privilegiare quelle soluzioni. Quindi non è automatico: dipende da iniziative di parte e dall’assenza di alternative percorribili.
D: Ho debiti fiscali molto alti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Posso ottenere uno sconto o devo pagarli per intero?
R: È possibile ottenere riduzioni sui debiti fiscali, ma non tramite una semplice richiesta unilaterale: occorre utilizzare gli strumenti legali disponibili. Al di fuori delle procedure concorsuali, periodicamente le leggi prevedono definizioni agevolate (“rottamazione delle cartelle”) in cui vengono abbuonati interessi e sanzioni, facendo pagare solo imposta e aggio in forma dilazionata. Ad esempio, la “rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 ha consentito di pagare i ruoli fino al 2017 senza sanzioni né interessi di mora, in 18 rate. Bisogna verificare se i suoi debiti rientrano in qualche finestra agevolata. In sede concorsuale, invece, esiste la transazione fiscale: all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato si può proporre al Fisco un pagamento parziale del credito tributario (anche del credito privilegiato per imposte, differendo dalla regola generale che i privilegiati vanno pagati integralmente). La legge oggi consente, in caso di dissenso dell’Erario, che il tribunale omologhi comunque il piano se ritiene che al Fisco venga offerto almeno quanto otterrebbe in liquidazione . Questo è il cosiddetto cram-down fiscale. Dunque, nel contesto di un piano concordatario, può legittimamente offrire uno sconto sul debito fiscale (IVA compresa) motivato dalle prospettive di realizzo: se l’alternativa fallimentare darebbe zero, offrire ad esempio il 30% in concordato può essere ragionevole e approvabile. Al di fuori del concordato, AER non può autonomamente ridurre il tributo (salvo appunto le rottamazioni decise per legge). Può però concedere rateizzazioni fino a 72 rate mensili (6 anni) standard, o fino a 120 rate in casi di comprovata grave difficoltà. Quindi: sì, è possibile ridurre o dilazionare i debiti fiscali, ma attraverso specifici istituti – occorre pianificare un approccio negoziale o concorsuale. Un consulente fiscale esperto valuterà la strada migliore in base all’entità del debito e alla situazione aziendale.
D: I soci di una SRL o SPA rispondono con il loro patrimonio personale dei debiti della società?
R: In linea generale no, i soci di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) hanno responsabilità limitata: rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale sottoscritto (perdendo semmai il valore delle loro quote, ma non oltre). Il patrimonio personale dei soci è dunque al riparo dai debiti aziendali. Fanno eccezione i casi in cui un socio abbia rilasciato garanzie personali (fideiussioni, avalli) in favore di creditori sociali – situazione frequente con le banche: se il socio o amministratore ha garantito un mutuo aziendale, allora la banca potrà escutere lui per il pagamento integrale, indipendentemente dalla responsabilità limitata. Altro caso di eccezione: se viene accertato un abuso della personalità giuridica, ad esempio una confusione tra patrimonio sociale e personale, i creditori potrebbero tentare un’azione di responsabilità extra codice civile (la cosiddetta “azione di lifting del velo societario” – teoricamente ammissibile in caso di frode, sottocapitalizzazione fittizia, etc., sebbene rara in giurisprudenza italiana). Inoltre, i soci amministratori potrebbero incorrere in responsabilità risarcitorie indirette: ad esempio, se hanno aggravato il dissesto con atti dolosi o colposi, il curatore fallimentare può citarli per danni e colpire il loro patrimonio personale . Ma tale responsabilità non discende dallo status di socio in sé, bensì da condotte di mala gestio. In sintesi, per il socio “investitore” che non ha prestato garanzie né commesso irregolarità, il peggior effetto dei debiti sociali è vedere azzerato il valore della propria partecipazione e perdere eventuali finanziamenti soci non rimborsati; non rischia la casa o i beni personali. Al contrario, i soci di società di persone (S.n.c., soci accomandatari di S.a.s.) sì, hanno responsabilità illimitata e solidale: in quel caso tutti i loro beni possono essere aggrediti per soddisfare i debiti sociali. Ma nel quesito si parla di SRL, quindi vale la regola della distinzione patrimoniale.
D: La crisi di liquidità può scusarmi per non aver pagato l’IVA o i contributi?
R: Purtroppo no, la crisi di liquidità di per sé non è considerata dalla legge italiana una giustificazione per l’omesso versamento di tributi o contributi quando questi integrano reato. La giurisprudenza penale è costante nel ritenere che le difficoltà finanziarie rientrano nel rischio d’impresa ordinario e non configurano forza maggiore, a meno di eventi davvero eccezionali e non imputabili all’imprenditore . Per esempio, se un imprenditore sceglie di pagare stipendi e fornitori ma di non versare l’IVA, pur animato da intenzioni di sopravvivenza aziendale, commette comunque il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) se supera la soglia di punibilità, perché si considera che abbia volontariamente allocato le risorse altrove sapendo di non pagare l’imposta. In passato i giudici erano molto severi: condanne per omesso versamento scattavano quasi automatiche quando c’era la soglia superata. Recentemente, con la riforma del 2024, si è introdotto un temperamento: il reato si perfeziona solo se l’imprenditore non si attiva in alcun modo per pagare (non chiedendo rateazione entro i termini, o facendosi decadere da una rateazione) . Quindi, se lei è in crisi e non può pagare l’IVA, la cosa migliore da fare per evitare il penale è: presentare la dichiarazione IVA comunque, e poi chiedere un piano di rateizzo all’Agenzia Entrate (ad esempio 6 anni). Finché il piano è in essere e lei paga le rate, il nuovo art. 10-ter modificato la considera non punibile (il reato è sospeso fino a fine anno successivo e poi neanche sorge se le rate vengono onorate) . Se invece non paga nulla e non chiede aiuti, alla scadenza del termine per la rateazione (oggi 30 aprile dell’anno successivo per l’IVA) scatterebbe la condizione di punibilità. Per i contributi INPS, la soglia è molto più bassa (€10.000 annui) e la crisi di liquidità non esclude il reato oltre quella soglia, se entro 3 mesi dal termine non si è pagato. In conclusione, la crisi economica di per sé non la scusa; tuttavia il legislatore le offre strumenti per gestire legalmente il problema (rateazioni, richiesta di fondo di solidarietà, cassa integrazione per alleggerire i costi del personale, accesso a procedure concorsuali). Anche in sede penale, talvolta alcune sentenze hanno assolto imprenditori dimostratisi assolutamente impossibilitati (ad esempio, mancato incasso di crediti importanti che dovevano servire a pagare l’IVA ). Ma sono casi limite e serve provare che l’evento era imprevedibile e fuori dal controllo (e.g. calamità naturali, insolvenze di sistema). La regola rimane che la liquidity crunch non è di per sé esimente. Quindi è essenziale attivarsi per tempo con gli strumenti leciti di differimento e, se ciò non basta, mettere in sicurezza l’azienda tramite un percorso concordatario piuttosto che accumulare reati.
D: Sto valutando il concordato preventivo. Che differenza c’è rispetto al piano attestato o all’accordo di ristrutturazione?
R: Si tratta di tre strumenti diversi per natura e grado di coinvolgimento del tribunale:
– Il piano attestato di risanamento è un accordo stragiudiziale, che non richiede l’approvazione del tribunale. È fondato sul consenso privato dei creditori coinvolti e sull’attestazione di un esperto indipendente circa la fattibilità. Serve soprattutto a proteggere da revocatorie i pagamenti/garanzie eseguiti in esecuzione del piano . Non offre di per sé protezione dalle azioni esecutive (nessun automatic stay), per cui è indicato se pensa di ottenere rapidamente e in silenzio l’adesione dei creditori principali.
– L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F., ora art. 60 CCII) sta a metà: è un accordo volontario ma con omologazione del tribunale. Serve il consenso di almeno il 60% dei crediti, e l’omologa rende l’accordo efficace anche verso i creditori non aderenti, purché pagati integralmente secondo i termini dell’accordo. Offre misure protettive (può chiedere il blocco delle azioni esecutive durante l’omologazione). Non comporta votazione di tutti i creditori come nel concordato, ma solo adesione minima qualificata e controllo giudiziale. È uno strumento meno “invasivo” del concordato, indicato se riesce ad avere l’appoggio della maggior parte dei creditori (di solito banche) e vuole un risultato più vincolante del semplice piano attestato. Ad esempio, consente di forzare (entro limiti) anche creditori dissenzienti minoritari.
– Il concordato preventivo è la procedura concorsuale completa: coinvolge tutti i creditori, è pubblica, comporta la gestione sotto controllo del tribunale e degli organi nominati, e richiede il voto favorevole della maggioranza dei creditori (o delle classi). A differenza dei precedenti, può imporre tagli e ristrutturazioni anche a chi è contrario, purché la maggioranza sia d’accordo. Offre il massimo livello di protezione (stop totale ai creditori ex lege) e consente soluzioni anche senza l’adesione di molti (ti basta convincere oltre il 50%). È però la più complessa e costosa da gestire.
In sintesi: se la situazione è ancora gestibile in bonis con il dialogo e credi di poter ottenere accordi da almeno 60% dei crediti, un accordo di ristrutturazione potrebbe essere preferibile (meno oneroso del concordato, più flessibile, e con alcune recenti innovazioni come cram-down fiscale ). Se invece la crisi è estesa, i creditori sono tanti e frammentati e serve congelare tutto subito, il concordato preventivo offre un ombrello più ampio. Il piano attestato resta l’opzione più leggera e confidenziale, ma efficace solo con accordo di fatto di (quasi) tutti i creditori rilevanti e con rischio residuo di iniziative ostili di eventuali esclusi. Spesso si parte magari con un piano attestato; se non basta, si passa a un accordo 182-bis; se ancora non si risolve, si entra in concordato. Ogni step comporta un crescente intervento giudiziario e una maggiore certezza di risultato vincolante.
D: Durante un concordato preventivo posso continuare a partecipare a gare pubbliche o ottenere finanziamenti agevolati?
R: In linea di principio sì, purché siano rispettate certe condizioni. Uno dei requisiti spesso richiesti nei bandi e per erogazioni pubbliche è la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa (DURC regolare). Quando un’impresa è in concordato preventivo, come visto, per legge essa non può pagare i debiti pregressi (inclusi contributi e imposte scadute) a causa del divieto di cui all’art. 168 L.F. Ciò creava un cortocircuito: l’azienda in concordato avrebbe un DURC irregolare e quindi non potrebbe qualificarsi per gare o contributi, frustrando il tentativo di continuità. A tal proposito è intervenuta la giurisprudenza (Cass., ord. 9522/2024) chiarendo che la presentazione della domanda di concordato e il conseguente divieto legale di pagamento collocano l’impresa in una situazione di regolarità contributiva “di diritto” . In altre parole, durante il concordato l’azienda è come se fosse “in bonis” quanto a obblighi contributivi, perché la moratoria imposta dalla legge non può andare a suo discapito nei rapporti con la P.A. Conseguenza pratica: l’impresa ammessa a concordato preventivo può richiedere il DURC e questo deve essere rilasciato come regolare (limitatamente al periodo di procedura), in quanto si considera sospeso l’obbligo di versamento. Dunque può partecipare a gare d’appalto (spesso però il bando richiede di comunicare lo stato di concordato; alcune stazioni appaltanti potrebbero subordinare la partecipazione a una specifica autorizzazione del tribunale che dichiari la capacità di portare a termine il contratto – autorizzazione che il debitore in concordato può chiedere ex art. 95 CCII). Quanto a finanziamenti agevolati o contributi pubblici, similmente, non può essere negata l’erogazione solo per DURC irregolare se l’irregolarità dipende dal concordato stesso. La Cassazione nel caso di una cooperativa editoriale in concordato ha confermato il diritto a ricevere i contributi statali all’editoria, senza dover presentare il DURC, proprio per questa ragione . Ovviamente l’impresa deve essere in concordato in continuità (se è liquidatorio e cessa attività, sarebbe diverso: lì l’interesse a partecipare a gare nuove non c’è). In sintesi, il concordato non preclude la partecipazione a gare o l’accesso a fondi pubblici, a patto di rispettare le formalità (comunicare lo stato concorsuale) e far valere i propri diritti. Anzi, la legge e la giurisprudenza hanno voluto rimuovere ostacoli per favorire la prosecuzione dell’attività: proprio perché l’obiettivo del concordato in continuità è evitare l’uscita dal mercato dell’azienda. Quindi, da debitore, faccia valere la pronuncia della Cassazione e le norme relative per ottenere i documenti di regolarità necessari.
D: Se la mia società fallisce, i creditori potranno rivalersi su di me in futuro per i debiti non pagati?
R: Dipende dalla forma giuridica e dalle circostanze. Se la sua società è di capitali (Srl, Spa) e lei non ha garanzie personali in essere, i creditori insoddisfatti dopo la chiusura del fallimento non potranno agire ulteriormente né verso la società (che verrà cancellata) né verso di lei personalmente, salvo che si configurino eccezioni di responsabilità specifiche. In generale, la chiusura della procedura concorsuale segna il termine del concorso dei creditori e la fine dell’esecuzione collettiva, ma non estingue formalmente i debiti: semplicemente la società debitrice viene cancellata e cessa di esistere, e i crediti rimangono insoddisfatti senza soggetto da perseguitare. I creditori sociali potrebbero tentare azioni verso gli ex amministratori o soci per responsabilità personali (es. azione ex art. 2476 comma 7 c.c. se c’è stato danno da mala gestio, o verso soci se vi sono stati indebiti prelievi), ma non esiste un titolo esecutivo diretto per recuperare da lei come ex titolare della società un debito sociale residuo. Se invece lei fosse un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile di società di persone, allora il fallimento la coinvolge personalmente e, a fine procedura, i creditori tornerebbero in teoria a poter agire sul suo patrimonio futuro per i crediti non soddisfatti . In tal caso, per evitare che ciò accada, c’è l’istituto dell’esdebitazione: lei, come persona fisica fallita, potrà chiedere al tribunale di essere liberato da tutti i debiti residui dopo la chiusura del fallimento . Se viene concessa (e viene concessa nella stragrande maggioranza dei casi in cui il fallito ha collaborato), i creditori non potranno più perseguirla per quei debiti. Quindi, concretamente:
– Se il debitore è una società: alla chiusura la società viene cancellata, i debiti insoddisfatti diventano inesigibili (non c’è più il soggetto). I creditori possono rivalersi solo se esistono garanti (ad esempio un coobbligato, un fideiussore, un’assicurazione) o se individuano cause di responsabilità contro amministratori/sindaci. Ma non possono chiedere ai soci di una Srl il pagamento dei residui solo perché erano soci (a meno di casi fraudolenti con dolo dei soci, ma parliamo di situazioni straordinarie).
– Se il debitore è persona fisica fallita: i creditori riacquistano il diritto di agire per il non pagato, ma se il fallito ottiene l’esdebitazione, tale diritto viene meno definitivamente .
In conclusione, di norma lei non sarà perseguito per i debiti residui se parliamo di società di capitali. Qualora invece ne fosse personalmente debitore (ditta individuale), punti all’esdebitazione per mettersi al riparo. Ricordo anche che alcuni debiti particolari non rientrano nell’esdebitazione (ad esempio debiti alimentari verso familiari, obblighi di mantenimento, certi debiti da risarcimento danni per illecito extracontrattuale non inclusi, multe penali): per quelli, il creditore potrebbe ancora agire anche post-fallimento. Ma trattasi di eccezioni. La regola per i debiti d’impresa commerciali è: o li paga la procedura concorsuale, o se non li paga nessuno, amen – il debitore persona giuridica scompare, quello persona fisica viene perdonato.
D: Cosa posso fare per difendermi se un creditore ottiene un pignoramento o un decreto ingiuntivo?
R: Dipende dalla situazione finanziaria generale e dalla fondatezza del credito. Le opzioni principali:
– Opporsi legalmente: se il creditore ha chiesto un decreto ingiuntivo e lei ha motivi per contestare il debito (perché non dovuto, errato, già pagato, prescritto, ecc.), presenti opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Ciò porterà la questione in giudizio ordinario, dandole tempo e possibilità di difesa. Similmente, se scatta un pignoramento, può proporre opposizione all’esecuzione (per contestare ad esempio vizi formali, illegittimità dell’azione, impignorabilità di certi beni) o chiedere al giudice della esecuzione una sospensione se ha ragioni forti (ad esempio, sta per depositare domanda di concordato). Le opposizioni giudiziarie vanno seguite da un avvocato esperto in procedure esecutive.
– Chiedere misure protettive concorsuali: se il debito è legittimo ma lei ha bisogno di tempo per sistemare le cose in modo unitario, l’alternativa è attivare subito una procedura concorsuale o di composizione negoziata. Ad esempio, depositando un ricorso per concordato preventivo “in bianco”, la legge blocca immediatamente tutte le azioni esecutive (art. 168 L.F.) – quindi ferma anche pignoramenti in corso (essendo che il giudice li sospende). Oppure, avviando la composizione negoziata, può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono i pignoramenti. Questa seconda via è indicata se la situazione di debito è generale e non isolata: in pratica, invece di difendersi creditore per creditore, portarla su un tavolo unico dove tutte le esecuzioni sono congelate e si cerca un accordo globale o un piano.
– Negoziare con il creditore: una via di difesa “morbida” è contattare subito il creditore che ha avviato l’azione e proporre una soluzione bonaria: ad esempio, offrire un pagamento parziale immediato per far ritirare il pignoramento, oppure concedere garanzie in cambio di una dilazione. Molti creditori sono disponibili a ritirare l’azione legale se vedono serietà e intravedono un rientro concreto, pur se graduale. Formalizzate sempre per iscritto eventuali accordi, chiedendo all’avvocato di controparte di sospendere la procedura nel frattempo.
– Tutela del patrimonio personale: se il pignoramento riguarda beni essenziali (p.es. macchinari cruciali per l’attività), e lei ha già in mente di fare un concordato, può chiedere al tribunale, anche prima del concordato, un provvedimento d’urgenza per sospendere quell’azione esecutiva in vista del deposito della domanda (si è visto raramente ma è teoricamente possibile ex art. 55 CCII). Se riguarda conti bancari e rischia di paralizzare l’attività, la mossa di presentare un concordato in bianco è molto efficace: appena depositato, comunica la pendenza del concordato all’ufficiale giudiziario e in banca, e in forza della legge il pignoramento di solito viene congelato, permettendole di usare i conti per la gestione corrente autorizzata (in concordato, il giudice può anche sbloccare somme pignorate se servono per la continuità).
In sintesi, la difesa immediata contro l’aggressione del singolo creditore passa o da una reazione processuale (opposizioni) o da uno scudo concorsuale (concordato/composizione). La scelta dipende se la pretesa è contestabile nel merito (allora l’opposizione ha senso) o se è fondata ma lei ha bisogno di tempo/soluzione generale (allora meglio il concorsuale). Tenere comunque presente che l’opposizione allunga i tempi ma, se alla fine risulta che il debito c’era, avrà solo differito l’inevitabile salvo nel frattempo aver trovato liquidità o concordato. Per questo, l’opposizione fine a sé stessa spesso serve solo a prendere fiato, e di quell’ossigeno deve approfittare per strutturare una soluzione definitiva (accordo, piano, rifinanziamento).
D: Una volta chiusa la procedura (concordato o fallimento), posso aprire una nuova attività?
R: Sì, in generale nulla vieta di aprire una nuova attività imprenditoriale dopo la chiusura di un concordato o anche dopo il fallimento, ma con alcune precisazioni:
– Se ha chiuso un concordato preventivo regolarmente adempiuto, l’impresa può proseguire la sua vita (nel caso di concordato in continuità) oppure, se era liquidatorio, dopo l’omologa può anche succedere che la società venga cancellata. Tuttavia, gli ex soci o lo stesso imprenditore individuale possono immediatamente costituire una nuova società o una nuova impresa e ripartire – non ci sono preclusioni legali né interdizioni a farlo, a patto che abbiano adempiuto gli obblighi concordatari. Anzi, il concordato non comporta neppure incapacitazioni personali (non è un fallimento con interdizione). Quindi l’imprenditore può tranquillamente ricominciare.
– Se ha subito una liquidazione giudiziale (fallimento), durante la procedura il fallito persona fisica è soggetto a una incapacità temporanea: non può avere una nuova impresa, né assumere cariche societarie senza informare il giudice. Dopo la chiusura del fallimento, questa incapacità cessa. Dunque, formalmente potrà tornare ad aprire una partita IVA e avviare un’attività. Bisognerà però considerare gli aspetti pratici: il reputational risk (banche e fornitori sapranno del precedente fallimento e potrebbero essere cauti nel concederle fido), e la questione di aver ottenuto o meno l’esdebitazione. Se è esdebitato, riparte pulito senza code; se non fosse esdebitato, i vecchi creditori potrebbero ancora infastidirlo su redditi futuri (ma se è persona fisica conviene sempre chiedere esdebitazione per evitarlo). Inoltre, ci sono alcuni ruoli da cui il fallito è interdetto per un periodo: ad esempio, per la legge fallimentare, i falliti non potevano ricoprire cariche di amministratore di società per 5 anni salvo riabilitazione. Col CCII la riabilitazione fallimentare è sostanzialmente automatica con l’esdebitazione o la chiusura senza rilievi; però, per dire, se volesse fare l’imprenditore in settori regolati (es. finanza, appalti pubblici) potrebbero esserci restrizioni temporanee legate al precedente fallimento. Nel settore pubblico appalti, un fallimento nei 5 anni precedenti era causa di esclusione se non c’era continuità dell’impresa. Come persona fisica, dopo l’esdebitazione, lei ottiene anche la riabilitazione civile, quindi recupera ogni diritto.
– Attenzione: se il suo fallimento è stato caratterizzato da reati di bancarotta e c’è una condanna, allora la pena accessoria potrebbe includere l’interdizione all’esercizio di impresa o a rivestire cariche societarie per un certo periodo (fino a 10 anni in casi gravi). Quella è una limitazione seria. Ma confido che uno scenario del genere non la riguardi se ha gestito onestamente.
In assenza di condanne penali, quindi, può tornare a fare impresa. Molti imprenditori falliti di successo in Italia sono ripartiti poi con nuove aziende (pensiamo a casi celebri di imprenditori che dopo il fallimento hanno avuto secondi inizi). La legge vuole proprio consentire il fresh start, perché l’economia ne beneficia se chi ha imparato da un insuccesso può rimettersi in gioco senza stigma perpetuo. Grazie all’esdebitazione, potrà farlo senza trascinarsi i vecchi debiti come palla al piede.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Tipologie di debiti d’impresa, conseguenze e possibili difese
| Tipologia di debito | Esempi comuni | Conseguenze principali se insoluto | Strumenti di difesa del debitore |
|---|---|---|---|
| Debiti fiscali (Erario) | IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali | – Cartelle esattoriali da Agenzia Entrate Riscossione<br>– Sanzioni e interessi di mora crescenti<br>– Possibili ipoteche su immobili (> €20k) e fermi amministrativi su veicoli (> €1k)<br>– Pignoramento di conti correnti e beni mobili da parte di AER (anche senza decreto ingiuntivo)<br>– Azione revocatoria Erario su atti dispositivi pregiudizievoli (entro 1 anno dalla notifica cartella)<br>– Se importi rilevanti: segnalazione al PM per reati tributari (omesso versamento IVA > €75k; omesso versamento ritenute > €50k dal 2024) | – Rateizzazione fino a 6 anni (standard) o 10 anni (piani straordinari) per importi elevati e temporanea difficoltà, per diluire l’esborso<br>– Definizioni agevolate (quando previste da legge: es. “rottamazione” delle cartelle con stralcio di sanzioni e interessi) <br>– Transazione fiscale in procedure concorsuali: proporre pagamento parziale/dilazionato di imposte in concordato o accordo omologato (anche senza adesione Fisco, col cram-down) <br>– Composizione negoziata: possibilità di accordi ad hoc con l’Erario (sospensione delle esecuzioni, richiesta di dilazioni ex art. 19 DPR 602/73 durante le trattative)<br>– Tutela penale: evitare soglie di punibilità tramite pagamenti parziali o richieste di rate; se reato configurato, preparare difesa dimostrando eventuale forza maggiore (difficile) o attivarsi per pagare prima di processo (possibile causa di non punibilità se integrale pagamento prima della dichiarazione di apertura dibattimento, ai sensi art. 13 D.Lgs. 74/2000) |
| Debiti verso INPS/INAIL (contributi previdenziali) | Contributi dipendenti (IVS), contributi datori di lavoro, premi INAIL | – Cartelle esattoriali analoghe a quelle fiscali (INPS affida a AER il recupero dei contributi non versati)<br>– Sanzioni civili per ritardato pagamento (sanz. ridotte se rateizza prima di notifica cartella)<br>– DURC irregolare: preclusione da appalti pubblici e incentivi finché non regolarizza (salvo eccezione concordato) <br>– Reato di omesso versamento ritenute previdenziali > €10.000 annui (contravvenzione penale) ; importi ≤ €10.000: sanzione amministrativa 1,5-4 volte l’omesso <br>– Possibile azione di responsabilità personale verso amministratori per mancato versamento contributi trattenuti ai dipendenti (in alcuni casi INPS può agire ex art. 2394 c.c. se danno a creditori) | – Rateizzazione INPS (fino 24 rate mensili, estensibili a 36-60 rate in casi speciali) per rimettersi in regola e ottenere DURC<br>– Dilazione su cartelle tramite AER (come per debiti fiscali)<br>– Rimessione in bonis: pagamento entro 3 mesi dal termine per evitare la punibilità penale (il reato non scatta se versi i contributi dovuti entro 90 gg dalla contestazione o dall’accertamento) <br>– Concordato preventivo: sospende l’obbligo di pagamento contributi pregressi, quindi DURC considerato regolare e azienda può continuare operatività ; nel piano possibile transazione contributiva (pagamento parziale di contributi privilegiati con voto INPS)<br>– Esdebitazione finale: eventuali contributi rimasti non pagati in fallimento vengono resi inesigibili verso il debitore con l’esdebitazione (INPS compreso) (le sanzioni amministrative pecuniarie però non sono debiti civili, quindi quelle eventualmente restano) |
| Debiti bancari e finanziari | Mutui ipotecari, leasing macchinari, affidamenti di conto, emissioni obbligazionarie, finanziamenti soci | – Decadenza dal termine in caso di mancato pagamento rate: la banca può esigere subito l’intero debito residuo<br>– Azione esecutiva rapida sulla base di titoli esecutivi (contratti di mutuo bancari sono titoli esecutivi stragiudiziali) – es. pignoramento immobili ipotecati senza passare dal tribunale se mutuo non pagato<br>– Escussione di garanzie: fideiussioni (escusse su patrimonio personale di chi le ha rilasciate), pegni (realizzazione del pegno su titoli/merci), riserva di proprietà (es: leasing, il bene può essere ripreso)<br>– Segnalazione in Centrale Rischi di Bankitalia come sofferenza: impatto reputazionale e blocco accesso a nuovo credito<br>– Possibile istanza di fallimento se credito rilevante e impresa insolvente (le banche spesso la usano per tutelare interessi generali e accelerare il recupero)<br>– Eventuale revoca fidi e scoperti, con obbligo immediato di rientro | – Piano di ristrutturazione del debito bancario: negoziare con le banche una moratoria (sospensione pagamenti quota capitale per 6-12 mesi) o un refinancing (nuovo prestito che paga il vecchio alle nuove condizioni, magari assistito da garanzie pubbliche come Fondo PMI)<br>– Accordo di ristrutturazione ex 182-bis: coinvolgere le banche in un accordo omologato che consente di estendere ai dissenzienti (se almeno 75% aderisce, l’accordo vincola tutte le finanziarie classificate come omogenee) ; vantaggio: blocca azioni esecutive e consente cram-down di minoranza<br>– Concordato in continuità: può prevedere la continuazione dei rapporti bancari essenziali (ad es. mantenimento conto per incassi) con autorizzazione del tribunale; eventuali crediti bancari ipotecari sono rinegoziabili nel piano (allungamento scadenze, pagamento parziale se ipoteca eccedente valore bene ecc.), con soddisfazione almeno pari al valore di realizzo del bene in vendita coattiva<br>– Consolidamento debiti con intervento terzo: trovare un investitore o fondo che rilevi i debiti bancari a sconto (le banche cedono NPL a recuperatori con forti sconti) e poi concordare con lui un nuovo piano – difesa fuori tribunale ma praticabile se appare sul mercato un soggetto interessato<br>– Difesa tecnica su contratti: verificare se tassi applicati sono usurari o se vi sono clausole invalide (anatocismo, indeterminatezza); agire giudizialmente per far rideterminare il debito (questo non elimina il debito ma riduce l’entità e crea spazio negoziale)<br>– Garanzie personali: se ha dato fideiussione, valuti con legale se è nulla (molte fideiussioni omnibus bancarie ante 2018 sono state ritenute nulle perché conformi a schema ABI censurato da Antitrust, aprendo brecce per non pagare); oppure proteggere il proprio patrimonio attraverso i benefici di escussione (chiedere di escutere prima la società garantita) |
| Debiti verso fornitori (trade) | Fatture per acquisto materiali, servizi; canoni di locazione immobile; bollette utenze aziendali | – Interessi moratori commerciali elevati ex D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE +8% circa) dal giorno successivo alla scadenza fattura, salvo patti diversi<br>– Fornitore può sospendere ulteriori forniture se il contratto lo permette per inadempimento (rischio di stop produttivo per mancanza materie)<br>– Azioni legali individuali: decreto ingiuntivo (ottenibile rapidamente se ha fatture e DDT), seguito da pignoramenti su conto, su merci in magazzino, su crediti verso clienti (blocco incassi via pignoramento presso terzi), su macchinari non vincolati (con però rischio revocatoria se li vendesse)<br>– Possibile precetto e istanza di fallimento se l’inadempimento è grave e persistente (anche piccoli fornitori in gruppo possono provocare il fallimento)<br>– Se fornitore ha riserva di proprietà sul bene venduto, può rivendicarlo (reclamo restituzione) se non pagato, privandola di quell’asset<br>– Recesso/risoluzione di contratti in corso per inadempimento (es: appaltatore non pagato subappaltatori, questi risolvono)<br>– Rapporti deteriorati: perdita fiducia nella filiera, passaggio a anticipi o contrassegno | – Gestione proattiva: comunicare con fornitori chiave, riconoscere il problema e proporre soluzioni come piani di rientro rateali o parziali (saldo e stralcio) prima che intraprendano vie legali. Formalizzare accordi transattivi (meglio con clausola che credito si estingue se pagato tot) per evitare di pagare interamente con risorse che non ha<br>– Moratoria consensuale multi-fornitore: se i fornitori appartengono a una filiera (es. cluster di subfornitori), convocarli insieme spiegando la situazione e proponendo temporanea moratoria dei pagamenti per X mesi seguita da ripresa parziale: avere tutti d’accordo evita che uno corra in tribunale (perché sanno che se tengono duro forse recuperano ordini futuri). Non è facile da coordinare, ma alcuni distretti lo fanno per non mandare in crisi l’intero ecosistema produttivo<br>– Composizione negoziata con fornitore strategico: far intervenire l’esperto negoziatore per convincere fornitori critici a proseguire fornitura e attendere, magari offrendo garanzie aggiuntive (pegno su prodotto finito, accordo di distribuzione futura, ecc.) sotto supervisione dell’esperto<br>– Concordato preventivo: congelare tutti i debiti verso fornitori e proporre loro un pagamento percentuale (es: 30%) in xx mesi come dividendo concordatario. In questo caso il fornitore non può più agire individualmente e deve attendere l’esito: se il concordato viene omologato, riceverà quella percentuale e il resto è inesigibile. Se rigettato, potrà riprendere azioni, ma intanto l’azienda ha avuto respiro. Concordato in continuità mantiene i contratti essenziali in essere (fornitore non può risolvere se la fornitura è necessaria e l’azienda adempie le obbligazioni correnti)<br>– Fondo di garanzia contratti: valutare se possibile attivare assicurazioni crediti (tipo SACE) o garanzie statali su forniture critiche, per dare comfort al fornitore che sarà pagato almeno in parte dallo Stato se l’azienda non ce la fa. È più prevenzione che cura, ma in crisi avanzata si può chiedere a un terzo di garantire nuove forniture (spesso il cliente finale interessato a salvare l’azienda interviene per garantire fornitori di quell’azienda)<br>– Opposizione a decreto ingiuntivo: se il fornitore agisce e ci sono contestazioni sulla fornitura (vizi merce, ritardi, inadempimenti del fornitore), presentare opposizione per guadagnare tempo e magari negoziare nel frattempo una soluzione. Attenzione: dev’essere basata su eccezioni serie, altrimenti si aggiungono solo spese. |
| Debiti verso dipendenti (retribuzioni e TFR) | Stipendi mensili non pagati, premi, straordinari; Trattamento di Fine Rapporto maturato; ferie non godute | – Malcontento interno, scioperi o dimissioni di massa (i dipendenti possono legittimamente interrompere la prestazione se non pagati, con preavviso in caso di dimissioni per giusta causa, e azienda perde forza lavoro qualificata)<br>– Decreti ingiuntivi individuali o tramite sindacati: i lavoratori possono ottenere ingiunzioni in via d’urgenza (art. 423 c.p.c.) per le paghe arretrate, esecutive immediatamente (pignoramenti su c/c aziendale possibili a breve)<br>– Denuncia presso ITL (ispettorato del lavoro) e possibile intervento penale: NB: il mancato pagamento delle retribuzioni oltre una certa soglia temporale può configurare contravvenzioni (art. 2 L. 195/1955 prevede arresto fino a 6 mesi o ammenda per mancata corresponsione stipendi, ma solo su querela e raramente applicata se poi paghi)<br>– Attivazione del Fondo di Garanzia INPS: se l’azienda fallisce o non paga dopo tentativi esecutivi, i dipendenti possono chiedere al Fondo il pagamento del TFR e ultime 3 mensilità; il Fondo poi diventa creditore surrogato nel fallimento (INPS privilegia i suoi crediti surrogati come i lavoratori avrebbero)<br>– Eventuale istanza di fallimento: raramente i lavoratori chiedono il fallimento in proprio, ma potrebbero farlo (soprattutto se licenziati e l’azienda non paga TFR: per accedere al Fondo INPS serve insolvenza conclamata, quindi a volte i dipendenti stessi provocano il fallimento per ottenere il dovuto dal Fondo) | – Accordi sindacali: trattare con i sindacati o i dipendenti un accordo di dilazione paga/TFR, magari con il supporto di ammortizzatori sociali (es. Cassa Integrazione straordinaria per crisi, che alleggerisce l’onere salariale per l’azienda, pagando direttamente una parte ai lavoratori). Un accordo potrebbe essere “pagheremo gli arretrati in 3 tranche nei prossimi 6 mesi, nel frattempo attiviamo CIG per 80% salario corrente” ecc. Formalizzare in sede sindacale dà più garanzie ai lavoratori che l’azienda è impegna seriamente<br>– Prededucibilità in concordato: se entra in concordato preventivo, gli stipendi dei 3 mesi precedenti la domanda e il TFR maturato in quel periodo vanno pagati integralmente come crediti prededucibili. Questo può risolvere parzialmente il problema: ad esempio, presentando domanda di concordato oggi, i mesi recenti devono essere saldati (magari con un finanziamento ponte autorizzato). I crediti più vecchi dei lavoratori restano privilegiati ma concorsuali (possono essere falcidiati solo se il concordato è in continuità e garantisce comunque il 20% minimo a chirografari e ai privilegiati degradati). Nella prassi spesso nei concordati in continuità si paga il 100% anche ai lavoratori per motivi sociali e di consenso. Il vantaggio per il debitore è che col concordato i lavoratori non possono agire esecutivamente e devono attendere la procedura, ricevendo comunque almeno in parte il dovuto con preferenza assoluta.<br>– Procedure concorsuali minori: se l’azienda non è soggetta a fallimento, può attivare una liquidazione controllata ex CCII; in tal caso i lavoratori accedono comunque al Fondo di Garanzia INPS per TFR e stipendi. Dunque, una “difesa” indiretta per il datore persona fisica è: se vede che non potrà pagare TFR, tanto vale aprire una procedura concorsuale così il Fondo interviene e libera i lavoratori dal peso, evitando cause individuali. È brutto a dirsi, ma a volte il fallimento viene richiesto proprio nell’interesse dei lavoratori.<br>– Priorità in eventuale piano: se vuole tenere i lavoratori, deve dare un segnale di affidabilità. Ad esempio, può proporre in un piano attestato o accordo che i crediti dei dipendenti saranno pagati al 100% magari in 6 mesi, mentre i fornitori prendono il 40%. Mostrare questa sensibilità può mantenere la coesione della forza lavoro. Inoltre, evitare trattamenti peggiorativi per i dipendenti aiuta a prevenire cause di lavoro e contenziosi che inquinerebbero la procedura concorsuale.<br>– Riduzione del personale: come misura di risanamento, valutare se l’organico è sovradimensionato. Concordare eventualmente esodi incentivati o cassa integrazione per ristrutturazione, in modo da ridurre il costo fisso mensile ed evitare di accumulare altri debiti salariali. È una difesa “dolorosa” ma talvolta necessaria per salvare parte dell’impresa. In concordato, i licenziamenti collettivi seguono una procedura accelerata (45 giorni) con intervento del GD. |
Tabella 2 – Confronto tra principali strumenti di regolazione della crisi
| Caratteristica | Piano attestato di risanamento | Accordo di ristrutturazione | Concordato preventivo | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|---|
| Normativa di riferimento | Art. 56 CCII (già art. 67 L.F. co.3 lett. d) | Artt. 57-64 CCII (già art. 182-bis L.F.) | Artt. 84-120 CCII (già artt. 160-186 L.F.) | Artt. 121-270 CCII (già L.F. 1-118) |
| Soglia di consenso necessaria | 100% dei creditori coinvolti (accordo contrattuale) | ≥60% dei crediti (adesione qualificata; estendibile a non aderenti pagati per intero) | ≥50% dei crediti votanti (maggioranza in ogni classe, salvo cram-down giud.) | N/A (procedura coatta; non dipende da consenso creditori) |
| Ruolo del Tribunale | Nessuno (strumento stragiudiziale puro; eventuale pubblicazione registro imprese ma senza omologazione) | Omologazione richiesta dal debitore al Tribunale; intervento limitato a controllo legittimità e merito essenziale; eventuali misure protettive durante omologa | Ammissione, omologazione e vigilanza da parte del Tribunale; nomina commissario giudiziale; giudice delegato supervisiona | Dichiarazione apertura con sentenza; nomina curatore, giudice delegato; stretta sorveglianza giudiziaria di ogni atto |
| Gestione dell’impresa | Rimane al debitore integralmente (nessuna procedura aperta) | Rimane al debitore; nessun organo nominato, salvo attestatore per perizia e eventuale commissario ad acta se accordo particolare (raro) | Debitore in possesso, ma sotto controllo del commissario e con atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione | Spossessamento: il Curatore amministra e liquida i beni; il debitore perde disponibilità patrimonio |
| Protezione dalle azioni dei creditori | Nessuna automatica (creditori liberi di agire salvo impegni contrattuali a standstill) | Sì, dal deposito dell’accordo può chiedersi al Tribunale la sospensione delle azioni esecutive (simile art. 168 L.F.) durante iter di omologa; omologazione rende accordo vincolante e impedisce azioni difformi | Sì, piena: dal deposito della domanda (anche “in bianco”) scatta divieto di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari ; creditori possono far valere i crediti solo secondo il piano omologato (post-omologa) | Sì, apertura della procedura sospende azioni esecutive individuali e pignoramenti in corso con confluenza nel fallimento; creditori possono insinuarsi al passivo soltanto |
| Continuità aziendale | Possibile, anzi obiettivo principale (risanare e proseguire attività) | Possibile, accordo può supportare continuità se creditori strategici aderiscono (spesso usato per ristrutturazioni finanziarie mantenendo l’impresa operativa) | Può essere in continuità (piano che prevede prosecuzione attività sotto vigilanza) o liquidatorio (cessazione e vendita beni); la continuità è ammessa e favorita se massimizza valore | Generalmente no, salvo esercizio provvisorio temporaneo autorizzato per vendere meglio l’azienda; la regola è la cessazione e liquidazione pezzi/beni |
| Trattamento dei creditori | Basato su accordi individuali: alcuni possono essere soddisfatti integralmente, altri parzialmente a seconda delle intese; necessario pagare per intero i “dissentienti estranei” entro piano per evitare azioni (principio: non pregiudicare chi non aderisce) | I creditori aderenti accettano riduzioni/dilazioni come da accordo; i non aderenti devono essere comunque pagati al 100% salvo diverso accordo (quindi tipicamente esclusi dall’accordo e pagati regolarmente) . Possibile estendere l’accordo a intere categorie (es. banche) se super soglia aderenti e garantito loro trattamento non deteriore | Si possono dividere in classi. I creditori privilegiati in linea di massima vanno pagati integralmente salvo: consenso a diversamente (transazione fiscale e similari) o incapienza del loro bene (in tal caso la parte chirografaria prende percentuale come gli altri). I chirografari ricevono la % proposta (anche <100%). Devono ricevere almeno quanto riceverebbero in liquidazione (best interest test). Post omologa, il debitore è liberato dai debiti residui chirografari non soddisfatti | Creditori privilegiati soddisfatti in ordine di prelazione dal realizzo dei beni (di solito percentuale variabile dal 100% a meno, se insufficiente attivo); creditori chirografari spesso ricevono nulla o piccola percentuale dal riparto finale. Alla chiusura, i crediti insoddisfatti persistono giuridicamente ma non hanno più un patrimonio su cui rivalersi (eccetto aggredire eventuali nuovi beni ex fallito se persona fisica, salvo esdebitazione) |
| Vantaggi principali | – Rapidità e riservatezza: nessuna pubblicità della crisi, accordi bilaterali flessibili<br>– Protezione da revocatoria: atti e pagamenti eseguiti in esecuzione del piano non revocabili in futuro <br>– Nessun costo di procedura o intervento esterno (solo compenso attestatore)<br>– Debitore mantiene pieno controllo su azienda e negoziati | – Vincolatività erga omnes dopo omologa: anche i dissenzienti (che siano stati trattati non worse-off) sono legati dall’accordo <br>– Azioni esecutive sospese durante omologa (tutela simile a concordato senza passare per voto generale)<br>– Procedura più snella del concordato: niente voto di massa, niente commissario (di solito), tempi di omologa relativamente brevi (4-6 mesi)<br>– Possibilità di cram-down del Fisco e di banche dissenzienti se soglie adesione alte | – Sospensione immediata di tutte le azioni dei creditori, stop interessi su chirografari, niente ipoteche giudiziali insidiabili<br>– Possibilità di sciogliersi da contratti pendenti troppo onerosi con autorizzazione tribunale (es. recesso da leasing) o modificarli (anche rapporti di lavoro, con ok GD) in funzione del piano<br>– Cancellazione di parte consistente dei debiti: può prevedere haircut significativi su chirografari e, con transazione, anche su privilegiati erariali<br>– Se in continuità: l’impresa può proseguire l’attività, mantenere marchio, clienti e dipendenti (piano permettendo); se liquidazione: avviene in modo ordinato e sotto controllo del debitore in possesso<br>– Esdebitazione intrinseca: a esecuzione del concordato, il debitore è libero dai debiti pregressi (per la percentuale falcidiata) definitivamente<br>– Durata procedura relativamente breve (1-2 anni) rispetto a fallimento pluriennale; costi inferiori a fallimento se l’attivo è gestito dal debitore (niente curatore che liquida per anni) | – Solleva il debitore dall’onere di gestire una situazione ingestibile: viene nominato un curatore professionista che si occupa di tutto (per l’imprenditore stressato può quasi essere un “sollievo” delegare)<br>– Consente l’esdebitazione del fallito a fine procedura, quindi offre la chance di ripartire senza debiti residui (beneficio persona fisica) <br>– Distribuzione controllata secondo legge assicura parità trattamento creditori (beneficio più per creditori che debitore, ma evita favoritismi e relative responsabilità penali al debitore)<br>– Possibilità di esercizio provvisorio/vendita in blocco dell’azienda: se c’è un compratore interessato, il curatore può salvare parti dell’impresa vendendole in continuità (il debitore però perde proprietà dell’azienda venduta)<br>– Tempistiche per chiudere eventuali pendenze: la procedura fallimentare sospende prescrizioni e termina i contratti onerosi, facendo tabula rasa del passato – il debitore collabora e poi si libera dal peso (psicologicamente una chiusura definitiva) |
| Svantaggi e rischi | – Nessuna protezione contro creditori non aderenti: basta un creditore aggressivo estraneo al piano per far saltare il risanamento (pignorando beni critici o chiedendo fallimento)<br>– Necessità di liquidità iniziale per pagare i creditori estranei per intero (il piano deve indicare risorse destinate a loro) ; se l’azienda è a secco di cassa, è dura attuare piano<br>– Rischio di insuccesso non gestibile: se le assunzioni del piano si rivelano errate e l’azienda non si risana, non c’è una procedura protetta di riserva – si torna al punto di partenza (anzi, magari con nuovi debiti contratti) e si rischia fallimento con possibili contestazioni su atti compiuti (protezione revocatoria regge salvo frode, ma il dissesto peggiorato può aggravare responsabilità amministratori)<br>– Attestatore: costo e potenziale responsabilità per il professionista (che potrebbe essere conservativo nel giudizio); se attestazione negativa, il piano non parte nemmeno | – Richiede coinvolgimento di molti creditori in tempi brevi: bisogna convincere almeno il 60%, operazione che in pratica significa discutere con i principali (banche, fornitori grandi) e avere loro commitment, altrimenti non si raggiunge soglia. Questo può essere oneroso in termini di tempo e risorse di negoziazione<br>– I creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (se chirografari) o entro la scadenza originaria (se privilegiati non scaduti), altrimenti possono agire: ciò impone che l’accordo preveda tutta la finanza per soddisfare integralmente i dissenzienti – se questi rappresentano il 40% o meno ma con importi rilevanti, può essere comunque insostenibile per l’azienda<br>– Pubblicità: l’accordo viene pubblicato nel registro imprese, quindi i terzi conoscono che l’azienda ha ristrutturato il debito (possibile danno reputazionale, seppur minore che per concordato/fallimento)<br>– Se l’accordo non viene eseguito (inadempimento successivo), si può aprire il fallimento su istanza dei creditori non soddisfatti; inoltre, l’accordo non offre esdebitazione per la parte eccedente il pagamento concordato (anche se in pratica se paga ciò che ha promesso, residui non ce ne sono, quindi problema non si pone) | – Procedura complessa: costi di commissario, legali, perito attestatore, ecc., e oneri di gestione sotto autorizzazione (ogni spesa straordinaria va autorizzata, può rallentare operatività)<br>– Richiede consenso dei creditori: se il piano è respinto con voto negativo, l’esito è il fallimento. Quindi è un all-in: va preparato bene o si rischia di bruciare l’ultima carta e precipitare nella liquidazione giudiziale<br>– Perdita di autonomia: l’imprenditore non può compiere atti liberamente, vive in una sorta di amministrazione controllata. Alcuni trovano difficile operare sotto scrutinio e con risorse contingentate<br>– Pagamenti durante procedura: deve comunque pagare forniture correnti, e creare le riserve per pagare creditori prededucibili e privilegiati come da piano; se c’è uno scostamento significativo dal piano (es. risultati peggiori) e non riesce a correggere, il concordato può essere revocato o convertito in fallimento<br>– In caso di revoca o cessazione del concordato (per inadempimento dell’imprenditore o annullamento), si torna alla liquidazione giudiziale e con aggravio: atti compiuti in costanza di concordato potrebbero esser scrutinati per bancarotta (ad es. pagamenti non autorizzati diventano bancarotta semplice), e i creditori avranno perso tempo ottenendo forse percentuali minori<br>– Reputazione: un concordato è comunque un’ammissione pubblica di insolvenza, visibile a tutti gli stakeholder; può danneggiare rapporti commerciali durante e dopo la procedura (anche se, se in continuità e con successo, l’impresa può poi superare lo stigma) | – Il debitore perde completamente il controllo: deve affidarsi al curatore anche per esigenze personali sul patrimonio (es. prelevare dal libretto di risparmio è vietato se rientra nell’attivo fallimentare). Questo può essere umiliante e scomodo<br>– Tempi lunghi e incertezza: un fallimento medio dura anni (anche 5-10 anni se attivo complesso); il debitore rimane in un limbo e i creditori vedono soldi tardi o mai. L’imprenditore persona fisica non può ottenere esdebitazione prima di aver atteso la fine e fatto istanza (anni)<br>– Costi alti erodono l’attivo: compenso del curatore proporzionale ai valori recuperati, spese legali per cause, ecc. Spesso i creditori chirografari non prendono nulla perché quel poco che si ricava va a pagare spese di procedura e privilegiati. Dal punto di vista del debitore, è frustrante vedere liquidato tutto a poco prezzo e neanche soddisfare i creditori<br>– Indagine sulla condotta del debitore: la procedura fallimentare porta in luce tutto, anche eventuali errori passati: c’è il rischio concreto di azioni di responsabilità (se società) e azioni penali. Il curatore può denunciare per bancarotta o altri reati; insomma il fallimento mette il debitore sotto una lente, e se questi ha compiuto irregolarità, verranno quasi certamente a galla con conseguenze giudiziarie<br>– Interdizioni personali: per tutta la durata, il fallito persona fisica subisce limitazioni (non può ricoprire cariche, non può ottenere passaporto senza ok, ecc.). Gli effetti negativi sul piano personale e sociale possono essere notevoli (anche se oggi meno infamanti di un tempo, la parola “fallito” è ancora pesante) |
Casi pratici e simulazioni (scenario Italia)
Caso 1: Risanamento aziendale tramite piano attestato e continuità
La “Alfa Machinery S.r.l.” produce macchinari industriali su commessa. A inizio 2024 registra una forte crisi di liquidità: ha €2 milioni di debiti verso fornitori (in gran parte scaduti da 90+ giorni), €500k di arretrati IVA e ritenute, e un mutuo ipotecario di €800k con rate insolute da 3 mesi. La produzione però ha ordini significativi per l’anno successivo, con margini potenziali che consentirebbero di rientrare. – Azioni intraprese: La società si rivolge a un advisor e decide di tentare un piano attestato di risanamento. Prepara un piano industriale che prevede: immissione di €300k di nuova finanza da parte dei soci; dismissione di un capannone inutilizzato per €400k; riduzione costi del personale tramite 5 esuberi con accordo sindacale. Con queste risorse, nel piano si propone di pagare integralmente i debiti fiscali e bancari entro 6 mesi, e di pagare i fornitori al 60% del loro credito, in 12 rate mensili (per i fornitori strategici si prevede pagamento integrale ma dilazionato). Un attestatore indipendente esamina il piano e rilascia relazione positiva sulla veridicità dei dati (ordini, impegni di capitale dei soci, ecc.) e sulla fattibilità economica: giudica realistiche le prospettive di utile e cash flow, tali da sostenere le rate ai fornitori e i pagamenti correnti. Tutti i principali creditori vengono coinvolti in riunioni di illustrazione del piano. Le banche acconsentono a non agire sul mutuo e ad aspettare la vendita del capannone per ricevere il saldo (nel frattempo mantengono interessi). L’Agenzia Entrate accetta un’istanza di rateizzazione in 6 anni, ma l’azienda intende estinguerla prima (come da piano) e comunica la cosa. I fornitori: su 50 fornitori, 45 (rappresentanti il 95% del totale dovuto) aderiscono formalmente alla proposta di stralcio 60%; 5 piccoli fornitori rifiutano. Per questi 5 fornitori dissenzienti (con credito totale €100k), il piano prevede che verranno pagati integralmente entro 3 mesi dall’omologa del piano, usando parte dei fondi soci – ciò è necessario per evitare che agiscano. Una volta ottenute le adesioni scritte, la Alfa S.r.l. pubblica il piano e l’attestazione presso il Registro Imprese per cristallizzare la data e beneficiare della protezione di legge. Il piano viene poi eseguito: i soci versano €300k subito, vendono il capannone in 2 mesi realizzando €400k; con questi €700k iniziali pagano IVA arretrata e ritenute (circa €200k), portano in pari i contributi e alcune mensilità dipendenti scoperte (€50k), pagano i 5 fornitori dissenzienti (€100k) e versano 3 rate del mutuo (€50k). Nel frattempo la produzione riprende ritmo grazie ai materiali che i fornitori (anche se pagati parzialmente) tornano a consegnare – confidando nel piano. Dopo 1 anno, Alfa S.r.l. è tornata corrente con i debiti fiscali e bancari (mutuo rinegoziato su 5 anni con tasso invariato, banca non ha preteso tutto subito vedendo il rispetto del piano) e ha pagato il 60% dovuto ai fornitori (i quali, soddisfatti di aver recuperato almeno una buona parte, continuano il rapporto commerciale). L’azienda è salva, non è passato dal tribunale e la notorietà della crisi è rimasta limitata agli addetti ai lavori. La protezione ex art. 166 CCII ha impedito che eventuali pagamenti fatti potessero essere revocati: per esempio, un fornitore estraneo fu pagato al 100% e poi la società fallì due anni dopo? In questo caso, quel pagamento non sarebbe revocabile perché compiuto in esecuzione del piano attestato . – Note: Questo scenario mostra un risanamento riuscito* con piano attestato. Fattori chiave del successo: creditori disposti a collaborare (specialmente i fornitori, che hanno preferito il 60% anziché rischiare un fallimento e forse nulla), apporto di capitali freschi e dismissioni da parte del debitore per generare liquidità immediata, e attenta analisi di fattibilità da parte dell’attestatore che ha dato credibilità al piano. Un rischio del piano attestato è sempre l’adesione integrale: in questo caso c’erano alcuni dissenzienti, ma di peso modesto e pagati integralm. Il debito fiscale, potenzialmente killer, è stato coperto con dilazione legale e con risorse a breve (capannone). La garanzia per i creditori è l’attestazione e la trasparenza dei dati, che li ha convinti che il 60% oggi era meglio del 0% domani. Effettivamente Alfa S.r.l., attuando il piano con disciplina, ha evitato il fallimento e dopo un anno è tornata liquida. Se non avesse rispettato il piano, i creditori sarebbero stati comunque liberi di agire (nessun giudice li bloccava se il debitore fosse divenuto inadempiente agli accordi).
Caso 2: Concordato preventivo liquidatorio vs fallimento
La “Beta Macchine S.p.A.”, storica azienda con 100 dipendenti, è sovraindebitata: ha debiti finanziari e commerciali per €10 milioni, a fronte di un attivo di soli €6 milioni (immobili e macchinari per €4M, crediti esigibili per €1M, liquidità quasi zero, magazzino scarso). La società è insolvente: ha già saltato pagamenti di mutui e stipendi, e alcuni creditori hanno pignoramenti in corso. Le prospettive di mercato sono negative, nessun piano industriale appare in grado di risollevarla in tempi utili. Si prevedono perdite continue se l’attività prosegue. Un creditore ha depositato istanza di fallimento. – Opzione A (concordato liquidatorio): Beta Macchine decide di presentare domanda di concordato preventivo per evitare il fallimento “disordinato”. Il piano, di tipo liquidatorio, prevede di cessare l’attività produttiva, vendere in asta i macchinari e l’immobile, e recuperare i crediti. Stimando ricavi di liquidazione attorno a €4M, propone di pagare integralmente i debiti privilegiati (banche ipotecarie per €2M, TFR e stipendi arretrati €0.5M, Erario €0.5M con transazione fiscale che prevede pagamento parziale dell’IVA privileggiata al 80%) e di destinare il resto (circa €1M netto) ai chirografari, che così otterrebbero circa il 10% dei loro crediti. Offre inoltre ai dipendenti la pronta attivazione del Fondo di Garanzia INPS per il TFR residuo e la NASpI (indennità di disoccupazione). Il tribunale ammette la società al concordato – sospendendo nel frattempo le azioni esecutive dei creditori. I creditori vengono suddivisi in classi: classe privilegiati (che prenderanno 100% salvo Fisco 80%), classe chirografari (10%). In adunanza, i privilegiati votano a favore (sono soddisfatti quasi per intero, e hanno interesse a evitare lungaggini fallimentari), i chirografari in maggioranza pure approvano (molti ragionano che 10% in concordato è certo e in pochi mesi, mentre in fallimento non è detto prendano di più e comunque dopo anni). Si raggiunge il quorum e il concordato viene omologato. Un liquidatore giudiziale (ex commissario) vende gli asset nei 6 mesi successivi: se i realizzi corrispondono alle attese, paga i creditori secondo il piano. Beta Macchine S.p.A., eseguito il piano, viene cancellata dal registro imprese. I creditori chirografari hanno incassato il 10% dei loro crediti e, grazie all’omologa concordataria, non possono reclamare il restante 90% in alcun modo in futuro. I debiti si considerano estinti secondo la falcidia approvata. Gli ex amministratori di Beta non subiscono procedure di responsabilità perché il dissesto è stato gestito regolarmente (hanno scelto il concordato per tempo anziché aggravare il buco). Non emergono fattispecie penalmente rilevanti (i pagamenti preferenziali fatti negli ultimi mesi – ad alcuni fornitori – non sono revocabili individualmente perché bloccati dal concordato; potrebbero configurare bancarotta preferenziale, ma essendo stati fatti prima del deposito concordato e quando l’insolvenza già c’era, i rischi penali ci sono: tuttavia, sono stati di entità modesta e non dolosi, quindi finisce senza conseguenze penali rilevanti per amministratori). I dipendenti ottengono rapidamente nuovo impiego in aziende concorrenti (grazie anche alla NASpI che li sostiene nei mesi di transizione). – Opzione B (fallimento): Se Beta Macchine non avesse fatto il concordato, il tribunale avrebbe dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) su istanza del creditore. Un curatore avrebbe preso in mano l’azienda, interrotto immediatamente l’attività (salvo provvisorio esercizio di poche commesse per 2 mesi), licenziato tutti i dipendenti, e condotto le vendite di beni nel corso di 1-2 anni. Verosimilmente, tra costi di procedura e svalutazioni forzate, l’attivo di €6M lorde si sarebbe magari ridotto a €3M liquidi. L’ordine di distribuzione avrebbe comunque soddisfatto prima i privilegiati: banche ipotecarie e dipendenti forse recuperano quasi tutto (ma con attesa di anni), l’Erario come creditore privilegiato avrebbe preteso 100% del suo (in fallimento non c’è transazione fiscale, salvo il curatore non usi art. 63 CCII per proporre egli un accordo fiscale, cosa non scontata). Se i privilegiati assorbono €3M, rimarrebbero zero per i chirografari (che quindi nel fallimento prendono 0%). Questi ultimi, a fine procedura, riavrebbero teoricamente diritto di inseguire Beta per il residuo, ma Beta è dissolta come società, quindi nulla da fare. Gli ex amministratori però in fallimento sarebbero forse bersaglio di azioni di responsabilità: il curatore scruta i bilanci e trova che negli ultimi due anni hanno continuato a fare investimenti azzardati distribuendo anche dividendi nonostante segnali di insolvenza. Il curatore li cita in giudizio ex art. 2476 c.c. chiedendo €1M di danni. Inoltre, emergono pagamenti preferenziali: uno di €200k a una società collegata, per cui parte un procedimento penale per bancarotta preferenziale. In sostanza, nel fallimento gli amministratori di Beta subiscono più conseguenze negative (patrimoniali e reputazionali) rispetto al concordato. I creditori privilegiati realizzano forse un po’ meno (ad es. il Fisco nella liquidazione fallimentare non trattiene 80 ma pretende 100, quindi se attivo era limitato magari banche recuperano 90% anziché 100). I creditori chirografari han preso zero invece che 10%. I dipendenti hanno comunque avuto il Fondo di Garanzia per TFR, ma magari hanno aspettato 1 anno in più perché la procedura ci ha messo tempo a certificare i loro crediti. – Commento: Questo caso mostra che, pur nella comune sorte liquidatoria, il concordato preventivo può portare a un esito migliore per alcuni stakeholder: i creditori chirografari almeno hanno ottenuto qualcosa (10%) e in tempi rapidi, mentre nel fallimento classico sarebbero rimasti all’asciutto dopo anni . Anche i privilegiati hanno avuto soddisfazione più celere e certa (nel fallimento avrebbero potuto subire più decurtazioni per spese). Dal lato debitore, la società comunque sparisce in entrambi i casi, ma nel concordato la gestione è rimasta in mano agli amministratori fino all’omologa, consentendo vendite più ragionate e una conclusione ordinata. I costi di procedura nel concordato (commissario, liquidatore) sono stati inferiori probabilmente ai costi di un lungo fallimento con vari legali. Gli amministratori hanno evitato l’onta del fallimento e relative interdizioni. Infine, l’esdebitazione: nel fallimento, gli ex imprenditori avrebbero dovuto chiedere l’esdebitazione per liberarsi da eventuali garanzie personali rimanenti; nel concordato, non occorre perché la falcidia concordataria di per sé li libera dai debiti residui una volta adempiuto il piano. D’altro canto, il concordato richiede la approvazione dei creditori: nel caso, è avvenuta per convenienza. Se i chirografari fossero stati più litigiosi e avessero bocciato la proposta (magari sperando in future azioni di responsabilità per incrementare l’attivo fallimentare), Beta sarebbe fallita e tutti sarebbero tornati all’opzione B, ma con mesi persi. Fortunatamente, la maggioranza ha compreso la situazione e votato sì.
Caso 3: Composizione negoziata con successo parziale e concordato semplificato finale
La “Gamma Impianti S.r.l.” (costruttrice di impianti automatizzati) nel 2025 fronteggia squilibri finanziari: ordini in calo, debiti verso banche €3M (mutui e fidi), debiti verso fornitori €2M, debiti fiscali €1M. L’azienda è ancora in bonis (paga gli stipendi e buona parte dei debiti, ma la previsione di cash flow mostra che entro 6 mesi finirà la liquidità e non potrà pagare rate mutui né fornitori correnti). Gli amministratori vogliono agire per tempo per evitare insolvenza conclamata. – Svolgimento: Gamma attiva nel giugno 2025 la composizione negoziata della crisi nominando un esperto indipendente dalla CCIAA. Sotto la guida dell’esperto, avvia trattative con le banche (3 istituti principali) e con un pool di fornitori strategici. Richiede e ottiene dal Tribunale una misura protettiva: per 3 mesi nessun creditore può iniziare azioni esecutive né iscrivere ipoteche sui beni aziendali. Ciò blocca sul nascere un’azione di pignoramento che una banca stava per avviare su macchinari dati in garanzia. Durante i 3 mesi, l’esperto verifica che l’azienda ha un core sano, ma un eccesso di indebitamento storico. Formula una possibile soluzione: una ristrutturazione del debito bancario con stralcio. Le banche però non trovano un accordo comune: due accettano l’idea di trasformare €1M dei loro crediti in partecipazione al capitale (diventando socie) e di prorogare il rientro sul restante; la terza banca (creditrice di €1.5M) rifiuta sia stralci che equity, e anzi degrada il rating e prepara istanza di fallimento qualora la negoziazione decada. Sul fronte fornitori, l’esperto riesce a convincere i 5 maggiori (su 50) a continuare forniture per 4 mesi senza pagamento immediato, in cambio della prospettiva di essere soddisfatti integralmente su linee future se l’azienda riprende (una sorta di accordo morale). Ma molti fornitori minori restano sul piede di guerra. Dopo 4 mesi di negoziato, l’esperto conclude che non c’è accordo globale: le condizioni poste da quella banca e da troppi fornitori non permettono un risanamento consensuale completo. Tuttavia, nota anche che grazie alla protezione ottenuta e al tempo trascorso, l’azienda ha nel frattempo completato alcune commesse incassando €0.5M, riducendo un po’ il debito verso fornitori e consegnando lavori che altrimenti sarebbero rimasti a metà. A questo punto, scaduto il periodo di composizione negoziata, Gamma non ha un accordo extragiudiziale fattibile. Decide quindi di ripiegare su un concordato semplificato liquidatorio (strumento disponibile poiché la composizione negoziata non ha avuto esito positivo). Entro 60 giorni dalla chiusura delle trattative, presenta al Tribunale un piano di concordato semplificato ex art. 25-sexies: prevede di liquidare in 6 mesi tutti i beni dell’azienda (macchinari, magazzino e crediti residui) stimando un ricavato di €2.5M, con cui pagare: i creditori privilegiati (banche con ipoteca sui capannoni, Erario per IVA) al valore di realizzo delle garanzie (circa 50% dei rispettivi crediti), e i chirografari con un dividendo pari al 20%. Non c’è votazione dei creditori su questo piano, data la natura semplificata; il Tribunale, dopo aver acquisito la relazione dell’esperto che attesta di aver esperito invano ogni tentativo e giudica equo il piano proposto (nessuno prende meno di quanto avrebbe ipoteticamente preso in fallimento), omologa il concordato semplificato. La procedura prosegue con la liquidazione: vengono venduti i macchinari (anche grazie a contatti con fornitori che li ricomprano in conto saldo), incassati i crediti lavori in corso, etc. Dopo 8 mesi i creditori ricevono i riparti: le due banche “disponibili” prendono un 60% circa dei loro crediti (meglio che in fallimento forse avrebbero 40% causa ipoteche su beni svalutati), la banca ostile pure prende 60% (e riflette che se avesse accettato l’equity forse sarebbe rimasta in gioco), i fornitori ricevono ~20%, l’Erario ottiene 50% del suo (ma quell’importo era l’equivalente del realizzo su beni, quindi è il massimo ottenibile). Gamma S.r.l. cessa l’attività e viene liquidata, ma i soci amministratori non subiscono un fallimento formale. Potranno attivarsi per una nuova iniziativa più snella in futuro, liberi dai debiti pregressi. – Analisi: In questo scenario, la composizione negoziata non ha salvato l’azienda come going concern, però ha funzionato come passo intermedio per minimizzare i danni e condurre a una soluzione concorsuale più efficace del fallimento. Durante i negoziati, l’azienda ha evitato di cadere subito in mano ai creditori, completando lavori e preservando valore. La mancanza di accordo con tutti i creditori è un esito possibile: almeno si è individuato per tempo che un concordato preventivo tradizionale sarebbe stato bocciato (perché la terza banca avrebbe votato no bloccando maggioranza). Allora si è scelta la strada del concordato semplificato, che non richiede voto dei creditori. Ciò ha “scavalcato” l’opposizione di quella banca recalcitrante, pur garantendole un trattamento pari (se non migliore) a quello che avrebbe avuto da un fallimento. Il risultato: liquidazione ordinata, senza procedure esecutive frammentarie; i creditori hanno avuto percentuali discrete in tempi inferiori; i fornitori almeno un 20% anziché forse nulla in fallimento (20% resa possibile anche dal completamento commesse – in fallimento i lavori in corso sarebbero andati perduti, riducendo ancor più l’attivo realizzabile). I dipendenti non menzionati probabilmente sono stati licenziati appena partito il concordato semplificato, però hanno subito potuto chiedere il Fondo di garanzia e la NASpI, vista la chiusura immediata. Questo caso è realistico nel rappresentare come l’esperto della composizione negoziata possa comunque aiutare: benché non abbia trovato l’accordo ideale, ha gettato le basi per il concordato semplificato e ha fornito una perizia fondamentale al tribunale per convincerlo dell’equità del piano. Senza composizione negoziata, Gamma sarebbe forse finita in fallimento su istanza della banca, con esiti peggiori per tutti. Così invece i soci hanno “guidato” la liquidazione e si sono chiusi dignitosamente la crisi. La prospettiva del fresh start* per loro rimane aperta, mentre con un fallimento e magari accuse di condotta aggravante (se non avessero provato a trattare) sarebbe stata più fosca.
Gestisci un’impresa di fabbricazione di macchinari industriali e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori, dipendenti o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci un’impresa di fabbricazione di macchinari industriali e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori, dipendenti o Agenzia delle Entrate?
Hai mutui o leasing per impianti e macchine utensili, cartelle esattoriali, IVA o contributi arretrati, e temi pignoramenti, revoche di fidi o la chiusura dell’attività?
👉 Non è la fine: la legge oggi ti consente di bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti, e proteggere la tua azienda, grazie alle soluzioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
In questa guida scoprirai perché molte imprese metalmeccaniche e manifatturiere si trovano in difficoltà, quali strategie legali puoi adottare, e come difenderti per salvare o chiudere la tua attività in modo protetto e senza fallire.
⚙️ Perché le imprese di fabbricazione di macchinari si indebitano
Il comparto industriale è tra i più esposti a oscillazioni di mercato e crisi economiche globali. Le principali cause di indebitamento sono:
- Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti o committenti;
- Aumenti dei costi di energia, acciaio e componenti meccanici;
- Mutui e leasing onerosi per impianti, linee di produzione e macchinari CNC;
- Appalti non pagati o sospesi;
- Pressione fiscale e contributiva troppo elevata;
- Errori nella gestione dei flussi di cassa e nelle pianificazioni fiscali.
📌 Tutto questo può generare rapidamente debiti fiscali, bancari e commerciali, che se non gestiti in tempo, portano a blocchi produttivi, licenziamenti o pignoramenti aziendali.
🧾 Tipologie di debiti più comuni nel settore industriale
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IVA, IRPEF, INPS, INAIL, TARI, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Leasing e mutui per macchinari, torni CNC, presse, linee automatizzate e immobili industriali.
- Scoperti di conto e linee di credito aziendali.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori di materie prime, componenti meccanici o software industriali.
✅ Debiti verso dipendenti e collaboratori
- Stipendi arretrati, contributi previdenziali non versati, TFR.
✅ Debiti personali o garanzie fideiussorie
- Fideiussioni firmate da soci o amministratori per prestiti e finanziamenti aziendali.
⚠️ Cosa rischia un’impresa di fabbricazione indebitata
Se non agisci in tempo, puoi subire conseguenze gravi come:
- pignoramenti di conti correnti, impianti e mezzi di produzione;
- revoca di fidi e finanziamenti;
- blocchi di forniture o contratti commerciali;
- iscrizioni di ipoteche o decreti ingiuntivi;
- perdita di credibilità verso clienti e istituti di credito.
👉 Tuttavia, puoi bloccare subito le azioni dei creditori, ristrutturare i debiti e salvare la tua impresa, o chiuderla in modo ordinato e protetto, senza fallimento.
🧩 Le soluzioni legali per le imprese industriali con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Un avvocato può aiutarti a trattare con istituti di credito e fornitori per ottenere:
- saldo e stralcio dei debiti (paghi solo una parte della somma dovuta);
- rateizzazioni più lunghe e sostenibili;
- sospensioni temporanee dei pagamenti.
👉 È la scelta giusta per chi ha ancora commesse attive e vuole evitare l’interruzione della produzione.
💠 2. Concordato minore (per SRL o società industriali)
È una procedura giudiziale prevista dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) che consente di:
- bloccare immediatamente pignoramenti, cartelle e azioni dei creditori;
- ridurre legalmente i debiti fiscali e bancari;
- mantenere la continuità aziendale e i rapporti con clienti e fornitori.
📌 È ideale per imprese strutturate che vogliono risanarsi e continuare a produrre.
💠 3. Procedura di sovraindebitamento (per ditte individuali e microimprese)
È la procedura legale più adatta a piccoli imprenditori e artigiani.
Consente di:
- bloccare pignoramenti, cartelle e azioni esecutive;
- presentare un piano di pagamento parziale e sostenibile;
- ottenere la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).
📌 Perfetta per laboratori artigiani o microaziende del settore metalmeccanico.
💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)
Se la tua attività non è più sostenibile, puoi chiudere in modo legale e protetto, mettendo a disposizione solo i beni non essenziali (macchinari vecchi, magazzino, automezzi).
Alla fine della procedura, il Tribunale cancella tutti i debiti residui, consentendoti di ripartire senza pendenze.
💠 5. Verifica e contestazione di cartelle e accertamenti fiscali
Molti debiti fiscali o contributivi sono errati o prescritti.
Un avvocato può:
- controllare la prescrizione (5 o 10 anni);
- eccepire irregolarità di notifica o errori di calcolo;
- chiedere la sospensione o l’annullamento del debito.
🏭 Cosa fare subito
✅ 1. Analizza la situazione economica e debitoria
Raccogli bilanci, cartelle, contratti, leasing e documenti fiscali per avere un quadro completo.
✅ 2. Blocca i creditori con una procedura legale
Con il deposito in Tribunale di un concordato o di una procedura di sovraindebitamento, tutti i creditori vengono sospesi per legge.
✅ 3. Non firmare rateizzazioni o prestiti non sostenibili
Serve una strategia completa e approvata dal Tribunale, che protegga te e la tua azienda.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale del titolare o amministratore.
- Visura camerale e bilanci aziendali.
- Dichiarazioni fiscali e posizione INPS/INAIL.
- Contratti di leasing, mutui e finanziamenti.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori, clienti e commesse attive.
- Estratti conto bancari e situazione patrimoniale.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi legale e finanziaria: 1–3 settimane.
- Deposito della procedura: 1–2 mesi.
- Blocco dei creditori: immediato al deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Stop a pignoramenti, cartelle e sequestri.
- Riduzione o cancellazione legale dei debiti.
- Tutela dei macchinari e della produzione.
- Ripartenza economica e reputazionale dell’azienda.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni dei creditori.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Continuità produttiva durante la procedura.
✅ Protezione degli impianti e dei beni aziendali.
✅ Chiusura legale e ordinata senza fallimento.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle, decreti o notifiche dell’Agenzia delle Entrate.
- Accumulare nuovi debiti o prestiti per coprire i vecchi.
- Pagare solo alcuni creditori peggiorando la posizione complessiva.
- Vendere beni aziendali senza tutela legale.
- Rimandare troppo: agire presto è fondamentale per salvare l’impresa.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione fiscale e debitoria nel dettaglio.
📌 Ti guida nella scelta tra rinegoziazione, sovraindebitamento, concordato o liquidazione controllata.
✍️ Redige e deposita il piano in Tribunale per bloccare subito i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche, leasing e fornitori.
🔁 Ti accompagna fino alla cancellazione definitiva dei debiti o alla ristrutturazione completa della tua impresa industriale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di imprese metalmeccaniche e manifatturiere con debiti fiscali e finanziari.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere un’impresa di fabbricazione di macchinari per l’industria con debiti non significa essere destinati al fallimento.
Con una difesa legale tempestiva e personalizzata, puoi bloccare i creditori, ridurre drasticamente i debiti e continuare a produrre in modo regolare e sicuro, oppure chiudere l’attività in modo protetto e senza rischi.
Il Codice della Crisi d’Impresa tutela chi agisce con trasparenza e vuole davvero ripartire.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova produzione libera dai debiti comincia oggi.