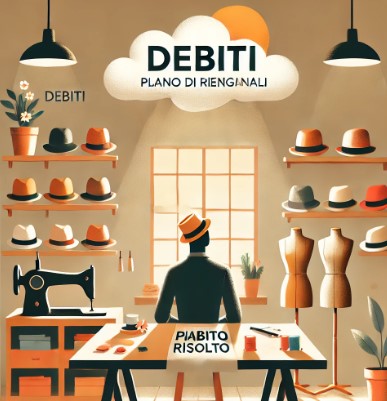Gestisci un’attività di produzione artigianale di cappelli e ti trovi in difficoltà economica per via di debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche? È una situazione sempre più comune per le imprese del settore manifatturiero e della moda artigianale, colpite dall’aumento dei costi, dalla concorrenza estera e dal calo della domanda interna. Quando le spese superano gli incassi e si accumulano cartelle esattoriali, contributi arretrati o rate di finanziamenti non pagate, il rischio di chiusura diventa concreto. La buona notizia è che esistono soluzioni legali per bloccare la riscossione, rateizzare o cancellare i debiti, proteggendo la tua impresa e il tuo patrimonio personale.
Perché molte aziende artigianali di cappelli si indebitano
Le cause dell’indebitamento nel settore artigianale derivano da una combinazione di fattori economici e gestionali. La produzione di cappelli richiede materiali di qualità, manodopera specializzata e attrezzature costose. I costi per energia, tessuti e accessori sono aumentati, mentre i margini di guadagno si sono ridotti. Inoltre, la concorrenza dei prodotti industriali a basso costo e le difficoltà di distribuzione nel mercato italiano ed estero hanno ridotto la redditività. Molti artigiani, per mantenere viva l’attività, rinviano il pagamento delle tasse o dei contributi, accumulando interessi e sanzioni che, nel tempo, fanno lievitare il debito in modo insostenibile.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Quando i debiti con il Fisco o gli enti previdenziali non vengono pagati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’INPS possono avviare rapidamente le procedure di recupero. Le più frequenti sono la notifica di cartelle esattoriali, le intimazioni di pagamento, i pignoramenti dei conti correnti o dei crediti verso i clienti, i fermi amministrativi sui veicoli, le ipoteche sugli immobili e i sequestri dei beni aziendali. Gli importi aumentano a causa di sanzioni e interessi, mentre la pressione fiscale e la burocrazia rendono sempre più difficile lavorare serenamente. Se operi come ditta individuale o società artigiana, rispondi personalmente dei debiti, rischiando di compromettere anche i beni personali e familiari.
Cosa fare subito se la tua azienda di cappelli ha debiti
Il primo passo è conoscere con precisione l’entità e la natura dei debiti. Richiedi l’estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per sapere quanto devi e a chi. Poi verifica la regolarità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica, importi prescritti o somme non dovute che un avvocato può impugnare. Se i debiti sono legittimi, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo nel frattempo le azioni di riscossione. È utile anche controllare se è disponibile una definizione agevolata (rottamazione), che permette di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. Se hai già subito pignoramenti o ipoteche, puoi ottenere la sospensione immediata con un ricorso o un’istanza di autotutela.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se la situazione è ormai fuori controllo e non riesci più a gestire i debiti, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È una procedura legale rivolta a piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori autonomi che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui (esdebitazione). È uno strumento riconosciuto dai tribunali italiani e rappresenta una soluzione concreta per salvare l’impresa o chiuderla in modo ordinato, senza lasciare pendenze fiscali o bancarie.
Come difendersi da banche, fornitori e finanziarie
Molte imprese artigianali hanno debiti con banche, finanziarie o fornitori di materie prime e attrezzature. In questi casi puoi chiedere la rinegoziazione dei finanziamenti, la sospensione temporanea delle rate o proporre un saldo e stralcio per chiudere i debiti a un importo ridotto. È possibile anche verificare la presenza di clausole abusive o tassi usurari nei contratti e impugnare decreti ingiuntivi o pignoramenti entro i termini di legge. Un avvocato esperto può assisterti nella trattativa con banche e fornitori, aiutandoti a evitare il blocco dell’attività e a proteggere i beni aziendali indispensabili per la produzione.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Una difesa legale tempestiva e ben strutturata può consentirti di sospendere pignoramenti e procedure di riscossione, ottenere la rateizzazione o cancellazione dei debiti, proteggere la casa e i beni personali, garantire la continuità dell’attività e ripartire su basi solide. In molti casi è possibile ristrutturare l’impresa, salvaguardando i posti di lavoro e la reputazione aziendale.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto cartelle, pignoramenti o intimazioni di pagamento, se hai debiti con il Fisco, l’INPS o le banche che non riesci più a sostenere o se temi il blocco dell’attività o il sequestro dei beni. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa può impugnare le cartelle illegittime, bloccare la riscossione e guidarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire in tempo è fondamentale per salvare la tua impresa e tutelare il tuo futuro economico.
⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o gli avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, ipoteche e perdita dei beni aziendali. Intervenire subito è l’unico modo per salvare la tua attività e proteggere la tua famiglia.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle imprese artigiane – spiega cosa fare se gestisci un’azienda di produzione di cappelli artigianali con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che stanno mettendo a rischio la tua attività artigianale?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua impresa, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
La produzione artigianale di cappelli – spesso portata avanti da piccoli imprenditori, ditte individuali o società a conduzione familiare – può trovarsi esposta a difficoltà finanziarie per molte ragioni: investimenti iniziali, cali di commesse, crisi economiche generali o eventi imprevisti. Quando un artigiano cappellaio accumula debiti (verso fornitori, banche, fisco, enti previdenziali, ecc.), è fondamentale conoscere quali strumenti legali l’ordinamento italiano offre dal punto di vista del debitore per gestire la crisi ed evitare conseguenze irreparabili. In questa guida avanzata, rivolta a avvocati, privati e imprenditori, esamineremo in dettaglio la normativa italiana aggiornata a settembre 2025, con riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti, per capire cosa fare e come difendersi in caso di sovraindebitamento di un’impresa artigiana di cappelli. Adotteremo un linguaggio giuridico ma accessibile, forniremo tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande e Risposte (FAQ). L’obiettivo è offrire una panoramica completa delle tutele e procedure – dai piani di rientro alle nuove procedure del Codice della Crisi – che consentono al debitore di ottenere una “seconda opportunità” evitando di essere schiacciato dai debiti in modo definitivo.
Contesto: artigiani indebitati e rischi connessi
Gli artigiani – come un produttore di cappelli artigianali – spesso operano tramite ditte individuali o piccole società. Ciò significa che la linea di separazione tra patrimonio d’impresa e personale può essere sottile, soprattutto nelle ditte individuali o nelle società di persone con soci a responsabilità illimitata. In caso di debiti non pagati, il quadro normativo prevede diverse forme di responsabilità patrimoniale. Vediamo il contesto generale e perché il tema è cruciale:
- Responsabilità patrimoniale universale: per il codice civile, il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.). L’artigiano cappellaio indebitato rischia quindi l’aggressione del proprio patrimonio da parte dei creditori, salvo limiti di legge specifici (come vedremo per l’abitazione principale e altri casi) .
- Debiti d’impresa vs debiti personali: Un artigiano in forma di ditta individuale non ha separazione patrimoniale – i debiti contratti per l’attività gravano sul patrimonio personale. Se invece opera tramite una società di capitali (es. una SRL artigiana), teoricamente i debiti sociali si limitano al patrimonio della società. Tuttavia, nella pratica molti artigiani anche soci di SRL rilasciano garanzie personali (fideiussioni) alle banche o ai fornitori, oppure incorrono in responsabilità personali per debiti tributari/previdenziali (ad esempio per omesso versamento di ritenute o IVA possono scattare sanzioni personali). Pertanto, anche dietro una forma societaria, il piccolo imprenditore artigiano può vedere il proprio patrimonio personale esposto.
- Crisi di liquidità e insolvenza: il sovraindebitamento è uno stato in cui l’artigiano non riesce più a far fronte regolarmente alle obbligazioni. La legge distingue tra crisi (squilibrio prospettico, difficoltà finanziarie che rendono probabile l’insolvenza) e insolvenza (incapacità attuale di pagare i debiti in modo regolare) . Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) definisce formalmente il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza di soggetti non fallibili – consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e in generale debitori non assoggettabili a procedure fallimentari ordinarie . Questa categoria include tipicamente l’artigiano individuale o la piccola impresa artigiana sotto le soglie di fallibilità.
- Soglie di fallibilità: in Italia, non tutti gli imprenditori commerciali possono essere dichiarati falliti (oggi liquidati giudizialmente). Le piccole imprese sotto determinati parametri di fatturato, attivo e debiti sono escluse dal fallimento e rientrano nel campo del sovraindebitamento. Tali soglie (non modificate sostanzialmente dal CCII) sono: aver avuto nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale annuo non superiore a circa €300.000, ricavi lordi annui non superiori a €200.000, e un debito anche non scaduto non superiore a €500.000 (art. 2, co.1 lett. d CCII che richiama in sostanza i limiti ex art. 1 L.Fall.). Un artigiano cappellaio di modeste dimensioni in genere rientra in questi parametri, quindi non è soggetto a fallimento e potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento (piani di ristrutturazione o concordato minore) . Se invece l’impresa artigiana avesse dimensioni superiori a tali soglie, in caso di insolvenza potrà essere soggetta a procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).
- Conseguenze del sovraindebitamento non gestito: se un artigiano indebitato non interviene con strumenti legali adeguati, i creditori possono attivare azioni esecutive individuali: pignoramenti immobiliari (compresi laboratori, capannoni o case di proprietà, fatti salvi i limiti sulla prima casa di cui diremo), pignoramenti mobiliari (macchinari, automezzi tramite fermo amministrativo, ecc.), pignoramenti presso terzi (crediti verso clienti, conti correnti, stipendio del titolare se nel frattempo ha un altro lavoro). Inoltre, i singoli creditori potrebbero presentare istanze di fallimento (se applicabile) o sollecitare procedure concorsuali. Tutto ciò mette a rischio la continuazione dell’attività artigianale e persino i beni primari del debitore (casa, mezzi di sostentamento), con impatti gravissimi sulla sua vita e quella della famiglia. È proprio per evitare queste conseguenze che il legislatore ha approntato specifici strumenti di composizione della crisi, volti a contemperare le ragioni dei creditori con la tutela della dignità e della sopravvivenza economica del debitore.
In sintesi, l’artigiano indebitato si trova al centro di opposte esigenze: da un lato l’obbligo di pagare i creditori, dall’altro il diritto a non essere economicamente “annientato” dai debiti. Le sezioni seguenti illustreranno le tipologie di debiti più comuni e le rispettive conseguenze, quindi gli strumenti legali di difesa e composizione del debito, sia straordinari (procedure concorsuali) sia ordinari (azioni oppositive e dilatorie), tenendo sempre presente il punto di vista del debitore in difficoltà.
Tipologie di debiti comuni e relative conseguenze per l’artigiano
Un’analisi efficace deve distinguere i diversi tipi di debito che un artigiano cappellaio può aver accumulato, poiché la natura del credito influisce sulle strategie di gestione e sulle azioni che il creditore può intraprendere. Di seguito esaminiamo le categorie principali di debiti e i rischi connessi per il debitore.
Debiti bancari e finanziari
Debiti verso banche e finanziarie: comprendono mutui per acquisto di macchinari o immobili, scoperti di conto, finanziamenti per liquidità, leasing su attrezzature, o prestiti personali eventualmente contratti per sostenere l’attività. Questi debiti comportano spesso garanzie reali o personali: – Garanzie reali: Se il debito è garantito da ipoteca su un immobile (es. il laboratorio o la casa del titolare) o da pegno su beni, la banca creditrice ha diritto di prelazione su quei beni. In caso di inadempimento, può attivare una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato (pignoramento e vendita all’asta) o sul bene dato in pegno, per soddisfarsi sul ricavato. – Garanzie personali: Molti istituti richiedono la fideiussione personale del titolare (o dei soci). In caso di insolvenza della ditta, la banca può escutere direttamente il garante sul suo patrimonio personale.
Conseguenze e strumenti di difesa: se l’artigiano non paga le rate, la banca di norma invia intimazioni e poi procede a decadenza dal beneficio del termine, chiedendo l’immediato pagamento di tutto il debito residuo. Se non si trova un accordo (come un piano di rientro o una rinegoziazione), la banca può: – Agire in giudizio per decreto ingiuntivo (spesso ottenuto in tempi rapidi data la prova scritta del credito bancario). Una volta esecutivo, procederà a pignoramento dei beni disponibili. – Escutere le garanzie reali: ad esempio iniziare un pignoramento immobiliare sull’immobile ipotecato. La presenza di ipoteca dà al creditore fondiario alcuni privilegi processuali: ad esempio, nel caso di mutuo fondiario, la banca può iniziare o proseguire l’esecuzione immobiliare anche se è pendente una procedura concorsuale minore del debitore . La Cassazione nel 2024 ha confermato che, in una procedura di liquidazione del sovraindebitato, il creditore ipotecario fondiario può proseguire l’esecuzione individuale nonostante l’apertura della procedura, grazie al privilegio processuale ex art. 41 TUB . Ciò significa che, ad esempio, se l’artigiano ha un mutuo fondiario sulla sede dell’attività e tenta la liquidazione controllata, la banca potrebbe comunque far vendere l’immobile separatamente (con obbligo però di versare in procedura l’eventuale eccedenza ricavata).
- Pignorare altri beni o crediti: se ci sono fideiussori, conti bancari in attivo, crediti verso terzi (clienti), la banca può pignorarli (es. pignoramento presso terzi del conto corrente aziendale/personale).
Per difendersi, l’artigiano può: – Negoziare una moratoria o ristrutturazione del debito con la banca, magari tramite un consulente, presentando un piano credibile di rientro parziale (saldo e stralcio) o dilazionato. Le banche, se vedono concrete prospettive di recupero maggiore rispetto alla liquidazione forzata, possono accettare la ristrutturazione. – Attivare procedure concorsuali minori (come concordato minore o piano del consumatore, se applicabile) offrendo il pagamento parziale del dovuto. In tali procedure, il trattamento dei creditori privilegiati come le banche ipotecarie segue regole specifiche: bisogna garantire loro almeno quanto otterrebbero liquidando la garanzia. Se il piano propone di pagarli in misura o tempi peggiori del loro diritto, hanno facoltà di voto contrario e opposizione. Ad esempio, la Cassazione ha ribadito che se un creditore ipotecario in un concordato minore viene pagato oltre i termini contrattuali iniziali, ciò equivale a un sacrificio e gli conferisce diritto di voto sulla proposta . Nel piano del consumatore, dove non c’è voto, inizialmente la legge 3/2012 prevedeva un limite massimo di moratoria di 1 anno per pagare i creditori privilegiati, salvo vendita del bene; tale limite però è interpretato ora in modo più flessibile: Cass. 4622/2024 ha statuito che il termine annuale non è perentorio e che, se la dilazione più lunga migliora la soddisfazione dei creditori, è ammissibile anche un piano che paghi l’ipoteca in più di cinque anni . – Opposizioni legali: se la banca agisce in via monitoria (decreto ingiuntivo), verificare con l’avvocato l’eventuale presenza di vizi (es. interessi usurari o anatocistici, indebiti addebiti) e proporre opposizione al decreto per guadagnare tempo o ridurre il debito contestando la legittimità di parte delle somme. Allo stesso modo, nel pignoramento immobiliare si possono verificare vizi di notifica o procedura da far valere con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se vi sono fondati motivi.
Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
Debiti di fornitura: l’attività di cappellaio artigiano comporta l’acquisto di materiali (stoffe, teline, accessori), servizi (es. tintorie, consulenze) e talvolta il pagamento di collaboratori o laboratori esterni. Se l’artigiano non paga le fatture ai fornitori, questi ultimi possono tutelarsi in vari modi: – Interessi di mora e sospensione forniture: Il fornitore può applicare interessi di mora (spesso rilevanti secondo il D. Lgs. 231/2002 per transazioni commerciali) e potrebbe sospendere ulteriori forniture, aggravando le difficoltà dell’artigiano. – Recupero crediti stragiudiziale: molti fornitori si rivolgono a società di recupero crediti o inviano diffide tramite legale. Ciò può preludere a un’azione legale, ma talvolta porta a transazioni. L’artigiano debitore, se possibile, dovrebbe cercare un accordo (“saldo e stralcio” ossia pagamento parziale a fronte di rinuncia al resto) soprattutto con fornitori che non convenga portare a procedimento lungo. – Azione monitoria e pignoramento: un fornitore non pagato può ottenere un decreto ingiuntivo (ha come prova la fattura e DDT, contratti, ecc.) e, decorso il termine, procedere a pignorare beni o crediti del debitore. Ad esempio, potrebbe pignorare il conto corrente aziendale/personale o attrezzature non indispensabili. Può anche iscrivere ipoteca giudiziale su immobili dell’artigiano dopo il decreto ingiuntivo, a garanzia del credito.
Strumenti di difesa: – Controllo delle pretese: Innanzitutto, verificare se il credito del fornitore è certo, liquido ed esigibile. Se ci sono contestazioni sulla qualità della merce, vizi, ritardi nelle consegne, l’artigiano può opporre eccezioni per ridurre l’importo dovuto o chiedere risarcimenti. Queste eccezioni possono sollevarsi in un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. – Negoziazione e piani di rientro: Spesso i fornitori sono interessati a mantenere il rapporto commerciale. L’artigiano, magari coadiuvato da un advisor, può proporre un piano di rientro extragiudiziale dilazionato, da formalizzare con scrittura privata. Ciò evita l’immediata aggressione patrimoniale, purché il debitore rispetti le nuove scadenze. Attenzione: se si firma una ricognizione di debito o cambiali, si da al creditore uno strumento esecutivo più rapido in caso di inadempimento, quindi occorre essere sicuri di poter rispettare il piano. – Procedura di composizione della crisi: Nelle procedure concorsuali minori (piano del consumatore, concordato minore), i fornitori rientrano tra i creditori chirografari (non privilegiati) a meno che vantino privilegio speciale (es. privilegio artigiano o edile per lavori su beni altrui, di solito non applicabile a forniture ordinarie di materie prime). In un piano di ristrutturazione o concordato, tali creditori chirografari spesso subiscono un taglio (falcidia) consistente del credito. Il piano può prevedere di pagarli solo in parte (percentuale sul dovuto) e in tempi differiti, e la parte residua viene cancellata (esdebitata) a esecuzione del piano . Se la maggioranza (nel concordato minore) approva o il giudice omologa (nel piano del consumatore), anche i fornitori dissenzienti sono obbligati alla riduzione. Ad esempio, se un artigiano ha €50.000 di debiti con vari fornitori, il piano potrebbe prevedere il pagamento del 20%, liberando il debitore dal restante 80%. Va però notato che, secondo la Cassazione n. 28013/2022, un piano del consumatore che offra ai chirografari una soddisfazione “irrisoria” (nel caso concreto meno del 4%) può essere dichiarato inammissibile per difetto di causa, in quanto un minimo di ritorno per i creditori è necessario . Non esiste una soglia fissa di legge, ma occorre buon senso e proporzionalità nella proposta. – Tutela del patrimonio personale: se l’artigiano opera in forma societaria e non ha garanzie personali verso fornitori, il rischio è limitato ai beni aziendali. Tuttavia spesso i fornitori, potendo aggredire facilmente macchinari o merci, mettono a rischio la continuità aziendale. Una mossa difensiva può essere valutare il concordato preventivo (se fallibile) o il concordato minore: l’apertura di tale procedura sospende le azioni esecutive in corso e impone ai creditori di aderire alla soluzione collettiva, anziché procedere individualmente (vedi infra sulle misure protettive).
Debiti tributari (Erario) e cartelle esattoriali
Debiti verso l’Erario: includono imposte non pagate (IVA, imposte sui redditi, IRAP), ritenute non versate, imposte locali (IMU, TARI) e relative sanzioni e interessi. Tali debiti normalmente vengono affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) (ex Equitalia) per la riscossione coattiva, a meno che non siano pagati o rateizzati spontaneamente. Le forme tipiche che assume il debito tributario sono: – Cartelle esattoriali: titolo esecutivo emesso dall’Agenzia Riscossione a seguito di ruolo. Se l’artigiano non paga entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva e l’AER può avviare misure cautelari/esecutive. – Accertamenti esecutivi: avvisi dell’Agenzia delle Entrate che, decorsi i termini, valgono come titolo esecutivo similmente alle cartelle.
Poteri dell’Agente della Riscossione: AER ha strumenti peculiari per riscuotere: – Fermo amministrativo di beni mobili registrati: può iscrivere fermo su un autoveicolo o furgone dell’impresa, impedendone la circolazione legale. Questo di norma avviene dopo un preavviso al debitore. Non esiste un importo minimo di legge per il fermo (anche importi modesti possono teoricamente generarlo), sebbene in passato Equitalia usasse soglie di prassi (ad es. non sotto €500-€1000). Per debiti maggiori (sopra €2.000) il fermo può colpire più veicoli, fino anche a tutti (in passato: fino a 10 veicoli per debiti €2.000-10.000, oltre 10 veicoli se debiti >€10.000) . Effetti: il fermo non realizza il credito ma vincola il bene, inducendo il debitore a pagare per ottenere la cancellazione (anche perché circolare con veicolo sottoposto a fermo comporta sanzioni severe) . – Ipoteca esattoriale: per debiti sopra certe soglie AER può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore come misura cautelare (in genere per debiti da €20.000 in su, su immobili di valore). L’ipoteca è un preavviso di possibile espropriazione futura e garantisce il credito con prelazione. – Pignoramento immobiliare: la vendita all’asta di immobili del debitore da parte di AER è soggetta a stringenti limiti di legge a tutela dell’abitazione principale. In nessun caso AER può pignorare l’immobile del debitore se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte : 1. L’immobile è unico immobile di proprietà del debitore; 2. È adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; 3. Non è un immobile di lusso (categorie catastali escluse A/8, A/9 ecc.).
Questa è la condizione della cosiddetta *“prima casa” non pignorabile* dal Fisco. Se tali requisiti sussistono, l’Agenzia potrà al più iscrivere ipoteca legale sull’immobile (a tutela del credito) ma **non potrà procedere alla vendita all’asta** . Negli altri casi (cioè immobili diversi dalla prima casa, oppure se il debitore ha più immobili, o l’immobile non è prima casa), **AER può pignorare e vendere** ma solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni ulteriori :
– Il **debito totale** affidato in riscossione supera €120.000 ;
– Il **valore complessivo** degli immobili di proprietà del debitore (risultante dalle visure catastali) supera €120.000 ;
– **Sono passati almeno 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca** senza che il debitore abbia pagato o ottenuto la sospensione del debito .
In pratica, AER deve prima iscrivere ipoteca; se dopo 6 mesi il debitore non ha ancora pagato o rateizzato, e il debito è consistente (>120k), allora può iniziare il pignoramento immobiliare. Queste tutele legislative (introdotte dal 2013) evitano che, per debiti fiscali relativamente piccoli, persone e famiglie perdano la casa di abitazione. Va notato che questi limiti valgono *solo per AER*: un creditore **privato** (es. banca o fornitore) può pignorare la casa anche per importi inferiori, in assenza di altre tutele.
- Pignoramento presso terzi da parte di AER: L’Agente della Riscossione può pignorare conti correnti, stipendio, pensione, crediti verso clienti dell’artigiano, con modalità semplificate. Ad esempio, invia direttamente all’istituto bancario l’ordine di blocco del conto fino a concorrenza del debito. Per stipendi/salari (nel caso in cui l’artigiano abbia anche un lavoro dipendente, o per stipendi di dipendenti in caso di ritenute non versate) esistono limiti percentuali pignorabili:
- Fino a €2.500 (netti) mensili: pignorabile 1/10 ;
- Tra €2.500 e €5.000: pignorabile 1/7 ;
- Oltre €5.000: pignorabile 1/5 (20%), che è anche il limite generale previsto dal codice di procedura civile per stipendi e pensioni .
- In ogni caso, l’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente non può essere pignorato ed è lasciato al debitore (tale norma garantisce un minimo vitale nel momento del pignoramento).
- Per pensioni, la legge tutela un importo minimo pari all’assegno sociale aumentato della metà: solo l’eccedenza è pignorabile e comunque sempre nei limiti di 1/5.
Difendersi dai debiti fiscali: i debiti tributari hanno natura privilegiata (in gran parte) e inoltre, se consistenti e riferiti a IVA o ritenute non versate, possono sfociare in illeciti penali tributari. Dunque la gestione di questi debiti è prioritaria. Gli strumenti sono: – Definizioni agevolate e condoni: il legislatore, specie negli ultimi anni, ha introdotto misure straordinarie di sollievo. Ad esempio la “rottamazione delle cartelle” (vari provvedimenti dal 2016 al 2023) permette al debitore di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta e pochi oneri, condonando sanzioni e interessi di mora. L’ultima “rottamazione-quater” (2023) ha ad esempio consentito di definire i ruoli fino al 30/6/2022 con abbattimento totale di interessi e sanzioni, e pagamento in 18 rate in 5 anni. Altre norme (L. 197/2022) hanno previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a €1.000 affidati ad AER dal 2000-2015. È importante che l’artigiano monitori questi provvedimenti (generalmente ad adesione volontaria entro termini fissati) perché possono ridurre drasticamente il carico fiscale. – Rateizzazioni ordinarie: se non vi sono definizioni speciali attive, il debitore può sempre chiedere a AER la rateizzazione del debito in cartella. Attualmente: per debiti fino a €120.000 è concessa di diritto una dilazione ordinaria fino a 72 rate mensili (6 anni) semplicemente su richiesta; per importi superiori occorre dimostrare una temporanea situazione di difficoltà economica e si può ottenere fino a 6 anni (72 rate) o, in casi gravi, una dilazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni) . La rateazione evita le azioni esecutive, purché le rate vengano pagate puntualmente (basta saltare la soglia massima di rate consecutive non pagate – generalmente 5 – perché la dilazione decada). – Sospensioni e impugnative: valutare con un tributarista se le cartelle o gli accertamenti siano contestabili (vizi di notifica, prescrizione, decadenza, errore di calcolo). Se si presenta ricorso in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) o istanza di autotutela, in certi casi si può ottenere la sospensione della riscossione. Es. una cartella mai notificata regolarmente non può dar luogo a pignoramento: se AER agisce, il debitore può opporsi davanti al giudice dell’esecuzione per nullità della notifica. – Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo o minore, accordi di ristrutturazione) è possibile proporre il pagamento parziale di debiti fiscali e previdenziali (transazione fiscale ex art. 63 CCII). In passato ciò richiedeva il voto favorevole dell’Erario e degli enti, ma le recenti riforme hanno introdotto il cram down fiscale: il tribunale può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche senza voto favorevole del Fisco se la proposta è più conveniente della liquidazione . Dal 2023 inoltre la transazione fiscale è stata estesa anche alla composizione negoziata (strumento extra-giudiziale di cui infra) . Queste innovazioni tolgono all’Erario un potere di veto che in passato spesso bloccava i piani di ristrutturazione. – Misure protettive nelle procedure concorsuali: se l’artigiano presenta un ricorso per concordato minore o un piano di ristrutturazione dei debiti, può chiedere al tribunale misure di sospensione dei procedimenti esecutivi. Il giudice, se concede le misure protettive, ordina che non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né si possano acquisire nuove garanzie sui beni del debitore sino all’omologazione . Ciò congela anche l’attività di AER (fermi, pignoramenti) durante la procedura, a tutela del patrimonio e della par condicio. Attenzione però: in caso di piano del consumatore o concordato minore, tali misure non scattano automaticamente alla presentazione del ricorso – devono essere specificamente richieste dal debitore e autorizzate dal giudice con decreto . Il nuovo Codice consente ai creditori di fare reclamo contro l’eventuale concessione delle misure protettive (specie se ritengono che il debitore stia abusando del congelamento solo per ritardare senza vera prospettiva di ristrutturazione).
Debiti previdenziali e verso enti (INPS, INAIL, casse)
Gli artigiani sono tenuti al versamento di contributi obbligatori all’INPS gestione artigiani e commercianti (contributi fissi trimestrali più contributi sul reddito eccedente il minimale) e, se hanno dipendenti, di contributi come sostituto d’imposta e premi INAIL. Il mancato pagamento di tali contributi genera: – Avvisi di addebito INPS: titoli esecutivi analoghi alle cartelle, che confluiscono anch’essi nell’attività di Agenzia Entrate-Riscossione. – Sanzioni civili: i contributi omessi non versati nei termini subiscono sanzioni civili (interessi e importi aggiuntivi) spesso elevate, che tendono a far lievitare il debito. – DURC irregolare: il debitore risulterà non in regola col DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con la conseguenza di non poter partecipare a gare pubbliche e, se lavora anche come subappaltatore o fornitore in edilizia, può subire sospensioni nei pagamenti.
Azioni di riscossione: i contributi omessi seguono la stessa via delle imposte: cartelle esattoriali o avvisi di addebito e poteri di pignoramento tramite AER. Inoltre, per i contributi dipendenti (trattenute in busta paga non versate) e per l’IVA, ricordiamo che superare determinate soglie di omesso versamento integra reati penali (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000). Ciò esula dall’ambito civile di questa guida, ma è un’ulteriore pressione sul debitore a regolarizzare.
Strumenti di gestione e difesa: analoghi a quelli fiscali: – Rateazioni con INPS/AER: gli avvisi di addebito INPS sono rateizzabili con procedure simili alle imposte (l’INPS può concedere piani fino a 24 rate per contributi correnti; se passato ad AER, le regole di rateazione sono quelle generali già viste). – Transazione contributiva: in concordati o accordi, insieme alla transazione fiscale si può proporre falcidia dei contributi. La legge prevede però che i contributi previdenziali per le gestioni obbligatorie non possano essere falcidiati oltre una certa misura salvo adesione dell’ente, a tutela delle prestazioni pensionistiche. Le recenti norme di cram down valgono anche per gli enti previdenziali pubblici (es. INPS), equiparati agli enti fiscali per l’omologazione forzata . – Contenzioso e prescrizione: i contributi hanno termini di prescrizione (5 anni generalmente). Verificare con un legale specializzato se i crediti INPS sono prescritti, e in caso eccepirlo in giudizio o con istanza all’ente. Attenzione: la notifica di una cartella interrompe la prescrizione, ma se la cartella non è stata notificata regolarmente o l’INPS non ha agito entro 5 anni, il debito potrebbe essere non più dovuto. – Sovraindebitamento: nelle procedure come piano del consumatore/concordato minore, i debiti contributivi rientrano tra quelli privilegiati (per la parte di contributi puri) e chirografari (per sanzioni civili). Il piano deve garantire il rispetto della graduatoria dei privilegi: ad esempio, non si può pagare nulla sui contributi e dare invece qualcosa ai chirografari, perché i crediti previdenziali (come i fiscali) hanno privilegio generale sui mobili dell’azienda (ex art. 2753 c.c.) e vanno soddisfatti prima dei fornitori chirografari. È possibile tuttavia proporre di falcidiare parzialmente anche il credito privilegiato, se la liquidazione del patrimonio darebbe comunque ai contributi una soddisfazione parziale (in concordato preventivo tale falcidia è ammessa salvo che su ritenute non versate). Nei piani del consumatore, il giudice valuterà la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria anche per l’INPS: se il piano offre all’INPS almeno quanto ricaverebbe pignorando, può omologarlo anche senza consenso dell’ente (applicando di fatto un cram down contributivo) .
Altre passività: canoni, utenze, finanziamenti privati
Un artigiano potrebbe avere anche altri debiti: – Canoni locazione del laboratorio/negozio: il proprietario dell’immobile può attivare sfratto per morosità (con liberazione dei locali in pochi mesi) e agire per il credito dei canoni insoluti con decreto ingiuntivo. Inoltre, la legge gli riconosce privilegio sui beni mobili del conduttore che si trovano nell’immobile (pegno locatizio ex art. 2764 c.c.), quindi può farli pignorare con precedenza su altri creditori. – Utenze e fornitori di servizi (energia, telefono): oltre al distacco del servizio per morosità, i creditori possono cedere il credito a società di recupero o agire giudizialmente. Questi debiti in genere sono di importo minore ma in massa possono contribuire al sovraindebitamento. – Finanziamenti da privati o familiari: a volte l’artigiano può avere prestiti informali. Se formalizzati con scritture o assegni, il creditore può agire come un qualunque altro creditore chirografario. Se invece erano somme non dichiarate, potrebbero emergere solo nel contesto familiare, ma in una procedura concorsuale tutti i debiti vanno dichiarati: anche il parente creditore sarà trattato come chirografario (sempre che il credito non venga contestato per simulazione). – Sanzioni amministrative (multe): le multe stradali o altre sanzioni amministrative finiscono anch’esse in cartelle esattoriali. Nei piani di sovraindebitamento, le multe sono considerate crediti chirografari di diritto pubblico: possono essere falcidiate fino anche all’azzeramento (non essendo tributi né contributi, non godono di privilegio né richiedono transazione fiscale per essere ridotte). – Debiti da fideiussioni escusse: se l’artigiano aveva garantito debiti altrui (es. di un consorzio, di un collega) e la garanzia è escussa, egli diviene debitore verso il creditore in solido. Rientra comunque nella categoria ordinaria del debito civile.
Conseguenze e difesa: analoghe ai casi visti – ogni creditore cercherà il modo più rapido per soddisfarsi, e l’artigiano dovrà contrattare piani di rientro o ricorrere alle procedure unitarie per bloccarli. Un punto importante: evitare la proliferazione di azioni esecutive disordinate. Se già uno o più creditori hanno pignorato beni, altri potrebbero intervenire su quelle esecuzioni (concorso) peggiorando la situazione. In tali frangenti, può essere opportuno valutare l’accesso immediato a una procedura concorsuale unitaria (come il concordato minore) che concentri la gestione dei debiti in tribunale e sospenda le esecuzioni individuali . Tuttavia, l’accesso a queste procedure richiede tempo e preparazione (serve l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi e la redazione di un piano e proposta dettagliata).
Nei paragrafi seguenti entreremo nel vivo degli strumenti legali di soluzione del sovraindebitamento, delineati dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza e dalla legislazione speciale, evidenziando per ciascuno modalità di accesso, vantaggi, limiti e novità normative fino al 2025.
Strumenti legali per la gestione e la risoluzione dei debiti
Quando la situazione debitoria diventa insostenibile, l’artigiano indebitato ha davanti a sé due strade non esclusive: soluzioni stragiudiziali (accordi privati, piani di rientro, rifinanziamenti) oppure procedure concorsuali e para-concorsuali previste dalla legge (procedure di sovraindebitamento per non fallibili, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati, ecc.). Analizziamo in dettaglio questi strumenti, partendo dalle procedure di sovraindebitamento introdotte dalla Legge 3/2012 (aggiornata nel Codice della Crisi 2019/2022) e proseguendo con gli altri istituti di composizione delle crisi d’impresa.
Procedure di sovraindebitamento (debitori non fallibili)
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019 entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022, ha riorganizzato le procedure già previste dalla Legge 3/2012 per i debitori civili e piccoli imprenditori (sovraindebitati). Le procedure disponibili (Titolo IV, Capo II CCII) sono essenzialmente tre:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): ex “piano del consumatore”, riservata alle persone fisiche consumatrici (che hanno debiti personali estranei ad attività d’impresa).
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII): ex “accordo di composizione della crisi”, destinato ai debitori non consumatori non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative, ecc.) .
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): ex “liquidazione del patrimonio”, procedura liquidatoria, che può essere volontaria o anche chiesta dai creditori in taluni casi.
A queste si aggiunge una speciale misura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) per i casi in cui proprio non vi sia nulla da liquidare.
Vediamo singolarmente in cosa consistono:
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore)
Chi può accedervi: solo la persona fisica consumatore, definita dall’art. 2, co.1, lett. f) CCII come la persona fisica che ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta . Dunque un artigiano in attività non è un consumatore per i debiti inerenti all’attività. Tuttavia, un artigiano potrebbe accedere come consumatore se i suoi debiti sono promiscui o se ha cessato l’attività: ad esempio, un ex imprenditore artigiano che ha chiuso la ditta e i debiti residui (anche derivanti dall’attività passata) può provare a qualificarsi come consumatore se attualmente agisce al di fuori di qualsiasi attività imprenditoriale . La giurisprudenza ha dibattuto il tema del “sovraindebitamento misto” (debiti in parte da attività, in parte da vita privata): secondo un autorevole orientamento, si può guardare alla finalità del singolo debito e ammettere al piano del consumatore la persona fisica i cui debiti commerciali sono accessori e non prevalenti, purché attualmente non svolga più attività d’impresa . In ogni caso, nel nostro scenario l’artigiano cappellaio probabilmente dovrà usare il concordato minore se la sua posizione debitoria riguarda l’attività; potrà invece usare il piano del consumatore per eventuali debiti estranei all’attività (es. debiti personali, familiari).
Caratteristiche della procedura: la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale semplificata e senza voto dei creditori. In sintesi: – Il consumatore, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) nominato dal tribunale, predispone un Piano in cui indica come intende pagare, anche parzialmente e/o in forma dilazionata, i propri debiti . Il piano può prevedere qualsiasi forma di ristrutturazione: dilazioni pluriennali, stralcio di parte dei crediti, cessione di alcuni beni per pagare in parte i creditori, mantenimento di altri beni. Ad esempio, potrebbe proporre di pagare integralmente i debiti ipotecari (per salvare la casa) ma solo il 30% dei debiti chirografari, tramite rate mensili in 5 anni derivanti dal reddito da lavoro. – Devono essere rispettati alcuni vincoli: ai creditori privilegiati (pegno, ipoteca, privilegio) va garantito almeno l’equivalente di quanto otterrebbero in una liquidazione controllata . Questo è il principio della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Inoltre il piano può prevedere il pagamento a scadenza naturale delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa del debitore (come introdotto nel CCII art. 67(5)): ciò consente di non dover per forza “accelerare” il rimborso del mutuo nel piano, ma continuare a pagarlo alle scadenze originarie, evitando di perdere l’abitazione. – Il piano può includere anche debiti futuri: ad esempio, la legge consente di ristrutturare debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio , riducendo la quota ceduta o falcidiando il credito residuo – notevole novità, poiché prima tali crediti venivano considerati di regola intoccabili dovendo il quinto proseguire. – L’OCC redige una relazione particolareggiata (art. 68 CCII) da allegare, in cui attesta la veridicità dei dati, le cause dell’indebitamento, e valuta la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore. – Si deposita il ricorso con il piano presso il tribunale competente (residenza del debitore). Non c’è voto dei creditori: i creditori vengono informati e possono presentare eventuali contestazioni (osservazioni) , ma non hanno un potere deliberativo sulla proposta. – Misure protettive: il consumatore deve chiedere eventualmente al giudice la sospensione delle azioni esecutive, che non scatta automaticamente . Se concessa, tutti i creditori (anche il Fisco, le banche ecc.) non possono iniziare né proseguire pignoramenti fino all’omologazione. – Omologazione giudiziale: si tiene un’udienza dinanzi al giudice monocratico in cui si valuta il piano. Il giudice verifica: 1. Requisiti soggettivi: assenza di cause ostative ex art. 69 CCII – ossia che il debitore non abbia con dolo o colpa grave aggravato la sua posizione o contratto debiti in malafede/frode, e che non abbia già ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti (o più di due volte in totale) . Queste condizioni di meritevolezza sono fondamentali: se emergono, il piano non è ammissibile. Va però segnalato un importante cambio di prospettiva: la meritevolezza nel nuovo CCII è formulata in negativo (“assenza di frode, malafede, colpa grave”) rispetto alla formulazione più discrezionale della vecchia legge 3/2012 (che richiedeva che il debitore fosse “meritevole” in senso ampio). La Cassazione 22890/2023 ha chiarito che per i procedimenti pendenti non omologati al momento dell’entrata in vigore del CCII, si applica la nuova disciplina, rilevando la differenza sostanziale tra il vecchio criterio di meritevolezza e il nuovo: ora conta solo che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con condotte gravemente colpevoli o fraudolente . Questa interpretazione restrittiva è a vantaggio del debitore, e la Suprema Corte auspica che i giudici di merito vi si attengano (quindi, meno spazio per valutazioni “morali” generiche e più focus su comportamenti oggettivamente scorretti). 2. Fattibilità del piano: ossia che le risorse prospettate (redditi futuri, liquidazione di beni, intervento di terzi) siano realistiche e sufficienti a coprire quanto promesso . Ad esempio, se il piano prevede rate per 5 anni, ci si aspetta che il debitore abbia redditi stabili o un garante. 3. Convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione: anche se i creditori non votano, se qualcuno contesta la convenienza, il giudice può omologare il piano solo se ritiene che ogni creditore ottenga col piano almeno quanto otterrebbe dallo scenario liquidatorio . Questa è una sorta di cram-down giudiziale: se un creditore, poniamo una banca, obietta di ricevere troppo poco, il giudice confronta la percentuale offerta col presumibile attivo ricavabile liquidando i beni del debitore. Se col piano la banca riceve, ad esempio, il 40% e in caso di liquidazione prenderebbe il 20%, il giudice potrà omologare anche contro il parere della banca (art. 70, co.9 CCII). 4. Assenza di frode ai creditori: ad esempio, se il debitore ha dolosamente sottratto o simulato parti dell’attivo (venduto beni a parenti prima di chiedere il piano, o nascosto entrate), il giudice può ritenere violato l’obbligo di lealtà e rigettare. Un caso tipico è la donazione di beni prima del piano: la Cassazione ha ritenuto, ad esempio, che la donazione di un immobile alla figlia prima di proporre un accordo è un atto in frode ai creditori che giustifica il diniego di omologa . Inoltre, anche se quell’immobile non è più del debitore, va considerato nel calcolo della convenienza liquidatoria perché il creditore ipotecario avrebbe potuto revocare la donazione e soddisfarsi: escluderlo dal piano rende la proposta meno conveniente rispetto alla liquidazione con revocatoria . – Se il giudice riscontra tutti i requisiti, omologa il piano con decreto. Da quel momento, il piano diviene vincolante per tutti i creditori anteriori. Effetti principali: – I creditori non possono più iniziare né proseguire azioni esecutive individuali per i debiti oggetto del piano (devono accontentarsi di quanto ricevono secondo il piano). – Il debitore deve eseguire puntualmente gli impegni previsti (pagare le rate, cedere i beni promessi, ecc.). Viene normalmente nominato un OCC/gestore che sovraintende all’esecuzione, paga i creditori con le somme via via raccolte e riferisce al giudice eventuali problemi. – Se il debitore non adempie senza giustificazione o vìola gli obblighi (es. fa nuovi debiti ingiustificati, non versa ai creditori ciò che doveva), su istanza dei creditori o d’ufficio il tribunale può revocare l’omologazione . La revoca comporta la perdita delle protezioni e, generalmente, l’apertura di una liquidazione controllata del patrimonio su richiesta del debitore o anche dei creditori in caso di frode . – Esdebitazione: una volta eseguito il piano, il debitore ottiene la definitiva liberazione dai debiti residui non soddisfatti. In realtà, l’effetto esdebitatorio è immediato ex lege dall’omologazione, condizionato risolutivamente al corretto adempimento del piano. Ciò significa che i crediti anteriori non più previsti dal piano rimangono inesigibili nei confronti del debitore (salvo riattivarsi solo se la procedura si risolve in revoca per inadempimento colpevole). In caso di buon esito, il debitore ha la cosiddetta fresh start: i debiti vengono cancellati nella parte non pagata.
Vantaggi e limiti del piano del consumatore: Il grande vantaggio è la mancanza di voto dei creditori: un debitore meritevole può ottenere il piano anche contro il volere di tutti i creditori, se convince il giudice della sostenibilità e correttezza della proposta. Questo strumento è pensato proprio per aiutare la persona sommersa dai debiti a ripartire, bilanciando l’interesse sociale a dare una seconda chance con quello dei creditori a recuperare almeno in parte il dovuto. D’altro canto, il limite è che non tutti possono qualificare come consumatori (un artigiano in attività no, come detto) e che richiede trasparenza e correttezza assoluta: qualsiasi comportamento oscuro del debitore (documenti falsi, omissione di beni, peggioramento volontario del passivo) costituisce reato e causa di rigetto . Il CCII ha infatti introdotto all’art. 344 sanzioni penali severe per il debitore che fraudolentemente altera la propria situazione ai fini dell’accesso o durante la procedura .
Concordato minore (accordo di ristrutturazione per imprenditori minori)
Chi può accedervi: il concordato minore è riservato ai debitori non fallibili che non siano consumatori . In pratica: – Imprenditori minori commerciali (sotto soglie art. 2 CCII), – Imprenditori agricoli (esenti da fallimento), – Professionisti e lavoratori autonomi, – Start-up innovative, – Enti non profit indebitati, – e in generale “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale” che non sia persona fisica consumatore.
Nel nostro caso, l’artigiano cappellaio che abbia debiti derivanti dalla sua attività rientra esattamente nella figura di imprenditore minore e quindi il concordato minore è lo strumento concorsuale principe a sua disposizione per evitare la liquidazione e trovare un accordo con i creditori.
Natura della procedura: il concordato minore è simile a un piccolo concordato preventivo, ma adattato ai non fallibili. Le sue caratteristiche: – Proposta e piano del debitore: il debitore (con l’ausilio dell’OCC) formula una proposta di concordato minore ai creditori accompagnata da un piano contenente le modalità attuative . Può prevedere: – Continuità aziendale: il debitore prosegue la sua attività e paga i creditori col ricavato futuro (magari riducendo il debito). Oppure l’azienda può essere ceduta in esercizio a terzi. – Liquidazione dei beni: oppure può essere un concordato liquidatorio (l’attività cessa e i beni vengono venduti per pagare i creditori in percentuale). – Misto: frequente è un piano con cessione di alcuni beni (es. immobili) e prosecuzione dell’attività limitata per generare utili con cui pagare il resto. – Voto dei creditori: a differenza del piano del consumatore, qui i creditori votano. Il giudice, ricevuto il ricorso, apre la procedura con decreto (se ci sono i documenti e condizioni) e fissa un termine (max 30 giorni) perché i creditori esprimano la propria adesione o mancata adesione alla proposta via PEC all’OCC . Si richiede, per l’approvazione, il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto . Dunque è un meccanismo di maggioranza semplice (50%+1 in valore). – Attenzione: quali creditori votano? In generale tutti i creditori chirografari votano; i privilegiati votano solo se la proposta prevede di soddisfarli in misura inferiore al 100% o con dilazioni non conformi ai loro diritti (ad esempio, se un creditore ipotecario viene pagato integralmente ma oltre i tempi contrattuali, la giurisprudenza ritiene che subendo un pregiudizio temporale debba avere diritto di voto) . La Cassazione 22797/2023 ha appunto ribadito che il creditore ipotecario non interamente soddisfatto nei tempi o importi previsti contrattualmente va considerato ai fini del voto, per via del sacrificio impostogli . – I creditori privilegiati integralmente soddisfatti non votano (non hanno interesse, in quanto non falcidiati). I loro crediti però contano ai fini del calcolo di maggioranza? Nel concordato preventivo solitamente no, si calcola sul totale dei crediti ammessi al voto. Nel concordato minore, per analogia, il computo esclude chi non aveva diritto di voto (anche se la norma non è dettagliatissima, la prassi segue il modello concordato preventivo). – Misure protettive: anche qui, su istanza del debitore, il giudice può impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dal decreto di apertura fino all’omologa . Questo “scudo” tutela il patrimonio durante le trattative. – Omologazione: se i creditori approvano a maggioranza la proposta e il piano è fattibile e lecito, il tribunale omologa con sentenza (manca l’udienza se non ci sono contestazioni). Se ci sono contestazioni di creditori rimasti dissenzienti, il giudice verifica comunque le condizioni di legge (tra cui la percentuale minima di soddisfazione eventualmente prevista dall’art. 79 CCII per il concordato minore – il CCII ha introdotto percentuali minime per il concordato preventivo, ma per il minore potrebbe applicarsi per analogia l’art. 79 se richiamato espressamente). – Importante: il Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti per rendere queste procedure più accessibili. Ad esempio ha confermato il diritto di reclamo in appello se la proposta viene dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado (prima era dibattuto). Ha anche sottolineato la necessità di valutare meglio la fattibilità economica e il comportamento del debitore. Inoltre, anche nella composizione minore vale il principio che, se omologata, la procedura produce l’effetto esdebitatorio senza bisogno di attendere una formale istanza di esdebitazione finale (a differenza del fallimento classico). – Mancata omologazione: se la proposta non raggiunge la maggioranza dei consensi, o il giudice nega l’omologa (ad es. perché il piano è manifestamente inattuabile o vìola norme – ad es. paga prima un chirografario di un privilegiato), cosa succede? Il tribunale, su istanza del debitore, apre in un secondo momento la liquidazione controllata . Quindi il debitore può ripiegare sulla liquidazione del patrimonio. Se invece sono emersi atti di frode, anche i creditori o il PM potrebbero far aprire la liquidazione . Da notare: se la mancata omologa è solo per ragioni formali o per dissenso dei creditori, il debitore può teoricamente proporre un nuovo concordato minore modificato. La Cassazione ha affermato (sia pure in riferimento alla L.3/2012) che il rigetto di un accordo non preclude una nuova proposta ristrutturatoria migliorativa, e che anzi il debitore non va “bloccato” al primo errore . – Esecuzione del concordato minore: una volta omologato, il debitore (o l’eventuale liquidatore nominato per cedere certi beni) deve attuare il piano sotto la vigilanza dell’OCC. Il concordato minore produce effetti anche verso eventuali soci illimitatamente responsabili (es. soci di SNC) salvo patto contrario . Se il debitore è una società, la delibera di accesso al concordato deve essere presa dagli amministratori e formalizzata da notaio, depositata al registro imprese .
Vantaggi e svantaggi: il concordato minore consente al debitore imprenditore di coinvolgere attivamente i creditori nella soluzione, ottenendo se possibile il loro consenso a un taglio dei debiti pur di evitare la liquidazione integrale. Rispetto al piano del consumatore, è meno “unilaterale” (serve il voto), ma permette di gestire crisi di natura imprenditoriale con eventualmente la continuazione dell’attività. Per un artigiano che voglia salvare la propria bottega e riprendersi, può essere ideale: ad esempio, propone ai creditori un piano a 5 anni, continua a lavorare e a pagare con gli utili. Se i creditori capiscono che ricaverebbero meno dalla chiusura e liquidazione (spesso vera per piccole aziende il cui valore maggiore è nell’avviamento e nelle capacità dell’artigiano stesso), saranno incentivati ad aderire. Da notare che dal 2022-2023 le regole si sono fatte più flessibili a favore di soluzioni concordate: ad esempio è stato introdotto il cram down fiscale anche nel concordato minore (per analogia con l’accordo di ristrutturazione), quindi il giudice può omologare il concordato minore anche senza voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate o INPS, purché li ritenga soddisfatti almeno quanto in liquidazione . Inoltre è stato eliminato qualsiasi requisito di meritevolezza per l’accesso al concordato minore (a differenza del piano consumatore): tuttavia restano anche qui le cause ostative generali (non aver già avuto esdebitazione recente, etc., e l’assenza di frode o colpa grave) per poter essere ammessi , codificate nell’art. 77 CCII. In pratica, se uno ha frodato i creditori, il tribunale potrebbe non ammettere il concordato; ma se semplicemente l’impresa è andata male per sfortuna o errori, il concordato minore è percorribile.
Liquidazione controllata del sovraindebitato
La liquidazione controllata (artt. 268 e segg. CCII) è l’equivalente del fallimento (ora liquidazione giudiziale) per i debitori non fallibili. È una procedura che mira a liquidare tutti i beni del debitore per distribuire il ricavato ai creditori secondo le regole di priorità dei crediti. Caratteristiche: – Può essere chiesta dal debitore stesso (volontaria) depositando un’istanza di apertura , oppure può essere avviata su richiesta dei creditori o del PM ma solo se il debitore ha commesso atti di frode o se vi è stata revoca di un concordato minore per inadempimento o frode . Normalmente, in mancanza di frode, i creditori non possono “far fallire” un non fallibile, proprio per definizione; quindi se l’artigiano semplicemente non paga ma non fa atti illeciti, i creditori individualmente lo perseguono senza poter forzare una liquidazione concorsuale. Però se l’artigiano deposita un piano e poi bara, allora i creditori potranno chiedere la conversione in liquidazione. – Nella liquidazione controllata volontaria, il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (salvo i beni impignorabili ex lege, come oggetti di stretta utilità, stipendi nei limiti impignorabili, ecc.) per soddisfare i creditori in modo proporzionale. Il tribunale nomina un liquidatore (figura simile al curatore fallimentare) che raccoglie l’attivo, lo vende (anche l’azienda intera se opportuno), verifica i crediti (stato passivo) e poi ripartisce. – Il procedimento ricalca la liquidazione giudiziale: si apre con un decreto (se volontaria) o sentenza (se coattiva), si formano gli elenchi di attivo e passivo , i creditori presentano domanda di insinuazione, il liquidatore compila lo stato passivo e si procede alle vendite seguendo un programma di liquidazione. La durata massima prevista per l’esecuzione del programma nel nuovo CCII è 3 anni (per la liquidazione controllata; 5 anni per quella giudiziale) , prorogabili solo eccezionalmente. Ciò per evitare procedure infinite. – Effetti per il debitore: la liquidazione comporta la perdita della disponibilità dei beni in capo al debitore, che però non subisce incapacità personali (diversamente dal fallimento vecchio regime, qui non c’è interdizione dall’attività, sebbene è improbabile possa proseguire l’attività se i beni dell’azienda sono liquidati). Il debitore persona fisica ha diritto a mantenere quanto serve per il sostentamento suo e della famiglia (ciascun mese, un importo pari a quello necessario al mantenimento secondo valutazione del giudice). – Esdebitazione conseguente: la finalità della liquidazione controllata, oltre a soddisfare i creditori, è liberare il debitore onesto dai debiti residui. La legge prevede che decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata, il tribunale debba pronunciarsi d’ufficio sull’esdebitazione (cioè sul perdono dei debiti non pagati) . Non serve un’istanza specifica del debitore, è quasi automatica, subordinata però a verifica dei presupposti. In pratica: se il debitore ha collaborato, non ha nascosto beni e non è incorso in cause ostative, alla chiusura della liquidazione ottiene l’esdebitazione integrale dei debiti rimasti insoddisfatti . Questa è un’importante novità del CCII, chiamata esdebitazione “di diritto”: diversamente dalla vecchia legge fallimentare in cui l’esdebitazione post-fallimento andava chiesta e poteva essere negata, ora è lo standard salvo eccezioni. Rimane un controllo giudiziale: l’art. 282 CCII chiarisce che il beneficio è concesso con decreto se ci sono i requisiti (essenzialmente meritevolezza, cooperazione, assenza di frodi) . Se il debitore ha frodato o nascosto attivo, non verrà esdebitato. – Se la liquidazione controllata è aperta a seguito di frodi o atti in malafede, la legge dice espressamente che quell’eventuale condotta non preclude l’accesso alla liquidazione ma preclude l’esdebitazione finale . In altre parole, anche il debitore poco meritevole verrà liquidato (a tutela dei creditori), però alla fine rimarrà comunque responsabile per l’eventuale debito non soddisfatto (non otterrà la cancellazione dei debiti residui) .
Per un artigiano sovraindebitato, la liquidazione controllata è l’ultima risorsa: significa chiudere la propria attività e liquidare tutto quanto per pagare i creditori. È una scelta dolorosa ma a volte necessaria quando non vi è modo di continuare e il debito è troppo alto. Vantaggio: dopo, il debitore persona fisica può ripartire pulito (salvo eccezioni), quindi è una “morte e resurrezione” economica. Inoltre, grazie alla “esdebitazione di diritto”, non c’è più l’alea di restare per sempre debitori: dopo la procedura i creditori non soddisfatti non potranno più pretendere nulla (tranne i debiti non esdebitabili per legge, es. obblighi di mantenimento, risarcimenti per danni da fatto illecito e sanzioni penali/amministrative non pecuniarie, che restano a carico).
Bisogna anche menzionare un fenomeno particolare: il creditore fondiario (banca), come visto, può avere un diritto di agire separatamente anche durante la liquidazione controllata . In tal caso, se ad esempio una banca ipotecaria vende direttamente l’immobile, poi passerà al liquidatore l’eventuale eccedenza. Questa peculiarità, retaggio del Testo Unico Bancario, fa sì che la liquidazione controllata non sia sempre un “ombrello” totale contro i pignoramenti (quel caso eccezionale a parte).
Esdebitazione del debitore incapiente
È un istituto innovativo introdotto prima dalla L. 3/2012 (come modificata dal 2020) e ora disciplinato nell’art. 283 CCII. Serve a dare la liberazione dai debiti anche a chi: – È persona fisica meritevole, – È sovraindebitato, – Non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno minima (nemmeno in prospettiva con un piano).
In pratica, il “debitore incapiente” è colui che non possiede beni liquidabili né ha redditi aggredibili oltre il minimo vitale, ma vorrebbe comunque uscire dalla situazione debitoria per ripartire. Per costui, aprire una procedura di liquidazione tradizionale sarebbe inutile (non c’è nulla da liquidare e le procedure hanno un costo). L’art. 283 prevede allora che il debitore possa chiedere direttamente l’esdebitazione a costo zero.
Condizioni principali per l’esdebitazione incapiente: – Il debitore deve essere persona fisica. – Meritevolezza: non deve aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode (requisito uguale agli altri strumenti) . – Assenza di attivo liquidabile: deve provare di non poter offrire alcuna utilità ai creditori, neanche in futuro, se non quelle strettamente necessarie al sostentamento proprio e della famiglia . L’art. 283 co.2 indica parametri per definire “nessuna utilità”, al netto delle spese essenziali di mantenimento. Quindi, ad esempio, una persona che guadagna appena per vivere al minimo, senza beni, rientra in questa categoria. – Adempimento di doveri di collaborazione: il debitore incapiente deve aver fornito tutta la documentazione e informazione sulla sua situazione senza reticenze. – Non deve aver già usufruito di un’esdebitazione negli ultimi 5 anni né presentare una domanda simile abusiva.
Procedura: si deposita una domanda al tribunale (di solito con l’ausilio dell’OCC) chiedendo il beneficio. L’OCC verifica la situazione debitoria e reddituale. Il tribunale fissa un’udienza, ascolta eventualmente creditori (che potrebbero contestare la meritevolezza o far presente elementi ignorati). Se ritiene i presupposti soddisfatti, emette decreto di esdebitazione del debitore incapiente. Da quel momento: – Tutti i debiti antecedenti sono cancellati e il debitore ne è liberato, senza aver pagato nulla. Per questo si parla di esdebitazione “a costo zero”. – Eccezione importanti: restano comunque dovuti (per legge) eventuali debiti per mantenimento e alimenti, risarcimenti da fatti illeciti e sanzioni penali e amministrative non pecuniarie (art. 282 CCII): questi non si estinguono nemmeno con il fallimento e quindi nemmeno con l’esdebitazione incapiente. – Obbligo quadriennale: se entro 4 anni dal decreto il debitore incapiente dovesse ottenere sopravvenienze attive rilevanti (eredità, vincite, forte aumento di reddito), tali che potrebbe soddisfare almeno il 10% dei vecchi debiti, allora scatta un obbligo di pagamento in favore dei vecchi creditori fino a concorrenza di quel 10% . In sostanza è previsto che l’esdebitato incapiente “restituisca” qualcosa ai creditori se la sua situazione migliora sensibilmente entro i 4 anni successivi. Per vigilare, l’OCC rimane attivo per quel quadriennio e il debitore deve presentare annualmente una dichiarazione su eventuali miglioramenti patrimoniali . Se viola questo obbligo o mente, commette reato e può vedersi revocare il beneficio. – Sanzioni penali: come visto, l’art. 344 CCII comma 2 estende al debitore incapiente le pene se produce documentazione falsa o omette di dichiarare miglioramenti nel periodo di sorveglianza .
L’esdebitazione incapiente è una misura eccezionale e residuale, ma di civiltà giuridica, perché riconosce che a volte è preferibile liberare una persona dai debiti impossibili per reinserirla nel tessuto produttivo , piuttosto che condannarla a una “schiavitù” debitoria perpetua che non giova nemmeno ai creditori (i quali tanto non potrebbero comunque incassare nulla). Essa non è una procedura concorsuale in senso stretto (non c’è concorso né liquidazione) , ma un beneficio concessorio. Va gestita con prudenza: il debitore deve valutare con i professionisti se rientra nei parametri, altrimenti rischia il rigetto.
Esempio pratico: Tizio, ex artigiano cappellaio, ha chiuso l’attività e non ha beni né lavoro; ha 100.000 € di debiti tra banche e Fisco. Vive con una pensione sociale. Tizio potrebbe chiedere l’esdebitazione incapiente, provando di non avere nulla se non quel minimo di pensione. Il tribunale, verificata l’assenza di comportamenti dolosi (Tizio non ha nascosto soldi sotto il mattone, ha proprio nulla), concede l’esdebitazione. Tizio non dovrà più quei 100.000 €. Se però tra due anni Tizio ereditasse un appartamento o vincesse alla lotteria, avrebbe l’obbligo di destinare ai vecchi creditori una somma pari almeno al 10% di quanto dovuto (diciamo 10.000 € su 100.000, se le risorse lo consentono).
Altre procedure concorsuali e di risanamento per le imprese in crisi
Oltre alle procedure di sovraindebitamento, il nostro ordinamento (soprattutto dopo il 2022) offre ulteriori strumenti che l’artigiano o piccolo imprenditore potrebbe valutare, specie se la sua attività è ancora teoricamente vitale e di dimensioni un po’ più grandi. Ne elenchiamo brevemente alcuni per completezza, sebbene il focus resti sul debitore artigiano non fallibile.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (per imprenditori soggetti a fallimento o sopra-soglia): previsti dagli artt. 57 e segg. CCII (ex art. 182-bis L.Fall.). Si tratta di un accordo privatistico ma omologato dal tribunale tra il debitore e una parte qualificata dei creditori. Richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti (percentuale ridotta in alcuni casi speciali: accordi agevolati al 30% per debiti finanziari con intermediari, secondo le ultime riforme). Una volta raggiunte le firme necessarie, il tribunale può omologare l’accordo rendendolo vincolante anche per i creditori estranei (che verranno pagati integralmente, fuori accordo, entro 120 giorni). Negli accordi è cruciale il trattamento del Fisco ed enti: come già detto, si può includere la transazione fiscale (dilazione o stralcio di imposte) e dal 2022 vige il cram down fiscale: se il Fisco non aderisce ma l’accordo è più vantaggioso della liquidazione, il tribunale può omologare comunque . Un artigiano potrebbe pensare a un accordo se ha pochi grandi creditori (es. banche) disposti a trattare. Per le micro imprese l’accordo formale è però meno usato che il concordato minore, perché tanto vale coinvolgere tutti i creditori con quello.
- Concordato preventivo (ordinario e “minore”): Il concordato preventivo è la procedura concorsuale classica per le imprese fallibili in crisi (artt. 84-120 CCII). Prevede tipicamente un quorum del 66% dei crediti per l’approvazione, soglie minime di pagamento dei chirografari (almeno 20% in caso di liquidatorio ordinario, ridotte a 10% se concordato minore liquidatorio) , ecc. Nel 2022-2023 il concordato preventivo è stato semplificato e integrato con vari sottotipi, come:
- Concordato in continuità aziendale (il debitore prosegue l’impresa, mantenendo o cedendo l’azienda come going concern).
- Concordato liquidatorio (vendita di beni, con l’obbligo di una soglia minima 20% ai chirografari) – ora possibile anche in versione concordato semplificato post composizione negoziata, senza voto, per accelerare in certi casi.
- Concordato minore di cui già detto, destinato ai non fallibili. Queste procedure per un artigiano rilevano se egli oltrepassa le soglie di non fallibilità: ad es. un’azienda artigiana che in realtà è abbastanza grande da fallire, per salvarsi può proporre un concordato preventivo tradizionale. Non ci dilunghiamo in quanto esulano dal target “non fallibile”.
- Composizione negoziata della crisi: introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021) e oggi parte del CCII (art. 12 e segg.), è uno strumento volontario e stragiudiziale assistito. Un imprenditore (anche piccolo, non c’è limite minimo né esclusione per settori) che si trova in situazione di crisi o insolvenza anche conclamata può accedere a una piattaforma online e chiedere la nomina di un esperto indipendente. Questo esperto guiderà per un periodo (fino 6 mesi + proroga) le trattative tra l’imprenditore e i creditori per raggiungere un accordo di ristrutturazione o altra soluzione. Durante la composizione negoziata l’imprenditore può ottenere misure protettive dal tribunale per bloccare le azioni esecutive . Il Correttivo ter 2024 ha ampliato la portata: oggi possono accedere anche imprenditori già insolventi e non solo in crisi incipiente ; è stata introdotta la possibilità di una transazione fiscale nella composizione negoziata ; sono state allentate le condizioni per prorogare le trattative (non serve più il consenso di tutti i creditori, basta l’accordo di quelli in trattativa o anche solo richiesta dell’imprenditore con esperto) . La composizione negoziata è uno strumento non giudiziale: alla fine può sfociare in vari esiti, ad esempio un contratto di ristrutturazione firmato con alcuni creditori, una convenzione moratoria, un accordo ad hoc con le banche, oppure nessun accordo (in tal caso l’imprenditore può ripiegare su concordato semplificato). È utile se l’artigiano vede la crisi arrivare e vuole muoversi prima di essere insolvente conclamato, cercando di rinegoziare i debiti con l’aiuto di un esperto terzo. Nel contesto del cappellaio indebitato, la composizione negoziata potrebbe essere usata se la situazione non è disperata: ad esempio, ha ordini e prospettive, ma troppi debiti pregressi – con l’aiuto dell’esperto prova a convincere banche e creditori a dilazionare o ridurre il debito evitando di entrare in procedure più stigmatizzanti.
- Piani attestati di risanamento: (art. 56 CCII, ex art. 67 L.Fall.) – non sono procedure concorsuali, ma piani di risanamento predisposti dall’imprenditore e accompagnati da una relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati e l’attuabilità del piano. Depositarli al registro imprese dà efficacia esimente: gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti a revocatoria fallimentare. Tuttavia, a differenza degli accordi o concordati, il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti: vale solo con chi l’ha accettato. È quindi un puro accordo contrattuale plurilaterale con in più un’attestazione formale. Poteva essere uno strumento utile in epoca di lockdown per rinegoziare esposizioni bancarie con tranquillità, ma per micro imprese raramente è utilizzato (costi dell’attestazione, bassa utilità se i creditori sono tanti e non tutti aderenti).
- Esdebitazione post-fallimentare per gli imprenditori commerciali maggiori: ricordiamo che già dal 2006 un fallito persona fisica (imprenditore individuale) può chiedere al termine del fallimento di essere esdebitato dai debiti residui (art. 278 CCII, ex art. 142 L.Fall.). Questo oggi è equiparabile all’esdebitazione di diritto di cui sopra, ma con differenze: l’esdebitazione ordinaria dopo liquidazione giudiziale può essere negata se il debitore non ha soddisfatto almeno parzialmente i chirografari (prima si chiedeva il 25%, ora la norma è più flessibile, ma l’assenza totale di pagamento ai chirografari può costare il diniego, salvo incapienza non imputabile). L’artigiano tuttavia ricade di norma nelle procedure minori, quindi questa esdebitazione classica non lo riguarda direttamente.
Riassumendo, il ventaglio di soluzioni legali va: – dal tentativo informale (piani di rientro, accordi bonari), – alle procedure negoziate (composizione assistita senza giudice), – agli accordi giudiziali su base contrattuale (accordi di ristrutturazione), – ai concordati (soluzioni giudiziali con voto), – per arrivare alla liquidazione concorsuale e all’esdebitazione finale.
Nella sezione successiva ci concentriamo su come il debitore artigiano può difendersi concretamente dalle azioni esecutive dei creditori nel frattempo e come comportarsi durante questo percorso.
Come difendersi dalle azioni dei creditori (profili pratici)
Abbiamo visto i rimedi di fondo per ristrutturare o liquidare i debiti. Ma nel concreto quotidiano, come può un artigiano indebitato difendersi dalle pressioni e azioni immediate dei creditori? Questa sezione offre consigli pratici e illustra diritti e limiti che possono aiutare a guadagnare tempo, proteggere beni essenziali e arrivare alla soluzione di sovraindebitamento con il minor danno possibile.
1. Monitorare lo stato delle posizioni debitorie e delle eventuali procedure
Conoscere per agire: il debitore deve anzitutto tenere traccia di tutte le comunicazioni e atti ricevuti: – Raccogliere le cartelle esattoriali, atti di precetto, decreti ingiuntivi eventualmente notificati. Spesso il sovraindebitato è tentato di “ignorare” la posta spiacevole, ma è un errore: bisogna sapere se un creditore ha già titolo esecutivo e può procedere a pignoramenti. – Verificare termini di opposizione: es. se si riceve un decreto ingiuntivo non dichiarato provvisoriamente esecutivo, si hanno 40 giorni per fare opposizione. Se il decreto non viene opposto, diventa definitivo ed esecutivo. Opporsi, se ci sono motivi di contestazione anche parziali, può allungare i tempi e forzare il creditore a discutere la causa. In alcuni casi, l’opposizione può portare a una soluzione transattiva in corso di causa. – Atti di pignoramento: se arriva un atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi), il debitore ha opportunità di reagire: – Può cercare di conciliare con il creditore anche in quella fase (magari ottenendo la sospensione dell’asta se si trova un accordo). – Può verificare con l’avvocato vizi del pignoramento (notifica errata, mancanza di presupposti): es. un pignoramento immobiliare di AER senza che vi fosse la condizione dei €120.000 di debito o senza attendere 30 giorni dal preavviso d’ipoteca sarebbe impugnabile come illegittimo . – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se il debitore contesta il diritto stesso del creditore di procedere (es. perché ha pagato o la somma non è dovuta), può proporla per far sospendere o cessare l’esecuzione. – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): va fatta entro 20 giorni se ci sono irregolarità formali negli atti della procedura. – Istanza di conversione del pignoramento: nel pignoramento mobiliare o presso terzi, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al debito più spese, pagando ratealmente in max 48 mesi (art. 495 c.p.c.). Questa è una chance di “riottenere” i beni pignorati (o evitare la vendita immobiliare) se si ha la capacità di pagare a rate l’intero dovuto. Spesso però il sovraindebitato non riesce a coprire l’intero importo, se potesse non sarebbe in quella situazione. Tuttavia, con aiuto magari di familiari, a volte si evita la vendita forzata (specie di immobili a basso valore che in asta andrebbero svenduti) tramite questa conversione.
2. Proteggere i beni essenziali (casa, strumenti di lavoro, redditi minimi)
Abitazione principale: abbiamo già dettagliato il forte scudo per la prima casa verso i debiti fiscali . Ma per altri creditori privati non c’è divieto: la casa può essere pignorata da una banca o un fornitore. Cosa può fare il debitore? – Fondo patrimoniale o trust: se l’artigiano in tempi non sospetti (molto prima dei debiti) avesse vincolato l’immobile in un fondo patrimoniale, potrebbe opporsi al pignoramento qualora il debito non sia per necessità familiari. Tuttavia, se i debiti sono d’impresa, la giurisprudenza spesso li considera comunque “necessari” se l’attività serve a mantenere la famiglia. Inoltre, costituire un fondo patrimoniale o trust quando i debiti sono già prevedibili può esporre ad azione revocatoria e talvolta anche a imputazioni di sottrazione fraudolenta. Quindi è un campo minato: da valutare con molta prudenza e solo se fatto in periodi di tranquillità economica. – Opposizione per sproporzione o possibilità di vendita privata: nel pignoramento immobiliare normale, il debitore può chiedere la sospensione se dimostra che il valore dell’immobile è nettamente superiore al debito e offre immediatamente di pagare (non molto comune). Con il Correttivo ter ci sono state novità nel caso di vendita a terzi: ad esempio, un creditore ipotecario in liquidazione giudiziale può contestare se il prezzo concordato è troppo basso , ma nel caso di esecuzioni individuali la legge non consente al debitore di bloccare l’asta lamentando prezzo vile, se non seguendo la procedura delle aste con ribassi progressivi. – Aspettare il sovraindebitamento: se il debitore presenta un ricorso per concordato minore e ottiene le misure protettive, il pignoramento immobiliare (pure se avviato da banca o fornitore) viene sospeso prima della vendita . In alcuni tribunali, i giudici esecutivi sospendono su istanza del debitore se è pendente una procedura di sovraindebitamento con misure protettive ordinate dal giudice concorsuale (è un ordine di legge, l’atto di pignoramento durante la protezione sarebbe nullo). – Vendita volontaria pre-asta: un suggerimento pratico se la casa è pignorata, può essere tentare di vendere privatamente l’immobile prima che vada all’asta (si può chiedere al GE autorizzazione a vendere privatamente, che spesso è concessa se c’è un compratore a prezzo congruo). Così si ricava di più e si chiudono più debiti, riducendo il residuo. Questo però richiede un compratore in tempi brevi.
Strumenti ed utensili di lavoro: il codice di procedura civile (art. 515) dichiara impignorabili gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, del mestiere o dell’arte del debitore, a meno che il pignoramento sia eseguito per il credito dello stesso tipo (es. debito per pagare quei beni). Dunque, se l’artigiano cappellaio ha macchinari essenziali (macchina da cucire industriale, forme, telai), in teoria l’ufficiale giudiziario non dovrebbe pignorarli poiché servono per il suo sostentamento professionale. Questa tutela però è relativa: se i macchinari hanno un valore rilevante e ci sono altri beni per vivere, alcuni giudici ammettono il pignoramento comunque, considerando impignorabili solo gli attrezzi di modesto valore e indispensabili. Inoltre non vale verso il Fisco: AER può pignorare anche strumenti di lavoro, ma con un limite massimo di 1/5 per valore (deve lasciare i restanti 4/5, art. 62 DPR 602/73). Difesa: se un ufficiale giudiziario volesse pignorare, il debitore può opporre l’impignorabilità spiegando che quell’oggetto gli serve per lavorare. In caso di contestazione, deciderà il giudice.
Conto corrente e stipendi/pensioni: come visto: – L’ultimo stipendio accreditato su conto non si tocca . – Se l’artigiano ha conto in rosso, spesso la banca trattiene eventuali accrediti (diritto di compensazione). Aprire un conto basico presso altra banca dove accreditare entrate future può aiutare a sfuggire a compensazioni, pur sapendo che quel nuovo conto è comunque aggredibile se scoperto. Ma se è uno conto intitolato a un familiare fidato e le entrate vanno lì, il creditore potrebbe non trovarlo (pratica non ortodossa e con rischi se confonde patrimoni, ma spesso utilizzata di fatto). – Dopo eventuale pignoramento presso terzi, al debitore conviene negoziare col creditore: ad esempio, in caso di pignoramento stipendio, si può proporre al creditore una soluzione congiunta (es. “ti pago un 50% subito e togli il pignoramento”). Se il creditore accetta, si può fare istanza congiunta al giudice per cessazione della materia del contendere e liberare la quota stipendiale. Molti creditori accettano stralci quando vedono che il recupero tramite pignoramento sarebbe lungo e parziale. – Ricordare che ci sono minimi vitali impignorabili: per le pensioni, circa €754 mensili (assegno sociale + metà) non si toccano; per i conti, se il conto ha depositi inferiori a 1.344€, AER può pignorare solo la parte eccedente 1.344€ (tre volte l’assegno sociale) se su quel conto affluisce stipendio/pensione. Queste soglie si aggiornano, ma il debitore deve sapere di poter reclamare almeno quel minimo.
Società di persone e soci: se l’attività cappellaia è svolta in società di persone (SNC, SAS), i soci illimitatamente responsabili rispondono solidalmente. Un creditore può aggredire direttamente il socio con un decreto ingiuntivo, senza nemmeno escutere prima la società (nelle SNC la responsabilità è solidale e paritetica). Tuttavia per l’esecuzione, la legge prevede prima di escutere la società (art. 2304 c.c.), ma in pratica ciò non offre grande scudo se la società non paga. Il socio può difendersi come persona fisica con i medesimi strumenti (sovraindebitamento, se la società non è fallibile; opposizioni ecc.). Nelle procedure di concordato minore presentata dalla società, gli effetti dell’omologazione si estendono ai soci illimitatamente responsabili salvo patto contrario . Ciò è molto importante: significa che se una SNC artigiana ottiene un concordato minore omologato, anche i soci persone fisiche beneficiano della liberazione dai debiti sociali secondo la proposta (a meno che abbiano deciso diversamente). È una differenza dal fallimento, dove i creditori dei soci rimangono separati: qui il concordato minore risolve in solido la posizione, facilitando la chiusura completa della crisi.
3. Evitare comportamenti che aggravino la posizione (dovere di lealtà)
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” non significa solo resistere alle azioni, ma anche non peggiorare la propria situazione giuridica. Alcuni comportamenti sbagliati possono compromettere l’accesso alle soluzioni o addirittura costituire reato: – Non fare atti in frode: vendere o regalare beni per sottrarli ai creditori (es. intestare a parenti la casa, svuotare conti, cedere magazzino in nero) è altamente sconsigliato. Oltre al rischio di azione revocatoria (entro 2 anni per atti a titolo gratuito e atti anomali) che annulla tali atti, nel contesto del sovraindebitamento costituirebbe quella “malafede o frode” che impedisce l’omologa del piano e l’esdebitazione . Inoltre il CCII lo sanziona penalmente . È preferibile conservare il patrimonio e usarlo trasparentemente nelle procedure concorsuali, magari ottenendo la cancellazione di una parte consistente di debiti, piuttosto che occultarlo maldestramente e perdere i benefici legali. – Non creare nuovo indebitamento ingiustificato: durante le trattative o procedure, il debitore non deve aggravare la sua esposizione. Ad esempio, contrarre un nuovo prestito sapendo di non poterlo restituire per pagare un vecchio creditore (il classico “pagare un debito con altro debito”) di solito peggiora le cose. Inoltre, in procedura concordataria, aggravare la posizione debitoria intenzionalmente dopo il deposito del piano è condotta sanzionata . – Pagare fuori piano: se è in corso una procedura di composizione (piano del consumatore o concordato), il debitore non può fare preferenze pagando sottobanco qualche creditore a discapito degli altri, pena la revoca o sanzioni (art. 344 punisce i pagamenti non autorizzati in violazione del piano omologato). – Comunicare con i creditori con buona fede: a volte ignorare completamente i creditori porta questi a esasperarsi e agire duramente. È meglio, ove possibile, tenere un canale aperto: spiegare la situazione, manifestare la volontà di trovare soluzioni. Questo non vuol dire ammettere ogni pretesa (sempre meglio con l’avvocato non fare ammissioni scritte che interrompano prescrizioni se non necessario), ma almeno mostrare che non c’è volontà elusiva. Alcuni creditori possono accettare attese se vedono il debitore attivo nel risanamento (ad esempio, se sanno che sta predisponendo un piano di concordato, potrebbero attendere l’esito anziché proseguire aggressivamente). – Raccogliere la documentazione completa: per preparare una procedura di sovraindebitamento, occorre tutta la contabilità, gli estratti conto, le notifiche di cartelle, gli atti di causa, ecc. Fornire all’OCC documenti incompleti o falsi è deleterio: l’OCC deve poter attestare la completezza. La Cassazione nel 2023 ha tutelato un debitore il cui piano del consumatore era stato omologato ma poi rischiava di saltare perché mancavano indicazioni su formalità ipotecarie: ha statuito che se il piano è omologato, la responsabilità di eventuali incompletezze documentali non può ricadere sul consumatore, in quanto l’OCC e il giudice dovevano verificarle prima dell’omologa . Ciò significa che il debitore, una volta che fa tutto in buona fede e ottiene l’omologa, è protetto da ulteriori contestazioni documentali: eventuali errori non faranno annullare il piano a suo danno . Ma per arrivare all’omologa senza intoppi conviene dall’inizio essere precisi e trasparenti.
4. Pianificare con consulenti esperti un percorso sostenibile
Affrontare la giungla di debiti e procedure senza assistenza è rischioso. Il debitore artigiano dovrebbe coinvolgere: – Un avvocato esperto in crisi d’impresa e sovraindebitamento: per valutare le opzioni legali, predisporre eventuali opposizioni alle azioni giudiziarie dei creditori, interfacciarsi con il tribunale per le procedure concorsuali. – Un commercialista o consulente finanziario: per esaminare la situazione economica, predisporre eventuali piani, calcolare convenienze per creditori (necessario ad es. per redigere un buon piano che superi il test di convenienza). Anche per predisporre bilanci o documenti contabili richiesti dal tribunale. – Organismo di composizione della crisi (OCC): è un ente o professionista nominato dal tribunale in sede di procedura di sovraindebitamento. Il debitore può contattare un OCC territoriale anche prima di depositare il ricorso, per ottenere consulenza preliminare sul da farsi. Alcuni OCC offrono sportelli di orientamento al debitore sovraindebitato, aiutando a capire se ci sono i presupposti e quale procedura scegliere. – Associazioni di categoria o di consumatori: talvolta hanno convenzioni con professionisti per aiutare piccoli imprenditori in difficoltà. Ad esempio, esistono organizzazioni specializzate in composizione delle crisi da sovraindebitamento che affiancano il debitore nell’iter.
Costi: molti debitori esitano a cercare aiuto per timore dei costi professionali. Va chiarito che: – Nelle procedure di sovraindebitamento, il compenso dell’OCC e le spese concorsuali sono prededucibili nel piano (cioè vanno considerati e verranno pagati prima degli altri crediti con le risorse del piano stesso) . Se il debitore è totalmente incapiente, spesso gli OCC convenzionati con tribunale applicano tariffe minime o dilazionano, a volte rinunciano se non c’è recupero (sanno che c’è una finalità sociale). – Alcuni enti locali hanno convenzioni per cui parte dei costi dell’OCC sono coperti da fondi pubblici, specie nei casi di indebitamento “sociale” grave. – Gratuito patrocinio: se il debitore ha redditi sotto le soglie di legge (circa €11.700 annui, valore da verificare), può accedere al patrocinio a spese dello Stato per le cause di opposizione esecutiva o altre cause civili e anche per la procedura di sovraindebitamento (quest’ultima interpretazione è stata incerta ma taluni tribunali ammettono il patrocinio per la procedura concorsuale in quanto volontaria giurisdizionale). – In ogni caso, i benefici ottenibili (riduzione di centinaia di migliaia di euro di debiti) di solito superano di gran lunga i costi professionali, quindi è un investimento necessario per salvarsi finanziariamente.
5. Valutare soluzioni ibride e timing
Scelta del momento giusto: ogni situazione è unica. A volte può convenire avviare subito la procedura concorsuale (per bloccare i creditori), altre volte attendere qualche definizione agevolata (es. aspettare l’uscita di una rottamazione cartelle per ridurre il debito fiscale e poi fare il piano per il resto). Ad esempio, nel 2023 chi aveva molte cartelle ha magari aspettato di aderire alla rottamazione-quater, riducendo il monte debiti, e poi a fine 2023 ha presentato un piano per gli altri debiti. Soluzioni combinate: nulla vieta al debitore di usare più strumenti combinati: – Saldo e stralcio su alcuni debiti + piano per altri: es. l’artigiano riesce a ottenere uno sconto e paga integralmente (a prezzo ridotto) i fornitori chiave con aiuto di un parente, mentre per i restanti debiti meno critici va a concordato minore. Così elimina possibili oppositori forti e rende più fluida l’approvazione del piano. – Consolidamento debiti privato: se ancora ha un minimo di merito creditizio, potrebbe ottenere un prestito (magari garantito dal Fondo PMI se eleggibile) per pagare i debiti più pressanti, poi rimborsare un unico finanziatore in più anni. Questo però è raro per chi è già molto indebitato: le banche concedono consolidamento solo a soggetti ancora solvibili. – Famiglia e rete di sostegno: coinvolgere familiari o soci amici nella soluzione: contributi di terzi nel piano (un parente che si offre di versare X euro per migliorare l’offerta ai creditori) possono fare la differenza sulla fattibilità del piano stesso (es. se un parente offre ipoteca sulla sua casa per un mutuo da cui ricavare liquidità, come in un caso di piano del consumatore a Viterbo ).
Concludendo questa sezione, “difendersi” dalle azioni dei creditori significa utilizzare attivamente i propri diritti processuali (opposizioni, richieste di sospensione, ecc.), sfruttare le protezioni legali (impignorabilità di certi beni, misure protettive nelle procedure), e tenere una condotta proattiva e trasparente per poter accedere con successo agli strumenti di composizione della crisi. L’atteggiamento migliore per un debitore onesto è mostrarsi collaborativo nella cornice della legge, senza farsi paralizzare dalla paura o dalla vergogna: la situazione di sovraindebitamento è riconosciuta come un problema sociale di grande rilevanza e l’ordinamento offre vie d’uscita proprio per evitare l’esclusione economica permanente .
Novità normative e giurisprudenziali recenti (aggiornate a settembre 2025)
Negli ultimi anni (2020-2025) la materia della crisi d’impresa e del sovraindebitamento è stata rivoluzionata e affinata. È importante segnalare alcune novità normative e pronunce giurisprudenziali che costituiscono gli ultimi sviluppi applicativi, al fine di utilizzare le soluzioni più attuali nel caso del nostro artigiano indebitato.
Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
Entrato in vigore definitivamente a metà 2022 (dopo varie proroghe), il D.Lgs. 14/2019 ha unificato la disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. Esso ha abrogato la vecchia legge fallimentare del 1942 e anche la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, assorbendone le procedure con alcune modifiche terminologiche e sostanziali: – Fallimento ora si chiama liquidazione giudiziale. – Le procedure di sovraindebitamento hanno cambiato nome (come visto: piano del consumatore → ristrutturazione debiti consumatore; accordo composizione → concordato minore; liquidazione patrimonio → liquidazione controllata). – Sono stati introdotti principî generali comuni (es. obbligo di leale collaborazione del debitore, definizioni unificate di insolvenza, crisi, ecc. ). – Viene incentivata l’emersione anticipata della crisi: obblighi di segnalazione e istituti come la composizione negoziata per affrontare la crisi prima che diventi insolvenza conclamata. – Per i sovraindebitati in particolare, il CCII ha: – Reso automatico l’effetto esdebitatorio al termine delle procedure concordatarie minori (non occorre più una domanda separata di esdebitazione se il piano è completato) . – Introdotto la esdebitazione di diritto dopo liquidazione controllata (3 anni). – Sancito la possibilità di esdebitazione dell’incapiente come procedura autonoma (prima era una clausola nella L.3/2012 modificata nel 2020). – Eliminato il concetto di “meritevolezza discrezionale” nel piano del consumatore, sostituendolo con criteri più oggettivi (assenza di dolo, colpa grave, frode) . – Previsione della moratoria mutuo prima casa e della inclusione cessione del quinto nel piano del consumatore, innovazioni a favore del debitore . – Creato la figura unificata dell’OCC iscritto in apposito registro nazionale, con requisiti di professionalità.
Decreti correttivi del CCII
Dal 2019 ad oggi, il Codice della Crisi è stato oggetto di ben tre decreti correttivi: – D.Lgs. 147/2020 (Correttivo “bis”): intervenuto su varie parti, ma la sua entrata in vigore è slittata insieme al Codice. Ha integrato la normativa con le prime modifiche richieste e alcune anticipazioni della direttiva UE 2019/1023. – D.Lgs. 83/2022: ha adeguato il Codice definitivamente alla direttiva UE 2019/1023 (sulle ristrutturazioni e insolvenza) prima della sua entrata in vigore. Per i sovraindebitati, ad esempio, questo decreto ha introdotto il cram down fiscale nei concordati preventivi e accordi, e affinato la procedura di composizione negoziata. – D.Lgs. 136/2024 (Correttivo “ter”): pubblicato a settembre 2024, è quello più recente e di ampia portata. Ha apportato decine di modifiche sia di dettaglio sia sostanziali, mirate a: – Chiarire dubbi interpretativi emersi nella prassi 2022-2024 . – Recepire orientamenti giurisprudenziali che nel frattempo si stavano formando (es: ha esplicitato che contro il provvedimento di inammissibilità di un piano del consumatore o accordo è ammesso reclamo in appello, in linea con Cass. 30529/2024 ). – Snellire e rendere più efficaci le procedure: ad esempio, ha reso più facile per l’imprenditore insolvente accedere alla composizione negoziata ; ha introdotto la transazione fiscale in quella sede ; ha perfezionato il cram down fiscale negli accordi . – Percentuali minime nel cram down fiscale: ora negli accordi di ristrutturazione, se il Fisco non aderisce, il tribunale può omologare solo se il trattamento proposto al Fisco non è inferiore alla percentuale minima fissata per legge (la normativa secondaria fissa soglie di solito intorno al 30% salvo eccezioni). Il Correttivo ter ha infatti dettagliato le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti pubblici per consentire il cram down . – Migliorie nel concordato preventivo: ha rivisto requisiti di ammissibilità, introdotto classamento dei privilegi degradati, ecc. (riguarda meno il nostro focus). – Procedure minori: dal sommario del Massimario Cassazione (Relazione n.10/2025) risulta che il correttivo-ter ha semplificato l’accesso agli strumenti di composizione per soggetti non fallibili e potenziato l’esdebitazione, come già accennato . Ciò si traduce in una maggiore certezza del beneficio di liberazione e in un incoraggiamento ad usarle.
In definitiva, l’impianto normativo a settembre 2025 vede un CCII consolidato e raffinato: per il debitore artigiano questo significa poter contare su procedure più efficaci e veloci e su giudici ormai più rodati nella loro applicazione.
Giurisprudenza recente in tema di sovraindebitamento
Molte pronunce della Corte di Cassazione negli anni 2022-2024 hanno risolto questioni interpretative, spesso a favore di una lettura pro-debitore (compatibilmente con i diritti dei creditori). Eccone alcune di rilievo: – Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2023 n.4613: ha affrontato il tema dell’alternativa liquidatoria nell’accordo di composizione (vecchio regime) . Ha stabilito che, nel valutare se un accordo è ammissibile rispetto al creditore ipotecario, bisogna considerare anche i beni che il creditore avrebbe potuto aggredire con azioni revocatorie. Nel caso, un immobile donato prima: il tribunale aveva rigettato l’accordo considerandolo atto in frode e perché l’offerta al creditore ipotecario non teneva conto dell’immobile donato che avrebbe potuto recuperare . La Cassazione ha condiviso questo approccio: se il debitore ha alienato beni prima, nella comparazione liquidatoria si considerano come se fossero disponibili tramite revocatoria . Questo precede il CCII ma rimane pertinente: in pratica, l’argomento “non ho nulla da dare perché l’ho regalato a mio figlio” non regge, perché quel bene verrebbe revocato in liquidazione. – Cass. Sez. I, 27 luglio 2023 n.22890: già citata sul concetto di meritevolezza. Importante perché: – Ha sancito che il nuovo criterio del CCII si applica ai procedimenti in corso non ancora omologati (norma intertemporale). – Ha distinto il vecchio “meritevole” (valutazione ampia, comportamentale) dal nuovo “assenza di frode o colpa grave” (valutazione più oggettiva e ristretta) . – Ha censurato i giudici di merito che continuavano ad applicare il vecchio standard oltre l’entrata in vigore del CCII . Questo orientamento tutela il debitore: ad esempio, se un artigiano consumatore aveva fatto qualche scelta economica avventata ma non dolosa, non potrà più essere giudicato “non meritevole” salvo rientri in colpa grave specifica. – Cass. Sez. I, 27 luglio 2023 n.22900: caso interessante in cui dopo l’omologa di un piano del consumatore, c’era un’incompletezza nel decreto di omologa (non indicava i dati per cancellare ipoteche su un immobile da mantenere). La debitrice aveva chiesto correzione, il giudice gliel’ha negata imputando a lei il difetto (mancava la certificazione ipotecaria). La Cassazione ha annullato quelle decisioni, affermando un principio: una volta omologato il piano, il controllo documentale competeva all’OCC e al giudice, quindi l’incompletezza non può esser fatta ricadere sul consumatore né portare all’annullamento del piano . Inoltre, la sentenza ha ribadito che i provvedimenti decisori in sede di reclamo (come la decisione su omologa) sono ricorribili per Cassazione, confermando l’orientamento sulla natura decisoria degli esiti delle procedure di sovraindebitamento . Implicazione pratica: il debitore non verrà punito per eventuali leggerezze formali post-omologa; se il piano è stato omologato, la protezione rimane (a meno di inadempimento sostanziale o dolo). – Cass. Sez. I, 27 novembre 2024 n.30538: ha sottolineato l’importanza di valutare il comportamento pregresso del debitore anche nelle procedure di accordo (dove formalmente la meritevolezza non era richiesta). Sostiene che anche senza una clausola di meritevolezza nell’accordo, è legittimo per il giudice considerare come il debitore sia giunto a sovraindebitamento per giudicarne l’affidabilità . Inoltre ha chiarito chi vota per i crediti fiscali (Agenzia delle Entrate, non l’Agente della Riscossione) . Ciò indica una tendenza a non far passare accordi in cui il debitore ha colpe gravi: quindi, pur senza voto, il debitore “furbo” rischia il rigetto. – Cass. Sez. I, 27 novembre 2024 n.30529: ha confermato che non è impugnabile in Cassazione il provvedimento che dichiara inammissibile una proposta (perché non decide su diritti, il debitore può ripresentarla modificata) , mentre lo è quello che nega o concede l’omologa (decisorio) . Questa pronuncia e la precedente sono state recepite nel Correttivo ter che consente reclamo sull’inammissibilità proprio per dare un grado di controllo . – Cass. Sez. I, 20 febbraio 2024 n.4622: già menzionata sul tema dilazione > 1 anno ai creditori privilegiati nel piano del consumatore . Ha reso più flessibile l’interpretazione: se la dilazione maggiore comporta maggior vantaggio per i creditori, è ammessa. Quindi, ad esempio, un piano che paga un’ipoteca in 7 anni anziché liquidare subito l’immobile può essere omologato se la banca ottiene più soldi (anche se più tardi) di quanti ne otterrebbe dall’asta immediata . Questo è a favore del debitore che vuole mantenere la casa e tratta con la banca un pagamento lungo. – Cass. Sez. I, 19 ottobre 2024 n.22914: ha invertito un precedente orientamento e deciso (come visto) che il privilegio fondiario consente al creditore fondiario di proseguire l’esecuzione nonostante la liquidazione del sovraindebitato . Questa è sfavorevole al debitore, ma è la legge bancaria. Possibile in futuro un intervento normativo per allineare questa disparità (se ne discute, perché confligge un po’ col principio della par condicio nelle procedure minori). – Cass. Sez. I, 23 settembre 2022 n.28013: (già citata del 2022) ha sancito che un piano con soddisfacimento dei chirografari quasi nullo può essere respinto per difetto di causa (i creditori devono ricevere una utilità apprezzabile) . Lasciano ai giudici di merito la valutazione caso per caso, ma il messaggio è: evitare piani meramente “abusivi” in cui il debitore chiede l’esdebitazione dando ai creditori somme simboliche. Questo per equità del sistema (seconda chance sì, ma non uno scherno per i creditori).
In sostanza, la giurisprudenza recente: – Ha chiarito procedure e rimedi (ricorsi, reclami, competenze di voto). – Ha teso ad armonizzare il vecchio e nuovo regime in senso favorevole alla finalità del nuovo (es. applicazione immediata dei criteri CCII). – Ha anche messo paletti di serietà (no a piani fittizi con 1% ai creditori, no a comportamenti opachi, sì a considerare la condotta rilevante). – Ha difeso il debitor good-faith (vedi caso incompletezza doc: colpa dell’OCC, non punir debitore).
Implicazioni per l’artigiano cappellaio indebitato
Alla luce delle novità: – Il nostro debitore può affrontare la crisi con più fiducia che in passato: le norme attuali e la giurisprudenza formano un ambiente più favorevole alla soluzione della crisi piuttosto che alla punizione del fallito. – Gli conviene aggiornarsi e sfruttare le ultime misure: ad esempio, se in passato un suo primo piano è stato dichiarato inammissibile, ora può appellare (grazie al correttivo) o riproporlo corretto (grazie alla Cassazione che lo consente) . – Il debitore deve essere consapevole dei propri diritti (esdebitazione quasi garantita se si comporta bene) ma anche dei doveri (non potrà farla franca se compie atti subdoli: le pene e i rigetti lo colpirebbero). – Infine, l’artigiano noterà come il sistema attuale realizza meglio quell’istanza sociale di “fresh start”: l’insolvency non è più visto come stigma morale, bensì come situazione da regolare nell’interesse di tutti, evitando che la persona indebitata sia economicamente morta per sempre .
Con tutte queste conoscenze, passiamo a rispondere in modo mirato ad alcune domande frequenti che un artigiano indebitato potrebbe porsi.
Domande frequenti (FAQ)
D1: Chi può accedere al “piano del consumatore” (ristrutturazione dei debiti del consumatore)?
R: Può accedere solo la persona fisica che non ha debiti derivanti da attività d’impresa o professionale, ossia il consumatore puro . Se hai un’attività artigiana ancora in corso, i debiti di quell’attività non possono essere trattati con il piano del consumatore. Tuttavia, se hai sia debiti da attività che personali, e hai chiuso l’attività o comunque ora agisci come privato, potrebbe esserci margine per qualificarti consumatore riguardo ai debiti non legati all’impresa . In linea di massima, un artigiano in attività userà il concordato minore, non il piano consumatore, a meno che la mole di debiti sia tutta extra-aziendale.
D2: Quali sono le principali differenze tra il piano del consumatore e il concordato minore?
R: Riassumiamo le differenze chiave:
– Soggetti: piano consumatore solo persona fisica non imprenditore ; concordato minore per imprenditori minori, professionisti, ecc., non consumatori .
– Voto dei creditori: nel piano consumatore non c’è voto – decide solo il giudice ; nel concordato minore i creditori votano e serve la maggioranza >50% .
– Meritevolezza: il piano consumatore richiede assenza di frode o colpa grave (viene valutata dal giudice) ; nel concordato minore formalmente non c’è requisito di meritevolezza, anche se condotte fraudolente possono portare al diniego o ad altre conseguenze .
– Tipologia di debiti: piano consumatore tipicamente per debiti personali (es. bollette, affitti, prestiti personali, magari anche qualche debito fiscale se non legato ad attività); concordato minore include debiti di un’attività (fornitori, banche per l’azienda, debiti fiscali d’impresa, ecc.).
– Esiti: entrambi portano all’esdebitazione, ma nel concordato minore è prevista la conversione in liquidazione controllata se la proposta non va in porto , mentre nel piano consumatore se non è omologato semplicemente non produce effetti (il debitore può semmai riprovare con un accordo diverso o la liquidazione volontaria).
D3: Che succede ai debiti fiscali e contributivi (verso Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, INPS) in una procedura di sovraindebitamento? Possono essere tagliati?
R: Sì, possono essere inclusi nel piano o concordato e ridotti o dilazionati, ma con alcune cautele: – Se proponi un piano del consumatore, il Fisco e l’INPS rientrano come creditori privilegiati (per imposte e contributi) o chirografari (per sanzioni). Devi assicurare loro almeno quanto otterrebbero liquidando i tuoi beni . Puoi certamente prevedere di non pagarli al 100%, ad esempio spesso IVA e contributi vengono falcidiati perché il patrimonio non consentirebbe il pagamento integrale. Il giudice valuterà la convenienza e può omologare anche se l’Agenzia è contraria, purché il piano sia più vantaggioso per loro rispetto a uno scenario di vendita forzata . Dal 2021 è stato chiarito che il giudice può imporre il cram-down fiscale, cioè dare efficacia al piano anche senza adesione del Fisco (lo stesso vale nel concordato minore analogamente). Naturalmente, è opportuno offrire il massimo possibile compatibile con le tue risorse. Nota: non puoi decidere tu di non pagare affatto l’IVA o le ritenute se avresti beni per pagarne almeno una parte, perché il giudice non lo accetterebbe. Ma se il patrimonio è nullo, si può arrivare anche ad azzerare – in tal caso probabilmente ricorreresti alla liquidazione con esdebitazione. – Nel concordato minore, il trattamento fiscale/contributivo richiede in più il voto: l’Agenzia Entrate (o INPS) ha diritto di voto come creditore. Se vota contro ma la maggioranza complessiva è raggiunta e il tribunale reputa il trattamento adeguato, può comunque omologare in cram down. Quindi in pratica si può ugualmente ridurre il debito fiscale. Tieni presente che normative speciali impongono alcune soglie: ad esempio, se fai una transazione fiscale devi offrire almeno il valore di liquidazione e rispettare eventuali percentuali minime stabilite dal MEF (dopo il correttivo ter) . Ma in sostanza, sì: cartelle, IVA, contributi possono essere ridotti e dilazionati. – Attenzione però: le sanzioni penali e amministrative pecuniarie (es. ammende, sanzioni amministrative per violazioni) non sono esdebitabili. Quelle non vengono cancellate nemmeno a fine procedura (art. 282 CCII). Le sanzioni tributarie amministrative invece (sanzioni per omessi versamenti, ecc.) sono falcidiabili come credito chirografario e vengono esdebitate (non rientrano nel divieto, il divieto vale per sanzioni non fiscali).
D4: La mia casa di abitazione è a rischio se ho molti debiti? Possono portarmela via?
R: Dipende da chi è il creditore e dalle condizioni, vediamo: – Se i debiti sono col Fisco (Agenzia Entrate-Riscossione): la prima casa (se unica, non di lusso e vi risiedi) è impignorabile da parte loro . Possono metterci ipoteca se il debito > €20.000, ma non possono eseguire il pignoramento e vendita . Negli altri casi (se hai altri immobili o la casa non è prima casa), AER può pignorarla solo se il debito supera €120.000 e il valore casa > €120.000 e sia passata ipoteca da almeno 6 mesi . Quindi c’è una protezione forte.
– Se i creditori sono privati (banche, fornitori): purtroppo la prima casa è pignorabile da loro, senza soglia minima (anche per debiti piccoli teoricamente, anche se in pratica raramente si procede per importi irrisori). Quindi la banca con mutuo certamente può procedere in caso di insolvenza (ha ipoteca), e anche un fornitore con grosso credito potrebbe tentare. Non esistono divieti generali in questi casi.
Tuttavia, soluzioni:
– In una procedura di sovraindebitamento potresti prevedere di tenere la casa, continuando a pagare il mutuo (se sostenibile) e offrendo qualcosa agli altri creditori. Con il piano, finché lo rispetti, i creditori chirografari non potranno toccare la casa.
– Potresti valutare di ridurre i debiti garantiti sulla casa: es. se c’è un secondo grado ipoteca, pagarne una parte in piano e rimuoverla. O usare il fondo prima casa del coniuge (se esistente) come difesa se il debito non è per bisogni familiari. Ma sono eccezioni complesse.
– Se proprio non riesci, la casa potrebbe dover essere venduta per soddisfare i creditori (magari venduta dal liquidatore invece che all’asta, per ottenere più valore). In ogni caso, la legge tutela che tu abbia un alloggio sostitutivo o mezzi per procurartelo. Non esplicitamente, ma ad esempio il giudice potrebbe lasciarti nell’immobile fino a fine scuola dei figli, o darti parte del ricavato se serve a prendere un altro alloggio minimo (questo soprattutto in soluzioni concordate con creditori).
– Se la casa è in comproprietà con coniuge o terzi: i creditori possono pignorare la tua quota. Il coniuge comproprietario può evitare la svendita chiedendo di assegnarsi l’intero e corrispondere la parte debito (non sempre agevole).
In sintesi, la prima casa ha scudo contro Fisco, non contro gli altri; ma le procedure concorsuali e la trattativa possono spesso evitare la perdita dell’abitazione, specialmente se c’è un mutuo in corso che conviene continuare .
D5: Se faccio una delle procedure di sovraindebitamento (piano o concordato minore), posso continuare a lavorare come artigiano o devo chiudere l’attività?
R: Una delle finalità della riforma è proprio consentire la continuità aziendale ove possibile. Quindi:
– Nel concordato minore, è espressamente previsto che il debitore può proporre un piano in continuità, ossia continuando l’attività, magari ridimensionandola ma tenendola in vita, se ciò offre migliori prospettive di recupero crediti . Ad esempio, potresti dire: “mi impegno a destinare ai creditori il 50% dei profitti della mia bottega di cappelli per i prossimi 5 anni, più venderò un macchinario non essenziale”. Se questo piano è realistico e credibile (magari con ordini già in portafoglio, con costi sotto controllo), i creditori potrebbero preferirlo alla chiusura immediata.
– Anche nel piano del consumatore nulla vieta che tu continui a lavorare come artigiano – se sei consumatore vuol dire che hai chiuso la partita IVA, ma potresti svolgere un lavoro dipendente o altro e usare quel reddito per pagare i creditori.
– Nella liquidazione controllata, invece, l’attività in essere di norma cessa, perché i beni vengono liquidati. Ma se ci fosse convenienza a proseguire temporaneamente per vendere scorte o completare lavori, il liquidatore può anche autorizzare l’esercizio provvisorio per un periodo, come avviene nel fallimento. Tuttavia è raro per micro imprese.
Quindi, scegliendo il concordato minore, è possibile mantenere aperta la tua attività di cappellaio durante e dopo la procedura – il che è ideale se vuoi provare a risollevarla. Chiaramente dovrai operare con il piano approvato, e eventuali spese straordinarie potrebbero richiedere ok del OCC o del giudice per non alterare il piano.
D6: I creditori possono opporsi o ostacolarmi se scelgo di avviare una procedura di sovraindebitamento?
R: Possono provare, ma la legge offre tutele: – Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, i creditori non votano ma possono presentare “osservazioni” per segnalare, ad esempio, che non sono d’accordo sulla ricostruzione del debito o che il debitore è stato fraudolento. Il giudice le valuterà, ma la decisione finale spetta a lui. Quindi se il tuo piano è equilibrato e tu in buona fede, le opposizioni dei creditori potrebbero essere respinte. Ad esempio il creditore può dire “non sono d’accordo a prendere 30%”, ma se 30% è il meglio possibile, il giudice omologa comunque .
– Nel concordato minore, i creditori votano. Quindi se non piace possono votare no. Serve la maggioranza del 50%+1 dei crediti : quindi se hai un creditore grande può bloccare se da solo ha più del 50%. Però tu puoi convincere i creditori della bontà del piano anticipatamente, magari negoziando a monte. In più, se c’è un creditore “pubblico” (Erario) che vota no ma gli altri sì, il tribunale può forzare l’omologa se la proposta al Fisco è almeno pari al ricavabile in liquidazione . Quindi un singolo creditore non ha potere di veto assoluto (tranne il caso uno ne detenga proprio oltre il 50% dei crediti; lì bisogna o soddisfarlo meglio o scorporarlo in classe a parte, ma nel minore non c’è divisione in classi, a differenza del concordato preventivo).
– Durante la procedura, i creditori non possono iniziare/persistere con pignoramenti se il giudice ha accordato le misure protettive . Possono però chiedere al tribunale di revocarle dimostrando che tu stai pregiudicando i loro interessi (ad es. stai dissipando beni). Se tu segui le regole, è difficile che il giudice glielo conceda.
– Dopo l’omologa, i creditori possono reclamare in appello se ritengono violati i loro diritti (es: dicono che il piano non li soddisfa quanto la liquidazione, oppure contestano la tua meritevolezza). L’appello non sospende automaticamente l’efficacia, a meno che ottengano sospensione. L’esperienza dice che raramente riescono a far ribaltare l’omologa se il piano è stato ben congegnato.
In sintesi: i creditori hanno voce (soprattutto nel concordato minore), ma non un potere arbitrario di bloccarti. Se offri loro il massimo equo possibile e rispetti le formalità, la legge tende a far prevalere la logica del recupero parziale ordinato sul “tutto o niente” individuale.
D7: Quali debiti restano comunque, cioè non si cancellano neanche dopo l’esdebitazione?
R: L’esdebitazione (sia quella conseguente a procedure, sia quella dell’incapiente) non copre: – Obblighi di mantenimento e alimentari fissati per legge (es: assegno mantenimento figli, coniuge). Quelli devi continuarli a pagare. – Debiti per risarcimento danni da fatto illecito grave (in particolare, per danni da responsabilità extracontrattuale): se ad esempio hai una condanna per aver causato volontariamente un danno e devi risarcire, non si estingue. – Multe penali e amministrative: ad esempio un’ammenda penale, o una sanzione amministrativa pecuniaria comminata come punizione (non parliamo di sanzioni tributarie: quelle sì vengono falcidiate; qui si intende per es. una multa Antitrust, una sanzione per violazione norme sicurezza sul lavoro, etc.).
– Debiti estranei alla procedura: ovviamente restano fuori quelli sorti dopo l’omologazione (i debiti nuovi). Fai attenzione: se contrai debiti durante l’esecuzione del piano senza il ok del giudice, potresti avere guai (e comunque quei debiti non saranno esdebitati). – In passato, la legge fallimentare escludeva dall’esdebitazione alcuni debiti fiscali per ritenute non versate; oggi nel sovraindebitamento questa distinzione non c’è espressa, quindi tendenzialmente anche l’IVA e le ritenute vengono esdebitate (dopo liquidazione). È materia un po’ controversa in dottrina, ma propendiamo che siano incluse nell’esdebitazione, altrimenti vanificherebbe in parte la finalità. – Se l’esdebitazione è concessa in ambito di liquidazione ma hai agito con frode o colpa grave, il giudice la può negare del tutto (quindi rimarrebbero tutti i debiti). Ugualmente, se l’hai già avuta negli ultimi 5 anni o più di due volte, non puoi chiederla .
In pratica, per un artigiano indebitato tipicamente i debiti “normali” (fiscali, banche, fornitori) sono esdebitabili, mentre resterebbe ad es. l’obbligo di mantenimento verso i figli. Quindi dopo la procedura avrai una situazione pulita, tolte quelle eccezioni.
D8: Quanto tempo ci vuole per completare queste procedure e avere la liberazione dai debiti?
R: I tempi variano a seconda dello strumento e della complessità:
– Un piano del consumatore può essere relativamente veloce: da pochi mesi a circa un anno per arrivare all’omologazione (dipende dal carico del tribunale, e se i creditori fanno opposizioni). Dopo l’omologa, la durata dipende dal piano stesso: se prevedi pagamenti in 4 anni, l’esdebitazione definitiva (completamento) arriverà dopo quei 4 anni quando avrai eseguito tutto. Ma l’effetto di sospensione delle azioni è immediato dall’ammissione e soprattutto l’effetto liberatorio condizionato scatta già con l’omologa, quindi i creditori non possono più perseguitarti per il pregresso durante l’esecuzione.
– Un concordato minore richiede anch’esso alcuni mesi per il processo di voto e omologazione. Diciamo 6-12 mesi mediamente. Poi l’esecuzione del piano può durare anch’essa diversi anni in base a ciò che hai promesso (massimo 4-5 anni in genere, ma teoricamente non c’è un limite legale strettissimo come nel concordato preventivo che ora limita a 10 anni alcune dilazioni). Finché esegui, i creditori sono bloccati e al termine ottieni l’esdebitazione automatica.
– Una liquidazione controllata dura un po’ di più di solito: i 3 anni massimi sono il target per chiuderla , ma realisticamente potrebbero volerci 2-4 anni a seconda delle difficoltà di vendere eventuali beni. Comunque per legge si cerca di chiudere entro 3 anni . L’esdebitazione arriva con la chiusura o comunque trascorsi 3 anni (il tribunale deve pronunciarsi) .
– L’esdebitazione dell’incapiente è la più rapida: si tratta di un giudizio a cui segue un decreto, potrebbe concludersi in qualche mese; una volta emesso il decreto sei libero dai debiti, salvo il periodo di 4 anni di “controllo” per eventuali sopravvenienze .
– La composizione negoziata di per sé dura al massimo 6+6 mesi ; se sfocia in concordato semplificato, aggiungi altri ~6 mesi. Ma se funziona con un accordo stragiudiziale, potresti risolvere in pochi mesi e uscire dalla crisi senza procedure giudiziali.
In sintesi: per un artigiano con debiti, dalla decisione di affidarsi a una procedura concorsuale al momento in cui si vede “liberato”, consideriamo circa 1 anno per l’omologazione (dopo il quale la pressione dei creditori cessa) e altri 3-5 anni per completare i pagamenti secondo il piano e ottenere il fresh start finale. È comunque molto meglio di restare inseguiti dai creditori a tempo indeterminato.
D9: Posso presentare di nuovo una procedura se la prima volta non va a buon fine?
R: Sì, entro certi limiti: – Se un piano del consumatore viene dichiarato inammissibile o non omologato, puoi senz’altro riproporre un’altra soluzione (magari cambiando i termini, migliorando l’offerta ai creditori, oppure convertendo in concordato minore se nel frattempo hai chiuso l’attività, ecc.). La legge lo consente e la Cassazione ha chiarito che il rigetto iniziale non preclude di riprovare correggendo gli errori .
– Se invece un piano viene omologato e poi revocato per tuo inadempimento colpevole o frode, allora la situazione è più grave: in teoria potresti ancora tentare un concordato minore o liquidazione, ma sarà difficilissimo perché hai perso credibilità; anzi spesso la revoca comporta l’apertura d’ufficio della liquidazione controllata . Quindi meglio non far fallire un piano omologato.
– Per il concordato minore: se i creditori votano no e il giudice non omologa, puoi proporre un nuovo concordato minore modificato. Non c’è un divieto espresso. Devi però magari trattare con i creditori per capire cosa vogliono.
– Cause ostative temporali: la legge impedisce di accedere ai benefici se già hai avuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti . Quindi, se hai fatto una procedura conclusa con esdebitazione, non puoi ottenerne un’altra prima di 5 anni. Ma questo vale dopo che hai completato una procedura. Se semplicemente ne hai iniziata una e non è andata a buon fine senza esdebitazione, puoi comunque tentare altra via. Es: proponi un accordo, non passa, allora provi la liquidazione: possibile. Quello che non potresti fare è, ad esempio, completare un piano nel 2023 con esdebitazione e poi nel 2024 ricrearti debiti e chiedere un nuovo piano: non te lo fanno fare (salvo casi eccezionali e autorizzazioni specifiche).
In pratica, l’ordinamento scoraggia i “seriali” della cancellazione debiti, ma consente di ritentare se la prima volta non si è riusciti, specie se lo fai in buona fede e c’è un effettivo mutamento (nuove risorse, diverso approccio).
D10: Che costi devo affrontare per avviare un piano di sovraindebitamento?
R: I costi principali sono:
– Compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC): è stabilito dal DM 202/2014 con parametri a scaglioni sul valore del debito, ma spesso gli OCC territoriali applicano tariffe calmierate. Ad esempio, per una pratica semplice può essere qualche migliaio di euro. Questo compenso viene normalmente inserito nel piano stesso e pagato con i soldi destinati alla procedura (prededucibile) , quindi non serve che tu lo paghi anticipato (tranne magari un acconto).
– Spese legali del tuo avvocato: dipende da quanto lavoro c’è (opposizioni da fare, numero di creditori, ecc.). Anche queste talvolta possono essere inserite nel passivo prededucibile, ma di solito l’avvocato chiede almeno in parte il pagamento a te, magari rateizzato. Qui conviene accordarsi: molti professionisti comprendono la difficoltà e fanno piani di pagamento. Se hai i requisiti, puoi chiedere il gratuito patrocinio (reddito sotto soglia) per fargli pagare dallo Stato una parte.
– Attestazioni o relazioni tecniche: se serve ad esempio far stimare un immobile, pagare un perito (a volte il liquidatore lo fa e prende dal ricavato). Nei piani minori non serve attestatore esterno (è l’OCC che fa relazione), quindi risparmi su quel fronte.
– Contributo unificato e bolli: attualmente per il ricorso di sovraindebitamento c’è un contributo unificato ridotto (nei vecchi piani era €98 circa). Dunque spese vive in tribunale sono contenute.
In molti casi, il costo complessivo è relativamente basso rispetto ai debiti da cui ti liberi. Ad esempio, se hai €200k debiti e paghi magari €5k-10k tra spese e compensi OCC e legali, è un investimento del 5% per toglierti il 95% del peso. In più, se la situazione è grave, come detto diversi OCC riducono i compensi, e alcune regioni hanno fondi di solidarietà (informati presso OCC locali).
D11: L’apertura di queste procedure viene pubblicata o resa nota in qualche registro? Ho timore della reputazione.
R: Sì, c’è una pubblicità legale prevista, ma limitata: – L’apertura del concordato minore viene iscritta al Registro delle Imprese se riguarda un imprenditore (anche minore) , così come la domanda di concordato viene pubblicata su registro imprese . Questo per avvisare terzi creditori. Quindi se uno fa una visura camerale della tua ditta, vedrà annotato che sei in concordato minore. Anche l’omologa poi sarà annotata e la chiusura.
– Il piano del consumatore per persona fisica non imprenditore invece non va al Registro Imprese, ma in teoria viene pubblicato sul Portale delle Procedure Concorsuali nazionale, accessibile però agli addetti ai lavori. I creditori vengono avvisati singolarmente. Non c’è affissione pubblica nei comuni come succedeva col fallimento un tempo. – L’elenco dei sovraindebitati non è pubblico di per sé (non c’è un albo dei “piani del consumatore” consultabile dal pubblico, ad eccezione del registro imprese per i soggetti ivi iscritti).
– Se sei una società, la notizia può essere ripresa da banche dati (tipo Cerved) e quindi influire sul rating. Ma d’altronde se sei sovraindebitato, il rating era già compromesso.
– Dal punto di vista reputazionale personale, queste procedure non comportano l’interdizione o l’incapacità civile come il vecchio fallimento: non sei “marchiato” legalmente se non per il tempo strettamente di esecuzione (ad esempio non potrai assumere cariche se la legge lo vieta durante la procedura, ma nel sovraindebitamento ciò non accade, è per i fallimenti societari).
Insomma, c’è trasparenza verso gli interessati, ma non vieni certo additato pubblicamente. La procedura si svolge in tribunale ma spesso in camera di consiglio (non udienze pubbliche). Chi verrà a sapere? I creditori (ovviamente) e eventuali partner d’affari se fanno ricerche camerali. Considera però che la reputazione può persino migliorare a lungo termine: un artigiano che ha risolto legalmente i suoi debiti e riparte sarà più affidabile di uno costantemente inseguito da decreti ingiuntivi. E oggi c’è sensibilità sul tema: un tempo il fallito era uno stigma, oggi chi usa la legge per risollevarsi viene visto come uno che ha avuto il coraggio di ristrutturare e ripartire.
D12: Se ottengo un piano concordato e poi adempio tutto, in futuro potrò ottenere credito o avrò problemi (tipo crif, protesti)?
R: Dipende, ma le prospettive sono buone: – Se avevi protesti (assegni, cambiali non pagate), quelli restano iscritti per 5 anni salvo riabilitazione. Puoi chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale dopo un anno dal protesto, se hai poi pagato o se la procedura ha definito quel debito. – Le centrali rischi private (CRIF ecc.) registrano i ritardi e insoluti. Se con la procedura i debiti vengono cancellati, i creditori dovrebbero segnalare la chiusura a saldo stralcio. Comunque dopo qualche anno (di solito 3 anni dal saldo) la posizione si pulisce. – Le banche in futuro valuteranno che hai avuto un’insolvenza, ma anche che l’hai gestita regolarmente e ne sei uscito. Diciamo che sarà difficile ottenere subito credito significativo appena esdebitato (nessuno dà facilmente soldi a chi ha ridotto i debiti legalmente perché vuol dire che non li ha pagati integralmente), ma col tempo, dimostrando redditi e affidabilità corrente, potrai tornare “bancabile”. – Dal punto di vista legale, una volta chiuso il piano, sei come “rinato economicamente”: non risultano carichi pendenti. Solo se qualcuno va a spulciare archivi storici tribunale troverà che hai fatto quella procedura. – Ricorda, c’è quella regola dei 5 anni per rifare un’altra esdebitazione: quindi cerca di non indebitarti di nuovo pesantemente almeno per 5 anni. In sostanza, concluso il percorso di sovraindebitamento, potrai tornare a chiedere un prestito per investire (magari serviranno garanzie maggiori inizialmente). Molti ex indebitati riescono a ricostruirsi un buon nome – specie se la causa dei debiti era legata a sfortune specifiche e non a scorrettezze.
D13: Quali rischi penali ci sono per un debitore sovraindebitato?
R: In generale, l’insolvenza civile non comporta reati. Però ci sono alcuni reati da evitare: – Sottrazione fraudolenta al pagamento di creditori (art. 388 c.p.): se vendi o sposti beni per frodare i creditori, potresti essere denunciato e condannato. Esempio: svuoti il conto dopo precetto, vendi la macchina a un prestanome per evitare il pignoramento – questo è reato. Se invece li coinvolgi regolarmente nel piano, nessun reato. – Bancarotta semplice o fraudolenta: queste si applicano solo se sei soggetto a fallimento (quindi se la tua impresa fosse fallibile e venissi dichiarato in liquidazione giudiziale). Se resti nell’ambito sovraindebitamento, non diventi fallito e quindi non si applica la bancarotta. (Attenzione però: se commetti fatti di distrazione di beni e poi vieni comunque dichiarato in liquidazione giudiziale – ipotesi, scoprono che in realtà eri fallibile – potresti rispondere di bancarotta fraudolenta per quei atti). – Reati tributari: omesso versamento IVA oltre soglia (€250k) o omesso versamento ritenute > €150k sono reati. Quindi se i tuoi debiti includono ad esempio IVA non versata di 300k, c’è un potenziale reato a parte. La procedura di sovraindebitamento non estingue né condona il reato (può solo trattare il debito). Dovrai affrontare il procedimento penale eventualmente, dove la tua migliore difesa sarà mostrare che stai pagando (ma se fai un piano che falcidia l’IVA, paradossalmente ammetti di non poterla pagare tutta: ciò non ti esonera da responsabilità penale, salvo cause di forza maggiore). In questi casi serve assistenza legale specifica sul penale tributario. – Reati nel corso della procedura (art. 344 CCII): come già evidenziato, se falsifichi o nascondi documenti, simuli crediti, violi gli obblighi durante le procedure, è reato . Le pene vanno da 6 mesi a 2 anni più multa. Ad esempio, se dopo aver ottenuto l’esdebitazione incapiente non dichiari una vincita entro 4 anni e lo scoprono, commetti reato . – Usura, abusivo credito, ecc.: se disperato ti rivolgi a usurai, attenzione che poi entri in contesti criminali. Dal tuo lato vittima non è reato, ma ovviamente è pericolo. Invece se hai emesso assegni scoperti, potresti subire denunce (più aspetto civilistico, ma occhio a non incorrere in truffa).
In sintesi, se agisci onestamente e trasparentemente, non incorri in reati solo per essere indebitato. L’ordinamento vuole aiutare chi è schiacciato dai debiti onestamente contratti . I guai penali sorgono se cerchi scorciatoie illecite o se la tua insolvenza deriva da frodi. Un consiglio: durante le procedure, segui i consigli del legale e OCC, rispetta ogni obbligo di comunicazione, e tutto filerà liscio anche penalmente.
D14: L’accordo con i creditori di cui si parla (saldo e stralcio) devo farlo davanti al giudice o posso farlo in privato?
R: Puoi farlo privatamente. Il “saldo e stralcio” è un accordo transattivo ordinario: ad esempio, scrivi al fornitore: “ti pago il 30% entro 2 mesi e ci consideriamo chiusi, altrimenti mi dichiaro insolvente”, e se lui accetta, formalizzate la rinuncia al resto del credito. Questa è una transazione stragiudiziale. Molti debitori la usano prima di rivolgersi a procedure concorsuali, soprattutto con creditori singoli. Non coinvolge il tribunale (se non per dire, se c’è già un decreto ingiuntivo, serve far depositare la rinuncia).
La differenza con procedure come il concordato è che il saldo e stralcio vincola solo chi aderisce. Quindi se hai 10 creditori e fai accordo con 7 di loro, restano fuori gli altri 3 che potranno agire. Invece in un concordato, coinvolgi tutti in un colpo solo e l’omologa li vincola anche se non consenzienti (purché maggioranza sia pro).
In ogni caso, nulla vieta di combinare: potresti fare saldo e stralcio con alcuni creditori minori per ridurre il numero di creditori, e poi procedere con un accordo di ristrutturazione o concordato per i restanti più consistenti. È una strategia valida.
D15: Un esempio pratico: sono un artigiano con ditta individuale, ho debiti totali per 150 mila euro: 50k banca (mutuo su laboratorio), 30k fornitori, 40k Agenzia Entrate (IVA e IRPEF), 30k INPS. Ho una casa dove abito con mutuo residuo. Come potrebbe essere impostato un piano?
R: Naturalmente ogni caso va studiato, ma ipotizziamo: – Valutazione attivo: hai casa (valore diciamo 100k € con mutuo residuo 60k), un laboratorio di proprietà o in affitto? supponiamo laboratorio in affitto (quindi c’è solo casa come immobile) e macchinari modesti (valore realizzo 10k). Reddito dall’attività 20k annuo (al netto spese vive) con cui mantenere famiglia.
– Opzione 1 (Concordato minore in continuità):
– Banca (mutuo laboratorio? o se era su casa): se il mutuo è su casa di abitazione, proteggerla è prioritario. Potresti proporre di continuare a pagare le rate del mutuo regolarmente (quindi la banca ipotecaria è soddisfatta fuori concordato ai sensi art. 67 co.5 CCII) . Se invece è mutuo su laboratorio affittato, valuta se conviene vendere quell’immobile.
– Fornitori (30k): potresti proporre di pagare loro, ad esempio, il 20% (6k) dilazionato in 4 anni, quindi circa 1.5k anno da distribuire.
– Agenzia Entrate (40k IVA/IRPEF): IVA è privilegiata. Offri magari di pagare il 50% (20k) in 4 anni (5k all’anno). IRPEF potrebbe essere in parte chirografario, ma includi un buon trattamento perché il Fisco deve essere soddisfatto almeno come liquidazione: se la casa vale 40k di equity libera (valore 100 – mutuo 60) e vendendola il Fisco prenderebbe, ipotesi, 20k, allora offrire 20k va bene.
– INPS (30k): contributi privilegio. Magari li tratti come il Fisco: 15k (50%) in 4 anni.
– Strumenti: mantieni l’attività per generare quei flussi (5k+5k all’anno = 10k anno + 1.5k fornitori = 11.5k anno). Dal reddito 20k, destinare 11.5k a piano e 8.5k a famiglia fattibile forse.
– Casa: la lasci fuori vendite, continui a pagar mutuo (che supponiamo 5k anno) che hai già considerato nei 8.5k per famiglia. I creditori chirografari accettano di non toccarla perché tanto ottengono il 20% via pagamenti da reddito.
– Durata: 4 anni. Al termine hai pagato: 6k fornitori + 20k Fisco + 15k INPS = 41k + i mutui correnti. Debiti residui ~109k vengono esdebitati.
Questo concordato sarebbe plausibile se i creditori vedono che vendendo casa e macchinari forse avrebbero preso anche meno (perché casa in asta forse venduta 80k, tolto mutuo 60, restano 20 da dividersi tra Fisco/INPS), azienda chiusa niente più redditi. Così invece prendono 41k totali e tu salvi casa e lavoro.
– Opzione 2 (Liquidazione controllata): vendere casa (ricava 100k, paga mutuo 60, restano 40 per creditori), vendere macchinari 10k, totale 50k. Paghi su priorità: privilegiati Fisco/INPS 40k prima (magari coperti quasi interamente), resterebbero spiccioli ai fornitori. Dopo 3 anni esdebitazione, perdi casa però e forse attività. Non ideale, ma se l’opzione 1 non fosse fattibile (es. reddito troppo basso per sostenere pagamenti), almeno sai che in 3 anni sei libero, pur senza casa.
– Opzione 3 (Piano consumatore): se avessi chiuso l’attività e trovato lavoro dipendente, come consumatore potresti fare simile a opzione 1 ma con giudice che decide e senza voto creditori. Ad esempio, offri 500€ mese per 5 anni (30k totali) da stipendio, distribuiti su Fisco/INPS prioritariamente e poco ai fornitori; giudice omologa se conviene rispetto a liquidare casa.
Quindi il disegno del piano consiste nel bilanciare: cosa posso pagare in 4-5 anni con il mio lavoro? Quali beni posso sacrificare (es. se avevi un secondo immobile o un’auto di lusso, conviene venderli per fare cassa)? Cosa ottengono i creditori in questo scenario rispetto a se mi spogliano di tutto subito? Se la risposta è uguale o meglio, il piano passa.
D16: Se durante la procedura mi accorgo che non riesco a rispettare il piano, posso modificarlo in corsa?
R: Dipende dalla fase: – Prima dell’omologazione, puoi presentare modifiche (ad es. dopo le osservazioni creditori). Col Correttivo-ter è stato chiarito che nel concordato preventivo e accordi è possibile modificare la proposta e ripetere alcune formalità . Nel concordato minore, analogamente, potresti ritirare e presentare nuova proposta (chiarito in Cass 2024). Nel piano consumatore, puoi integrare elementi all’udienza se serve, ma sostanziali modifiche di solito richiedono nuovo ricorso. – Dopo l’omologazione, il piano consumatore non si può modificare (è un provvedimento giudiziale). Nel concordato minore, non è previsto espressamente un meccanismo di modifica post-omologa. Quindi, se sopravvengono difficoltà: – Puoi chiedere al giudice di essere autorizzato a qualche variazione minore (ad es. vendere un bene diverso previsto, con equivalente risultato). Ma se è proprio un default (non riesci a pagare le rate), rischi la revoca del concordato .
– Nel concordato preventivo grande esiste l’istituto di modifica sostanziale del piano in corso di omologa (art. 118-bis CCII) , ma per concordato minore ciò non è regolato dettagliatamente (per analogia, forse applicabile). – Se il motivo è giustificato (es. un evento esterno, malattia), potresti sperare nella clemenza: il giudice può prorogare di qualche tempo l’esecuzione (specialmente nel piano consumatore il giudice è più flessibile, essendo simile a un concordato giudiziale). – Come ultima ratio, prima che sia revocato d’ufficio, puoi chiedere tu la conversione in liquidazione controllata. Così chiudi lì, liquidano quello che c’è e ti esdebitano.
In breve, una volta omologato devi fare di tutto per rispettarlo. Un minimo di elasticità c’è (ad esempio, se paghi qualche rata in ritardo ma recuperi, spesso va bene). Ma grosse modifiche no, perché i creditori hanno accettato/ottenuto certe condizioni. Quindi il piano va calibrato realisticamente dall’inizio per evitare di doverlo cambiare.
Queste FAQ coprono molti dubbi tipici. Ovviamente ogni caso concreto va personalizzato: la legge offre gli strumenti, ma vanno applicati tenendo conto delle peculiarità di ogni attività artigianale e famiglia debitrice.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo due tabelle di sintesi: la Tabella 1 confronta le caratteristiche principali delle diverse procedure di soluzione del sovraindebitamento dal punto di vista del debitore; la Tabella 2 elenca i vari tipi di debito con i possibili strumenti di gestione o difesa.
Tabella 1 – Confronto procedure di sovraindebitamento e concorsuali minori
| Procedura (riferimento normativo) | Soggetti ammessi | Voto dei creditori | Durata tipica pagamenti | Effetto sui debiti | Note principali |
|---|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione debiti consumatore<br/>(Artt. 67-73 CCII, ex piano consumatore) | Persona fisica consumatore (no debiti d’impresa) | No voto (omologa giudice dopo eventuali contestazioni) | Fino ~5-7 anni (oltre solo se mantiene mutuo casa) | Debiti anteriori ridotti/cancellati come da piano omologato; esdebitazione a fine piano | – Richiede assenza dolo o colpa grave del debitore .<br/>– Protegge casa (possibile continuare mutuo) .<br/>– Creditori non decidono, ma giudice valuta convenienza e meritevolezza . |
| Concordato minore<br/>(Artt. 74-83 CCII, ex accordo composizione) | Debitori non fallibili non consumatori (es. artigiani, professionisti, piccole società) | Sì, voto a maggioranza dei crediti >50% | Flessibile, tipicamente 3-5 anni (può prevedere anche cessioni immediate e pagamenti dilazionati) | Debiti falcidiati secondo proposta se omologata; esdebitazione a fine esecuzione piano | – Richiede adesione maggioranza crediti; dissenzienti vincolati se omologa .<br/>– Misure protettive su richiesta bloccano azioni esecutive .<br/>– Possibile continuità aziendale (proseguire attività durante piano) .<br/>– Se non omologato, possibile conversione in liquidazione controllata . |
| Liquidazione controllata<br/>(Artt. 268-277 CCII, ex liquidazione patrimonio) | Debitori non fallibili insolventi (sia consumatori che non) | N/A (non c’è voto; liquidatore vende beni e paga creditori secondo legge) | Durata liquidazione ~3 anni (obiettivo normativo) ; esdebitazione valutata decorsi 3 anni | Debiti soddisfatti in base a realizzo attivo; residuo cancellato (salvo eccezioni) con decreto esdebitazione | – Procedura liquidatoria: il patrimonio viene tutto destinato ai creditori. <br/>– Possibile iniziativa debitori (volontaria) o creditori/PM in caso di frode o revoca concordato .<br/>– Prima casa: se unica e non lusso, di regola non viene venduta in liquidazione controllata? (Il CCII non lo esplicita, ma si tende a tutelare il necessario al debitore). Comunque AER non può pignorarla .<br/>– Esdebitazione di diritto salvo comportamenti fraudolenti . |
| Esdebitazione del debitore incapiente<br/>(Art. 283 CCII) | Persona fisica sovraindebitata, senza attivo né redditi aggredibili, meritevole | N/A (istanza individuale al giudice, creditori possono esporre osservazioni) | Nessun pagamento (debitor incapiente per definizione); durata monitoraggio 4 anni dopo il decreto | Tutti i debiti cancellati immediatamente dal decreto (eccetto debiti non esdebitabili ex lege) | – Rimedio eccezionale “a costo zero” per casi disperati, una tantum .<br/>– Obbligo del debitore di dichiarare sopravvenienze utili entro 4 anni e pagarne parte ai creditori (≥10%) .<br/>– Sanzioni penali se mendace .<br/>– Richiede stretta prova di incapienza (il necessario mantenimento escluso) . |
| Accordo di ristrutturazione<br/>(Art. 57 CCII, ex 182-bis L.F.) | Imprese anche fallibili (solitamente medio-grandi) | Necessario accordo con ≥60% dei crediti (gli altri stanno fuori ma devono essere pagati integralmente) | Stabilita dall’accordo (spesso 5-7 anni) | Vincola solo aderenti + eventuale estensione omologando (cram-down enti pubblici) | – Procedura semi-privata: creditori negoziano direttamente.<br/>– Omologa tribunale; possibili misure protettive durante trattativa.<br/>– Transazione fiscale: possibile includere Fisco/INPS, ora con cram-down se dissenzienti .<br/>– Utile se pochi creditori principali. |
| Concordato preventivo<br/>(Artt. 84-120 CCII) | Imprese soggette a fallimento (medie-grandi) | Voto per classi, maggioranza 2/3 crediti per approvare (soglie più alte) | Fino a 4-5 anni (liquidat.) o oltre 5 se continuità (ma soglie minime pagamento chirografo 20% o 30% a seconda) | Debiti ridotti secondo piano, esdebitazione automatica all’omologa per persona fisica | – Procedura complessa, costosa, adatta a crisi più grandi.<br/>– Prevede classi di creditori, percentuali minime di soddisfacimento (20% chirografi liquida, 10% se concordato minore) .<br/>– Oltre scopo guida. |
| Composizione negoziata<br/>(Artt. 12-25 CCII, DL 118/21) | Imprese di qualsiasi dimensione in crisi o insolvenza incipiente | Non è prevista votazione (è trattativa stragiudiziale) | Fase trattativa max 6+6 mesi ; eventuale accordo definisce tempi pagamenti | Dipende dall’esito: se accordo stragiudiziale, debiti rimodulati consensualmente; se fallisce si può passare a concorsuale | – Nomina di esperto indipendente che facilita accordo .<br/>– Misure protettive ottenibili per congelare azioni .<br/>– Possibile accordo transattivo con creditori senza formalità concorsuali (ma va adesione unanime di quelli coinvolti).<br/>– Introdotta transazione fiscale anche qui dal 2024 . |
Tabella 2 – Tipologie di debito e strumenti di difesa/soluzione
| Tipo di debito | Caratteristiche e rischi principali | Strumenti di difesa e soluzione (sintesi) |
|---|---|---|
| Bancari (mutui, finanziamenti) | – Garanzie reali (ipoteche, pegni) -> rischio pignoramento immediato beni dati in garanzia in caso di insolvenza.<br/>– Possibile decadenza dal termine: banca chiede tutto subito se salto rate.<br/>– Fideiussioni: escussione su patrimonio personale garante. | – Rinegoziazione privata: chiedere moratoria o allungamento piano di ammortamento.<br/>– Piani del consumatore/concordati: proporre pagamento parziale/dilazionato; se ipoteca -> assicurare almeno valore bene , possibile dilazione più lunga se migliorativa .<br/>– Opposizioni legali: verificare tassi usura o anatocismo per ridurre importo dovuto in giudizio.<br/>– Misure protettive: bloccare azioni esecutive con ricorso a procedura concorsuale . |
| Fornitori commerciali | – Azioni rapide: decreto ingiuntivo e pignoramento beni/conti.<br/>– Interruzione forniture, danno a continuità azienda.<br/>– Possibile insinuazione di fallimento (se fallibile). | – Saldo e stralcio extragiudiziale: accordo sconto e pagamento parziale lump-sum.<br/>– Piano/concordato: pagare % concordata (anche bassa, purché non irrisoria ) e liberarsi saldo.<br/>– Opposizione a decreto: se contestazioni su fornitura, per rinviare e negoziare.<br/>– Garanzie pubbliche: se fornitore ha titolo, possibile chiedere rateazione giudiziale (raramente concessa). |
| Erario – Fisco (IVA, imposte) | – Privilegio su buona parte (IVA, ritenute) -> precedenza pagamento.<br/>– Riscossione a mezzo AER: cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti anche presso terzi.<br/>– Sanzioni e interessi aumentano col tempo; possibili reati per omessi versamenti sopra soglie. | – Definizioni agevolate: rottamazione cartelle (taglio sanzioni/interessi) , mini-condoni (stralcio <=1.000€).<br/>– Rateizzazione AER: 72 o 120 rate secondo importo/difficoltà, per bloccare azioni (decade se salti troppe rate).<br/>– Transazione fiscale nei piani: proporre pagamento parziale e dilazionato; tribunale può omologare anche senza adesione Fisco se offerta ≥ scenario liquidatorio .<br/>– Opposizione / sgravio: controllare notifiche e prescrizioni, fare ricorso se cartella illegittima.<br/>– Protezione prima casa: AER non può pignorare abitazione principale deb. (solo ipoteca). |
| Contributi previdenziali (INPS) e premi (INAIL) | – Assimilabili a imposte: contributi obbligatori con privilegio generale sui mobili (dopo stipendi).<br/>– Riscossione tramite AER (cartelle) o avvisi INPS esecutivi.<br/>– Mancato versamento può precludere DURC e benefici previdenziali; ritenute dipendenti non versate sono reato > soglia. | – Rateazione INPS/AER: come per imposte, piano dilazione (spesso necessario per DURC provvisorio).<br/>– Transazione contributiva: in concordato o accordo prevedere pagamento parziale di contributi (ora ammessa con cram-down come il Fisco) .<br/>– Verifica prescrizione: contributi prescritti (5 anni) non più dovuti se l’ente non ha agito in tempo.<br/>– Procedura concorsuale: includere debito in piano, con trattamento almeno pari liquidazione (spesso contributi vanno pagati in percentuale simile al Fisco). |
| Debiti locazione e leasing | – Locatore ha privilegio sui beni mobili nell’immobile (fino a 2 anni canoni) -> può far vendere macchinari presenti (pegno legale) prima di altri creditori.<br/>– Sfratto per morosità: rischio cessazione attività se locale essenziale. | – Negoziare col locatore: magari dilazione arretrati in cambio di rinnovo, o consensuale riduzione spazio/canone.<br/>– Procedura concorsuale: debito locatore spesso chirografo (salvo pegno legale) – può essere falcidiato; eventuale rilascio immobile se non sostenibile.<br/>– Opposizione a sfratto? Difficile, solo per morosità contestata; meglio trovare accordo rapido.<br/>– Leasing: restituire bene se inutilizzabile e trattare su maxicanone finale; in concordato il lessor è creditore chirografo per differenza (bene leasing va valutato). |
| Utenze e piccoli crediti | – Fornitori utilities (energia, telefono) possono sospendere servizio per morosità.<br/>– Spesso cedono crediti a recuperatori che insistono con solleciti.<br/>– Importi singolarmente piccoli ma numerosi, rischiano decreti ingiuntivi cumulativi. | – Piano consumatore/concordato: inserire tutti questi crediti chirografari, spesso pagando percentuale minima o nulla (soprattutto se creditori non si presentano neppure).<br/>– Negoziare piani di rientro brevi: a volte gestori riattivano servizio se paghi ratealmente arretrato + depositi cauzionali.<br/>– Attenzione distacco acqua/luce: per uso domestico essenziale spesso ci sono tutele (non distaccano se familiare fragile etc.), informarsi normative specifiche. |
| Debiti personali (prestiti, carte di credito) | – Spesso chirografari puri (nessuna garanzia), ma istituti di credito usano decreti ingiuntivi rapidi.<br/>– Segnalazioni in centrali rischi, pressioni call center recupero.<br/>– Se con coobbligati (es. coniuge garante), agiscono pure su loro. | – Piano del consumatore: è fatto apposta per liberare da prestiti al consumo non sostenibili; si possono tagliare fortemente .<br/>– Concordato minore: similmente, banche come creditori chirografari prendono quota proposta.<br/>– Stralcio extragiudiziale: società credito a volte accettano 30-40% a saldo per chiudere (soprattutto se credito deteriorato da anni). Conviene tentare prima di procedura.<br/>– Attenzione coobbligati: se il tuo piano libera te, il coobbligato (es. coniuge) resta obbligato per l’intero, a meno che sia anch’egli nella procedura. Valuta procedura familiare congiunta se applicabile. |
| Debiti da garanzie prestate | – Se hai fatto da garante (fideiussore) per altri, e questi non pagano, il creditore può escuterti anche se tu in origine non hai ricevuto nulla.<br/>– Debito di regresso verso il debitore principale (se paghi tu, puoi rivalerti sul debitore originario, di solito insolvente). | – Sovraindebitamento: questi debiti di garanzia rientrano come tuoi debiti a tutti gli effetti.<br/>– Puoi inserirli nel piano e falcidiarli come gli altri (il creditore originario sarà trattato per l’importo escusso o escutendo). Esempio: sei garante di prestito €50k, il debitore principale non paga, banca chiede a te: tu nel piano offri 50% su quel debito, banca aderisce = ti liberi, ma il debitore principale resta obbligato verso di te per diritto di regresso, che però tu probabilmente non riscuoterai (lo potresti esdebitare se magari siete in procedura congiunta).<br/>– Coordinamento con procedura debitore principale: se anche l’altro è in crisi, possibilità di concordati separati o uno unico familiare se requisiti. |
| Sanzioni amministrative e multe | – Multe stradali, sanzioni enti locali ecc. vanno a ruolo (cartella) se non pagate.<br/>– Non producono interessi elevatissimi (mora sì, ma non anatocismo).<br/>– Non godono di privilegi (chirografari).<br/>– Non esdebitabili se punitive? (In CCII si parla di sanzioni penali e amministrative pecuniarie non esdebitabili, su dubbio se includa tutte le amm.ve: l’orientamento è di sì, tutte non esdebitabili). | – Definizioni locali: a volte condoni locali cancellano interessi sulle multe o le riducono (dipende da Comune/periodo).<br/>– In procedura: le sanzioni pecuniarie statali/locali probabilmente non vengono esdebitate ex art. 282 lett. a) CCII, essendo debiti per sanzione amministrativa. Questo significa che, a rigore, dovresti pagarle integralmente o rischi di doverle dopo. Molti giudici però le equiparano a debiti chirografari normali e li esdebitano (era così con L.3/2012). Va verificata prassi locale.<br/>– Prudenzialmente, se hai multe sostanziose, nel piano considera di pagarne una parte significativa, per convincere giudice a includerle. |
Conclusioni
Affrontare una situazione di sovraindebitamento come quella di un produttore artigianale di cappelli sommerso dai debiti è certamente impegnativo, ma – come abbiamo illustrato – non è una condanna senza via d’uscita. Il nostro ordinamento, specie con le riforme più recenti, offre un ampio ventaglio di strumenti per riequilibrare la posizione debitoria e permettere al soggetto onesto ma sfortunato di ripartire da capo. La chiave di tutto, dal punto di vista del debitore, è agire con tempestività e trasparenza: non aspettare che tutti i creditori abbiano avviato esecuzioni e non cercare scorciatoie illecite, bensì attivarsi per trovare una soluzione negoziale o giudiziale.
Nel corso di questa guida abbiamo visto che: – L’artigiano indebitato può optare per procedure concorsuali minori (piano del consumatore se applicabile, concordato minore, liquidazione controllata) che congelano le azioni individuali e portano, se ben gestite, alla cancellazione dei debiti residui . – Queste procedure, grazie alle novità legislative fino al 2025, sono più accessibili (meno formalismi, più tutela del debitore meritevole) e flessibili (cram-down del fisco, esdebitazione automatica) che in passato . – Esistono anche soluzioni stragiudiziali (accordi, piani di rientro) che possono risolvere situazioni meno complesse, specie con pochi creditori, e che possono essere utilizzate in sinergia con le procedure giudiziali. – Strumenti specifici come la composizione negoziata possono prevenire il tracollo se attivati per tempo, evitando di arrivare all’insolvenza conclamata e magari salvando l’impresa. – Durante tutto il percorso, il debitore ha dei diritti (impignorabilità di certi beni, soglie, opposizioni) che gli permettono di conservare il necessario per vivere e lavorare, ma anche dei doveri di correttezza la cui violazione comporta sanzioni (incluso penali) .
In particolare, dal punto di vista del debitore, è fondamentale ricordare: – Non esiste più l’onta del fallimento a vita: oggi anche i piccoli imprenditori possono ambire all’esdebitazione e a continuare l’attività, magari ridimensionata, attraverso procedure costruite su misura per loro . – Le istituzioni (tribunali, OCC) offrono supporto e cercano soluzioni eque: come evidenziato dalla Cassazione, l’intento è di evitare che chi è schiacciato dai debiti venga espulso per sempre dall’economia attiva . – Bisogna però “metterci la faccia”: affrontare la realtà, farsi aiutare da professionisti, e prendere decisioni difficili (come sacrificare un bene, ridurre il tenore di vita) in vista di un risultato finale liberatorio.
Per un artigiano cappellaio indebitato, difendersi efficacemente significa in ultima analisi diventare parte attiva del processo di risanamento: con gli strumenti giuridici adeguati, può passare da una condizione di oppressione e passività (subire pignoramenti, diffide, interessi) ad una di controllo della situazione (proponendo un piano ai creditori, gestendo in prima persona la soluzione concorsuale). Questa trasformazione – oltre a salvare spesso l’attività e i beni essenziali – restituisce dignità e prospettiva di futuro al debitore.
In conclusione, se “produci cappelli artigianali ma hai debiti”, non devi arrenderti né cedere a scorciatoie sbagliate: informati, pianifica e agisci con gli strumenti legali a disposizione. Come un cappellaio esperto riesce a rammendare un cappello rovinato ridandogli forma e bellezza, così un debitore, con l’aiuto delle norme e dei professionisti giusti, può rimettere insieme i pezzi della propria stabilità finanziaria, uscendo dal tunnel dell’indebitamento e tornando a guardare avanti.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali (aggiornate al 2025):
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, in vigore dal 15/07/2022 (come modif. da D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024). Particolarmente rilevanti: art. 2 (definizioni di “consumatore”, “imprenditore minore”, “sovraindebitamento”) ; artt. 67-73 (ristrutturazione debiti consumatore) ; artt. 74-83 (concordato minore) ; artt. 268-277 (liquidazione controllata); art. 283 (esdebitazione incapiente) ; art. 344 (fattispecie penali per debitore in procedura) .
- Legge 27 gennaio 2012 n.3 (vecchia “legge sul sovraindebitamento”) – ABROGATA dal CCII, ma utile per i principi ispiratori. Emendata da L.176/2020 con introd. esdebitazione incapiente.
- Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e Consiglio, sulla ristrutturazione e insolvenza. Recepita dal CCII, ha incoraggiato la seconda opportunità per imprenditori e armonizzato il cram-down fiscale.
- D.L. 118/2021 conv. L.147/2021: istituzione Composizione Negoziata per la Crisi.
- D.Lgs. 13 ottobre 2022 n.83 (c.d. “Correttivo bis” CCII) e D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (c.d. “Correttivo ter” CCII) – Decreti integrativi e correttivi del Codice della Crisi. Il Correttivo-ter in particolare ha introdotto modifiche su misure protettive, percentuali di soddisfo enti, transazione fiscale in composizione negoziata, ecc. .
- Codice di Procedura Civile, artt. 474 e segg. (esecuzioni forzate), art. 515 (beni impignorabili, tra cui strumenti di lavoro) ; art. 495 (conversione pignoramento in somme); art. 569 e segg. (vendite immobiliari).
- DPR 602/1973 (riscossione imposte), in particolare art. 72-ter, 72-bis (pignoramento presso terzi semplificato), art. 77 (ipoteca esattoriale), art. 79 (limiti pignoramento pensioni e stipendi da parte AER) , art. 76 (pignoramento immobiliare con soglie di €120.000) , art. 86 (fermo amministrativo).
- Codice Penale, art. 388 co.6 (sottrazione fraudolenta al pagamento di creditori); D.Lgs. 74/2000, artt. 10-bis, 10-ter (omesso versamento tributi).
- Corte di Cassazione – massime e sentenze recenti:
- Cass. Civ. Sez. I, 14/02/2023 n. 4613: presupposti ammissibilità accordo sovraindebitamento, alternativa liquidatoria e atti in frode (donazione prima della procedura considerata ai fini del calcolo) .
- Cass. Civ. Sez. I, 27/07/2023 n. 22890: applicazione immediata del CCII ai procedimenti in corso, differenza criteri di meritevolezza (L.3/2012 vs CCII) .
- Cass. Civ. Sez. I, 27/07/2023 n. 22900: dopo omologa piano consumatore, incompletezze documenti non imputabili al debitore; ammissibilità ricorso straordinario su provvedimenti decisori in reclamo .
- Cass. Civ. Sez. I, 27/11/2024 n. 30538: valutazione affidabilità del debitore nell’accordo anche senza clausola meritevolezza; diritto di voto crediti fiscali spetta ad Agenzia Entrate .
- Cass. Civ. Sez. I, 27/11/2024 n. 30529: provvedimento di inammissibilità di proposta non è decisorio e non ricorribile ex art.111 Cost. .
- Cass. Civ. Sez. I, 20/02/2024 n. 4622: possibilità di dilazione oltre un anno per creditori privilegiati nel piano consumatore se più tutelante – moratoria annuale di L.3/2012 non è limite perentorio .
- Cass. Civ. Sez. I, 19/10/2024 n. 22914: il creditore fondiario (mutuo ipotecario) può iniziare/proseguire esecuzione individuale nonostante apertura liquidazione sovraindebitato, in virtù privilegio ex art. 41 TUB .
- Cass. Civ. Sez. I, 23/09/2022 n. 28013: piano consumatore con soddisfacimento chirografari esiguo può essere dichiarato inammissibile per difetto di causa (percentuale ai chirografari non deve essere irrisoria, valutazione caso per caso) .
- Cass. Civ. Sez. III, 26/07/2023 n. 22715: (ordinanza) ha affrontato il concetto di consumatore vs professionista in procedura, presumibilmente in linea con la distinzione consumatore puro e debiti promiscui (cfr. Corte Appello Firenze definizione consumatore sovraindebitato).
- Cass. Civ. Sez. I, 27/07/2023 n. 22890: (massima ufficiale) “In tema di sovraindebitamento, se il procedimento di omologazione del piano del consumatore è in corso all’entrata in vigore del CCII, trovano applicazione i nuovi criteri di meritevolezza ex art. 67 CCII, fondati sull’assenza di colpa grave, malafede o frode nella genesi dell’indebitamento, diversi dalla previgente nozione di meritevolezza di cui alla L.3/2012” .
- Tribunale di Bergamo – sez. sovraindebitamento: linee guida e modulistica (es. modulistica ricorso art. 67 CCII, ecc.) .
- OCC Brescia (Ordine Avvocati) – Nota informativa 2023 sulle procedure di composizione nel CCII: contiene requisiti accesso e cause ostative , fasi delle procedure , disciplina esdebitazione incapiente , ecc.
- Linee guida del Massimario Cassazione n.10/2025 sul Correttivo-ter: evidenziano modifiche apportate alle varie procedure, es. composizione negoziata, concordato semplificato, istituti sovraindebitamento .
- Agenzia Entrate-Riscossione – informazioni su procedure esecutive (sito istituzionale): criteri pignoramento immobiliare (soglia €120.000, divieto prima casa) , limiti pignoramento stipendio , fermo auto prassi ecc.
Gestisci un laboratorio o un’impresa artigianale di produzione di cappelli e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci un laboratorio o un’impresa artigianale di produzione di cappelli e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori o Agenzia delle Entrate?
Hai leasing o prestiti per macchinari tessili, cartelle esattoriali, IVA arretrata o contributi non versati, e temi pignoramenti o la chiusura del laboratorio?
👉 Non sei solo: molte botteghe e imprese artigiane del settore moda stanno affrontando situazioni di sovraindebitamento, ma la legge oggi offre soluzioni legali efficaci per bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti e ripartire in modo regolare e protetto.
In questa guida scoprirai perché le imprese artigiane del settore moda entrano in crisi, quali strumenti di difesa legale puoi usare, e come salvare la tua attività o chiuderla senza fallire.
🎩 Perché le imprese artigiane di cappelli si indebitano
Il settore della produzione artigianale di cappelli e accessori è in crisi per diversi motivi:
- Aumento dei costi di materiali, energia e manodopera;
- Calo delle vendite dovuto alla concorrenza estera e all’online;
- Ritardi nei pagamenti da parte di boutique, grossisti o rivenditori;
- Fidi bancari ridotti o revocati;
- Tassazione elevata e difficoltà nel versare imposte e contributi;
- Spese fisse per affitti e macchinari troppo alte rispetto ai ricavi.
📌 Tutto ciò può trasformarsi in una spirale di debiti fiscali, bancari e commerciali che rischiano di compromettere anni di lavoro e il futuro dell’attività artigiana.
🧾 I debiti più frequenti per le imprese artigiane del settore moda
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IRPEF, IVA, INPS, INAIL, TARI, cartelle esattoriali, accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Mutui o leasing per macchinari, impianti e locali.
- Prestiti per acquisto di tessuti o materie prime.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non pagate a fornitori di stoffe, filati, accessori, packaging e spedizioni.
✅ Debiti verso dipendenti o collaboratori
- Stipendi arretrati, contributi previdenziali non versati.
✅ Debiti personali o fideiussioni
- Garanzie personali dei soci o del titolare su mutui e prestiti aziendali.
⚠️ Cosa rischia un’impresa artigiana indebitata
Se non agisci in tempo, i creditori possono:
- pignorare macchinari, strumenti e conti correnti;
- bloccare i fornitori o le forniture di materiali;
- revocare fidi o leasing;
- iscrivere ipoteche su immobili e beni personali;
- avviare esecuzioni o richieste di fallimento.
👉 Tuttavia, la legge oggi ti consente di bloccare immediatamente ogni azione dei creditori, ristrutturare o cancellare i debiti e salvare la tua bottega artigiana, senza fallire.
🧩 Le soluzioni legali per imprese artigiane con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Con l’aiuto di un avvocato puoi ottenere:
- saldo e stralcio dei debiti, pagando una parte ridotta delle somme dovute;
- piani di rientro rateali compatibili con i tuoi ricavi;
- sospensione temporanea dei pagamenti per evitare pignoramenti e revoche.
👉 È la soluzione più immediata per chi vuole continuare a lavorare e preservare clienti e commesse.
💠 2. Procedura di sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa)
È la principale procedura per artigiani, microimprese e titolari di botteghe che non riescono più a pagare i debiti.
Permette di:
- bloccare pignoramenti e cartelle;
- proporre un piano di pagamento parziale e sostenibile;
- ottenere la cancellazione totale dei debiti residui (esdebitazione).
📌 È accessibile anche a chi ha chiuso la partita IVA ma rimane gravato da debiti fiscali o bancari.
💠 3. Concordato minore (per società artigiane)
Se gestisci un laboratorio organizzato come società (SNC, SRL, cooperativa artigiana), puoi accedere al concordato minore.
Consente di:
- bloccare immediatamente tutte le azioni dei creditori;
- ridurre legalmente i debiti complessivi;
- continuare la produzione e salvare posti di lavoro.
💠 4. Liquidazione controllata (ex fallimento personale)
Se la tua attività non è più sostenibile, puoi chiudere in modo legale e protetto, mettendo a disposizione solo i beni non indispensabili (macchinari obsoleti, scorte, veicoli).
Al termine, il Tribunale cancella tutti i debiti residui, permettendoti di ricominciare senza pendenze.
💠 5. Verifica di cartelle e accertamenti fiscali
Molti debiti con l’Agenzia delle Entrate sono prescritti o notificati in modo irregolare.
Un avvocato può:
- verificare la prescrizione (5 o 10 anni);
- controllare errori di calcolo e duplicazioni;
- chiedere la sospensione o l’annullamento delle cartelle illegittime.
🧵 Cosa fare subito
✅ 1. Analizza la situazione economica e i debiti
Raccogli cartelle, leasing, mutui, contratti, estratti conto e debiti verso fornitori.
✅ 2. Blocca i creditori immediatamente
Con il deposito di una procedura di sovraindebitamento o concordato, pignoramenti e azioni vengono sospesi per legge.
✅ 3. Non firmare rateizzazioni non sostenibili
Evita soluzioni improvvisate o proposte da agenzie non autorizzate: serve una strategia legale completa, tutelata dal Tribunale.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Visura camerale o certificato di chiusura della partita IVA.
- Dichiarazioni dei redditi e posizione INPS/INAIL.
- Contratti di leasing e mutui.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori, clienti e fatture pendenti.
- Inventario di macchinari e materiali.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e strategia legale: 1–3 settimane.
- Deposito del piano o della procedura: 1–2 mesi.
- Sospensione immediata dei creditori: al momento del deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Blocco di pignoramenti, cartelle e ipoteche.
- Riduzione o cancellazione dei debiti residui.
- Tutela degli strumenti indispensabili per lavorare.
- Ripartenza economica e professionale pulita.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Stop immediato a tutte le azioni dei creditori.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Continuità dell’attività artigiana durante la procedura.
✅ Tutela dei beni e delle attrezzature essenziali.
✅ Possibilità di chiudere in modo ordinato e ripartire senza debiti.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o solleciti dell’Agenzia delle Entrate.
- Accumulare nuovi debiti per coprire i vecchi.
- Firmare accordi non sostenibili o non assistiti da un legale.
- Rivolgerti a “consulenti del debito” non abilitati.
- Aspettare troppo tempo prima di agire.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la situazione finanziaria e debitoria della tua impresa artigiana.
📌 Ti consiglia la strategia migliore (rinegoziazione, concordato, sovraindebitamento o liquidazione controllata).
✍️ Redige e deposita il piano legale in Tribunale per bloccare subito i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche, fornitori e dipendenti.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione definitiva dei debiti e alla piena riabilitazione economica e professionale.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario, commerciale e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di imprese artigiane e laboratori del settore moda con debiti fiscali e bancari.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere un’impresa artigiana di produzione di cappelli con debiti non significa essere destinati alla chiusura.
Con una difesa legale mirata e tempestiva, puoi bloccare i creditori, ridurre le somme dovute e salvare la tua bottega o chiuderla in modo ordinato, senza fallire.
Il Codice della Crisi d’Impresa ti tutela: se agisci in tempo, puoi tornare a lavorare in serenità e creatività.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova creazione senza debiti comincia oggi.