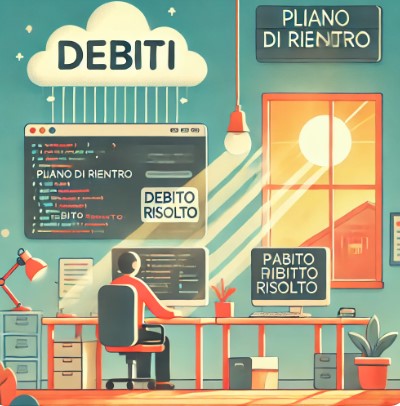Gestisci una software house o un’attività di sviluppo informatico e ti trovi in difficoltà economica per via di debiti con il Fisco, l’INPS, le banche o i fornitori? È una situazione che molti imprenditori del settore tecnologico stanno affrontando. La crescita discontinua del mercato digitale, la forte concorrenza e l’aumento dei costi di gestione hanno messo in difficoltà molte realtà innovative. Quando iniziano ad accumularsi cartelle esattoriali, finanziamenti non pagati o contributi arretrati, la pressione fiscale e finanziaria può diventare insostenibile. La buona notizia è che esistono strumenti legali efficaci per bloccare la riscossione, rateizzare o cancellare i debiti, proteggendo la tua attività e i tuoi beni personali.
Perché molte software house si indebitano
Le cause dell’indebitamento nel settore informatico sono molteplici. Le piccole software house investono costantemente in aggiornamenti tecnologici, infrastrutture IT, licenze e formazione del personale. I pagamenti dei clienti — spesso aziende o enti pubblici — arrivano in ritardo, mentre le scadenze fiscali e contributive non si fermano. L’aumento dei costi operativi, le fluttuazioni del mercato e la difficoltà di accesso al credito rendono complesso mantenere un equilibrio finanziario stabile. Per sostenere i progetti e pagare i dipendenti, molti imprenditori rinviano i versamenti delle imposte o dei contributi, accumulando debiti che col tempo diventano difficili da gestire.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
Se i debiti fiscali o contributivi non vengono pagati, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali possono avviare azioni di recupero. Tra le principali: la notifica di cartelle esattoriali, le intimazioni di pagamento, i pignoramenti dei conti correnti, i fermi amministrativi sui veicoli aziendali, le ipoteche sugli immobili o sui beni strumentali e i sequestri dei crediti verso i clienti. Gli importi aumentano nel tempo a causa di sanzioni e interessi, aggravando ulteriormente la situazione. Se operi come ditta individuale o socio di una società di persone, rispondi personalmente dei debiti, rischiando anche i tuoi beni privati.
Cosa fare subito se la tua software house ha debiti
Il primo passo è analizzare la situazione debitoria in modo preciso. Richiedi l’estratto di ruolo aggiornato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conoscere l’importo complessivo e le annualità coinvolte. Poi verifica la validità delle cartelle: molti atti contengono errori di notifica o importi prescritti che un avvocato può contestare. Se il debito è legittimo, puoi chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili, sospendendo temporaneamente le procedure di riscossione. È utile anche verificare se è disponibile una definizione agevolata (rottamazione), che consente di pagare solo il capitale eliminando sanzioni e interessi. Se hai già ricevuto pignoramenti o ipoteche, puoi bloccare le azioni esecutive presentando un ricorso o un’istanza di autotutela.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se i debiti sono troppo alti o non riesci più a far fronte alle scadenze, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È uno strumento legale pensato per piccole imprese, startup e professionisti che consente di bloccare pignoramenti, sospendere le azioni dei creditori e ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residui (esdebitazione). È una soluzione riconosciuta dai tribunali italiani, utile per salvare l’attività, mantenere i contratti e preservare la reputazione aziendale nel settore.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molte software house si trovano anche in difficoltà con banche o fornitori di servizi tecnologici. Se non riesci più a pagare leasing, mutui o canoni software, puoi chiedere la rinegoziazione dei contratti o la sospensione temporanea delle rate. È inoltre possibile proporre un saldo e stralcio, chiudendo la posizione a un importo ridotto, oppure contestare clausole abusive o tassi usurari presenti nei contratti di finanziamento. In caso di decreti ingiuntivi o pignoramenti, è fondamentale agire subito con un avvocato per presentare opposizione entro i termini di legge.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Con una difesa legale tempestiva e ben strutturata puoi sospendere pignoramenti e riscossioni, ottenere la rateizzazione o la cancellazione dei debiti, proteggere la sede aziendale e i beni personali, evitare la chiusura dell’impresa e ripartire su basi più solide. Molte piccole software house, grazie a una gestione legale corretta, sono riuscite a ristrutturare il proprio debito e a continuare a operare senza perdere clienti e contratti.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi rivolgerti a un avvocato se hai ricevuto cartelle o intimazioni di pagamento, se hai debiti fiscali, contributivi o bancari che non riesci più a sostenere o se rischi il blocco dei conti e la sospensione dei contratti. Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa può contestare gli atti illegittimi, bloccare la riscossione e accompagnarti nella procedura di esdebitazione fino alla cancellazione definitiva dei debiti. Agire subito è fondamentale per salvare l’impresa e tutelare la tua reputazione professionale.
⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o gli avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, blocchi dei conti e perdita di contratti con clienti e partner. Intervenire tempestivamente è l’unico modo per proteggere la tua attività e il tuo futuro imprenditoriale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela delle imprese tecnologiche – spiega cosa fare se gestisci una software house con debiti, come bloccare la riscossione e come cancellare legalmente le somme dovute grazie agli strumenti previsti dalla legge.
👉 Hai debiti fiscali, contributivi o bancari che mettono a rischio la tua software house?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Le piccole software house – startup e imprese informatiche di dimensioni ridotte – possono trovarsi esposte a debiti significativi verso Fisco, enti previdenziali, banche e fornitori. In Italia, la gestione dei debiti aziendali è stata rivoluzionata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 2022, che ha introdotto nuovi strumenti per prevenire e affrontare la crisi. In questa guida approfondita (aggiornata a settembre 2025) esamineremo cosa fare e come difendersi dal sovraindebitamento per una piccola software house, con un taglio giuridico avanzato ma dal punto di vista pratico del debitore. Verranno illustrati i diversi tipi di debiti e rischi collegati, gli strumenti stragiudiziali e concorsuali per risanare o liquidare l’azienda, incluse le ultime novità normative (composizione negoziata, piani attestati, concordato “semplificato” ecc.), e le tutele per evitare conseguenze peggiori.
Struttura della guida: Inizieremo classificando le tipologie di debito (tributari, previdenziali, bancari, commerciali) e le relative conseguenze. Poi analizzeremo le strategie di risanamento stragiudiziali (negoziazioni private, piani di rientro, ecc.) e le procedure concorsuali formali previste dal CCII (accordi di ristrutturazione, concordati preventivi e minori, concordato semplificato post-composizione negoziata, liquidazione giudiziale o controllata). Ci soffermeremo in dettaglio sulla composizione negoziata della crisi, nuovo strumento chiave per le PMI introdotto nel 2021, e sul concordato semplificato di liquidazione. Approfondiremo i profili fiscali (come trattare i debiti tributari e contributivi nei piani) e i possibili risvolti penali (reati fallimentari e tributari). La guida include tabelle riepilogative, FAQ (domande e risposte) sugli interrogativi più comuni, ed esempi pratici di strategie risolutive. Infine, troverete una sezione con fonti normative e giurisprudenziali aggiornate per ulteriori riferimenti. L’obiettivo è fornire a imprenditori, professionisti e consulenti legali uno strumento completo per orientarsi nella gestione avanzata della crisi d’impresa di una software house debitrice, indicando come difendere l’azienda e il patrimonio personale dai creditori nel rispetto della legge.
1. Tipologie di debiti di una software house e relativi rischi
Una piccola software house può contrarre vari tipi di debiti aziendali, ciascuno con caratteristiche e conseguenze specifiche. Comprendere la natura dei debiti è fondamentale per individuare le soluzioni più efficaci e le difese possibili. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debito per un’impresa informatica e i rischi correlati per il debitore.
1.1 Debiti tributari (fiscali)
I debiti verso il Fisco comprendono imposte non versate (es. IVA, IRES, IRAP), ritenute fiscali non pagate (come le ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni dei dipendenti o sui compensi dei professionisti) e relative sanzioni e interessi di mora. Nelle piccole imprese tecnologiche, questi debiti possono accumularsi in caso di carenza di liquidità o errata pianificazione fiscale. I rischi principali associati ai debiti tributari sono:
- Aggio di riscossione, interessi e sanzioni: il mancato versamento nei termini comporta sanzioni tributarie e interessi di mora che fanno lievitare l’importo dovuto. Ad esempio, l’omesso versamento IVA è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta, oltre interessi, salvo definizioni agevolate.
- Iscrizione a ruolo e cartelle esattoriali: dopo la notifica degli avvisi e l’iscrizione a ruolo, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) emette cartelle di pagamento. Se la software house non paga nemmeno le cartelle, la riscossione coattiva si attiva .
- Azioni esecutive e cautelari: l’Agente della Riscossione può procedere con misure cautelari come il fermo amministrativo di veicoli aziendali e l’ipoteca su immobili, seguite da pignoramenti di conti correnti, crediti verso clienti, attrezzature informatiche e altri beni aziendali. Queste misure possono paralizzare l’operatività dell’impresa. Ad esempio, è frequente il blocco del conto corrente tramite pignoramento presso la banca, impedendo di fatto all’azienda di incassare crediti e pagare spese correnti.
- Rischio di istanza di fallimento da parte del Fisco: se il debito fiscale è ingente e l’impresa inadempiente, l’Erario (tramite l’Avvocatura o Agenzia Entrate Riscossione) può presentare istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) al tribunale. Anche debiti IVA relativamente elevati hanno giustificato istanze di fallimento in passato. Il CCII ora consente di avviare procedure di liquidazione anche per debitori minori, evitando zone franche di impunità .
- Conseguenze penali: alcuni debiti fiscali, se non pagati oltre soglie di legge, configurano reati tributari. In particolare, l’omesso versamento di IVA per importi superiori a 250.000 € annui e l’omesso versamento di ritenute dovute per oltre 150.000 € annui costituiscono reato punibile con la reclusione (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000). Ciò significa che se una software house non versa IVA o ritenute per importi rilevanti, l’amministratore può essere perseguito penalmente indipendentemente dall’avvio di procedure concorsuali. Anche la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (es. distrarre beni per evitare che il Fisco vi soddisfi il credito) è reato ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000. La Cassazione ha chiarito che tali reati tributari non “si assorbono” con i reati fallimentari: perseguono interessi giuridici diversi (Erario vs massa creditoria) e possono concorrere cumulativamente . Esempio: un amministratore che accumuli un grosso debito IVA non pagato e contemporaneamente distragga risorse dall’azienda può rispondere sia di omesso versamento IVA sia di bancarotta fraudolenta, con cumulo di pene.
In sintesi, i debiti fiscali non pagati espongono la società a un’escalation di misure repressive: prima amministrative (sanzioni/ interessi), poi esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) e infine, in caso di insolvenza conclamata, concorsuali (istanze di fallimento) e persino penali per gli organi sociali. Difendersi da questi debiti richiede tempestività (richiedere dilazioni o definizioni agevolate quando disponibili, oppure includerli subito in piani di ristrutturazione) e massima attenzione alle soglie penalmente rilevanti, privilegiando il pagamento di IVA e ritenute appena possibile o almeno inserendole in un accordo con il Fisco per evitare imputazioni.
1.2 Debiti previdenziali (INPS e INAIL)
Le software house con dipendenti hanno obblighi contributivi verso enti previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). I debiti contributivi possono derivare dal mancato versamento di contributi obbligatori per i dipendenti (quote a carico dell’azienda e trattenute a carico del lavoratore), dei contributi dovuti per eventuali soci lavoratori o per il titolare (gestione artigiani/commercianti), nonché dei premi assicurativi INAIL. In caso di crisi di liquidità, l’impresa potrebbe omettere questi versamenti. Le conseguenze principali sono:
- Sanzioni civili e interessi moratori: il mancato pagamento dei contributi entro il termine di legge (di norma il 16 del mese successivo per i contributi mensili) comporta sanzioni da parte dell’INPS (c.d. sanzioni civili) che si accumulano nel tempo. Tali sanzioni possono essere anche elevate (fino al 9% annuo circa, più una somma aggiuntiva) e fanno crescere il debito complessivo .
- Cartelle esattoriali e ingiunzioni INPS: analogamente al Fisco, anche l’INPS si avvale dell’Agente della Riscossione per riscuotere i crediti contributivi. Dopo l’iscrizione a ruolo, vengono emesse cartelle esattoriali per i contributi non pagati. In alcuni casi l’INPS può emettere un’ingiunzione propria (ex art. 30 D.P.R. 602/1973) per crediti a breve termine. Se la software house non paga, scattano pignoramenti su conti e beni aziendali analoghi a quelli fiscali.
- DURC irregolare e blocchi operativi: la presenza di debiti contributivi non consente di ottenere il DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Un DURC irregolare impedisce la partecipazione a bandi pubblici e può comportare la sospensione dei pagamenti da parte di enti pubblici per contratti in corso . Nel settore ICT, questo è rilevante se la software house ha commesse con la Pubblica Amministrazione o con grandi aziende che richiedono fornitori in regola con i contributi. Un DURC negativo può comportare anche l’impossibilità di accedere a certi bonus o finanziamenti pubblici. In alcune procedure concorsuali, tuttavia, è possibile ottenere una proroga del DURC presentando un piano di rientro o una transazione con l’ente previdenziale . Ad esempio, se l’azienda presenta un concordato preventivo in continuità e prevede il pagamento integrale dei contributi, l’INPS può rilasciare un DURC provvisorio per permettere all’impresa di proseguire i contratti pubblici durante l’esecuzione del piano.
- Azioni penali specifiche: l’omissione dolosa del versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti oltre una certa soglia costituisce reato (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). Attualmente, non pagare le ritenute previdenziali per un importo superiore a €10.000 annui è penalmente sanzionato. Ciò significa che se la software house non versa le trattenute INPS sulle retribuzioni per oltre 10.000 € in un anno, il legale rappresentante rischia una condanna penale (pena massima fino a 3 anni). Da notare che, diversamente dall’omesso versamento IVA, questo reato non richiede soglie altissime: può colpire anche piccole imprese se proseguono a non pagare i contributi dei dipendenti. Inoltre, l’indebita compensazione di crediti inesistenti per “azzerare” debiti INPS configura reato ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.
- Interventi del Fondo di Garanzia e rivalsa: se l’azienda diviene insolvente e non paga TFR e ultime mensilità ai dipendenti, interviene il Fondo di Garanzia INPS per corrispondere ai lavoratori quanto dovuto (nei limiti di legge). L’INPS però si surroga nel credito ed entrerà tra i creditori dell’azienda per recuperare quanto pagato ai dipendenti. Questo significa che l’INPS avrà un ulteriore titolo di credito (privilegiato) verso la software house, aggravando il passivo. Inoltre, l’INPS potrebbe promuovere l’apertura di una procedura concorsuale se ciò è necessario per attivare il Fondo di Garanzia (nel passato l’INPS presentava istanze di fallimento per poter pagare i dipendenti insoluti e poi rivalersi).
In breve, i debiti previdenziali hanno effetti simili a quelli fiscali: rendono irregolare l’azienda (niente DURC), la espongono a pignoramenti e, se protratti, possono sfociare in procedure concorsuali e anche in responsabilità penali a carico degli amministratori. Una difesa efficace comprende richiedere rateazioni all’INPS (solitamente concesse fino a 24 rate mensili, estensibili in casi eccezionali) o includere i debiti contributivi in un piano di ristrutturazione. È importante sapere che al di fuori di una procedura concorsuale omologata, l’INPS non può legalmente rinunciare a contributi dovuti (nemmeno con accordi transattivi ad hoc) . Un eventuale accordo stragiudiziale per ridurre il debito INPS sarebbe nullo perché la materia è sottratta alla libera disponibilità delle parti . Solo all’interno di strumenti come il concordato o l’accordo di ristrutturazione si può ottenere una transazione previdenziale efficace, omologata dal giudice, che falcidi parte di contributi e sanzioni secondo quanto la legge consente (dopo il 2024, anche i contributi possono essere ridotti in alcuni limiti, v. §7.1). Fuori da tali casi, l’unica soluzione legale è la dilazione: pagare a rate l’intero dovuto, perché accordi privati di saldo e stralcio su contributi sono nulli . Pertanto, per difendersi da debiti INPS conviene attivare strumenti formali o adempiere tramite piani di rateazione legalmente previsti, evitando di ignorare il problema (un DURC negativo prolungato spesso causa la perdita di commesse vitali per l’impresa).
1.3 Debiti bancari e finanziari
Le piccole imprese software spesso finanziano la propria attività con prestiti bancari, linee di credito in conto corrente (fidi, anticipi su fatture), leasing su attrezzature informatiche, finanziamenti agevolati (ad es. fondi per startup innovative) o con capitale di venture capital. Debiti bancari tipici includono: mutui chirografari o ipotecari, scoperti di c/c, castelletti per anticipo fatture, leasing per hardware/software, e finanziamenti da società Fintech o di factoring. Quando la software house non riesce a rispettare le scadenze di rimborso, si attivano meccanismi di tutela del credito bancario con effetti severi:
- Revoca degli affidamenti e segnalazioni in Centrale Rischi: se l’impresa ritarda i pagamenti o peggiorano i suoi indici finanziari, la banca può revocare i fidi di cassa e gli affidamenti concessi, riducendo o azzerando la linea di credito disponibile. Questo significa che un conto precedentemente “affidato” diventa improvvisamente scoperto esigibile, obbligando l’azienda a rientrare immediatamente delle somme utilizzate. Inoltre la banca, di fronte al deteriorarsi del credito, segnalerà la posizione come “a sofferenza” alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e/o a sistemi privati di informazione creditizia (CRIF). Tale segnalazione pregiudica la reputazione creditizia dell’azienda e dei suoi garanti, tagliando l’accesso a nuovo credito. Va segnalato però che dal 2024 esiste un divieto di legge per le banche di revocare o ridurre gli affidamenti solo a causa dell’accesso alla composizione negoziata della crisi . Se l’impresa attiva la composizione negoziata (v. sezione 5) e ottiene misure protettive dal tribunale, le banche non possono unilateralmente chiudere le linee di credito né ridurre i plafond con la motivazione della procedura in corso . Inoltre non possono segnalare a Centrale Rischi il semplice fatto che l’azienda ha sospeso i pagamenti durante le trattative . Queste tutele (introdotte dal “correttivo-ter” nel 2024) bilanciano gli interessi: impediscono alle banche reazioni automatiche che comprometterebbero la continuità aziendale e la riuscita del risanamento . Fuori dal caso particolare della composizione negoziata con misure protettive, però, le banche mantengono il potere di revoca secondo contratto: in mancanza di un accordo o provvedimento protettivo, un covenant violato o un ritardo di pagamento possono far scattare la revoca del fido e la segnalazione.
- Decadenza dal beneficio del termine e richieste di rientro: al manifestarsi dell’insolvenza, le banche spesso accelerano i finanziamenti: dichiarano la decadenza dal termine (se prevista contrattualmente) e richiedono il pagamento immediato di tutto il capitale residuo del mutuo o del prestito. Per esempio, se la software house aveva un mutuo quinquennale e salta alcune rate, la banca può inviare una comunicazione di decadenza dal termine, rendendo esigibile l’intero debito residuo in un’unica soluzione. Questo ovviamente aggrava la posizione debitoria, perché somme che sarebbero scadute in futuro diventano subito dovute.
- Decreti ingiuntivi e procedure esecutive: la banca (o la società di leasing) può ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo basato sul contratto di finanziamento e sull’estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Con il decreto, procede a pignorare i beni della società. In caso di mutuo ipotecario non pagato, può avviare esecuzioni immobiliari sugli immobili concessi in garanzia. Se vi sono beni dati in leasing, il mancato pagamento comporta la risoluzione del contratto e la restituzione immediata dei beni (server, computer, automezzi) con successiva rivendita da parte della società di leasing e addebito dell’eventuale differenza. Un aspetto cruciale: molte piccole imprese ottengono finanziamenti bancari grazie a garanzie personali (fideiussioni) fornite dai soci o da terzi, o grazie a garanzie statali (es. Fondo di Garanzia MCC). Se la società non paga, la banca escuterà i garanti. Ciò implica che il debito “aziendale” si trasforma in debito personale per i fideiussori: la banca può aggredire il patrimonio personale dei soci garanti (case, conti personali). Ad esempio, se il socio ha ipotecato la propria casa a garanzia di un prestito alla società, in caso di insolvenza la banca potrà avviare l’esecuzione ipotecaria sulla casa del socio, separatamente dalle vicende societarie. Durante la composizione negoziata è ora possibile ottenere inibitorie anche su queste azioni: un tribunale ha recentemente bloccato in via cautelare la banca dal escutere la garanzia statale MCC durante le trattative, estendendo la protezione anche a quella fattispecie . Tuttavia, al di fuori di misure protettive concesse, il garante generalmente non è protetto dalle iniziative dei creditori.
- Procedura concorsuale avviata dalla banca: se i debiti verso banche sono rilevanti, l’inadempimento può spingere la banca (o più spesso la società di factoring o di leasing) a presentare istanza di fallimento/liquidazione giudiziale. Storicamente, molti fallimenti d’impresa sono stati chiesti da banche creditorie. La soglia per legittimare un’istanza era modesta (anche insoluti per poche decine di migliaia di euro potevano giustificarla, purché l’insolvenza fosse dimostrabile). Con il CCII, anche le piccole imprese “sotto soglia” possono essere assoggettate a procedure come il concordato minore o la liquidazione controllata su iniziativa del debitore; resta in teoria la possibilità per un creditore di provocare l’apertura di una liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti di insolvenza e dimensionali (v. §2.1 sulle soglie). In qualunque caso, l’attivismo della banca creditrice mette una fortissima pressione sulla società debitrice.
- Ulteriori costi e perdite: il contenzioso bancario comporta spese legali e interessi di mora elevati (talvolta tassi contrattuali più alti in caso di default). Inoltre, la segnalazione a sofferenza può far chiudere le linee di credito anche presso altre banche, per effetto del sistema bancario integrato: l’impresa viene considerata “scoperta” e quindi ogni istituto tende a tirarsi indietro. Ciò crea un effetto domino: una software house che va in sofferenza con una banca rischia di vedersi revocare fidi e affidamenti anche da tutte le altre, ritrovandosi improvvisamente senza liquidità.
Come difendersi dai debiti bancari? Innanzitutto, monitorando attentamente il rapporto con gli istituti di credito: in caso di difficoltà, è meglio comunicare tempestivamente con la banca per concordare un piano di rientro volontario, piuttosto che subire passivamente la revoca dei fidi. Spesso le banche, se vedono collaborazione, possono concedere una moratoria o rinegoziare il piano di ammortamento (es. allungare la durata del mutuo per ridurre la rata). Dal 2020 in poi vari provvedimenti (accordi ABI e norme emergenziali) hanno consentito moratorie sui mutui per PMI in crisi, e una software house potrebbe avervi accesso se in possesso dei requisiti. È importante anche sfruttare eventuali garanzie pubbliche (es. richiedere finanziamenti con garanzia Fondo PMI) che però in caso di insolvenza saranno escusse dallo Stato: ciò non elimina il debito ma cambia il creditore (subentrerà il Mediocredito Centrale o l’erario). Nelle procedure di composizione negoziata e concorsuali, come vedremo, ci sono strumenti per gestire le banche: la moratoria legale (misure protettive) e la possibilità di imporre ristrutturazioni del debito bancario attraverso accordi omologati o concordati, anche contro il parere di eventuali banche dissenzienti (cram-down). Da ultimo, per proteggere il patrimonio personale, è bene evitare per quanto possibile di offrire garanzie personali; se già fornite, il socio garante potrebbe valutare soluzioni sul piano personale (ad esempio accedere a una procedura di sovraindebitamento per liberarsi dalla garanzia residua – v. §6.2). La legge, tuttavia, non consente di scaricare la crisi solo sui garanti: se l’azienda è salvabile, conviene trovare un accordo globale che coinvolga anche la posizione dei fideiussori (magari con un contributo economico di questi nel piano, in cambio della liberazione dalle garanzie).
1.4 Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali
Un’altra categoria tipica di debiti per una software house riguarda i debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi. Ad esempio: fornitori di hardware, licenze software di terzi, servizi cloud, affitto dei locali, consulenti esterni, agenzie di marketing, utenze (energia, telefono), e così via. Essendo aziende di piccole dimensioni, spesso le software house collaborano con freelance o subfornitori (es. sviluppatori a contratto, designer, partner tecnologici): anche questi rientrano tra i creditori in caso di mancato pagamento delle loro fatture.
Le conseguenze del mancato pagamento verso fornitori sono principalmente:
- Sospensione delle forniture o servizi: i fornitori, se non pagati, cessano di fornire beni o prestazioni. Ciò può avere impatto immediato sull’operatività: si pensi al fornitore cloud che disattiva i server per bollette non pagate, o al proprietario dell’ufficio che intima lo sfratto per affitti insoluti. La software house rischia così di non poter più utilizzare strumenti essenziali (hosting, licenze) o di perdere la sede operativa, aggravando ulteriormente la crisi.
- Azioni legali individuali: diversamente da Fisco e banche, i fornitori non hanno privilegi speciali né poteri cautelari automatici, ma possono agire tramite l’autorità giudiziaria per ottenere il dovuto. Il percorso tipico è ottenere un decreto ingiuntivo per le fatture non pagate (spesso immediatamente esecutivo se corredato da estratti autentici delle scritture e solleciti). Ottenuto il titolo, il fornitore procede al pignoramento di conti bancari, crediti presso terzi (ad esempio può pignorare i crediti che la software house vanta verso i propri clienti), oppure attrezzature e beni mobili presenti in sede. Queste azioni esecutive frammentate possono disgregare il patrimonio aziendale: più creditori procedono in ordine sparso, rischiando di saccheggiare i beni migliori (ad es. il server, l’auto aziendale) e lasciando magari irrisolto il debito se il valore ricavato non copre tutto.
- Apertura di procedure concorsuali su iniziativa dei creditori commerciali: un singolo fornitore generalmente ha crediti modesti rispetto a banche o Fisco, ma un gruppo di fornitori insoddisfatti può agire in modo coordinato. È possibile, ad esempio, che più creditori si uniscano nell’istanza di fallimento (ciascuno portando il proprio credito per dimostrare l’insolvenza). In passato, la giurisprudenza ammetteva il cumulo di più crediti di fornitori per superare la soglia di fallibilità e provare lo stato di insolvenza. Con il Codice della crisi, l’accesso alle procedure è più flessibile: anche un imprenditore minore (sotto le soglie) può essere soggetto a concordato minore o liquidazione controllata, ma la legge prevede che siano di regola volontarie (attivate dal debitore). Dunque, i fornitori potrebbero avere meno incentivo a chiedere la liquidazione giudiziale se sanno che l’azienda è “sotto soglia” e otterrebbero solo la liquidazione controllata, procedura accessibile in teoria su ricorso del debitore o su conversione di un concordato minore. Resta il fatto che, se la crisi è grave, anche i fornitori possono esercitare pressione legale notevole.
- Danni reputazionali e contrattuali: una software house inadempiente verso fornitori potrebbe vedere compromessa la propria reputazione nel settore. I partner commerciali potrebbero diffidare a intraprendere nuovi progetti. Inoltre, i clienti più importanti potrebbero temere ripercussioni sui servizi (ad esempio, se i fornitori cloud bloccano i server, i clienti finali della software house ne risentono). Questo può portare a un circolo vizioso: i problemi finanziari interni diventano noti e causano perdita di fiducia del mercato, peggiorando le entrate future. In taluni casi, contratti chiave con clienti contengono clausole risolutive legate allo stato di insolvenza o al coinvolgimento in procedure concorsuali: se un fornitore ottiene un pignoramento, il cliente potrebbe venirne a conoscenza (ad esempio tramite atto di pignoramento presso di sé) e valutare di interrompere il contratto per inaffidabilità.
Difendersi dai debiti verso fornitori implica cercare di negoziare prima che la situazione degeneri. Spesso i fornitori, specialmente se anch’essi PMI, preferiscono trovare un accordo – ad esempio, accettando un pagamento parziale immediato a saldo, o una dilazione – piuttosto che affrontare lunghe cause dal risultato incerto. Una strategia può essere classificare i fornitori per importanza: pagare quelli critici per la continuità (energia elettrica, cloud, licenze vitali) e cercare con gli altri intese di rientro graduale. Attenzione però a non incorrere in pagamenti preferenziali pericolosi: pagare selettivamente alcuni fornitori e lasciarne altri insoluti, se poi si finisce in fallimento entro 6 mesi, espone al rischio di azione revocatoria fallimentare (il curatore può chiedere indietro le somme pagate a quei fornitori privilegiati, se prova la scientia decoctionis). Un modo per mitigare questo è formalizzare un piano di accordo stragiudiziale più generale, magari facendolo attestare (v. piano attestato §3.2) o farlo rientrare in composizione negoziata, ottenendo così la protezione dalle revocatorie . In ogni caso, comunicazione trasparente e buonafede con i fornitori sono fondamentali: avvisare in anticipo delle difficoltà e della volontà di onorare i debiti in modo graduale può preservare rapporti e guadagnare tempo, rispetto a sparire e attendere le ingiunzioni. Se poi la situazione precipita, i debiti fornitori, essendo chirografari (non privilegiati), possono essere inclusi in procedure concorsuali con prospettiva di pagamento parziale: ad esempio, in un concordato preventivo liquidatorio i fornitori potrebbero aspettarsi solo una percentuale (talvolta modesta) del loro credito , ma almeno in tempi definiti e senza dover inseguire singolarmente l’impresa.
1.5 Riepilogo dei tipi di debito e azioni dei creditori
Per riassumere, riportiamo in tabella le principali categorie di debito aziendale, i relativi creditori e le azioni tipiche che questi possono intraprendere contro una software house debitore, nonché le conseguenze per l’impresa e il debitore (incluso l’imprenditore personalmente).
| Tipo di debito | Creditori tipici | Azioni e rischi per il debitore |
|---|---|---|
| Debiti fiscali (imposte, IVA, ritenute) | Agenzia delle Entrate (credito), Agenzia Entrate Riscossione (riscossione) | – Emissione di cartelle esattoriali con sanzioni e interessi di mora elevati. <br>– Fermi amministrativi su veicoli aziendali; ipoteche legali su immobili. <br>– Pignoramenti di conti correnti, crediti verso clienti, beni mobili registrati. <br>– Istanza di fallimento/liquidazione giudiziale se insolvenza conclamata. <br>– Reati tributari per omessi versamenti oltre soglia (es. IVA >250k €, ritenute >150k €) a carico degli amministratori . |
| Debiti contributivi (INPS, INAIL) | INPS, INAIL (creditori), Agenzia Riscossione (riscossione coattiva) | – Avvisi di addebito INPS e cartelle per contributi non versati, con sanzioni civili (interessi e somme aggiuntive). <br>– Pignoramenti su conti e beni come per il Fisco (anche qui con privilegi su beni mobili e immobili ex artt. 2753 c.c.). <br>– Sospensione DURC, impedendo appalti e pagamenti da PA . <br>– Attivazione Fondo di garanzia INPS per TFR e salari (surroga INPS come creditore privilegiato). <br>– Reato omesso versamento contributi > €10.000 annui (azione penale verso il legale rappresentante). |
| Debiti bancari/finanziari (prestiti, mutui, leasing) | Banche; società leasing; factor; cessionari crediti | – Revoca fidi e affidamenti in c/c (segnalazione a Centrale Rischi come sofferenza, peggioramento merito creditizio) . <br>– Decadenza dal termine su mutui: richiesta immediata dell’intero debito residuo. <br>– Decreto ingiuntivo rapido e pignoramenti (conti, crediti, beni dati a leasing: es. se server in leasing, sequestro immediato). <br>– Escussione di garanzie: fideiussioni personali dei soci (aggrediti beni personali), garanzie statali (MCC) – in composizione negoziata si può bloccare in via d’urgenza l’escussione . <br>– Istanza di procedura concorsuale (spesso banche o leasing chiedono il fallimento se il debito è ingente e non garantito integralmente). |
| Debiti verso fornitori (commerciali, affitti, utenze) | Fornitori vari (B2B), locatori immobili, utility | – Sospensione forniture/servizi: interruzione immediata di forniture essenziali (es. cloud, licenze, utenze) con danno operativo. <br>– Decreti ingiuntivi per fatture non pagate; azioni esecutive singole (pignoramento conti, magazzino, attrezzature) – rischio disgregazione beni e attività. <br>– Danneggiamento reputazione: perdita fiducia fornitori (richieste pagamento anticipato in futuro) e clienti (timore di default azienda). <br>– Possibile azione collettiva: gruppi di fornitori presentano istanza di insolvenza (specie se debiti diffusi e impresa “in fuga”). <br>– Nessun privilegio in caso di concorso: se si arriva a procedura, sono crediti chirografari (rischio forte decurtazione nel concordato, es. possibili pagamenti <20%). |
| Debiti verso il personale (stipendi, TFR) | Dipendenti; collaboratori; sindacati (in rappresentanza) | – Vertenze di lavoro: ingiunzioni per stipendi non corrisposti (titolo immediatamente esecutivo ex art. 409 c.p.c.), con pignoramenti e privilegio generale sui beni mobili. <br>– Dimissioni in massa: perdita di forza lavoro chiave (sviluppatori, tecnici) se non pagati, con rischio paralisi progetti. <br>– Intervento INPS: per fallimento/liquidazione, INPS paga TFR e ultime 3 mensilità ai dipendenti e poi si surroga come creditore privilegiato. <br>– Possibile reato: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sui salari è penale (>€10k/anno); anche gli stipendi non pagati reiteratamente possono configurare violazioni (es. appropriazione indebita se trattenute sindacali non versate). |
Nota: I creditori privilegiati (Erario, INPS, lavoratori) in caso di procedura concorsuale devono essere soddisfatti nei limiti del valore di liquidazione dei loro beni collaterali o prelazioni. I creditori chirografari (es. fornitori non garantiti) ricevono solo l’eventuale eccedenza di attivo, spesso pochi centesimi per euro di credito. Per questo in molti concordati liquidatori la percentuale ai chirografari è bassa (la legge richiede almeno il 20% nei concordati liquidatori ordinari, salvo alcune eccezioni ).
2. Valutazione iniziale della crisi: capire gravità e soluzioni possibili
Quando una piccola software house accumula debiti su più fronti, è fondamentale valutare con precisione la situazione di crisi prima di intraprendere qualunque azione. Questa sezione spiega come identificare lo stato di crisi o insolvenza dell’azienda e quali considerazioni fare per scegliere la strategia più adatta (risanamento o liquidazione).
2.1 Stato di crisi vs insolvenza: definizioni e indici
Il CCII distingue tra “crisi” e “insolvenza” dell’impresa (art. 2 CCII). In parole semplici:
- Lo stato di crisi è una situazione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza futura se non si interviene . Può manifestarsi come carenza di liquidità prospettica, margini operativi negativi, erosione del patrimonio, difficoltà nel rispettare regolarmente le scadenze. È dunque una fase incipiente, un campanello d’allarme che l’impresa potrebbe non farcela in futuro. Ad esempio, una software house che negli ultimi mesi ha sistematicamente pagato fornitori e tasse in ritardo perché i flussi di cassa dai clienti sono insufficienti, è verosimilmente in “crisi” anche se non completamente insolvente ad oggi.
- Lo stato di insolvenza è invece l’incapacità attuale dell’impresa di soddisfare regolarmente le obbligazioni, per mancanza di mezzi liquidi o capaci di trasformarsi in liquidi prontamente (art. 2, co. 1, lett. b CCII). È la situazione in cui i debiti scaduti rimangono impagati e l’azienda non ha risorse o credito per fronteggiarli. Ad esempio, se la software house ha i conti pignorati, niente cassa e magazzino inesistente (solo immobilizzazioni immateriali non liquidabili subito), e accumula arretrati con tutti, è insolvente. L’insolvenza è la condizione per l’apertura delle procedure concorsuali “giudiziali” come il fallimento (ora liquidazione giudiziale) o il concordato preventivo ordinario.
Il confine può non essere netto: spesso la crisi peggiora gradualmente fino a sfociare in insolvenza conclamata. Il CCII inoltre introduce il concetto di “insolvenza probabile” o “rischio di insolvenza”, e incoraggia ad agire già in quella fase (ad esempio con la composizione negoziata si può intervenire prima di essere insolventi, anche solo in presenza di “squilibrio” e insolvenza prospettica) .
Indicatori di crisi e obblighi organizzativi
La normativa italiana oggi impone agli amministratori di dotare la società di “assetti organizzativi adeguati” (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.) anche per rilevare per tempo gli indizi di crisi. Questo significa che anche una piccola impresa dovrebbe tenere sotto controllo alcuni indicatori utili a prevedere tensioni finanziarie, ad esempio:
- DSCR (Debt Service Coverage Ratio): rapporto tra flussi di cassa attesi e debiti finanziari in scadenza a breve. Un DSCR < 1 è segnale di possibile crisi (non genera abbastanza cassa per pagare i debiti prossimi).
- Indicatori di bilancio: margini operativi (EBITDA, EBIT) negativi o in forte calo, capitale netto che tende a zero o negativo (erosione per perdite), indice di liquidità (current ratio) < 1, eccessivo indebitamento (debt/equity molto alto).
- Andamento settore e portafoglio ordini: per una software house, la perdita di un cliente importante o il fallimento di partner chiave potrebbe preludere a difficoltà future.
- Insoluti su pagamenti correnti: ad esempio i primi ritardi nel versare IVA o contributi, o i primi sconfinamenti di conto, vanno letti come allarmi.
Gli amministratori hanno l’obbligo di attivarsi senza indugio appena emergono segnali di crisi. Il mancato tempestivo intervento può costituire colpa grave e portare a responsabilità per aggravamento del dissesto (sanzionabile come “bancarotta semplice” in caso di fallimento) . La Cassazione ha di recente confermato la condanna di un amministratore proprio per aver proseguito l’attività accumulando debiti, nonostante l’inesigibilità dei crediti vantati rendesse irreversibile la crisi . In altre parole, trascinare un’impresa decotta sperando in un miracolo è contrario ai doveri di corretta gestione e può costare caro in tribunale. Al contrario, attivarsi precocemente può offrire più soluzioni di risanamento e anche, in caso di esito negativo, essere valutato come elemento di buona fede (utile per ottenere l’esdebitazione o evitare accuse di mala gestio) .
Soglie dimensionali e qualificazione dell’impresa
In passato (legge fallimentare), solo l’imprenditore commerciale “non piccolo” poteva essere dichiarato fallito. Esistevano tre parametri: attivo di €300.000, ricavi €200.000, debiti €500.000; se non superavi almeno 2 su 3 negli ultimi esercizi, eri “piccolo” e quindi esonerato dal fallimento. Oggi, con il CCII, la situazione è cambiata:
- Il fallimento è stato sostituito dalla liquidazione giudiziale, riservata agli imprenditori sopra soglia (art. 121 CCII, requisiti simili ai precedenti).
- Tuttavia sono state introdotte procedure anche per i “sotto soglia”: il concordato minore e la liquidazione controllata (capo dedicato del CCII per la crisi da sovraindebitamento). Inoltre, il nuovo concordato semplificato post-composizione negoziata è accessibile a qualsiasi imprenditore, anche piccolo o agricolo .
- Ciò significa che anche una micro software house (es. una SRL con ricavi sotto €200k) che prima non poteva accedere al concordato preventivo, oggi può attivare strumenti di regolazione della crisi (concordato minore se volontario, o liquidazione controllata se vuole liquidare il patrimonio) .
- I creditori tuttavia non possono chiederne la liquidazione giudiziale se rimane “sotto soglia” (perché quella è riservata ai soggetti maggiori), ma in teoria rimane la difficoltà: se l’impresa è sotto soglia, i creditori dovrebbero attenderne l’iniziativa (o forzare procedendo esecutivamente sui beni individuali).
- In pratica, il legislatore ha voluto estendere le tutele concorsuali a tutti i debitori, senza zone franche: l’artigiano o la piccola software house che prima poteva sparire lasciando debiti ora deve anch’essa confrontarsi con procedure di composizione o insolvenza (volontarie, assistite dagli OCC – Organismi di Composizione della Crisi). Resta però un dualismo: il concordato preventivo “ordinario” e la liquidazione giudiziale sono per i soggetti di maggiori dimensioni, mentre il concordato minore e la liquidazione controllata sono per i sottosoglia e professionisti.
Per l’imprenditore è importante capire dove si colloca: se la software house è una SRL con discreti ricavi e debiti > €500k, potrebbe rientrare fra i fallibili ordinari; se è molto piccola, le procedure disponibili saranno quelle “minori”. Ad ogni modo, come vedremo, gli strumenti sono simili nei principi (tutti mirano o a risanare o a liquidare con esdebitazione) e la scelta dipenderà più dalla sostenibilità del business che dal mero dato dimensionale.
2.2 Salvare l’azienda o liquidarla? – Analisi di fattibilità
Una volta compresa la severità della crisi, la domanda cruciale per il debitore è: esistono prospettive reali di risanamento della software house, oppure è inevitabile la cessazione dell’attività e la liquidazione dei beni? Da questa valutazione dipende l’approccio da seguire.
Fattori da considerare per valutare il risanamento:
- Competitività e prospettive di mercato: la software house ha prodotti/servizi validi e richiesti? Ha un portafoglio clienti fidelizzato o contratti in corso che genereranno ricavi futuri? Se l’azienda è ancora competitiva (magari ha solo un problema finanziario temporaneo), vale la pena tentare di salvarla. Se invece il suo prodotto è obsoleto o ha perso mercato, salvarla potrebbe essere inutile accanimento.
- Cause della crisi rimuovibili: occorre identificare le cause del dissesto. Ad esempio: progetti chiave andati male, ritardi nei pagamenti da grossi clienti (cash flow crunch), costi fissi troppo alti, investimenti errati. Se tali cause sono rimediabili (si può tagliare qualche costo, si può recuperare crediti, trovare nuovi soci, ecc.), il risanamento è praticabile. Se invece la causa è strutturale (es. modello di business sbagliato, tecnologia superata, perdita irreversibile di reputazione), la crisi è difficilmente sanabile.
- Disponibilità di risorse fresche: spesso per risanare serve nuova finanza: i soci possono apportare capitali? Ci sono investitori interessati (business angel, venture capital) disposti a subentrare rilevando quote? O la società possiede asset vendibili non strategici (un immobile, partecipazioni) per fare cassa? Senza risorse nuove, qualsiasi piano di ristrutturazione rischia di essere solo teorico. La legge incentiva nuovi apporti nei piani di concordato (richiede spesso un apporto esterno almeno del 10% dell’attivo nel concordato liquidatorio ).
- Entità del debito e sostenibilità in un piano: bisogna fare un business plan prospettico e vedere se l’azienda, ristrutturata, sarebbe in grado di pagare almeno in parte i debiti in un orizzonte ragionevole (di solito 3-5 anni in un concordato). Se il monte debiti è sproporzionato rispetto alla capacità di generare cassa, il risanamento potrebbe non essere fattibile se non falcidiando fortemente i crediti (cosa possibile solo con procedure omologate). Ad esempio, se la software house ha debiti totali per €1 milione ma genera utile lordo annuale di €50k, anche spalmando in 5 anni non coprirebbe che una frazione – salvo un taglio ai debiti o nuovi ricavi straordinari.
- Impatto occupazionale e know-how: una software house “vive” del know-how dei suoi tecnici e sviluppatori. Liquidare l’azienda significa disperdere quel patrimonio umano (oltre che lasciare a casa il personale). Se il team è valido e la società ha progetti innovativi in corso, c’è un valore intangibile che andrebbe perso con la chiusura. Questo può far propendere per un tentativo di continuità, magari con un concordato in continuità aziendale (cioè proseguendo l’attività mentre si paga il debito parzialmente). Viceversa, se l’organico si è già dissolto (dipendenti licenziati o dimessi) e non c’è più capacità produttiva interna, la continuità potrebbe essere già compromessa.
- Responsabilità personali e vantaggi delle procedure: occorre anche valutare il punto di vista dell’imprenditore/soci. Se la società è insolvente e non si fa nulla, i creditori aggrediranno comunque i beni (anche personali se garantiti) e alla fine l’impresa cesserà disordinatamente. Invece utilizzare una procedura concorsuale può dare benefici come: protezione dai creditori, esdebitazione (liberazione dei debiti residui) a fine procedura, e riduzione del rischio di azioni di responsabilità contro gli amministratori (un concordato evita il fallimento e quindi in parte anche l’accertamento giudiziale delle responsabilità). Pertanto a volte conviene avviare una procedura ordinata anche se si è destinati alla liquidazione, perché la si fa in modo controllato e con esdebitazione, piuttosto che subire centinaia di cause ed esecuzioni.
Decisione risanamento vs liquidazione: Se dalla valutazione risulta che l’azienda ha concrete prospettive di risanamento – ossia può tornare in bonis eliminando una parte dei debiti e ristrutturando l’organizzazione – allora si punterà a strumenti come la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione o il concordato in continuità (ordinario o minore). Invece, se si conclude che l’azienda è decotta senza rimedio, la scelta razionale è prepararsi a una liquidazione ordinata. Ciò può avvenire tramite concordato liquidatorio (ordinario o semplificato) oppure, se non c’è accordo, attraverso la liquidazione giudiziale/controllata con nomina di un liquidatore o curatore terzo.
Va sottolineato che il CCII incoraggia comunque di attivarsi (anche solo con la composizione negoziata) prima che l’insolvenza diventi conclamata. Anche se alla fine ci si indirizzerà verso la liquidazione, aver tentato in buona fede un percorso di composizione è considerato positivamente e può facilitare poi l’accesso a strumenti come l’esdebitazione . Inoltre, il legislatore ha introdotto il “concordato semplificato” proprio come opzione rapida per liquidare i beni sotto controllo del tribunale, quando la via del risanamento è preclusa . In pratica, l’imprenditore onesto che non è riuscito a salvare l’azienda in trattativa, può proporre un concordato semplificato e evitare così il fallimento tradizionale, chiudendo più velocemente la vicenda .
Esempio: Una software house con 10 dipendenti, specializzata in sviluppo app mobile, perde il suo cliente principale che rappresentava il 50% del fatturato. Si trova con €300k di debiti accumulati (Fisco, banche, fornitori) e flussi dimezzati. Analisi: il mercato delle app è ancora buono, il team è competente (vale la pena salvarlo), forse diversificando i clienti l’azienda può riprendersi. La crisi è dovuta a dipendenza da un cliente, quindi potenzialmente superabile. In questo caso, tentare un risanamento ha senso: magari cercando un socio finanziatore o un partner commerciale che apporti nuovi contratti, e nel frattempo ristrutturando i debiti su più anni. Si potrebbe avviare una composizione negoziata per congelare i creditori e concordare nuovi termini (o un concordato in continuità se serve). Al contrario, consideriamo un’altra software house che produce software gestionale obsoleto, ha perso tutte le commesse, i 5 programmatori migliori se ne sono andati e resta solo il titolare ultra-indebitato con €200k di debiti e praticamente zero ricavi attesi. Qui mantenere in vita l’azienda non ha prospettiva: meglio chiudere, magari vendere quel poco di IP (proprietà intellettuale) rimasta a qualche concorrente, e usare il ricavato per pagare qualcosa ai creditori. In tal caso, un concordato semplificato liquidatorio (cessione degli asset residui) o direttamente la liquidazione controllata potrebbero essere la scelta. Il titolare potrà poi cercare l’esdebitazione e magari ripartire in un nuovo progetto imprenditoriale su basi diverse.
3. Soluzioni stragiudiziali per gestire i debiti (negoziazione privata)
Se dall’analisi emerge che la software house ha chance di sopravvivenza, oppure se si vuole comunque evitare la rigidità delle procedure giudiziarie, il primo approccio consigliabile è tentare di sistemare i debiti fuori dal tribunale, in via stragiudiziale. Questa sezione esamina gli strumenti negoziali e privatistici a disposizione del debitore per ristrutturare i debiti senza ricorrere (almeno inizialmente) a una procedura concorsuale formale. Tali strumenti includono: la rinegoziazione diretta con i creditori (accordi individuali, moratorie), i piani di rientro rateali (specie con Fisco e INPS), eventuali operazioni finanziarie di rifinanziamento, e istituti di maggior sofisticazione come il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII.
L’uso di soluzioni stragiudiziali richiede però consenso dei creditori: non c’è l’intervento del giudice a imporre tagli o standstill, quindi l’efficacia dipende dalla disponibilità delle controparti. Vediamo nel dettaglio.
3.1 Trattative dirette e accordi stragiudiziali con i creditori
La via più immediata per difendersi dai creditori è parlare con loro. Spesso, specialmente quando i creditori sono molteplici, questi non hanno una visione d’insieme e ciascuno agisce per conto proprio (il che può portare al collasso dell’impresa e alla perdita per tutti). Un imprenditore accorto può provare a riunire i principali creditori attorno a un tavolo e proporre un accordo di ristrutturazione stragiudiziale, ad esempio articolato così:
- Moratoria sui pagamenti: chiedere ai creditori di sospendere temporaneamente azioni legali ed esecutive e di congelare le scadenze per alcuni mesi, mentre si elabora un piano di risanamento o si cercano risorse. Questo è spesso il primo passo per prendere fiato.
- Dilazione del debito: proporre un calendario di rientro a medio termine (es: pagamenti mensili/trimestrali nell’arco di 2-3 anni) anziché l’immediato saldo. Molti creditori preferiscono incassare gradualmente piuttosto che rischiare di innescare un fallimento e recuperare molto meno.
- Taglio (stralcio) parziale: convincere i creditori a rinunciare a una parte del credito in cambio di un pagamento parziale immediato. Tipico il caso: “vi pago subito il 50% a saldo e stralcio”. Ciò attrae il creditore se teme di recuperare ancora meno attendendo. Ovviamente, servono liquidità pronte per fare queste offerte: l’azienda deve magari farsi prestare i fondi dai soci o vendere un asset.
- Conversione del debito in capitale: in casi avanzati, un creditore potrebbe accettare di diventare socio (equity) invece di creditore, convertendo il proprio credito in quote/azioni della software house. Questo avviene soprattutto con investitori finanziari o fornitori strategici interessati a mantenere in vita l’impresa. La conversione allevia il bilancio (debiti che spariscono) ma diluisce le quote dei soci originari.
- Accordi bilaterali riservati: con alcuni creditori si possono stipulare patti individuali, ad esempio una transazione col fisco tramite adesione a un istituto definitorio, oppure un accordo col fornitore strategico in cui il debito viene ridotto in cambio di un contratto futuro (una sorta di compensazione indiretta).
Vantaggi di una soluzione stragiudiziale: è informale, rapida e riservata (non diventa di pubblico dominio come un concordato). L’impresa rimane in controllo totale. Non c’è la pubblicità negativa di una procedura concorsuale. Si evitano i costi di tribunale e curatori/commissari. Inoltre, la negoziazione creativa consente soluzioni flessibili (es. baratto di beni, accordi commerciali) che nei tribunali sarebbero complicate.
Svantaggi e limiti: non c’è alcun vincolo per i dissenzienti. Anche se il 90% dei creditori accetta, basta un creditore rilevante che rifiuta per far fallire l’intera ristrutturazione. Soprattutto, manca un meccanismo di stay legale: se un creditore vuole aggredire l’azienda durante le trattative, può farlo (a meno di aver ottenuto da lui un accordo di standstill). Questo rende fragile la posizione del debitore: uno può fare da free rider e pignorare mentre gli altri trattano. C’è poi la questione revocatoria: i pagamenti fatti ai creditori in questo contesto, se l’azienda poi fallisce entro 6 mesi, possono essere revocati dal curatore (pagamenti di debiti scaduti) come atti preferenziali. Questo spaventa i creditori: se accettano un pagamento ridotto stragiudiziale e poi l’impresa fallisce, rischiano di dover restituire quelle somme alla massa. Una tutela in tal senso è formalizzare l’accordo stragiudiziale in un piano attestato di risanamento e registrarlo (v. §3.2): in tal caso i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano attestato non sono revocabili . Ciò offre maggiore certezza ai creditori aderenti.
Approccio pratico: conviene focalizzarsi sui creditori chiave (quelli il cui consenso è indispensabile per evitare il fallimento). Ad esempio, se c’è un grosso debito con la banca e col fisco, è prioritario negoziare con loro. I piccoli creditori magari seguono a ruota se vedono che i “grandi” hanno accettato un piano. È saggio predisporre un mini-piano finanziario da condividere: uno schema di come in 2-3 anni l’azienda genererà cassa e ripagherà le quote promesse. Ciò aumenta la credibilità. Può essere utile farsi affiancare da un advisor finanziario o legale nelle trattative, per dare un tono più serio e rassicurante (i creditori vedono che l’impresa ha consulenti e sta affrontando professionalmente la crisi). Inoltre, se la tensione è elevata, spesso l’annuncio che l’azienda valuta un concordato può spingere i creditori a preferire un accordo stragiudiziale (per evitare di finire in tribunale dove potrebbero incassare meno). Questa è quasi una strategia “del bastone e della carota”: o accettate questo piano bonario, oppure sarò costretto a fare un concordato/fallimento e probabilmente prenderete poco o nulla.
Conclusione: La negoziazione privata è sempre il primo tentativo: se funziona, è la soluzione meno traumatica. Ma il debitore deve avere un piano credibile e un forte potere di persuasione. Se i creditori non si fidano o sono troppi e non coordinabili, allora occorre passare agli strumenti semi-giudiziali o giudiziali, dove interviene l’autorità a imporre la ristrutturazione (v. sezioni successive).
3.2 Rateizzazioni e definizioni agevolate di debiti fiscali e contributivi
Tra gli strumenti stragiudiziali, un ruolo importante è giocato dalle dilazioni di pagamento concesse per legge dai principali enti creditori pubblici. In particolare:
- Rateazione cartelle esattoriali (Agenzia Entrate-Riscossione): la normativa consente al debitore di chiedere un piano di dilazione dei debiti iscritti a ruolo. Attualmente, per debiti fino a €120.000 è concessa automaticamente una rateazione fino a 72 rate mensili (6 anni) con semplice autocertificazione dello stato di difficoltà . Per importi superiori, occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, e l’ente può concedere fino a 6 anni (72 rate) o nei casi di comprovata e grave difficoltà, fino a 120 rate mensili (10 anni). Le rateazioni consentono di bloccare le azioni esecutive dell’Agente della Riscossione, finché il piano viene rispettato. Attenzione: se la società salta 5 rate, la rateazione decade automaticamente e l’intero debito residuo torna esigibile in un colpo solo, con ripresa delle azioni esecutive. Inoltre, se successivamente viene aperta una procedura concorsuale, tutte le rateazioni in essere decadono a meno che il debito residuo non sia inserito nella procedura . Quindi, se si prospetta un concordato, meglio includere i debiti fiscali nel piano di concordato anziché confidare nella prosecuzione della dilazione esterna.
- Dilazione diretta contributi INPS: analogamente, l’INPS può concedere rateizzazioni dei crediti contributivi fuori ruolo (es. contributi correnti non versati). La durata tipica è 24 mesi, estendibile fino a 36-60 mesi in casi di crisi aziendale e previo rispetto di condizioni (piano di rientro). Anche qui, il mancato pagamento di alcune rate comporta decadenza e ripresa del recupero integrale.
- Definizioni agevolate (“rottamazioni”): negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure straordinarie che permettono di definire i debiti con l’erario risparmiando su sanzioni e interessi. Ad esempio: la “rottamazione-ter” (D.L. 119/2018) e la recente “rottamazione-quater” (L. 197/2022) hanno permesso ai debitori di pagare le cartelle senza sanzioni né interessi di mora (solo capitale + interessi legali) in 18 rate. Se la software house rientrava tra i beneficiari e ha presentato domanda, può ridurre significativamente il carico fiscale. Tali misure tuttavia non tagliano il capitale dovuto (non c’è stralcio delle imposte) e richiedono di pagare regolarmente tutte le rate: se si decade da una rottamazione, non si può più dilazionare quelle somme. Nel 2023 è stata prevista anche la definizione agevolata dei debiti INPS sotto €1.000 affidati all’agente pubblico (saldo e stralcio con esclusione sanzioni). Queste opportunità vanno colte entro termini tassativi di legge.
- Transazioni extragiudiziali coi creditori privati: pur senza valore legale erga omnes, la società può siglare accordi di rientro scritti con singoli fornitori o banche, in cui si pattuisce la rateazione del debito o la riduzione. Tali accordi, se ben congegnati, possono prevedere clausole di riservatezza (per non allarmare altri creditori) e clausole risolutive (se salta una rata, il creditore può agire subito). Sono contratti a tutti gli effetti, vincolanti tra le parti. Un esempio: la software house firma con un fornitore un piano di rientro da €100k in 24 mesi, riconoscendo il debito e obbligandosi a pagare 24 rate; il fornitore accetta di non procedere legalmente finché le rate sono puntuali e magari di rinunciare a 10k di interessi se tutto va bene. Questo accordo, se l’azienda lo onora, evita cause. Il rischio è che, essendo bilaterale, se poi la società entra in concordato o fallisce, quel creditore sarà stato trattato diversamente dagli altri (questo può sollevare questioni di revocatoria per i pagamenti fatti, se non protetto da un piano attestato pubblicato).
Considerazioni utili: prima di passare a misure drastiche, il debitore dovrebbe esaminare tutte le opzioni di dilazione e agevolazione disponibili e fare un calendario integrato. Ad esempio, potrebbe risultare che rateizzando in 6 anni le cartelle e ottenendo una moratoria di 1 anno dai fornitori, l’azienda può sopravvivere senza procedure. Oppure, se c’è una rottamazione in corso, conviene rispettarla perché offre uno sconto su sanzioni non ottenibile altrove. Tuttavia, bisogna anche prevedere il caso in cui nonostante le dilazioni la situazione peggiori: se l’impresa entra comunque in crisi, come detto, le rateazioni decadono se non vengono inglobate in una procedura.
In definitiva, le rateazioni e le definizioni agevolate sono strumenti importanti per prendere tempo e ridurre il peso degli oneri accessori. Un uso intelligente di queste possibilità (ad esempio chiedere subito la rateazione appena arriva una cartella, per evitare pignoramenti, oppure aderire alle rottamazioni entro le scadenze di legge) può alleggerire la pressione sui flussi di cassa e dare spazio al risanamento. Ma va ricordato che sono misure unilaterali (concesse dall’ente pubblico) che non risolvono se la struttura del debito è insostenibile: se il debito è troppo alto per le capacità dell’impresa, serve comunque una ristrutturazione più profonda, coinvolgendo tutti i creditori in un disegno unico.
3.3 Rifinanziamento e apporto di nuovi capitali
Parallelamente alla gestione negoziale dei debiti, un pilastro di ogni piano di salvataggio è procurarsi nuove risorse finanziarie. Una software house, trovandosi stretta dai debiti, può cercare denaro fresco tramite:
- Nuovo finanziamento bancario o da investitori: opzione difficile se l’azienda è già in crisi, perché banche e investitori tendono a non prestare a soggetti insolventi. Tuttavia, esistono fondi o operatori specializzati nel finanziamento in distressed (a tassi elevati e con garanzie). Con la composizione negoziata, per esempio, la società può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile (che sarà rimborsato prima degli altri debiti, se l’azienda poi fallisce), per sostenere il piano . Ciò rende più appetibile per un finanziatore concedere credito in crisi. Inoltre alcune regioni/stato offrono fondi di salvataggio per PMI in crisi temporanea.
- Apporti dei soci (equity o quasi-equity): i soci attuali possono decidere di mettere altro capitale nell’azienda, se credono nel rilancio. Possono farlo come aumento di capitale (migliore per i creditori, perché rafforza il patrimonio netto) o come finanziamento soci (prestito da restituire, ma attenzione: in caso di fallimento è postergato). Spesso, nei concordati, si prevede un contributo dei soci a fondo perduto per garantire una percentuale minima ai creditori . Ad esempio, i soci potrebbero versare €50.000 per pagare in parte i creditori, ottenendo in cambio magari di mantenere la guida dell’azienda risanata.
- Vendita di asset non strategici: un modo per fare cassa è vendere beni che non servono al core business. Nel caso di una software house, gli asset tangibili sono pochi (hardware, magari un immobile se possiede la sede). Più frequentemente si può cedere un ramo d’azienda o un progetto. Ad esempio: vendere a una società terza la proprietà di un software sviluppato internamente, mantenendo magari una royalty sulle vendite future. Oppure cedere una partecipazione detenuta. Bisogna valutare bene il valore: vendere in fretta può portare a ricavare meno del reale valore. Con l’autorizzazione del tribunale (in composizione negoziata o in concordato in bianco) si può effettuare la vendita di beni senza incorrere in revocatoria , quindi è consigliabile passare dal tribunale in questi casi. La competitività dell’operazione va garantita (meglio fare una gara o sollecitare più offerte).
- Strumenti di garanzia del credito esistenti: ad esempio, se l’azienda ha crediti verso clienti, può anticiparli o cederli (factoring). Se ha magazzino o contratti futuri, può usarli come garanzia per ottenere liquidità (pledge su crediti futuri). Queste operazioni però spesso aggravano la posizione (perché si incassa subito ma poi mancherà quell’attivo).
- Riduzione costi e personale: non è proprio “entrata di capitali”, ma ridurre drasticamente i costi può equivalere a recuperare risorse. Ad esempio attivare la cassa integrazione guadagni (se accessibile) per i dipendenti in esubero consente di risparmiare liquidità mentre si riorganizza.
Nota: In composizione negoziata, come vedremo, esiste un incentivo: se la negoziazione riesce e si conclude con un accordo, l’esperto nominato ottiene un compenso raddoppiato, mentre se fallisce no . Inoltre l’impresa ha diritto a un credito d’imposta sulle spese di consulenza per il piano di risanamento entro certi limiti (misura introdotta nel 2021 per incoraggiare l’uso di professionisti). Quindi potrebbe esserci anche un leggero sostegno pubblico alle spese di ristrutturazione.
3.4 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Tra le soluzioni stragiudiziali merita un approfondimento il piano attestato di risanamento, previsto dall’art. 56 CCII (che ricalca l’ex art. 67, co. 3, lett. d) L.F.). È uno strumento ibrido: privatistico (non c’è omologazione né intervento del tribunale) ma con alcuni effetti legali rilevanti.
Caratteristiche del piano attestato:
- È un piano industriale e finanziario che l’imprenditore elabora con l’obiettivo di risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione economico-patrimoniale dell’impresa . In pratica, un documento che descrive la strategia di rilancio: come verranno ristrutturati i debiti, quali misure di efficientamento, quali ricavi futuri attesi.
- Deve essere attestato da un professionista indipendente (iscritto a Registro revisori o con requisiti ex art. 2 CCII) che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . Questa relazione di attestazione è fondamentale per dare credibilità e per attivare le protezioni di legge.
- Il piano può anche includere accordi con alcuni creditori (ad esempio banche che sottoscrivono nuovi patti di rientro, fornitori che accettano stralci). Tuttavia non vincola i creditori estranei: è essenzialmente un contratto privato tra l’impresa e ciascun creditore che vi aderisce . Non c’è effetto erga omnes; un creditore che non firma rimane libero nelle sue pretese.
- Deve essere pubblicato nel registro delle imprese per produrre uno specifico effetto: gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . Questo scudo anti-revocatoria (art. 56, co. 3 CCII) è il grande vantaggio del piano attestato: i pagamenti fatti ai creditori secondo il piano non potranno essere “richiamati indietro” dal curatore se poi l’azienda fallisce. Ciò dà tranquillità ai creditori aderenti e agli investitori.
- Non prevede alcun intervento del tribunale: zero pubblicità (a parte la pubblicazione al Registro Imprese che però è “meno visibile” di una procedura concorsuale) e nessun commissario. Quindi l’azienda evita lo stigma e continua ad operare serenamente.
Contenuto tipico del piano attestato: In pratica un piano attestato ben fatto comprende varie sezioni, come indicato dalla prassi :
- Premessa e obiettivi: dichiarazione d’intenti (es. ridurre debiti del 50% e tornare liquidi in 3 anni).
- Descrizione dell’azienda e cause della crisi: analisi di cosa è andato storto (es. calo di fatturato per COVID, investimenti sbagliati, ecc.).
- Situazione economico-patrimoniale: dati di bilancio attuali, entità dei debiti per categoria (banche, fornitori, Erario).
- Indicatori di crisi: esporre eventuali indicatori (flussi di cassa, DSCR, indici negativi).
- Business plan di rilancio: quali azioni concrete per tornare in utile (riduzione costi, nuovi prodotti, marketing).
- Manovra finanziaria: qui la parte cruciale – come si intende trattare con ciascun gruppo di creditori. Esempio: “banche: consolidamento prestiti su 5 anni con interessi ridotti; fornitori: saldo 70% debito in 12 mesi; Erario: richiesta dilazione e stralcio sanzioni attraverso transazione fiscale; nuovi apporti dei soci per €XX; eventuale cessione ramo d’azienda non core per €YY” .
- Proiezioni finanziarie: cash flow previsionali a 5 anni con scenari ottimistico/base/pessimistico.
- Attestazione finale del professionista: la relazione di attestazione che afferma che i dati sono veritieri e che il piano è fattibile e idoneo a risanare (quest’ultima frase è chiave: l’attestatore deve poter dire che se tutto va come nel piano, l’azienda torna in bonis).
- Documenti legali allegati: riferimenti normativi (art. 56 CCII) e dichiarazione di pubblicazione, eventuali condizioni sospensive (es. efficacia del piano se tutte le banche aderiscono).
Vantaggi principali del piano attestato:
- Nessuna procedura formale: l’azienda evita l’onta di un concordato, e può tenerlo riservato (lo conoscono solo i creditori coinvolti, oltre alla pubblicazione RI che però non ha la risonanza di un fallimento).
- Protezione da revocatorie: come detto, i pagamenti fatti in esecuzione del piano e le garanzie concesse non saranno revocabili . Questo significa che i creditori possono accettare pagamenti dilazionati o parziali con la sicurezza di non doverli restituire se successivamente l’impresa dovesse comunque fallire. È un incentivo forte ad aderire, specie per le banche.
- Flessibilità: il piano può prevedere qualsiasi soluzione, non essendoci le rigidità delle classi, del voto, ecc. Si può anche decidere di soddisfare diversamente vari creditori senza dover rispettare strettamente la par condicio (di fatto fai accordi singoli). Basta che chi aderisce sia d’accordo.
- Tempo guadagnato senza interferenze: non c’è un giudice che incalza con scadenze per depositare documenti o pagare contributi; i tempi li governa l’impresa (anche se realisticamente, l’attestatore non attesterà un piano troppo lungo e vago: serve comunque concretezza entro un paio d’anni di orizzonte).
Svantaggi e rischi del piano attestato:
- Nessuna tutela verso creditori non aderenti: se c’è un creditore importante che non firma il piano, è libero di agire per vie legali. Il piano attestato non offre alcuna moratoria legale generale. Non a caso, spesso il piano attestato funziona con pochi creditori, magari uno o due banche e pochi fornitori. Se ce ne sono tanti, diventa improbo avere l’accordo di tutti. Laddove serve vincolare una minoranza dissenziente, il piano attestato “non basta” e si dovrà optare per un accordo di ristrutturazione o un concordato omologato.
- Nessun blocco automatico delle azioni esecutive: come detto, se un estraneo vuole attaccare, può farlo. Per questo in alcuni casi si combina il piano attestato con la composizione negoziata: la composizione offre il ombrello protettivo (misure protettive) e la figura dell’esperto per trattare, e può sfociare in un piano attestato come output . Infatti nulla vieta che, durante la composizione negoziata, l’imprenditore elabori un piano di risanamento attestato e faccia firmare i creditori; conclusa la composizione, deposita il piano attestato firmato e beneficia subito della protezione anti-revocatoria. L’esperto nominato potrebbe addirittura essere lo stesso che poi firma l’attestazione come professionista (se ha i requisiti di indipendenza richiesti), per dare continuità .
- Non impone sacrifici se non consensuali: un creditore può dire di no e chiedere il 100% in tribunale. Per questo il piano attestato è adatto quando la platea creditoria è limitata e ragionevolmente cooperativa (es: 3 banche che preferiscono ristrutturare il debito, e pochi fornitori di importo marginale), oppure come cornice integrativa di un percorso semigiudiziale.
- Revocatoria differita: se poi l’impresa non rispetta il piano attestato e finisce in fallimento, ovviamente i pagamenti fatti al di fuori del piano restano revocabili, e il fatto di aver tentato un piano non evita eventuali azioni di responsabilità se era chiaro che non poteva funzionare (il piano maldestro potrebbe essere visto come aggravamento del dissesto se ha comportato costi inutili).
- Costi dell’attestazione: pur non avendo costi di procedura, c’è il costo del professionista attestatore (spesso un commercialista esperto di crisi), che vorrà compenso. Ma è di solito inferiore ai costi di un commissario giudiziale e spalmabile.
In sintesi, il piano attestato di risanamento è lo strumento ideale per crisi affrontabili su base contrattuale, con creditori pochi e disponibili. Dà protezione legale minima (anti-revoca) ma non risolve conflitti forti. Per questo il legislatore l’ha mantenuto come opzione “leggera”. Spesso può essere un primo step: l’imprenditore prova un piano attestato; se funziona, bene, altrimenti tiene in mano quell’analisi e passa a un accordo omologato o concordato. Come diceva un commentatore, la composizione negoziata e il piano attestato sono complementari: la prima offre tempo e metodo, il secondo conclude l’accordo in sicurezza . Se invece c’è bisogno di vincolare una minoranza di creditori riluttanti, il piano attestato non è sufficiente e occorre uno strumento concorsuale con omologa .
4. Strumenti di regolazione concorsuale della crisi (procedure giudiziali)
Quando la negoziazione privata non basta o non è praticabile – ad esempio perché i creditori sono troppi, o alcuni sono irriducibili – la piccola software house può ricorrere alle procedure concorsuali, cioè strumenti legali formalizzati che coinvolgono l’autorità giudiziaria. In queste procedure, a differenza degli accordi privati, esistono regole specifiche per proteggere il debitore (stay delle azioni esecutive) e per imporre soluzioni anche ai creditori dissenzienti (ad es. tramite omologazione giudiziale di un accordo o voto a maggioranza in un concordato). Di contro, sono procedimenti pubblici, con costi e formalità maggiori, e comportano una parziale perdita di controllo da parte dell’imprenditore.
Il Codice della crisi d’impresa ha introdotto un ventaglio di procedure, tra cui: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (vari tipi), il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), i concordati preventivi (ordinario e “minore”), il concordato semplificato (post composizione negoziata) e le procedure liquidatorie (liquidazione giudiziale e controllata). Esploreremo qui i principali, focalizzando su quelli più applicabili a una piccola software house, specie se in continuità (che vuole proseguire l’attività) oppure se destinata alla liquidazione.
4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento concorsuale negoziale, introdotto originariamente nel 2005 e ora disciplinato dal CCII con varie innovazioni. In sintesi, consiste in un accordo tra il debitore e una parte consistente dei creditori, il quale viene poi sottoposto all’omologazione del tribunale . Una volta omologato, l’accordo produce effetti anche verso i creditori che non vi hanno aderito, purché abbiano ricevuto quanto loro spettava secondo la legge.
Caratteristiche chiave:
- Per chiedere l’omologazione, l’accordo deve essere sottoscritto da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali (accordo ordinario, art. 57 CCII) . Il CCII ha introdotto alcune varianti:
- Accordo agevolato (art. 60 CCII): permette di ottenere misure protettive con il 30% di adesioni già raccolte , fermo restando che per l’omologa serva poi il 60%. Questa variante aiuta a proteggere l’impresa durante la raccolta delle firme.
- Accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): se il debitore ottiene l’adesione di almeno il 75% dei creditori di una certa categoria omogenea (es. banche), può chiedere al tribunale di estendere l’accordo anche ai creditori dissenzienti di quella stessa categoria . Ad esempio, se 80% delle banche per valore accetta, la ristrutturazione può essere resa vincolante anche sul 20% che ha rifiutato.
- Accordi con transazione fiscale (artt. 63-64 CCII): consentono di includere nella ristrutturazione anche i debiti tributari e contributivi con un trattamento di favore (riduzione sanzioni e interessi, e possibile falcidia del capitale entro certi limiti) . Importante: oggi, grazie alle modifiche del 2024, è possibile ridurre anche il capitale dei debiti fiscali e contributivi fino al 50% circa, a condizione di offrire a Erario/INPS almeno quanto otterrebbero in una liquidazione . Inoltre, l’Agenzia Entrate deve rispondere entro 90 giorni, altrimenti il silenzio vale assenso .
- L’accordo va accompagnato da una relazione di un esperto attestatore che certifichi la veridicità dei dati aziendali e che il piano è fattibile e migliore per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione . Questa attestazione è simile a quella del concordato. Serve a dare garanzia che non si stanno danneggiando i creditori non aderenti.
- Il procedimento: il debitore deposita ricorso al tribunale allegando l’accordo firmato dai creditori aderenti, la relazione attestatrice e tutti i documenti contabili . Deve anche pubblicare il ricorso nel Registro imprese. La prassi e giurisprudenza indicano che il ricorso presentato senza previa iscrizione nel registro è inammissibile (la pubblicità è a tutela dei terzi creditori, per informarli che c’è un accordo in omologa).
- Misure protettive: il debitore può chiedere già con il ricorso di sospendere le azioni esecutive dei creditori (similmente al concordato). Se l’accordo è agevolato, è sufficiente avere il 30% di consensi per ottenere la protezione provvisoria . Ciò impedisce ai creditori di agire individualmente mentre pende l’omologazione.
- Omologazione in tribunale: il giudice (spesso con udienza in cui sentire eventuali oppositori) verifica varie cose: correttezza formale, percentuali di adesione raggiunte (>=60%), convenienza dell’accordo per i creditori non aderenti (devono ricevere almeno quanto avrebbero in liquidazione), trattamento dei privilegiati conforme alla legge (non si può dare ai privilegiati meno di quanto otterrebbero liquidando le garanzie, salvo consenso) . Se tutto è in ordine, il tribunale omologa l’accordo rendendolo efficace per tutti. Se qualcosa non va, può rigettare.
- Una volta omologato, l’accordo va eseguito come da piano. Di solito non c’è un commissario che sovrintende (a differenza del concordato, qui l’esecuzione è rimessa al debitore stesso, eventualmente vigilato dall’attestatore o altri se nominati contrattualmente). Se l’impresa non rispetta l’accordo, i creditori tornano liberi di agire secondo i termini originari.
Vantaggi degli accordi di ristrutturazione:
- Maggioranza contrattuale anziché unanimità: è il beneficio principale. Il debitore non deve convincere ogni singolo creditore; è sufficiente raggiungere la soglia di legge (60%) e il resto può essere tirato dentro con l’omologa. Questo supera il limite del piano attestato che richiede consenso di tutti quelli da coinvolgere.
- Coinvolgimento limitato del tribunale: rispetto al concordato, l’accordo è più “snello”: non c’è il voto formale dei creditori in adunanza, non c’è un commissario giudiziale nominato (tranne che il giudice potrebbe nominarne uno di controllo in caso di particolare complessità, ma è raro), e i tempi sono potenzialmente più rapidi. Il giudice si limita a omologare e intervenire se ci sono opposizioni.
- Possibilità di soluzioni mirate: il debitore può decidere di includere solo certi creditori. Ad esempio, può fare un accordo con tutte le banche e i fornitori principali, lasciando fuori piccoli creditori che pagherà a parte. Non è come il concordato che coinvolge tutti i creditori (nel concordato tutti sono vincolati e concorrono, salvo quelli estranei per legge). Nell’accordo, formalmente vincola solo aderenti e qualche dissenziente “minore”, ma spesso di fatto comprende la gran parte. Questa flessibilità consente di modellare bene la ristrutturazione.
- Transazione fiscale e contributiva: come detto, è possibile tagliare debiti fiscali e previdenziali all’interno di un accordo omologato . Ciò è un enorme plus, specie per PMI che spesso hanno grosse esposizioni verso Erario/INPS. Dopo il 2024, con il correttivo, la procedura per queste transazioni è migliorata (silenzio-assenso 90 giorni, possibilità di cram-down sull’ente se la proposta è conveniente) .
- Meno pubblicità negativa: pur essendo pubblicato e con omologa in tribunale (quindi un minimo di pubblicità c’è), nell’immaginario collettivo l’accordo di ristrutturazione è percepito meno negativamente di un fallimento o concordato. A volte si riesce a presentarlo come “accordo con banche” e quindi si evita lo stigma totale. Inoltre, la gestione rimane all’imprenditore (non c’è spossessamento né amministrazione controllata).
- Possibilità di presentare domanda “in bianco” (con riserva): il CCII consente di presentare un ricorso di omologa con riserva, ossia senza allegare subito tutte le firme, ottenendo nel frattempo le misure protettive (è l’equivalente dell’istituto di concordato in bianco per gli accordi). Questo dà tempo (fino a 60 giorni + proroga 60) per raccogliere le adesioni restanti . È utile se hai già una base e vuoi bloccare i creditori mentre concludi l’accordo.
Svantaggi e limiti degli accordi di ristrutturazione:
- Soglia di adesione elevata: il 60% dei crediti totali non è banale da raggiungere. Se la struttura del debito è molto frammentata (molti piccoli fornitori), può essere arduo. In pratica, gli accordi sono usati più spesso quando c’è un numero ristretto di creditori che rappresentano la maggior parte del debito (es. banche e fisco). Se i creditori sono centinaia, conviene il concordato.
- Protezione limitata ai soli concordati agevolati: per ottenere lo stay immediato con meno del 60% servono i requisiti dell’accordo agevolato (30%). Se il debitore non ha ancora convinto almeno il 30%, non può fermare le azioni. Ciò pone pressione a trattare velocemente. In composizione negoziata però l’impresa può ottenere lo stay pure prima di avere adesioni; infatti molti usano prima la composizione negoziata e poi formalizzano l’accordo.
- Opposizioni in sede di omologa: i creditori non aderenti possono comparire in tribunale e fare opposizione all’omologa. Se convincono il giudice che il piano li danneggia (ad es. un creditore privilegiato non firmatario dimostra che riceve meno di quanto avrebbe dal realizzo della garanzia), l’omologa può essere negata o il piano dovrà essere modificato . Quindi i non aderenti, pur non avendo votato, hanno voce in fase di omologa per tutelarsi. Ad esempio, un creditore che lamenta disparità di trattamento ingiustificate potrebbe ottenere la non omologa.
- Necessità di liquidità per eventuali stralci up-front: spesso l’accordo prevede che chi aderisce ottiene subito un pagamento (parziale). Servono risorse immediate per convincere i creditori a firmare. Se l’impresa non ne ha, l’accordo rischia di essere poco attraente. Nel concordato, invece, i creditori sanno che incasseranno più tardi dalla liquidazione dell’attivo; nell’accordo, uno si aspetta magari un bonifico appena firma.
- Assenza di voto formalizzato: se da un lato evita burocrazia, dall’altro impedisce strategie come il cram down interclassi del concordato. Cioè non c’è la possibilità di far approvare a maggioranza di classi e poi forzare anche classi contrarie (come col concordato, v. §5). L’accordo o raggiunge il 60% e viene omologato oppure nulla, non esiste accordo con 50% più giudice (quello semmai è il PRO di cui diremo). Quindi se non si arriva al 60, non c’è possibilità di omologa (eccetto PRO).
Applicabilità a una piccola software house: supponiamo la nostra software house abbia debiti per €500k: €200k con banche, €150k fiscali, €50k INPS e €100k fornitori. Un possibile accordo di ristrutturazione potrebbe concentrarsi su banche ed Erario. Se la società ottiene l’adesione delle banche (che sono il 40% del debito) e magari di alcuni fornitori e arriva al 60%, può includere nel pacchetto anche Fisco e INPS con una transazione fiscale (ad esempio pagando il 80% dell’IVA e il 50% di altre imposte in 5 anni , e simile per INPS). Se l’Agenzia Entrate sta zitta 90 giorni, è ok . L’accordo omologato obbligherà tutti i firmatari a rispettare le nuove scadenze, e i fornitori non firmatari comunque non potrebbero procedere esecutivamente finché l’accordo è eseguito (beneficiano del fatto che l’impresa non fallisce e magari vengono pagati a parte). Questo strumento è spesso usato per aziende non troppo grandi dove la maggior parte del debito è concentrata in pochi creditori “negoziabili”.
4.2 Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (detto in breve PRO, dagli artt. 64-bis – 64-octies CCII) è un istituto nuovo introdotto nel 2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1023. Si colloca a metà tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo.
In sostanza, il PRO consente al debitore di predisporre un piano di ristrutturazione e sottoporlo direttamente al giudice per l’omologazione anche senza il consenso unanime di tutti i creditori coinvolti. La logica è: se certe maggioranze qualificate per categorie di creditori sono favorevoli, il piano può essere omologato e reso vincolante per tutti i creditori di quelle categorie, pur in assenza di un voto formale in adunanza .
Caratteristiche in breve:
- Il debitore elabora un piano suddividendo i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi omogenei (analogo al concordato).
- Non c’è una votazione in adunanza dei creditori come nel concordato. Invece, il piano può essere presentato avendo raccolto adesioni informali da una parte dei creditori (ad es. accordi individuali) o anche senza adesioni formali.
- Il giudice omologa il piano se determinate condizioni sono soddisfatte: in particolare, se per ciascuna classe di creditori il piano prevede che i dissenzienti non ricevano meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale e se almeno una certa parte di classi ha espresso consenso (o comunque non si oppone). Il CCII prevede che una percentuale di creditori per classe (ad esempio 75%) o un certo numero di classi favorevoli possa far sì che il piano sia omologato coattivamente anche sulle classi contrarie .
- In pratica, il PRO è un meccanismo di cram-down giudiziale: permette di forzare un piano di ristrutturazione sui creditori dissenzienti a condizioni eque. Ad esempio, se ci sono 4 classi di creditori e 3 classi sono d’accordo, la quarta può essere inclusa nel piano comunque, a patto che il trattamento rispetti la priorità e sia più vantaggioso che in fallimento.
- Il PRO dunque amplia le possibilità di abbattimento unilaterale dei debiti rispetto all’accordo di ristrutturazione classico . Non serve il 60% di tutti i crediti, basta convincere abbastanza creditori per classe o per numero di classi secondo le regole (che ricalcano in parte il cross-class cram-down della Direttiva Insolvenza).
- Dopo l’omologa, il piano PRO vincola tutti i creditori previsti dal piano. Se un creditore non ha ricevuto quanto la legge gli garantiva (minimo da liquidazione), può opporsi in appello.
- Il PRO è uno strumento ancora poco sperimentato, pensato per situazioni complesse dove è difficile ottenere l’adesione formale del 60% ma l’impresa merita di essere ristrutturata lo stesso.
Applicabilità pratica: Una piccola software house raramente ha bisogno di un PRO, che è pensato per casi con molti creditori e strutture di debito complesse (tipicamente aziende più grandi). Tuttavia, se ad esempio vi fossero molti creditori frammentati e l’impresa volesse evitare un concordato per non passare dal voto in adunanza (o temesse di non raggiungere il quorum, ma riuscisse a persuadere almeno le classi principali), potrebbe tentare un PRO. Resta comunque una procedura concorsuale a tutti gli effetti (va depositata in tribunale, con misure protettive, ecc.), con costi e tempi simili a un concordato. La differenza è la flessibilità di omologa senza voto.
4.3 Concordato preventivo (ordinario e “minore”)
Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale di risanamento o liquidazione dell’impresa, in cui il debitore propone ai creditori un piano che prevede il soddisfacimento (integrale o parziale) dei crediti, sotto controllo del tribunale e con voto dei creditori. È disciplinato dagli artt. 84-118 CCII (per il concordato preventivo ordinario) e dagli artt. 74-83 CCII (per il concordato “minore” destinato agli imprenditori sotto soglia).
Scopo e tipologie: Il concordato preventivo consente di evitare la liquidazione giudiziale (fallimento) offrendo ai creditori un’alternativa concordata. Può essere: – Concordato in continuità aziendale: se prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente da parte del debitore o indirettamente tramite affitto/cessione d’azienda durante la procedura . Questo tipo di concordato mira a salvaguardare la continuità dell’impresa, mantenere i posti di lavoro e preservare il valore “dinamico” (avviamento, know-how). La legge e la giurisprudenza richiedono che nel piano di continuità siano garantiti certi pagamenti: ad esempio, i creditori privilegiati possono essere pagati non immediatamente ma entro un anno dall’omologazione (esteso a 2 anni dal correttivo 2022), purché siano soddisfatti integralmente . I creditori chirografari possono ricevere percentuali anche ridotte, ma in continuità prima del CCII c’era l’obbligo di un contributo minimo del 20% (ora ridotto al 10% in continuità pura, come da art. 84 co.6 CCII) . Un vantaggio del concordato con continuità è che l’impresa continua ad operare, i contratti essenziali possono proseguire e l’azienda può generare utili per pagare i creditori. – Concordato liquidatorio: se prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione di tutto o parte del patrimonio per pagare i creditori . In questo caso l’azienda solitamente viene messa in vendita o i suoi asset sono dismessi singolarmente, e il ricavato (al netto delle spese) distribuito ai creditori in proporzione ai loro diritti. È una procedura vicina al fallimento, ma con la differenza che è proposta dal debitore e può contenere elementi di convenienza (es. l’apporto di risorse esterne, oppure un timing più rapido). La legge impone(va) una soglia minima di soddisfazione per i chirografari: nella L.F. era 20%, nel CCII art. 84 co.6 era inizialmente 20% (ridotto a 10% se apporto esterno del 10%). Questa materia è stata oggetto di modifiche, ma indicativamente un minimo del 20% è richiesto nel liquidatorio puro . Nel concordato liquidatorio, spesso c’è la figura di un liquidatore nominato dal tribunale per vendere i beni dopo l’omologa (può anche essere il proponente se di fiducia).
Procedura (ordinario): – L’imprenditore in stato di insolvenza (o di crisi) predispone un piano e una proposta di concordato indicando cosa offre ai creditori e come intende attuare il piano. Si depositano in tribunale il ricorso corredato dai documenti: bilanci, elenco creditori, inventario attivo, piano e la relazione di un attestatore indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano . – Fase di ammissione: il tribunale valuta la proposta e, se ha requisiti di legge (fattibilità, non contrarietà norme), ammette il debitore al concordato. Nomina un giudice delegato e un commissario giudiziale (professionista terzo che vigila sulla gestione) . Da questo momento, l’impresa opera sotto la supervisione del commissario e con limitazioni (atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione). Viene fissata l’adunanza dei creditori per il voto, di solito entro 120-180 giorni. – Misure protettive automatiche: dalla pubblicazione del ricorso in registro imprese, i creditori chirografari non possono iniziare o proseguire azioni esecutive; eventuali pignoramenti in corso rimangono sospesi. I creditori privilegiati possono procedere (salvo diversa disposizione), ma in genere il tribunale su richiesta estende le misure protettive a tutti . Ciò mette in sicurezza l’azienda durante la procedura. – Votazione dei creditori: all’adunanza (o per via telematica) i creditori votano il concordato, divisi eventualmente in classi se il piano lo prevede. Serve il voto favorevole di >50% dei crediti ammessi al voto (calcolati per classi e poi in totale, con alcune particolarità: i privilegiati di solito non votano se non intaccati, ecc.). Se ci sono classi, basta la maggioranza per ciascuna classe o il cram-down se alcune classi votano sì e altre no ma sono comunque soddisfatte adeguatamente (il tribunale può omologare nonostante il voto negativo di una classe, se ritiene il piano equo e conveniente per quella classe dissenziente). – Omologazione: in assenza di opposizioni (o rigettatele), il tribunale omologa il concordato. Da quel momento, il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori. Il commissario cessa (o diventa liquidatore se liquidatorio). – Esecuzione del piano: se in continuità, l’imprenditore prosegue l’attività e deve effettuare i pagamenti come da piano (il mancato rispetto può portare a risoluzione del concordato e fallimento). Se liquidatorio, un liquidatore giudiziale nominato vende i beni secondo le modalità del piano e distribuisce i dividendi ai creditori.
Concordato minore: per le imprese sotto soglia (piccole) c’è una procedura analoga semplificata: – Non c’è il requisito di insolvenza conclamata: basta lo stato di crisi. – Il piano dev’essere tale da assicurare il pagamento di almeno il 20% ai creditori chirografari (limite previsto per il concordato minore), a meno di apporto esterno. – Il voto si svolge ma con possibili semplificazioni: ad esempio, nei concordati minori l’accertamento dei crediti ai fini del voto non è definitivo (evita contenziosi lunghi, semplicemente si conteggiano i crediti salvo conguaglio) . – Possono accedervi anche soggetti non fallibili prima: imprenditori agricoli, start-up innovative ecc. (in realtà, per start-up c’era già esenzione da fallimento, ora possono fare concordato minore). – In sostanza è un concordato su misura delle piccole imprese, con costi e formalità leggermente ridotti.
Differenze chiave rispetto ad accordi e piani attestati: il concordato coinvolge tutti i creditori (salvo quelli post-petition o esclusi per legge come i crediti fiscali futuri). Anche chi è contrario deve subire il trattamento stabilito a maggioranza e omologato dal giudice . Inoltre il concordato consente di modificare la graduazione legale in certi limiti (ad es. degradare al chirografo la parte non garantita dei crediti ipotecari se il valore del bene non copre tutto; comprimere i privilegi se accettano o comunque dando loro quel che avrebbero in fallimento). Permette anche di cancellare garanzie reali con l’omologa (cosa che in un accordo privato richiederebbe il consenso del garantito). D’altro canto: – Il concordato è pubblico: l’apertura è iscritta al Registro Imprese e pubblicata, i fornitori e clienti spesso lo vengono a sapere (rischio contraccolpi commerciali). – L’imprenditore è sorvegliato e parzialmente limitato: non può compiere atti di gestione straordinaria senza ok del giudice. In casi estremi, se la gestione fosse infedele, il tribunale può revocare l’ammissione e far dichiarare il fallimento ai sensi dell’art. 173 L.F. (ora in CCII). – I costi: c’è un commissario da remunerare, e spese di giustizia. Queste spese sono prededucibili (si pagano prima degli altri crediti) e vanno computate nel piano. – I tempi: un concordato può richiedere 6 mesi – 1 anno tra deposito e omologa (spesso anche di più se opposizioni). È più lungo di un accordo che magari in 2-3 mesi si omologa.
Perché usare il concordato: se non c’è altra via per gestire la crisi, ossia se i creditori non cooperano spontaneamente e il debitore necessita della forza della legge per imporre tagli e dilazioni, il concordato è l’arma finale prima del fallimento. Si sacrifica un po’ di riservatezza e autonomia, ma si ottiene: – Blocco totale dei creditori (respiro immediato). – Possibilità di ristrutturare anche quei debiti che altrimenti sarebbero intoccabili, come quelli erariali (tramite la transazione fiscale ex art. 63 CCII, oggi ammessa nei concordati anche per IVA e contributi con possibili falcidie ). – Cram down dei creditori contrari (anche se una classe vota no, il giudice può omologare lo stesso se il piano è conveniente per loro). – Eventuale esdebitazione del debitore personale a fine procedura (nel caso di socio illimitatamente responsabile o imprenditore individuale, dopo la liquidazione concordataria possono chiedere esdebitazione). – In più, se l’imprenditore rispetta le regole, mantiene in mano la gestione (nel fallimento la perderebbe del tutto). Nel concordato in continuità, l’imprenditore gestisce l’azienda (sotto vigilanza del commissario) e una volta omologato rimane alla guida attuando il piano.
Concordato e responsabilità penale: va segnalato che comportamenti illeciti durante il concordato possono integrare reato di bancarotta concordataria. L’art. 236 L.F. (ancora in vigore in attesa di riforma penale) punisce con la stessa pena della bancarotta fraudolenta chi commette frodi nel concordato . Ad esempio, occultare attivo o simulare passivo in sede di concordato è bancarotta fraudolenta. La Cassazione ha appunto equiparato la gravità: la bancarotta fraudolenta da concordato è punita come quella da fallimento . Quindi il concordato non è una terra franca: richiede trasparenza e correttezza, altrimenti si rischiano condanne penali.
Il caso della nostra software house: se ha prospettive di rilancio (nuovi contratti in vista, squadra valida) ma ha bisogno di liberarsi dei debiti pregressi che soffocano, potrebbe presentare un concordato preventivo in continuità. Ad esempio propone: pagherò integralmente IVA e INPS in 2 anni (moratoria permessa di 2 anni sui privilegiati ), pagherò il 30% ai chirografari (fornitori, banche per la parte scoperta) in 5 anni con flussi di cassa futuri, grazie al fatto che la società continuerà l’attività e i soci apportano un extra di capitale. I creditori votano; se approvano, l’azienda esce dal concordato e prosegue, con debiti ridotti. Oppure, se la situazione è compromessa e non si vede rilancio, la software house opta per un concordato liquidatorio: propone di vendere il software di proprietà e gli altri asset a un competitor interessato e distribuire quel ricavato (meno spese) ai creditori. Magari grazie a un contributo dei soci riesce a garantire il 25% ai chirografari. Questo eviterebbe la lunga procedura fallimentare: in 6 mesi si omologa, in altri 6 si vendono i beni e si chiude tutto, con l’azienda che cessa ma i soci liberati dai debiti residui della società (che viene poi cancellata). Spesso i Tribunali raccomandano: se non c’è continuità, preferite il concordato semplificato (se possibile) o la liquidazione diretta, perché il concordato liquidatorio ordinario può risultare un inutile aggravio di costi e tempo se non offre un plus ai creditori.
4.4 Concordato “semplificato” per la liquidazione (art. 25-sexies CCII)
Il concordato semplificato è un particolare tipo di concordato riservato al caso in cui la composizione negoziata della crisi sia stata tentata ma senza successo. Introdotto inizialmente dal D.L. 118/2021 (art. 18) e ora disciplinato negli artt. 25-sexies, septies, octies CCII , ha caratteristiche peculiari:
- Accesso subordinato: solo chi ha seguito la procedura di composizione negoziata con un esperto indipendente e non è riuscito a concludere un accordo, può accedere al concordato semplificato . Serve che l’esperto, nella relazione finale, attesti che le trattative si sono svolte regolarmente ma non hanno portato a una soluzione. Non è più richiesto (dopo il correttivo 2024) che le trattative siano “non andate a buon fine” in modo tassativo , basta la conclusione delle stesse.
- Finalità esclusiva di liquidazione: il concordato semplificato può essere solo liquidatorio, non è ammessa la continuità aziendale . L’impresa dunque nel semplificato non prosegue l’attività oltre quanto strettamente necessario a liquidare. Non si può usare il semplificato per ristrutturare l’azienda e continuare a operare – per quello c’è il concordato preventivo ordinario. L’obiettivo è liquidare in modo ordinato i beni e distribuire il ricavato ai creditori in tempi rapidi .
- Nessun voto dei creditori: questa è la differenza più significativa. Nel concordato semplificato non è prevista l’adunanza né la votazione dei creditori . Il debitore deposita la proposta di concordato semplificato al tribunale, indicando come intende liquidare i beni e come distribuirne il valore (il piano di liquidazione). I creditori vengono informati e possono presentare opposizioni all’omologazione se contrari, ma non c’è una votazione per classi con maggioranze. La decisione finale spetta interamente al Tribunale in sede di omologa .
- Organi ridotti: nel semplificato non viene nominato un commissario giudiziale né un giudice delegato per gestire la procedura . Il tribunale può avvalersi di un esperto indipendente ausiliario per valutare il piano (spesso nominano lo stesso esperto che ha seguito la composizione o un altro) e, dopo l’omologa, nomina un liquidatore giudiziale che procederà alla vendita dei beni . Quindi la procedura è più semplice e snella: niente organi durante la fase di approvazione (che rallenterebbero e costerebbero), solo un liquidatore post-omologa.
- Soggetti ammessi: molto importante, possono accedervi tutti gli imprenditori, anche sotto soglia o agricoli, purché abbiano fatto la composizione negoziata . Questo allarga la platea: artigiani, piccoli commercianti, startup, imprenditori agricoli – esclusi dal fallimento tradizionale – possono utilizzare il semplificato se hanno seguito l’iter richiesto . Di fatto, il semplificato funge da surrogato per il fallimento concordato anche per chi non era fallibile.
- Contenuto della proposta: il debitore propone la cessione di tutti i beni ai creditori, indicandone le modalità di realizzo (vendita unitariamente, spezzettata, assegnazione a un terzo). Può prevedere di cedere l’intera azienda o rami se ciò massimizza il valore . Non c’è obbligo di percentuale minima ai chirografari (diversamente dal concordato ordinario) , quindi teoricamente potrebbe proporre anche il pagamento di percentuali molto basse se il patrimonio è esiguo. Tuttavia, ogni creditore deve ricevere una “utilità” almeno pari a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale . Non si può dare zero a un creditore che nella liquidazione fallimentare avrebbe preso qualcosa (fosse pure il recupero IVA per crediti inesigibili) . Ad esempio, il Tribunale di Bergamo ha bocciato un semplificato dove una classe di creditori non otteneva nulla, considerando che anche in fallimento avrebbero potuto ottenere un minimo (benefici fiscali) . Dunque qualche soddisfacimento per tutti va garantito, sebbene modesto.
- Procedure protettive e termini: col correttivo 2024, è stato chiarito che il debitore che presenta domanda di concordato semplificato può beneficiare delle stesse misure protettive e cautelari del concordato ordinario . Può anche presentare domanda di concordato semplificato con riserva (in bianco) se ha bisogno di tempo per predisporre il piano . La procedura quindi acquisisce strumenti completi di tutela durante la pendenza.
- Ruolo del tribunale: il tribunale verifica la buona fede del debitore nelle trattative precedenti (che non abbia abusato della composizione solo per prendere tempo) e la convenienza della proposta per i creditori. Se ritiene che il piano dia ai creditori almeno quanto la liquidazione giudiziale, omologa nonostante eventuali opposizioni . Se invece ravvisa abuso o mancanza di convenienza, può rigettare e aprire la liquidazione giudiziale. Ad esempio il Tribunale di Napoli ha revocato l’ammissibilità di un concordato semplificato aprendo il fallimento, perché il debitore aveva tenuto condotte irregolari e in mala fede durante la composizione .
- Esecuzione e chiusura: il liquidatore nominato dal tribunale esegue le vendite (seguendo regole semplificate o quelle del concordato liquida ordinario per trasparenza ) e distribuisce i proventi. Al termine, presenta un rendiconto e il tribunale dichiara chiusa la procedura. L’imprenditore (se persona fisica) può poi chiedere l’esdebitazione per liberarsi di eventuali debiti residui non soddisfatti .
Vantaggi del concordato semplificato:
- Rapidità e semplicità: niente voto creditori, niente commissario, meno udienze. In pochi mesi si può arrivare all’omologa, risparmiando tempo e costi. È concepito come ultima via legale veloce per evitare la liquidazione giudiziale ordinaria .
- Minori costi procedurali: l’assenza di commissario e comitato creditori riduce spese. Resta solo il compenso del liquidatore alla fine (e dell’eventuale ausiliario pre-omologa).
- Accessibile ai piccoli e a categorie prima escluse: come detto, anche il piccolissimo imprenditore può avere questa opportunità di “concordato senza voto”. Prima, se sotto soglia, l’unica era il piano di sovraindebitamento (che però richiedeva adesione del giudice OCC).
- Certezza di esito per il debitore onesto: se l’imprenditore ha agito correttamente nella negoziazione e la crisi è irrisolvibile se non liquidando, il semplificato garantisce di arrivare a una conclusione ordinata. Evita la lunga agonia di una liquidazione giudiziale con curatore (che spesso dura anni). Ad esempio, un concordato semplificato può concludersi in 1 anno tot: qualche mese per omologa e 6-12 mesi per liquidare beni, contro i 5-6 anni medi di un fallimento.
- Esdebitazione finale: come per il fallimento o concordato, il debitore persona fisica può essere esdebitato ossia liberato dai debiti residui insoddisfatti . Ciò consente un fresh start. Anche i soci di SRL beneficiano indirettamente: la società viene poi cancellata e i crediti non pagati rimangono senza soggetto su cui rifarsi (i soci non ne rispondono, salvo garanzie personali).
- Minori formalità sui pagamenti: nel semplificato non c’è l’obbligo delle percentuali minime (20%) tipico del concordato ordinario, quindi anche un realizzo minimo può essere distribuito senza impedimenti normativi (fatto salvo il rispetto della convenienza minima per ciascuno). Ad esempio, è stato omologato un concordato semplificato dove i creditori privilegiati (erario, INPS) prendevano solo il 5-6% del dovuto a causa dell’incapienza del patrimonio – cosa che nel concordato ordinario non sarebbe stata possibile senza consenso dell’ente, mentre qui il giudice l’ha accettato vista la mancanza di alternative.
Svantaggi e attenzioni:
- Pre-requisito della composizione negoziata: non è accessibile a chi non ha prima tentato la composizione. Questo è un filtro importante: occorre investire tempo (e costi dell’esperto) nella fase negoziale. Se un imprenditore salta la composizione, non può chiedere direttamente il semplificato.
- Niente continuità: se in realtà l’impresa avrebbe potenziale di salvataggio, il semplificato non è la via. Non può mantenere l’attività in esercizio continuativo, se non quel minimo per vendere meglio i beni. Ad esempio, l’impresa non può continuare a fatturare e portare avanti i progetti per anni: deve vendere e chiudere. I tribunali hanno sottolineato che il semplificato è extrema ratio e non consente di protrarre l’attività se non finalizzata alla liquidazione immediata .
- Valutazione severa della buona fede: siccome i creditori non votano, il giudice è molto attento ad evitare abusi. Se il debitore ha anche solo dato l’impressione di usare la composizione per congelare i creditori e poi presentare un piano squilibrato a proprio favore, rischia il rigetto. Occorre comportarsi in modo trasparente e corretto. Ad esempio, occultare un attivo durante la composizione e poi non offrirlo nel piano semplificato sarebbe esiziale se scoperto.
- Nessuna ristrutturazione del debito: qui non c’è “risanamento”, solo liquidazione. Quindi i contratti aziendali, i dipendenti – tutto sarà chiuso o ceduto. È una soluzione di chiusura ordinata, non di salvataggio. Per alcuni imprenditori, psicologicamente e strategicamente, potrebbe equivalere a gettare la spugna. Va intrapresa con questa consapevolezza.
- Interesse dei creditori protetto dalla legge: i creditori, pur senza voto, hanno comunque la protezione del controllo giudiziale. Inoltre, se qualche creditore ritiene di essere penalizzato oltre legge, può opporsi. Ad esempio, se un creditore ipotecario viene trattato peggio di quanto l’immobile farebbe in vendita libera, potrà farlo notare in opposizione e il giudice non omologherà finché non si adegua il piano. Quindi il debitore non può esagerare con proposte squilibrate confidando nell’assenza di voto.
In sintesi, il concordato semplificato è un potente strumento introdotto di recente per risolvere crisi irreversibili in modo rapido, con un equo bilanciamento tra creditori (che risparmiano tempo e qualcosa ottengono comunque) e debitore (che evita il fallimento lungo e ottiene la liberazione dai debiti). Va visto come una exit strategy quando il turnaround non è riuscito.
Nel caso della nostra software house: se avesse provato la composizione negoziata sperando in un investitore o accordo e ciò non è avvenuto, e la situazione è peggiorata tanto da non poter più stare sul mercato, potrebbe presentare un concordato semplificato. Ad esempio: l’azienda chiuderà, cederà il proprio software e il database clienti a un’altra società per €50k, e tale importo verrà distribuito ai creditori (che hanno complessivamente €500k di crediti). Supponiamo che in fallimento avrebbero ricavato forse €30k dopo anni: nel concordato semplificato se offre €50k subito e a tutti un pro-quota migliore, il giudice potrebbe omologare anche se i creditori prendono solo il 10% dei loro crediti, riconoscendo che è più di quanto avrebbero dal fallimento (dove magari l’avviamento si sarebbe perso del tutto e i costi di procedura avrebbero eroso il ricavato). I creditori non votano, la procedura si conclude in pochi mesi, i soci vedono la società terminare ma almeno senza strascichi, e l’amministratore evita il fallimento (potenzialmente anche responsabilità per aggravamento, ecc.). Attenzione: se però emergesse che l’imprenditore aveva ricevuto durante la composizione un’offerta migliore (es. un investitore offriva €100k ma lui l’ha rifiutata per ragioni personali) e ora ne offre 50 ai creditori, il tribunale potrebbe dubitare della correttezza e rigettare. Quindi sempre massima trasparenza.
4.5 Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata
Se nessuno degli strumenti sopra descritti viene attivato con successo, l’esito finale è la liquidazione concorsuale dell’impresa. Nel CCII abbiamo due tipi:
- Liquidazione giudiziale (LJ): erede del “fallimento”, è aperta su istanza di un creditore, del debitore o d’ufficio in certi casi, per imprenditori commerciali sopra soglia in stato d’insolvenza.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (LC): evoluzione della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, destinata a imprenditori minori, professionisti, consumatori insolventi. Di solito è volontaria (su ricorso del debitore), ma il CCII ha lasciato aperta la possibilità che, in caso di concordato minore non omologato, il tribunale apra d’ufficio la liquidazione controllata.
Dal punto di vista pratico, entrambe funzionano similmente: – Un curatore o liquidatore viene nominato dal tribunale e sostituisce l’imprenditore nella gestione dei beni. – L’impresa cessa la sua attività, salvo esercizio provvisorio autorizzato per massimizzare il valore di vendita (poco probabile per una micro software house a meno di completare qualche progetto vendibile). – Si forma lo stato passivo: l’elenco dei crediti ammessi, con grado (privilegi, ipoteche, chirografi). I creditori fanno domanda di insinuazione, il curatore esamina e il giudice delegato decide con ordinanza (o provvedimento del giudice relatore nel sovraindebitamento). – Il curatore/liquidatore liquida tutti i beni: vende l’azienda (se possibile), incassa crediti, vende attrezzature, chiude i conti e recupera eventuali cause in corso (o le continua per incassare crediti). Può anche esercitare azioni revocatorie su atti pregiudizievoli compiuti prima (per recuperare pagamenti preferenziali fatti ai creditori o beni distratti). – A liquidazione conclusa, redige un riparto: prima paga le spese di procedura e i crediti prededucibili, poi i privilegiati (in ordine di causa) fino a capienza, infine se resta qualcosa i chirografari in percentuale. Spesso per i chirografari non resta nulla o pochi punti percentuali. – La procedura termina con un decreto di chiusura. La società fallita (se persona giuridica) viene cancellata dal Registro Imprese; se l’imprenditore è persona fisica, la procedura chiude ma i debiti residui tecnicamente restano (a meno che non ottenga esdebitazione).
Esdebitazione: è un istituto fondamentale per dare un nuovo inizio al debitore persona fisica onesto ma sfortunato. Dopo la chiusura del fallimento o liquidazione controllata, l’imprenditore (o il socio illimitatamente responsabile) può chiedere al tribunale l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti . Il tribunale la concede se il debitore ha cooperato lealmente, non ha commesso irregolarità gravi e non è stato condannato per bancarotta fraudolenta, ecc. Con l’esdebitazione, tutti i crediti concorsuali (tranne poche eccezioni come obblighi di mantenimento, risarcimenti da illecito penale e sanzioni pecuniarie amministrative/penali) sono estinti e il debitore può ricominciare senza quel fardello. Il CCII prevede anche l’esdebitazione dell’incapiente immediata per il debitore persona fisica nullatenente che non ha nulla da liquidare, in casi di particolare meritevolezza, evitando la procedura lunga.
Per una SRL: la liquidazione giudiziale comporta la perdita di controllo totale e la probabile fine della società. I soci di capitale non rispondono dei debiti sociali, quindi dopo la chiusura i debiti rimasti non sono recuperabili (creditori a mani vuote). Tuttavia, il curatore potrebbe agire contro amministratori o soci se ravvisa responsabilità (es. azione di responsabilità verso amministratori per mala gestione, o verso soci per finanziamenti postergati, o revoca di prelevamenti). Quindi non c’è responsabilità automatica, ma eventuali azioni giudiziarie mirate sì.
Differenze LJ vs LC: la liquidazione controllata è in genere promossa dal debitore stesso o dal giudice di un concordato minore in esito negativo. Non c’è la “stigma” del fallimento (anche terminologicamente). Le regole di gestione però sono analoghe: c’è un liquidatore nominato e un giudice controllore, si formano i crediti, si vende tutto. Anche nel sovraindebitamento c’è esdebitazione.
Perché evitare la liquidazione giudiziale? Dal lato debitore: perché perde il controllo, subisce possibili azioni di responsabilità, la procedura è lunga e intricata (ad esempio un amministratore fallito deve subire l’interrogatorio del curatore, consegnare documenti, e può incorrere in imputazioni penali se emergono irregolarità). Inoltre l’azienda viene smembrata senza riguardo alla continuità: spesso i beni intangibili (clienti, software) perdono valore, i dipendenti perdono il lavoro subito. Insomma, è la “peggiore” per il debitore, ma talvolta inevitabile se non si trova altra via.
Dal lato creditori: il fallimento è una procedura garantista ma lenta e spesso poco soddisfacente. Piccoli creditori chirografari raramente vedono soldi (a volte percepiscono un mini dividendo dopo anni). Tuttavia, è l’ultimo strumento per far valere i propri diritti se il debitore non coopera in altro modo.
Il ruolo eventuale del debitore in LJ: può succedere che il debitore si rassegni e collabori col curatore (fornendo informazioni, magari trovando acquirenti per l’azienda – c’è l’istituto del concordato fallimentare, ossia un accordo proposto dal fallito o terzi dopo la dichiarazione di fallimento, per chiudere prima la procedura pagando almeno il 20% ai chirografari; ma è raro e deve essere votato dai creditori). Nel CCII, l’equivalente è il “concordato nella liquidazione giudiziale”, un’opzione per chiudere anticipatamente la LJ con una proposta del debitore o terzi votata dai creditori (simile a un concordato post-fallimentare).
Conclusione: la liquidazione giudiziale/controllata è l’extrema ratio quando la ristrutturazione non è percorribile o è fallita. Per una piccola software house, significherà la fine dell’impresa. I titolari dovranno cercare altre strade (magari i programmatori apriranno una nuova società con altro nome? È possibile, fermo restando qualche limitazione legale: ad esempio, se un soggetto è stato amministratore di un fallimento, non può per qualche tempo assumere cariche in nuove società senza informare i soci ex art. 2504 c.c., e se ha commesso reati può subire inabilitazioni).
Spesso è preferibile che l’imprenditore, valutata l’inevitabilità della fine, scelga una via concordata (accordo, concordato, semplificato) per governare la liquidazione piuttosto che subirla. In tal modo può limitare i danni reputazionali e giuridici e magari ottenere la liberazione dei debiti. Solo se ciò non riesce, si giunge alla liquidazione concorsuale classica.
5. Focus: la composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata della crisi è uno strumento innovativo introdotto in Italia nel 2021 e ora integrato nel CCII (artt. 12-25-sexies) . Merita un approfondimento dedicato perché rappresenta oggi l’approccio più avanzato e promettente per aiutare le imprese in difficoltà, incluse le piccole software house, a risanarsi fuori dalle aule di tribunale ma con il supporto della legge.
5.1 Cos’è e come funziona la composizione negoziata
La composizione negoziata (spesso abbreviata in CNC) è una procedura volontaria, riservata e stragiudiziale in cui l’imprenditore, trovandosi in condizioni di squilibrio economico o finanziario (crisi o insolvenza probabile, anche prima dell’insolvenza conclamata), chiede la nomina di un esperto indipendente. Questo esperto ha il compito di affiancare l’imprenditore nel tentativo di raggiungere un accordo con i creditori per superare la crisi .
Punti chiave del funzionamento:
- Accesso tramite piattaforma online: l’imprenditore presenta istanza tramite un portale web nazionale gestito dalle Camere di Commercio (Unioncamere). Deve allegare una serie di documenti (ultimi bilanci, situazione debitoria dettagliata, una proposta di piano di risanamento, elenco beni, certificati debiti fiscali/contributivi, ecc.). Fino al 31/12/2024 c’è una semplificazione: basta autocertificare di aver richiesto i certificati tributari e INPS, senza doverli aspettare . L’istanza dev’essere ben motivata e dimostrare che c’è una prospettiva di risanamento (anche se incertezza è ammessa).
- Nomina dell’esperto: entro pochi giorni, una commissione presso la Camera di Commercio nomina un esperto negoziatore scelto da un elenco nazionale (di solito commercialisti, avvocati o consulenti con formazione specifica) di comprovata indipendenza e competenza. L’esperto deve dichiarare la sua indipendenza rispetto al caso e accettare l’incarico entro 2 giorni .
- Fase delle trattative riservate: una volta nominato, l’esperto convoca l’imprenditore e ascolta la sua situazione. Predispone poi incontri (anche da remoto) con i principali creditori. Tutto avviene in modo confidenziale: l’apertura della composizione negoziata non è pubblica, a meno che l’imprenditore non richieda misure protettive al tribunale (vedi sotto). I creditori vengono invitati a partecipare in modo attivo e informato. L’esperto svolge una funzione di mediatore: analizza i dati aziendali, individua possibili soluzioni (ristrutturazioni del debito, nuovi finanziamenti, cessioni, etc.) e cerca di far convergere le parti su un accordo. Ha una check-list ministeriale di aspetti da considerare e riferisce periodicamente sullo stato delle trattative. La durata standard è 180 giorni, prorogabile se ci sono concreti progressi (con le nuove norme 2024 la proroga è più agevole su richiesta motivata e col parere favorevole dell’esperto) .
- Misure protettive e cautelari: l’imprenditore può chiedere al tribunale la concessione di misure protettive temporanee sui suoi beni, per evitare che i creditori pregiudichino le trattative con azioni esecutive. Tipicamente, si chiede di sospendere per 4 mesi (prorogabili) i pignoramenti, le ingiunzioni e altri atti di esecuzione . Il tribunale, valutata la situazione (basta un fumus di risanabilità, non si chiede insolvenza accertata), emette un decreto di protezione con efficacia generale (erga omnes), che viene pubblicato al RI per conoscenza pubblica . Da quel momento, nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, né acquisire titoli di prelazione senza autorizzazione. Questo è cruciale per dare respiro all’azienda: si blocca l’emorragia del contenzioso e si guadagna tempo per trattare. Le misure protettive possono essere integrate da misure cautelari atipiche: ad esempio, alcuni tribunali hanno inibito in via cautelare a un socio di minoranza di chiedere un’amministrazione straordinaria durante la CNC , oppure hanno bloccato la banca dal escutere garanzie (vedi Trib. Modena 2025 sopra) . Ciò dimostra la flessibilità dello strumento. Importantissimo aggiornamento 2024: per legge ora le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti durante la composizione negoziata solo per il fatto che essa è iniziata, finché durano le misure protettive . E non possono segnalare a CRIF/Centrale Rischi la sospensione pagamenti dovuta alle trattative . Questo toglie un grosso rischio che prima scoraggiava dal ricorrere alla CNC (il timore di essere “marchiato” dalle banche). Il principio di standstill bancario è ora nella legge ed è stato applicato da pronunce come Trib. Venezia, ord. 13/1/2025 .
- Gestione corrente dell’impresa: durante la CNC, l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda. Non è spossessato né affiancato da organi come nel concordato. Tuttavia, deve consultare l’esperto prima di atti di straordinaria amministrazione non previsti dal piano iniziale. Se compie atti senza consulto, e tali atti pregiudicano i creditori, possono non essere protetti da eventuale futura esenzione da revocatoria. Con le misure protettive attive, per fare atti straordinari può chiedere autorizzazione al tribunale ex art. 19 CCII (ad esempio vendere un bene, contrarre un finanziamento urgentemente) . L’esperto non ha poteri decisionali, ma deve vigilare e segnalare eventuali abusi o condotte scorrette del debitore. Può, in casi gravi, porre fine anticipatamente alla procedura se vede mancanza di buona fede.
- Facilitazioni durante la procedura: la legge offre incentivi: possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili autorizzati dal tribunale (che saranno rimborsati con precedenza se poi c’è fallimento), protezione dalle revocatorie per atti autorizzati (es. pagamenti di fornitori strategici fatti su indicazione dell’esperto), e ora – novità – la possibilità di proporre una transazione fiscale già in composizione negoziata . Con D.Lgs. 136/2024, infatti, l’imprenditore in CNC può trattare con il Fisco una riduzione o dilazione delle imposte dovute (come in concordato) . Ciò era prima un vuoto normativo ora colmato: adesso in CNC è possibile per esempio proporre ad Agenzia Entrate un pagamento parziale di imposte e sanzioni, evitando di dover aspettare un concordato per farlo. Resta esclusa però la transazione contributiva INPS, non espressamente ammessa in CNC , quindi i debiti contributivi possono essere solo dilazionati secondo le norme ordinarie, non falcidiati in CNC (se ci sono grossi debiti INPS, potrà essere necessario un accordo di ristrutturazione o concordato).
- Esito della composizione: entro il termine (di base 180 gg, prorogabile come detto) l’esperto tira le somme. Possibili esiti:
- Accordo stragiudiziale raggiunto: i creditori e il debitore concludono uno o più accordi contrattuali (es. transazioni bilaterali, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione da omologare). La composizione termina con successo e l’esperto redige una relazione finale positiva. Ad esempio, si concorda un piano attestato firmato da tutti i creditori principali (l’esperto può diventare lui stesso l’attestatore del piano, essendo indipendente, per dare continuità ). Oppure i creditori accettano un accordo ex art. 57 CCII che sarà poi omologato.
- Proposta di concordato o altra procedura: durante la CNC ci si accorge che serve formalizzare una procedura concorsuale (accordo omologato o concordato). La legge lo consente: l’imprenditore può depositare domanda di concordato preventivo (anche semplificato se liquidatorio) o accordo di ristrutturazione. In tal caso la CNC si chiude e si “converte” nella procedura regolata dall’art. 23 co. 2 CCII . Molti concordati oggi nascono a valle di una CNC semiriuscita , perché le trattative hanno spianato la strada (creditori già in larga misura consenzienti, piano già definito) e il concordato arriva “pre-cotto” garantendo approvazione veloce . Insomma la CNC può fungere da pre-concordato invisibile .
- Mancato accordo – attivazione concordato semplificato: se la CNC fallisce e non c’è tempo o modo di fare un concordato preventivo ordinario, il debitore può optare per il concordato semplificato (descritto prima). L’esperto infatti nella relazione finale evidenzierà che nessun accordo è stato raggiunto; il debitore, entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale relazione, può depositare ricorso per concordato semplificato . In tal caso, la CNC sfocia in una procedura concorsuale liquidatoria rapida (come da art. 25-sexies CCII).
- Mancato accordo – nessuna ulteriore iniziativa: la CNC può chiudersi senza alcuna soluzione, ad esempio perché l’imprenditore vi rinuncia, o l’esperto dichiara impossibile proseguire (magari ha riscontrato che l’imprenditore non fornisce informazioni o i creditori non intendono trattare). In questo caso, terminata la protezione, l’azienda torna esposta ai creditori. Se l’insolvenza è grave, probabilmente qualche creditore chiederà il fallimento . Se invece c’è ancora margine, l’impresa potrebbe provare comunque un concordato tradizionale in extremis, ma sarebbe tardivo. Va notato però che il periodo di CNC non viene considerato come inattività colpevole in un eventuale successivo fallimento . Anzi, aver tentato la CNC può essere valutato a favore del debitore (ad es. per la concessione dell’esdebitazione o nel giudicare la condotta ai fini di bancarotta semplice) . Dunque, anche se fallisce, averci provato in buona fede è meglio che niente.
- Chiusura e attestazione finale: l’esperto, in qualsiasi caso, redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e l’outcome. Se c’è accordo, deposita la relazione all’ufficio del registro e termina l’incarico. Se non c’è accordo e si passa a concordato semplificato, deposita al tribunale. La relazione è importante anche per il giudice: ad esempio, in sede di omologa di un semplificato, il tribunale verifica la buona fede proprio basandosi sulla relazione dell’esperto (Trib. Milano 23/4/24 ha detto che il controllo del tribunale sulla correttezza trattative è esterno, fidandosi dell’esperto salvo opposizioni ).
5.2 Perché la composizione negoziata è utile al debitore (software house)
La composizione negoziata incarna la filosofia della “prevenzione” della crisi. I suoi vantaggi dal punto di vista di una piccola software house debitrice sono molteplici:
- Riservatezza iniziale: a differenza di un concordato, l’avvio della CNC non viene a conoscenza del pubblico (tranne se si attivano le misure protettive, allora c’è pubblicazione al RI, che comunque è meno eclatante di un fallimento). Questo consente di affrontare i problemi senza allarmare clienti, fornitori e dipendenti. L’impresa può continuare a lavorare con minima distruzione di valore reputazionale finché discute coi creditori riservatamente.
- Sospensione delle azioni dei creditori: con le misure protettive, la software house ottiene uno scudo legale: niente pignoramenti, niente decreti ingiuntivi, niente istanze di fallimento nel frattempo . Può così concentrarsi sul piano di risanamento senza l’acqua alla gola quotidiana dei provvedimenti. Inoltre, come evidenziato, le banche non possono peggiorare la sua posizione (niente revoca fidi, niente segnalazioni) , preservando la continuità finanziaria necessaria. Questo è fondamentale: in passato, uno dei timori era che appena trapelava la notizia di una procedura, le banche tagliavano i fondi e l’azienda moriva; ora c’è una tutela esplicita .
- Trattativa assistita e competente: l’imprenditore piccolo spesso non ha tutte le competenze o l’autorità per condurre negoziati duri con banche o Fisco. L’esperto nominato è una figura autorevole e neutrale, il cui coinvolgimento spinge anche i creditori a sedersi al tavolo con serietà . Le banche ad esempio devono partecipare in modo attivo e informato (è previsto come dovere di correttezza), e non possono rifiutare senza motivo proposte ragionevoli. L’esperto aiuta a superare diffidenze e conflitti, portando competenze tecniche (può suggerire soluzioni, come rifinanziamenti, ristrutturazioni di linea, coinvolgimento di investitori).
- Flessibilità delle soluzioni: nella CNC non c’è uno schema rigido come in tribunale. Qualsiasi soluzione concordata tra le parti è valida: si può combinare una moratoria per alcuni debiti, un taglio per altri, la cessione di un ramo, l’ingresso di un nuovo socio, ecc. La legge incoraggia la creatività negoziale, limitandosi a offrire il contesto protetto. Ad esempio, se un investitore vuole entrare, in CNC si può ottenere l’autorizzazione rapida e una corsia per farlo (finanziamenti prededucibili). Oppure se conviene vendere un bene prima che perda valore, si può fare autorizzare senza timore di revocatoria futura .
- Mantenimento operatività aziendale: l’impresa continua a lavorare durante la CNC. Non solo: normative collegate garantiscono possibilità di continuare contratti pubblici nonostante pendenze contributive (se c’è un piano di rientro presentato, v. DURC provvisorio ) e di accedere ad ammortizzatori (è prassi attivare CIGS per crisi in caso di esuberi mentre si tratta, se applicabile). Ciò significa che la CNC consente di salvaguardare il valore aziendale (dipendenti, clienti) molto meglio di un fallimento dove tutto si blocca.
- Nessun costo giudiziale: non ci sono tasse di tribunale né organi da pagare come commissari (tranne un eventuale compenso all’esperto). Il compenso dell’esperto è stabilito in base a decreto ministeriale e commisurato all’attività svolta e all’esito: tra l’altro, col nuovo correttivo, l’esperto riceve un bonus (raddoppio del compenso) solo se la negoziazione si conclude con un accordo . Se non si conclude nulla, prende il minimo (che comunque è stato un po’ alzato per garantirgli decoro) . Questo incentiva anche l’esperto a impegnarsi attivamente per trovare una soluzione (non deve essere un mero notaio che poi comunque viene pagato). In ogni caso, parliamo di costi inferiori rispetto a quelli di un lungo concordato o fallimento. Inoltre, in passato c’era un credito d’imposta del 50% sui compensi dei professionisti che aiutavano l’impresa in CNC (commercialisti, avvocati), entro 20k euro: bisognerebbe verificare se rifinanziato per il 2023-25, ma segnaliamo che c’è stata questa agevolazione.
- Cornice propedeutica ad altri strumenti: come ben spiegito in §4, la CNC non esclude concordati o accordi, anzi li prepara . È come una fase di “laboratorio protetto”: se da essa scaturisce un accordo, bene, altrimenti si potrà comunque attivare un concordato con molte più chance di successo (perché i creditori saranno già informati e alcuni d’accordo). Il CCII infatti la inserisce come parte integrante del sistema di regolazione della crisi: se funziona, risolve privatamente; se no, sbocca in un concordato semplificato . Dunque per il debitore è un win-win: provare la CNC non pregiudica affatto il diritto di ricorrere poi a concordato, anzi sospende eventuali termini ostativi (prima c’era il problema: se un creditore chiede fallimento, potevo proporre concordato solo prima della sentenza, ma in CNC era incerto; ora è risolto e pendente CNC non porta all’automatico fallimento, v. Trib. Bergamo 23/1/24 citato in fonti ).
- Minor impatto su responsabilità personali: come già detto, se l’imprenditore aderisce alla CNC per tempo, mostra adempimento del dovere di attivarsi tempestivamente ex art. 2086 c.c. In caso di successivo fallimento, questo può evitare accuse di tardività (bancarotta semplice) perché lui ha tentato di evitare il dissesto irreversibile . Inoltre, se dovesse emergere insolvenza penalmente rilevante (reati tributari), aver intrapreso trattative potrebbe giovare in fase di giudizio come prova di volontà di rimediare.
In conclusione, la composizione negoziata rappresenta oggi per la piccola software house indebitata la via più promettente per difendersi dai creditori e risanare l’azienda senza perdere il controllo . Come recita lo slogan, è la via più intelligente per uscire dalla crisi senza perdere l’azienda . Ovviamente non è una bacchetta magica: funziona se c’è ancora un’azienda valida da salvare (“ragionevole perseguibilità del risanamento” verificata dall’esperto). Se la situazione è disperata (azienda decotta), la CNC potrebbe solo posticipare l’inevitabile; in tal caso, però, permette almeno di gestire l’inevitabile fine in modo ordinato (verso concordato semplificato).
Caso pratico d’uso CNC: La BetaSoft S.r.l., software house, inizia a non pagare contributi e fornitori. Il socio di minoranza vuole chiedere l’amministrazione straordinaria, ma l’azienda attiva la CNC. Ottiene subito dal tribunale la protezione: i creditori non possono agire e il socio non può presentare istanze confliggenti (come deciso da Trib. Milano ord. 2/2/24 in un caso analogo di socio, cit. sopra) . L’esperto studia la situazione: BetaSoft ha un bel prodotto ma problemi di cassa. Si decide di cercare investitori. Durante la CNC, l’esperto ottiene autorizzazione a vendere un asset non core (un brevetto inutile a BetaSoft) per fare cassa e pagare i dipendenti arretrati, evitando che se ne vadano (atto autorizzato e protetto da revocatoria) . Intanto negozia con le banche la ristrutturazione dei mutui: grazie al divieto di revoca fidi, le banche mantengono le linee aperte , BetaSoft continua ad operare e consegna un progetto a un cliente, incassando liquidità. Dopo 4 mesi, un fondo di venture si dichiara disponibile ad entrare con capitale a patto di ridurre il debito fiscale. Si propone allora all’Agenzia Entrate una transazione fiscale: pagamento 50% delle imposte con stralcio di sanzioni . L’AE ci sta (o tace 90 gg, assenso) e i soci approvano l’aumento di capitale per il fondo. A questo punto, l’azienda ha un accordo quadro: banche che allungano i prestiti, fisco dimezzato, nuovo socio con capitali freschi. L’esperto attesta un piano di risanamento finale, i creditori firmano. La CNC si chiude con successo. BetaSoft è salva, i creditori ricevono magari il 70% in media dei loro crediti ma evitano il fallimento (avrebbero preso meno), i posti di lavoro sono salvi e l’azienda può crescere col nuovo socio. Questo scenario ideale mostra il potenziale: bloccare i creditori per trattare, convincere con aiuto dell’esperto, tagliare legalmente dove si può (sanzioni), e apportare risorse nuove.
6. Altri aspetti: debiti personali dei soci, profili fiscali e penali
Abbiamo finora trattato la situazione dal lato azienda. Ma spesso, specie nelle piccole realtà, la distinzione tra debiti della società e debiti dell’imprenditore/soci può sfumare. Inoltre, la gestione di una crisi porta con sé implicazioni fiscali e rischi penali che vanno considerati. Vediamo dunque:
6.1 Debiti personali dei soci o amministratori e sovraindebitamento
Una “software house” potrebbe essere una ditta individuale (dunque i debiti fanno capo direttamente all’imprenditore) o una società di persone (s.n.c., s.a.s., i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio) o una s.r.l. (soci limitatamente responsabili, di norma no obblighi personali). Inoltre, i soci o amministratori potrebbero avere garanzie personali su debiti sociali (fideiussioni, ipoteche su beni personali).
Pertanto, la crisi dell’azienda può riflettersi sul piano personale dei soggetti coinvolti. È fondamentale tenerne conto per una soluzione completa.
Società di capitali (s.r.l., s.p.a.): i soci non rispondono dei debiti sociali, quindi se l’azienda viene liquidata concorsualmente e poi cancellata, i creditori insoddisfatti non possono aggredire i soci (a meno di casi eccezionali: socio garante o azioni di malversazione) . Dunque, per i soci, l’importante è evitare di aver dato garanzie. Se le hanno date, quei creditori (es. banche) potranno comunque escuterle. In tal caso i soci guaranti dovranno affrontare il proprio indebitamento personale. Potranno farlo, se non riescono a pagare, tramite le procedure di sovraindebitamento (ora denominate concordato minore se imprenditori o piano del consumatore se consumatori). Attenzione: un socio che garantisce un debito della società non è considerato un consumatore per quel debito , in quanto è un debito contratto per finalità imprenditoriale (sua, indiretta). La Cassazione ha stabilito che la presenza anche di un solo debito di natura imprenditoriale rende inammissibile un piano del consumatore . Quindi, il socio fideiussore dovrà eventualmente ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata per liberarsi di quel debito, non al piano del consumatore . Un esempio: Tizio è socio di Beta Srl e ha garantito un mutuo. Beta Srl fa concordato e paga parzialmente le banche, la banca escute Tizio per il residuo 50k. Tizio è un privato, ma quel debito nasce dall’attività di Beta, dunque Tizio dovrà usare la procedura da sovraindebitato “non consumatore” (accordo di composizione o liquidazione persona fisica). Magari Tizio può proporre ai suoi creditori personali (inclusa la banca escutrice) un piano del consumatore misto? No, se c’è quel debito imprenditoriale, la Cassazione direbbe di no. Dovrà fare un accordo di ristrutturazione per sovraindebitati (che è simile a concordato minore, richiede 60% consensi) o direttamente liquidare il suo patrimonio personale con liquidazione controllata ed ottenere esdebitazione.
Società di persone (snc, sas): qui i soci (illimitatamente responsabili) sono co-obbligati per le obbligazioni sociali. In caso di fallimento ante 2022, fallivano anche i soci. Col CCII, se una snc entra in liquidazione giudiziale, di regola anche i soci illimitati subiscono la liquidazione del loro patrimonio (c’è una estensione automatica?). Il CCII sembra aver mantenuto l’estensione: l’art. 256 CCII prevede l’estensione della liquidazione ai soci illimitatamente responsabili. Comunque, in queste situazioni, conviene a soci e società coordinare le procedure. Il CCII prevede la possibilità di procedure di gruppo o coordinate. I soci illimitati possono presentare un concordato minore unitamente alla società o un piano familiare. Ad esempio, una snc Beta e i due soci presentano un concordato congiunto: Beta paga col suo attivo, i soci apportano magari soldi personali o vendono beni personali per aumentare il recovery, e in cambio ottengono l’esdebitazione dei debiti personali residuali. Questo si può fare in un concordato minore di gruppo (il CCII lo consente). In sede di CNC, anche i gruppi di imprese possono fare trattativa unitaria e si può includere i soci? Non formalmente, ma se i soci offrono risorse, certamente influenza il piano.
Ditte individuali/professionisti: essendo coincidenti con la persona, se fanno concordato minore o liquidazione controllata, liberano i propri debiti. Possono includere tutti i debiti personali (anche extraziendali, ad es. debito familiare). Se ne hanno troppi, esdebitazione finale permetterà di ripartire.
Implicazioni pratiche: Una strategia tipica se la società è liquidata ma rimangono debiti garantiti dai soci: spezzare il fronte. Far fare alla società il suo concordato/liquidazione per chiuderla, e contestualmente i soci fideiussori possono presentare un piano del consumatore (se la garanzia fu data a favore di società altrui, forse è considerato debito da consumo? Probabilmente no se era loro società) oppure un accordo di composizione per i debiti residui. Ad esempio, nel caso di impiantistica citato nelle fonti, proponevano: concordato minore per la società e piano del consumatore per i soci per i debiti personali da fideiussioni . Ma come visto, attenzione, la Cassazione esclude il piano del consumatore se i debiti sono “imprenditoriali” anche se personali.
Dunque, un avvocato deve valutare tutte le posizioni: non serve salvare la società se poi i soci restano con debiti ingestibili che li portano al tracollo personale (sarebbero demotivati a continuare l’attività). Idealmente, si cerca una soluzione integrata: magari i soci mettono soldi per la società e i creditori liberano i soci dalle garanzie (questo si può pattuire nell’accordo – es. banca accetta concordato con 70% pagato e rinuncia a rivalersi sul garante per il restante). Oppure i soci pagano qualcosa in un piano personale e ottengono la liberazione. Tutto dev’essere orchestrato.
6.2 Trattamento fiscale e contributivo dei debiti nelle procedure
Già toccato in precedenza, riassumiamo le regole principali relative a Fisco e contributi nelle procedure concorsuali:
- Privilegi: i crediti tributari e contributivi hanno privilegi generali sui mobili (artt. 2752 e 2753 c.c.) e, per alcune imposte, anche ipoteche su immobili. Ciò implica che in un concordato/liquidazione devono ricevere almeno quanto otterrebbero vendendo quei beni su cui hanno privilegio . Non si può dare ai privilegiati meno del valore di realizzo delle garanzie. Tuttavia, è ammesso differire il pagamento (moratoria) fino a 2 anni dall’omologazione se il piano garantisce integrale soddisfacimento . Nei concordati in continuità, questo è prassi.
- Transazione fiscale (art. 63 CCII): il debitore può proporre nel piano di concordato o accordo di ristrutturazione un trattamento agevolato per i crediti fiscali e contributivi. Questo può includere: pagamento parziale del debito (taglio del capitale fino a certe percentuali), stralcio totale di sanzioni e interessi (che di regola sono sempre falcidiabili al 100%), e dilazioni fino a 10 anni . Un professionista attestatore deve certificare che la proposta è conveniente per l’erario (dà almeno quanto la liquidazione giudiziale) . L’Agenzia Entrate ha 90 giorni per aderire o rifiutare; se tace, vale come assenso (introdotto per evitare i silenzi-endemici) . Se AE rifiuta ma la proposta era conveniente, il debitore può chiedere al giudice l’omologazione nonostante il diniego (cram-down) . Per i contributi previdenziali (INPS), analogamente l’art. 63 consente la transazione contributiva: taglio sanzioni/interessi e capitale con limite (una prassi indicava 50% capitale massimo). Il correttivo 2024 ha meglio integrato questa possibilità .
- Effetti fiscali delle riduzioni di debito: va ricordato che se un debito viene cancellato (per condono, prescrizione o concordato), si genera una sopravvenienza attiva tassabile per l’impresa (art. 88 TUIR). Tuttavia, l’art. 88 TUIR esenta da tassazione le sopravvenienze attive da concordato preventivo omologato o da accordo di ristrutturazione omologato (per evitare di penalizzare chi risana). Mentre quelle da piano attestato non sono esenti (perché non omologato): dunque se in piano attestato una banca rinuncia a 50k credito, quei 50k diventano tassabili per l’azienda come provento straordinario. Questo è da considerare: a volte conviene l’accordo omologato così l’abbattimento non genera tasse. Anche le rinunce di soci a crediti verso società possono essere esenti se fatte in attuazione di piani di risanamento (norme speciali lo prevedono).
- IVA nei concordati: prima era dibattuto se l’IVA potesse essere falcidiata in concordato, dato il vincolo europeo. La Corte Costituzionale nel 2021 (sent. 245/2021) ha aperto alla falcidia IVA se il concordato è liquidatorio e il fisco è dissenziente ma prende almeno il “valore di liquidazione”. Il CCII recepisce il principio: sì, l’IVA può essere tagliata purché non prenda meno del 100% di quanto spetterebbe in caso di fallimento. In pratica, se c’è incapienza, anche l’IVA può non essere pagata integralmente, basta che in percentuale ottenga la stessa percentuale dell’attivo che avrebbe avuto (spesso quell’attivo è zero per l’IVA se altri privilegi saturano).
- DURC: come visto, durante una procedura concorsuale in continuità (es. concordato in continuità), se si prevede di pagare i contributi nei termini del piano, l’INPS di solito può rilasciare un DURC regolare temporaneo. È prassi consentita per non bloccare cantieri e contratti pubblici. Nel concordato preventivo in continuità, la legge (art. 189 CCII) prevede che l’ammissione al concordato non costituisce di per sé motivo di esclusione da appalti, purché l’azienda presenti un piano di adempimento dei debiti contributivi. Dunque, la software house in concordato potrebbe continuare a lavorare per la PA se rispetta il piano su contributi e tributi. Viceversa, se fosse liquidatorio, il DURC è sospeso e i contratti pubblici si chiudono.
- Profili IVA cassa/IVA liquidazione: se la procedura vende beni, deve emettere fattura con IVA o può non farlo? Il curatore fallimentare quando vende emette fattura senza IVA ex art. 74bis DPR 633/72 se l’IVA sul bene era già a debito del fallito prima del fallimento. Ma nel concordato, l’imprenditore continua l’attività, quindi ad esempio vendite in continuità hanno normale IVA da versare (in prededuzione). In liquidazione concorsuale, l’IVA sulle vendite di beni mobili spesso è debito prededucibile (quindi da pagare prima di distribuire ai creditori, il che incide).
- Trattamento fiscale dei costi da procedure: le perdite su crediti per stralci concordatari sono deducibili per i creditori; per il debitore, i debiti abbandonati generano proventi esenti se concordato. Eventuali pagamenti di sanzioni e interessi, se fatti, non sono deducibili (le sanzioni mai deducibili, gli interessi di mora su tributi pare di no perché sanzioni civili assimilate).
- Fondo perduto imposte differite: talvolta nelle procedure di risanamento c’è il tema dell’utilizzo di eventuali perdite fiscali accumulate dalla società. Esempio: BetaSoft ha perdite pregresse; se risorge, quelle perdite abbatteranno utili futuri. Ma attenzione alla regola sulle continuazione dell’attività e patrimonio: in caso di concordato con accollo di debiti, le perdite fiscali potrebbero decadere se la maggioranza del capitale cambia e l’attività cambia (art. 172 c.7 TUIR). Questo è tecnico, ma in pratica, se entra un nuovo socio e i vecchi escono, c’è il rischio di perdere gli utilizzi di perdite pregresse. È un dettaglio da considerare quando un investitore subentra.
6.3 Rischi penali e come prevenirli
Abbiamo disseminato il discorso di considerazioni penali: qui li riuniamo per chiarezza sul “punto di vista del debitore”.
Reati fallimentari: se l’azienda va in liquidazione giudiziale, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere di: – Bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 L.F.): se prima del fallimento hanno distratto, sottratto o occultato beni aziendali, o aggravato dolosamente il dissesto . Esempio: vendere a prezzo vile un bene a un amico per toglierlo dalla massa, o prelevare indebitamente denaro. Oppure creare passività fittizie. Questo reato è molto grave (pena fino a 10+ anni). Prevenzione: non fare atti di spoliazione; in crisi, meglio fare tutto alla luce del sole e se serve realizzare beni, farlo a valori di mercato e documentatamente per necessità aziendale. – Bancarotta fraudolenta documentale: se l’amministrazione tiene i libri in modo da non far ricostruire il patrimonio, ad esempio occultando o falsificando contabilità . Quindi mai “truccare” libri o distruggerli. Anche gettare via fatture e perdere file contabili configura questo. La software house deve conservare tutta la contabilità e semmai presentare la situazione chiara appena c’è odore di fallimento. – Bancarotta semplice (art. 217): per comportamenti meno dolosi ma imprudenti come aver aggravato la crisi con spese personali eccessive, operazioni speculative avventate, ritardo nell’istanza di fallimento . Ad esempio, continuare a contrarre debiti sapendo di non poter pagare, oppure tardare anni prima di mollare facendo aumentare il buco, oppure non tenere le scritture contabili regolarmente. La bancarotta semplice è contravvenzione con pene minori, ma sempre da evitare. Prevenzione: agire appena ci si accorge dell’insolvenza (qui torna utile la CNC: la tempestività esclude colpa grave). Evitare di fare il “testa dura” accumulando debiti per ostinazione; potrebbe essere visto come dolo eventuale e portare a fraudolenta preferenziale se paghi solo alcuni. – Bancarotta preferenziale: se prima della dichiarazione di fallimento l’imprenditore paga o garantisce un creditore a scapito della par condicio (sapendo di essere in decozione) . Esempio: a fine corsa pagare interamente un fornitore amico e non gli altri. Questa è fraudolenta. Attenzione: la normale revocatoria non implica reato, ma se c’era intenzione di favorire uno a danno di altri, c’è illecita preferenza penale. Prevenzione: trattare tutti equamente prima del fallimento, o meglio fare i pagamenti critici solo all’interno di un piano legittimo o con autorizzazione dell’esperto/CNC (così si prova che era per necessità di prosecuzione, non per favoritismo). – Reati societari connessi: falso in bilancio (se contabilità taroccata per coprire perdite), indebita restituzione conferimenti, ecc., possono emergere in caso di crisi e peggiorare le cose.
Reati tributari correlati alla crisi: – Omesso versamento IVA e ritenute: già citati. Il solo fatto di non pagare oltre soglia entro la scadenza integra reato. Ma se prima del giudizio l’imprenditore regolarizza (paga) il debito, il reato è estinto. Utilizzare una procedura concorsuale non estingue da sé il reato, ma se con il concordato si paga l’IVA omessa prima della sentenza, il penale viene meno per adempimento del ravvedimento operoso tardivo. Dunque, un vantaggio di includere IVA in un piano e pagarla al 100% è evitare condanna penale (lo facciamo per il rappresentante legale!). Se invece la si falcidia, il reato rimarrebbe (salvo interpretazioni su cause di non punibilità per fatto non più previsto come reato? Non credo applicabile). – Emissione di fatture false: a volte imprese in crisi tentano di generare finti crediti IVA. Oltre ad essere reato fiscale grave (fino a 6 anni), peggiora il dissesto. Da evitare assolutamente. – Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): se prima o durante la riscossione coattiva il debitore simula vendite o crea trust o fondi per sottrarre beni al Fisco, è reato . E spesso concorre con bancarotta se poi fallisce. Cass. 10750/2025 ha chiarito che possono stare assieme i reati di sottrazione imposte e bancarotta impropria, senza assorbimento . Quindi se la software house, ad esempio, sposta soldi su un conto estero per non farseli pignorare, rischia art. 11. – Indebita compensazione (art. 10-quater): usare crediti tributari falsi o non spettanti per non pagare contributi o imposte è reato. Emerge spesso nelle crisi (l’azienda compensa crediti IVA fittizi per non versare INPS). Anche questo porta a guai giudiziari.
Altre fattispecie: – Usura bancaria?: a volte imprenditori disperati accusano le banche di usura interessi. In pochi casi può emergere, ma non è uno strumento difensivo robusto. Piuttosto, segnalare eventuali tassi ultralegali può far ottenere ricalcoli nel passivo. – Responsabilità penale dell’ente (D.Lgs. 231/01): in contesti di crisi, se amministratori commettono reati (es. reati tributari, ora alcuni sono presupposto 231), la società potrebbe essere sanzionata amministrativamente. Però una volta in liquidazione, questo perde significato pratico.
Come il debitore può mitigare rischi penali: 1. Agire in buona fede e trasparenza: coinvolgere consulenti, attestatori, fare relazioni veritiere. Questo può evitare allegazioni di dolo. Ad esempio, presentare un concordato con documenti falsi è reato (falso in attestazione – punibile attestatore e imprenditore se collusi). 2. Evitare atti distrattivi a priori: se serve monetizzare beni personali, farlo con prezzo giusto e immettere i fondi in azienda (così non è distrazione, ma apporto). Non “nascondere” capitali all’estero. 3. Documentare scelte: se si paga un fornitore durante crisi, appuntarsi la ragione (era indispensabile per continuare attività) e preferibilmente farlo col placet dell’esperto CNC o nell’ambito di un piano (così è difficile che lo chiamino bancarotta preferenziale). 4. Rispettare obblighi contabili: tenere libri aggiornati sino all’ultimo giorno. Consegnarli subito al curatore in caso di fallimento. 5. Non aggravare inutilmente il dissesto: se a un certo punto è palese che non c’è salvezza, meglio fermarsi e consegnarsi alla procedura (fallimento o liquidazione). Continuare ad accumulare debiti (es. continuare a ordinare forniture senza pagarle per mesi) verrà visto come colpa grave o dolo eventuale. Meglio chiudere prima (staccare la spina). 6. Consulta un penalista in anticipo: se ci sono situazioni borderline (IVA non versata etc.), pianificare la difesa: ad esempio, fare di tutto per far rientrare il debito entro certi limiti o versare almeno parziali per scendere sotto soglia prima di bilanci.
Esempio negativo: SoftTech srl in crisi dal 2023 smette di pagare IVA e contributi, ma continua a incassare dai clienti e i soci prelevano soldi per sé. Nel 2025 fallisce. Gli amministratori rischiano: bancarotta fraudolenta per distrazione (soldi portati via invece di pagare il fisco), bancarotta fraud. preferenziale se hanno pagato prima la banca garantita, omesso versamento IVA come reato fiscale. Un disastro.
Esempio positivo: DataSoft srl in crisi attiva CNC nel 2024 quando vede che non potrà pagare IVA di dicembre. Durante CNC, con accordo, paga l’IVA (magari dilazionata) e vende un’auto aziendale per pagare gli stipendi. Fallisce comunque nel 2025 (nonostante tentativi). Però: ha pagato l’IVA -> niente reato omesso versamento; ha venduto asset con autorizzazione -> niente bancarotta; ha provato CNC -> ridotto aggravamento. Forse verrà accusato solo di bancarotta semplice per l’insuccesso, ma con buone chance di essere assolto per aver fatto il possibile. Otterrà esdebitazione perché mostratosi diligente. Questa differenza di approccio cambia completamente lo scenario legale post-crisi per il debitore.
Con quanto sopra, abbiamo delineato in modo esteso e dettagliato cosa può fare una piccola software house indebitata per difendersi e cercare di uscire dalla crisi, esplorando strumenti negoziali e concorsuali, implicazioni normative aggiornate a settembre 2025 e riferimenti a sentenze e prassi più recenti.
Nel capitolo seguente risponderemo in forma sintetica ad alcune domande frequenti, per chiarire dubbi comuni di imprenditori-debitori e offrire un ulteriore riepilogo pratico delle nozioni trattate.
7. Domande frequenti (FAQ) su debiti e difese per la software house
D: Una piccola SRL “software house” può essere dichiarata fallita oppure no, essendo piccola?
R: Sì, anche le piccole società possono essere soggette a procedure concorsuali, sebbene con qualche particolarità. In passato le imprese “sotto soglia” (attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k) non potevano fallire, ma oggi il Codice della crisi ha introdotto procedure ad hoc per loro (il concordato minore e la liquidazione controllata) . Inoltre, il concordato semplificato è aperto a qualsiasi imprenditore (anche piccolissimo) purché abbia tentato la composizione negoziata . Quindi, pur se tecnicamente una micro impresa non subisce la “liquidazione giudiziale” classica, può comunque essere coinvolta in una liquidazione concorsuale (controllata) o usare concordati minori. In altre parole: nessuno è davvero “immune” dal concorso se insolvente; la legge ha solo differenziato le procedure in base alla dimensione.
D: Cosa rischiano personalmente gli amministratori o i soci se la società non paga i debiti?
R: Dipende dal tipo di società e dalle loro azioni: – Se è una SRL o altra società di capitali, i soci godono di responsabilità limitata: non rispondono dei debiti sociali con i propri beni . Eccezioni: se hanno prestato garanzie personali (fideiussioni), allora il creditore può escutere il socio per il debito non pagato in procedura . Oppure se hanno compiuto abusi (es. confusione patrimoni, sottocapitalizzazione dolosa) potrebbero essere chiamati a rispondere per responsabilità verso creditori. L’amministratore invece può avere responsabilità civili verso la società (azione di responsabilità se ha aggravato i danni) e rischia responsabilità personali per alcuni debiti specifici: ad esempio, se non versa l’IVA o le ritenute fiscali può incorrere in sanzioni e reati a titolo personale; se non paga contributi dipendenti oltre €10k annui commette reato. Inoltre, in caso di fallimento, l’amministratore può essere accusato di bancarotta se ha commesso irregolarità (distrazioni, preferenze, mala gestione) . Tuttavia, semplicemente essere amministratore di una SRL fallita non comporta di per sé debiti personali (i crediti rimasti insoddisfatti muoiono con la società) , né un divieto perpetuo di fare impresa (salvo interdizioni temporanee se condannato penalmente). – Se è una società di persone (snc, sas), i soci illimitatamente responsabili rispondono con il loro patrimonio di tutti i debiti sociali. Quindi se l’azienda non paga, i creditori possono rifarsi sui soci (anche chiedendone il fallimento personale, in estensione). Il Codice della crisi in tal caso prevede la liquidazione controllata anche per i soci. Per limitare i danni, i soci possono fare un concordato minore per ristrutturare i loro debiti personali parallelamente a quelli sociali. – Ditte individuali: qui non c’è separazione: il titolare risponde con i suoi beni di tutto. Può però accedere a procedure da sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore) e all’esdebitazione finale per liberarsi dai debiti residuali.
In sintesi, il socio di SRL per i debiti sociali in sé non rischia il patrimonio personale , mentre il socio illimitato o l’imprenditore individuale sì. L’amministratore però rischia sul piano penale se ha violato obblighi di legge (tributari, fallimentari).
D: Vale la pena tentare la composizione negoziata della crisi o conviene andare subito in concordato?
R: Nella gran parte dei casi vale la pena tentare la composizione negoziata prima. La composizione negoziata è riservata, rapida e flessibile, e permette di negoziare un risanamento con l’aiuto di un esperto senza gli oneri di una procedura pubblica . Se funziona, si può evitare del tutto il concordato (che è più lungo e costoso). Ad esempio, nella composizione puoi trovare un accordo con le banche e i fornitori, ottenendo magari dilazioni e nuovi finanziamenti, e risanare l’azienda senza far sapere nulla al mercato. Il concordato preventivo è invece formale, richiede di essere già insolvente conclamato, comporta il voto dei creditori e l’intervento del tribunale . Si usa quando serve obbligare creditori dissenzienti o quando la composizione fallisce. Dunque l’approccio suggerito dal legislatore è: prima provi la via negoziale (CNC), poi, se non basta, c’è sempre la procedura concorsuale classica . Molte aziende riescono a evitare il concordato proprio grazie a un accordo raggiunto in composizione . In sintesi: tentare la CNC offre potenziali benefici senza precludere il concordato dopo; al contrario, aprire subito un concordato impedisce di provare soluzioni più “soft”. Quindi meglio iniziare in via stragiudiziale e riservata.
D: Nel piano posso includere i debiti col Fisco e con l’INPS, e magari ridurli?
R: Sì. Nelle procedure concorsuali omologate (accordi di ristrutturazione e concordati) la legge oggi consente espressamente di proporre una transazione fiscale e contributiva . Puoi quindi includere i debiti tributari (IVA, imposte dirette, etc.) e contributivi e offrire di pagarli solo in parte (ad esempio il 50%) e/o diluirli fino a 10 anni, nonché annullare sanzioni e interessi . L’importante è che l’offerta sia conveniente rispetto a cosa otterrebbe il Fisco/INPS in un fallimento (quindi di solito devi offrire almeno il valore di realizzo dei beni su cui hanno garanzia) . Se l’Erario (Agenzia Entrate) non risponde entro 90 giorni, il silenzio vale assenso – una novità del 2021/2022. E se rifiuta ma la tua proposta era vantaggiosa, il tribunale può omologare lo stesso (cram-down). Fuori dalle procedure, invece, non puoi unilateralmente ridurre il debito fiscale o contributivo: al massimo ottieni dilazioni (rateazioni) o aderisci a una “rottamazione” se prevista per legge. Quindi, se hai un grande debito fiscale e vuoi tagliarlo, devi passare da un accordo omologato o concordato. Da poco, anche nella composizione negoziata (fase stragiudiziale) è stato ammesso di negoziare una transazione col Fisco , ma resta un accordo volontario. Diciamo che lo strumento più forte per “stralciare” imposte e contributi è il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale . Lì puoi proporre, ad esempio: pagherò il 100% dell’IVA e il 30% di Irpef e Inail, azzerando sanzioni. L’ente valuterà. Ricorda comunque che l’IVA e le ritenute non versate implicano reati se sopra soglia: falcidiarle nel piano non cancella il reato, se non le paghi poi potresti rispondere penalmente. Perciò spesso si tende a offrire il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute in qualsiasi piano (o almeno sopra soglia di non punibilità), e semmai tagliare altre imposte o interessi.
D: Cosa succede se durante la composizione negoziata un creditore cerca comunque di portare la società in tribunale o pignora beni?
R: Se sono state attivate le misure protettive dal tribunale, i creditori non possono procedere con azioni esecutive o cautelari . Ciò significa che qualsiasi pignoramento iniziato viene sospeso e non se ne possono iniziare di nuovi. Anche i termini per fare istanza di fallimento sono sospesi. Quindi, ad esempio, un creditore che provi comunque a notificare un pignoramento di un conto violerebbe il divieto e l’atto sarebbe inefficace (l’istituto bancario non dovrebbe eseguirlo). Inoltre, per legge le banche non possono revocare fidi né ridurre affidamenti solo perché hai avviato la composizione . Non possono neppure segnalare a Centrale Rischi il fatto che stai negoziando e sospendendo pagamenti . Dunque, con le misure protettive attive, sei al riparo da quelle reazioni “a catena” dei creditori. Se qualche creditore prova a forzare, puoi segnalarlo al tribunale che ha emesso le misure: tipicamente il giudice le rinnoverà e richiamerà all’ordine il creditore. Caso diverso: se non hai chiesto misure protettive, i creditori tecnicamente potrebbero agire. Tuttavia, spesso in composizione negoziata senza misure c’è un tacito accordo a congelare. Ma è rischioso. Quindi conviene chiedere la protezione salvo tu sia certo che nessuno agirà. Infine, se un creditore presenta istanza di fallimento mentre sei in composizione, oggi la legge prevede che non venga dichiarato fallimento immediatamente: la pendenza della composizione è causa di improcedibilità temporanea (c’era confusione inizialmente, ma il “correttivo-ter” 2024 ha chiarito che anche con istanza pendente puoi accedere a CNC e al concordato semplificato) . Quindi, di fatto, sei protetto dal fallimento finché la CNC è in corso e rispetti le condizioni.
D: Qual è la differenza tra concordato preventivo “normale” e concordato semplificato?
R: Riassumiamo le principali differenze: – Il concordato preventivo tradizionale prevede il voto dei creditori e può essere sia in continuità (l’azienda prosegue l’attività) sia liquidatorio . Il concordato semplificato, invece, è solo liquidatorio (serve a liquidare il patrimonio) e non ha voto dei creditori . – Per accedere al concordato preventivo standard devi essere in stato di insolvenza (o crisi) e devi avere i requisiti dimensionali (non essere piccolissimo). Nel semplificato, puoi essere anche piccolissimo o imprenditore agricolo, perché l’unico requisito soggettivo è aver fatto la composizione negoziata . Anche imprenditori sotto soglia o agricoltori, esclusi dal preventivo ordinario, possono fare il semplificato . – Nel preventivo ordinario vengono nominati dal tribunale un commissario giudiziale e un giudice delegato che controllano l’azienda durante la procedura . Nel semplificato no: niente commissario né giudice delegato . Solo eventualmente un esperto ausiliario del giudice per valutare il piano e poi, dopo omologa, un liquidatore giudiziale che vende i beni . Quindi il semplificato è più snello e meno costoso. – Tempi e approvazione: nel preventivo ordinario i creditori votano e serve la maggioranza, poi il giudice omologa se tutto regolare. Nel semplificato decide tutto il tribunale senza voto dei creditori, i quali al massimo possono fare opposizione dopo (il giudice valuta le opposizioni ma se ritiene il piano conveniente per la massa, può omologare nonostante il dissenso) . Ciò rende il processo molto più veloce (niente adunanza, niente attesa voti). – Pagamento minimo ai chirografari: nel concordato preventivo liquidatorio la legge prevede (salvo modifiche) una percentuale minima da garantire ai creditori chirografari (indicativamente 20% nel CCII attuale) . Nel concordato semplificato non c’è alcuna percentuale minima obbligatoria . Puoi proporre anche pochi centesimi per euro, se purtroppo il patrimonio è limitato. Tuttavia, devi garantire a ogni creditore un’utilità non inferiore a quella che avrebbe nella liquidazione fallimentare (non puoi dare zero se avrebbe avuto qualcosa) . Ad esempio, non puoi escludere del tutto una categoria se in fallimento avrebbe recuperato, fosse anche tramite benefici fiscali. – Continuità aziendale: nel preventivo ordinario puoi anche mantenere in vita l’azienda (continuità diretta o tramite affitto/cessione a terzi con continuità) . Nel semplificato no continuità: l’unico scopo è liquidare il patrimonio e cessare l’attività il prima possibile . Il tribunale di Milano 2025 ha proprio ribadito che nel semplificato non è ammessa la prosecuzione dell’attività se non finalizzata immediatamente alla cessione dei beni . – Quando si applicano: il concordato preventivo è per qualunque situazione (quando decidi tu di attivarlo, se insolvente e sopra soglia). Il semplificato è uno strumento eccezionale per i casi in cui hai provato la composizione negoziata senza soluzione . Non puoi saltare direttamente al semplificato: è come un “piano B” se fallisce il tentativo stragiudiziale. – Esempio pratico: nel preventivo ordinario devi elaborare un piano dettagliato, sottoporlo al voto di classi di creditori, convincere le maggioranze e c’è un commissario che supervisiona. Nel semplificato presenti una proposta di cessione dei beni, c’è un’udienza di omologa, i creditori se vogliono fanno reclamo, e il giudice decide; poi nomina un liquidatore che fa le vendite. Nessuna votazione, meno lungaggini .
In breve, il concordato semplificato è una versione speciale, più rapida e senza voto, utilizzabile solo a valle di una composizione negoziata fallita, per chiudere la crisi liquidando l’azienda senza passare anni in fallimento . Il preventivo ordinario è la procedura concorsuale standard con voto e possibili scenari di continuità.
D: Se la società viene liquidata (concordato o fallimento), i debiti che restano chi li paga? I soci possono aprire un’altra attività?
R: Se parliamo di una SRL o altra società di capitali, al termine della procedura concorsuale la società sarà cancellata e i debiti sociali insoddisfatti restano inesigibili perché il debitore (la società) non esiste più . I soci non ne rispondono, a meno che avessero dato garanzie personali. Quindi, i creditori non soddisfatti perdono quei soldi (salvo rifarsi su garanti). I soci sono liberi di costituire una nuova società e proseguire l’attività con quella (è frequente che, chiusa una società in dissesto, i soci ne aprano un’altra “pulita” – questo è legittimo se non ci sono stati abusi). Ci sono però alcune limitazioni da considerare: – Se l’amministratore o socio ha commesso reati fallimentari, potrebbe subire interdizioni (tipo il divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di società per 5-10 anni). – Inoltre, in certi contesti normativi specifici, chi ha avuto ruoli in società insolventi può avere restrizioni (ad esempio per accedere a ruoli pubblici o bandi per start-up innovative vi sono requisiti di onorabilità). Ma in linea generale, sì, i soci possono ripartire con un nuovo progetto. Anzi, la ratio dell’esdebitazione e della responsabilità limitata è proprio dare una seconda chance senza il peso dei vecchi debiti . Se invece parliamo di un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, la procedura concorsuale (liquidazione controllata) liquida anche i suoi beni personali, ma i debiti residui in capo a lui (persona fisica) possono essere cancellati tramite la procedura di esdebitazione . L’esdebitazione, se concessa dal tribunale a fine procedura, libera il debitore persona fisica da tutti i debiti non soddisfatti (eccetto pochissime eccezioni). Quindi, ad esempio, un imprenditore individuale dopo la liquidazione controllata ottiene l’esdebitazione e potrà avviare una nuova attività senza quei debiti pregressi. Quindi, anche in quel caso, si può ripartire, con la tranquillità di avere il “saldo zero” sui vecchi debiti (certo, avrà perso eventualmente beni personali liquidati, ma non avrà ulteriori pretese sui suoi futuri guadagni da parte dei vecchi creditori) .
Diciamo che l’ordinamento attuale incentiva il fresh start: chiudere l’impresa decotta, liberare l’imprenditore onesto dai debiti e permettergli di creare magari una nuova impresa di successo (portandosi l’esperienza accumulata, anche degli errori). L’importante è non fare “phoenix company” in modo illecito (tipo spogliare la vecchia e trasferire tutto alla nuova a danno dei creditori: quello sarebbe bancarotta fraudolenta). Ma se tutto avviene con trasparenza (creditori informati, procedure seguite), è lecito.
D: Quanto costa affrontare queste procedure e chi paga questi costi?
R: Ci sono costi di diversa natura: – Nella fase stragiudiziale (es. composizione negoziata) i costi sono contenuti: non ci sono contributi unificati da pagare, solo il compenso dell’esperto nominato. L’esperto viene pagato dall’impresa secondo parametri ministeriali (in base all’attivo e al risultato). Come aggiornato nel 2024, non si può pattuire in anticipo un compenso con l’esperto e questo verrà determinato alla fine in base all’opera svolta . Se la CNC riesce con un accordo, l’esperto prende un bonus (fino al doppio). Se fallisce, prende il minimo (che però è stato aumentato un po’ per garantire dignità) . Parliamo di qualche migliaio di euro per PMI (per grandi gruppi i compensi salgono, ma per una software house piccola il compenso dell’esperto potrebbe essere ad esempio €5.000-10.000). L’impresa inoltre potrebbe pagare i propri consulenti (avvocato, commercialista) per assisterla: quelli sono costi variabili (c’è stato un credito d’imposta su parte di essi entro un tetto, per alleggerire). Questi costi, in caso di successo, sono poca cosa rispetto ai benefici; in caso di insuccesso, al massimo avranno leggermente aumentato il passivo (ma l’esperto no, perché credo il suo compenso sia prededucibile in eventuale fallimento quindi viene prima degli altri). – Nelle procedure concorsuali vere e proprie (concordati, accordi, liquidazioni) i costi aumentano. Bisogna considerare: – Il compenso del commissario giudiziale (nel concordato ordinario) o del liquidatore giudiziale (nel concordato semplificato o liquidazione). Questo compenso è stabilito dal tribunale a fine procedura, in percentuale sull’attivo e sull’effettivo lavoro. Più l’impresa è grande e la procedura complessa, più sale (può essere qualche percento dell’attivo realizzato). – Il compenso dell’attestatore indipendente che redige la relazione (nel concordato o accordo serve). Questo di solito è contrattato col professionista e pagato dall’impresa (in prededuzione, quindi se poi fallisce quell’onorario è un credito prededucibile). – Le spese legali per gli avvocati che seguono la procedura, eventuali onorari del tribunale (c’è un contributo unificato per il ricorso di concordato di alcune centinaia di euro). – Tutti questi costi di procedura sono prededucibili, significa che nel piano vanno calcolati e verranno pagati prima di soddisfare i creditori. Per esempio, se hai attivo 100 e costi procedura 10, ai creditori ne andranno 90. Se l’attivo non basta neppure a pagare i costi, può succedere che la procedura venga chiusa per insufficienza (in fallimento spesso lo Stato si accolla parte spese non coperte). Nel concordato, devi dimostrare di saper coprire i costi, altrimenti non te lo omologano. – Indicativamente, un concordato preventivo può costare un 5-10% dell’attivo in oneri (commissario + spese), oltre ai consulenti. Un concordato semplificato costerà meno perché niente commissario (solo liquidatore poi). Una liquidazione giudiziale costa anch’essa una percentuale (il curatore ha un compenso liquidato per scaglioni sul attivo realizzato). – Chi li paga? In prima battuta li paga l’azienda con le sue risorse, in quanto costi della procedura. Se c’è cassa disponibile, verranno prelevati da lì man mano (ad es. un commissario può chiedere acconti). Se non c’è cassa, i professionisti spesso aspettano di essere pagati con le vendite dei beni. Se la procedura va in default e non ci sono soldi per pagarli, una parte può rimanere a carico Erario (in fallimento c’è un fondo per spese). Ma ovviamente professionisti e tribunale cercano di evitare di lavorare gratis: ad esempio in concordato ti chiedono prove che puoi pagare almeno spese, se no non procedono. – Da notare: i crediti sorti dopo l’apertura di una procedura autorizzata (prededucibili) vanno pagati prima di tutto, altrimenti la procedura rischia la conversione in fallimento. Ad esempio, se in concordato in continuità contrai nuovi debiti e non li paghi regolarmente, il concordato può essere revocato.
In sintesi: affrontare una crisi con gli strumenti legali comporta certamente dei costi (esperti, legali, attestatori, organi vari). Tutti questi costi devono essere stimati e inseriti nel piano, e alla fine sono sopportati dal patrimonio dell’impresa (quindi indirettamente dai creditori, perché riducono ciò che resta per loro). Tuttavia, sono il “prezzo” da pagare per risolvere la situazione in modo ordinato. Spesso, questi costi sono molto inferiori rispetto al danno che si avrebbe senza procedura (es. contenziosi frammentati, esecuzioni disordinate che bruciano valore). Ad esempio, pagare un commissario 10.000 € può sembrare tanto, ma se grazie al concordato i creditori recuperano 200k invece di zero, è ben speso. Va anche detto che le procedure per PMI sono state semplificate proprio per ridurre i costi (es. semplificato, niente commissario). Quindi, per rispondere direttamente: i costi di procedure e consulenze vanno a carico dell’impresa (prededucibili nella massa), e devono essere considerati nel decidere la via (se il patrimonio è minuscolo, un concordato può non valere la candela, meglio la chiusura diretta).
D: Che succede in pratica ai contratti in corso (clienti, fornitori) e al DURC durante una procedura concorsuale?
R: Dipende dalla procedura e se c’è continuità: – In un concordato preventivo in continuità, la regola è che i contratti pendenti non si risolvono automaticamente. L’azienda può chiedere al tribunale di autorizzarla a sciogliersi da contratti eccessivamente onerosi o non più utili, pagando eventualmente un indennizzo contrattuale in prededuzione . Se non chiede nulla, i contratti proseguono regolarmente (la controparte però può chiedere garanzie di adempiere). Ad esempio, se la software house ha un contratto di locazione ufficio, in concordato può decidere di continuarlo (pagando regolarmente i canoni post-ammissione in prededuzione) oppure chiedere di scioglierlo se non serve più. Nel concordato liquidatorio, di solito l’attività cessa e i contratti vengono risolti o ceduti. Il curatore o liquidatore può interrompere forniture, licenziare personale ecc. (con le tutele di legge del caso: es. può licenziare per cessazione attività col nulla osta del giudice delegato). – DURC: Durante una procedura, la regola generale sarebbe che se ci sono debiti contributivi, il DURC è irregolare. Tuttavia, normative speciali consentono DURC provvisori in presenza di piani. Nello specifico, con il DL 69/2013 e seguenti, un’azienda in concordato preventivo con continuità può ottenere il DURC se inserisce nel piano il pagamento integrale dei contributi, anche se non li ha ancora pagati, purché rispetti le scadenze del piano . Questo per non farla escludere da appalti. Quindi, per la nostra software house, se è in concordato in continuità e ha debiti INPS, dovrà prevedere di pagarli magari dilazionati ma al 100%, in modo da ottenere subito un DURC valido e poter continuare a lavorare con clienti pubblici o strutturati (che lo richiedono). Se invece la società va in liquidazione o fallimento, il DURC ovviamente cessa di essere rilevante (l’attività è chiusa, quindi non deve partecipare a gare). – Durante la composizione negoziata o accordo, formalmente se hai debiti contributivi il DURC risulta negativo. Però nulla vieta di accordarsi con INPS: ad esempio, se presenti un piano di rientro contributi all’INPS e inizi a pagare le rate, l’INPS a volte concede un DURC “in corso di regolarizzazione”. E come detto, in concordato o accordo omologato, c’è proprio la norma che consente di considerare regolare il DURC se i debiti contributivi sono coperti da transazione approvata e stai rispettando quelle scadenze . – Contratti con la PA: attenzione, il codice appalti prevede che l’ammissione a concordato non esclude l’azienda da un appalto in corso (art. 94 D.Lgs. 36/2023), ma l’azienda deve poter dare garanzie di esecuzione. Se è concordato in continuità, di solito la PA può continuare il contratto, se è liquidatorio la PA può risolvere. Se la software house ha contratti di fornitura, i clienti privati magari sono preoccupati se sanno del concordato; tuttavia non possono risolvere ipso facto per il concordato (clausole risolutive per fallimento non si applicano al concordato, se in continuità). Devono rispettare i termini, e l’azienda pure (i crediti da eseguire dopo l’apertura concordato sono prededucibili, quindi quei fornitori vanno pagati regolarmente). – Fornitori durante la procedura: quelli anteriori diventano creditori concorsuali e non forniranno più se non a pagamento anticipato o dietro autorizzazione di pagamento in prededuzione (fornitura essenziale). Ad esempio, nel concordato il debitore può pagare in prededuzione i fornitori essenziali per la continuazione (dietro autorizzazione del tribunale), altrimenti quelli non consegnano. Questi pagamenti sono ammessi pur essendo debiti ante procedura, se servono a evitare l’interruzione (specie utilities, ecc.). – Employees (dipendenti): in continuità restano dipendenti e maturano stipendi prededucibili (devono essere pagati regolarmente). In liquidazione invece il liquidatore li licenzia subito (o chiede cassa integrazione se disponibile) e maturano TFR e competenze che diventano crediti privilegiati. Il Fondo di garanzia INPS poi li paga e subentra (come già spiegato). – In un concordato semplificato o liquidazione controllata, i contratti cessano con la liquidazione (salvo se vendi l’azienda intera, il compratore potrà subentrare). Nel semplificato c’è stata una pronuncia (Trib. Lecce 30/10/23) dove hanno venduto l’azienda a un terzo nel contesto del concordato semplificato , quindi il terzo ha presumibilmente continuato i contratti.
Riassumendo: durante le procedure, se c’è l’intenzione di proseguire l’attività, la legge offre strumenti per mantenere attivi i contratti (nessuna risoluzione automatica) e per avere un DURC regolare e non essere tagliati fuori dalle commesse pubbliche . Se invece l’attività cessa, i contratti vengono risolti e il DURC diventa irrilevante (anzi, in fallimento la PA rescinde i contratti per cessazione soggetto).
Simulazione pratica finale: SoftwareX S.r.l. ha €300k di debiti (100k banca con ipoteca su sede, 50k debiti fornitori, 50k debiti fiscali, 30k INPS, 70k altre passività) e un prodotto software innovativo in sviluppo. Fatturato in calo, cassa quasi zero. Tenta la composizione negoziata: ottiene standstill, coinvolge investitori; purtroppo l’investitore offre di comprare solo il software non finito per 50k e nessuno vuole finanziare la continuazione. Con l’aiuto dell’esperto, la società capisce che non riuscirà a proseguire l’attività in modo redditizio. Allora opta per un concordato semplificato: propone di cedere il software e i pochi asset (pc, ecc.) e distribuire i €50k ottenuti. Il giudice verifica: la banca ipotecaria prenderebbe ad es. €30k (valore sede) su 60k dovuti, l’Erario 5k su 50k (10%) ma in fallimento avrebbe preso forse nulla perché ipoteca banca copriva sede e mobile non c’era attivo; i fornitori chirografari prendono 10% pure loro; totale 50k. Approva. In 6 mesi si vende, si ripartisce. SoftwareX è cancellata. Il socio aveva garantito la banca per 20k scoperti: ora la banca incassa 30k dal concordato e escute il socio per gli altri 30k. Il socio, rimasto con questo debito, avvia una liquidazione controllata personale (ha pochi beni, una casa modesta esente da ipoteca perché prima casa non di lusso, quindi in sostanza poco da prendere). Dopo la liquidazione, ottiene l’esdebitazione del debito residuo. Risultato: l’azienda è chiusa ordinatamente, i creditori hanno avuto almeno qualcosa velocemente (forse più che in fallimento), il socio ha perso la partecipazione e liquidato ciò che poteva ma poi è stato liberato dal debito residuo. Egli può quindi (con cautela) lanciare una nuova attività tra qualche anno, avendo imparato la lezione. I dipendenti di SoftwareX hanno usufruito del Fondo INPS per TFR e ferie non godute. Nessuno è finito imputato penalmente perché tutto è stato fatto alla luce del sole; anzi, aver seguito la CNC e il concordato aiuta a mostrare correttezza. Questo scenario mostra una via di uscita dignitosa da una crisi irreversibile.
In conclusione, per una piccola software house con debiti è fondamentale agire tempestivamente, valutare la gravità della crisi e utilizzare gli strumenti legali appropriati (negoziali o concorsuali) per gestire e ridurre l’esposizione debitoria. Dal punto di vista del debitore, esistono oggi molte opportunità di difesa: accordi con i creditori, piani attestati con protezioni, composizione negoziata con supporto esperto, concordati per risanare in continuità o, se necessario, procedure di liquidazione guidate e mitigate (concordato semplificato, esdebitazione) per non trascinarsi indefinitamente il peso dei debiti. La chiave è affrontare la situazione con trasparenza e buonafede, facendosi assistere da professionisti specializzati, così da massimizzare le chance di salvare l’azienda se è salvabile, o quantomeno di chiudere la crisi limitando i danni economici e personali.
Gestisci una software house o startup tecnologica e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori, dipendenti o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Gestisci una software house o startup tecnologica e ti ritrovi con debiti verso banche, fornitori, dipendenti o Agenzia delle Entrate?
Hai mutui o leasing per server e hardware, cartelle esattoriali o contributi arretrati, e temi pignoramenti, blocchi bancari o la chiusura dell’attività?
👉 Non sei solo: molte software house, anche innovative, si trovano in difficoltà a causa della pressione fiscale e della volatilità del mercato digitale.
La buona notizia è che oggi puoi difenderti legalmente, bloccare i creditori, ridurre i debiti e rilanciare o chiudere in modo protetto la tua attività, grazie agli strumenti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019).
In questa guida scoprirai perché le piccole software house accumulano debiti, quali soluzioni legali puoi adottare e come ottenere una vera seconda possibilità.
💻 Perché le software house finiscono in crisi
Il settore IT e digitale, pur in crescita, presenta molte criticità economiche per le piccole realtà:
- Pagamenti ritardati o mancati da clienti e PA;
- Investimenti iniziali elevati in server, licenze, hardware e sviluppo;
- Calo della liquidità dovuto a progetti non conclusi o non incassati;
- Tassazione e contributi elevati rispetto ai ricavi;
- Errori di pianificazione finanziaria o costi fissi non sostenibili;
- Competizione internazionale che riduce i margini di guadagno.
📌 Questi fattori portano molte piccole software house a indebitarsi progressivamente, fino a trovarsi schiacciate da debiti fiscali, bancari e commerciali.
🧾 I debiti più comuni nelle software house
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IVA, IRPEF, INPS, INAIL, TARI, cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Leasing e prestiti per server, computer, mobili d’ufficio e software a pagamento.
- Fidi aziendali e scoperti di conto.
✅ Debiti commerciali
- Fatture non saldate a collaboratori freelance, agenzie di marketing, fornitori di licenze o servizi cloud.
✅ Debiti verso dipendenti o collaboratori
- Stipendi arretrati, contributi non versati, TFR non pagato.
✅ Debiti personali o fideiussioni
- Garanzie firmate dai soci o amministratori per prestiti aziendali.
⚠️ Cosa rischia una software house indebitata
Se non affronti la situazione, i creditori possono:
- pignorare conti correnti e crediti verso clienti;
- revocare fidi e linee di credito, bloccando i flussi di cassa;
- sequestrare server, hardware o beni aziendali;
- iscrivere ipoteche o avviare azioni giudiziarie;
- bloccare i rapporti con clienti pubblici e privati.
👉 Tuttavia, la legge oggi tutela anche le imprese del settore digitale, consentendoti di bloccare le azioni dei creditori, ristrutturare i debiti e ripartire legalmente e in sicurezza.
🧩 Le soluzioni legali per una software house con debiti
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
Con l’assistenza legale puoi trattare accordi di saldo e stralcio o piani di pagamento personalizzati, ottenendo:
- riduzioni del debito complessivo (anche fino al 70%);
- rateizzazioni sostenibili, legate ai flussi di cassa;
- sospensioni temporanee delle rate per riprendere fiato.
👉 È la soluzione più rapida per chi vuole continuare a lavorare e mantenere i clienti.
💠 2. Concordato minore (per SRL o società di persone)
Previsto dal Codice della Crisi d’Impresa, consente alle società di:
- bloccare immediatamente pignoramenti e azioni dei creditori;
- ristrutturare i debiti tramite un piano approvato dal Tribunale;
- mantenere attivi contratti, dipendenti e commesse.
📌 È ideale per software house con più soci e personale da salvaguardare.
💠 3. Procedura di sovraindebitamento (per ditte individuali e piccoli imprenditori)
È lo strumento più efficace per chi ha una microimpresa o una piccola partita IVA nel mondo IT.
Consente di:
- bloccare subito i creditori e sospendere pignoramenti e cartelle;
- proporre un piano di rientro parziale, sostenibile nel tempo;
- ottenere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione).
👉 Perfetta per chi lavora come sviluppatore indipendente o titolare di una piccola software house artigiana.
💠 4. Liquidazione controllata dei beni (ex fallimento personale)
Se l’attività non è più recuperabile, puoi chiudere in modo legale e protetto, mettendo a disposizione solo i beni non essenziali.
Alla fine, il Tribunale cancella tutti i debiti residui, permettendoti di ripartire senza pendenze fiscali o bancarie.
💠 5. Verifica e contestazione delle cartelle esattoriali
Molti debiti fiscali derivano da errori o notifiche irregolari.
Un avvocato può:
- controllare la prescrizione (5 o 10 anni);
- eccepire errori di calcolo o vizi formali;
- chiedere la sospensione o l’annullamento parziale del debito.
🧠 Cosa fare subito
✅ 1. Raccogli tutte le informazioni sui debiti
Prepara cartelle, mutui, bilanci, contratti, fatture e crediti verso clienti.
✅ 2. Blocca immediatamente le azioni dei creditori
Con il deposito di una procedura di sovraindebitamento o concordato, pignoramenti e cartelle vengono sospesi per legge.
✅ 3. Evita di accendere nuovi prestiti o firmare rateizzazioni “capestro”
Serve una strategia complessiva, approvata dal Tribunale, che tuteli i tuoi beni e la tua attività.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Visura camerale e bilanci societari.
- Dichiarazioni fiscali e posizione INPS/INAIL.
- Contratti di leasing o mutuo.
- Cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
- Elenco fornitori, collaboratori e clienti.
- Estratti conto bancari e documentazione contabile.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi e valutazione legale: 1–3 settimane.
- Deposito del piano o della procedura: 1–2 mesi.
- Blocco dei creditori: immediato al deposito.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Stop a pignoramenti, ipoteche e cartelle.
- Riduzione o cancellazione totale dei debiti residui.
- Tutela dei beni aziendali e personali.
- Ripartenza economica e professionale in regola.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni di recupero crediti.
✅ Riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Continuità operativa durante la procedura.
✅ Tutela di contratti, dipendenti e strumenti informatici.
✅ Possibilità di chiudere in modo ordinato e ripartire pulito.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o notifiche dell’Agenzia delle Entrate.
- Accumulare nuovi debiti per coprire i vecchi.
- Pagare solo alcuni creditori peggiorando la situazione complessiva.
- Rivolgerti a “consulenti del debito” non avvocati o non abilitati.
- Aspettare troppo: ogni mese di ritardo peggiora la posizione.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione economica e debitoria nel dettaglio.
📌 Ti guida nella scelta della soluzione più vantaggiosa (rinegoziazione, concordato, sovraindebitamento o liquidazione).
✍️ Redige e deposita il piano legale in Tribunale per bloccare subito i creditori.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con Agenzia delle Entrate, banche, fornitori e collaboratori.
🔁 Ti accompagna fino alla cancellazione definitiva dei debiti o alla ristrutturazione completa della tua attività IT.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto commerciale, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di software house, startup digitali e imprese IT indebitate.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere una software house con debiti non significa essere destinati a fallire.
Con una difesa legale tempestiva e strutturata, puoi bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti fiscali e bancari e continuare a operare o chiudere in modo ordinato e senza fallimento.
La legge oggi tutela chi agisce in buona fede e vuole ripartire in modo legale e sostenibile.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova release professionale senza debiti comincia oggi.