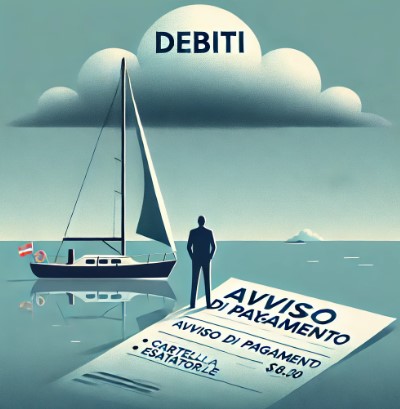Lavori come skipper professionista o gestisci un’attività legata alla nautica e ti trovi in difficoltà economica per via di debiti con il Fisco, l’INPS o le banche?
Negli ultimi anni, molti skipper, comandanti e lavoratori del settore nautico hanno accumulato debiti a causa dell’aumento dei costi di gestione delle imbarcazioni, della stagionalità dei lavori e dei ritardi nei pagamenti dei clienti o delle società di charter.
Quando iniziano ad accumularsi cartelle esattoriali o insoluti bancari, la situazione può degenerare rapidamente, con pignoramenti, fermi amministrativi e blocchi dei conti correnti.
La buona notizia è che la legge offre strumenti concreti per difendersi, rateizzare o cancellare i debiti, salvando la propria attività e il proprio futuro professionale.
In questa guida spieghiamo cosa fare, come gestire un indebitamento crescente e quali soluzioni legali utilizzare per proteggere il tuo reddito e il tuo patrimonio.
Perché molti skipper si trovano in difficoltà economica
Le cause più frequenti dei debiti tra i professionisti del mare sono:
- ritardi nei pagamenti da parte di armatori, società di charter o agenzie;
- tasse e contributi non versati nei periodi di inattività stagionale;
- spese elevate per patente, assicurazioni, certificazioni e corsi obbligatori;
- finanziamenti per l’acquisto o il noleggio di imbarcazioni;
- costi imprevisti di manutenzione e carburante;
- riduzione delle commesse a causa della crisi del turismo nautico o del maltempo.
Molti skipper lavorano come autonomi con partita IVA o come collaboratori stagionali, e nei periodi di fermo spesso rinviano il pagamento di tasse o contributi, accumulando debiti difficili da sostenere.
Cosa succede se non paghi tasse o contributi
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) e l’INPS possono avviare rapidamente azioni di recupero, come:
- cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento;
- pignoramenti dei conti correnti o dei compensi;
- fermi amministrativi sui mezzi di trasporto o sulle imbarcazioni;
- ipoteche su immobili o beni personali;
- sequestri dei crediti verso clienti o intermediari;
- applicazione di interessi e sanzioni che fanno crescere l’importo del debito nel tempo.
Se operi come ditta individuale o libero professionista, rispondi personalmente con i tuoi beni dei debiti dell’attività. Intervenire subito è quindi essenziale per bloccare le azioni esecutive.
Cosa fare subito se hai debiti come skipper
Ecco i primi passi pratici da compiere per affrontare la situazione in modo legale e strategico:
- Richiedi l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Serve per conoscere l’importo esatto dei debiti e le annualità coinvolte. - Verifica la regolarità delle cartelle.
Molte contengono errori di notifica o somme prescritte che un avvocato può far annullare. - Chiedi la rateizzazione.
Puoi ottenere fino a 120 rate mensili e sospendere le azioni esecutive durante il pagamento. - Controlla se è attiva una definizione agevolata (rottamazione).
Ti consente di pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi. - Blocca eventuali pignoramenti o ipoteche in corso.
Con un ricorso o un’istanza di autotutela puoi ottenere la sospensione immediata.
Le soluzioni legali per chi non riesce più a pagare
Se il debito è diventato troppo alto o insostenibile, puoi accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
È una procedura legale dedicata a lavoratori autonomi, artigiani e professionisti che consente di:
- bloccare pignoramenti e azioni dei creditori;
- presentare un piano di rientro sostenibile;
- ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti residui (esdebitazione).
È uno strumento efficace e riconosciuto dai tribunali italiani, utile per chi non riesce più a far fronte ai debiti ma vuole ripartire senza rischiare il fallimento personale.
Come difendersi da banche, finanziarie e fornitori
Molti skipper si indebitano con banche o finanziarie per coprire spese stagionali o per acquistare imbarcazioni e attrezzature. Se non riesci più a sostenere le rate, puoi:
- chiedere la rinegoziazione o sospensione temporanea dei pagamenti;
- proporre un saldo e stralcio, chiudendo la posizione con una somma ridotta;
- verificare la presenza di interessi usurari o clausole abusive nei contratti di finanziamento;
- impugnare decreti ingiuntivi o pignoramenti entro i termini di legge.
Un avvocato può assisterti nel negoziare con i creditori e trovare soluzioni sostenibili, evitando l’aggravarsi della situazione.
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
Con una difesa legale mirata puoi:
- sospendere o bloccare pignoramenti e ipoteche;
- ottenere la rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi;
- proteggere la tua casa e i beni personali;
- cancellare legalmente i debiti residui;
- mantenere o chiudere l’attività in modo regolare;
- ripartire senza la pressione di creditori o riscossione forzata.
Una strategia difensiva tempestiva può davvero salvare la tua situazione finanziaria e professionale.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi contattare un avvocato se:
- hai ricevuto cartelle, intimazioni o pignoramenti;
- hai debiti fiscali o bancari che non riesci più a gestire;
- rischi il sequestro o il fermo dei beni strumentali;
- vuoi rateizzare, definire o cancellare legalmente i tuoi debiti.
Un avvocato esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento può contestare atti illegittimi, bloccare le azioni esecutive e guidarti fino alla cancellazione definitiva dei debiti.
⚠️ Attenzione: ignorare le cartelle o gli avvisi di pagamento può portare rapidamente a pignoramenti, sequestri e perdita dei beni personali. Agire tempestivamente è l’unico modo per salvare la tua attività e difendere il tuo futuro professionale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela dei lavoratori del settore nautico – spiega cosa fare se sei uno skipper con debiti, come bloccare le azioni dei creditori e come cancellare legalmente le somme dovute attraverso gli strumenti previsti dalla legge.
👉 Sei uno skipper con debiti fiscali, bancari o contributivi?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo le possibilità di rateizzazione o esdebitazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per proteggere la tua attività, i tuoi beni e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Essere uno skipper – il comandante di un’imbarcazione da diporto – può significare trasformare la propria passione per il mare in una professione. Tuttavia, come avviene in qualsiasi attività, anche uno skipper può trovarsi ad affrontare debiti ingenti. Tali debiti possono derivare da diverse cause: obblighi fiscali non onorati (ad esempio imposte o IVA legate all’attività nautica), contributi previdenziali arretrati, fatture di fornitori (manutenzioni, carburante, ormeggi), rate di mutuo per l’acquisto di una barca, finanziamenti per l’attività turistica o sportiva, oppure prestiti personali contratti per sostenere l’impresa. La pandemia, le crisi economiche o semplicemente una stagione turistica sfavorevole possono far precipitare la situazione finanziaria di chi lavora nel settore nautico.
Questa guida – aggiornata a settembre 2025 – fornisce un’analisi avanzata e dettagliata su cosa fare e come difendersi se uno skipper si trova sovraindebitato (cioè nell’impossibilità di pagare regolarmente i propri debiti). Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma dal taglio divulgativo, idoneo sia ai professionisti del diritto (avvocati, consulenti) sia agli stessi debitori (privati imprenditori o lavoratori marittimi) che necessitano di orientamento. Il punto di vista adottato è quello del debitore, evidenziando gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento italiano per chi, in buona fede, cerca di risolvere la propria esposizione debitoria.
Affronteremo le diverse tipologie di debiti che uno skipper può accumulare – da quelli fiscali e previdenziali a quelli verso banche, fornitori o privati – e le relative conseguenze legali in caso di mancato pagamento. Illustreremo poi le strategie difensive e le soluzioni percorribili: dalle trattative stragiudiziali (come accordi a saldo e stralcio o piani di rientro) alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotte dalla legge italiana (c.d. “legge salva-suicidi” del 2012, oggi assorbita nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). Esamineremo strumenti come la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’innovativa esdebitazione del debitore incapiente, senza tralasciare i metodi per proteggere il patrimonio personale (ad esempio tramite fondo patrimoniale o trust) e le cautele da adottare per non incorrere in abusi o addirittura reati.
La guida include tabelle riepilogative per sintetizzare concetti chiave, esempi pratici e un formato domande e risposte per chiarire i dubbi frequenti. Al termine, una sezione raccoglierà le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli ed aggiornate – tra cui recenti sentenze della Corte di Cassazione fino al 2025 – che supportano le informazioni fornite, così che il lettore abbia riferimenti solidi da invocare anche in sede legale. L’obiettivo finale è fornire allo skipper indebitato una “bussola” per navigare nel mare tempestoso dei debiti, intravedendo un porto sicuro in cui approdare grazie agli strumenti di legge che garantiscono, quando possibile, una seconda opportunità al debitore onesto in difficoltà .
Tipologie di debiti e conseguenze legali per lo skipper
Uno skipper può contrarre debiti di varia natura nell’esercizio della propria attività o nella sfera personale. È importante distinguere tra le diverse tipologie di debito, perché ciascuna categoria è regolata da norme specifiche e può comportare differenti rischi e rimedi. Di seguito esamineremo i principali tipi di debiti che gravano tipicamente su chi opera nel settore nautico (o su un piccolo imprenditore in genere), evidenziandone le caratteristiche e le conseguenze legali in caso di mancato pagamento.
Debiti fiscali (erariali e locali)
I debiti fiscali sono quelli verso l’erario (lo Stato) o gli enti locali, derivanti dal mancato versamento di imposte e tributi. Per uno skipper, tali debiti possono riferirsi ad esempio a IVA non versata sulle attività di charter nautico, IRPEF (imposta sul reddito) non pagata sui compensi percepiti, IRAP se dovuta, oppure tasse locali come l’IMU su eventuali immobili (es. un capannone o ufficio) o la tassa sui rifiuti per la sede operativa.
Quando un tributo non viene pagato entro le scadenze, l’ente impositore (Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, il Comune per i tributi locali, etc.) iscrive a ruolo l’importo dovuto e incarica l’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate–Riscossione, ex Equitalia) di procedere al recupero coattivo. Viene emessa quindi una cartella di pagamento (la famosa “cartella esattoriale”) notificata al contribuente. Se la cartella non è contestata entro i termini o pagata entro 60 giorni, il debito diviene definitivo ed esigibile. A quel punto, l’Agente della Riscossione può attivare le misure cautelari ed esecutive previste dal D.P.R. 602/1973: ad esempio l’iscrizione di un’ipoteca su beni immobili o mobili registrati del debitore (inclusa un’eventuale imbarcazione di proprietà dello skipper), il fermo amministrativo su autoveicoli o motoveicoli (provvedimento che impedisce la circolazione del mezzo), o pignoramenti.
Va evidenziato che in Italia la prima casa adibita ad abitazione principale del debitore, se questi possiede un solo immobile non di lusso, non può essere pignorata dall’Agente della Riscossione per debiti tributari inferiori a una certa soglia (attualmente €120.000) . Tale tutela è stata introdotta per legge nel 2013 e mira a evitare che il contribuente e la sua famiglia restino privi dell’abitazione. Ciò non toglie però che sulla casa possa comunque essere iscritta un’ipoteca a garanzia del credito (con importo minimo del debito pari a €20.000) e che, al superare delle soglie di legge, anche l’abitazione principale possa finire all’asta. Nessuna protezione invece è prevista per altri immobili diversi dall’abitazione principale, né per beni mobili registrati: se uno skipper è proprietario di una barca o gommoni registrati, tali beni possono essere ipotecati e pignorati dall’Erario al pari di qualsiasi altro cespite patrimoniale.
Un caso tipico di debitore fiscale è lo skipper/imprenditore che, trovandosi in crisi di liquidità, ha dovuto scegliere se pagare dipendenti e fornitori oppure saldare IVA e ritenute fiscali. Spesso, in situazioni di difficoltà, si opta per rimandare il versamento delle imposte per far fronte alle spese più urgenti: così facendo però si accumulano debiti tributari che, con sanzioni e interessi, crescono rapidamente e sono difficili da estinguere in un’unica soluzione. Il mancato pagamento di imposte può anche avere implicazioni penali in casi estremi – ad esempio omesso versamento di IVA oltre soglie rilevanti o indebite compensazioni – ma nella presente guida ci concentreremo sugli aspetti civili e sulle tutele del debitore.
Le conseguenze del mancato pagamento di debiti fiscali includono dunque: – L’iscrizione a ruolo e la notifica di cartelle esattoriali. – L’aggravio di sanzioni amministrative (spesso il 30% per omesso versamento) e interessi di mora. – Misure cautelari come il fermo amministrativo di veicoli o l’iscrizione di ipoteca su beni (immobili, imbarcazioni, automezzi). – Azioni esecutive: trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento né accordo di rateizzazione, l’Agente può procedere al pignoramento dei beni del debitore. Ciò può significare il pignoramento immobiliare (es. casa, terreno), il pignoramento mobiliare (beni presenti nell’abitazione o magazzino, sebbene quest’ultimo sia meno frequente e spesso infruttuoso), oppure il pignoramento presso terzi (tipicamente conti correnti, crediti verso clienti, o una quota dello stipendio/pensione se il debitore è lavoratore dipendente o pensionato). – In particolare, il pignoramento del conto corrente è uno scenario da evitare: quando l’Agente della Riscossione notifica un atto di pignoramento alla banca, i fondi sul conto fino a concorrenza del debito vengono bloccati e destinati al pagamento coattivo dopo 60 giorni. Uno skipper che riceva pagamenti tramite bonifici o POS sul proprio conto rischia dunque di vederselo congelare, con grave pregiudizio per la prosecuzione dell’attività. – Se il debito fiscale è molto elevato e il debitore è un imprenditore, vi è anche il rischio (per crediti oltre determinate soglie) che l’Agenzia delle Entrate possa presentare istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) nei confronti dell’impresa individuale o della società debitrice. Questo però avviene solo per imprese di dimensioni fallibili e come extrema ratio, quando si ritiene che il patrimonio del debitore vada gestito unitariamente da una procedura concorsuale.
Un aspetto importante da considerare in ottica difensiva è la prescrizione dei debiti tributari. I tributi erariali (come IRPEF, IVA) di regola seguono la prescrizione ordinaria decennale se il credito è definitivo, mentre i tributi locali hanno spesso prescrizione quinquennale, così come i contributi previdenziali sono soggetti al termine di 5 anni (vedremo oltre). La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata impugnazione di una cartella esattoriale non trasforma il termine di prescrizione breve in quello lungo decennale (come accadrebbe invece se vi fosse un giudicato) . Ciò significa che, ad esempio, una cartella per IMU o TARI non contestata conserva la prescrizione di 5 anni propria di quei tributi e potrà essere eccepita dal debitore se l’Agente della Riscossione lascia decorrere cinque anni senza atti interruttivi . Questa eccezione va sollevata dinanzi al giudice competente (commissione tributaria o giudice dell’esecuzione, a seconda dei casi) in sede di opposizione, ma rappresenta una fondamentale arma di difesa: in molti casi debiti fiscali “datati” possono essere annullati proprio per intervenuta prescrizione, evitando al debitore il pagamento.
Debiti contributivi e previdenziali
Accanto ai debiti tributari, uno skipper può avere debiti previdenziali, ossia somme non versate agli enti previdenziali o assicurativi. Si pensi ad esempio ai contributi obbligatori dovuti all’INPS (per se stesso, se opera come lavoratore autonomo con partita IVA o ditta individuale, e per eventuali marinai/dipendenti imbarcati), oppure ai premi non pagati all’INAIL (assicurazione infortuni). Anche un lavoratore marittimo dipendente potrebbe trovarsi, a seguito di controlli, con richieste contributive dall’INPS (ad esempio per omissioni contributive del datore di lavoro che l’ente tenta di recuperare dal lavoratore stesso in taluni casi) o più comunemente debiti verso le casse professionali (qualora lo skipper sia iscritto a qualche albo) o verso la gestione separata.
Le somme dovute all’INPS e ad altri enti previdenziali seguono un percorso di recupero simile a quello fiscale: l’INPS notifica un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (un atto che ha già efficacia esecutiva senza bisogno di passare dal giudice), il quale viene poi trasmesso all’Agente della Riscossione per la notifica e l’esecuzione forzata. In passato l’INPS utilizzava anch’essa le cartelle esattoriali; dal 2011 gli avvisi di addebito hanno sostituito le cartelle per i crediti contributivi, ma per il debitore cambia poco in termini pratici: decorsi 60 giorni senza pagamento, si attivano le stesse misure (fermi, ipoteche, pignoramenti) viste per i debiti fiscali.
Una peculiarità dei debiti contributivi è la prescrizione breve. La legge n.335/1995 ha infatti stabilito, con alcune eccezioni transitorie, che i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, salvo atti interruttivi. La giurisprudenza – inclusa la Suprema Corte a Sezioni Unite – ha confermato che la notifica di un avviso di addebito o cartella non pagata non converte automaticamente questo termine in dieci anni . Dunque, se l’INPS notifica un avviso nel 2018 e poi non compie altri atti fino al 2024, il credito si sarà prescritto in cinque anni. Ciò costituisce un motivo di opposizione che il debitore può far valere per far annullare le pretese ormai tardive dell’ente.
Le conseguenze del mancato pagamento dei contributi non sono dissimili da quelle dei debiti fiscali: – Sanzioni: l’INPS applica sanzioni civili per omesso versamento contributivo, che possono essere anche molto onerose (in passato si parlava di interessi di mora e somme aggiuntive con tassi elevati). Spesso su lunghi periodi il debito contributivo quasi raddoppia per via delle sanzioni. – Misure cautelari ed esecutive identiche a quelle già descritte: fermo di veicoli, ipoteche, pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi. – In aggiunta, se il debitore è anche datore di lavoro, il mancato pagamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori configurava un reato (omesso versamento di ritenute INPS) se superava una certa soglia annua. Negli ultimi anni le soglie di punibilità e la qualificazione penale di tale condotta hanno subito modifiche, ma è un ulteriore profilo di rischio da menzionare: chi trattiene dalle buste paga dei dipendenti i contributi e non li versa all’ente, oltre alle sanzioni civili rischia sanzioni penali in presenza di dolo e importi rilevanti.
Dal punto di vista delle tutele per il debitore, anche con l’INPS è possibile ottenere rateizzazioni del debito (di norma fino a 24 mesi, estensibili nei casi di crisi fino a 36 o 60 mesi in alcune circostanze particolari). Inoltre, i debiti contributivi possono rientrare nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, dove l’ente previdenziale è trattato analogamente agli altri creditori privilegiati (pur con alcune rigidità, ad esempio l’impossibilità di falcidiare oltre un certo limite i crediti per contributi che godono di privilegio generale sui mobili).
Debiti verso banche e finanziarie (mutui, leasing, prestiti)
Molti skipper investono nell’acquisto di un’imbarcazione o di attrezzature costose per la propria attività, ricorrendo a finanziamenti bancari. Pensiamo a chi compra a rate uno yacht per noleggi turistici, o accende un mutuo nautico (analogamente al mutuo immobiliare) per una barca a vela, oppure contrae un prestito per l’acquisto di motori, attrezzature subacquee, o per fare cassa durante la bassa stagione. Questi debiti finanziari sono in genere garantiti da contratti precisi: nel caso di mutuo o leasing sull’imbarcazione, la barca stessa può essere data in garanzia (es. ipoteca navale iscritta sul registro delle imbarcazioni, oppure leasing in cui la banca rimane proprietaria del bene fino a riscatto). Se invece lo skipper ha acceso un mutuo per la propria casa o un prestito personale non finalizzato, le garanzie possono essere la casa (ipoteca immobiliare), una polizza fideiussoria o semplicemente la firma con obbligo di pagamento.
Le conseguenze dell’inadempimento di questi debiti finanziari seguono le regole generali del codice civile e del Testo Unico Bancario: – In caso di mutuo ipotecario sulla casa o di leasing/mutuo sulla barca, il mancato pagamento di un certo numero di rate (di solito 7 rate mensili complessive, anche non consecutive, ai sensi dell’art. 40 TUB) dà diritto alla banca di risolvere il contratto e avviare l’esecuzione forzata sul bene posto a garanzia. Ciò significa, ad esempio, che la casa verrà sottoposta a pignoramento immobiliare e messa all’asta giudiziaria, oppure che la barca in leasing verrà ritirata dalla finanziaria e venduta. – Per i prestiti personali o i fidi bancari non garantiti, l’istituto di credito in caso di mancato pagamento tipicamente ottiene un decreto ingiuntivo dal tribunale (ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva se il credito è fondato su contratto bancario e estratto conto ex art. 50 TUB). Decorso il termine per l’opposizione (40 giorni), il decreto diventa definitivo e la banca potrà procedere con pignoramenti sui beni del debitore come visto sopra (conto corrente, beni mobili, stipendio ecc.). – Se il prestito era garantito da una fideiussione (es. lo skipper potrebbe aver fornito garanzie personali o fatto garantire il debito da un familiare), l’inadempimento comporta richieste di pagamento anche al fideiussore e possibilità di agire sul suo patrimonio.
Le aste giudiziarie di beni come immobili o imbarcazioni spesso non consentono di ricavare il pieno valore di mercato del bene. Ciò significa che, ad esempio, se uno yacht comprato a 100.000 € viene pignorato e venduto all’asta per 50.000 €, la banca recupera quella somma ma può comunque agire nei confronti dello skipper per il debito residuo (salvo si tratti di leasing in cui la restituzione del bene può talvolta chiudere la posizione). Lo skipper quindi rischia di perdere l’imbarcazione e allo stesso tempo restare con un debito non integralmente soddisfatto dall’esecuzione. Questo scenario è comune anche nei mutui immobiliari: la vendita forzata dell’immobile spesso non estingue l’intero debito, lasciando il debitore senza casa e con un’esposizione residua.
Va sottolineato che il sistema bancario è soggetto a regole rigorose ma anche a qualche possibilità di negoziazione: – Sospensione delle rate: in situazioni di difficoltà temporanea (perdita del lavoro, calamità naturali, crisi settoriali) varie leggi hanno previsto la possibilità di sospendere le rate del mutuo prima casa per un certo periodo (es. Fondo Gasparrini per la sospensione mutui prima casa). Un skipper potrebbe aver beneficiato durante la pandemia di moratorie sui mutui per l’impresa turistica o per la prima casa. – Rinegoziazione: è spesso possibile, prima di arrivare al default totale, tentare con la banca una rinegoziazione del piano di ammortamento (allungando la durata del mutuo per abbassare la rata) o un consolidamento dei debiti (se ci sono più prestiti, unendoli in uno solo magari con garanzia ipotecaria). – Saldo e stralcio: se la situazione è già compromessa, talvolta la banca accetta un accordo transattivo a saldo e stralcio – ad esempio ricevere subito una percentuale del debito (magari grazie a un aiuto di familiari del debitore) e rinunciare al resto, evitando le lungaggini e incertezze di una procedura esecutiva. Tali accordi sono possibili soprattutto se il debitore non ha altri beni aggredibili o se la banca ritiene di ricavare di più con l’accordo rispetto all’asta.
Insoluti nei confronti delle banche finiscono nelle segnalazioni presso sistemi come CRIF (centrale rischi finanziari privata) o la Centrale Rischi di Banca d’Italia, minando la reputazione creditizia dello skipper e rendendo difficoltoso ottenere nuova finanza. Risolvere definitivamente queste posizioni debitorie (anche tramite le procedure di esdebitazione di cui diremo) è fondamentale per poter tornare “affidabili” e ripartire.
Debiti verso fornitori e altri privati
Nel corso dell’attività, un’impresa di charter nautico o uno skipper libero professionista possono accumulare debiti anche verso soggetti privati: fornitori di beni e servizi (cantieri navali per riparazioni, forniture di attrezzature, agenzie marittime, carburanti), partner commerciali, oppure anche soci e amici che abbiano prestato denaro per l’attività. In ambito personale, possono esservi debiti verso familiari, oppure obbligazioni di mantenimento (ad esempio il versamento di assegni di mantenimento al coniuge separato o ai figli).
I debiti verso fornitori rientrano nella categoria dei debiti commerciali chirografari (non garantiti da particolari privilegio, salvo che il fornitore abbia un privilegio speciale – ad es. il meccanico navale potrebbe iscrivere un privilegio sul motore riparato, o la ditta di ormeggio potrebbe avere un privilegio sul mezzo ormeggiato, ma sono casi specifici). In genere, se le fatture restano non pagate, il fornitore adotterà le vie legali ordinarie: – Potrà richiedere un decreto ingiuntivo al tribunale competente, provando il credito con fatture, DDT, contratti. Il debitore ha 40 giorni per fare opposizione motivata; se non la propone o l’opposizione viene rigettata, si forma un titolo esecutivo utilizzabile per il pignoramento. – In alcuni casi, il fornitore può ricorrere a procedura arbitrale (se prevista dai contratti) o a solleciti di società di recupero crediti prima di adire il giudice. Ma una volta ottenuto un titolo esecutivo, il fornitore diventa a tutti gli effetti un creditore come gli altri, che può pignorare beni o crediti del debitore.
Un aspetto particolare riguarda il rapporto tra debiti professionali e personali. Un soggetto può avere debiti misti: ad esempio, un ex armatore/skipper che ha chiuso l’attività avrà debiti verso fornitori (d’impresa) ma anche debiti personali (carta di credito, prestito per l’auto, ecc.). Ai fini delle soluzioni di sovraindebitamento, occorre valutare quali siano prevalenti, come vedremo: la legge distingue infatti tra consumatore e imprenditore sovraindebitato.
Le conseguenze dei debiti commerciali non pagati si manifestano principalmente sul piano patrimoniale: il rischio è di subire pignoramenti analoghi a quelli già descritti. Non vi sono particolari tutele legali per il debitore, se non quelle generali: ad esempio, alcuni beni sono per legge impignorabili (art. 514 c.p.c.), come gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione (entro limiti di valore ragionevoli) oppure il letto, gli abiti, i viveri necessari al sostentamento familiare. Difficilmente un creditore procedente arriverà a pignorare l’armadio o le pentole di casa – di norma si concentra su conti bancari, auto, immobili, crediti – ma è importante sapere che la legge garantisce comunque un minimo vitale al debitore.
Debiti verso dipendenti: un altro tipo di debito che può riguardare uno skipper in veste di datore di lavoro sono le retribuzioni non pagate al proprio equipaggio o ad altri lavoratori. Tali crediti per stipendi sono privilegiati (privilegio generale sui mobili del datore ex art. 2751 bis c.c.) e, se non corrisposti, possono portare i dipendenti a fare vertenza di lavoro e ad iscrivere pignoramenti sui beni dell’armatore. Inoltre, il Fondo di Garanzia INPS potrebbe anticipare il TFR o le ultime mensilità ai dipendenti in caso di insolvenza del datore, surrogandosi poi come creditore.
In sintesi, i debiti verso creditori privati espongono il debitore allo stesso tipo di azioni esecutive già viste. Non esistono “soglie di tolleranza” come nel caso dell’abitazione principale con il fisco: un fornitore non pagato può far pignorare anche l’unica casa del debitore (salvo, beninteso, che questa sia già protetta da un fondo patrimoniale efficace, questione di cui diremo a parte). L’ordinamento tuttavia offre la possibilità, come vedremo, di includere anche questi debiti in eventuali procedure di composizione della crisi o di trovare accordi stragiudiziali.
Il rischio di fallimento (liquidazione giudiziale)
Prima di passare alle soluzioni, va menzionato un ulteriore rischio giuridico per l’imprenditore indebitato: il fallimento (oggi tecnicamente chiamato liquidazione giudiziale nel nuovo Codice della Crisi). Non tutti i debitori possono però essere dichiarati falliti: la legge esclude da questa procedura i soggetti “minori” (piccoli imprenditori sotto certe soglie, professionisti, imprenditori agricoli, consumatori). In base all’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi, sono non assoggettabili a liquidazione giudiziale gli imprenditori che, negli ultimi esercizi, non hanno superato determinati limiti dimensionali (ricavi lordi annui sotto circa 200.000 €, debiti totali sotto 500.000 €, attivo patrimoniale sotto 300.000 €) , oltre naturalmente ai privati non imprenditori .
Uno skipper che svolga l’attività in forma di ditta individuale o piccola società potrebbe rientrare in queste soglie, e dunque i suoi creditori non potrebbero chiederne il fallimento. In tal caso, l’alternativa per risolvere la crisi di debiti è appunto ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (destinate ai non fallibili). Se invece l’impresa supera le soglie, il pericolo è che uno o più creditori (compreso il Fisco per debiti fiscali rilevanti) presentino istanza di fallimento al tribunale. L’apertura di una liquidazione giudiziale comporta la nomina di un curatore che gestirà tutto il patrimonio, la sospensione delle azioni individuali dei creditori e la liquidazione di tutti i beni, secondo le regole concorsuali.
Dal punto di vista del debitore, il fallimento non è certo desiderabile: si perde la disponibilità dei propri beni, l’attività d’impresa viene spossessata, e si subisce per anni una serie di limitazioni e controlli. Tuttavia, anche in caso di fallimento, la legge prevede la possibilità per la persona fallita, a fine procedura, di ottenere la esdebitazione (cioè la liberazione dai debiti residui rimasti insoddisfatti), purché abbia collaborato lealmente e non abbia commesso irregolarità gravi . Questa “fresh start” dopo il fallimento era prevista già nella vecchia legge fallimentare ed è confermata dal nuovo Codice della Crisi.
Per uno skipper “sotto soglia” che non può essere dichiarato fallito, il ventaglio di strumenti utili coincide invece con le procedure di sovraindebitamento di cui parleremo nella prossima sezione.
Strategie difensive e soluzioni per il debitore
Dopo aver delineato i problemi, passiamo alle possibili soluzioni. Un debitore – incluso il nostro skipper indebitato – non è senza speranza: l’ordinamento offre vari strumenti per difendersi dalle azioni dei creditori e, soprattutto, per cercare di ristrutturare o azzerare i debiti in modo legale. Si possono distinguere strategie stragiudiziali (accordi e iniziative che non richiedono l’intervento formale del tribunale) e procedure giudiziali previste dalla legge per gestire situazioni di insolvenza o sovraindebitamento.
Vediamo in dettaglio le opzioni disponibili, ricordando sempre che ogni situazione concreta va valutata specificamente – spesso con l’ausilio di un professionista esperto – per combinare al meglio i vari strumenti.
Soluzioni stragiudiziali (accordi privati e piani di rientro)
Prima di coinvolgere un tribunale, è spesso opportuno tentare soluzioni bonarie con i creditori. Le trattative stragiudiziali permettono maggiore flessibilità e minor formalità. Ecco alcuni approcci tipici:
- Rinegoziazione dei debiti con i creditori privati: consiste nel contattare i fornitori, le banche o altri creditori e proporre un nuovo piano di rientro. Ad esempio, si può chiedere di dilazionare il pagamento su più mesi, magari riconoscendo un interesse di mora, oppure ottenere una riduzione dell’importo dovuto se si paga subito una parte. Molte imprese creditrici, soprattutto se comprendono la temporaneità delle difficoltà del debitore, preferiscono ottenere qualcosa (anche se in ritardo o in parte) piuttosto che avventurarsi in costose e incerte azioni legali. La chiave è mostrare buona fede e presentare un piano credibile, ad esempio supportato da un’analisi delle entrate future (nel caso di uno skipper, le prenotazioni per la stagione successiva) e dall’impegno a ridurre spese non essenziali.
- Saldo e stralcio: è una forma particolare di accordo stragiudiziale in cui il debitore offre ai creditori il pagamento immediato di una percentuale del debito, solitamente in un’unica soluzione (o poche rate ravvicinate), a fronte della rinuncia a ogni ulteriore pretesa. Ad esempio, su un debito di €50.000 si potrebbe trattare per definire il tutto pagando €20.000 entro 30 giorni. Questa soluzione richiede che il debitore abbia accesso a una liquidità immediata (spesso proviene dall’aiuto di un familiare o dalla vendita di un bene) e funziona meglio quando il creditore sa che alternative (esecuzioni) potrebbero dargli un ricavo minore o molto dilazionato. Le banche talvolta accettano saldi a stralcio su posizioni deteriorate (NPL) specie se il debitore è nullatenente o se il credito è stato ceduto a società di recupero, le quali acquistandolo a sconto possono guadagnare anche con un incasso parziale.
- Consolidamento dei debiti: se lo skipper ha molti piccoli debiti con varie finanziarie, una strada (qualora la situazione creditizia non sia ancora compromessa del tutto) è rivolgersi a una banca per ottenere un prestito di consolidamento. In pratica, si contrae un nuovo finanziamento più grande con cui estinguere tutti i debiti frammentati, restando poi con un’unica rata mensile più sostenibile. Questo approccio è però fattibile solo se il debitore ha mantenuto un merito creditizio sufficiente e garanzie adeguate; se si è già segnalati come cattivi pagatori, difficilmente si otterranno nuovi finanziamenti.
- Rateizzazioni e definizioni agevolate per debiti fiscali: sul fronte fiscale, l’Agente della Riscossione consente di ottenere un piano di rateazione standard fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 senza necessità di prove di difficoltà, e piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) in casi di grave e comprovata situazione di liquidità. Presentando apposita istanza e rispettando le condizioni, il debitore può evitare azioni esecutive purché paghi regolarmente le rate accordate. Inoltre, negli ultimi anni sono state varate diverse definizioni agevolate (“rottamazioni delle cartelle”), l’ultima delle quali nel 2023, che permettono di estinguere i debiti fiscali pagando l’imposta e gli interessi legali ma risparmiando su sanzioni e interessi di mora. Tali misure sono previste da leggi speciali (spesso collegate alle Leggi di Bilancio) e richiedono la presentazione di una domanda entro termini specifici. È importante che un debitore con molte cartelle stia attento a queste finestre normative, perché possono ridurre sensibilmente l’importo dovuto e dilazionare il pagamento.
- Transazione fiscale e contributiva: in senso proprio, la “transazione fiscale” è uno strumento che si attua all’interno di procedure concorsuali (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione) e ora anche nel concordato minore del sovraindebitamento. Consiste nella possibilità di proporre all’erario e agli enti previdenziali un trattamento dilazionato o parzialmente falcidiato dei loro crediti, con il loro consenso. Fuori dalle procedure giudiziali, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha un potere discrezionale di accettare meno del dovuto: può solo applicare le definizioni agevolate previste per legge. Quindi, per un soggetto non fallibile, l’idea di “accordarsi” privatamente con il Fisco per pagare meno deve passare necessariamente attraverso le procedure di sovraindebitamento omologate dal tribunale, di cui tratteremo oltre.
- Vendita di beni prima dell’esecuzione: un debitore in difficoltà può valutare di vendere spontaneamente qualche bene per fare cassa e pagare i creditori, piuttosto che attendere che sia pignorato e venduto all’asta. Ad esempio, vendere un secondo immobile, un’auto di lusso, o la stessa barca se è possibile ricavarne un prezzo di mercato, può fornire liquidità per ridurre l’esposizione debitoria. Occorre però prudenza: se la vendita avviene quando i debiti sono già scaduti e il patrimonio residuo del debitore risulta insufficiente, i creditori potrebbero successivamente agire con un’azione revocatoria sostenendo che quella vendita li ha pregiudicati (soprattutto se è una vendita a un parente o a un prezzo irrisorio). La legge consente di dichiarare inefficaci verso i creditori gli atti di disposizione compiuti dal debitore a titolo gratuito nei due anni antecedenti, o a titolo oneroso entro 5 anni se c’è consapevolezza del pregiudizio (art. 2901 c.c.). Quindi, vendere per pagare i debiti va bene, vendere per sottrarre il ricavato ai creditori no. Nel primo caso la vendita stessa dovrà far parte di un piano di risanamento trasparente.
In generale, le soluzioni stragiudiziali funzionano meglio quando: 1. Il numero dei creditori non è troppo elevato (è più facile accordarsi con 3-4 soggetti principali piuttosto che con decine di piccoli creditori). 2. Il debitore ha ancora credibilità e i creditori nutrono fiducia che valga la pena negoziare. 3. Ci sono prospettive reali di ripresa dell’attività o comunque di reperimento di risorse (ad esempio una stagione turistica promettente, la possibilità di affittare la barca, un immobile vendibile, familiari disposti ad aiutare). 4. Non vi sono già procedimenti esecutivi troppo avanzati (quando i beni sono già pignorati e all’asta, i margini di trattativa si riducono; tuttavia, finché l’asta non è avvenuta, un accordo con il creditore procedente può comunque portare alla rinuncia all’esecuzione).
Va anche detto che la negoziazione privata non sempre riesce e, soprattutto, non vincola eventuali creditori dissenzienti: basta un creditore aggressivo per far fallire la strategia, perché potrebbe pignorare beni mentre gli altri trattano. Per questo motivo il legislatore ha creato le procedure concorsuali di composizione della crisi, che consentono di coinvolgere tutti i creditori in modo vincolante. Analizziamo allora queste soluzioni giudiziali, pensate proprio per chi si trova sommerso dai debiti.
Procedure di sovraindebitamento (legge “salva suicidi” e Codice della Crisi)
Dal 2012 in Italia esiste una legge specifica per affrontare le crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (cioè piccoli imprenditori, professionisti, consumatori). Si tratta della Legge 3/2012, detta anche legge “salva suicidi” per l’intento sociale di offrire una via d’uscita ai debitori civili onesti ma in disperata difficoltà. Dal 15 luglio 2022, le disposizioni di quella legge sono state incorporate e aggiornate nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), in particolare agli articoli 65-83 per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento . La normativa è stata ulteriormente ritoccata con i decreti correttivi (D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) per migliorarne l’efficacia. Queste procedure rappresentano una “via giudiziale” per regolare tutti i debiti in modo unitario, sotto il controllo di un giudice, con effetti vincolanti per tutti i creditori (anche per quelli che non fossero d’accordo), a condizione di rispettare determinati requisiti di legge.
Le procedure previste attualmente sono quattro: 1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): dedicata ai debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per fini estranei all’attività di impresa (quindi debiti personali, familiari, di consumo). È una procedura che non richiede l’accordo dei creditori: il debitore propone un piano di pagamento sostenibile e, se il tribunale lo ritiene equo e fattibile, può omologarlo anche con il dissenso dei creditori . È l’ideale per il soggetto privato (es. lo skipper dipendente o ex imprenditore i cui debiti residui ora sono solo personali). 2. Concordato minore (ex accordo di composizione): è la procedura riservata ai debitori non fallibili che non siano consumatori, quindi tipicamente piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, o soggetti che hanno debiti in parte professionali e in parte personali . Prevede un accordo con i creditori, i quali vengono suddivisi in classi e votano sulla proposta; serve il raggiungimento di determinate maggioranze perché il piano sia approvato . In sostanza è un piccolo concordato preventivo, dove l’accordo coi creditori è essenziale (il giudice non può imporlo contro il voto contrario delle maggioranze). Un esempio: un armatore individuale con debiti verso fornitori, banche e Fisco potrebbe presentare un concordato minore offrendo ai creditori il pagamento di una certa percentuale (migliore di quanto otterrebbero liquidando tutto) magari dilazionata, e se una maggioranza qualificata approva, il tribunale omologa rendendolo vincolante anche per i dissenzienti. 3. Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): è la procedura di tipo liquidatorio. Il debitore (o talvolta un creditore) chiede che tutto il patrimonio disponibile sia liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale per soddisfare i creditori. È simile a un fallimento semplificato per i non fallibili. Il vantaggio principale per il debitore è che, a fine liquidazione, egli può ottenere l’esdebitazione di tutti i debiti residui non pagati con il ricavato . Si usa quando il debitore non ha entrate sufficienti per proporre un piano, ma possiede qualche bene liquidabile oppure anche nulla – vedremo infatti che c’è un sottotipo particolare per chi non ha proprio nulla da liquidare. 4. Esdebitazione del debitore incapiente: questo è lo strumento introdotto dal Codice della Crisi (art. 283 CCII) per il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in futuro . In pratica è la cancellazione totale dei debiti a “costo zero”, riservata però a chi è assolutamente nullatenente e privo di reddito, e che non ha colpa grave o dolo nel proprio indebitamento. È una misura eccezionale, ammissibile una sola volta nella vita , pensata per situazioni di povertà estrema: ad esempio, un ex imprenditore che ha perso tutto e non potrà mai pagare nulla ai creditori può chiedere al tribunale di essere liberato dai suoi debiti, così da non restare marchiato a vita. Il giudice valuta con rigore la meritevolezza del richiedente e se davvero non vi siano beni o redditi occultati. L’esdebitazione incapiente, se concessa, estingue i debiti civili (restano però esclusi eventuali debiti di mantenimento, multe e sanzioni penali o amministrative non conciliabili, come previsto dalla legge).
È importante notare che tutte queste procedure richiedono la assenza di atti in frode e la buona fede del debitore. Fin dall’origine, la legge 3/2012 imponeva che il debitore non dovesse aver colposamente aggravato la sua posizione né frodato i creditori (il concetto di meritevolezza). Il nuovo Codice ha in parte rivisto il criterio, distinguendo tra procedure: per il consumatore, l’accesso è consentito se egli non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ; per il concordato minore la meritevolezza non è formalmente richiesta ma la Cassazione ha chiarito che va comunque valutata l’affidabilità del proponente e le cause dell’indebitamento . In qualunque procedura, se emergono atti dolosi di frode (es. aver sottratto beni ai creditori poco prima), il beneficio dell’esdebitazione può essere negato o revocato.
Vediamo in sintesi ciascuna procedura come funziona e come può applicarsi al caso di uno skipper:
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore)
Questa procedura, disciplinata dagli artt. 67-73 CCII, è il diretto successore del “piano del consumatore” della legge 3/2012. Chi può accedervi: persone fisiche che hanno contratto la maggior parte dei debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Ciò significa che se uno skipper ha chiuso la sua ditta e ora i debiti residui sono in gran parte personali (mutuo casa, finanziarie, magari anche cartelle fiscali ma riferite ad aspetti personali), potrebbe qualificare come consumatore. Se invece i debiti riguardano prevalentemente l’attività d’impresa (IVA, fornitori dell’impresa nautica, leasing barca), egli dovrà usare il concordato minore. Vi sono zone grigie in cui il soggetto ha debiti misti: la giurisprudenza ha ritenuto che si debba guardare alla prevalenza ; se i debiti d’impresa sono solo marginali, si potrebbe ammettere comunque il piano del consumatore.
Come funziona: il debitore, con l’ausilio obbligatorio di un organismo di composizione della crisi (OCC) o di un professionista nominato dal giudice, predispone un piano che permette a un debitore in difficoltà di uscire dai debiti attraverso un piano di pagamenti sostenibile per la situazione attuale del debitore . Il piano deve indicare quanta parte dei debiti il debitore riuscirà a pagare e in che tempi. Deve trattarsi di un importo sostenibile in base al suo reddito e patrimonio attuale, lasciando fuori il necessario al mantenimento suo e della famiglia (il c.d. minimum vitale). Il piano può prevedere pagamenti periodici, utilizzo di parte dello stipendio/pensione, oppure liquidazione di qualche bene non essenziale. Importante: non è richiesto di pagare tutti i debiti integralmente. Anzi, l’obiettivo del piano è pagare solo la parte di debito che il debitore realisticamente può permettersi, cancellando il resto con l’esdebitazione finale. Non c’è una soglia fissa, ma chiaramente il piano deve garantire ai creditori una certa utilità e non essere meramente simbolico (ad esempio, piani che offrivano meno del 5% ai chirografari sono stati talora respinti per mancanza di causa dello stesso) .
Un vantaggio enorme di questa procedura è che non serve il consenso dei creditori: il piano viene comunicato ai creditori, i quali possono eventualmente sollevare opposizioni o osservazioni, ma non votano né possono impedire al giudice di omologarlo se esso rispetta i requisiti di legge . In pratica, la decisione è rimessa al tribunale, il quale verifica: – la regolarità formale e la completezza delle informazioni fornite; – la fattibilità del piano, anche avvalendosi dell’attestazione dell’OCC (che certifica l’attendibilità dei dati e la previsione di adempimento); – la conformità dell’offerta al principio che i creditori privilegiati (pignoratizi, ipotecari) non possono ricevere meno di quanto avrebbero ottenuto dalla liquidazione dei beni gravati (c.d. test dell’alternativa liquidatoria, per cui se c’è un’ipoteca su un immobile, occorre offrire a quel creditore almeno il valore di realizzo che avrebbe dalla vendita forzata dell’immobile stesso ); – la meritevolezza del consumatore (assenza di dolo o colpa grave nella genesi dei debiti, secondo il criterio attuale).
Se il giudice è convinto su questi punti, omologa il piano e da quel momento esso diventa vincolante per tutti i creditori anteriori. Gli effetti principali sono: – Sospensione/cessazione delle azioni esecutive individuali: i creditori non possono più iniziare né proseguire pignoramenti o altre azioni, dovendo accontentarsi di quanto previsto nel piano. Se qualche procedura esecutiva era già in corso (es. un’asta di casa), il giudice dell’esecuzione, su istanza, sospende la vendita durante il periodo in cui il piano viene presentato e valutato, e all’omologa dispone la chiusura dell’esecuzione (salvo il caso particolare dei creditori fondiari, vedi oltre). – Divieto di iscrivere ipoteche giudiziali o acquisire privilegi dal giorno della presentazione della domanda di piano: ciò impedisce ai creditori di avvantaggiarsi all’ultimo minuto. – Esecuzione controllata del piano: l’OCC vigila che il debitore adempia alle obbligazioni come da piano. Se il debitore adempie regolarmente, al termine del piano il giudice emette il decreto che cancella i debiti residui non pagati (esdebitazione) . Se invece il debitore non rispetta il piano senza giustificato motivo, la procedura può essere revocata e i crediti tornano esigibili per intero.
Questa è spesso la soluzione ottimale per un privato indebitato. Immaginiamo un esempio: Mario è un ex skipper dipendente che, per arrotondare, aveva contratto vari prestiti personali (per comprare un piccolo gommone da usare in escursioni private, per ristrutturare casa, ecc.) e ora si trova disoccupato con 60.000 € di debiti tra finanziarie e carte di credito. Non possiede casa (vive in affitto) e l’unico bene è il gommone ormai vecchio. Mario potrebbe presentare un piano del consumatore offrendo, ad esempio, di pagare 300 € al mese per 5 anni usando un nuovo stipendio (se trova lavoro) o parte della NASpI/disoccupazione, così da versare un totale di 18.000 € ai creditori, pari al 30% del debito. Se il giudice verifica che Mario non ha tenuto condotte fraudolente e che 300 € al mese sono il massimo che può dare, potrà omologare il piano anche se le finanziarie volessero di più. A buon fine del piano, i restanti 42.000 € circa verrebbero cancellati definitivamente , dando a Mario una seconda chance. Nel frattempo, le finanziarie non potrebbero pignorargli il conto né il gommone perché la procedura li blocca.
Aggiornamenti normativi recenti: Una novità interessante introdotta nel 2024 (D.Lgs. 136/2024) riguarda la possibilità di moratorie oltre un anno per i creditori privilegiati. Prima, l’art. 8 L.3/2012 (ripreso dal CCII) prevedeva che nel piano del consumatore il pagamento dei creditori ipotecari/privilegiati potesse essere dilazionato al massimo di un anno dall’omologa, salvo liquidazione dei beni . Questo limitava la possibilità di proporre ai creditori ipotecari piani a lungo termine. La Cassazione però ha chiarito che tale termine non è perentorio: se un piano offre garanzie migliori ai creditori, si può prevedere che un creditore ipotecario venga pagato anche in un periodo più lungo . Ad esempio, un mutuo residuo potrebbe essere rimborsato in 5-10 anni all’interno del piano se ciò assicura più benefici che liquidare subito l’immobile. Questa flessibilità, confermata da Cass. n. 4622/2024, viene ora recepita nelle prassi.
Un altro problema applicativo riguardava la meritevolezza: alcuni tribunali, dopo l’entrata in vigore del CCII, continuavano a richiedere i vecchi criteri più stringenti di meritevolezza anche al consumatore. La Cassazione (sent. n. 22890/2023) ha invece sottolineato che il nuovo criterio è più ampio e coincide sostanzialmente con l’assenza di frode o colpa grave . Ciò è un auspicio per una valutazione meno punitiva e più oggettiva: il consumatore non va “colpevolizzato” se è sovraindebitato, a meno che abbia proprio volutamente abusato del credito o dilapidato risorse in modo irresponsabile.
Concordato minore (Accordo di composizione per imprenditori minori)
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, è – come detto – la procedura analoga al piano ma destinata ai debitori non consumatori. Tipici candidati: il piccolo armatore imprenditore individuale, la società di charter di piccole dimensioni, il professionista nautico con partita IVA, o anche soggetti con debiti misti in prevalenza d’impresa.
Funzionamento: anche qui serve l’assistenza di un OCC o professionista nominato. Si elabora un piano che può prevedere la ristrutturazione dell’impresa (se ancora attiva) o la liquidazione parziale dei beni. Si devono classificare i creditori in diverse classi se hanno cause di prelazione differenti o interessi economici divergenti. Il piano viene sottoposto al voto dei creditori: per l’approvazione occorre il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (nel calcolo si distinguono classi e si richiede un minimo di assenso per ciascuna classe, secondo regole analoghe al concordato preventivo). I creditori privilegiati che vengono soddisfatti integralmente o che non subiscono modifiche dei loro diritti non hanno diritto di voto; quelli che vengono parzialmente sacrificati (es: si propone di pagare un ipotecario al 80% e il resto stralciare, oppure dilazionare oltre i termini contrattuali) votano anch’essi e contano nelle maggioranze .
Se la maggioranza richiesta approva il concordato, il tribunale lo omologa, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori (anche per i dissenzienti e per gli assenti al voto). Se invece i creditori non approvano, la procedura viene dichiarata infruttuosa; il debitore a quel punto potrebbe “ripiegare” su una liquidazione controllata del patrimonio.
I requisiti di fattibilità, completezza delle informazioni e correttezza del debitore sono analoghi a quelli del piano del consumatore, con l’eccezione che nel concordato minore il legislatore non ha voluto espressamente una valutazione di meritevolezza soggettiva (probabilmente perché è già insita nel giudizio dei creditori espressi col voto). Tuttavia, come accennato, la Cassazione (sent. n. 30538/2024) ha affermato che il tribunale, pur in mancanza di un criterio esplicito di meritevolezza, può e deve considerare l’affidabilità del debitore e il suo comportamento pregresso, prima di omologare un accordo . Questo per bilanciare l’assenza del controllo tramite meritevolezza formale con un controllo sostanziale di buona fede.
Vantaggi del concordato minore: permette di gestire anche situazioni con componenti aziendali. Ad esempio, se la ditta di charter è ancora attiva e potrebbe risanarsi riducendo il debito, il piano potrebbe prevedere la continuazione dell’attività (c.d. concordato minore in continuità) offrendo ai creditori di essere pagati coi flussi di cassa futuri. Oppure, se l’attività è cessata, si può proporre di liquidare alcuni beni (la barca, un immobile) e distribuire il ricavato ai creditori in percentuale concordata, evitando però le azioni esecutive disordinate e ottenendo comunque la liberazione dai debiti. In più, qui è possibile includere anche i crediti erariali e contributivi chiedendo la loro adesione (transazione fiscale/contributiva): l’Agenzia delle Entrate e l’INPS potranno votare a favore di un trattamento che li soddisfi almeno in parte, accettando una falcidia o dilazione dei rispettivi crediti.
Limiti: il concordato minore, dovendo ottenere il voto dei creditori, può risultare più difficile da realizzare se i creditori sono ostili o troppo numerosi. Il debitore non ha la garanzia dell’omologa contro la loro volontà (salvo il cram-down eventuale se solo alcuni dissenzienti contestano senza ragione, ma è un tecnicismo applicabile in casi limitati). In sostanza, è uno strumento utile se c’è spazio di negoziazione con i creditori principali. Se invece i creditori sono irreperibili o rigidi, il debitore minore preferirà forse la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata per passare oltre.
È opportuno evidenziare un aspetto segnalato dalla giurisprudenza: creditori ipotecari e diritto di voto. La Cassazione ha ribadito (sent. 22797/2023) che se un creditore ipotecario subisce dal piano un pagamento non conforme al contratto (ad esempio viene pagato in 10 anni anziché alle scadenze originarie), ciò costituisce per lui un “sacrificio” che gli attribuisce diritto di voto . Questo è importante perché in passato c’era dubbio se bastasse pagare integralmente un ipotecario, seppur in modo dilazionato, per escluderlo dal voto. Ora sappiamo che anche la dilazione significativa dà diritto di voto al privilegiato. Quindi, nel costruire il piano, occorre calcolare le maggioranze tenendo conto di questi voti.
Infine, durante il concordato minore il debitore gode di misure protettive: può chiedere al tribunale di sospendere eventuali azioni esecutive già pendenti e di vietare nuovi pignoramenti mentre la proposta è al vaglio (solitamente per non più di 120 giorni, prorogabili in casi eccezionali). Inoltre, l’omologa del concordato minore, come per il piano, comporta l’esdebitazione del debitore rispetto ai crediti coinvolti: se egli adempie alle obbligazioni assunte col concordato, i crediti residui vengono definitivamente cancellati.
Liquidazione controllata del sovraindebitato
Questa procedura, prevista agli artt. 268-277 CCII, riprende la “liquidazione del patrimonio” della vecchia legge. La differenza rispetto al fallimento (liquidazione giudiziale) è che qui stiamo operando su un soggetto non fallibile, con regole più snelle e su base volontaria (di solito). Il debitore infatti può domandare la propria liquidazione quando capisce di non poter offrire un piano sostenibile. In alcuni casi possono chiederla anche i creditori o l’OCC se un piano concordatario fallisce, ma perlopiù è una scelta del debitore stesso per venire a capo della situazione in modo ordinato.
Cosa comporta: Il tribunale apre la procedura e nomina un liquidatore, che prende in consegna tutto il patrimonio attuale del debitore (e anche i sopravvenuti nell’arco di 4 anni dall’apertura, salvo quelli derivanti da redditi da lavoro in misura necessaria al mantenimento). Il liquidatore ha poteri simili a quelli di un curatore fallimentare: può vendere i beni mobili e immobili, anche d’ufficio o tramite commissionario, ripartisce il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione (privilegi, ipoteche, ecc.), sotto la sorveglianza di un giudice delegato.
Il debitore ha l’obbligo di collaborare, di non nascondere nulla, di consegnare documentazione e anche parte dei suoi redditi se eccedono il necessario. In cambio, ottiene due benefici: 1. Il blocco immediato delle azioni esecutive individuali: una volta aperta la liquidazione controllata, i creditori concorrono soltanto in quella procedura e non possono più agire singolarmente (c’è una parità di trattamento). 2. L’esdebitazione a fine procedura: quando il liquidatore ha terminato le operazioni, il debitore persona fisica può chiedere di essere liberato dai debiti residui non soddisfatti. Il tribunale gliela concede se ritiene che abbia cooperato lealmente e non vi siano ragioni ostative (ad esempio frodi). Non è necessario, a differenza del passato, che sia stato pagato almeno in parte ogni creditore chirografo: anche se i creditori non prendono nulla, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione.
Il caso tipico per la liquidazione controllata è quello di chi possiede ancora dei beni ma non riesce a gestire concordatamente la crisi. Ad esempio, un ex imprenditore nautico con una casa e una barca ipotecate e vari debiti: mettendo tutto in liquidazione controllata, la casa e la barca verranno vendute dal liquidatore (possibilmente a valori di mercato migliori che in un’asta precipitosa), i creditori privilegiati incasseranno fino a concorrenza e i chirografari in base a cosa residua, e poi il debitore sarà liberato dal resto. La Cassazione ha però di recente evidenziato un aspetto problematico: per i creditori fondiari (quelli garantiti da ipoteca di primo grado su immobile, tipicamente banche per mutui fondiari) vale, anche nella liquidazione da sovraindebitamento, la regola dell’art. 41 TUB che consente loro di proseguire o iniziare l’esecuzione individuale nonostante la procedura concorsuale . In altre parole, se la casa è ipotecata, la banca può scegliere di portare avanti la sua azione esecutiva individuale, e la liquidazione concorsuale si limiterà a distribuire l’eventuale attivo per gli altri creditori. Questa è una differenza rispetto al fallimento, in cui pure il creditore fondiario può procedere in via separata. La pronuncia (Cass. 22914/2024) ha suscitato dibattito e si attendono sviluppi, ma per ora va tenuto presente: aprire la liquidazione non garantisce automaticamente di fermare l’asta di una casa ipotecata da mutuo fondiario.
Durata: una liquidazione controllata dura in media qualche anno, a seconda della complessità nel vendere i beni. Durante questo periodo il debitore è sorvegliato (non può ad esempio alienare beni senza coinvolgere la procedura) ma mantiene la gestione di quanto non facente parte dell’attivo ceduto (ad esempio i redditi futuri al netto della quota destinata ai creditori).
Esdebitazione del debitore incapiente (“fresh start” a zero)
Questa misura speciale merita un cenno separato. Introdotta dall’art. 283 CCII, consente alla persona fisica che non ha nulla da offrire ai creditori di ottenere comunque la cancellazione dei debiti. Si rivolge quindi al debitore veramente disperato, il cosiddetto nullatenente “meritevole”. La ratio è di evitare che costui rimanga per sempre esclavo dei debiti senza via d’uscita, quando è evidente che neppure una liquidazione darebbe frutti.
Condizioni principali: – Il debitore non deve avere alcun patrimonio liquidabile né attuale né prospettico. Se ha anche solo un piccolo bene cedibile, deve prima ricorrere alla liquidazione controllata normale. – Il debitore non deve aver ottenuto in precedenza altra esdebitazione incapiente; è ammessa una sola volta. – Deve essere meritevole: non aver commesso atti di frode, non aver dissipato volontariamente il patrimonio, non aver fatto spese voluttuarie sproporzionate contribuendo con dolo o colpa grave al proprio dissesto. – Deve dimostrare di non poter offrire neanche parzialmente soddisfazione ai creditori, nemmeno in futuro (ad es. è disoccupato stabile, non ha competenze facilmente monetizzabili, ha un’età o condizioni di salute che rendono improbabile una ripresa reddituale significativa). – Deve comunque presentare tutta la documentazione sui debiti e sui redditi/patrimonio degli ultimi anni, coinvolgendo un OCC per certificare il rispetto dei requisiti.
La procedura è semplificata: il debitore deposita ricorso al tribunale con l’ausilio dell’OCC, indicando i motivi della propria insolvenza e la totale incapienza. Il giudice convoca i creditori per sentire eventuali osservazioni; se ritiene tutto regolare, emette un decreto di esdebitazione che cancella i debiti. Possono essere imposti obblighi al debitore: ad esempio, se nei 4 anni successivi dovesse sopravvenire una qualche utilità (un’eredità, una vincita, un miglioramento di reddito), egli dovrà pagare comunque i creditori fino a concorrenza di quanto ricevuto, altrimenti l’esdebitazione può essere revocata. Questo per evitare furbizie.
Un esempio concreto può essere il seguente: Tizio, skipper cinquantenne, ha cessato l’attività dopo aver perso la barca (pignorata dalla banca) e la casa (venduta per pagare debiti). Gli restano debiti per 100.000 € tra banche e Fisco. Tizio ora non ha nulla intestato, vive ospite da un parente e ha un reddito modesto da lavoretti saltuari. In queste condizioni, anche liquidare formalmente il patrimonio non darebbe nulla ai creditori, perché di fatto non c’è patrimonio. Tizio può chiedere l’esdebitazione da incapiente: se il tribunale accerta che non vi sono stati atti in frode e che la sua situazione è realmente compromessa senza risorse, potrà cancellare quei 100.000 € di debiti in blocco , liberando Tizio dall’incubo di essere perseguitato a vita. Naturalmente, se Tizio l’anno dopo vincesse alla lotteria 50.000 €, dovrebbe darli ai vecchi creditori (il beneficio non è un condono assoluto se arrivano capacità di pagamento entro 4 anni). Ma in mancanza di miracoli, i creditori non potranno più agire contro di lui.
Questa misura è stata salutata come un importante progresso sociale , perché riconosce il diritto al fallimento onesto anche al povero debitore civile, analogamente a quanto succede in altri Paesi. Allo stesso tempo, la legge è attenta a prevenire abusi: chi ha anche minime risorse è tenuto prima a metterle a disposizione nella liquidazione; chi ha colpe nel proprio dissesto non viene premiato; e la possibilità è unica, quindi chi ne beneficia sa di doversela giocare bene.
Strumenti di protezione del patrimonio del debitore
Oltre alle soluzioni che portano a risolvere o ridurre i debiti, è opportuno menzionare quegli strumenti giuridici che un debitore può aver adottato (o pensare di adottare) per proteggere i propri beni dalle aggressioni dei creditori. Tra i più noti vi sono il fondo patrimoniale e il trust. È importante però comprenderne bene limiti e rischi, perché il loro utilizzo improprio può risultare inefficace o addirittura controproducente.
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è un istituto del diritto di famiglia (artt. 167-171 c.c.) che consente ai coniugi – o anche alle unioni civili, e dal 2016 pure a un singolo genitore per i figli minori – di destinare determinati beni (immobili, mobili registrati come autovetture o imbarcazioni, e titoli di credito) ai bisogni della famiglia. I beni inseriti nel fondo formano un patrimonio separato, con il vincolo che frutti e utilizzo devono servire alla famiglia, e con un limite ai creditori: i creditori non possono pignorare i beni del fondo per debiti estranei ai bisogni familiari, purché fossero a conoscenza di tale estraneità (art. 170 c.c.) .
Molti imprenditori, temendo il rischio di debiti, hanno negli anni costituito un fondo patrimoniale su beni come la casa di abitazione, sperando così di “blindarli” dai futuri creditori dell’attività. Tuttavia la tutela del fondo è meno ampia di quanto talora si creda: – Opera solo per debiti estranei ai bisogni familiari: ciò significa che se il debito è stato contratto per scopi inerenti ai bisogni della famiglia, il creditore può comunque aggredire i beni del fondo. E chi definisce cos’è “bisogno familiare”? La giurisprudenza lo interpreta in senso abbastanza lato: non solo le esigenze essenziali (cibo, salute, casa), ma anche tutto ciò che indirettamente mantiene la famiglia. Ad esempio, debiti contratti per l’attività lavorativa principale del capofamiglia sono considerati di regola funzionali al mantenimento della famiglia stessa, e quindi non estranei . Se uno skipper ha messo la casa in fondo patrimoniale, ma i debiti derivano dalla sua attività con cui manteneva moglie e figli, difficilmente potrà opporre il fondo ai creditori di quei debiti: i tribunali diranno che quell’obbligazione era connessa alle esigenze familiari perché il reddito dell’attività era destinato alla famiglia . – Necessaria conoscenza del creditore: l’art. 170 c.c. richiede, per negare l’azione esecutiva, che il creditore conoscesse (al momento del credito) che esso era stato contratto per scopi estranei alla famiglia . Questo è un onere della prova molto difficile per il debitore: deve dimostrare che il creditore sapeva. Se parliamo di Fisco o banca, quasi mai si potrà dimostrare una consapevolezza del genere. È più facile nei debiti chiaramente estranei (ad es: uno dei coniugi fa da garante per un terzo: quel debito per definizione non riguarda la famiglia, e il creditore – es. la banca – lo sa perché il finanziamento era per un altro soggetto; ecco un caso in cui l’esecuzione su fondo potrebbe essere bloccata). – Limiti temporali e opponibilità: il fondo va costituito con atto pubblico e annotato a margine dell’atto di matrimonio per essere opponibile. Se non si è fatto ciò, i creditori possono non tenerne conto. Inoltre, se il fondo è costituito quando già i debiti stavano sorgendo, è suscettibile di essere revocato come atto in frode (revocatoria ordinaria entro 5 anni) .
Di recente la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito questi concetti (Cass. civ. n. 21438/2025): non basta che il debito sia legato all’attività lavorativa per dire che è estraneo ai bisogni familiari; occorre che il creditore potesse percepire chiaramente che quel debito nulla aveva a che fare con la famiglia . Insomma, la protezione del fondo non è automatica né generale , ma circoscritta a casi particolari.
Per uno skipper, tipicamente i debiti professionali saranno considerati inerenti al lavoro che sfama la famiglia, quindi i creditori (banche, Fisco, fornitori) potranno attaccare anche casa e barca nel fondo. Diverso sarebbe se avesse debiti completamente scollegati (ad es. una fideiussione prestata ad un amico per l’acquisto di un’auto: questo sarebbe estraneo alla famiglia e noto come tale, dunque il fondo potrebbe reggere a quella specifica esecuzione). Anche debiti derivanti da illecito extracontrattuale: se, poniamo, uno skipper provoca un danno nautico e viene condannato al risarcimento, quel debito potrebbe non essere per bisogni familiari; ma se stava lavorando, forse lo è comunque perché legato alla sua attività produttiva di reddito.
In pratica, il fondo patrimoniale offre una protezione limitata. Serve se si vogliono preservare i beni da aggressioni legate a debiti eccentrici rispetto alla famiglia. Non serve a impedire l’escussione da parte del fisco per le tasse di famiglia, né delle banche per il mutuo familiare, né dei creditori dell’attività principale se i proventi andavano alla famiglia . Per un imprenditore, insomma, non è uno scudo assoluto. Come indicato dagli esperti, bisogna considerarlo solo entro i suoi limiti e attuarlo con criterio: – Costituirlo in tempi non sospetti, quando ancora non ci sono grosse esposizioni (se lo fai alla vigilia del default, verrà probabilmente revocato). – Conferire beni che davvero sono legati alla famiglia (tipicamente la casa di abitazione). – Evitare confusioni tra conto famiglia e conto impresa, altrimenti ogni spesa diventa “per la famiglia” e addio protezione. – Informare eventualmente i contraenti del fatto che esiste il fondo e che l’obbligazione assunta è per fini estranei (anche se, va detto, raramente un creditore accetterebbe di firmare sapendo che poi non potrà aggredire quei beni).
In conclusione, il fondo patrimoniale non è la panacea: resta utile in un’ottica di pianificazione patrimoniale preventiva, ma non salva l’imprenditore da responsabilità professionali o tributarie, a meno di situazioni molto specifiche .
Trust e altri vincoli di destinazione
Un altro strumento diffuso per proteggere il patrimonio è il trust di diritto anglosassone, che l’ordinamento italiano riconosce in virtù della Convenzione dell’Aja del 1985 (ratificata con L. 364/1989) . Nel trust, un disponente trasferisce beni a un trustee affinché li amministri a beneficio di certi beneficiari o per un fine determinato. I beni in trust formano un patrimonio separato rispetto sia al disponente che al trustee : questa segregazione è ciò che rende il trust attraente per proteggere i beni da possibili pretese dei creditori del disponente (se non addirittura del trustee o dei beneficiari). Ad esempio, uno skipper potrebbe istituire un trust familiare e trasferirvi la proprietà della casa o di altri cespiti, nominando trustee un fiduciario, a vantaggio dei figli, con lo scopo di tutelare tali beni nel lungo periodo.
Tuttavia, anche il trust non è intoccabile. Le autorità (specie il Fisco) e i creditori possono reagire in diversi modi: – Sul piano civile, attraverso l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare: se il trust viene costituito dopo che esisteva già un debito (o era prevedibile che sarebbe sorto), i creditori defraudati possono chiederne l’inefficacia nei loro confronti. In particolare, il trust auto-dichiarato (dove il disponente è anche trustee) o con beneficiari legati al disponente viene spesso visto con sospetto: potrebbe trattarsi di uno schermo simulato, dove il debitore in realtà continua a disporre dei beni come prima. Se tale simulazione è provata, gli atti del trust sono dichiarati inopponibili ai creditori ex art. 2901 c.c. – Sul piano penale, attenzione: se il trust è usato per sottrarre beni al Fisco in presenza di debiti tributari, si può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). La Cassazione penale ha affermato che costituire un trust auto-destinato (dove disponente e beneficiario coincidono in sostanza) per schermare i propri beni di fronte a una cartella esattoriale rientra nella fattispecie penale . Quindi non solo i creditori civili possono aggredire il trust, ma il disponente rischia addirittura conseguenze penali se l’operazione è chiaramente fraudolenta e volta a evitare il pagamento di imposte. – Un trust opaco (senza obbligo di distribuzione di redditi ai beneficiari) potrebbe sollevare questioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate tende a considerare i redditi generati comunque imputabili al disponente o al trustee se il trust è considerato interposto. Ad esempio, in un caso recente un trust estero è stato disconosciuto e i redditi tassati in capo al disponente, sulla base del principio substance over form, privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma giuridica .
Ciò non significa che il trust sia sempre illecito. Se istituito per tempo e per scopi genuini, ad esempio la tutela dei figli disabili, la pianificazione successoria o la protezione di beni familiari quando non ci sono debiti all’orizzonte, il trust è valido e rispettato dall’ordinamento. Ma il confine tra pianificazione lecita e abuso di diritto è sottile : se il trust viene creato in prossimità di difficoltà finanziarie con l’unico scopo di mettere in salvo i beni dai creditori, quasi certamente sarà attaccato con successo. La tempistica è spesso la prova chiave: creare un trust “d’urgenza” appena arrivano gli accertamenti fiscali o le citazioni in tribunale è un pessimo segnale.
Un cenno va anche all’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: si tratta di un vincolo di destinazione introdotto nel 2006 che permette di destinare beni immobili o mobili registrati a uno scopo meritevole (anche a tutela di una persona con disabilità, o per un’attività di impresa) per max 90 anni o vita del beneficiario. È una sorta di trust “all’italiana”, con pubblicità nei registri immobiliari. Anch’esso crea una separazione patrimoniale e può essere usato per proteggere un bene da creditori estranei allo scopo. Ha costi notarili e fiscali, ed è meno noto nella prassi . Come per il trust, se usato con finalità fraudolente verrà revocato; se usato in modo corretto (e non a ridosso di un default) può aiutare a segregare ad esempio un immobile per la famiglia in modo simile al fondo patrimoniale, ma anche per scopi imprenditoriali specifici.
Riassumendo sui trust/vincoli: uno skipper prudentemente potrebbe aver istituito un trust o vincolo per tutelare la casa con largo anticipo e per motivi leciti; questo probabilmente reggerà e i creditori non potranno toccare quel bene. Ma fare questi atti quando si è già indebitati è inefficace: i creditori vedranno attraverso la cortina e otterranno tutela giudiziaria. Come efficacemente espresso dalla giurisprudenza, “un trust privo di reale autonomia – quando il disponente ne mantiene controllo di fatto – può essere qualificato come mero schermo simulato, inefficace verso Fisco e dei creditori” . Viceversa, un trust istituito in bonis e per finalità legittime gode della tutela di legge, salvo sempre lo scrutinio sulla genuinità .
Altre tutele del debitore: diritti inespropriabili e opposizioni legali
Chiudiamo la rassegna degli strumenti difensivi con alcuni aspetti aggiuntivi: – Limiti all’espropriabilità di stipendi e pensioni: un skipper che sia lavoratore dipendente in ambito marittimo (ad esempio comandante per conto di un’azienda) e che abbia debiti personali, può trovarsi con una trattenuta sullo stipendio in caso di pignoramento presso terzi da parte di un creditore. La legge prevede che lo stipendio possa essere pignorato nei limiti di 1/5 del netto mensile (salvo concorso di cause diverse). Per le pensioni, esiste anche una soglia di impignorabilità assoluta pari a circa 1,5 volte l’assegno sociale (oggi attorno a €750): la parte di pensione sotto tale soglia non si tocca, oltre si può pignorare il quinto. Queste norme (art. 545 c.p.c.) garantiscono al debitore un minimo di sussistenza. Anche i sussidi e indennità di navigazione, se qualificati come sostentamento, potrebbero godere di protezioni simili. – Opposizione a cartelle e atti esecutivi: il debitore ha diritto di difendersi in giudizio contro atti illegittimi o infondati. Ad esempio, se una cartella esattoriale è viziata nella notifica, o contiene importi non dovuti, è possibile presentare ricorso alle competenti Corti di Giustizia Tributaria (nuovo nome delle Commissioni Tributarie) entro 60 giorni, ottenendo l’annullamento totale o parziale dell’atto. Se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo su un credito contestato (magari lo skipper ritiene di non dovergli quanto richiesto), si può fare opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, aprendo un giudizio di merito in cui far valere le proprie eccezioni. Ancora, se viene notificato un atto di precetto (l’ultimo avviso prima del pignoramento) basato su un titolo invalido o già pagato, si può proporre opposizione all’esecuzione per far dichiarare l’inefficacia di quel titolo. Insomma, l’inerzia è nemica del debitore: ogni atto va esaminato insieme a un legale per cogliere se ci sono margini di opposizione. Spesso, termini persi equivalgono a diritti persi. – Usura, anatocismo e verifiche sui crediti bancari: in alcuni casi, dietro un debito verso la banca può celarsi l’applicazione di interessi usurari o di clausole nulle (ad esempio interessi anatocistici illegittimi). Far esaminare da un esperto di diritto bancario i contratti di mutuo, di conto corrente o leasing potrebbe portare a scoprire che una parte del debito preteso non è dovuta legalmente. Sebbene la materia sia complessa e le cause bancarie lunghe, è un’opzione che qualche debitore considera, specialmente quando le cifre per interessi e spese superano il capitale.
- Sovraindebitamento familiare: infine, notiamo che la legge consente, in talune situazioni, una gestione unitaria dei debiti di più membri della stessa famiglia. Ad esempio, marito e moglie indebitati insieme possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi con un piano comune, se le loro posizioni sono intrecciate (le modifiche del 2020-2021 lo hanno facilitato). Questo può essere utile per uno skipper sposato la cui moglie magari ha co-firmato prestiti o è contitolare di debiti: invece di due procedure separate, se ne fa una sola, riducendo costi e garantendo un risultato coordinato.
Dopo aver passato in rassegna gli strumenti, passiamo ora a una sezione di Domande e Risposte pratiche che spesso vengono poste dai debitori in situazioni analoghe, per chiarire dubbi ricorrenti. Successivamente proporremo anche alcune tabelle riepilogative per riassumere i punti chiave emersi.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Si può finire in carcere per dei debiti non pagati?
R: In linea generale no, il nostro ordinamento – come la maggior parte dei sistemi moderni – vieta la detenzione per inadempimento di obbligazioni civili (il cosiddetto divieto di “carcere per debiti” sancito dall’art. 21 Costituzione). Tuttavia, attenzione: questo vale per i debiti civili e commerciali. Diverso è se il mancato pagamento configura un reato. Ad esempio, non è reato non pagare un fornitore o una banca, ma può esserlo omettere il versamento di imposte sopra certe soglie (omesso versamento IVA oltre 250.000 €, reato tributario) o contributi previdenziali omessi per importi rilevanti (reato ora depenalizzato sotto soglie minime). Inoltre, l’elusione fraudolenta dei creditori (ad esempio, nascondere beni durante una procedura esecutiva, simulare la propria insolvibilità) può costituire reato di frode ai creditori. Quindi, sebbene nessuno venga arrestato “perché è indebitato”, comportamenti illeciti connessi al non pagamento possono avere rilievo penale. Per il debitore onesto che semplicemente non ce la fa economicamente a pagare, la sanzione è soltanto patrimoniale (pignoramenti, perdita dei beni), non la privazione della libertà.
D: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può portarmi via la casa o la barca?
R: Può farlo a certe condizioni. Come spiegato, la casa di abitazione principale del debitore non è ipotecabile né espropriabile per debiti fiscali sotto €120.000, se è l’unico proprietà e vi risiede il debitore . Sopra quella soglia, oppure se il debitore ha altri immobili, la casa può essere pignorata e venduta all’asta anche dall’Agente pubblico. Invece una barca da diporto, non essendo “prima casa”, non gode di alcuna protezione: se il debito supera €8.000 l’Agente può iscrivere un fermo amministrativo che impedisce di navigare; oltre €20.000 può iscrivere ipoteca; e oltre le soglie di legge può procedere a pignorare e far vendere l’imbarcazione, seguendo le procedure speciali per le vendite di unità navali (che sono simili a quelle per i beni mobili registrati). Quindi sì, in mancanza di altre soluzioni, il Fisco può colpire anche la barca di uno skipper debitore. Soluzioni come il fondo patrimoniale o il trust, come visto, difficilmente bloccherebbero il Fisco se il debito fiscale riguarda l’attività con cui si manteneva la famiglia . È sempre preferibile cercare di rateizzare o definire prima che si arrivi a queste misure drastiche.
D: Cosa succede se non pago più le rate del mutuo della barca (o del gommone) che ho acquistato?
R: La banca, dopo i solleciti di rito, potrà risolvere il contratto di mutuo e chiedere il rimborso integrale del debito residuo in un’unica soluzione. Non ottenendolo, agirà giudizialmente. Se c’è un’ipoteca navale sulla barca, l’azione tipica è il pignoramento e la vendita forzata dell’imbarcazione. Tale vendita avviene attraverso il tribunale competente, con stima dell’unità e fissazione di un’asta. L’acquirente all’asta ottiene la barca libera da ipoteche. Se il ricavato non basta a coprire il debito, tu resterai debitore per la differenza (salvo diversi accordi). In parallelo, verrai probabilmente segnalato come “cattivo pagatore” in centrale rischi. È bene, appena ci si accorge di non riuscire più a pagare, non aspettare il pignoramento: contatta la banca, verifica se è possibile una moratoria (a volte per i leasing nautici c’erano stati accordi di categoria per sospendere le rate in momenti di crisi), oppure considera di vendere tu stesso la barca sul mercato libero (di solito spunta prezzi migliori dell’asta) per poi rimborsare la banca col ricavato. Se la banca vede collaborazione, potrebbe preferire un accordo transattivo sul residuo dopo vendita spontanea, invece di procedere forzosamente.
D: Ho debiti con fornitori del charter nautico e alcuni minacciano di portarmi via la barca. Possono farlo anche se la barca è di una società e i debiti personali?
R: Bisogna distinguere: se la barca appartiene a una società (es. una s.r.l. di cui tu sei socio) e i debiti sono contratti dalla società, ovviamente i creditori sociali possono pignorare la barca (bene della società debitrice). Se invece la barca è intestata a una società e i debiti sono personali tuoi, in genere i creditori personali non possono aggredire beni di una società distinta, salvo che dimostrino che la società è tuo alter ego e provino una simulazione (caso estremo). Quindi, tenere i beni in una società di capitali separa il patrimonio. Attenzione però: molte volte gli imprenditori nautici danno garanzie personali per i debiti sociali (fideiussioni a banche, firme personali ai fornitori): in tal caso, se la società non paga, il creditore può agire sul tuo patrimonio personale (casa, auto personali, conti personali) ma comunque non sui beni della società (come la barca) se questa società non è debitrice diretta. Diverso il discorso se la società è una ditta individuale: lì non c’è distinzione, l’imbarcazione intestata alla ditta è un bene del debitore imprenditore e risponde di tutti i debiti.
D: Cosa rischio se lascio semplicemente che i creditori mi pignorino tutto, senza fare nessuna procedura?
R: Rischi di subire la cosiddetta “esecuzione frazionata e prolungata”: ogni creditore può agire sui tuoi beni, magari in tempi diversi, vendendo pezzo per pezzo a poco prezzo, e se qualcosa resta dovuto tornerà alla carica più avanti (fintanto che i debiti non siano prescritti o estinti). In assenza di una procedura concorsuale, i debiti non spariscono mai completamente: se un’asta paga al creditore solo il 50%, quel creditore potrà tra qualche anno cercare altri beni o redditi da aggredire per il restante 50%, e così via. Il risultato è che rimani esposto a vita, con la prospettiva di non poter mai ricostruire nulla a tuo nome per paura che venga preso. Questo ha conseguenze personali pesanti (stress, impossibilità di programmare il futuro). Al contrario, attivare una procedura di sovraindebitamento o, se applicabile, subire un fallimento, conduce prima o poi a una chiusura definitiva: con l’esdebitazione vieni liberato legalmente dai debiti residui . È la differenza tra un percorso di qualche anno per tornare “puliti” e un limbo indefinito. Pertanto, arrendersi all’inerzia non è affatto consigliabile. Meglio sfruttare le tutele di legge per voltare pagina, se possibile.
D: In una procedura di sovraindebitamento dovrò vendere per forza la casa o la barca?
R: Dipende dal tipo di procedura e dalla sostenibilità del piano senza liquidare quei beni. Nel piano del consumatore, se la casa di abitazione è ipotecata, a volte si riesce a mantenerla includendo nel piano la continuazione del pagamento del mutuo regolarmente (conservazione dell’immobile). Alcuni tribunali, valutando caso per caso, hanno approvato piani dove la famiglia manteneva la prima casa pagando gradualmente le rate scadute e riprendendo il mutuo. Questo è possibile se il piano risulta comunque più vantaggioso per tutti rispetto alla vendita forzata. Analogamente, una barca potrebbe essere conservata se è strumentale al reddito del debitore (es. la usa per lavorare) e se lasciargliela genera introiti per pagare i creditori maggiori di quanto darebbe una vendita. Viceversa, nel concordato minore e nella liquidazione, di norma i beni non essenziali vanno venduti: la casa finisce nel piano solo se i creditori ipotecari ottengono almeno il valore di realizzo (spesso coincide con la vendita stessa); la barca, se c’è un leasing o ipoteca, probabilmente va liquidata perché difficilmente potrà essere “risparmiata” salvo pagare integralmente il garantito. Tieni presente che la legge 3/2012 aveva un articolo (art. 12-ter, comma 4) che permetteva di escludere la prima casa dalla liquidazione se non eccessivamente di lusso e se ciò non pregiudicava i creditori: alcuni tribunali applicavano questa norma a tutela dell’abitazione familiare. Nel CCII tale previsione non è esplicita, ma resta la possibilità che il giudice, valutate le circostanze (ad es. valore modesto della casa e bambini piccoli del debitore), favorisca soluzioni che la salvino. In definitiva, non è automatico che tutto vada venduto: c’è margine di negoziazione e di convincimento nella procedura. L’assistenza di un buon OCC/consulente sarà decisiva per studiare la strategia migliore (tenere il bene vs liquidarlo) bilanciando tuo interesse e convenienza dei creditori.
D: Quali debiti NON si cancellano nemmeno con queste procedure?
R: La regola generale delle procedure di sovraindebitamento è che tutti i debiti anteriori sono compresi e, se non soddisfatti integralmente, vengono esdebitati. Fanno però eccezione alcuni debiti di natura particolare, per i quali la legge esclude l’esdebitazione: – Le obbligazioni alimentari e di mantenimento: se devi versare assegni di mantenimento a ex coniuge o figli, quelli non li puoi falcidiare né far cancellare; rimangono dovuti integralmente (altrimenti si penalizzerebbero i diritti altrui). – Le sanzioni penali (multe, ammende) e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano risarcitorie: ad esempio, le contravvenzioni al Codice della Strada o le sanzioni tributarie per violazioni (anche se su queste ultime c’è dibattito, spesso vengono comunque ricomprese con assenso dell’ente). – Debiti per danni da fatto illecito extracontrattuale se derivanti da reato non colposo: cioè se sei debitore per aver commesso un delitto doloso (es. truffa, lesioni volontarie), quei risarcimenti potrebbero non essere esdebitabili per ragioni di ordine pubblico. – L’IVA e poche altre eccezioni di diritto UE in passato erano ritenute inesdebitabili, ma la normativa italiana attuale consente di includere anche l’IVA (salvo attendere una pronuncia di omologazione; c’era un dibattito poi superato).
In ogni caso, queste esclusioni sono limitate. La stragrande maggioranza dei debiti, specie quelli commerciali, finanziari, fiscali e contributivi, viene spazzata via dall’esdebitazione finale, a patto che il debitore rispetti le regole della procedura e agisca correttamente. Questo è il grande sollievo del sistema: come evidenziato, l’intento è di non lasciare la persona inseguita a vita dai creditori , ma di dare una soluzione definitiva equilibrata (il debitore paga quel che può, i creditori incassano il ragionevole, il resto si cancella).
D: I miei debiti sono stati ceduti a società di recupero crediti che mi tempestano di telefonate. Posso includere anche loro nelle procedure?
R: Sì, certamente. I cessionari del credito (società di recupero o veicoli che hanno comprato i crediti deteriorati da banche, finanziarie, utility) subentrano esattamente nella posizione dei creditori originari e partecipano come tali alle procedure. Dovrai elencarli nella lista dei creditori con il nome corretto e l’importo aggiornato. Una volta omologato un piano o aperta una liquidazione, anche queste società dovranno rispettare le misure di sospensione: ad esempio non potranno più chiamarti a tutte le ore né mandare esattori, perché la gestione del debito passerà sotto l’egida dell’OCC e del tribunale. Un consiglio: comunica loro tramite raccomandata/PEC che hai avviato una procedura ex L.3/2012 (ora CCII) e fornisci i riferimenti dell’OCC nominato; spesso ciò è sufficiente a far interrompere le azioni di recupero “aggressive”, perché sanno che dovranno trattare nell’ambito della procedura legale e non possono avere corsie preferenziali.
D: Quanto tempo ci vuole per tornare puliti?
R: La durata varia a seconda della soluzione scelta e della complessità del caso: – Un piano del consumatore può essere omologato in pochi mesi (3-6 mesi tipicamente), dopodiché dura per il periodo previsto (spesso 4-5 anni di pagamento). Quindi in totale diciamo 5 anni medi prima di ottenere il decreto di esdebitazione. – Un concordato minore richiede un po’ di tempo per il voto: direi 6-12 mesi per omologa, poi se prevede pagamenti anch’esso dura il periodo del piano (spesso dai 3 ai 5 anni). – Una liquidazione controllata dipende dall’attivo: se ci sono beni da vendere, possono volerci 2-3 anni per liquidare tutto; l’esdebitazione poi arriva subito a fine procedura. Se non ci sono beni, può chiudersi prima, anche in 1 anno. – L’esdebitazione dell’incapiente è la più rapida sulla carta: qualche mese per il decreto e poi la persona è libera (fatti salvi quei 4 anni di “osservazione” per eventuali sopravvenienze). C’è da dire che spesso c’è un periodo di preparazione (raccolta documenti, incontri con OCC) che può durare vari mesi prima del deposito in tribunale. E alcune procedure possono subire intoppi o opposizioni che le allungano. In ogni caso, parliamo di pochi anni, non decenni, e al termine c’è la luce: come ricordato in dottrina, la persona può ripartire con una “fedina finanziaria” pulita e senza lo spettro dei vecchi debiti. Vale la pena a fronte magari di 5 anni di sacrifici ottenere ciò, piuttosto che trascinarsi debiti per decenni.
D: Dopo l’esdebitazione potrò di nuovo accedere a finanziamenti o aprire attività?
R: Sì, l’esdebitazione non comporta interdizioni future. Il nominativo del debitore comparirà per un certo tempo nei registri dei falliti o delle procedure (tenuti presso i tribunali), ma questo non è di solito pubblico mainstream. Le banche dati creditizie private registrano le insolvenze e le segnalazioni CRIF di solito per 36 mesi dall’ultima segnalazione o aggiornamento negativo. Ottenuta l’esdebitazione, si può portare il decreto che lo attesta alla Banca d’Italia e chiedere l’aggiornamento della propria posizione in Centrale Rischi. In pratica, si torna ad essere finanziariamente “vergini”. Ovviamente, l’accesso immediato a nuovo credito non è automatico: le banche potrebbero inizialmente essere prudenti. Ma se il soggetto riprende un lavoro stabile e dopo qualche tempo chiede un prestito, nulla gli vieta di farlo: legalmente è come se i debiti pregressi fossero estinti, e non c’è alcun divieto di indebitarsi di nuovo (anche se, auspicabilmente, con più cautela). Molti parlano di fresh start proprio per indicare la possibilità di ripartire sia economicamente sia socialmente senza l’etichetta di “insolvente”.
D: Ho costituito un trust anni fa per i miei figli: i creditori possono attaccarlo comunque?
R: Se il trust è stato costituito anni fa, quando non avevi magari debiti rilevanti, e aveva una finalità legittima (tutela dei figli per gli studi, ecc.), è più difficile per i creditori contestarlo. Dovrebbero intentare una causa sostenendo che il trust è simulato o fraudolento. Avendo molti anni alle spalle, la revocatoria ordinaria potrebbe non essere più esercitabile (c’è un termine di 5 anni dall’atto). Rimane la possibilità, se portato in giudizio, che provino a far dichiarare il trust come sham (schermo fittizio) se emergesse che in realtà continui tu a usare quei beni come fossero tuoi. Ad esempio, se hai messo la villa in trust ma tu e famiglia continuate a goderne come prima e il trustee è di fatto un tuo prestanome, un giudice potrebbe, in caso di esecuzione, ignorare il trust e far vendere comunque la villa considerandola ancora parte del tuo patrimonio (c’è una pronuncia Cass. civ. 34075/2024 che ha dichiarato nullo un pignoramento formalmente intestato al trust stesso, perché andava fatto nei confronti del trustee, a riprova che la procedura deve essere corretta, ma se la sostanza è che il trust è finto, esistono mezzi per non darvi effetto ). In sintesi: un trust “anziano” e genuino è abbastanza sicuro; uno recente o gestito male può essere penetrato. Se hai dubbi, meglio consultare un legale per valutare l’esposizione del trust ai tuoi creditori attuali.
D: Conviene aprire una società per separare i rischi e proteggere i beni personali?
R: In generale, sì, operare tramite una società di capitali (es. SRL) invece che come ditta individuale limita la responsabilità ai beni della società. Molti skipper/armatori hanno una SRL per il charter: in caso di debiti della SRL, tu come socio perdi al massimo il capitale investito, ma casa tua è al sicuro (salvo appunto garanzie personali prestate o casi di mala gestio così gravi da sfociare nella responsabilità personale degli amministratori). Attenzione però: se la società è piccola e la banca ti chiede comunque garanzia personale per darti prestiti, oppure i fornitori vogliono la tua avallo, allora la distinzione si assottiglia perché i creditori sociali potranno aggredire anche te in forza di quelle garanzie. Altro punto: la società va gestita correttamente anche in crisi; dal 2021 esiste la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa e obblighi di segnalazione per evitare che gli amministratori aggravino i danni ai creditori. Se una SRL va in default e ci sono atti distrattivi, i creditori potrebbero accusare l’amministratore (te) di responsabilità patrimoniale per mala gestione, vanificando parte della protezione. Quindi la forma societaria è raccomandabile per limitare i rischi, ma non è uno schermo totale se poi nei fatti l’imprenditore si espone personalmente o non rispetta le regole.
D: Posso fare affidamento su aiuti pubblici o sul “fondo antiusura” dello Stato se sono indebitato?
R: Esistono dei fondi pubblici: ad esempio il Fondo di prevenzione dell’usura gestito dal MEF concede garanzie a banche che erogano prestiti a soggetti sovraindebitati a rischio usura, per aiutarli a consolidare i debiti in modo sostenibile. Però sono interventi limitati e non di massa: bisogna rivolgersi alle Fondazioni antiusura presenti sul territorio, che valutano caso per caso. In genere questi strumenti si attivano quando c’è pericolo concreto che il debitore cada vittima di usurai, e comunque serve avere un minimo di reddito per rimborsare il nuovo prestito garantito dallo Stato. Altri aiuti: i servizi di consulenza delle associazioni dei consumatori o delle Camere di Commercio (che hanno sportelli per la composizione crisi da sovraindebitamento) possono dare orientamento gratuito. Dal punto di vista normativo, la vera “ancora di salvezza” è la già citata legge sul sovraindebitamento che, pur non regalando denaro, consente legalmente di tagliare il debito.
D: Se aderisco a una procedura di sovraindebitamento, i miei beni futuri (eredità, vincite) saranno al sicuro dai vecchi creditori?
R: Una volta ottenuta l’esdebitazione, i vecchi creditori non potranno più toccare nulla, né del presente né del futuro. L’unica eccezione è nella esdebitazione incapiente: come detto, se entro 4 anni ricevi somme rilevanti, devi destinarle ai creditori fino a soddisfarli o almeno in parte, pena revoca del beneficio . Ma per le procedure ordinarie (piano, concordato, liquidazione con esdebitazione finale), dopo la chiusura positiva tu rinasci libero: se ad esempio fra 10 anni ereditassi una casa dallo zio, i creditori del passato non avrebbero più alcun diritto, perché il debito è stato cancellato giudizialmente. Quindi potrai goderti l’eredità, eventualmente usando prudenza se temi nuovi indebitamenti (es: potresti allora decidere di fare un fondo patrimoniale o un trust, ma a quel punto con una situazione pulita e creditori nuovi inesistenti).
Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione dei concetti esposti, riportiamo alcune tabelle di sintesi.
Tabella 1: Tipologie di debito e caratteristiche principali
| Tipo di debito | Esempi per uno skipper | Prescrizione | Garanzie/Privilegi | Recupero e rischi per il debitore |
|---|---|---|---|---|
| Fiscale (Erariale) | IVA, IRPEF, IRES su redditi da charter, sanzioni | 10 anni (se tributo erariale) ; atti interruttivi necessari | Privilegio generale sui mobili per imposte dirette; ipoteca esattoriale su beni per debiti > €20k | Cartella esattoriale → fermo auto, ipoteca casa/barca, pignoramenti. No pignoramento prima casa sotto soglia . |
| Fiscale (Locale) | IMU su immobile, TARI su ufficio, ecc. | 5 anni (tributi locali periodici) | Privilegio su mobili del debitore per tributi locali (di rango inferiore a quello erariale) | Cartella esattoriale → simile a sopra (Agenzia Riscossione). Nessuna tutela speciale sulla prima casa per debiti locali (la protezione prima casa vale solo per l’Agente pubblico su tributi erariali). |
| Contributivo | Contributi INPS artigiani/commercianti, Gestione separata, premi INAIL | 5 anni (generalmente, ex L.335/95) | Privilegio generale sui mobili (contributi lavoro hanno grado alto). | Avviso di addebito INPS → stesso iter di cartella. Pignoramenti possibili su beni personali, conti, ecc. Nessuna protezione prima casa specifica (segue regole tributi erariali se ruolo Equitalia). |
| Bancario – mutuo | Mutuo per acquisto barca o casa | 10 anni (rate mutuo non pagate soggette a prescrizione ordinaria) | Ipoteca volontaria sull’immobile o bene registrato; eventuale pegno se su titoli. | Decreto ingiuntivo (se risoluzione anticipata del mutuo) → pignoramento bene ipotecato. Bene venduto all’asta; se ricavato insufficiente, debito residuo chirografario a tuo carico. Segnalazione in Centrale Rischi. |
| Bancario – credito | Prestito personale, scoperto conto, carta credito | 10 anni dalla scadenza/fido revocato | Eventuale privilegio se cambiale; altrimenti chirografo. A volte garanzia consortile o personale. | Decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 50 TUB → pignoramento stipendi, conti, ecc. Segnalazione in sistemi creditizi come sofferenza. |
| Leasing | Leasing nautico (barca in leasing) | 10 anni per canoni scaduti | Clausola patto marciano (dal 2017) consente riprendersi bene e vendere, tenendo il dovuto. Bene è di proprietà della società leasing fino a riscatto. | Risoluzione leasing per morosità → ritiro immediato dell’imbarcazione; vendita privata o giudiziaria. Se prezzo < debito leasing, residuo dovuto (ma patto marciano impone per legge restituzione eccedenze se valore > debito). |
| Fornitori commerciali | Fatture per carburante, ormeggio, manutenzione barca | 5 anni (diritti diversi da lavoro e senza prescrizione breve specifica) | In genere chirografo puro. Eccezione: alcuni hanno privilegio speciale (es. creditore riparatore nave ha privilegio su nave stessa ex art. 552 Cod.Nav.). | Decreto ingiuntivo → pignoramenti vari. Possibile sequestro conservativo se fondato timore di perdita garanzia. Nessuna protezione specifica: tutti i beni aggredibili tranne quelli impignorabili ex lege (strumenti lavoro in parte, beni di minimo vitale ex art. 514 c.p.c.). |
| Dipendenti (lavoro) | Retribuzioni equipaggio non pagate | 5 anni (retribuzioni) | Privilegio generale sui mobili (alto grado) ex art. 2751-bis c.c.; privilegio su nave per salari equipaggio (Cod.Nav.) | Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (crediti lavoro) → pignoramento conti, eventuali beni aziendali. Possono insinuarsi in procedure concorsuali con privilegio prioritario. |
| Personali vari | Debiti verso amici, familiari, spese mediche, ecc. | 10 anni se riconosciuti con scrittura; 5 anni se periodici o non formalizzati | Chirografari (salvo eventuali pegni su beni dati a garanzia privata) | Possono richiedere ingiunzione o citazione in giudizio. Una volta a titolo esecutivo, agiscono su qualsiasi bene come altri creditori (salvo beni impignorabili). |
| Fiscale sanzionatorio | Multe stradali, sanzioni tributarie | 5 anni (sanzioni amm.ve ordinarie) | Nessun privilegio per sanzioni pecuniarie (solo imposta ha privilegio). | Cartelle esattoriali separate. Nelle procedure di sovraindebitamento le sanzioni vengono di regola trattate come chirografarie (spesso azzerate), ma formalmente alcune non sarebbero esdebitabili (multe penali, sanzioni amministrative non risarcitorie). |
Note: la prescrizione indicata può essere interrotta e decorrere di nuovo dal momento dell’atto interruttivo (diffida, raccomandata, atto giudiziario). Inoltre la conversione del termine breve in decennale ex art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; un atto amministrativo non opposto (come la cartella) resta soggetto al termine proprio del credito . I privilegi indicati condizionano il modo in cui i crediti vengono pagati in concorso e nelle esecuzioni: un creditore privilegiato o ipotecario sarà soddisfatto con precedenza sul ricavato dei beni su cui insiste la sua garanzia.
Tabella 2: Confronto tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
| Procedura | Soggetti ammessi | Necessità accordo creditori? | Durata tipica | Esito per il debitore |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione debiti consumatore (artt. 67-73 CCII) | Persona fisica “consumatore” (debiti personali non di impresa prevalenti) | No, omologazione giudiziale anche senza consenso creditori (salvo eventuali privilegiati in deroga) | 4-5 anni di piano (dopo ~6 mesi per omologa) | Pagamento parziale dei debiti secondo il piano; esdebitazione totale residuo a fine piano se rispettato . Creditori vincolati dal decreto di omologa. |
| Concordato minore (artt. 74-83 CCII) | Debitore sovraindebitato non consumatore (piccoli imprenditori, professionisti, start-up, imprenditori cessati, soggetti con debiti misti) | Sì, serve voto favorevole della maggioranza dei crediti votanti (maggioranze per classi). Omologato dal giudice se c’è approvazione. | Variabile: se piano in continuità può durare 5 anni o più; se liquidatorio, tempi di liquidazione beni (2-3 anni). | Se adempie agli obblighi concordatari, esdebitazione del residuo insoddisfatto. Se non approvato dai creditori, possibile conversione in liquidazione controllata. |
| Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) | Qualsiasi debitore non fallibile insolvente (anche consumatore o imprenditore minore). Avviabile su istanza del debitore o convertita da procedure fallite. | Non applicabile (non c’è accordo, è liquidazione concorsuale). Creditori partecipano ma non “approvano”. | 1-3 anni (dipende dall’attivo da liquidare; se niente attivo può chiudersi in pochi mesi). | Liquidazione di tutti i beni tramite liquidatore; chiusura procedura con decreto di esdebitazione per il debitore persona fisica . Debiti cancellati salvo eccezioni di legge. |
| Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) | Persona fisica nullatenente “meritevole”, una volta sola. Non per imprenditore in attività (dev’essere cessata). | Non richiede accordo né pagamento creditori (creditori possono essere sentiti, ma nessun voto). | Pochi mesi per ottenere il decreto, poi 4 anni di “osservazione” per eventuali utilità sopravvenute. | Cancellazione immediata di tutti i debiti senza pagamenti . Se entro 4 anni il debitore acquisisce risorse, deve destinarle in pagamento ai vecchi creditori (pena revoca beneficio); decorso il quadriennio, liberazione definitiva. |
Tabella 3: Strumenti di protezione patrimoniale e loro efficacia
| Strumento | Descrizione | Vantaggi | Limiti / Rischi |
|---|---|---|---|
| Fondo patrimoniale | Vincolo su beni destinati ai bisogni della famiglia (costituito da coniugi o per figli). Beni impignorabili per debiti estranei a bisogni fam. se creditori ne erano a conoscenza . | – Semplicità e costo contenuto (atto notarile). <br>- Protegge effettivamente dai crediti totalmente estranei (es. fideiussioni per terzi, investimenti speculativi personali) . <br>- Tutela la casa di abitazione da debiti non familiari se ben strutturato. | – Non protegge dai debiti dell’attività lavorativa principale (considerati per bisogni fam.) .<br>- Il creditore deve conoscere l’estraneità (onus probandi sul debitore) .<br>- Revocabile se costituito in prossimità della crisi (entro 5 anni, art. 2901 c.c.) .<br>- Vale solo tra coniugi/uniti (single no, salvo per figli minori con trust/2645-ter).<br>- Se il reddito del debitore deriva dall’attività d’impresa, il confine tra spese personali e familiari tende ad annullarsi (Cass. 5097/2009: reddito integralmente destinato alla famiglia = debiti impresa non estranei) . |
| Trust (autodichiarato o con trustee terzo) | Trasferimento di beni a un trustee con scopo di tutela patrimoniale (es. trust familiare). Beni segregati fuori dal patrimonio del disponente . | – Massima separazione: beni non aggredibili dai creditori personali del disponente se trust istituito in tempi non sospetti per finalità legittime .<br>- Flessibilità di gestione (trustee può gestire per il sostentamento dei beneficiari).<br>- Riconosciuto in Italia (Conv. Aja) e modulabile (revocabile/irrevocabile, discrezionale/fisso) . | – Costi elevati (notaio, eventuale trustee professionale).<br>- Se fatto dopo insorgenza debiti, attaccabile con azione revocatoria (5 anni) o dichiarato sham se disponente mantiene controllo .<br>- Possibili profili di reato se scopo è sottrarre beni al Fisco (Cass. Pen. 13844/2024) .<br>- Gestione poco trasparente può portare a qualificarlo come schermo simulato inefficace verso i creditori .<br>- Aspetti fiscali complessi (imposte di donazione, tassazione trust opaco con nuove norme in evoluzione). |
| Vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.) | Atto pubblico che destina un immobile o bene registrato a uno scopo meritevole (familiare o altruistico) per max 90 anni. Patrimonio separato limitato al bene vincolato e ai suoi frutti. | – Opponibile ai terzi con trascrizione (come ipoteca).<br>- Flessibile: scopi vari (tutela disabili, garantire finanziamento, ecc.).<br>- Costo relativamente inferiore al trust estero, normativa italiana. | – Meno diffuso nella prassi, conoscenza limitata .<br>- Come il fondo, tutela solo per debiti estranei allo scopo dichiarato; e creditori possono contestare scopo fittizio.<br>- Revocabile ex art. 2901 c.c. se in frode ai creditori (entro 5 anni). |
| Società di capitali | Intestare beni (barca, immobili) a una s.r.l. o s.p.a. di famiglia. Separazione tra patrimonio sociale e personale. | – Creditori personali non possono aggredire beni sociali (e viceversa).<br>- Debiti d’impresa limitati al patrimonio della società (salvo garanzie personali).<br>- Possibilità di far fallire la società lasciando indenne il socio (se non ha garanzie). | – Se socio/amministratore presta fideiussioni personali, perde beneficio separazione per quei debiti.<br>- Costi di gestione e oneri amministrativi società.<br>- Gestione scorretta può portare a abuso di personalità giuridica (azione revocatoria su conferimenti anomali, responsabilità per mala gestio).<br>- In caso di insolvenza societaria, la società può essere sottoposta a liquidazione giudiziale (fallimento) con riflessi indiretti sul socio/amministratore. |
Conclusione
Affrontare una situazione di sovraindebitamento come quella di uno skipper sommerso dai debiti è senza dubbio impegnativo, ma l’esperienza insegna che esistono vie d’uscita legali e concrete. L’ordinamento italiano, specialmente negli ultimi anni, ha compiuto notevoli passi avanti per predisporre strumenti di tutela del debitore sovraindebitato – dal favor debitoris ispiratore della legge “salva suicidi” , fino alle più recenti innovazioni del Codice della Crisi (come l’esdebitazione totale per il debitore incapiente) . Ciò risponde a un’evoluzione culturale: dal biasimare il debitore in difficoltà si è passati a comprendere che offrire una seconda chance a chi è onesto e cooperativo è un beneficio non solo personale ma anche sociale ed economico, perché consente di recuperare individui al circuito produttivo e combattere fenomeni degenerativi (usura, lavoro nero, depressione sociale).
Dal punto di vista pratico, il debitore-skipper deve anzitutto prendere consapevolezza della propria situazione finanziaria: fare un inventario dei debiti, dei creditori, delle risorse disponibili. Quindi attivarsi presto, senza aspettare che i problemi degenerino in cause e pignoramenti. Il ventaglio di soluzioni include: – Negoziare con i creditori chiave, se possibile, per guadagnare tempo o ridurre il debito (una telefonata franca alla banca o al fornitore a volte ottiene più di quanto si pensi, specie se supportata da un professionista che dia credibilità). – Valutare le procedure formali di sovraindebitamento: contattare un Organismo di Composizione della Crisi (spesso istituito presso le Camere di Commercio o gli Ordini professionali locali) per farsi assistere. Con il loro aiuto, scegliere se tentare un piano del consumatore o concordato minore, o se optare direttamente per la liquidazione controllata, spiegando bene tutte le implicazioni. – Proteggere, nel frattempo, il necessario per vivere: ad esempio spostare l’accredito dello stipendio su un conto non aggredibile in caso di pignoramento (ci sono limiti all’impignorabilità di somme pagate nei 7 giorni, etc., ma serve un occhio esperto per queste tecnicalità), evitare di accumulare troppa liquidità su conti facilmente pignorabili, eventualmente ragionare su strumenti protettivi entro il lecito (senza commettere sottrazioni fraudolente). – Mantenere la trasparenza e la buona fede: collaborare con l’OCC, fornire tutti i dati, non nascondere nulla. Una piccola incongruenza o bugia scoperta in fase di procedura potrebbe compromettere l’intera operazione . Meglio dichiarare anche gli insuccessi e le spese fatte – i giudici apprezzano la chiarezza e la volontà di rimediare. – Non scoraggiarsi per eventuali iniziali insuccessi: se un giudice dovesse dichiarare inammissibile una proposta di piano, spesso è possibile correggere il tiro e ripresentarla (ora è esplicitamente previsto anche un reclamo in caso di inammissibilità, grazie alle modifiche del 2022-2024) . L’importante è individuare la causa del rifiuto (documentazione incompleta? offerta troppo bassa? errori procedurali?) e porvi rimedio.
Per concludere, la difesa del debitore in Italia non è più un miraggio. Uno skipper indebitato ha oggi gli strumenti legali per difendersi dalle pretese più spietate – sospendendo aste e pignoramenti, contestando gli atti viziati, eccependo prescrizioni – e per risollevarsi con procedure che, pur richiedendo sacrifici, gli permetteranno di ripartire senza il fardello dei debiti passati. È un cammino da intraprendere con serietà e con l’assistenza di professionisti esperti (avvocati, commercialisti, OCC), ma al termine del quale l’ex debitore potrà finalmente tornare a solcare le acque della propria vita professionale con una navigazione più serena e libera dai marosi finanziari precedenti.
Sei uno skipper professionista o freelance e ti trovi in difficoltà economica, con debiti verso fornitori, banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei uno skipper professionista o freelance e ti trovi in difficoltà economica, con debiti verso fornitori, banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate?
Hai accumulato cartelle esattoriali, contributi INPS arretrati o rate non pagate e ora temi pignoramenti o il blocco dell’attività nautica?
👉 Non tutto è perduto: anche per chi lavora nel settore marittimo, la legge offre strumenti concreti per difendersi, ridurre o cancellare i debiti e ripartire legalmente, senza rischiare la perdita della barca o dei contratti di charter.
In questa guida scoprirai come affrontare una situazione di indebitamento come skipper o comandante di imbarcazioni, quali sono le soluzioni legali possibili, e come proteggere i tuoi beni e la tua carriera.
⚖️ Perché molti skipper si trovano indebitati
L’attività di skipper, sia come libero professionista che come titolare di piccole società nautiche, è tra le più esposte a crisi finanziarie.
Le cause più comuni sono:
- stagionalità del lavoro e lunghi periodi di inattività;
- ritardi nei pagamenti da parte dei clienti o dei charter;
- contributi e tasse elevate rispetto ai guadagni reali;
- mutui o leasing per l’acquisto di barche o attrezzature;
- sanzioni fiscali o previdenziali dovute a errori di gestione.
📌 Quando i debiti aumentano e non riesci più a pagarli, rischi fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti e perdita della licenza o dei beni personali.
🚤 Tipologie di debiti più frequenti per gli skipper
✅ Debiti fiscali e contributivi
- IRPEF, IVA, INPS, INAIL, cartelle esattoriali e accertamenti fiscali.
✅ Debiti bancari e finanziari
- Mutui nautici, leasing per imbarcazioni o motori, prestiti personali.
✅ Debiti commerciali
- Fornitori di carburante, manutenzione, ormeggi, assicurazioni o agenzie charter.
✅ Debiti personali o familiari
- Carte di credito, prestiti o garanzie fideiussorie firmate per società nautiche.
🧠 Cosa rischi se non intervieni subito
Se ignori la situazione, i creditori possono:
- bloccare i conti bancari o il conto del charter;
- avviare pignoramenti dei compensi o dei beni personali;
- far scattare fermi o ipoteche su imbarcazioni;
- segnalarti in centrali rischi o sistemi creditizi;
- in caso di partita IVA, sospendere i rapporti commerciali con le società di charter o i clienti.
👉 Tuttavia, la legge oggi ti permette di bloccare tutto e ricominciare da zero, attraverso strumenti di composizione della crisi e difesa legale.
🧩 Le soluzioni legali per gli skipper indebitati
💠 1. Rinegoziazione dei debiti con banche e fornitori
È possibile trattare accordi di saldo e stralcio o piani di rientro sostenibili, soprattutto se i creditori sanno che non possono recuperare tutto.
Puoi ottenere:
- rate più leggere o sospensione temporanea dei pagamenti;
- riduzione del capitale e cancellazione di interessi e sanzioni;
- saldo definitivo con importi inferiori (anche -60%).
👉 È ideale se hai ancora contratti di lavoro o charter attivi e vuoi preservare la tua reputazione professionale.
💠 2. Procedura di sovraindebitamento (Legge n. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)
È la soluzione principale per skipper, freelance o ex imprenditori non fallibili.
Permette di:
- bloccare immediatamente pignoramenti, ipoteche e cartelle esattoriali;
- presentare un piano di pagamento parziale in base ai redditi disponibili;
- ottenere, al termine, la cancellazione totale del debito residuo (esdebitazione).
📌 È accessibile anche a chi ha chiuso la partita IVA o non ha più un reddito stabile.
💠 3. Liquidazione controllata dei beni (ex procedura di fallimento personale)
Se la tua attività non è più sostenibile, puoi liquidare i beni non essenziali (auto, imbarcazione, risparmi) in modo controllato dal Tribunale.
Dopo la chiusura della procedura, tutti i debiti vengono cancellati, consentendoti di ripartire pulito e senza pendenze.
💠 4. Concordato minore (per società nautiche o skipper con ditta individuale)
Se operi con una ditta o una piccola società di charter, puoi proporre ai creditori un concordato minore, approvato dal Tribunale, che prevede:
- una riduzione complessiva dei debiti;
- la sospensione immediata delle azioni esecutive;
- la ripartenza dell’attività con piano di rientro sostenibile.
💠 5. Verifica di cartelle e accertamenti fiscali
Molti skipper hanno debiti fiscali gonfiati da sanzioni e interessi.
Un avvocato può controllare:
- la prescrizione (spesso 5 anni per INPS e 10 per imposte dirette);
- eventuali errori di notifica o duplicazioni;
- la possibilità di chiedere l’annullamento o lo sgravio parziale.
⚓ Cosa fare subito
✅ 1. Fai un elenco completo dei debiti
Indica per ogni creditore: importo, tipo di debito, anno di origine e stato della pratica (sollecito, cartella, causa, pignoramento).
✅ 2. Non firmare accordi senza assistenza legale
Molte proposte di banche o finanziarie nascondono costi nascosti o condizioni peggiorative.
Serve una strategia unitaria, gestita da un avvocato esperto in crisi del debitore.
✅ 3. Agisci subito per bloccare le azioni esecutive
Con il deposito di una procedura di sovraindebitamento o concordato, puoi ottenere il blocco immediato dei pignoramenti e delle richieste dei creditori.
📋 Documenti utili per la difesa
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Certificato di iscrizione alla Capitaneria o all’albo professionale (se skipper professionista).
- Dichiarazioni dei redditi e posizione INPS/IVA.
- Estratti conto bancari e mutui nautici.
- Contratti di charter, leasing, assicurazioni e fornitori.
- Cartelle esattoriali, solleciti, decreti ingiuntivi.
⏱️ Tempi e risultati
- Analisi della situazione debitoria: 1–2 settimane.
- Presentazione del piano o della procedura: 1–3 mesi.
- Sospensione delle azioni dei creditori: immediata con il deposito in Tribunale.
- Durata del piano di rientro: da 1 a 5 anni.
🎯 Risultati concreti:
- Blocco di pignoramenti, fermi e ipoteche.
- Riduzione o cancellazione dei debiti.
- Tutela del patrimonio personale e lavorativo.
- Ripartenza professionale pulita e senza pendenze fiscali.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocchi ogni azione dei creditori e del Fisco.
✅ Ottieni una riduzione legale dei debiti fino all’80%.
✅ Eviti il fallimento o la chiusura forzata dell’attività.
✅ Proteggi la tua barca e gli strumenti di lavoro.
✅ Riparti con una posizione economica pulita.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle e solleciti fiscali.
- Accumulare nuovi debiti o usare carte di credito per tamponare.
- Affidarsi a mediatori o “consulenti” non avvocati.
- Rimandare troppo: più passa il tempo, più aumentano interessi e sanzioni.
- Pagare solo alcuni creditori, peggiorando la posizione con gli altri.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione debitoria e valuta la procedura più adatta (piano, liquidazione o concordato).
📌 Blocca le azioni esecutive e le cartelle tramite procedura di sovraindebitamento.
✍️ Redige e deposita il piano di rientro o la richiesta di esdebitazione al Tribunale.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con banche, fornitori, Agenzia delle Entrate e autorità marittime.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione definitiva dei debiti e alla riabilitazione economica.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto marittimo, tributario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di skipper, comandanti e operatori del settore nautico.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere uno skipper con debiti non significa dover rinunciare alla propria professione.
Con una difesa legale mirata puoi bloccare i creditori, ridurre o cancellare i debiti fiscali e bancari e ripartire in regola con la legge.
Oggi il Codice della Crisi d’Impresa offre la possibilità di chiudere col passato e salvare la tua attività nautica.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua rotta verso una nuova vita senza debiti comincia qui.