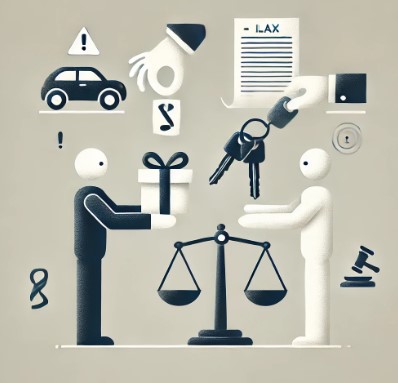Hai ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate o dall’INPS per fringe benefit concessi ai dipendenti ma non dichiarati?
Si tratta di un controllo sempre più frequente nelle aziende, in particolare per quei casi in cui i vantaggi concessi ai lavoratori – auto aziendali, buoni spesa, rimborsi spese, alloggi o altri benefit – non sono stati correttamente indicati in busta paga o nel modello 770.
L’Agenzia delle Entrate può infatti ritenere che tali benefit costituiscano reddito imponibile non dichiarato, e quindi soggetti a tassazione e contributi. Tuttavia, non tutte le contestazioni sono fondate: in molti casi i fringe benefit sono stati concessi nel rispetto della normativa o rientrano nei limiti di esenzione previsti dalla legge.
In questa guida spiegheremo quando il fringe benefit è imponibile, perché può essere contestato e come difendersi legalmente da un accertamento o da una sanzione.
Cosa sono i fringe benefit
I fringe benefit sono compensi in natura che il datore di lavoro concede al dipendente come parte della retribuzione.
Si tratta di vantaggi economici non corrisposti in denaro, ma che hanno un valore monetario riconoscibile, come ad esempio:
- auto aziendale ad uso promiscuo (per lavoro e uso personale);
- alloggio o casa in comodato d’uso;
- buoni pasto o buoni carburante;
- polizze assicurative sanitarie o sulla vita;
- prestiti agevolati ai dipendenti;
- rimborsi spese non documentati;
- telefoni, computer o altri beni aziendali concessi per uso personale.
In generale, i fringe benefit costituiscono reddito da lavoro dipendente e devono essere tassati, salvo le eccezioni espressamente previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Le soglie di esenzione previste dalla legge
L’articolo 51 del TUIR stabilisce che i fringe benefit non concorrono a formare reddito se di valore complessivo non superiore a 258,23 euro annui per ciascun dipendente.
Negli ultimi anni, a causa delle misure straordinarie post-pandemia, questa soglia è stata temporaneamente elevata (fino a 3.000 euro nel 2023) per i lavoratori con figli a carico.
Se il valore complessivo dei benefit concessi supera la soglia prevista, l’intero importo diventa imponibile, non solo la parte eccedente.
Inoltre, il datore di lavoro deve applicare la tassazione e i contributi previdenziali in busta paga, indicando correttamente il valore del benefit nel modello CU e nel 770.
Quando scatta la contestazione
La contestazione da parte del Fisco o dell’INPS può avvenire in diversi casi:
- fringe benefit non dichiarati o non indicati nelle certificazioni fiscali dei dipendenti;
- valore dei benefit sottostimato rispetto al reale utilizzo;
- rimborsi spese o premi aziendali qualificati come benefit esenti ma non supportati da documentazione;
- concessione di beni aziendali (auto, alloggi, telefoni) senza regolare contratto d’uso;
- compensi “mascherati” da benefit per ridurre il carico fiscale e contributivo.
In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate può contestare il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali, oltre a sanzioni e interessi. Tuttavia, in molti casi è possibile dimostrare la corretta gestione o la natura non imponibile del vantaggio concesso.
Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate
Durante le verifiche, l’Agenzia delle Entrate analizza:
- i contratti di lavoro e i regolamenti aziendali sui benefit;
- le buste paga e le certificazioni uniche dei dipendenti;
- la documentazione contabile dei costi sostenuti (fatture, note spese, carte carburante, polizze, ecc.);
- le comunicazioni interne e le policy aziendali sull’uso dei beni;
- i contratti di comodato o noleggio dei beni aziendali.
Se riscontra discrepanze o assenza di prove sufficienti, può considerare i benefit come reddito imponibile occulto e procedere con l’accertamento.
Cosa fare se ricevi un avviso di accertamento o una contestazione
Ricevere una contestazione per fringe benefit non dichiarati non significa che la pretesa del Fisco sia automaticamente valida.
Ecco i passaggi da seguire per difendersi correttamente:
- Leggi attentamente l’avviso ricevuto.
Verifica a quali dipendenti si riferisce, per quali annualità e con quali importi. - Raccogli tutta la documentazione utile.
Contratti di assegnazione dei beni, regolamenti aziendali, documenti contabili, comunicazioni interne e prove dell’effettivo utilizzo dei beni per fini lavorativi. - Controlla la correttezza della valutazione del Fisco.
Spesso l’Agenzia calcola il valore dei benefit in modo errato, senza considerare l’uso esclusivamente lavorativo o le franchigie di legge. - Fatti assistere da un avvocato esperto in diritto tributario o del lavoro.
Potrà predisporre una memoria difensiva, una richiesta di autotutela o un ricorso entro i termini di legge (generalmente 60 giorni).
Le principali strategie difensive
La difesa più efficace dipende dal tipo di fringe benefit contestato. Le strategie più comuni sono:
- dimostrare l’uso esclusivamente aziendale del bene, come nel caso di auto o cellulari concessi solo per lavoro;
- provare la corretta applicazione delle soglie di esenzione, se i benefit rientrano nei limiti di legge;
- produrre la documentazione mancante, come contratti o regolamenti che disciplinano la concessione;
- impugnare l’accertamento se l’Agenzia ha applicato criteri di valutazione arbitrari o retroattivi;
- chiedere la riduzione delle sanzioni o la definizione agevolata se la violazione è parzialmente riconosciuta.
In molti casi, una difesa documentata e ben articolata consente di ottenere l’annullamento o la forte riduzione della pretesa fiscale.
Le conseguenze per l’azienda e per i dipendenti
Se l’accertamento diventa definitivo, il datore di lavoro può essere obbligato a:
- versare le ritenute IRPEF non trattenute ai dipendenti;
- pagare i contributi previdenziali non versati;
- sostenere le sanzioni e gli interessi maturati.
Per i dipendenti, invece, il fringe benefit contestato può generare una maggiorazione del reddito imponibile e una successiva rettifica della dichiarazione dei redditi.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
È fondamentale rivolgersi a un avvocato se:
- hai ricevuto un avviso di accertamento o un verbale di verifica fiscale;
- il Fisco contesta benefit di importo rilevante o per più annualità;
- vuoi proporre ricorso o impugnare una cartella esattoriale derivante dall’accertamento.
Un avvocato esperto in diritto tributario e del lavoro può analizzare la fondatezza della contestazione, gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate e tutelarti in ogni fase del procedimento.
⚠️ Attenzione: non ignorare la contestazione. Se non presenti opposizione o documentazione entro i termini, l’accertamento diventa definitivo e può portare a pignoramenti e iscrizioni a ruolo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e diritto del lavoro – spiega in modo chiaro come comportarti se ricevi una contestazione per fringe benefit non dichiarati, quali prove raccogliere e come difenderti legalmente.
👉 Hai ricevuto una contestazione per fringe benefit ai dipendenti non dichiarati?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, valuteremo la legittimità della contestazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per difendere la tua azienda, ridurre le sanzioni e risolvere la controversia con il Fisco.
Introduzione
L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sui compensi in natura – i cosiddetti fringe benefit o retribuzioni non monetarie – erogati ai dipendenti senza la corretta tassazione. Si tratta di un tema complesso che intreccia normativa fiscale, contributiva e persino profili di diritto penale tributario. In questa guida avanzata – rivolta ad avvocati, imprenditori e contribuenti esperti – esamineremo dettagliatamente la normativa italiana (aggiornata a settembre 2025), le tecniche di accertamento utilizzate dal Fisco (in particolare ex artt. 38 e 39 del DPR 600/1973, e art. 51 TUIR) e soprattutto gli strumenti di difesa a disposizione del contribuente (il “debitore” d’imposta).
Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, fornendo riferimenti a fonti normative, prassi e sentenze aggiornate. Troverete tabelle riepilogative, domande e risposte (FAQ) su casi tipici e alcune simulazioni pratiche relative al contesto italiano. L’obiettivo è offrire un quadro completo di cosa fare se l’Agenzia contesta fringe benefit non dichiarati, illustrando sia come prevenire tali contestazioni sia come opporsi efficacemente, mantenendo il punto di vista del contribuente che deve difendersi dall’accertamento .
Cosa sono i fringe benefit e come sono tassati
Nel sistema tributario italiano, i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti “in natura” (beni, servizi o altre utilità erogati in luogo del denaro) sono considerati parte integrante del reddito di lavoro dipendente e, salvo specifiche eccezioni, vanno tassati come il normale stipendio. Il principio di onnicomprensività è sancito dall’art. 51, comma 1 del TUIR (DPR 917/1986), secondo cui «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» . In altre parole, ogni beneficio economicamente apprezzabile fornito al dipendente (vantaggi, beni o servizi) – se derivante dal rapporto di lavoro – concorre a formare il reddito imponibile .
Esempi comuni di fringe benefit includono: l’auto aziendale ad uso promiscuo (cioè utilizzabile sia per esigenze di servizio sia per scopi personali), un alloggio o abitazione fornita dall’azienda, i buoni pasto oltre le soglie di esenzione, i prestiti agevolati ai dipendenti, le polizze assicurative extra-professionali pagate dal datore, le azioni o stock option assegnate gratuitamente, l’uso personale di un telefono cellulare aziendale, i rimborsi spese forfettari non documentati, e in generale qualsiasi altro bene o servizio che il datore di lavoro offra al lavoratore traendone per quest’ultimo un vantaggio economico. Come vedremo, la normativa prevede criteri specifici per valutare ciascuno di questi benefit ai fini fiscali.
Limiti di esenzione e regole generali
Per favorire un uso limitato di tali strumenti, la legge prevede una soglia annua di esenzione: entro un certo importo totale, i fringe benefit non concorrono a formare il reddito del dipendente. L’art. 51, comma 3 TUIR stabilisce infatti che «non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (al dipendente) se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro»; viceversa, «se il valore è superiore a 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» . Quest’ultima previsione configura il noto meccanismo del “tutto o nulla”: se la somma dei fringe benefit annuali supera la soglia di esenzione, l’intero importo (e non solo la parte eccedente) diviene imponibile sia fiscalmente (Irpef) sia ai fini contributivi previdenziali .
Negli ultimi anni il legislatore ha più volte rimodulato questa soglia di esenzione, anche in via temporanea, per ragioni di politica economica e sociale. La tabella seguente riepiloga l’evoluzione dei limiti di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti negli anni recenti:
| Anno | Limite annuo di esenzione | Note e riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Fino al 2019 | € 258,23 | Soglia ordinaria ex art. 51 c.3 TUIR . |
| 2020-2021 | € 516,46 | Soglia raddoppiata in via temporanea (Decreto “Agosto” 2020, art. 112 DL 104/2020 conv. L.126/2020) . |
| 2022 | € 600,00 + utenze | Soglia elevata a €600 e inclusione dei rimborsi di bollette (acqua, luce, gas) per il solo 2022 (art. 12 DL 115/2022 “Aiuti-bis”) . Successivamente portata a €3.000 per il 2022 (DL 176/2022 “Aiuti-quater”) . |
| 2023 | € 258,23 (generale) – € 3.000 (solo per dipendenti con figli a carico) | Regime transitorio: art. 40 DL 48/2023 (“Decreto Lavoro”) . Solo i lavoratori con figli fiscalmente a carico beneficiano del tetto esentasse di €3.000 nel 2023 (comprensivo anche di bollette), mentre per gli altri rimane il limite ordinario di €258,23 . L’esenzione aggiuntiva a €3.000 è solo fiscale (IRPEF), non valida ai fini contributivi INPS . |
| 2024 | € 1.000 (generale) – € 2.000 (con figli a carico) | Introdotta in Legge di Bilancio 2024 (L.197/2023) la doppia soglia di esenzione fiscale e contributiva: €1.000 per tutti i dipendenti, elevata a €2.000 per i dipendenti con figli a carico . Estesa inoltre l’esenzione (entro tali limiti) ai rimborsi delle utenze domestiche e – come novità – alle spese per l’affitto o i mutui della prima casa del dipendente . |
| 2025-2027 | € 1.000 (generale) – € 2.000 (con figli a carico) | La Legge di Bilancio 2025 (L.207/2024) ha confermato per il triennio 2025-2027 le soglie già previste per il 2024 . Dunque restano stabili i limiti di €1.000 annui per tutti i dipendenti e €2.000 annui per quelli con figli a carico (in entrambi i casi comprensivi dei beni, servizi e somme per utenze, affitti e mutui prima casa) . In caso di superamento del limite, l’intero importo torna imponibile per imposte e contributi . |
Nota: Ai fini dell’eventuale soglia maggiorata per i figli a carico, il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto indicando i codici fiscali dei figli (secondo le modalità interne aziendali) . La condizione di “figlio fiscalmente a carico” segue la definizione dell’art. 12 TUIR (reddito del figlio non superiore a €4.000 annui, o €2.840,51 se oltre 24 anni) . È bene sottolineare inoltre che le norme temporanee possono differire tra imponibile fiscale e contributivo: ad esempio, per il 2023 i €3.000 erano esenti solo ai fini IRPEF ma non per i contributi INPS , mentre dal 2024 la esenzione è armonizzata sia sul piano fiscale sia su quello previdenziale (salvo diversa indicazione normativa).
Al di fuori di queste soglie di non imponibilità (o per i benefit non rientranti nelle eccezioni di legge), i fringe benefit sono soggetti a tassazione ordinaria come reddito di lavoro dipendente. Il datore di lavoro deve quindi assoggettarli a ritenute IRPEF e contabilizzarli nella Certificazione Unica del dipendente per l’anno di riferimento, nonché includerli nella base per i contributi previdenziali obbligatori (salvo esenzioni). In base al principio di cassa allargato, rileva il valore dei benefit percepiti nel periodo d’imposta, considerando anche quelli goduti entro il 12 gennaio dell’anno successivo (conguaglio fiscale) .
Valutazione fiscale dei principali benefit in natura
L’art. 51 TUIR, oltre a fissare il principio generale del “valore normale” per valutare i benefit (art. 51, co. 3 rinvia all’art. 9 TUIR sul valore di mercato ), elenca alcune regole specifiche di quantificazione forfettaria per fringe benefit frequenti (comma 4). Di seguito analizziamo i principali casi pratici:
- Autoveicoli ad uso promiscuo: Per le autovetture, motocicli e ciclomotori aziendali concessi in uso promiscuo al dipendente (uso sia lavorativo sia personale), la normativa prevede un criterio forfettario di determinazione del valore tassabile, in deroga al valore normale di mercato . Fino al 2024, la regola generale (introdotta dalla L.160/2019) era di considerare come fringe benefit il 30% di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolata secondo i costi chilometrici ACI, per i veicoli con emissioni di CO₂ comprese tra 61 g/km e 160 g/km . La percentuale era ridotta al 25% per i veicoli più ecologici (≤60 g/km CO₂) e aumentata al 50% e 60% rispettivamente per i veicoli con emissioni oltre 160 g/km e oltre 190 g/km . Dal 1° gennaio 2025, per i nuovi contratti di assegnazione, la Legge di Bilancio 2025 ha semplificato le aliquote incentivando l’elettrico: 50% del costo ACI per la generalità dei veicoli, 20% per gli ibridi plug-in e 10% per gli elettrici puri . (Una disciplina transitoria salvaguarda la “vecchia” percentuale per i veicoli già concessi o ordinati entro il 2024) . Esempio: un’auto tradizionale assegnata nel 2023 con costo chilometrico ACI di €0,50/km genera un fringe benefit annuo di €2.250 (15.000 km × €0,50 × 30%), interamente imponibile in quanto sopra soglia; la stessa auto assegnata nel 2025 genererà invece €3.750 (15.000 × €0,50 × 50%) come base imponibile. Se però al dipendente viene addebitato un importo per l’uso personale (es. trattenuta mensile in busta paga), tale somma si deduce dal benefit imponibile . La legge infatti prevede che il calcolo sia fatto “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente” a titolo di corrispettivo . Attenzione: secondo una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate, se il dipendente paga di tasca propria optional o accessori dell’auto aziendale, tali importi non riducono la base imponibile del fringe benefit auto , poiché non costituiscono un corrispettivo pagato al datore per l’utilizzo, ma una spesa volontaria.
- Alloggio aziendale: Se l’azienda concede in uso al dipendente un immobile (in locazione, comodato, o di proprietà aziendale) ad uso abitativo, il fringe benefit imponibile è calcolato – per disposizione di legge – come la differenza tra la rendita catastale annua dell’immobile (aumentata delle spese accessorie) e l’eventuale importo pagato dal dipendente per usufruirne . In formula: Valore benefit casa = Rendita catastale annua + spese (utenze, condominio, ecc.) – quota pagata dall’utente . Se l’immobile è privo di rendita catastale (es. non censito), si utilizza una rendita presunta basata su immobili similari . Esempio: un appartamento con rendita catastale di €1.200 annui, le cui bollette pagate dall’azienda ammontano a €400, concesso gratuitamente al dipendente, genera un fringe benefit di €1.600 annui . Se invece il lavoratore corrisponde un affitto simbolico (es. €500 annui), il benefit si riduce a €1.100. – Importante: va distinta la finalità. Se l’abitazione è concessa per esigenze lavorative imprescindibili (ad es. foresteria temporanea per un trasferimento o alloggio di servizio in cantiere remoto), potrebbe non configurarsi come vantaggio retributivo ma come strumento necessario all’esecuzione della prestazione. In tali casi particolari, si può sostenere l’assenza di tassazione (il beneficio è “strumentale” e non un arricchimento personale). Tuttavia, l’onere di provare la necessità aziendale dell’alloggio grava sul datore di lavoro e la giurisprudenza tende a riconoscere la natura retributiva dell’alloggio salvo prova chiara contraria . Di fatto, la Cassazione ha affermato che un’agevolazione abitativa concessa a un dipendente va considerata retribuzione imponibile se non è strettamente indispensabile alla prestazione lavorativa, costituendo un vantaggio economico continuativo per il lavoratore .
- Buoni pasto e mense: I buoni pasto e il servizio mensa aziendale seguono regole proprie. In base all’art. 51 TUIR, i ticket restaurant non concorrono al reddito fino a €4,00 cadauno se cartacei, o €8,00 se elettronici (importi esenti per ogni giornata lavorativa) . L’eventuale parte eccedente tali soglie giornaliere è imponibile. I pasti forniti gratuitamente in mense aziendali o convenzionate sono esenti (in misura ragionevole) . Dunque, una contestazione può sorgere se un datore fornisce buoni pasto oltre i limiti esenti senza tassazione: in tal caso, l’eccedenza deve essere recuperata a tassazione. Esempio: buoni pasto elettronici da €10: €8 restano non imponibili, €2 ciascuno diventano fringe benefit tassabile.
- Prestiti ai dipendenti: Se un’impresa concede prestiti o anticipazioni ai propri dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato (es. prestito aziendale a tasso zero), la differenza tra gli interessi calcolati al “tasso ufficiale” (ad es. tasso IRS o altro parametro indicato dal TUIR) e quelli effettivamente corrisposti dal lavoratore costituisce un fringe benefit tassabile . L’art. 51, comma 4, lett. b) TUIR disciplina infatti l’imponibile figurativo per i finanziamenti agevolati ai dipendenti. Esempio: un prestito di €10.000 a tasso 0% quando il tasso legale di riferimento è poniamo 1%, genera un beneficio tassabile pari a €100 (interesse figurativo non pagato) da imputare come reddito di lavoro dipendente.
- Azioni e stock option: L’assegnazione di azioni o quote societarie ai dipendenti può costituire retribuzione in natura. In via generale, se l’azienda offre azioni proprie (o di società del gruppo) ai dipendenti, il valore normale delle azioni (al netto di quanto eventualmente pagato dal lavoratore) è imponibile come fringe benefit. Vi è però un’esenzione specifica per i piani di azionariato diffuso: l’art. 51, comma 2, lett. g) TUIR esclude da tassazione le azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a €2.065,83 annui . Se tale importo è superato (o se le azioni non sono offerte alla generalità ma solo ad personam), l’intero valore concorre al reddito. Le stock option (diritti di acquistare azioni a prezzo scontato) sono imponibili al momento dell’esercizio se il prezzo pagato è inferiore al valore di mercato; anche qui, esenzioni sono previste in contesti specifici (start-up innovative, piani approvati etc.), ma esulano dallo scopo di questa guida.
- Altri benefit degni di nota: Polizze assicurative: i premi pagati dal datore per polizze a favore del dipendente (salvo quelle obbligatorie per legge o per CCNL, o quelle sanitarie rientranti in piani di welfare esenti) sono fringe benefit imponibili per il valore corrisposto. Regali e omaggi: beni di modico valore dati in occasioni speciali (Natale, anniversari) rientrano anch’essi nel conteggio dei €258,23 annuali; tuttavia, taluni contratti o prassi considerano esenti i regali di importo simbolico. Spese di trasporto: l’abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale pagato dall’azienda per il dipendente e familiari è esente (art. 51, comma 2, lett. d-bis) TUIR) , così come eventuali servizi di navetta aziendale . Al contrario, l’uso personale di dispositivi elettronici aziendali (PC, tablet, telefono) può generare fringe benefit se dall’uso promiscuo derivi un risparmio di spesa per il dipendente (in pratica però, per telefoni e computer l’Agenzia tende a tassare solo il rimborso di spese personali, mentre l’uso di un telefono aziendale per chiamate private di modesta entità spesso non viene contestato, applicandosi criteri di ragionevolezza amministrativa).
Riepilogando: tutti i beni, servizi o somme erogati al dipendente costituiscono reddito imponibile, salvo rientrino in specifiche esclusioni (previste dall’art. 51, commi 2 e 3 TUIR) o siano sotto le soglie di esenzione. Tra le esclusioni normative vi sono, ad esempio: i contributi previdenziali versati dal datore, l’utilizzo di servizi di welfare alla generalità dei dipendenti (ex art. 51 co.2 lett. f), i servizi di educazione, istruzione, assistenza familiare erogati dal datore (welfare legge di stabilità) , le mance per i dipendenti del settore turismo ecc. Ma attenzione: il fatto che un benefit possa non essere tassato ai fini IRPEF (perché escluso o entro soglia) non significa che non sia considerato retribuzione sotto il profilo lavoristico. Ad esempio, un’auto assegnata può essere esclusa da imposizione sotto un certo valore, ma andrà comunque considerata nella retribuzione annua ai fini di TFR, indennità di preavviso, ecc., in base al principio civilistico di omnicomprensività della retribuzione .
Quando scatta la contestazione del Fisco sui fringe benefit
Vediamo ora in quali casi l’Agenzia delle Entrate può contestare a un’azienda (o a un sostituto d’imposta) di aver erogato fringe benefit ai dipendenti senza adeguata tassazione, e su quali basi giuridiche. Le situazioni tipiche in cui scatta l’accertamento sono:
- Benefit concessi senza ritenute fiscali: il caso più comune è quando l’azienda non ha assoggettato a tassazione i valori di beni o servizi concessi ai dipendenti. Questo può emergere incrociando la contabilità aziendale (costi per auto, carburanti, affitti, rimborsi spese, ecc.) con le Certificazioni Uniche dei dipendenti. Se risultano spese aziendali riconducibili a vantaggi per i dipendenti, ma nessun corrispondente importo è stato dichiarato come fringe benefit, l’Ufficio presume un’omissione di tassazione . Esempio: l’azienda contabilizza €10.000 annui di spese carburante per l’auto di un dipendente, ma in busta paga del dipendente non risulta alcun fringe benefit auto: ciò sarà un chiaro indizio per i verificatori.
- Superamento dei limiti di esenzione: un altro scenario è quando i fringe benefit sono stati riconosciuti senza imposte confidando nell’esenzione, ma il loro valore eccede la soglia annua consentita. In tal caso, andava tassato l’intero importo, non solo l’eccedenza. L’Agenzia può contestare, ad esempio, che un dipendente ha ricevuto €400 di buoni acquisto in un anno, superando la soglia di €258,23: in base alla legge, l’intero importo (€400) era imponibile, ma se il datore non l’ha fatto, verrà recuperata la differenza . Analogamente, nel 2023, se un dipendente senza figli ha avuto €500 di benefit non tassati, l’Ufficio pretenderà le imposte sull’intera somma perché il limite di €258,23 è stato sforato.
- Documentazione carente sulla natura del benefit: il Fisco spesso verifica se l’azienda ha adeguata documentazione per sostenere l’eventuale natura strumentale o di necessità aziendale di certi costi. Se manca chiarezza, l’Ufficio può riqualificare quei costi come fringe benefit. Esempio: l’azienda rimborsa spese al dipendente per €3.000 annui senza pezze giustificative dettagliate (forfait). In assenza di note spese analitiche, il Fisco potrebbe considerare quei rimborsi come integrazione retributiva tassabile. Altrettanto, se un’auto aziendale non ha un registro di utilizzo o una policy che ne limiti l’uso personale, diventa arduo sostenere che non generi un fringe benefit: la mancanza di prova sull’inerenza esclusivamente aziendale porta l’Ufficio a presumere l’uso promiscuo (e quindi il vantaggio in capo al dipendente).
- Benefit concessi in modo sistematico e continuativo: quando beni o servizi sono forniti al lavoratore in maniera costante (ricorrente), è più difficile sostenere che non siano retribuzione. Il Fisco pone attenzione a situazioni in cui un benefit diventa di fatto parte integrante del pacchetto retributivo (ad esempio auto aziendale assegnata stabilmente, alloggio pagato per molti mesi, telefoni con spese interamente a carico datore, ecc.). In tali casi, anche se formalmente non contrattualizzati, i benefit possono essere assimilati a retribuzione fissa e la loro omissione dichiarativa viene contestata con maggiore rigore .
- Incongruenze tra dichiarazioni fiscali e costi aziendali: l’Amministrazione finanziaria effettua incroci e analisi di bilancio. Se un’azienda sostiene elevati costi per beni potenzialmente goduti dal personale (auto multiple, immobili, ecc.) mentre dichiara un monte salari esiguo, oppure se i dipendenti dichiarano solo stipendi modesti a fronte di evidenti benefici extra, scatta un alert. In sede di verifica, possono emergere discrepanze come: un amministratore con stipendio ufficiale basso ma con spese personali pagate dalla società (auto di lusso, viaggi familiari): ciò suggerisce utilizzo personale di beni sociali occulto. Tali incongruenze portano a contestare sia il maggior reddito di lavoro in capo al beneficiario, sia l’eventuale indebita deduzione di costi in capo all’azienda (vedi infra).
Quando l’Agenzia riscontra una di queste situazioni, procede a riqualificare i valori in questione come redditi da lavoro dipendente. Nella pratica operativa, l’accertamento può originare da controlli documentali (ex art.36-ter DPR 600/73 su CU e 770), da verifiche fiscali più approfondite (accessi, ispezioni e verifiche ex art.33 DPR 600/73, spesso condotte dalla Guardia di Finanza presso l’azienda) oppure dall’analisi dei dati comunicati (p.es. incrocio delle comunicazioni ex art. 51, co.4-bis TUIR sui rimborsi chilometrici, o – in passato – delle comunicazioni dei beni in godimento ai soci). Durante tali controlli, i funzionari applicano poteri istruttori ampi: possono chiedere libri paga, fatture, contratti di benefit, ecc., nonché ricorrere a indagini finanziarie sui conti aziendali per individuare spese anomale a beneficio di dipendenti.
Una volta accertata l’esistenza di fringe benefit non dichiarati, l’Ufficio notifica un Avviso di Accertamento per il recupero delle maggiori imposte dovute, tipicamente con riferimento all’IRPEF che sarebbe spettata sui redditi di lavoro dipendente non dichiarati. Poiché il sostituto d’imposta (datore di lavoro) è responsabile per le ritenute, l’accertamento viene rivolto normalmente all’azienda, richiedendo:
- il pagamento dell’IRPEF non versata su quei valori (generalmente calcolata in base agli scaglioni d’imposta dei dipendenti coinvolti, o come ritenuta omessa);
- il versamento delle relative addizionali regionali e comunali non trattenute;
- il pagamento dei contributi previdenziali INPS non versati (in quanto la base contributiva segue quella fiscale: i benefit imponibili fiscalmente lo sono anche contributivamente , salvo eccezioni temporalmente limitate);
- l’applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni commesse;
- il calcolo degli interessi di mora maturati sulle somme non versate.
Vediamo in dettaglio queste conseguenze dell’accertamento :
- Recupero a tassazione dei benefit: i compensi in natura vengono formalmente qualificati come redditi di lavoro dipendente imponibili per i periodi d’imposta contestati . Ciò comporta il ricalcolo dell’IRPEF dovuta su quei redditi. Trattandosi di ritenute non operate, l’Agenzia in genere richiede al datore l’intero ammontare dell’imposta che avrebbe dovuto trattenere (più addizionali). Ad esempio, se in un certo anno un dipendente in fascia IRPEF 38% ha ricevuto €5.000 di benefit non tassati, l’azienda dovrà versare circa €1.900 tra IRPEF e addizionali non assolte.
- Contributi previdenziali: parallelamente, l’INPS (spesso a seguito della segnalazione fiscale) può esigere i contributi omessi. I fringe benefit, salvo esenzione, fanno parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi (art. 12 L.153/1969) . Dunque, continuando l’esempio, su €5.000 di retribuzione in natura non dichiarata, il datore dovrà versare anche i contributi (a suo carico e a carico dipendente) calcolati su tale importo, oltre ad eventuali sanzioni civili per omissione contributiva. Va notato che imposte e contributi seguono logiche parallele ma autonome: l’Agenzia Entrate recupera le imposte, l’INPS i contributi. In sede di accertamento fiscale, comunque, spesso viene contestato anche il mancato assolvimento contributivo, preannunciando l’intervento dell’ente previdenziale.
- Sanzioni fiscali: la mancata dichiarazione/tassazione dei fringe benefit configura tipicamente una dichiarazione dei redditi infedele da parte del sostituto d’imposta (o anche del percettore, se tenuto a dichiarazione personale) e/o una omessa effettuazione di ritenute. Le sanzioni possono essere di due tipi:
- Sanzione per dichiarazione infedele: prevista dal D.Lgs. 471/1997 art. 1, pari al 90% dell’imposta evasa relativa ai redditi non dichiarati. In capo al datore di lavoro, se la violazione emerge nel 770 (dichiarazione del sostituto) o se viene considerata infedele la propria dichiarazione IRAP/IRES per aver dedotto costi non spettanti, si applica detta sanzione sul maggior tributo dovuto. Ad esempio, se dall’accertamento scaturiscono €10.000 di IRPEF non versata, la sanzione base è €9.000.
- Sanzione per omesso versamento di ritenute: se il datore ha operato la ritenuta ma non l’ha versata, si applicherebbe la sanzione del 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/97). Tuttavia, nei fringe benefit non dichiarati spesso la ritenuta non fu proprio operata, quindi tecnicamente si tratta di un’omissione di effettuazione della ritenuta. Questa è sanzionata come infedele dichiarazione (90%) se scoperta a consuntivo. In alternativa, a volte l’Ufficio potrebbe contestare la violazione dell’obbligo di operare ritenuta con sanzione del 20% (vecchia disciplina, oggi assorbita dal 90%). In pratica, la cornice sanzionatoria è severa ma modulabile in fase di definizione (vedremo oltre le possibilità di riduzione).
Inoltre, se l’azienda ha dedotto interamente costi che in realtà erano relativi a fringe benefit non tassati, l’Ufficio potrebbe contestarne l’indebita deduzione dal reddito d’impresa, in tutto o in parte . Ad esempio, i costi di un bene aziendale usato personalmente dal dipendente potrebbero essere ritenuti non inerenti per la quota di utilizzo personale, con recupero a tassazione IRES di quella quota. Questo profilo (indeducibilità) si affianca alla tassazione come retribuzione: il Fisco può quindi “colpire” sia il datore (negando deduzioni) che il dipendente (tassando il benefit) per la medesima fattispecie, in un’ottica di duplice livello impositivo (società e persona fisica).
- Interessi di mora: su tutte le somme dovute (imposte e ritenute non versate) vengono calcolati gli interessi al tasso legale (o al tasso di interesse fiscale) per il periodo intercorrente tra la scadenza originaria e la data di pagamento. Gli interessi non sono sanzionatori ma compensativi del ritardo.
- Verifiche collaterali e profili penali: una contestazione di fringe benefit può fare da apripista ad ulteriori controlli fiscali e contributivi sull’azienda. In particolare, se l’evasione è significativa, l’Ufficio può estendere l’indagine ad altri periodi d’imposta e ad altri aspetti (es. accertamento sintetico sul tenore di vita dei dipendenti beneficiari, controlli bancari, etc.). Inoltre, nei casi più gravi, la questione può sfociare in segnalazioni penali. Il diritto penale tributario prevede infatti reati come la dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e l’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs.74/2000) quando si superano determinate soglie. Ad esempio, l’omesso versamento di ritenute oltre €150.000 costituisce reato penale. Se i fringe benefit non dichiarati comportano imposte evase sopra €100.000 e rappresentano più del 10% dell’imponibile dichiarato, potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione infedele. In casi estremi, laddove la condotta fosse accompagnata da frode fiscale (es. utilizzo di fatture false per mascherare benefit personali) si potrebbe profilare la dichiarazione fraudolenta (art.2 D.Lgs.74/2000) o, quanto meno, l’aggravante dell’art. 3 (mezzi fraudolenti). Inoltre, se un socio o amministratore ha goduto di beni sociali occultando redditi, potrebbe addirittura intravedersi l’autoriciclaggio nel reimpiego di utilità aziendali sottratte a tassazione . Questi scenari penali sono riservati a situazioni di notevole evasione o artifici; nella gran parte dei casi ordinari di fringe benefit non dichiarati, si resta nell’alveo delle sanzioni amministrative. È però fondamentale esserne consapevoli: una contestazione di importo rilevante va gestita con attenzione anche per mitigare eventuali profili di responsabilità penale.
In sintesi, le contestazioni del Fisco sui fringe benefit non dichiarati possono essere molto onerose: oltre al tributo evaso, si rischiano sanzioni elevate e interessi, senza contare i contributi e le possibili ricadute penali e civilistiche (ad esempio, un dipendente potrebbe rivalersi se scopre che non sono stati versati contributi sulle utilità a lui spettanti, influendo su TFR o pensione). Ecco perché è essenziale attivare al più presto una difesa efficace, valutando tutte le strategie disponibili.
Come difendersi: strategie e strumenti di tutela
Di fronte a un avviso di accertamento che recupera a tassazione fringe benefit non dichiarati, il datore di lavoro (o il contribuente interessato) ha a disposizione vari strumenti di difesa, sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa. Occorre agire tempestivamente, poiché dal momento della notifica dell’atto decorrono termini stringenti per opporsi (in genere 60 giorni per il ricorso). In questa sezione esamineremo le possibili strategie difensive, distinguendo le fasi:
- difesa in fase di accertamento (prima che l’atto diventi definitivo, includendo il contraddittorio con l’ufficio, l’adesione, ecc.),
- difesa in sede giudiziale (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria),
- accenni alla tutela preventiva e accorgimenti per evitare contestazioni future.
Verifica e contraddittorio: preparare la difesa già in accertamento
Appena si riceve una contestazione (che può essere un Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, una comunicazione di irregolarità, o direttamente un avviso di accertamento), è buona norma analizzare in dettaglio le motivazioni dell’Ufficio e i calcoli effettuati. In particolare, verificate:
- Quali benefit e anni d’imposta sono contestati e in che misura.
- Come l’Agenzia ha calcolato il valore imponibile dei fringe benefit: ad esempio, ha applicato correttamente i criteri forfetari (auto, alloggio, etc.)? Ha sottratto eventuali contributi pagati dal dipendente? Ha rispettato la soglia di esenzione vigente in quell’anno? Ogni errore di calcolo o di normativa da parte dell’Ufficio può essere un punto a favore del contribuente .
- Se vi sono vizi formali nell’atto: mancanza di sottoscrizione, difetto di motivazione (ossia spiegazioni insufficienti sul perché dell’accertamento), notifica oltre i termini decadenziali, omessa indicazione del funzionario istruttore, ecc. I vizi formali o procedimentali possono portare all’annullamento dell’atto, anche indipendentemente dal merito .
- Esistenza di cause di non imponibilità che l’Ufficio non ha considerato: ad esempio, i beni erano inferiori alla soglia (sommati correttamente) o rientravano in un’esenzione particolare di legge. Se potete dimostrare che i benefit contestati in realtà erano entro i limiti di esenzione o esclusi per legge, la pretesa fiscale va ridimensionata o annullata .
In questa fase, è utile raccogliere tutta la documentazione disponibile: copie di policy aziendali sull’uso dei beni, contratti di assegnazione (es. contratto di car policy firmato dal dipendente), comunicazioni interne, estratti contabili, eventuali rimborsi spese dettagliati, ecc. Ogni prova che contestualizza l’utilizzo dei beni può servire. Ad esempio, un registro di utilizzo dell’auto (con indicazione dei km per lavoro vs personali) può supportare una quantificazione inferiore del benefit. Se l’alloggio era concesso perché il dipendente era distaccato lontano da casa, eventuali lettere di trasferta o accordi che menzionano l’obbligo di dimora possono essere evidenziati.
Molto importante: l’onere della prova in materia tributaria è distribuito come segue – semplificando: l’Agenzia deve provare i fatti su cui basa la contestazione (ad es. l’esistenza di un bene usato dal dipendente), mentre il contribuente deve provare gli elementi che giustificano esenzioni o deduzioni (ad es. che quell’uso era interamente aziendale, quindi non tassabile) . La Cassazione ha ribadito costantemente che spetta al contribuente documentare l’inerenza aziendale di un costo e la natura non retributiva di un beneficio, dovendo dimostrare il “raccordo causale” con l’attività d’impresa . Ciò significa che per difendersi efficacemente è spesso necessario produrre prove concrete a proprio favore, anziché limitarsi a contestare astrattamente le tesi del Fisco.
Se il procedimento è ancora nella fase del PVC (verbale della GdF) o di una lettera di compliance prima dell’emissione dell’avviso, si consiglia di sfruttare lo strumento delle osservazioni e memorie difensive: ai sensi dell’art. 12, c.7 dello Statuto del Contribuente (L.212/2000), dopo un PVC conclusivo il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni scritte. Questo è il momento per esporre già le proprie ragioni all’Ufficio, magari facendo leva su eventuali errori fattuali dei verificatori. Ad esempio, se l’Agenzia ha considerato anche benefit sotto soglia, lo si evidenzia chiedendo l’archiviazione per quella parte. Oppure si può far notare che un benefit era già tassato (doppia imposizione) o che un determinato importo era un rimborso spese documentato e non un fringe benefit. Tali memorie non garantiscono la chiusura positiva, ma potrebbero convincere l’Ufficio a sgravare in autotutela parzialmente o a modulare meglio l’atto.
Accertamento con adesione e definizione agevolata
Una volta notificato l’avviso di accertamento, prima di avviare il contenzioso è opportuno valutare l’opzione dell’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Questo strumento consente al contribuente di richiedere un confronto con l’Agenzia (presentando istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’atto) al fine di trovare un accordo sull’entità delle somme dovute. I vantaggi dell’adesione sono: la sospensione dei termini per il ricorso (l’istanza “congela” i 60 giorni per l’impugnazione finché non si esaurisce il procedimento di adesione) e, soprattutto, la riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quelle minime previste .
Nel caso dei fringe benefit, l’adesione può essere utile per discutere con l’Ufficio su valutazioni ed importi: ad esempio, si può sostenere una stima inferiore del valore normale di un benefit (portando quotazioni di mercato a supporto) e convincere l’ufficio a ridurre il recupero. Oppure si può far presente la volontà di rinunciare a contestare nel merito, chiedendo però il massimo sconto di sanzioni. In sede di adesione, infatti, c’è margine per evidenziare circostanze attenuanti (buona fede del contribuente, obiettiva incertezza normativa, ecc.) e ottenere un trattamento più favorevole.
Esempio pratico: supponiamo che l’Agenzia abbia contestato €20.000 di fringe benefit non tassati con sanzione del 90% (€18.000). In adesione il contribuente dimostra che alcuni benefit erano sotto soglia e riduce l’imponibile a €15.000; l’Ufficio accetta e, applicando l’adesione, riduce le sanzioni a 1/3 del minimo (ipotizziamo sanzione ridotta a ~30% dell’imposta invece che 90%). Il risultato è un atto finale concordato per, ad esempio, €15.000 di imposte + €4.500 di sanzioni (invece dei €18.000 iniziali) + interessi. Il contribuente a quel punto paga (di solito in forma rateale, fino a 8 rate trimestrali possibili) e la questione si chiude definitivamente senza contenzioso.
Se l’adesione fallisce (cioè non si raggiunge un accordo) o se non la si attiva, permane la via del ricorso tributario. Tuttavia, prima di andare in giudizio è bene verificare se è prevista qualche forma di definizione agevolata extra-ordinaria: ad esempio, nel 2023 il legislatore ha introdotto la possibilità di definire alcuni avvisi di accertamento con sanzioni ridotte al 3% (c.d. “ravvedimento speciale” per atti non impugnati) o la definizione agevolata delle liti pendenti. Queste sono misure straordinarie. Allo stato (settembre 2025), non risulta una definizione automatica specifica per fringe benefit, ma conviene sempre aggiornarsi sulle ultime disposizioni fiscali. In mancanza, resta percorribile la acquiescenza: se non si intende far ricorso, pagando entro 60 giorni si ha diritto alla riduzione delle sanzioni a 1/3 (simile all’adesione ma senza negoziazione sull’imponibile). L’acquiescenza conviene se si riconosce la fondatezza dell’accertamento e si vuole solo lo sconto sanzionatorio.
Ricorso in Commissione Tributaria (Corte di Giustizia Tributaria)
Se non si trova un accordo in via amministrativa, il passo successivo è proporre ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (il nuovo nome delle ex Commissioni Tributarie Provinciali). Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto (salvo sospensioni per adesione come detto). Il ricorso va notificato all’ufficio emittente e poi depositato presso la segreteria della Corte competente, pagando il contributo unificato (commisurato al valore della lite).
Nel ricorso occorre articolare in maniera chiara i motivi di impugnazione. Questi possono essere di legittimità (vizi formali, procedurali) e di merito (contestazione del merito della pretesa fiscale). Alcune possibili linee difensive nel merito di contestazioni su fringe benefit:
- Dimostrare che non si trattava di fringe benefit imponibili: se si riesce a provare che l’utilizzo del bene o la somma erogata non costituiva un vantaggio personale per il dipendente ma era strumentale all’attività lavorativa, si può sostenere che non andasse tassata. Ad esempio, presentando un dettagliato diario di servizio dell’auto che mostri utilizzi esclusivamente lavorativi (o la presenza di un preciso divieto contrattuale all’uso personale, con controlli effettuati), si può argomentare che l’auto non ha prodotto reddito per il dipendente. In diritto, ciò rientra nel negare la “percezione di un valore in relazione al lavoro” (assenza del presupposto dell’art.51 TUIR). Questa linea difensiva richiede prove solide e spesso testimonianze. I giudici valutano se il benefit fosse realmente un mero strumento di lavoro o un vantaggio aggiuntivo. La Cassazione, come visto, distingue tra beni strettamente necessari per il lavoro (non retributivi) e beni che apportano un arricchimento al dipendente (retributivi) . Sarà compito del ricorrente fornire elementi a sostegno della prima ipotesi.
- Contestare la quantificazione del benefit: in molti casi, l’accertamento può aver sovrastimato il valore imponibile. Si può eccepire che l’Ufficio ha applicato criteri errati: ad esempio, per un’auto assegnata nel 2019 ha usato la regola nuova (quando andava usato il 30% fisso), oppure ha incluso nel calcolo elementi non dovuti (magari non ha tolto le somme addebitate al dipendente). Oppure, nel caso di alloggio, può aver preso un valore di mercato invece che la rendita catastale (errore frequente dei verificatori non esperti). Tali errori aritmetici o metodologici vanno evidenziati e provati. Spesso allegare perizia o calcoli alternativi può essere convincente. Errori di diritto (applicazione di norma sbagliata) sono ancora più forti: il giudice annullerà la parte di atto illegittima. Ad esempio, se l’Agenzia avesse tassato solo l’eccedenza oltre €258,23 anziché l’intero importo, in giudizio si chiederebbe paradossalmente l’aggravamento (tassazione integrale) per coerenza normativa – scenario teorico perché di solito errano per difetto a danno contribuente.
- Far valere soglie di esenzione o norme speciali ignorate: il ricorrente dovrebbe sottolineare se in quell’anno c’era una norma di favore non applicata. Ad esempio: “Nel 2021 la soglia era 516,46€, i benefit contestati erano €500: dunque erano esenti, l’accertamento è infondato”. Oppure: “Nel 2022 le bollette erano esenti fino 600€, il Fisco le ha tassate erroneamente”. Citare la norma e magari la circolare esplicativa (es. Circ. 35/E 2022) aiuterà il giudice a comprendere il contesto .
- Inerenza dei costi e deduzioni correlate: se l’Ufficio ha anche negato deduzioni di costi all’azienda (doppiamente penalizzante), in ricorso si può sostenere l’inerenza di quei costi all’attività d’impresa. Ad esempio, l’auto aziendale, pur concesso l’uso promiscuo, era principalmente funzionale a rappresentanza e spostamenti di lavoro, quindi i costi sono deducibili almeno in parte. La giurisprudenza fiscale sul punto prevede che l’onere di provare l’inerenza è del contribuente, ma se esso dimostra che il bene era strumentalmente necessario all’attività (riunioni, cantieri, ecc.), i costi non vanno integralmente disconosciuti. In particolare, la Corte di Cassazione (ord. n.14222/2025) ha ribadito che il contribuente deve provare la correlazione dei costi all’impresa, documentandone l’effettiva destinazione produttiva . Nel ricorso si porteranno quindi elementi (anche testimoni, se ammessi) per provare che quei costi non erano meri sfizi personali mascherati, ma avevano una giustificazione economica nell’impresa.
- Vizi formali e procedurali: mai dimenticare di eccepire eventuali violazioni dello Statuto del Contribuente o altre irregolarità. Ad esempio, se l’accertamento è scaturito da un PVC, verificare che siano decorsi almeno 60 giorni tra il rilascio del PVC e l’emissione dell’avviso (termine per il diritto al contraddittorio, art.12 c.7 L.212/2000): la Cassazione su questo punto è altalenante, ma diversi giudici annullano l’atto emesso ante tempus. Altro esempio: se l’azienda aveva chiesto proroga per fornire documenti ed è stata negata violando i principi di collaborazione e buona fede (artt.5 e 6 L.212/2000), oppure se l’atto non contiene l’indicazione del funzionario responsabile (art.7 L.212/2000). Tali vizi, seppur formali, possono portare all’annullamento totale dell’avviso (o quantomeno costituire argomenti equitativi per le spese di giudizio).
Durante il contenzioso, è spesso utile chiedere Consulenza Tecnica quando la valutazione del benefit è complessa (es. valore di mercato di un immobile concesso: un CTU potrebbe stimare la rendita implicita). Inoltre, il ricorrente può valutare la sospensione dell’atto in pendenza di giudizio: se l’importo è elevato e crea pericolo per la continuità aziendale, si può presentare istanza di sospensione al Presidente della Corte tributaria entro 60 giorni, dimostrando il danno grave e irreparabile che subirebbe pagando subito. In caso di accoglimento, la riscossione viene sospesa fino alla sentenza di primo grado. In difetto, comunque, oggi la legge prevede che presentando ricorso la riscossione sia frazionata: l’Erario può esigere intanto solo un terzo delle imposte accertate dopo la sentenza di primo grado (se sfavorevole al contribuente), e il resto solo a fine processo (Dlgs 546/92 modificato dal DL 50/2017).
Se in primo grado si ottiene l’annullamento (parziale o totale) dell’accertamento, bene. Se invece l’esito è sfavorevole, resta la possibilità di appello (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado) alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) e poi, eventualmente, il ricorso per Cassazione (per soli motivi di diritto) dopo la sentenza di appello. Tali fasi sono oltre lo scopo immediato di questa guida; basti sapere che la difesa può proseguire nelle sedi superiori, con l’assistenza di difensori abilitati (in Cassazione serve l’iscrizione speciale). Conciliazioni giudiziali: in ogni grado di giudizio, è possibile chiedere una conciliazione con l’Ufficio (mediazione) che comporta sanzioni ridotte al 40% in primo grado (se la lite è sotto €50.000 c’è anzi l’obbligo di presentare inizialmente un reclamo-mediazione) o al 50% in appello. Dunque, se durante il processo emergono margini per accordarsi, si può chiudere la lite con un verbale di conciliazione e pagamento concordato.
Focus: casi particolari di benefit a amministratori, collaboratori e soci
Finora abbiamo parlato di fringe benefit ai lavoratori dipendenti. Ma spesso il tema concerne anche figure affini, come amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, o addirittura soci/familiare dell’imprenditore che utilizzano beni dell’azienda. È importante distinguere le casistiche perché la difesa cambia:
- Amministratori e collaboratori parasubordinati: i compensi degli amministratori di società (o dei co.co.co.) sono per il Fisco redditi assimilati al lavoro dipendente. Ciò significa che l’art. 51 TUIR si applica anche a loro. Dunque, se una SRL assegna un’auto aziendale al suo amministratore delegato per usi personali, essa va trattata fiscalmente come fringe benefit esattamente come per un dipendente . Analogamente per un collaboratore coordinato (es. un consulente con co.co.co.): i benefit concorrono al reddito assimilato. Difendersi: la difesa in caso di contestazione segue le medesime linee illustrate per i dipendenti. Si potrà sostenere che l’auto dell’amministratore era strumentale all’esercizio del suo incarico (riunioni, trasferte per conto della società) e che l’uso personale è stato inesistente o marginale. L’onere della prova è sempre in capo al contribuente, ma c’è da aggiungere un aspetto: spesso l’amministratore è anche socio. Se un benefit viene fruito da un amministratore-socio, il Fisco talvolta tenta di riqualificarlo come “utile distribuito” più che come compenso. Bisogna quindi chiarire il titolo in base al quale il bene era usato: se rientrava nel compenso amministratore (deliberato dall’assemblea) allora è reddito assimilato da tassare in capo all’amministratore stesso; se invece non vi è delibera e il socio usa comunque il bene, l’Agenzia può applicare la disciplina speciale dei beni ai soci (vedi punto successivo). In sede difensiva, conviene dimostrare l’esistenza di un compenso in natura deliberato (ad esempio un accordo del CDA che prevede l’uso dell’auto come parte del compenso): ciò inquadra correttamente il fatto come fringe benefit da lavoro, evitando la più severa presunzione sui soci.
- Beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore: questa è una situazione distinta, disciplinata espressamente dall’art. 67, co.1, lett. h-ter) del TUIR. Dal 2012, infatti, se un socio o un familiare utilizza un bene intestato alla società per fini privati, scatta in capo ad esso un reddito diverso imponibile pari alla differenza tra il valore normale di mercato del bene (per la quota di utilizzo) e l’eventuale corrispettivo pagato per averlo . Specularmente, la società non può dedurre i costi relativi a tali beni nella propria dichiarazione dei redditi, per la parte non adeguatamente remunerata, in quanto considerati non inerenti . Questa normativa mira a colpire l’uso personale di beni societari da parte dei soci che tentano di mascherare utilità personali dietro la persona giuridica. Un tipico esempio: la società intestataria di uno yacht o di una villa usata dal socio senza pagare affitto. In tal caso il socio deve dichiarare un reddito pari al canone di mercato non pagato, e la società non deduce i costi dello yacht/villa. Ai fini difensivi, se il Fisco contesta un “bene in godimento” al socio, le strade sono limitate:
- provare che il socio ha corrisposto un corrispettivo congruo per l’uso (se paga un prezzo di mercato, non c’è differenza tassabile),
- oppure provare che il bene in realtà era usato per scopi societari e non dal socio in quanto tale (ad es. l’auto aziendale la guidava il socio solo per attività d’impresa). Quest’ultimo punto è difficile se parliamo di un bene voluttuario (barca, casa di vacanza). Ma se il bene contestato era, poniamo, un computer o un telefono usato dal figlio dell’imprenditore che lavorava in azienda, si potrebbe sostenere che rientrava nell’attività lavorativa del familiare (che magari era anche dipendente).
- Un aspetto tecnico: la norma sui beni ai soci non si applica alle società semplici (Cass. n. 39696/2021 ha escluso le società non commerciali dal campo di applicazione) , ma per SRL, SNC, SAS etc. si applica pienamente. Dunque, se la verifica riguarda una società commerciale, difendersi sul presupposto soggettivo è inutile (a meno che, appunto, fosse società semplice).
- In giudizio, su questo tema ci si può focalizzare su eventuali errori dell’Agenzia nel calcolo del “valore di mercato” dell’uso del bene (che va determinato in base a prezzi di noleggio, canoni di locazione comparabili, ecc.). Se l’Ufficio ha preso un valore sproporzionato, si può far valere con perizie di parte. Inoltre, se per caso il socio utilizzatore era anche un dipendente, c’è da chiarire se tassare come reddito diverso o come reddito di lavoro (non cumulandoli). La Cassazione ha sostenuto che il regime dei beni ai soci può coesistere con quello di fringe benefit solo se il socio utilizzatore non è un dipendente; se invece è dipendente, tendenzialmente prevale la tassazione come reddito di lavoro (per evitare duplicazioni). In altre parole: o fringe benefit o reddito diverso, ma non entrambi. Su questo ci si può focalizzare per evitare doppia tassazione.
In conclusione, la difesa cambia leggermente prospettiva: per amministratori e co.co.co. si ragiona come per dipendenti (reddito assimilato, fringe benefit da contestare come non imponibili se strumentali); per soci/familiari non dipendenti si punta a negare che l’uso fosse “a titolo personale” oppure a ridurne la quantificazione. Dal punto di vista del debitore (contribuente), in ogni caso, è fondamentale evidenziare se l’Agenzia ha applicato correttamente le norme specifiche (art. 51 TUIR vs art. 67 TUIR) e se c’è stata eventualmente doppia imposizione (ad esempio, stessa auto contestata come benefit al dipendente e come utilità al socio – è raro ma va vigilato).
Simulazioni pratiche di difesa
Per rendere più concreti questi concetti, proponiamo alcune brevi simulazioni di situazioni tipiche e possibili difese:
Caso 1: Auto aziendale di lusso non dichiarata – Una SRL viene accertata perché dal bilancio emergono costi elevati per una auto di lusso (es. Porsche) in leasing, ufficialmente assegnata all’amministratore, il quale però non ha dichiarato fringe benefit. L’Agenzia presume un uso personale integrale e contesta €15.000 di benefit annui non tassati per tre anni, più indeducibilità di parte dei costi auto.
Difesa: in fase di adesione si riconosce un uso promiscuo ma si porta evidenza (agenda appuntamenti, email) che l’auto veniva usata anche per viaggi d’affari (fiere, incontri clienti) coprendo almeno 10.000 km/anno di percorrenze lavorative. Si propone di ridurre il benefit imponibile considerando solo una quota di uso personale (ad esempio il 50% dei km totali) – quindi ~€7.500 annui invece di 15.000. L’Ufficio può accettare una riduzione equitativa se convinto dalle prove. Si chiede inoltre di applicare la legge “beni ai soci” solo sulla parte di costi non giustificata da esigenze d’impresa, evitando duplicazioni. In mancanza di accordo, in giudizio si insiste su: applicazione eventualmente errata delle percentuali (era un’auto immatricolata nel 2020 quindi al 30% e non 50% come forse usato dall’Ufficio), presentando calcoli corretti; testimonianze di dipendenti attestanti che l’auto era spesso utilizzata per clienti (inerenza); e vizio di motivazione dell’avviso se non ha spiegato perché considera il 100% di uso privato. Un esito realistico potrebbe essere che la Commissione riconosca imponibile solo il 50% del benefit e annulli le sanzioni in eccedenza per incertezza (riduzione pena).
Caso 2: Buoni acquisto e omaggi natalizi – Un’azienda ha dato a ciascun dipendente nel 2024 una gift card da €500 come premio natalizio, senza tassarla, ritenendo si trattasse di welfare aziendale. In realtà, è un fringe benefit oltre la soglia di €258,23 (nel 2024 il limite generale era €1.000, ma attenzione: €500 a testa comunque incide). L’Agenzia contesta l’omessa ritenuta su €500 per ogni dipendente (diciamo 10 dipendenti, totale €5.000 imponibile) più sanzioni.
Difesa: qui la norma era favorevole perché nel 2024 la soglia è €1.000 e comprende anche beni erogati individualmente. Quindi nessuna violazione in realtà: €500 < €1.000, il datore era legittimato a non tassare. Bisogna evidenziarlo con la L.197/2023 alla mano . Probabilmente l’accertamento è frutto di errore (magari l’ufficio non aggiornato). Già in autotutela si chiederà l’annullamento allegando la norma. Qualora l’ufficio insista confondendo il 2023 col 2024, in ricorso la vittoria è quasi certa citando la legge e magari la circolare AE esplicativa che afferma l’esenzione entro €1.000 anche per beni non in piani welfare. Questo caso sottolinea l’importanza di conoscere gli aggiornamenti normativi: spesso il contribuente può far valere disposizioni sopravvenute a lui favorevoli.
Caso 3: Alloggio al dipendente in trasferta – Un dipendente è stato trasferito per 6 mesi da Milano a Roma nel 2022 per un progetto, e l’azienda gli ha pagato l’appartamento a Roma (affitto €1.200/mese). Non è stato tassato nulla come fringe benefit, ritenendo l’alloggio come rimborso spese di trasferta. L’Agenzia però contesta che la trasferta era lunga e doveva configurarsi benefit, tassando €7.200.
Difesa: si punterà a dimostrare che si trattava di trasferta temporanea (meno di 12 mesi magari) e che l’alloggio rientrava nel rimborso spese di trasferta esente (entro i limiti di deduzione art. 51 TUIR per trasferte). Se c’era un ordine di trasferta formale, lo si esibirà. Inoltre, l’art. 51 comma 5 TUIR esenta le indennità di trasferta fuori Comune entro certi massimali. Se l’azienda può ricondurre l’ospitalità in tali massimali (es. €46,48 die), potrebbe sostenere che l’alloggio ne era parte. Alternativamente, si potrebbe cercare un compromesso: tassare non l’intero affitto ma la rendita catastale (forse inferiore) applicando la regola generica del benefit casa, visto che l’azienda aveva comunque interesse a farlo risiedere lì. In giudizio, si argomenterà che l’alloggio fu fornito “per esigenze di lavoro temporanee, senza volontà remunerativa”, citando magari qualche sentenza di merito che equipara queste ipotesi alle trasferte e non ai fringe. Il giudice potrebbe ridurre la sanzione per incertezza normativa (caso borderline) o addirittura escludere tassazione se convinto che fu trasferta a tutti gli effetti.
Caso 4: Benefit “occulto” scoperto da movimenti bancari – La Guardia di Finanza, controllando i conti aziendali, scopre bonifici periodici della SRL per €2.000/mese verso il conto personale dell’amministratore senza causale chiara. La società li aveva registrati come “anticipi spese”. L’Agenzia li riqualifica come compensi in nero all’amministratore, quindi fringe benefit (o meglio redditi assimilati) non dichiarati, per €24.000 annui su 2 anni = €48.000.
Difesa: qui la materia sfuma nel campo dei compensi non dichiarati più che dei fringe benefit classici. Tuttavia, la logica difensiva potrebbe essere sostenere che erano anticipi per spese sostenute dall’amministratore per conto della società (trasferte, rappresentanza) e che egli poi ha rendicontato a parte (bisogna trovare pezze d’appoggio!). Se non ci sono giustificativi, la difesa è ardua: probabilmente conviene negoziare in adesione uno “sconto” (magari riconoscere solo €1.000/mese come extra stipendio, se l’amministratore aveva comunque un compenso base). In giudizio, se non si hanno prove documentali, ci si può concentrare su eventuali errori di metodo dell’ufficio (ad es. ha duplicato mensilità, o non ha considerato che su quei bonifici furono già trattenute delle ritenute di acconto – ipotesi). Si può anche contestare la qualificazione come reddito di lavoro dipendente: se l’amministratore non aveva delibere di compenso aggiuntivo, l’ufficio può aver erroneamente scelto la tassazione come lavoro autonomo (o viceversa). Una linea residuale è appellarsi all’art. 6, co.2 D.Lgs. 472/97 per chiedere la non applicazione di doppi regimi sanzionatori sul medesimo fatto (ma è tecnico). Questo caso dimostra che se un pagamento al dipendente o amministratore non è chiaro, il Fisco lo considererà reddito imponibile: la difesa deve giocoforza costruire una spiegazione alternativa credibile e provata per quei flussi finanziari.
Ogni situazione concreta può presentare peculiarità, ma il filo conduttore è: documentare il più possibile, conoscere le norme specifiche applicabili a quell’anno e a quella figura, e valutare pragmaticamente se conviene transare o andare fino in fondo. Spesso la decisione dipende dall’entità delle somme e dalla solidità delle prove: per importi modesti, una definizione può essere preferibile (limitando i rischi e i costi di una causa); per importi elevati, se si hanno buone ragioni, vale la pena combattere in giudizio.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito, alcune domande comuni sul tema dei fringe benefit non dichiarati, con risposte sintetiche che riassumono quanto esposto:
D: Cosa si intende esattamente per “fringe benefit”?
R: È qualsiasi forma di compenso non in denaro corrisposta al dipendente (o assimilato) in relazione al rapporto di lavoro. Può trattarsi di beni (auto, telefono, alloggio, ecc.), servizi (abbonamenti, viaggi premio) o somme pagate per spese personali (utenze domestiche, mutuo, ecc.). La caratteristica è che costituisce un vantaggio economico per il lavoratore, aggiuntivo rispetto allo stipendio monetario. La normativa fiscale (art. 51 TUIR) li considera parte del reddito di lavoro dipendente e li tassa di conseguenza, salvo specifiche esclusioni o entro una certa soglia annua di valore .
D: Quali fringe benefit sono esenti da tassazione?
R: In generale, tutti i benefit sono imponibili, tranne: quelli di valore complessivo annuo entro la soglia (vedi tabella: €258,23 ordinariamente, soglie elevate transitoriamente fino a 3.000 in alcuni casi) ; i beni/servizi rientranti nelle esclusioni dell’art.51 co.2 TUIR (es. contributi pensionistici obbligatori, servizi di mensa, abbonamenti trasporto pubblico, forme di welfare aziendale alla generalità dei dipendenti come asili nido, assicurazioni sanitarie collettive, ecc.) . Ad esempio, nel 2025 un dipendente senza figli può ricevere fino a €1.000 di beni/servizi (inclusi eventuali rimborsi bollette, affitto prima casa) senza imposizione ; se ha figli a carico, la soglia esente sale a €2.000. Sopra tali limiti, l’intero importo diventa tassabile. Altre esenzioni: buoni pasto fino €8 al giorno (elettronici) , regalo di azioni entro €2.065 annui se a tutti i dipendenti , ecc.
D: I fringe benefit sono soggetti anche a contributi previdenziali?
R: Sì, di regola sì. Ciò che costituisce reddito da lavoro ai fini fiscali, rientra anche nella retribuzione imponibile INPS (principio di armonizzazione basi imponibili, L.153/1969) . Quindi l’azienda deve versare i contributi su auto ad uso promiscuo, alloggi, ecc., salvo i benefit esclusi ex lege anche contributivamente (per esempio, i servizi di mensa e i rimborsi spese documentati per trasferte sono esclusi anche da contributi). Attenzione però a eccezioni temporanee: nel 2023 si era creata una difformità (3.000 euro esenti IRPEF per lavoratori con figli, ma la norma non citava la contribuzione, quindi INPS inizialmente riteneva comunque dovuti i contributi oltre €258) . Dal 2024 la doppia soglia 1000/2000 è esplicitamente esente sia fiscalmente che contributivamente . In sintesi, salvo indicazione contraria, un fringe benefit non tassato non sconta neanche contributi (e viceversa, se tassabile sconta anche INPS).
D: Un amministratore di società che usa un bene aziendale deve pagare tasse su questo uso?
R: Sì. Se l’amministratore è remunerato con compenso (anche in natura), tale utilizzo configura reddito assimilato al lavoro dipendente. Ad esempio, l’uso personale di un’auto aziendale da parte di un amministratore è tassato secondo le stesse regole (percentuale ACI) di un dipendente . Qualora l’amministratore non riceva un regolare compenso deliberato ma sia anche socio e usi ugualmente il bene, il Fisco può inquadrare la cosa come beneficio ai soci ex art.67 TUIR, tassando in capo all’amministratore-socio un reddito diverso pari al valore d’uso. In pratica: se l’assemblea ha deliberato che l’amministratore ha diritto all’auto quale fringe benefit, va tassato come reddito di lavoro assimilato; se nessun compenso era formalizzato, l’uso privato può essere comunque tassato come reddito diverso da partecipazione. In entrambi i casi, la società inoltre rischia la indeducibilità di quei costi per mancanza di inerenza .
D: Come incide il fringe benefit sulla busta paga e sul TFR?
R: In busta paga il fringe benefit può comparire come voce aggiuntiva (valore convenzionale) su cui vengono calcolate imposte e contributi. Per il TFR (trattamento di fine rapporto), il Codice Civile (art. 2120 c.c.) stabilisce che va calcolato su “tutto quanto il lavoratore ha diritto di percepire in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale” – ciò include i compensi in natura valutati al loro valore normale . La Corte di Cassazione ha confermato che i fringe benefit abituali concorrono al TFR (es: l’auto aziendale assegnata stabilmente aumenta la retribuzione annua utile) . Dunque, se un benefit è ricorrente e non occasionale, bisogna considerarlo anche nel calcolo di TFR, tredicesima, contributi, indennità di preavviso, ecc. (a prescindere dal trattamento fiscale: anche benefit esenti possono far parte della retribuzione contrattuale). In caso di cessazione del rapporto, se il datore ha fornito benefit e poi li revoca (es. auto aziendale tolta durante il preavviso), ciò può incidere su eventuali indennizzi: la giurisprudenza ha ritenuto che il lavoratore può avere diritto a un compenso sostitutivo se un benefit di natura retributiva gli viene revocato anticipatamente senza accordo .
D: Ho ricevuto un avviso di accertamento per fringe benefit non dichiarati. Devo pagare subito?
R: Non necessariamente subito, e soprattutto non tutto indiscriminatamente se intendi contestarlo. Una volta ricevuto l’atto, hai 60 giorni per decidere: puoi presentare ricorso (la presentazione del ricorso evita che l’atto diventi definitivo) oppure aderire all’accertamento con adesione, oppure pagare con sanzioni ridotte (acquiescenza). Se non fai nulla entro 60 giorni, l’accertamento diviene definitivo e l’Agenzia può iniziare la riscossione coattiva. Se fai ricorso, di regola l’importo non è dovuto fino alla sentenza di primo grado (salvo chiedano 1/3 provvisoriamente in caso di esito sfavorevole in primo grado). Puoi anche chiedere al giudice la sospensione se il pagamento immediato ti arreca un danno grave. In sintesi: non pagare senza valutare le opzioni. Spesso si può trovare un accordo con sanzioni ridotte (adesione) o ottenere la sospensione in attesa del giudizio. Se però riconosci la legittimità della pretesa e non vuoi litigare, pagando entro 60 gg hai diritto allo sconto delle sanzioni a 1/3 (il che può essere conveniente in alcuni casi).
D: L’azienda può rivalersi sul dipendente per le tasse sui fringe benefit non dichiarati?
R: Domanda delicata. In linea teorica, le imposte recuperate dall’Agenzia riguardano IRPEF che sarebbe stata a carico del dipendente (anche se è il datore a doverla versare come sostituto). Se l’azienda paga a posteriori tali imposte, potrebbe cercare di trattenerle dal dipendente, specie se esiste un patto o regolamento interno che lo prevede. Tuttavia, spesso le somme vengono richieste a distanza di anni, quando il dipendente magari neanche lavora più in azienda. Inoltre, il DPR 917/86 vieta di addebitare al dipendente le imposte su redditi di lavoro in misura superiore al suo netto percepito. In pratica, la rivalsa delle imposte non versate è possibile solo nei limiti in cui il lavoratore avrebbe dovuto pagarle se tassato regolarmente. Alcune aziende scelgono di non rivalersi per evitare controversie col personale (trattandosi in fondo di un loro errore). Sul piano legale, il datore di lavoro ha titolo per chiedere al dipendente le imposte da questi dovute sul reddito percepito (principio di trasferimento dell’onere d’imposta), ma in concreto è difficile. In caso di fringe benefit non dichiarati, spesso si tratta di importi che, se fossero stati tassati a tempo debito, il dipendente avrebbe pagato in più. Quindi eticamente la rivalsa ha una logica. Giuridicamente, alcuni contratti di lavoro o accordi prevedono espressamente che il valore dei benefit si intende al netto imposte, ergo il datore si fa carico anche delle imposte eventuali. Dunque, la risposta dipende dal caso: l’azienda può tentare la rivalsa (specie se il dipendente era consapevole dell’occultamento), ma non è detto che sia agevole. In ogni caso, questo è un problema interno tra datore e dipendente – irrilevante per il Fisco, che otterrà comunque il pagamento dal datore in quanto sostituto.
D: Come prevenire contestazioni sui fringe benefit in futuro?
R: La prevenzione si fa con una corretta gestione fiscale dei benefit. Alcuni consigli pratici: – Monitorare annualmente il valore dei benefit concessi a ciascun dipendente, per evitare di superare le soglie esenti (o se si supera, assicurarsi di tassare tutto correttamente in busta paga). – Formalizzare per iscritto la natura e le condizioni d’uso di beni aziendali: ad es. predisporre un regolamento per le auto aziendali che ne limiti l’uso personale (e far firmare al dipendente l’impegno), oppure specificare nei contratti di assegnazione che l’alloggio è concesso per esigenze di servizio. – Documentare l’utilizzo: tenere registri chilometrici, far compilare note spese dettagliate per rimborsi, conservare ricevute e fatture intestate all’azienda per spese che si rimborsano al dipendente. Così, in caso di controllo, si può dimostrare che quelle erano spese di lavoro e non liberalità. – Utilizzare i flexible benefit/welfare: molte voci (es. rimborso scuola figli, assicurazioni sanitarie) possono essere offerte in piani di welfare che godono di esenzione totale, anziché come fringe benefit tassabili. Questo riduce il rischio di contestazione e ottimizza il carico fiscale. – Coordinare HR e ufficio fiscale: chi gestisce il personale deve comunicare al reparto fiscale/consulente del lavoro tutti i benefit concessi, per permettere il corretto trattamento in busta paga. Mai erogare vantaggi “in sordina” pensando di fare favori al dipendente: se scoperti, costano molto di più. – Aggiornarsi sulle novità normative: come visto, ogni anno il limite di esenzione può cambiare (es. leggi di bilancio), così come le regole sulle auto aziendali o altri benefit. Mantenersi informati tramite circolari dell’Agenzia e fonti affidabili evita di applicare regole superate. Ad esempio, sapere che nel 2025 la soglia è 1.000/2.000 euro e che l’affitto prima casa è incluso nell’esenzione consente di strutturare piani di benefit conformi (mentre ignorare queste novità può portare a errori). – Conservare corrispondenza e delibere: se un CDA delibera un fringe benefit a un amministratore, conservarne copia; se si comunica al sindacato o alla RSU l’introduzione di un piano benefit (come richiesto dalle norme recenti, es. DL 48/2023 imponeva informativa preventiva alle RSU) , assicurarsi di avere prova di averlo fatto.
Seguendo queste prassi, si riduce drasticamente la probabilità di incorrere in contestazioni. In caso di dubbio interpretativo, meglio chiedere prima un parere qualificato (anche tramite interpello all’Agenzia delle Entrate) che affrontare un accertamento dopo. In ogni caso, qualora un controllo arrivi, aver tenuto un comportamento trasparente e documentato fornirà solide basi per difendersi o persino per ottenere l’archiviazione immediata della verifica.
Conclusioni
La materia dei fringe benefit non dichiarati richiede un equilibrio tra conoscenza tecnica delle norme e valutazione concreta delle situazioni aziendali. Dal punto di vista del contribuente, difendersi efficacemente significa:
- Conoscere i propri diritti (soglie di esenzione, esclusioni normative, termini procedurali) e farli valere tempestivamente.
- Verificare puntualmente l’operato del Fisco, individuando eventuali errori di calcolo o violazioni procedurali su cui costruire la difesa.
- Produrre prove convincenti riguardo alla natura dei benefit contestati, dimostrando ove possibile che non erano reali vantaggi retributivi oppure che l’imposizione calcolata dall’Ufficio è eccessiva.
- Valutare strumenti deflattivi come l’adesione o la conciliazione per ridurre il danno, specie quando la pretesa è fondata in parte: spesso il compromesso economico è preferibile a una lunga lite dall’esito incerto.
- Agire entro i termini: molti contribuenti perdono tutele semplicemente perché lasciano decorrere i termini del ricorso o dell’adesione. Anche se si sta dialogando con l’ufficio, occhio alle scadenze formali.
- Farsi assistere da professionisti esperti, in particolare in contenziosi di valore elevato: un commercialista o avvocato tributarista potrà individuare profili di illegittimità o strategie processuali che non sono evidenti ai non addetti ai lavori. Il ruolo del difensore è cruciale per analizzare la tipologia di compensi in natura contestati, verificare la corretta applicazione delle norme e costruire un ricorso fondato su prove concrete e vizi dell’accertamento .
In definitiva, il messaggio per imprenditori e contribuenti è duplice: da un lato prevenire implementando correttamente i fringe benefit (così da incentivarne l’uso lecito e al contempo evitare sanzioni); dall’altro, se la contestazione arriva, non rassegnarsi automaticamente a pagare – spesso vi sono margini per ridurre sensibilmente o annullare la pretesa ingiusta. I giudici tributari, quando posti di fronte a documentazione chiara e a motivazioni solide, sono perfettamente in grado di riconoscere un accertamento eccessivo o infondato e di dare ragione al contribuente.
L’evoluzione normativa recente (soprattutto dal 2020 in poi) ha reso la disciplina dei fringe benefit un bersaglio mobile: soglie che cambiano, eccezioni temporanee, nuove categorie di rimborsi esentati. È comprensibile che aziende e professionisti possano commettere in buona fede degli errori. Proprio per questo, in sede difensiva è spesso efficace far leva sull’obiettiva incertezza e sulla novità delle norme per chiedere la non applicazione di sanzioni o una interpretazione pro-contribuente. Il nostro ordinamento prevede che le sanzioni non siano dovute se vi era incertezza normativa oggettiva (art. 6 co.2 D.Lgs.472/97). Dimostrare che una certa regola era di difficile interpretazione (magari portando risoluzioni ministeriali contrastanti) può salvare almeno dalle sanzioni.
Concludendo, “come difendersi” da una contestazione per fringe benefit non dichiarati significa mettere in atto un mix di competenze: fiscali, legali e procedurali. Il debitore d’imposta ben consigliato può ridurre il più possibile l’impatto dell’accertamento: talvolta fino ad azzerarlo, altre volte trovando una transazione equa, in ogni caso evitando di pagare più del dovuto. La chiave è agire con tempestività, rigore documentale e con la giusta strategia legale. Questa guida, aggiornata alle ultime novità 2025, auspica di aver fornito un quadro avanzato e completo per orientarsi in tale difesa.
Ricordate: di fronte a un avviso di accertamento avete sempre almeno due opzioni – pagare o reagire – e quest’ultima spesso merita di essere percorsa, quantomeno per verificare (anche con ausilio professionale) se vi sono elementi per ridurre sensibilmente la pretesa fiscale. In molte situazioni, “il gioco vale la candela”, specialmente quando sono in discussione cifre importanti o principi che potrebbero ripresentarsi negli anni a venire per la vostra attività.
Hai ricevuto un’avviso di accertamento o una contestazione dall’Agenzia delle Entrate o dall’Ispettorato del Lavoro per fringe benefit non dichiarati ai dipendenti o collaboratori della tua azienda? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un’avviso di accertamento o una contestazione dall’Agenzia delle Entrate o dall’Ispettorato del Lavoro per fringe benefit non dichiarati ai dipendenti o collaboratori della tua azienda?
Ti viene contestato di aver fornito beni o servizi ai dipendenti (auto aziendali, buoni pasto, alloggi, viaggi, polizze, rimborsi spese, ecc.) senza averli inclusi nel reddito da lavoro dipendente?
👉 Attenzione: si tratta di una delle aree di controllo più attive da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma hai diritto a difenderti e, in molti casi, puoi dimostrare la legittimità del trattamento fiscale applicato o ottenere la riduzione delle sanzioni.
In questa guida ti spiego cosa sono i fringe benefit, quando diventano imponibili, perché possono essere contestati e quali strategie legali adottare per difendere te e la tua azienda.
⚖️ Cosa sono i fringe benefit
I fringe benefit sono benefici o vantaggi in natura che il datore di lavoro concede al dipendente o al collaboratore, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro.
📌 Esempi comuni di fringe benefit:
- Auto aziendale ad uso promiscuo;
- Alloggio aziendale o abitazione concessa al dipendente;
- Buoni pasto o buoni carburante;
- Polizze assicurative e sanitarie pagate dall’azienda;
- Prestiti agevolati;
- Rimborsi spese non documentati o “a forfait”;
- Dispositivi elettronici (PC, smartphone) ad uso personale.
Alcuni fringe benefit sono esclusi dalla tassazione entro certi limiti, altri invece devono essere dichiarati e tassati come reddito da lavoro dipendente.
📜 Cosa dice la normativa
La disciplina dei fringe benefit è contenuta nell’art. 51 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che distingue tra:
✅ Fringe benefit esenti da tassazione
- Fino a 258,23 € annui per ciascun dipendente (limite ordinario);
- Limite aumentato a 3.000 € per il 2022 e 2023 in caso di figli a carico (come da Decreti Aiuti);
- Esenti anche i rimborsi per spese di utenze domestiche (acqua, luce, gas) nei limiti previsti.
❌ Fringe benefit imponibili
- Auto aziendali, alloggi, polizze, viaggi, dispositivi elettronici, se l’utilizzo non è esclusivamente aziendale;
- Rimborsi o spese “forfettarie” non documentate;
- Vantaggi non previsti dai contratti collettivi o dal welfare aziendale approvato.
👉 Se l’azienda non ha dichiarato correttamente questi valori nel modello CU o 770, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’omessa tassazione dei fringe benefit.
💡 Quando scatta la contestazione
L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono avviare un accertamento se:
- hanno riscontrato spese aziendali non coerenti con l’attività;
- hanno trovato auto, alloggi o beni aziendali usati dai dipendenti o dagli amministratori;
- dai controlli incrociati (CU, 770, bilanci) risultano benefici non dichiarati;
- mancano documenti che provano l’uso esclusivamente lavorativo di beni o servizi aziendali.
📌 In questi casi, l’Agenzia può:
- tassare i fringe benefit come reddito da lavoro dipendente;
- recuperare le ritenute non operate;
- applicare sanzioni amministrative e interessi.
💰 Le conseguenze per l’azienda
In caso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può richiedere:
- il versamento delle imposte non trattenute e non versate;
- sanzioni dal 30% al 100% dell’importo evaso;
- interessi di mora;
- eventuali sanzioni previdenziali da parte dell’INPS o dell’Ispettorato del Lavoro.
👉 Inoltre, se i fringe benefit non dichiarati sono ingenti, può essere ipotizzata anche una responsabilità amministrativa o penale per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000).
🧠 Cosa fare subito
✅ 1. Analizza l’avviso di accertamento ricevuto
Controlla attentamente:
- gli anni fiscali contestati;
- i fringe benefit considerati imponibili;
- le prove o documenti usati dall’Agenzia;
- eventuali errori di calcolo o interpretazione.
👉 Un’analisi legale preliminare è essenziale per capire se l’accertamento è fondato o viziato.
✅ 2. Raccogli la documentazione giustificativa
Per difenderti, è fondamentale dimostrare che i benefici contestati:
- erano strumentali all’attività lavorativa (non uso personale);
- rientravano nei limiti di esenzione previsti dal TUIR;
- erano previsti da contratti o regolamenti aziendali di welfare;
- sono stati correttamente comunicati nelle dichiarazioni fiscali.
📂 Documenti utili:
- Contratti di assegnazione dei beni (auto, alloggi, dispositivi);
- Regolamento aziendale o accordi di welfare;
- Prove di uso aziendale (chilometraggio, schede carburante, tracciati GPS, ecc.);
- Prospetti paghe e CU dei dipendenti;
- Comunicazioni con il consulente del lavoro o il commercialista.
✅ 3. Richiedi un contraddittorio o presenta un’istanza di autotutela
Se l’Agenzia ha commesso errori evidenti o frainteso la documentazione, puoi chiedere un contraddittorio preventivo (entro 60 giorni dalla notifica) o un’istanza di autotutela, allegando le prove della tua buona fede e della correttezza fiscale.
✅ 4. Valuta il ricorso tributario
Se l’Agenzia emette un avviso di accertamento definitivo, puoi impugnarlo entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria).
Un avvocato può chiedere:
- la sospensione immediata del pagamento;
- l’annullamento totale o parziale dell’accertamento;
- il riconoscimento della non imponibilità o dell’uso esclusivamente aziendale dei beni contestati.
✅ 5. Verifica la prescrizione dei termini di accertamento
L’Agenzia può agire entro 5 anni (per controlli ordinari) o 7 anni in caso di dichiarazione infedele.
👉 Se la contestazione è fuori termine, puoi eccepire la decadenza dell’accertamento.
📋 Documenti fondamentali per la difesa
- Copia dell’avviso di accertamento o processo verbale di constatazione.
- Contratti di lavoro e regolamenti aziendali.
- Documenti di assegnazione dei beni o fringe benefit.
- Dichiarazioni fiscali e modelli CU/770.
- Documenti contabili e giustificativi.
⏱️ Tempi e risultati possibili
- Analisi del caso: 1–2 settimane.
- Contraddittorio o istanza di autotutela: 30–60 giorni.
- Ricorso in Corte Tributaria: entro 60 giorni dalla notifica.
- Decisione del giudice: 6–12 mesi medi.
🎯 Risultati concreti:
- Annullamento totale o parziale dell’accertamento.
- Cancellazione o riduzione delle sanzioni.
- Riconoscimento della corretta applicazione fiscale dei fringe benefit.
⚖️ I vantaggi della difesa legale
✅ Puoi dimostrare la buona fede dell’azienda e l’assenza di dolo.
✅ Eviti sanzioni sproporzionate e pignoramenti.
✅ Blocchi la riscossione immediata con la sospensione dell’atto.
✅ Regolarizzi la posizione fiscale e previdenziale senza danni d’immagine.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare l’avviso di accertamento.
- Pagare subito senza verificare la fondatezza della contestazione.
- Non fornire documentazione di supporto.
- Affidarsi a consulenti non avvocati o senza competenze in diritto tributario e del lavoro.
- Superare i 60 giorni per presentare ricorso.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza l’accertamento e le prove raccolte dall’Agenzia.
📌 Verifica la corretta qualificazione dei fringe benefit e i limiti di esenzione.
✍️ Redige memorie difensive, istanze di autotutela o ricorsi tributari.
⚖️ Ti rappresenta nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e davanti alla Corte Tributaria.
🔁 Ti assiste fino alla cancellazione o riduzione delle sanzioni e alla chiusura definitiva del contenzioso.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e del lavoro.
✔️ Specializzato nella difesa di imprese e datori di lavoro in materia di accertamenti fiscali.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Una contestazione per fringe benefit non dichiarati non va sottovalutata, ma neppure accettata senza verifica.
Con un’adeguata difesa legale e una corretta documentazione, puoi dimostrare la legittimità dei vantaggi concessi, bloccare le richieste dell’Agenzia e ridurre o annullare le sanzioni.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro gli accertamenti fiscali sui fringe benefit comincia oggi.