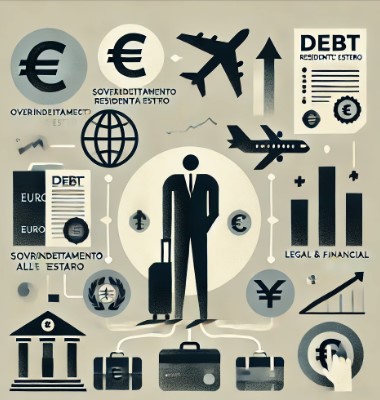Vivi all’estero ma hai ancora debiti in Italia che non riesci più a pagare?
Molti italiani residenti all’estero si trovano nella difficile situazione di avere cartelle esattoriali, mutui, finanziamenti o debiti bancari in Italia, che continuano a crescere con sanzioni e interessi.
Anche se non vivi più nel Paese, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e i creditori italiani possono continuare a notificare atti e chiedere il pagamento, e in alcuni casi avviare azioni esecutive sui beni rimasti in Italia (come conti correnti o immobili).
La buona notizia è che anche chi vive fuori dal territorio nazionale può accedere alla procedura di sovraindebitamento, bloccare la riscossione e chiedere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione).
Cos’è il sovraindebitamento e chi può beneficiarne
Il sovraindebitamento è una situazione in cui una persona non riesce più, con il proprio reddito e patrimonio, a far fronte ai debiti contratti.
La legge italiana – attraverso il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – consente anche ai privati, ex imprenditori, professionisti o piccoli imprenditori di accedere a una procedura legale per bloccare i creditori e ottenere la cancellazione o la riduzione dei debiti, anche se residenti all’estero.
Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento dall’estero
Puoi avviare la procedura se:
- Sei cittadino italiano residente all’estero, ma i tuoi debiti sono in Italia.
- Hai debiti fiscali, bancari, finanziari o commerciali contratti nel periodo in cui vivevi in Italia.
- Hai cartelle esattoriali, mutui o prestiti non pagati intestati in Italia.
- Sei un ex imprenditore o libero professionista che ha chiuso l’attività ma resta indebitato con il Fisco o le banche.
Non serve risiedere in Italia: basta dimostrare di avere ancora interessi giuridici, patrimoniali o fiscali nel territorio italiano (come debiti, conti, immobili o ex attività).
Come funziona la procedura per i residenti all’estero
- Analisi della posizione debitoria
Si parte con un’analisi completa dei debiti contratti in Italia: cartelle, prestiti, mutui, sentenze, contratti.
L’avvocato e l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) esaminano la situazione economica per individuare la procedura più adatta. - Scelta della procedura
- Piano del consumatore: per privati non imprenditori; il giudice approva un piano di pagamento sostenibile, senza bisogno del consenso dei creditori.
- Concordato minore: per ex imprenditori o professionisti; prevede un piano di rientro concordato con i creditori.
- Liquidazione controllata: se non puoi pagare nulla o hai solo beni da mettere a disposizione, il giudice liquida i beni e cancella i debiti residui.
- Esdebitazione del debitore incapiente: per chi non ha redditi né beni, il tribunale può cancellare integralmente i debiti se il debitore è meritevole.
- Presentazione della domanda al tribunale italiano
La procedura si svolge davanti al tribunale competente in Italia, che può essere quello del luogo dove hai avuto la tua ultima residenza o attività nel Paese.
L’avvocato si occupa di tutte le comunicazioni e dei depositi telematici, anche se ti trovi fisicamente all’estero. - Misure protettive immediate
Dal momento del deposito, il giudice può concedere la sospensione di pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e azioni di recupero, fermando ogni iniziativa dei creditori. - Omologa e cancellazione dei debiti
Dopo la verifica e l’approvazione del piano o della liquidazione, il tribunale emette il decreto di esdebitazione, che cancella in modo definitivo i debiti residui in Italia.
Quali debiti si possono cancellare
- Debiti con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS (IRPEF, IVA, contributi).
- Finanziamenti, mutui, prestiti personali, carte di credito.
- Debiti commerciali e con fornitori.
- Sanzioni e interessi maturati.
Non si cancellano invece:
- Obblighi alimentari o di mantenimento.
- Danni derivanti da reati o multe penali.
Vantaggi della procedura di sovraindebitamento per chi vive all’estero
- Puoi farla a distanza, tramite un avvocato in Italia che si occupa di tutto il procedimento.
- Blocca tutte le azioni esecutive avviate in Italia (pignoramenti, ipoteche, fermi).
- Cancellazione totale o parziale dei debiti con il decreto di esdebitazione.
- Regolarizzazione della posizione fiscale in Italia.
- Protezione del patrimonio e possibilità di ripartire senza debiti.
Documenti necessari per iniziare la procedura
- Documento di identità e codice fiscale italiano.
- Documentazione relativa ai debiti (cartelle, estratti conto, contratti, mutui).
- Eventuali buste paga o redditi percepiti all’estero.
- Elenco di eventuali beni o immobili in Italia.
- Dichiarazione dei redditi o ISEE (se disponibile).
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
- La sospensione immediata di ogni azione di riscossione in Italia.
- La cancellazione totale o parziale dei debiti fiscali e finanziari.
- La chiusura definitiva delle cartelle e delle segnalazioni.
- La possibilità di mantenere i beni personali essenziali.
- Il ritorno alla regolarità fiscale e finanziaria anche se vivi all’estero.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Devi contattare subito un avvocato tributarista o esperto in crisi da sovraindebitamento se:
- Hai debiti fiscali, bancari o contributivi rimasti in Italia.
- Hai ricevuto cartelle o notifiche dell’Agenzia delle Entrate anche all’estero.
- Vuoi evitare pignoramenti su beni o conti in Italia.
- Vuoi ottenere la cancellazione legale dei debiti tramite il tribunale.
Un avvocato specializzato può seguire tutto il percorso anche a distanza, coordinandosi con l’OCC e gestendo le comunicazioni telematiche con il tribunale italiano.
⚠️ Attenzione: non risolvere i debiti in Italia può comportare l’accumulo di interessi, la perdita di eventuali beni e la segnalazione nelle banche dati italiane. Agire in tempo, anche dall’estero, ti permette di bloccare la riscossione e ripartire pulito.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi da sovraindebitamento e difesa dei debitori residenti all’estero – spiega come funziona la procedura di sovraindebitamento per chi vive fuori dall’Italia, quali documenti servono e come ottenere la cancellazione dei debiti in modo sicuro e legale.
👉 Vivi all’estero ma hai ancora debiti o cartelle in Italia?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo.
Analizzeremo la tua posizione, verificheremo se puoi accedere alla procedura di esdebitazione e costruiremo una strategia personalizzata per bloccare la riscossione e cancellare i debiti anche se risiedi all’estero.
Introduzione al sovraindebitamento e alla residenza all’estero
Il sovraindebitamento indica la situazione in cui un soggetto (consumatore, professionista o piccola impresa non fallibile) non è più in grado di far fronte regolarmente ai propri debiti con il patrimonio o il reddito disponibili. In altre parole, si tratta di un perdurante squilibrio economico tra obbligazioni assunte e capacità di rimborso. Il legislatore italiano, a partire dalla Legge 3/2012, ha introdotto procedure ad hoc per gestire questa crisi, offrendo al debitore onesto una “seconda opportunità” di liberarsi dai debiti residui (c.d. esdebitazione) dopo aver soddisfatto i creditori in misura compatibile con le proprie effettive possibilità. Tali strumenti – oggi riformati ed inclusi nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – consentono di ristrutturare o liquidare i debiti secondo un piano sostenibile, evitando al debitore di rimanere schiacciato a vita dai debiti e permettendogli di tornare ad una vita dignitosa e produttiva .
Un quesito frequente è se possa accedere a queste procedure il soggetto residente all’estero. In passato la risposta non era scontata: la Legge 3/2012 stabiliva la competenza del tribunale del luogo di residenza del debitore, creando incertezze per i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) privi di domicilio in Italia. Oggi, grazie alla riforma del CCII, anche chi risiede stabilmente fuori dall’Italia può avvalersi delle procedure di sovraindebitamento italiane, purché sussistano concreti legami con l’Italia (debiti verso creditori italiani, beni sul territorio nazionale, conti bancari in Italia, ecc.). In pratica, il debitore residente all’estero deve dimostrare un collegamento economico-patrimoniale significativo con l’Italia, in modo da individuare sul territorio italiano un centro di interessi o quantomeno l’origine sostanziale dell’indebitamento. Come vedremo, in mancanza di un centro d’interessi in Italia diverso, la legge oggi individua nel Tribunale di Roma l’autorità competente a trattare queste procedure per i soggetti residenti all’estero.
Questa guida, aggiornata a settembre 2025, fornirà un quadro dettagliato e avanzato delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento applicabili al debitore italiano residente all’estero, con particolare attenzione alla normativa vigente (Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019, e successive modifiche), alla giurisprudenza più recente e agli aspetti pratici per l’accesso alle procedure. Adotteremo un linguaggio utile sia per professionisti legali sia per debitori (privati o piccoli imprenditori) che vogliono comprendere come uscire dalla spirale dei debiti in modo legale. Troverete domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative delle principali caratteristiche delle procedure (es. Piano del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata, ecc.), nonché casi pratici simulati focalizzati sul contesto italiano. Il tutto dal punto di vista del debitore, ovvero concentrandoci sulle opportunità e sugli obblighi del soggetto sovraindebitato che intende voltare pagina.
(Nota: Questa guida tiene conto delle più recenti modifiche normative e pronunce giurisprudenziali fino a settembre 2025. Tutte le fonti normative e le sentenze citate sono elencate in fondo al documento nella sezione Fonti e Riferimenti.)*
Quadro normativo e definizioni fondamentali
Normativa di riferimento: La disciplina italiana del sovraindebitamento nasce con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (nota come “Legge salva-suicidi”), poi confluita nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore in via definitiva il 15 luglio 2022) . Quest’ultimo ha riordinato la materia delle procedure concorsuali, includendo un’apposita sezione per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento destinate ai debitori civili e agli imprenditori minori. I principali strumenti oggi previsti (Capo II del Titolo IV CCII) sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (il “vecchio” piano del consumatore della L.3/2012, ora disciplinato dagli artt. 67-73 CCII), riservato ai debitori consumatori.
- Concordato minore (sostitutivo del previgente accordo di composizione della crisi, artt. 74-83 CCII), destinato ai debitori non consumatori che non possono accedere alle procedure maggiori (concordato preventivo o liquidazione giudiziale perché non soggetti fallibili).
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (corrispondente alla liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, artt. 268-277 CCII), ossia una procedura liquidatoria concorsuale dei beni del debitore sovraindebitato.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), introdotta con la riforma del 2020 e confermata nel CCII: una procedura semplificata che consente la cancellazione dei debiti residui del debitore persona fisica privo di qualsiasi utilità distribuibile ai creditori. Si tratta di un beneficio straordinario, azionabile una sola volta nella vita, e che esamineremo in dettaglio più avanti.
Definizioni chiave: Ai fini dell’accesso a queste procedure sono essenziali alcune definizioni normative:
- Sovraindebitato: è il debitore (persona fisica, consumatore o imprenditore minore) che si trova in uno stato di sovraindebitamento, definito come “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti” (art. 2, co.1, lett. c) CCII). In parole povere, il soggetto che non riesce più a pagare i propri debiti in modo regolare e integrale.
- Consumatore: la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 2, co.1, lett. e) CCII). È una nozione restrittiva: ad esempio, un piccolo imprenditore che abbia anche debiti personali può accedere al piano del consumatore solo se i debiti derivanti dall’attività d’impresa sono cessati e di modesta entità. La riforma ha chiarito che chi non ha cessato una precedente attività d’impresa rimane escluso dallo status di consumatore. Viceversa, la presenza di residui debiti d’impresa ormai chiusa in passato non preclude l’accesso al piano del consumatore secondo la nuova disciplina (superando un precedente orientamento giurisprudenziale più rigido).
- Imprenditore minore (o sotto-soglia): è l’imprenditore non assoggettabile a liquidazione giudiziale (ex fallimento) perché al di sotto dei parametri dimensionali di cui all’art. 1 L.Fall. (ora art. 2, co.1, lett. d) CCII). I limiti attualmente vigenti sono: debiti ≤ 500.000 €, ricavi ≤ 200.000 € annui e attivo ≤ 300.000 € (riferiti ai 3 esercizi precedenti). Chi rientra in questi limiti è considerato “non fallibile” e dunque può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Rientrano in tale categoria anche l’imprenditore agricolo sotto-soglia, le start-up innovative, le associazioni e ONLUS, i professionisti e lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali e gli enti pubblici per i debiti civili.
- Famiglia sovraindebitata: il CCII consente ora procedure familiari congiunte. Membri della stessa famiglia conviventi, i cui debiti abbiano un’origine comune, possono presentare un’unica procedura di composizione (art. 66 CCII). Ad esempio, coniugi coobbligati per gli stessi finanziamenti possono proporre un piano unico. Ciò riduce costi e tempi, ma richiede il doppio requisito di convivenza e comune origine dell’indebitamento. Anche i soci illimitatamente responsabili di società personali possono accedere congiuntamente (ad es. socio di SNC con debiti sociali e personali).
- Meritevolezza: è il requisito soggettivo di accesso, pensato per escludere dall’agevolazione chi abbia colpevolmente causato la propria insolvenza. La formulazione attuale (post riforma 2020) prevede che il debitore non debba aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sono dunque esclusi i debitori che abbiano agito con dolo o colpa grave (ad esempio accumulando debiti con comportamento fraudolento). Invece non è più motivo di esclusione l’essere stati imprudenti o aver fatto scelte finanziarie azzardate purché non si raggiunga la soglia della malafede grave. La riforma ha infatti eliminato i più rigidi criteri previgenti (come l’aver assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento o un eccessivo ricorso al credito sproporzionato al reddito). In sintesi, oggi conta soprattutto l’assenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi: ad esempio, un indebitamento derivante da spese mediche impreviste o dalla perdita del lavoro non preclude l’accesso, mentre resterebbe escluso chi abbia truffato i creditori. Persino situazioni prima considerate con sospetto, come i debiti da ludopatia (gioco d’azzardo patologico), sono stati talora ammessi se il giudice valuta l’incolpevolezza del debitore, riconoscendo la dipendenza patologica come causa del sovraindebitamento. Ogni caso è valutato concretamente, e come vedremo le misure protettive** della procedura (blocco dei pignoramenti) possono essere revocate se emergono atti in frode ai creditori da parte del debitore.
- Credito responsabile (merito creditizio): accanto alla meritevolezza del debitore, la legge richiama il tema del comportamento degli intermediari finanziari. Dal 2020 è stato rafforzato il principio per cui eventuali violazioni degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte delle banche/finanziarie non impediscono la procedura, anzi vengono “punite” implicitamente. In altre parole, se il debitore ha ottenuto prestiti che non avrebbe ragionevolmente potuto ripagare a causa della leggerezza dell’ente finanziatore nel concedere credito, ciò non costituisce colpa del debitore ai fini della procedura. Questo orientamento incoraggia i creditori a una concessione del credito più responsabile e tutela il debitore meritevole da un eccessivo indebitamento provocato anche da terzi.
- Esdebitazione: termine che indica la liberazione dai debiti residui non pagati al termine della procedura. È l’effetto “premiale” che il debitore ottiene una volta eseguite le obbligazioni previste dal piano o una volta liquidati i suoi beni: i debiti anteriori vengono cancellati (salvo alcune eccezioni di legge) e i creditori chirografari non possono più pretendere il pagamento di quanto rimasto insoddisfatto. Le eccezioni all’esdebitazione riguardano, anche nel CCII, i debiti non eliminabili per ragioni di ordine pubblico: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da fatti illeciti dovuti a titoli di danno, sanzioni penali o amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Tali debiti “personali” restano comunque a carico del debitore anche dopo la procedura. Altra eccezione: il debitore indegno può vedersi negare l’esdebitazione se emergono comportamenti fraudolenti o violazioni dei doveri di collaborazione.
In questo quadro normativo, il debitore residente all’estero può accedere a queste procedure alle stesse condizioni di merito di qualsiasi altro debitore in Italia (stato di sovraindebitamento attuale, qualifica di soggetto non fallibile, assenza di frode o colpa grave, etc.). La peculiarità per il residente estero riguarda soprattutto la competenza territoriale (dove presentare la domanda) e la necessità di dimostrare i legami con l’ordinamento italiano. Affronteremo ora proprio il tema cruciale della competenza e giurisdizione.
Competenza territoriale: il tribunale competente e il ruolo di Roma per i residenti all’estero
Una delle prime domande pratiche è: dove presentare la procedura di sovraindebitamento se il debitore risiede fuori dall’Italia? La risposta risiede nell’art. 27 CCII, che disciplina la competenza territoriale in materia di crisi e insolvenza. In generale, per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il proprio “centro degli interessi principali” (COMI). Il COMI di una persona fisica si presume coincidere con la sua residenza o domicilio abituale; se questi non sono noti, con l’ultima dimora conosciuta, e in mancanza perfino con il luogo di nascita. Questa presunzione è rilevante per determinare il foro competente in Italia.
- Debitore residente in Italia: se il sovraindebitato ha residenza o domicilio in Italia, la regola generale è che la domanda si presenta al tribunale del circondario corrispondente (es. Tribunale della città dove risiede). Questo vale sia per il consumatore (tribunale del luogo di residenza) sia per l’imprenditore minore (tribunale del luogo della sede principale dell’impresa). La giurisprudenza ha però chiarito che conta la sostanza più che la forma: il “centro principale degli interessi” potrebbe anche differire dalla residenza anagrafica, privilegiando il luogo dove il debitore svolge prevalentemente le sue attività economiche e ha i rapporti principali. Ad esempio, una ditta individuale formalmente con sede in un certo comune potrebbe avere il COMI altrove se lì concentra affari e debiti; in tal caso si potrebbe radicare la procedura nel tribunale del luogo di effettiva gestione degli interessi.
- Debitore italiano residente all’estero con domicilio in Italia: Se il debitore è iscritto all’AIRE ma mantiene un domicilio (o sede di interessi) in Italia, vi sono precedenti di ammissione della procedura nel tribunale italiano relativo a tale luogo. Ad esempio, il Tribunale di Vicenza (26/11/2016) ha accolto il ricorso di un italiano residente all’estero presentato nel tribunale dell’ultima residenza italiana e del domicilio della coniuge, dove si trovava il fulcro degli interessi economici comuni. Il giudice ritenne prevalente il luogo dei principali interessi rispetto alla residenza estera formale. Analogamente, il Tribunale di Forlì (27/5/2021) ha confermato questo approccio di sostanza. Dunque, se il debitore ha conservato in Italia un centro di relazioni economiche (un immobile, familiari a carico, un’attività in corso), potrà probabilmente rivolgersi al tribunale di quel luogo.
- Debitore residente all’estero senza domicilio o sede in Italia: Questa è la situazione più delicata ma oggi risolta espressamente dal legislatore. L’art. 27 CCII stabilisce infatti che se il centro degli interessi principali del debitore non è situato in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma. Roma funge dunque da foro “accentrato” per i sovraindebitati esteri. In altre parole, un cittadino italiano o comunque un soggetto con debiti in Italia ma residente all’estero, che non abbia un domicilio o sede di affari in Italia, dovrà depositare la domanda di sovraindebitamento presso il Tribunale di Roma. Questa disposizione evita un vuoto di tutela: in passato ci si interrogava se il debitore iscritto AIRE potesse restare escluso dalla procedura, con pregiudizio per sé (senza via d’uscita dai debiti) e per i creditori (impossibilità di soddisfazione parziale). Ora la legge offre una soluzione certa, prevenendo un’esclusione irragionevole.
È importante notare che la presenza di legami concreti con l’Italia rimane un requisito di fatto. Il tribunale (Roma, se COMI all’estero) dovrà verificare che esista almeno un collegamento giurisdizionale o economico: ad esempio, che i debiti siano verso creditori italiani, o che vi siano beni in Italia aggredibili. Se un soggetto ha tutti i debiti e i beni solo all’estero, potrebbe non avere senso (né giurisdizione effettiva) aprire una procedura in Italia. In pratica, per accedere dall’estero il debitore dovrà fornire prove di tali legami: contratti con soggetti italiani, procedure esecutive iniziate in Italia, proprietà immobiliari o mobili registrati in Italia, conti bancari italiani, ecc.. Più forte è il nesso con il sistema italiano, più agevole sarà l’accesso.
Riassumendo la competenza territoriale:
- Se risiedi in Italia: tribunale del luogo di residenza (o dove hai il principale centro d’affari).
- Se risiedi all’estero ma hai un domicilio/sede di interessi in Italia: tribunale di quel luogo (es.: ultima residenza nota, dove hai beni rilevanti o familiari).
- Se risiedi all’estero senza domicilio in Italia: Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 27 CCII.
Questa centralizzazione su Roma garantisce un punto di accesso univoco. Infatti, il Tribunale di Roma ha già predisposto apposite sezioni e best practice per gestire le domande provenienti dall’estero. Ad esempio, nelle linee guida romane si sottolinea che, in mancanza di residenza/domicilio italiani, la domanda va depositata a Roma indicando gli elementi di collegamento e che il giudice designato valuterà la sussistenza della giurisdizione italiana in base ai legami presentati. Inoltre, come vedremo, in questi casi il debitore dovrà generalmente affidarsi a un Gestore della crisi iscritto ad un OCC italiano (Organismo di Composizione della Crisi) e agire tramite un difensore in Italia per interfacciarsi col tribunale.
Esempio: Marco, cittadino italiano, si è trasferito stabilmente in Spagna dove lavora, ed è iscritto AIRE. Ha tuttavia debiti in Italia (mutuo residuo per una casa in Italia e alcune cartelle esattoriali) e possiede ancora un appartamento a Milano. In questo scenario, anche se risiede in Spagna, il centro principale degli interessi di Marco potrebbe essere considerato in Italia grazie all’immobile e ai debiti ivi localizzati. Potrebbe valutare due opzioni: (a) presentare la procedura al Tribunale di Milano, sostenendo che il suo centro di interessi coincide con l’immobile e gli affari rimasti a Milano; oppure (b) presentarla al Tribunale di Roma in base all’art. 27 CCII. La scelta dipenderà dalle circostanze (ad esempio, se la casa di Milano è affittata e genera reddito, ciò rafforza Milano come centro interessi; viceversa, se è sfitto e i rapporti principali sono con creditori pubblici nazionali, può essere più prudente Roma). In ogni caso, Marco dovrà nominare un OCC in Italia e seguire da remoto la procedura, eventualmente facendosi rappresentare nelle udienze dal suo avvocato.
In conclusione, risiedere all’estero non preclude affatto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento italiane, ma richiede attenzione alla questione della competenza territoriale e della giurisdizione. Grazie all’intervento del legislatore, oggi sappiamo che il Tribunale di Roma è competente per chi non ha un centro d’interessi in Italia. Resta fondamentale predisporre un dossier probatorio che illustri i legami con l’Italia per fondare la domanda. Nella sezione seguente vedremo come funzionano le singole procedure in concreto e come prepararsi, passo per passo, alla presentazione della domanda (documentazione, Organismo di Composizione della Crisi, ecc.), tenendo conto anche delle esigenze di chi opera a distanza dall’estero.
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: tipologie e caratteristiche
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio le diverse procedure che il debitore sovraindebitato (anche se residente all’estero) può attivare. Ciascuna di esse ha presupposti soggettivi specifici e modalità differenti di svolgimento. È fondamentale scegliere quella appropriata al proprio caso: ad esempio, il consumatore potrà avvalersi del piano del consumatore, mentre un piccolo imprenditore opterà per il concordato minore, e chi non ha beni liquidi potrà ricorrere alla liquidazione controllata o addirittura all’esdebitazione incapiente. Di seguito descriviamo ogni procedura in termini di destinatari, meccanismo, durata e effetti. Una tabella riepilogativa comparativa sarà fornita più avanti per confrontare a colpo d’occhio le principali differenze.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore)
Il piano del consumatore è la procedura riservata esclusivamente al debitore consumatore, cioè persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali. Si tratta di un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore al tribunale, con l’ausilio dell’OCC, finalizzato a regolare e ridurre l’esposizione debitoria in base alle sue reali possibilità economiche. Ecco le caratteristiche salienti:
- Accesso e presupposti: Può accedere chi è consumatore e si trova in stato di sovraindebitamento. Non può aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave (requisito di meritevolezza) . Non è richiesto di essere nullatenente; anzi, tipicamente il consumatore ha qualche reddito (stipendio, pensione) con cui intende pagare almeno in parte i debiti. È volontario: solo il debitore può attivare il piano (non i creditori).
- Contenuto del piano: Il debitore, con l’ausilio del Gestore della crisi nominato dall’OCC, predispone un piano di rientro sostenibile rispetto alle sue capacità di reddito e patrimonio. Può prevedere diverse soluzioni: pagamento parziale dei crediti in forma dilazionata, vendita di alcuni beni per pagare i creditori, stralcio di parte dei debiti chirografari, mantenendo però una quota di reddito sufficiente per il sostentamento proprio e della famiglia. Non è richiesto di pagare tutti i debiti integralmente: l’essenza del piano è proporre quanto il debitore può effettivamente permettersi, garantendo però ai creditori un trattamento più conveniente rispetto all’ipotesi liquidatoria. Ad esempio, un consumatore con debiti totali €100.000 potrebbe proporre di pagarne €30.000 in 5 anni (rateizzando una parte del suo stipendio) e di liberarsi del residuo. Il piano può anche prevedere classi di creditori e trattamenti diversificati, purché nel rispetto delle cause legittime di prelazione (ad esempio i crediti ipotecari vanno soddisfatti almeno nei limiti del valore del bene dato in garanzia). Importante: il quinto stipendiale (cessione del quinto in busta paga) può essere inserito nel piano per cessare la trattenuta, liberando risorse per un pagamento più equo a tutti i creditori.
- Niente voto dei creditori: A differenza delle procedure concorsuali tipiche, nel piano del consumatore i creditori non votano né devono approvare il piano. Il potere decisionale è affidato al Tribunale. Questa è una peculiarità rilevante: il consumatore meritevole può ottenere l’omologazione anche senza l’accordo dei creditori, i quali subiscono la falcidia proposta. Ovviamente, i creditori vengono coinvolti nel procedimento (possono presentare osservazioni e opposizioni), ma non esiste una soglia di voto. Il giudice omologa il piano se lo ritiene corretto, fattibile e rispondente ai requisiti di legge. In particolare, verifica la fattibilità economica (che le entrate promesse siano reali) e la meritevolezza del debitore . Con la riforma, il vaglio di meritevolezza è circoscritto all’assenza di colpa grave o frode, come detto, evitando valutazioni troppo severe sul comportamento pregresso del debitore. Ciò rende più agevole l’omologa rispetto al passato, come rilevato anche da Cass. civ. n. 1869/2016 e successive, che invitavano ad un approccio non punitivo verso il debitore consumatore.
- Procedimento: Presentata l’istanza all’OCC e redatta la proposta di piano con la relazione dell’OCC, il debitore deposita il ricorso in Tribunale. Il giudice può adottare misure protettive automatiche ex art. 69, co.4 CCII: la presentazione del ricorso sospende automaticamente eventuali procedure esecutive individuali in corso. Inoltre, il giudice può disporre altre misure protettive (tipo sospensione di interessi maturandi, blocco di ipoteche giudiziali recenti, ecc.) analoghe a quelle del concordato preventivo. Le misure protettive nel piano possono essere revocate se emergono atti in frode (es. occultamento di beni) su istanza dei creditori. Dopo aver sentito eventualmente le parti, il Tribunale procede all’omologazione. Se non vi sono opposizioni o se queste vengono respinte, il giudice omologa con decreto, che rende il piano obbligatorio per tutti i creditori anteriori . Da notare: l’omologazione del piano del consumatore non richiede il voto nemmeno per i crediti pubblici (fisco), i quali non possono opporsi se il trattamento proposto rispetta i criteri di convenienza (ad esempio il pagamento di una parte almeno pari a quanto otterrebbero in una liquidazione). La legge di bilancio 2019 aveva persino previsto un saldo e stralcio automatico per taluni debiti fiscali nelle procedure di liquidazione del patrimonio, con possibilità di pagare il 10% in caso di ISEE basso, segno di una tendenza a facilitare la composizione anche con l’Erario. Oggi, nella prassi, Agenzia Entrate Riscossione partecipa al procedimento come qualsiasi creditore chirografo: presenta il proprio credito e osservazioni, ma non può vetoare il piano se conforme alla legge.
- Effetti dell’omologazione: Il decreto di omologa rende il piano efficace verso tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti . Da quel momento, il debitore deve attenersi rigorosamente ai pagamenti e alle azioni previste dal piano sotto il controllo dell’OCC (che svolge funzioni di sorveglianza durante l’esecuzione). Le eventuali esecuzioni individuali ancora pendenti vengono definitivamente sospese o chiuse (il giudice dell’esecuzione dichiarerà improcedibili i pignoramenti, essendo intervenuta l’omologazione). Il debitore non può contrarre nuovi debiti se non nei limiti consentiti per la vita corrente e deve conservare l’integrità del suo patrimonio secondo buona fede. Al completamento dell’esecuzione del piano, l’OCC relaziona al tribunale e il debitore ottiene il decreto che lo esdebita, ossia cancella tutti i debiti residui non pagati nel piano. Da quel momento i creditori chirografari non potranno più agire per il recupero di quanto era dovuto in eccesso. In caso invece di inadempimento del piano per colpa del debitore (ad esempio smette di versare le rate senza giustificazione), il Tribunale – su istanza dei creditori – potrà revocare l’omologazione: i creditori riacquisteranno i diritti originari al netto di quanto eventualmente già incassato. Tuttavia, piccole irregolarità o ritardi possono essere gestiti: spesso i piani prevedono clausole di flessibilità (es. tolleranza di qualche giorno per i pagamenti, o possibilità di modificare il piano in caso di sopravvenienze rilevanti). Se il piano dovesse diventare impraticabile per cause non imputabili al debitore (ad es. nuovo evento sfortunato), il debitore può valutare di convertire la procedura in liquidazione controllata per ottenere comunque l’esdebitazione attraverso la vendita dei beni.
In sintesi, il piano del consumatore è uno strumento potente: consente al debitore persona fisica di proporre unilateralmente una soluzione ai propri debiti e, se ritenuta equa e sostenibile, di ottenerne l’approvazione giudiziale anche senza il consenso dei creditori. È pensato per situazioni in cui c’è un minimo di capacità di rimborso (es. un reddito da stipendio), ma non sufficiente a pagare tutto: il debitore salva il salvabile (magari conserva la prima casa, se riesce a pagare almeno i creditori ipotecari) e sacrifica una parte del reddito per un periodo determinato, al termine del quale riparte libero dai debiti pregressi. Dal punto di vista del creditore, il piano del consumatore può apparire penalizzante (imposto dall’alto), ma va considerato che senza di esso spesso il creditore non recupererebbe nulla (si pensi a creditori chirografari che altrimenti troverebbero il debitore nullatenente in fuga all’estero). Non a caso, la Cassazione ha più volte ribadito la finalità sociale di questa procedura e la necessità di interpretare le norme in modo da favorirne l’accesso ai debitori meritevoli .
Esempio pratico piano del consumatore (residenza estero): Luigi, ex dipendente italiano ora residente in Germania, ha mantenuto un lavoro da remoto per un’azienda italiana con stipendio di €1.500 mensili e ha debiti per €60.000 (prestiti personali in Italia e carte di credito). Luigi, tramite un OCC italiano, propone un piano: si impegna a versare €400 al mese ai creditori per 5 anni (totale ~€24.000), da suddividere proporzionalmente, offrendo quindi circa il 40% del dovuto e chiedendo lo stralcio del resto. Dimostra che €1.100 gli occorrono per vivere in Germania (affitto, spese) e €400 sono il massimo sostenibile. Il tribunale di Roma (essendo Luigi senza residenza in Italia) valuta positivamente il piano: i creditori, pur non felici, non propongono opposizione concreta. Il giudice omologa ritenendo che Luigi non ha colpa grave (i debiti derivano da periodi di disoccupazione) e che il piano è più vantaggioso di una liquidazione (Luigi non ha beni, quindi in assenza di piano i creditori avrebbero zero). Luigi esegue i pagamenti mensili tramite bonifico all’OCC che li distribuisce ai creditori. Dopo 5 anni, ottiene l’esdebitazione integrale: i creditori non potranno più pretendere i circa €36.000 rimasti non pagati. Luigi, pur avendo rimborsato solo il 40%, ha agito correttamente e viene liberato dai debiti, potendo così ricostruirsi un futuro finanziario senza l’ombra di quei debiti pregressi.
Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi)
Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati non consumatori: tipicamente piccoli imprenditori sotto-soglia, professionisti, ditte individuali, start-up non fallibili, imprenditori agricoli minori, ecc.. È la “controparte” del piano del consumatore per chi ha debiti anche di natura professionale o imprenditoriale. Fino al 2022, l’analoga procedura era chiamata accordo di composizione della crisi (L.3/2012). Il concordato minore ne rappresenta l’evoluzione, con alcune novità. Vediamone i punti qualificanti:
- Soggetti ammessi: qualsiasi debitore sovraindebitato diverso dal consumatore. Può quindi essere una persona fisica che ha debiti in parte derivanti da attività d’impresa o professionale in corso, oppure società di persone non fallibili, imprenditore agricolo, ente non profit indebitato, ecc. Importante: il consumatore puro non può accedere al concordato minore (deve usare il piano). Se un soggetto ha duplice veste (es. piccolo imprenditore con anche debiti personali), la legge specifica che se i debiti derivano in prevalenza da attività d’impresa, l’accesso è al concordato minore, mentre se sono per lo più personali può tentare il piano del consumatore. Inoltre, un fideiussore: il CCII stabilisce che il garante sovraindebitato segue la procedura collegata alla natura del debitore garantito (se garantiva un imprenditore deve fare concordato minore, se garantiva un consumatore può fare il piano). Questo dettaglio (art. 70 CCII) risolve dubbi del passato su come trattare i garanti.
- Natura della procedura: Si tratta di un accordo tra debitore e creditori, seppur mediato dal tribunale. A differenza del piano del consumatore, qui i creditori hanno diritto di voto sulla proposta. Il debitore prepara una proposta di concordato che verrà sottoposta all’approvazione dei creditori; in caso di voto favorevole, si passa all’omologa da parte del tribunale. Per certi versi ricorda un concordato preventivo semplificato per soggetti minori.
- Contenuto della proposta: Molto flessibile. Può prevedere la ristrutturazione dei debiti in vari modi (dilazione, stralcio parziale, conversione di debiti in equity se applicabile a società, ecc.), può contemplare la continuazione dell’attività aziendale (concordato in continuità) oppure la liquidazione di parte o di tutti i beni (concordato liquidatorio). È possibile anche coinvolgere risorse esterne (es. un terzo offre denaro per rilevare l’azienda, destinato ai creditori). Due scenari principali:
(a) Concordato minore in continuità: il debitore prosegue l’attività d’impresa durante e dopo la procedura, utilizzando i profitti futuri in parte per soddisfare i creditori. Ciò è permesso purché il piano sia fattibile e magari preveda anche qualche apporto di liquidità aggiuntiva per rendere conveniente ai creditori attendere.
(b) Concordato minore liquidatorio: il debitore cessa l’attività e propone di liquidare il proprio patrimonio a beneficio dei creditori, però rimanendo in ambito “concordato” anziché passare alla liquidazione controllata. La legge qui richiede però un quid pluris: se non c’è continuità, la proposta deve prevedere l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori (indicativamente, almeno un 10% in più rispetto a quanto otterrebbero dalla mera liquidazione). Questo per evitare che il concordato minore liquidatorio sia usato semplicemente come liquidazione “mascherata” senza vantaggi per i creditori. In pratica, l’imprenditore che chiude bottega dovrà trovare un contributo esterno (es. un familiare che conferisce una somma) da destinare ai creditori, altrimenti non è ammesso e si dovrà ripiegare sulla liquidazione controllata. - Ruolo dei creditori (voto): La proposta di concordato minore viene comunicata ai creditori e questi votano secondo le regole stabilite (analoghe a quelle del concordato preventivo per certi aspetti). È richiesta l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti ammessi al voto (secondo la vecchia legge 3/2012 era 60%; il CCII potrebbe aver confermato o leggermente modificato la percentuale: alcuni testi parlano di almeno il 50%, ma la norma attuale – art. 78 CCII – va verificata. Dalla guida ARD pare 50%, ma altre fonti indicano 60%. Verosimilmente, il CCII ha allineato la soglia al 50%+1 dei crediti, semplificando). In mancanza di tale maggioranza, la proposta non è approvata e la procedura viene dichiarata inammissibile (con conseguente possibilità per il debitore di ripiegare sulla liquidazione controllata). Se invece la maggioranza approva, si passa al giudizio di omologazione del tribunale.
- Intervento del tribunale: Anche qui, come nel piano, il giudice controlla legalità e fattibilità e soprattutto verifica il requisito soggettivo di meritevolezza (assenza di frode o colpa grave) da parte del debitore. Il tribunale inoltre esamina eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti: un creditore che non ha votato a favore può contestare l’omologazione se ritiene di essere trattato in modo deteriore rispetto ai favorevoli o se vi sono violazioni di legge. In particolare, vige la regola della par condicio tra creditori pari grado, salvo che abbiano espressamente approvato un trattamento differenziato. Se tutto è regolare, il tribunale omologa il concordato minore con sentenza (o decreto) che lo rende vincolante per tutti i creditori anteriori . A differenza del piano, qui l’omologa necessita sia del voto favorevole richiesto, sia del controllo di legittimità.
- Misure protettive: Anche nel concordato minore l’art. 69, co.4 CCII prevede la sospensione automatica delle azioni esecutive al momento del deposito della domanda. Quindi, presentato il ricorso di concordato minore (con proposta e documentazione), scattano gli stessi effetti protettivi del piano: blocco dei pignoramenti in corso e divieto di iniziarne di nuovi, inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti. Il giudice può adottare misure cautelari ulteriori se necessario (ad es. amministrazione controllata temporanea di beni per evitare depauperamenti). Queste misure, salvo diversa indicazione, durano sino all’omologazione. Vale quanto detto: se emergono atti in frode, i creditori possono chiedere la revoca delle protezioni e l’improcedibilità del concordato.
- Esecuzione e esdebitazione: Dopo l’omologa, il concordato minore viene eseguito sotto la vigilanza dell’OCC e, in caso di concordato in continuità, con eventuale nomina di un commissario giudiziale. Se il debitore adempie agli obblighi (pagamenti, cessione beni ecc.), al termine ottiene l’esdebitazione dei debiti residui analogamente al piano. Anche qui però, in base all’art. 84 co.4 CCII, è previsto che l’omologazione non pregiudica i diritti dei coobbligati e fideiussori salvo diversa pattuizione. Significa che se, ad esempio, la società Alfa fa concordato minore e paga i creditori al 30%, il fideiussore personale (es. il socio) resta obbligato per il restante 70% salvo che la proposta abbia previsto espressamente la liberazione anche delle fideiussioni (cosa teoricamente possibile inserire). È un aspetto tecnico ma importante: la liberazione del debitore principale non estingue automaticamente le garanzie di terzi, a meno che ciò sia concordato nella proposta e quindi accettato dai creditori garanti.
- Rapporto con la liquidazione controllata: Non di rado, il debitore presenta il concordato minore sperando nell’accordo, ma predispone anche un’alternativa. Se il concordato non viene approvato dai creditori, il CCII consente al debitore di chiedere la conversione in liquidazione controllata (art. 80 co.7 CCII) senza dover iniziare da capo con un nuovo ricorso. Questo “paracadute” evita che un fallimento dell’accordo lasci il debitore senza tutela. Anche se i creditori bocciano il piano, il tribunale potrebbe dichiarare aperta la liquidazione controllata d’ufficio, preservando il patrimonio per un concorso ordinato. Ciò riflette la logica per cui la liquidazione controllata è la soluzione residuale se un piano/concordato non è fattibile.
Esempio pratico concordato minore: Sofia è una piccola imprenditrice (artigiana) trasferitasi in Francia, con debiti per la sua ex attività in Italia (fornitori non pagati per 80.000 €, qualche debito fiscale 20.000 €). Non essendo consumatrice, Sofia non può usare il piano del consumatore. Propone tramite OCC un concordato minore: poiché ha chiuso l’attività, vende un macchinario rimasto (ricavando 10.000 €) e ottiene da un parente un finanziamento di 5.000 € per offrire ai creditori un totale di 15.000 € immediati, pari al 15% del debito. Nel concordato liquida tutto il patrimonio disponibile. I creditori votano: alcuni fornitori, temendo di non vedere nulla altrimenti, accettano; altri no. Si raggiunge circa il 55% di crediti favorevoli. I contrari (45%) vengono comunque vincolati perché superata la maggioranza richiesta (supponiamo sia sufficiente il 50%). Un creditore fiscale (Agenzia Entrate) è contrario perché vorrebbe di più, ma essendo minoranza non può bloccare. Si va in omologa: il giudice verifica che Sofia è meritevole (ha chiuso per crisi economica, senza frode) e che i creditori col concordato ottengono comunque più che in liquidazione (dove forse il 10% scarso). Omologa quindi il concordato minore. Sofia versa i 15.000 € promessi tramite l’OCC che ripartisce pro-quota ai creditori (i privilegiati come il Fisco prendono il provento del macchinario, i chirografari dividono il resto). Dopodiché Sofia ottiene l’esdebitazione: gli €85.000 di debiti residui sono cancellati e i creditori non potranno agire oltre. Notare che i fornitori insoddisfatti non hanno alternative: se non avessero accettato il concordato, si sarebbe aperta la liquidazione e probabilmente avrebbero recuperato ancora meno. La scelta di presentare concordato ha consentito a Sofia di chiudere i conti con un sacrificio parziale ma immediato e di ricominciare la sua attività in Francia senza l’assillo dei vecchi debiti italiani.
Liquidazione controllata del sovraindebitato (Liquidazione del patrimonio)
La liquidazione controllata è la procedura concorsuale che prevede la liquidazione (vendita) di tutto il patrimonio del debitore sovraindebitato, con distribuzione del ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Corrisponde, per i soggetti non fallibili, a ciò che è il “fallimento” (ora liquidazione giudiziale) per gli imprenditori maggiori. È dunque una procedura liquidatoria e concorsuale, che conduce – dopo la chiusura – all’esdebitazione del debitore onesto. Di regola, è il rimedio cui si ricorre quando non è possibile o non è riuscito un piano di ristrutturazione. Vediamone i tratti essenziali:
- Chi vi accede: Qualsiasi debitore sovraindebitato non fallibile può chiedere la propria liquidazione controllata (anche il consumatore, anche l’imprenditore minore). In genere, si sceglie la liquidazione quando il debitore non è in grado di proporre un piano di pagamento neppure parziale o quando il dissenso dei creditori rende impraticabile un accordo. Anche i creditori o il Pubblico Ministero potrebbero, in teoria, provocare l’apertura della liquidazione (in passato era così per la liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 su iniziativa esterna in alcuni casi, ad esempio su segnalazione del giudice se il piano veniva rigettato per frode). Tuttavia, la liquidazione controllata è prevalentemente volontaria: spesso è lo stesso debitore che, constatata l’impossibilità di pagare, chiede al tribunale di liquidare i propri beni per poi poter essere esdebitato.
- Presupposti oggettivi: Lo stato di sovraindebitamento. Non occorre la meritevolezza in fase di apertura (anche il debitore non meritevole potrebbe essere “costretto” in liquidazione su istanza creditori), ma attenzione: il debitore fraudolento alla fine non otterrà l’esdebitazione. Quindi, se emergono atti in frode durante la procedura, potrà essergli negato il beneficio finale. La liquidazione può essere aperta anche senza l’accordo dei creditori, è sufficiente la condizione di insolvenza/sovraindebitamento conclamata.
- Come funziona: Una volta disposta dal Tribunale con sentenza di apertura (o decreto), viene nominato un Liquidatore giudiziale (spesso coincide con il Gestore nominato dall’OCC, se la liquidazione è chiesta tramite OCC) che prende in consegna tutto il patrimonio del debitore. Si forma la massa attiva comprendendo beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni, eventuali stipendi futuri per la parte pignorabile, ecc. Vengono sospese tutte le azioni esecutive individuali (art. 14-quinquies L.3/2012 prevedeva il divieto di azioni esecutive e cautelari dalla data di apertura; il CCII presumibilmente contiene analoga previsione). I creditori presentano le loro domande di ammissione al passivo al liquidatore (c.d. stato passivo). Il liquidatore liquida i beni (vende all’asta l’immobile, realizza crediti, ecc.) e periodicamente distribuisce il ricavato ai creditori secondo le priorità di legge (prima i crediti prededucibili di procedura, poi eventuali privilegiati/ipotecari fino a capienza, infine i chirografari in proporzione). In questa procedura, a differenza delle precedenti, i creditori non votano nulla: subiscono passivamente la liquidazione secondo le regole classiche concorsuali. Anche eventuali crediti fiscali e contributivi partecipano come in un fallimento, con i loro privilegi e con le limitazioni (ad esempio l’IVA ha privilegio generale, ecc.). Il debitore è spossessato dell’amministrazione dei beni, ma non viene privato formalmente della titolarità: tuttavia, non può più disporne liberamente (ogni atto dispositivo sarebbe nullo). Egli ha obblighi di collaborazione col liquidatore e di trasparenza (deve consegnare documenti, informazioni, e segnalare tempestivamente sopravvenienze di reddito o patrimonio). Durante la liquidazione, il debitore può continuare a svolgere eventuali attività lavorative, ma, se genera reddito, la parte non necessaria al mantenimento (calcolata come eccedente all’assegno sociale aumentato della metà, come riferimento di sussistenza) può essere prelevata periodicamente dal liquidatore per incrementare la massa (simile al meccanismo di cessione del reddito nel fallimento).
- Durata: Il CCII ha introdotto un limite temporale alla liquidazione del sovraindebitato: la procedura dovrebbe concludersi entro 4 anni dall’apertura. Questo per evitare liquidazioni infinite. In verità, se la liquidazione dei beni non si conclude in 4 anni, gli effetti esdebitatori possono scattare comunque, ma il liquidatore proseguirà oltre se ci sono ancora attivi da realizzare (la norma indicata in potrebbe riferirsi al fatto che la liquidazione dei beni non preclude l’esdebitazione dopo 3-4 anni, e può proseguire senza limiti per realizzare eventuali asset rimasti). Nella pratica, una liquidazione controllata semplice (ad es. con solo beni mobili o piccoli immobili) spesso dura 2-3 anni, giusto il tempo di vendere e distribuire. Una durata eccessiva contrasterebbe col principio di ragionevole durata del processo.
- Esdebitazione “automatica” dopo 3 anni: Una delle novità più rilevanti del Codice della crisi è che trascorso un triennio dall’apertura della liquidazione controllata, il tribunale è chiamato a pronunciarsi d’ufficio sulla liberazione dai debiti residui, anche in assenza di specifica istanza del debitore . In pratica, se il debitore ha cooperato e non ci sono ragioni ostative, dopo 3 anni egli può ottenere l’esdebitazione con decreto del giudice, anche se la liquidazione non ha soddisfatto tutti i creditori. Questa esdebitazione viene definita “di diritto” (anche se comunque formalizzata con provvedimento) proprio perché il sistema la concede al meritevole automaticamente al termine del periodo, senza dover presentare un’apposita domanda come avveniva un tempo . Rimane comunque un controllo: il giudice verifica l’assenza di cause ostative (ad es. scoperta di frodi). Se tutto è regolare, emette il decreto di esdebitazione che libera il debitore da ogni debito concorsuale rimasto insoddisfatto.
- Clausola delle sopravvenienze: attenzione, anche qui c’è un vincolo quadriennale post-esdebitazione come per il debitore incapiente. L’art. 278 CCII (per le liquidazioni) prevede che se entro 4 anni dalla chiusura o dal decreto di esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti per il debitore, esse devono essere in parte destinate ai creditori nella misura in cui consentano di soddisfarli almeno al 10%. In altre parole, se il debitore “miracolato” entro 4 anni ottiene nuove risorse (una vincita, un’eredità cospicua), è previsto che quell’arricchimento inatteso non rimanga tutto al debitore se i creditori hanno preso meno del 10%: fino al raggiungimento del 10% ai creditori, vige un obbligo di pagamento residuo. Questo principio, comune anche all’esdebitazione incapiente, evita abusi e garantisce un minimo di recupero ai creditori in caso di fortune sopravvenute. Il debitore, a tal fine, deve presentare per 4 anni una dichiarazione annuale sulle eventuali utilità sopravvenute (commi 7-9 dell’art. 283 CCII). Il mancato deposito di queste dichiarazioni può portare a revoca del beneficio.
- Conclusione: La liquidazione termina con un decreto di chiusura (dopo il riparto finale). Segue il decreto di esdebitazione se non già concesso automaticamente. I crediti insoddisfatti, salvo le eccezioni (alimenti, multe), non sono più esigibili dal creditore nei confronti del debitore.
Quando conviene la liquidazione controllata? In genere, è indicata se il debitore non ha margini di reddito per offrire un piano, oppure se ha un patrimonio limitato da liquidare e vuole “tagliare” ogni rapporto con i creditori in tempi relativamente rapidi. Ad esempio, chi possiede solo una casa pignorabile e poco altro può pensare di “sacrificarla” in liquidazione e ripartire pulito dai debiti rimanenti. Anche per il debitore residente all’estero può essere una soluzione praticabile: magari questi non ha intenzione di rientrare in Italia o pagare rate, preferisce liquidare eventuali beni rimasti in Italia (es. vende l’immobile) e ottenere la cancellazione dei debiti italiani così da non avere più preoccupazioni internazionali (ricordiamo che con il meccanismo europeo, un creditore italiano potrebbe anche tentare di escutere beni del debitore all’estero se munito di titolo, quindi l’esdebitazione protegge ovunque dal lato giuridico).
Esempio pratico liquidazione controllata: Paolo, ex commerciante italiano ora emigrato in Canada, ha ancora in Italia dei beni: una seconda casa e un conto bancario, con debiti complessivi di €200.000 (banche e fornitori). Non ha redditi disponibili da offrire in un piano (in Canada guadagna appena per mantenersi). Decide quindi di avviare una liquidazione controllata davanti al Tribunale di Roma. L’OCC nominato verifica il patrimonio: la casa vale sui €120.000, il conto ha €5.000. Il tribunale apre la liquidazione, nomina un liquidatore e sospende i pignoramenti (la banca aveva già avviato esecuzione sulla casa, che ora confluisce nella procedura concorsuale). Il liquidatore vende l’immobile all’asta ricavando €100.000 netti, che distribuisce: paga prima le spese (OCC, tribunale), poi i creditori ipotecari (la banca magari aveva ipoteca di primo grado, incassa gran parte dei €100.000), rimane poco per i chirografari. Alla fine i creditori hanno ricevuto, ipotizziamo, un 50% la banca ipotecaria e solo 5% i chirografari, secondo i loro gradi. Dopo 3 anni, completate queste operazioni, Paolo chiede (o meglio, ottiene automaticamente) l’esdebitazione: il Tribunale verifica che Paolo ha cooperato (ha consegnato le chiavi della casa, firmato i documenti, ecc.), non ha nascosto nulla e non ha attuato frodi. Emana dunque il decreto di esdebitazione ex art. 282 CCII, liberandolo dai € (circa) 100.000 di debiti rimasti scoperti. Paolo non deve pagare più nulla su quei debiti. Dovrà solo ricordarsi, per i 4 anni successivi, di segnalare se gli capita una sopravvenienza (es. se vincesse alla lotteria €50.000 in questo periodo, il 10% dei debiti originari era €20.000, e la differenza tra quanto pagato e il 10% – se ad esempio i creditori avevano avuto il 30% in totale, nessuna obbligazione residua; se avevano avuto solo 5%, allora se Paolo riceve €50.000 dovrebbe destinarne una parte fino a portare soddisfazione al 10%). Passati i 4 anni senza novità, i creditori non avranno più nulla a che pretendere, neanche in caso di miglioramenti futuri di Paolo. La vicenda si chiude quindi con la liquidazione dei beni in Italia e la riabilitazione economica di Paolo.
Esdebitazione del debitore incapiente (“esdebitazione senza utilità”)
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è una procedura speciale e semplificata, introdotta in Italia nel 2020 (art. 14-quaterdecies L.3/2012, ora trasfuso nell’art. 283 CCII). Si rivolge al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in futuro. In parole semplici, il debitore totalmente “incapiente”, cioè privo di beni liquidabili e di reddito aggredibile, può chiedere direttamente la cancellazione dei propri debiti, senza passare attraverso una procedura concorsuale classica (piano o liquidazione). È una sorta di “fresh start” immediato, pensato per situazioni di indigenza assoluta. Data la portata eccezionale (si concede la liberazione dai debiti senza alcun pagamento ai creditori), la legge ha previsto condizioni rigorose:
- Requisiti per l’accesso:
(a) Incapacità economica totale: il debitore non deve poter offrire alcuna utilità ai creditori, né immediata né prospettica. Significa che non possiede beni vendibili, non ha risparmi, non ha un reddito stabile oltre il minimo vitale, e nemmeno si prevedono miglioramenti a breve. Questa valutazione è oggettiva e dev’essere supportata da documentazione completa sulla situazione patrimoniale e reddituale. Anche eventuali attivi futuri prevedibili (es. TFR maturando) potrebbero far escludere la totale incapienza, spingendo invece verso un piano o liquidazione.
(b) Meritevolezza elevata: il debitore deve essere “meritevole” ai sensi di legge, cioè non deve aver colposamente o dolosamente causato il sovraindebitamento. Viene qui richiesto uno scrutinio severo: atti in frode, abuso della buona fede dei creditori, spese voluttuarie spropositate potrebbero far rigettare la domanda di esdebitazione incapiente. Il giudice verifica in particolare l’assenza di dolo o colpa grave (specificato dal comma 7 dell’art. 283 CCII).
(c) Unica volta: il beneficio è concesso una tantum. La legge esplicitamente dice che il debitore persona fisica meritevole incapiente “può accedere all’esdebitazione solo per una volta”. Non è dunque possibile azzerare i debiti a costo zero più di una volta nella vita. Ciò per evitare che qualcuno possa approfittarne reiteratamente. - Procedimento: Il debitore presenta un’istanza al Tribunale (verosimilmente presso il tribunale competente come discusso, quindi Roma se risiede all’estero senza domicilio in Italia, altrimenti il tribunale del proprio domicilio) chiedendo l’esdebitazione di cui all’art. 283 CCII. Deve allegare tutta la documentazione attestante la propria situazione: elenco completo creditori, attestazione che nessun patrimonio liquidabile esiste (es. visure immobiliari negative, conto in banca vuoto), eventuale ISEE, stato di famiglia, condizioni di salute (se rilevano), ecc. Occorre presumibilmente il coinvolgimento di un OCC o comunque di un professionista che asseveri la situazione (il CCII prevede che la domanda possa essere presentata “per il tramite dell’OCC” anche qui, sebbene l’art. 283 demandi al giudice di stabilire modalità e tempi). Spesso, nella prassi emergente, il debitore incapiente si rivolge comunque a un OCC per farsi assistere nella redazione della richiesta e per avere un quadro attendibile della propria incapienza.
Il tribunale, valutati i requisiti, accoglie la domanda con decreto se ritiene verificato lo stato di totale incapacità e la meritevolezza. Il decreto di accoglimento dispone la liberazione di tutti i debiti del richiedente. Da notare che, trattandosi di procedura non concorsuale in senso stretto, non c’è un contraddittorio con i creditori come nelle altre procedure: i creditori vengono informati, ma non hanno potere di voto o veto. Possono semmai opporsi (ad esempio se un creditore è a conoscenza che il debitore ha nascosto un bene, potrà segnalarlo). Tuttavia, formalmente, l’udienza potrebbe anche non esservi: il giudice decide sulla base degli atti, magari con un’istruttoria informale (richiesta di chiarimenti all’OCC o al debitore). In caso di rigetto, il debitore incapiente potrà comunque tentare la via della liquidazione controllata ordinaria.
- Effetti per i creditori: Il provvedimento di accoglimento cancella tutti i debiti chirografari del debitore. I crediti privilegiati (ipotecari, pignoratizi) anch’essi restano inesigibili, poiché comunque non c’è patrimonio su cui rivalersi. Si tratta di un sostanziale sacrificio integrale imposto ai creditori: questi ultimi non ricevono nulla (o hanno già ricevuto briciole in eventuali esecuzioni precedenti andate deserte) e devono rinunciare definitivamente alle pretese. Da qui si capisce perché la norma sia concepita come eccezionale e subordinata a strette condizioni: è un reset totale dei debiti, giustificato solo in presenza di indigenza reale e involontaria. I creditori, dal canto loro, evitano spese ulteriori inseguendo un debitore da cui comunque non potrebbero ricavare nulla; e si può argomentare che vi è anche un interesse pubblico a togliere dal “sommerso” un soggetto altrimenti condannato all’irregolarità (perché chi è oppresso da debiti che non può pagare potrebbe lavorare in nero, fuggire, ecc., mentre liberarlo dai debiti gli permette di rientrare nell’economia legale produttiva) .
- Obblighi post-esdebitazione: Analogamente alla liquidazione, anche qui la legge pone la clausola delle sopravvenienze: nei 4 anni successivi al decreto di esdebitazione, se sopraggiungono utilità significative tali da permettere di pagare almeno il 10% dei debiti, il debitore rimane obbligato a soddisfarli entro tale limite. Questo significa che l’esdebitazione è revocabile parzialmente se entro 4 anni il debitore ottiene entrate insperate. Ad esempio, Tizio aveva €100.000 di debiti cancellati per incapienza; due anni dopo riceve un’eredità di €50.000. Poiché il 10% di 100.000 è €10.000, Tizio è tenuto a usare €10.000 di quell’eredità per pagare i vecchi creditori, ma oltre tale soglia può tenere il resto. La normativa non dettaglia esattamente le modalità (non essendoci un liquidatore in carica): tendenzialmente, il creditore interessato potrebbe chiedere al giudice che aveva concesso l’esdebitazione di revocare il beneficio se il debitore non spontaneamente paga. Il giudice, all’atto dell’esdebitazione, ordina al debitore di presentare annualmente per 4 anni una dichiarazione sulle eventuali utilità sopravvenute. L’OCC originario può essere incaricato di vigilare su questo adempimento e di verificare su richiesta del giudice se vi siano sopravvenienze (art. 283 co.9 CCII). Se il debitore omette di presentare la dichiarazione annuale, è prevista la revoca del beneficio. Non sono invece espressamente previste revoche per frodi scoperte successivamente (cosa invece presente nella esdebitazione post-fallimentare, art. 142 L.F., dove atti in frode occultati potevano far revocare l’esdebitazione). Ciò è stato criticato da alcuni commentatori: la mancanza di una previsione di revoca per frode sopravvenuta potrebbe creare iniquità. In ogni caso, se emergesse che il debitore incapiente aveva mentito (ad esempio possedeva un bene all’estero), quel decreto sarebbe suscettibile di revoca per dolo processuale (strumenti generali).
- Limiti oggettivi: L’esdebitazione incapiente non si applica ai debiti impignorabili per loro natura (es. alimenti dovuti) e, per analogia, non estingue le categorie di debiti esclusi dall’esdebitazione nelle procedure ordinarie (mantenimenti, multe penali, ecc., come già visto). Tuttavia, essendo disciplina nuova e autonoma, qualche dubbio interpretativo c’è: l’art. 278 CCII che esclude quei debiti è nel contesto delle esdebitazioni da liquidazione, mentre per l’incapiente non è ripetuto. Ci si chiede quindi se il debitore incapiente possa liberarsi anche di eventuali multe o alimenti arretrati. Dottrina e buon senso portano a escludere che possa liberarsi dagli alimenti non versati, essendo crediti di natura speciale non falcidiabili. Sarà comunque il giudice, caso per caso, a indicare eventuali debiti esclusi.
Unico “costo” della procedura incapienti: La legge prevede che il compenso dell’OCC sia ridotto della metà in questi casi, ma comunque c’è un minimo che il debitore deve versare per attivare la procedura (spesso intorno a poche centinaia di euro, talora rateizzabili). Inoltre, va pagato il contributo unificato ridotto dovuto al momento del deposito del ricorso (che varia a seconda se consumatore o meno, ma parliamo di importi modesti, es. €98). Molti OCC applicano tariffe simboliche agli incapienti (magari a carico di eventuali enti assistenziali). In sintesi, anche un nullatenente assoluto deve fare un piccolo sforzo economico iniziale per coprire le spese di procedura. Non esistono infatti fondi pubblici dedicati a finanziare queste procedure, sebbene si sia discusso di introdurre misure di supporto. Fortunatamente la riduzione del 50% rende sostenibile il compenso OCC, e spesso i professionisti accettano di essere pagati solo in parte o a esito ottenuto, vista la condizione disagiata del debitore incapiente.
Esempio pratico esdebitazione incapiente (residente estero): Anna, casalinga italiana residente all’estero (senza beni né redditi se non una piccola pensione sociale nel paese estero), ha in Italia debiti per €30.000 derivanti da vecchie bollette e prestiti che non riuscì a pagare prima di trasferirsi. Non possiede nulla in Italia e vive mantenuta dal figlio. Anna potrebbe ricorrere direttamente all’esdebitazione incapiente presso il Tribunale di Roma (competente essendo all’estero e senza domicilio in Italia). Allegando ISEE, certificati esteri di non reddito, nessun conto corrente attivo, ecc., dimostra di non poter dare assolutamente nulla ai suoi creditori. L’OCC la aiuta a redigere un elenco creditori e verificare che non ci siano beni nascosti. Il giudice valuta che Anna è effettivamente indigente e che i debiti sono stati causati più che altro da difficoltà economiche, non da colpa grave (ha tentato di pagarli ma con la sola pensione non riusciva). Accoglie quindi la domanda, emettendo decreto di esdebitazione: i €30.000 di debiti vengono cancellati. I creditori (perlopiù società di servizi e finanziarie) devono rinunciare a qualsiasi pretesa su di lei. Anna esce così da un incubo di lettere di diffida e decreti ingiuntivi che le arrivavano in Italia. Dovrà solo, nei 4 anni successivi, comunicare se le pervenisse qualche sostanza (poco probabile). Dopo 4 anni, anche quell’obbligo cessa e la procedura si considera definitivamente chiusa. Anna, pur non avendo pagato nulla, ha potuto rinascere economicamente, il che ha una valenza sociale positiva (in Italia e dovunque si trovi).
Va sottolineato che questa procedura, essendo relativamente nuova, ha visto le prime applicazioni pratiche nel 2021-2022 e la giurisprudenza si sta formando. Alcuni tribunali hanno concesso il beneficio con prudenza, altri hanno rigettato domande ritenendo non provata l’incapienza “assoluta”. Ad esempio, il Tribunale di Milano (30 settembre 2022) ha puntualizzato che lo stato di incapienza va considerato attuale e che mere eventualità di miglioramento futuro (senza basi) non devono precludere l’accesso. Dunque, il giudice deve fotografare la realtà corrente, non quella ipotetica. Inoltre, si discute se un debitore incapiente possa scegliere invece la liquidazione controllata: la dottrina nota che se ha anche pochi beni, forse è preferibile liquidarli formalmente per poi esdebitarsi, riservando l’esdebitazione incapiente ai casi di zero assoluto . Il CCII lascia al debitore la scelta, ma un debitore con qualche utilità (anche minima) non è tecnicamente incapiente, per cui in linea teorica dovrebbe percorrere la liquidazione. Chiaro che su queste soglie di valutazione incide la discrezionalità del tribunale.
Importante per il residente estero: L’esdebitazione incapiente di un residente all’estero segue le stesse regole: competenza a Roma salvo collegamento altrove, e necessità di legami con l’Italia (debiti verso soggetti italiani). È uno strumento utile, ad esempio, per italiani emigrati che abbiano lasciato in patria debiti e non possano oggettivamente pagare. Invece di restare per sempre inseguiti da quei debiti (che magari impediscono un rientro o generano pignoramenti su eventuali eredità future in Italia), possono chiudere i conti legalmente ottenendo la remissione totale. Dal punto di vista dei creditori, come detto, è un duro colpo; ma dal punto di vista del sistema economico, liberare una persona dalla trappola dei debiti produce benefici (la persona potrà, ad esempio, aprire un’attività all’estero o anche in Italia se tornasse, senza zavorre, contribuendo di nuovo all’economia) .
Fin qui abbiamo esposto le quattro principali procedure previste. Prima di passare agli aspetti pratico-procedurali e alle FAQ, proponiamo una tabella riepilogativa che confronta le caratteristiche di Piano del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata ed Esdebitazione incapiente:
| Procedura | Destinatari | Modalità | Durata indicativa | Consenso dei creditori | Esdebitazione finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano del consumatore (artt. 67-73 CCII) | Consumatori (persone fisiche non fallibili con debiti personali). Esempio: privato, lavoratore dipendente, pensionato con debiti bancari. | Ristrutturazione dei debiti su proposta del debitore, basata su pagamento parziale/dilazionato secondo le possibilità. Nessuna liquidazione integrale dei beni, salvo quanto previsto dal piano. Il giudice omologa se il piano è fattibile e il debitore è meritevole. OCC coinvolto per relazione. | Variabile. Spesso 3-5 anni di pagamenti rateali; può essere più lungo in casi particolari (alcuni piani eccezionali arrivano a 10-15 anni). Obiettivo: durata ragionevole per permettere al debitore di adempiere senza eccedere la sostenibilità. | Non richiesto. I creditori non votano il piano. Possono presentare osservazioni o opposizioni, ma la decisione è del Tribunale. Il giudice valuta convenienza e meritevolezza e può omologare anche con il dissenso totale dei creditori. | Sì, dopo completa esecuzione del piano il debitore è liberato dai debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione è decretata dal Tribunale a fine piano (non occorre domanda separata). Eventuali debiti esclusi per legge (alimenti, risarcimenti, multe) restano dovuti. |
| Concordato minore (artt. 74-83 CCII) | Debitori non consumatori non assoggettabili a fallimento: imprenditori minori, professionisti, start-up, imprese agricole sotto-soglia, enti non profit, ecc.. Esempio: artigiano indebitato, professionista con debiti fiscali e fornitori. | Accordo con i creditori su proposta del debitore, che può prevedere continuazione dell’attività (concordato in continuità) o cessazione con liquidazione beni (concordato liquidatorio). Richiede voto dei creditori e omologazione giudiziale. Permessa grande flessibilità (classi di creditori, falcidie, apporto di terzi) ma con obbligo di trattamento non inferiore alla liquidazione alternativa. | ~5 anni circa se in continuità (piani di rientro pluriennali), eventualmente fino a 6 anni in casi motivati. Se liquidatorio, durata dipende dalla vendita beni (simile a liquidazione, 2-3 anni). La legge mira a contenere la durata entro limiti ragionevoli (richiamo al principio di durata ragionevole del processo). | Sì, richiesto. Il concordato vincola tutti solo se approvato dai creditori con le maggioranze di legge (almeno 50% o 60% dei crediti, a seconda della norma applicabile). I creditori votano sulla proposta; i non votanti si considerano dissenzienti. Il tribunale omologa in caso di maggioranza favorevole e assenza di irregolarità, anche contro il parere della minoranza dissenziente (c.d. cram-down, salvo opposizioni fondate). | Sì, al termine dell’esecuzione del concordato il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residuali. L’omologa stessa non libera i coobbligati/fideiussori (salvo previsione contraria nel piano), ma libera il debitore principale. Se il debitore non adempie agli obblighi concordatari, l’omologa può essere revocata su istanza dei creditori e si può aprire liquidazione. |
| Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) | Qualunque sovraindebitato non fallibile (consumatore o meno) che non sia in grado di proporre o attuare un piano/accordo soddisfacente. Esempio: soggetto con troppi debiti rispetto al reddito, o con patrimonio liquidabile ma debiti eccedenti il valore, oppure che non ottiene l’accordo dei creditori sul piano. | Procedura concorsuale liquidatoria: il Tribunale apre la liquidazione, nomina un Liquidatore che vende tutti i beni del debitore e ripartisce il ricavato ai creditori secondo prelazioni. Il debitore è spossessato dei beni (salvo quelli impignorabili per legge) e tenuto a collaborare. È simile al fallimento ma per soggetti minori, sotto controllo OCC. Nessun pagamento parziale volontario: si liquidano forzatamente gli asset disponibili. | Dipende dall’attivo: circa 2-4 anni in media. Il CCII prevede che dopo 4 anni gli effetti esdebitatori scattino comunque. Spesso la gran parte delle attività si completa entro 2-3 anni (vendita beni, riparti). Dopo 3 anni, il tribunale può già pronunciarsi su esdebitazione anche se la procedura non è formalmente chiusa . | Non applicabile. Non c’è voto dei creditori: la liquidazione è disposta dal Tribunale su richiesta del debitore (o di creditori/PM in certi casi) e segue le regole concorsuali imperative. I creditori partecipano tramite insinuazione al passivo e ricevono quota di riparto, ma non devono approvare nulla. Possono semmai opporsi a decisioni del giudice (es. contestare uno stato passivo). | Sì, prevista di norma dopo 3 anni dall’apertura (esdebitazione “automatica” previa verifica meritevolezza). In ogni caso, a fine liquidazione o decorso il termine, il debitore onesto ottiene il decreto di esdebitazione che lo libera dai debiti insoddisfatti . Clausola: se entro 4 anni dal decreto esdebitazione sopravvengono utilità ≥10% dei debiti, il debitore deve pagare i creditori fino a tale soglia (obbligo di comunicazione annuale delle sopravvenienze). |
| Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) | Persona fisica totalmente incapiente (senza beni né reddito disponibile) e meritevole (no frode o colpa grave). Esempio: disoccupato nullatenente con debiti personali, che non potrebbe offrire nulla in un piano né in liquidazione. | Cancellazione dei debiti senza alcuna ripartizione, concessa dal Tribunale su istanza del debitore. Non è un vero e proprio “concordato” né una liquidazione: è un provvedimento di clemenza civile verso il debitore incolpevole. Il giudice valuta la documentazione, può sentire l’OCC o il debitore, quindi emette decreto di esdebitazione se tutti i requisiti sono soddisfatti. I creditori non ricevono nulla (salvo eventuali pagamenti simbolici già avvenuti). | Breve: il tempo tecnico per l’istruttoria. In media 2-3 mesi dal deposito all’emissione del decreto, potendo variare a seconda del tribunale. Non c’è fase esecutiva poiché non ci sono beni da liquidare. Gli effetti per i creditori sono immediati dal decreto. | Non previsto. I creditori non votano né possono opporsi in forma decisoria. Vengono al più sentiti per osservazioni. Il tribunale decide d’ufficio in camera di consiglio. Il ruolo dei creditori è marginale poiché la logica è tutelare il debitore meritevole e la collettività (evitando persone schiacciate dai debiti senza via d’uscita) . | Sì, immediata col decreto di accoglimento: il debitore è esdebitato da tutti i debiti antecedenti. Clausola: se entro 4 anni dal decreto sopraggiungono beni/redditi sufficienti a pagare almeno il 10% dei vecchi debiti, rimane l’obbligo per il debitore di pagare i creditori fino a quel limite. Il giudice indica le modalità e tempi per la dichiarazione annuale delle sopravvenienze e l’OCC vigila. Il beneficio può essere revocato se il debitore non presenta le dichiarazioni annuali o nega l’eventuale pagamento dovuto su sopravvenienze. (Non è ammessa una seconda esdebitazione incapiente: beneficio unico in vita). |
(Legenda: OCC = Organismo di Composizione della Crisi; COMI = Centro principale interessi del debitore; Ipoteca giudiziale = garanzia iscritta dopo azione legale; bold = punto di attenzione)*
Iter procedurale: come avviare una procedura di sovraindebitamento (passo per passo)
Dopo aver individuato quale procedura si confà alla propria situazione, il debitore (anche se residente all’estero) deve attivarsi concretamente. L’iter procedurale può sembrare complesso, ma è di fatto articolato in due fasi: una prima fase stragiudiziale seguita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), e una seconda fase giudiziale davanti al Tribunale competente. Di seguito illustriamo i passaggi fondamentali comuni (con alcune differenze tra procedura e procedura) e forniamo consigli pratici, specialmente per chi opera dall’estero.
1. Scelta e contatto dell’OCC competente: In base alla residenza/centro interessi del debitore, occorre individuare un Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente. L’OCC è un organismo pubblico o privato iscritto in apposito registro ministeriale, abilitato a gestire queste procedure . Solitamente, presso ogni Tribunale o Ordine professionale c’è almeno un OCC. Ad esempio, esiste l’OCC dell’Ordine dei Commercialisti locale, oppure OCC costituiti da associazioni di consumatori. Per il debitore residente all’estero, come visto, la competenza spesso sarà del Tribunale di Roma; quindi è opportuno rivolgersi a un OCC con sede nel distretto di Roma. Tuttavia, la norma non vieta di rivolgersi anche a OCC di altro distretto, purché poi la domanda sia presentata al tribunale corretto. Nella pratica, molti OCC agiscono per territorio: un OCC romano di solito segue casi afferenti al circondario di Roma. In caso di dubbio, si può consultare l’elenco nazionale degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia. Il debitore può liberamente scegliere l’OCC (non è obbligato a uno specifico), contattandolo via telefono/email. Sul sito di ogni OCC si trovano indicazioni per l’“istanza di gestione della crisi da sovraindebitamento”.
2. Istanza all’OCC e nomina del Gestore della crisi: Il debitore presenta formale domanda di apertura della procedura all’OCC, compilando modulistica con i propri dati, l’indicazione della procedura desiderata (piano, concordato o liquidazione) e allegando una prima documentazione base (documento identità, codice fiscale, stato di famiglia, ultime dichiarazioni dei redditi se esistenti, elenco dei principali debiti, ecc.). All’atto della domanda all’OCC, solitamente si paga una piccola quota di iscrizione o acconto sui compensi (alcuni OCC chiedono un anticipo di qualche centinaio di euro). Entro pochi giorni (la legge indicava 7 giorni in alcune disposizioni), l’OCC verifica la competenza e nomina un Gestore della crisi (solitamente un professionista iscritto all’albo dei gestori, come un commercialista o un avvocato formati in materia). Il Gestore diventerà il punto di riferimento del debitore: colui che lo aiuterà a predisporre la proposta, raccogliere i documenti e redigere la relazione particolareggiata da allegare al ricorso.
3. Raccolta documentazione e analisi della posizione debitoria: Questa è una fase cruciale. Il debitore deve fornire al Gestore tutta la documentazione che fotografa la sua situazione economica e patrimoniale. In particolare:
– Elenco completo di tutti i creditori e relativi importi dovuti, indicando se vi sono cause pendenti o titoli esecutivi (es.: banca X €…, Agenzia Entrate cartella n… €…, privato Y con scrittura privata €…, ecc.). Il Gestore spesso richiede di acquisire le visure nei registri (es. centrale rischi finanziaria, banche dati tribunali per cause esecutive, Agenzia delle Entrate-Riscossione per cartelle). Anche i creditori futuri noti (es. fideiussioni escusse) vanno indicati.
– Elenco e documenti dei beni di proprietà: immobili (visure catastali e ipotecarie), autoveicoli (visura PRA), conti correnti e depositi (estratti conto ultimi 1-2 anni), partecipazioni societarie, polizze assicurative con valore riscatto, ecc.
– Documenti sui redditi e spese: ultime dichiarazioni dei redditi (o modelli Redditi/730), ultime buste paga o cedolini pensione, eventuali sussidi, ISEE. Nonché elenco delle spese correnti (affitto, utenze, spese mediche, mantenimento figli) per valutare la parte di reddito disponibile per i creditori.
– Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi anni: vendite di immobili o beni rilevanti fatti negli ultimi 5 anni devono essere segnalati (il Gestore deve valutarne la eventuale revocabilità o se sono atti in frode).
– Situazione familiare: composizione del nucleo, presenza di persone a carico, condizioni di salute particolari (ad es. se il debitore o un familiare è invalido, ciò può incidere sulle sue spese e sulla valutazione di meritevolezza).
Il Gestore esamina tutto e verifica la completa esposizione: è suo compito assicurarsi che nessun debito venga occultato e che il patrimonio dichiarato sia veritiero. In parallelo, come accennato, l’OCC invia comunicazioni agli enti fiscali (Agenzia Entrate, INPS, ecc.) per avere la situazione aggiornata dei debiti tributari del debitore.
4. Predisposizione della proposta di soluzione e della Relazione dell’OCC: Sulla base dei dati raccolti, il debitore con l’aiuto del Gestore elabora una proposta di piano (se consumatore) o di concordato (se non consumatore) ovvero predispone gli atti per la liquidazione controllata. Il Gestore redige la sua Relazione particolareggiata (obbligatoria ex lege) in cui descrive: le cause dell’indebitamento, la diligenza o meno del debitore nel contrarre i debiti e nel comportarsi verso i creditori, l’eventuale solvibilità o creditworthness violata dalle banche (nel caso del consumatore: riferisce se ci sono state concessioni di credito irresponsabili), l’attestazione sulla fattibilità del piano e sull’esaustività delle informazioni. In pratica la Relazione dell’OCC è un documento chiave: deve dare al giudice un quadro chiaro e garantire che il debitore non abusa della procedura. Ad esempio, in caso di piano del consumatore la relazione conterrà un giudizio sulla meritevolezza (il Gestore segnalerà se a suo avviso ci sono indizi di colpa grave o frode) e sulla convenienza del piano per i creditori rispetto ad alternative. Se si tratta di concordato minore, la relazione evidenzierà come la proposta soddisfa il requisito di legge (ad esempio presenza di continuità o apporto esterno se liquidatorio). Nel caso di liquidazione, la relazione elenca l’attivo e passivo e dichiara che la liquidazione è preferibile ad altre soluzioni. Una volta completata bozza di proposta e relazione, il debitore la rivede insieme al Gestore, si apportano eventuali correzioni (es. il giudice potrebbe in fase pre-deposito, informalmente tramite OCC, suggerire modifiche per migliorare fattibilità).
5. Deposito del ricorso in Tribunale: Raggiunto un accordo sulla proposta, l’OCC notifica ai creditori (solo per il concordato? In passato per l’accordo serviva lettera ai creditori prima del deposito; ora il CCII prevede che la comunicazione ai creditori avvenga dopo il deposito, a cura del Tribunale per convocarli in udienza o per votare). Comunque, il ricorso va depositato al Tribunale competente (come individuato, es. Roma se debitore all’estero) con tutta la documentazione: ricorso introduttivo firmato dal difensore del debitore (è consigliabile farsi assistere da un avvocato per la fase giudiziale), la proposta di piano/accordo, la relazione dell’OCC, gli allegati (elenco creditori, inventario beni, attestati vari). Al deposito, occorre pagare il contributo unificato ridotto (circa €98 se consumatore, €259 se no, queste cifre possono variare leggermente) e la marca da bollo come per le procedure concorsuali. Si apre così ufficialmente la procedura presso il Tribunale.
6. Fase giudiziale: ammissione, misure protettive e omologazione: Ricevuto il ricorso, il Tribunale (in composizione monocratica o collegiale a seconda dei casi, di solito monocratica per piano/concordato minore) verifica la documentazione e concede immediatamente le misure protettive richieste dal debitore. Come già spiegato, la presentazione della domanda sospende di diritto le esecuzioni pendenti (art. 54 CCII e art. 69 co.4 CCII per sovraindebitamento). Il Tribunale emette un decreto che, tra l’altro, ordina la sospensione di pignoramenti in corso e il blocco di nuove azioni. Ad esempio, se c’era un’asta sulla casa fissata, viene sospesa. Inoltre dispone la comunicazione ai creditori: nel piano del consumatore il giudice fissa direttamente udienza di omologazione e i creditori possono entro un termine inviare osservazioni scritte; nel concordato minore, dispone l’apertura della votazione (che può avvenire in udienza o per mezzi telematici inviando la scheda di voto ai creditori). In liquidazione, il provvedimento di apertura nomina il liquidatore e fissa termini per insinuare i crediti.
Durante questa fase, il debitore e l’OCC devono attenersi alle prescrizioni del giudice. È possibile che il giudice chieda integrazioni (es. un chiarimento su un credito contestato). Se tutto è regolare, si giunge all’udienza di omologazione (per piano/concordato) oppure alla fase di approvazione dello stato passivo (per liquidazione). Nell’udienza di omologa del piano del consumatore, il giudice valuta meritevolezza e convenienza: se non emergono opposizioni fondate, dichiara omologato il piano. Nel concordato minore, se il voto ha raggiunto la maggioranza, il giudice esamina eventuali opposizioni di creditori dissenzienti e decide se omologare (può rifiutare l’omologa solo se la proposta viola la legge o è fraudolenta o se il credito del dissenziente avrebbe avuto soddisfacimento migliore altrimenti, cosa difficile da dimostrare se c’è il voto favorevole della maggioranza). Una volta emesso il decreto di omologazione (o sentenza, la forma varia), questo viene comunicato a tutti i creditori. Da quel momento il piano/concordato diventa vincolante erga omnes .
Nell’ipotesi in cui il giudice non omologhi – ad esempio scopre che il debitore ha falsificato dati (malafede), oppure nel concordato i creditori respingono la proposta – può chiudere la procedura di conseguenza: se c’è malafede o frode la chiude senza omologa (e i creditori tornano liberi di agire, anzi spesso manda atti al PM per bancarotta fraudolenta se del caso); se invece semplicemente i creditori non hanno approvato, di solito il tribunale, d’ufficio o su istanza del debitore, dichiara aperta la liquidazione controllata (convertendo la procedura).
7. Esecuzione della procedura: Dopo l’omologazione del piano o concordato, si passa alla fase esecutiva:
– Nel piano del consumatore: il debitore inizia a effettuare i pagamenti promessi (ad esempio versamenti mensili di una somma all’OCC o direttamente ai creditori secondo quanto stabilito). L’OCC monitora l’esecuzione e redige relazioni periodiche. Se il piano prevedeva vendite di beni, l’OCC può sovrintendere a tali vendite (o nominare un liquidatore ausiliario). Il debitore deve attenersi alle direttive: qualsiasi scostamento significativo deve essere autorizzato dal giudice (ad es. se il debitore ritarda qualche pagamento, va segnalato per evitare decadenze). Se nel corso dell’esecuzione il debitore dovesse migliorare la propria condizione, non è obbligato a offrire di più ai creditori di quanto stabilito, ma se dovesse peggiorare può chiedere una modifica del piano (art. 71 CCII prevede la possibilità di modifiche in caso di eventi imprevedibili, previa nuova valutazione del tribunale). Se il debitore viene meno agli obblighi senza giustificazione, i creditori o l’OCC possono segnalare la risoluzione del piano: il tribunale dichiarerebbe risolto il piano e i creditori riacquisterebbero le facoltà di recupero per le somme residue.
- Nel concordato minore: l’esecuzione è simile. Se è in continuità, il debitore prosegue la sua attività sotto vigilanza; se è liquidatorio, occorre procedere alle cessioni di beni come concordato. Spesso il giudice nomina un liquidatore ad acta per vendere i beni, oppure delega l’OCC stesso. I creditori ricevono i pagamenti nelle percentuali approvate. Può esserci un commissario giudiziale nominato (non obbligatorio nel concordato minore, ma se l’attività prosegue, il tribunale può nominare un professionista che vigili oltre all’OCC). La disciplina delle modifiche/risoluzione è analoga: se il debitore non paga le percentuali promesse ai creditori entro i termini previsti, il concordato viene risolto su istanza e i crediti tornano esigibili per intero (dedotto quanto ricevuto). Anche qui, però, è prassi prevedere un margine di tolleranza e la possibilità di proroghe moderate (il tribunale può concedere proroghe fino a 6 mesi per completare i pagamenti, in caso di difficoltà temporanee, come stabilito per il concordato preventivo e applicabile anche al minore per analogia).
- Nella liquidazione controllata: dopo l’apertura, il liquidatore svolge tutto il lavoro: vendite, riparti, ecc. Il debitore durante l’esecuzione della liquidazione è meno coinvolto, se non per la collaborazione (ad esempio, presentare ogni sei mesi l’aggiornamento sulle sue condizioni, segnalare eventuali entrate straordinarie, ecc.). Il liquidatore predisporrà uno schema di riparto dei fondi man mano realizzati, che il giudice approva e rende esecutivo per pagare i creditori. Il debitore potrebbe proporre egli stesso soluzioni per massimizzare l’attivo (es. trovare un acquirente per la casa a un prezzo migliore di quello d’asta). Tutte queste attività seguono la normativa concorsuale. Una volta esaurite, il liquidatore presenta conto finale e piano di riparto finale. Il tribunale dichiara chiusa la liquidazione.
- Nell’esdebitazione incapiente: non c’è fase esecutiva, in quanto una volta emesso il decreto di esdebitazione la procedura si limita alla vigilanza quadriennale sulle sopravvenienze come detto. Il debitore deve solo ricordarsi di presentare la dichiarazione annuale di sopravvenienze (se negative, ossia se nulla è cambiato, basterà dichiarare che non ha ricevuto utilità; se positive, quantificare l’importo ecc.). L’OCC verifica l’adempimento. Dopo 4 anni senza eventi, la procedura si considera definitivamente conclusa. Se invece c’è stata una sopravvenienza rilevante, il debitore dovrà aver ottemperato al pagamento parziale dovuto, altrimenti i creditori possono ricorrere al tribunale per far revocare l’esdebitazione (anche se la legge non dettaglia, è implicito che il mancato rispetto dell’obbligo comporti la revoca del beneficio, come pure la mancata dichiarazione annuale comporta revoca ex lege).
8. Chiusura e riabilitazione: Al completamento dell’iter, il risultato finale auspicato è la piena liberazione del debitore dai debiti passati (salvo quelli esclusi ex lege). Il tribunale emette un provvedimento conclusivo (decreto di esdebitazione e chiusura) che permette al debitore di non essere più perseguitabile per quei debiti. Da quel momento il debitore può anche richiedere la cancellazione delle segnalazioni nelle banche dati creditizie (CRIF, ecc.), presentando copia del decreto di omologa/esdebitazione: infatti, la normativa prevede la “riabilitazione” del soggetto, che torna ad essere economicamente attivo. Ad esempio, se aveva un protesto, potrà chiedere la riabilitazione in tribunale dopo 1 anno dall’esdebitazione; se era segnalato come cattivo pagatore, può far aggiornare la propria posizione con la dicitura che i debiti sono stati regolati con procedura di sovraindebitamento.
Nota sulla fiscalità: i debiti cancellati con sovraindebitamento non producono un reddito tassabile per il debitore. In genere, lo stralcio di debito potrebbe essere considerato fiscalmente sopravvenienza attiva, ma una specifica norma (art. 88, co.3 ter TUIR) esenta da imposizione i redditi derivanti da piani di risanamento omologati e procedure concorsuali minori. Dunque il debitore non deve temere di ricevere cartelle per “tasse” sui debiti condonati (fatto salvo che se dei debiti fiscali stessi vengono stralciati, su quelli non c’è tassazione ovviamente, essendo imposte non pagate).
Il ruolo dell’avvocato: sebbene la legge consenta al debitore di presentare il ricorso personalmente tramite OCC, è altamente consigliato farsi assistere da un avvocato esperto in procedure concorsuali per la fase giudiziale, specie per un debitore residente all’estero che potrebbe non poter partecipare di persona alle udienze. L’avvocato curerà la redazione del ricorso, dialogherà con il tribunale, affiancherà l’OCC e rappresenterà il debitore in udienza (il debitore può anche non comparire, se rappresentato). I costi legali possono essere concordati forfettariamente; considerato il fine sociale, molti professionisti praticano onorari calmierati. Va però calcolato tra le spese complessive (ad esempio nella procedura, il compenso OCC è prededucibile e così anche l’eventuale compenso legale se concordato all’interno della procedura).
Assistenza consolare: se il debitore risiede all’estero e ha difficoltà linguistiche o logistiche, può cercare supporto anche presso i Consolati italiani, i quali possono fornire informazioni di base sui diritti degli italiani all’estero e segnalare professionisti bilingue quando necessario. Ad ogni modo, molte fasi (raccolta documenti, comunicazioni) possono essere gestite via email/PEC e videochiamate con OCC e legale, riducendo la necessità di presenza fisica in Italia. Solo se è prevista un’audizione personale del debitore (ad esempio il giudice vuole interrogarlo per chiarimenti in un caso complesso), potrebbe rendersi necessario un viaggio per presenziare, ma spesso queste procedure si concludono senza che il debitore debba comparire di persona, specialmente se ben documentate.
Domande frequenti (FAQ) sulla procedura di sovraindebitamento per residenti all’estero
D: Un cittadino italiano residente all’estero può accedere alla legge sul sovraindebitamento?
R: Sì, può accedere a condizione che esistano legami giuridici o economici con l’Italia (come debiti verso enti o persone in Italia, beni situati in Italia, ultime residenze in Italia, ecc.). La normativa vigente (art. 27 CCII) prevede espressamente che se il centro degli interessi principali del debitore è all’estero, la competenza per la procedura è attribuita al Tribunale di Roma. In pratica, il debitore residente all’estero dovrà presentare la domanda a Roma, fornendo prova dei suoi collegamenti con l’Italia (es.: contratti, proprietà o altre relazioni). Se invece mantiene un domicilio o sede di affari in Italia, può presentarla al tribunale di quel luogo. Non è più richiesto di avere la residenza anagrafica in Italia: è sufficiente individuare un riferimento territoriale. Di fatto, oggi anche iscritti AIRE e italiani emigrati possono ottenere l’esdebitazione in Italia, evitando di restare per sempre debitori insolventi.
D: Come individuare il tribunale competente se vivo all’estero?
R: Se non hai né residenza né domicilio in Italia, sarà competente il Tribunale di Roma (foro previsto ex lege). Se hai ancora un domicilio, un ultimo indirizzo di residenza in Italia, o beni di rilievo in una certa città, potrebbe essere competente il tribunale di quel luogo qualora lo si possa considerare tuo “centro di interessi”. In dubbio, è preferibile rivolgersi al Tribunale di Roma, che funge da foro generale per i residenti all’estero. Nota che la competenza non incide negativamente sull’esito: è solo una questione di dove depositare. L’importante è presentare la domanda nel foro giusto per evitare eccezioni procedurali.
D: Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e come lo contatto dall’estero?
R: L’OCC è fondamentale: è l’ente che istruisce la tua pratica, nomina un Gestore della crisi e redige la relazione per il tribunale . Per contattarlo, puoi cercare online gli OCC del tribunale competente (es. per Roma: OCC istituiti dall’Ordine dei Commercialisti di Roma, OCC di associazioni convenzionate, etc.). Molti OCC hanno siti web con form di contatto e accettano domande via email/PEC. Dall’estero potrai comunicare via email, inviare scansioni dei documenti e, se richiesto, spedire originali. Assicurati di fornire un recapito PEC o email che controlli spesso, poiché le comunicazioni ufficiali possono avvenire lì. Se hai difficoltà linguistiche, scegli un OCC dove operino professionisti che parlano la tua lingua oltre l’italiano (in città grandi come Roma e Milano non è difficile trovare Gestori che parlano inglese, ad esempio). Tieni presente che il Gestore potrà svolgere incontri con te anche tramite videochiamata se necessario, quindi non è obbligatorio rientrare in Italia per ogni passaggio.
D: Quali debiti posso inserire nella procedura? Anche i debiti fiscali verso l’Italia?
R: Vanno inclusi tutti i debiti che hai al momento della presentazione, nessuno escluso, a prescindere dalla natura (bancari, finanziari, fornitori, personali, fiscali, verso l’Inps, verso privati, ecc.). L’unica distinzione è che alcuni debiti non potranno essere cancellati neanche a fine procedura: in particolare le obbligazioni alimentari (es. assegni di mantenimento dovuti all’ex coniuge o ai figli), le sanzioni penali o amministrative per illecito (multe stradali, ammende penali) e i debiti da risarcimento danni per fatti illeciti (es. danni da reato) restano in linea di principio esclusi dall’esdebitazione. Ciò significa che vanno comunque elencati e, se possibile, pagati almeno in parte, ma alla fine della procedura quei specifici creditori conserveranno (per la parte impagata) il loro credito – salvo che il giudice valuti diversamente in casi peculiari. Invece tutti i debiti “ordinari” (prestiti, mutui, bollette, fornitori, carte di credito, scoperti di conto, canoni, leasing, ecc.) rientrano a pieno titolo e possono essere ridotti/stralciati. Anche i debiti erariali (Agenzia Entrate Riscossione) rientrano: è espressamente previsto che i debiti tributari possono essere falcidiati nelle procedure di sovraindebitamento. In passato era necessario il parere dell’ente per accettare un pagamento parziale, oggi il giudice può omologare anche senza il consenso del Fisco, purché il trattamento del credito fiscale sia conforme alla legge (ad esempio l’IVA e le ritenute non versate vanno comunque soddisfatte almeno in misura pari a quanto otterrebbero su liquidazione, secondo giurisprudenza). Inoltre, esistono state norme (L.145/2018, “saldo e stralcio”) che hanno favorito l’abbinamento fra sovraindebitamento e stralcio fiscale, permettendo in certe condizioni di ridurre fortemente i debiti fiscali di persone in difficoltà (ad esempio pagando solo il 10% di alcune cartelle con ISEE basso). Quindi sì, anche le cartelle e i debiti con Agenzia Entrate/Equitalia possono essere gestiti, e tipicamente l’ADER si adegua ai piani approvati dal giudice.
D: Cosa succede ai pignoramenti in corso una volta avviata la procedura?
R: La presentazione della domanda di sovraindebitamento comporta la sospensione automatica di tutte le procedure esecutive individuali pendenti. Questo è un beneficio immediato: appena il ricorso viene registrato dal tribunale, il giudice emette un provvedimento che dispone il blocco dei pignoramenti e delle aste in corso. Ad esempio, se avevi la casa all’asta, l’asta viene rinviata e, in caso di omologazione del piano, definitivamente annullata (perché i creditori saranno soddisfatti nelle forme del piano). Se il pignoramento riguardava lo stipendio o la pensione, il giudice può ordinare al datore di lavoro o ente pensionistico di sospendere le trattenute alla fonte (tipicamente lo fa con l’omologa del piano del consumatore). Nel concordato minore e nella liquidazione controllata, analogamente, il debitore ottiene sollievo: i creditori non possono iniziare nuove esecuzioni né proseguirle su autorizzazione del giudice delegato (tutto confluisce nella procedura concorsuale). Attenzione però: la sospensione opera per legge con il deposito, ma è opportuno assicurarsi che i singoli agenti l’abbiano ricevuta. Sarà cura dell’OCC o del tuo avvocato notificare ai vari Ufficiali giudiziari e creditori il provvedimento di sospensione. Così, ad esempio, la banca creditrice ritirerà l’istanza di vendita all’asta, ecc. In sintesi, la procedura di sovraindebitamento ti mette al riparo dai creditori durante la negoziazione e, se tutto va bene, in modo permanente dopo l’omologa.
D: Devo essere presente personalmente alle udienze in Italia?
R: Nella maggior parte dei casi no, non è necessaria la tua presenza fisica. Puoi farti rappresentare dal tuo avvocato e dal Gestore dell’OCC. Il tribunale di solito decide sulla base degli atti e delle relazioni. Potrebbe esserci un’udienza (soprattutto se i creditori fanno opposizione) ma il debitore raramente viene interrogato di persona. Tuttavia il giudice può disporre la tua audizione se lo ritiene utile: ad esempio, per chiarire certe spese o movimenti finanziari sospetti. Questo accade di rado e di solito in contesti di dubbia meritevolezza, ma va messo in conto. Se vivi lontano e comparire di persona è gravoso, il tuo avvocato può chiedere di svolgere l’audizione da remoto (molti tribunali post-Covid accettano collegamenti via Teams o Skype per sentire parti all’estero in procedimenti civili). Quindi, ancor più in periodo attuale, la telematizzazione aiuta: potresti partecipare a distanza. Soltanto nella liquidazione, se dovessi essere convocato per il vero e proprio interrogatorio formale sullo stato d’insolvenza (simile all’interrogatorio del fallito), sarebbe preferibile essere presenti, ma anche qui alcuni giudici ammettono dichiarazioni scritte se il debitore è impossibilitato a venire. In pratica, molti debitori AIRE completano la procedura senza mai rientrare, coordinando tutto attraverso professionisti locali.
D: Cosa succede se, dopo l’esdebitazione, ereditassi dei beni o migliorassi la mia condizione economica?
R: Dipende dal quando avviene e dal quantum. Durante la procedura e fino alla sua chiusura, se la tua condizione migliora (es. trovi un lavoro ben pagato), devi comunicarlo: potrebbe essere necessario modificare il piano offrendo un po’ di più ai creditori o revocare in parte l’esdebitazione incapiente se il miglioramento è immediato. Dopo la chiusura della procedura, valgono le regole viste: c’è un periodo di “controllo” di 4 anni per eventuali sopravvenienze. Se ad esempio entro 4 anni dall’esdebitazione ricevi un’eredità consistente, la legge dice che resta obbligato a pagare i creditori fino al 10% dei loro crediti originari. Quindi dovrai destinare una parte di quell’eredità (o vincita, o altro arricchimento) a saldare i vecchi creditori almeno in misura del 10%. Se l’eredità è enorme tanto da poter pagare tutti, moralmente dovresti farlo ma legalmente sei tenuto solo fino a quel 10%. Oltre i 4 anni, invece, qualsiasi tua sopravvenienza è interamente tua: i creditori non possono più vantare nulla, neanche parzialmente. Facciamo un esempio: Tizio aveva €100k di debiti, ottiene esdebitazione incapiente nel 2025. Nel 2026 vince alla lotteria €50k: deve informare il giudice e destinare €10k ai creditori (il 10%). Nel 2030 (oltre 4 anni) vince altri €100k: questi restano tutti a Tizio senza obblighi, perché il periodo di “condizionalità” è scaduto. È come se passati quattro anni il beneficio diventasse definitivo e inoppugnabile. Da notare: se invece la tua procedura era un piano o concordato già eseguito, non c’è alcuna condizione futura – hai pagato ciò che dovevi e fine. L’unica situazione con vincolo post è appunto l’esdebitazione a costo zero e, in parte, la liquidazione (anch’essa prevede quel vincolo quadriennale). In ogni caso, la soglia del 10% funge da limite: se i creditori avevano già avuto il 10% o più durante la procedura, non sei tenuto a dar loro altro (quindi un miglioramento successivo è solo fortuna tua). Se invece avevano avuto meno del 10%, fino a colmare quell’importo sei impegnato.
D: Posso accedere di nuovo alla procedura se in futuro dovessi indebitarmi ancora?
R: Riaccedere non è semplice: l’obiettivo del legislatore è dare una seconda chance, ma non una terza, quarta, ecc. In particolare, per l’esdebitazione incapiente la legge è chiara: si può ottenere una volta sola nella vita. Dunque se hai già beneficiato di quella, non potrai chiederla di nuovo. Per il piano del consumatore o concordato minore, la legge non pone un divieto espresso di reiterazione, ma prevede che non si possa accedere se si è già avuta un’esdebitazione nei 5 anni precedenti (regola che c’era nella L.3/2012 e credo mantenuta: l’art. 69 CCII include il divieto se il debitore ha già ottenuto esdebitazione negli ultimi 5 anni). Quindi, ad esempio, se nel 2025 completi una procedura e sei esdebitato, fino al 2030 non potrai presentarne un’altra. E comunque, se hai già abusato una volta, un giudice guarderebbe con maggior rigore una tua nuova domanda. Inoltre, se la prima procedura è stata risolta o revocata per tuo inadempimento/frode, una seconda sarebbe vista con estremo sospetto. In sintesi, queste procedure vanno considerate un’occasione unica per ripartire, da non sprecare. Dopo, bisogna cercare di mantenersi solvibili, altrimenti si rischia di non avere più strumenti di sollievo. Detto ciò, se un domani – passati molti anni – avessi un nuovo sovraindebitamento (ad esempio per cause completamente diverse, come fare da garante per qualcuno), nulla vieta di chiedere un’altra procedura (salvo il caso incapiente). Ci sono casi in letteratura di persone che dopo 10-15 anni hanno usato due volte procedure simili (specie in paesi come gli USA con il Chapter 7/13 ciò accade). Ma ripeto: ogni volta sarà più difficile dimostrare la meritevolezza se ricadi nel problema.
D: Quali sono i costi da affrontare?
R: I costi principali sono: compenso dell’OCC, spese vive di giustizia (contributo unificato, bolli) e compenso dell’eventuale avvocato. L’OCC generalmente chiede un acconto iniziale modesto (ad esempio €200-400) e poi trattiene il resto del compenso all’esito (il compenso è approvato dal giudice e prelevato in prededuzione dalle somme destinate ai creditori, oppure pagato a parte dal debitore se non ci sono somme in procedura). I compensi OCC sono stabiliti per scaglioni dal DM 202/2014: variano a seconda della complessità e dell’attivo/passivo. Nelle procedure incapienti il compenso è dimezzato. Indicativamente, per situazioni semplici, il compenso finale OCC può aggirarsi tra €1.000 e €3.000. L’avvocato difensore, se ti avvali, avrà un onorario concordato (alcuni lavorano a forfait attorno a €2.000-3.000 per l’intera procedura; altri a tariffa oraria). Considera poi eventuali spese notarili se servono atti (es. se vendi un immobile nel piano, pagherai il notaio con i proventi) e spese di giustizia (in liquidazione, se c’è custodia di beni o altre formalità). In generale, rispetto ai benefici (potenzialmente decine o centinaia di migliaia di debiti cancellati), i costi vivi sono molto contenuti. Inoltre, molti OCC modulano il compenso in base alla situazione: ad esempio, se dal piano emergono risorse solo per i creditori al 5%, l’OCC potrebbe accontentarsi di un compenso ridotto. Ci sono casi in cui il compenso OCC viene addirittura pagato da un terzo benefattore quando il debitore è nullatenente. Dunque il consiglio è: non farsi spaventare dai costi iniziali. Informati presso l’OCC: spesso la prima consulenza è gratuita e forniranno un preventivo. Ricorda che c’è la possibilità del gratuito patrocinio a spese dello Stato solo per la difesa legale, se il tuo reddito (considerato il solo tuo se la controparte è l’insieme dei creditori) è sotto circa €11.700 annui: in tal caso lo Stato copre le spese dell’avvocato (ma non quelle dell’OCC). Purtroppo molti tribunali hanno opinioni discordanti sull’applicabilità del gratuito patrocinio in queste procedure – alcuni lo concedono, altri no ritenendo che non sia un “giudizio contenzioso”. Ad ogni modo, se ne hai i requisiti, vale la pena tentare.
D: Se ho già subito protesti o pignoramenti prima, la procedura di sovraindebitamento mi “pulisce” anche da quelli?
R: Sì, indirettamente. Mi spiego: la procedura non cancella di per sé i protesti (che vanno cancellati con apposita istanza una volta pagato o definito il debito) né rimuove le ipoteche iscritte (quelle volontarie restano ma se il debito viene soddisfatto o stralciato l’ipoteca viene cancellata su ordine del giudice). Tuttavia, nell’ambito dell’omologa e dell’esdebitazione, il giudice spesso ordina le cancellazioni necessarie. Ad esempio, se hai un pignoramento immobiliare trascritto, con l’omologa del piano che prevede una soluzione, il decreto d’omologa viene annotato e l’ipoteca giudiziale o il pignoramento possono essere cancellati su istanza. Se sei iscritto al CRIF come cattivo pagatore, dopo l’esdebitazione potrai inviare alle banche la copia del provvedimento e chiedere di aggiornare la tua posizione a “saldo effettuato per procedura concorsuale” (non sarà un punteggio altissimo, ma meglio di “insoluto”). Con il tempo, comunque, la tua affidabilità creditizia migliorerà. Già la legge impone che dopo l’esdebitazione l’interessato non sia discriminato nell’accesso al credito per il fatto di aver usato la procedura (art. 279 CCII). Ovviamente nella realtà le banche staranno caute, ma passati alcuni anni se hai un nuovo lavoro stabile potrai certamente ottenere finanziamenti. Molti debitori riferiscono che 2-3 anni dopo l’esdebitazione riescono ad accendere mutui o prestiti (a tassi un po’ più alti magari). Anche eventuali restrizioni come il divieto di avere carte di credito decadono: potrai tornare a far parte del sistema finanziario come un soggetto riabilitato. Se eri incappato in sanzioni penali per debiti (tipo assegni a vuoto), l’esdebitazione non cancella la sanzione ma la riabilitazione penale potrà essere più agevole mostrando di aver risolto la crisi.
D: In sintesi, qual è il vantaggio principale per un debitore residente all’estero ad usare le procedure italiane?
R: Il vantaggio è poter risolvere in modo definitivo i debiti rimasti in Italia sotto il controllo della legge e con un risultato di esdebitazione, evitando di restare in una sorta di limbo. Immagina di esserti trasferito all’estero ma di avere lasciato in Italia debiti: potresti essere tentato di ignorarli pensando “tanto vivo fuori, cosa possono farmi?”. Ma attenzione: all’interno dell’UE i creditori possono ottenere un titolo esecutivo italiano e farlo valere in altri paesi facilmente (regolamenti UE sull’esecuzione dei titoli). Anche fuori UE, se un giorno torni o se lasci beni in Italia (conto bancario, eredità che riceverai) i creditori possono aggredirli. Vivere con debiti pendenti significa poter subire pignoramenti inaspettati o vedersi negare opportunità (esempio: non puoi intestarti nulla in patria). Con la procedura di sovraindebitamento tu prendi in mano la situazione in modo proattivo, proponi una soluzione o offri il tuo patrimonio residuo e in cambio ottieni la pace legale: i creditori sono soddisfatti almeno in parte e poi non possono più cercarti per il resto . È letteralmente un nuovo inizio (“fresh start”). Molti nostri connazionali all’estero hanno utilizzato queste norme per chiudere i conti col passato e poter magari un domani rientrare senza paura di denunce o atti giudiziari. Inoltre, psicologicamente, poter risolvere la propria posizione debitoria riduce lo stress e migliora la qualità della vita, permettendo di concentrarsi sulle nuove attività all’estero senza il “peso” dei debiti pregressi. Quindi il vantaggio è sia giuridico (cancellazione legale dei debiti) sia pratico (riabilitazione economica) sia psicologico/sociale (togliersi un’etichetta di insolvente, potersi ricredere onorevolmente con i creditori pagando il possibile). Vale la pena sottolineare che tutto questo avviene sotto controllo giudiziario, quindi con la garanzia di trasparenza: non stai “scappando” dai debiti, li stai affrontando di petto e risolvendoli secondo la legge.
D: E se i miei debiti invece sono tutti all’estero (nel paese dove vivo) e non in Italia?
R: In tal caso, la legge italiana sul sovraindebitamento potrebbe non essere applicabile. Devi verificare se nel paese di residenza esiste una procedura analoga (molti paesi hanno leggi simili: ad es. la Francia ha la procédure de surendettement, il Regno Unito ha gli IVA – Individual Voluntary Arrangements e il Bankruptcy, la Germania l’Insolvenzverfahren privati, ecc.). La normativa italiana richiede comunque un collegamento con l’Italia. Se l’unico legame è la cittadinanza ma i debiti e il centro interessi sono tutti all’estero, probabilmente il tribunale italiano declinerebbe la giurisdizione. Potresti teoricamente iscriverti all’AIRE presso un comune italiano e sostenere che quell’ultima residenza italiana sia forum competente, ma se non hai creditori italiani né patrimonio in Italia la strada appare in salita. In scenari del genere, è più opportuno attivarsi nel paese estero secondo le leggi locali. Questa guida è incentrata su chi, pur essendo all’estero, è “sovraindebitato in Italia”. Se invece sei sovraindebitato all’estero e non in Italia, informati sulle procedure di quel paese – ogni ordinamento oggi ha forme di bankruptcy personale. Nulla vieta, comunque, che tu possa usare entrambe le vie: ad esempio, se hai debiti in Italia e anche all’estero, potresti dover attivare una procedura in ciascun paese per i debiti ivi accumulati, coordinandoti con professionisti di entrambi gli ordinamenti. Alcune normative riconoscono l’efficacia extraterritoriale delle procedure altrui (in UE, un piano di insolvenza in uno stato può avere effetti negli altri per i crediti lì, con il meccanismo del COMI determinante: dove hai il COMI prevalente dovrebbe farsi la procedura principale). Questo è un tema di insolvenza transfrontaliera su cui conviene ricevere consulenza specializzata, perché abbastanza complesso.
D: Le sentenze di omologa italiane sono riconosciute all’estero?
R: Sì, nell’Unione Europea vige il Regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere, che include anche le procedure di sovraindebitamento (considerate procedure di insolvenza per persone fisiche). Se la procedura italiana è aperta correttamente in base al COMI, la decisione di omologa e esdebitazione è riconosciuta in tutti gli altri Stati UE senza exequatur. Ciò significa che, ad esempio, un tuo creditore francese con un credito incluso nel piano italiano non potrà ignorare l’omologazione e continuare a perseguitarti in Francia: quell’omologazione, una volta notificata, è opponibile come titolo di “clausura” dell’obbligazione. Fuori dalla UE, dipende da convenzioni bilaterali o dalla reciprocità: ad esempio, in Svizzera potrebbe essere necessario un exequatur. Ma in linea generale, i principali paesi tendono a rispettare l’effetto esdebitativo straniero – anche perché se provassero a farti causa, tu esibirai la sentenza italiana di esdebitazione e in molti casi il giudice locale la considererà sufficiente a rigettare la pretesa (almeno per i paesi con affinità giuridica). Quindi, l’omologazione italiana ti protegge molto ampiamente.
D: Quali sono i principali motivi per cui una domanda di sovraindebitamento viene rifiutata dal tribunale?
R: I motivi tipici di rigetto o inammissibilità sono:
– Mancanza dei requisiti soggettivi: ad es. il debitore risulta invece fallibile (sfora i limiti dimensionali) o non è un consumatore quando tenta il piano come consumatore, oppure non è incapiente se chiede l’esdebitazione incapiente. Il tribunale quindi dice “procedura errata o non applicabile a te”. Questo si può prevenire analizzando bene la situazione prima.
– Difetto di competenza o giurisdizione: se sbagli tribunale (es. presenti in un tribunale che non è competente per territorio) o se il giudice ritiene che non hai sufficienti legami con l’Italia (per i residenti esteri). Il caso tipico: italiano emigrato che chiede procedura ma il giudice dice “non hai COMI qui, quindi non posso procedere”. Questo può succedere finché la prassi su art. 27 CCII non è uniformata. Comunque in tal caso potresti ripresentare al tribunale giusto (es. Roma).
– Carente meritevolezza o frode: se il giudice scopre atti in frode (es. che hai nascosto un immobile, o hai distratto soldi prima di fare la domanda) o che hai accumulato debiti con dolo (ad esempio hai truffato i creditori consapevolmente), può dichiarare inammissibile il ricorso. Nei piani del consumatore, prima del 2020 molti piani venivano rigettati perché il debitore “aveva assunto obbligazioni oltre le proprie possibilità” – oggi questo criterio è attenuato, ma resta la valutazione di colpa grave. Ad esempio, un caso tipico di colpa grave può essere: contrai 10 prestiti sapendo di non poterli restituire (a meno che non dimostri che eri vittima di circostanze eccezionali, altrimenti può essere visto come malafede). O ancora: hai dilapidato somme in gioco d’azzardo senza provare di esserti curato. Se il tribunale reputa il debitore “scientemente dissipatore” potrebbe negare l’accesso.
– Insufficiente informativa/documentazione: se non presenti tutti i documenti chiave o fornisci dati confusi, il giudice può respingere per mancanza di prova. Ad esempio: non elenchi un creditore rilevante e quello compare all’ultimo? Potrebbe bloccare tutto. Oppure non riesci a spiegare movimenti sul conto sospetti. È fondamentale essere trasparenti e completi: nessuna omissione. La guida del Gestore aiuta proprio a evitare questi errori.
– Piano non fattibile o convenienza mancante: nel caso di piano/concordato, se proponi cose irrealistiche (es. pagherò €500 al mese ma dal tuo bilancio risulta che ne hai a malapena 200 disponibili) o se offri troppo poco senza giustificazione, il giudice può non omologare. Anche se i creditori non votano (nel piano) il giudice può rifiutarsi di omologare se ritiene il piano non sostenibile o iniquo. Idem nel concordato: se per esempio un creditore dissenziente dimostra che avrebbe avuto il 50% in liquidazione e tu proponi il 20%, il giudice non omologa. Dunque la bontà economica della proposta deve esserci. Fortunatamente, con l’aiuto dell’OCC, i piani presentati sono di solito calibrati bene.
– Errori procedurali: ad esempio, dimenticare di pagare il contributo unificato, o che l’avvocato non abbia firma digitale su un atto (se telematico). Queste cose raramente portano a bocciatura se sanabili, ma vanno curate.
In definitiva, la chiave è: preparazione meticolosa, sincerità totale, supporto di professionisti competenti. Così le probabilità di successo sono alte. Le statistiche ufficiali mostrano che la maggior parte delle procedure che arrivano a omologa vengono eseguite con successo ed esdebitano i debitori, mentre quelle respinte spesso non arrivano nemmeno a deposito (il filtro OCC scarta i casi improponibili).
D: Quali sono le sentenze più importanti di recente sul sovraindebitamento?
R: Ne cito alcune che hanno segnato principi utili:
- Cassazione civile, Sez. I, 13 aprile 2022 n. 12115: ha ribadito la natura non sanzionatoria della valutazione di meritevolezza nel piano del consumatore, chiarendo che il giudice deve escludere solo colpa grave o dolo, non ogni condotta imprudente . Ha quindi avallato l’orientamento di “alleggerimento” del test di meritevolezza introdotto dalla L.176/2020.
- Cassazione civile, Sez. III, 27 luglio 2023 n. 22715: sentenza importante sui rapporti tra giudice dell’esecuzione e giudice del sovraindebitamento. Ha affermato che il giudice della procedura di sovraindebitamento non può dichiarare l’estinzione delle esecuzioni in corso prima dell’omologazione, salvo i casi espressamente previsti (nel piano del consumatore può sospendere, ma non chiudere le esecuzioni fino all’omologa definitiva). In pratica ha delineato che le misure protettive sospendono, ma la parola finale spetta poi alla sentenza di omologa. Ha inoltre chiarito che le controversie relative all’esecuzione (ad es. distribuzione somme pignorate) restano di competenza del giudice dell’esecuzione individuale finché la procedura di sovraindebitamento non è completata. Questa pronuncia ha sottolineato una separazione dei ruoli per evitare conflitti tra giudici.
- Cassazione civile, Sez. I, 27 luglio 2023 n. 22900: ha stabilito che tutti i provvedimenti di omologazione o diniego nelle procedure di sovraindebitamento sono ricorribili per cassazione (ricorso straordinario ex art.111 Cost.). Questo perché si tratta di provvedimenti aventi natura decisoria e incidente su diritti. Ciò significa che, ad esempio, un creditore insoddisfatto dall’omologa può fare ricorso in Cassazione (nei 30 giorni), o il debitore può ricorrere se gli negano l’omologa. La Cassazione sta quindi pian piano creando una giurisprudenza di legittimità su queste procedure, prima quasi assente.
- Tribunale di Forlì, 27 maggio 2021: (merita menzione) ha ammesso una procedura di accordo di composizione per un debitore residente all’estero ritenendo competente il luogo dell’ultimo domicilio comune con la moglie (in Italia), interpretando estensivamente la norma per non negare tutela. È un esempio di come i giudici di merito prima della riforma cercassero soluzioni pro-debitore. Oggi con l’art.27 CCII la soluzione è più lineare (competente Roma se niente Italia).
- Corte di Cassazione, Sez. I, 14 febbraio 2023 n. 4613: ha affrontato i presupposti di ammissibilità dell’accordo di composizione (ora concordato minore), in particolare sul tema dei debiti derivanti da attività cessate. Ha affermato che se l’attività imprenditoriale è cessata da tempo, i debiti residui possono essere trattati come sovraindebitamento e non precludono il piano del consumatore, aderendo all’interpretazione evolutiva poi codificata nel CCII.
- Cass. civ. Sez. I, 30 maggio 2023 n. 15230: (citata anche nell’articolo di dottrina) ha toccato il tema dell’esdebitazione nel fallimento (ora liquidazione giudiziale) e riflessi sulle procedure minori, consolidando il principio che l’esdebitazione è scopo primario e va concessa ove possibile al debitore meritevole, segno di un orientamento generale favorevole al “fresh start” .
Queste decisioni e altre sono elencate in fondo tra le Fonti e Riferimenti. In generale la tendenza delle corti è interpretare la legge in senso pro-debitore onesto, in linea anche con le indicazioni europee (la Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull’insolvenza incoraggia gli ordinamenti a facilitare la liberazione dai debiti per le persone fisiche, dopo un periodo massimo di 3 anni).
Conclusioni e consigli finali
Affrontare una situazione di sovraindebitamento può sembrare un percorso arduo, ancor più se ci si trova fisicamente lontani dal proprio paese. Tuttavia, come abbiamo visto, l’ordinamento italiano offre oggi una gamma di strumenti efficaci per tornare in equilibrio, e li rende accessibili anche a chi è residente all’estero grazie a regole chiare sulla competenza (Tribunale di Roma) e a una crescente sensibilità nel considerare il contesto globale del debitore.
Dal punto di vista pratico, il debitore residente all’estero dovrà mettere in conto un impegno iniziale nel raccogliere tutte le informazioni e nel coordinarsi con professionisti in Italia, ma potrà gestire la maggior parte delle attività da remoto. Organizzare bene i documenti, comunicare in modo sincero e completo con l’OCC, e affidarsi a consulenti esperti sono le chiavi del successo. Non bisogna vergognarsi della propria condizione: la vergogna spesso impedisce ai debitori di chiedere aiuto finché è troppo tardi, ma le procedure di sovraindebitamento sono fatte apposta per aiutare persone comuni travolte dai debiti per circostanze negative. In Italia, a differenza di altri paesi, c’è voluto tempo per far radicare una “cultura del fresh start” (il fallimento personale era un tabù); oggi finalmente si sta affermando l’idea che liberare i debitori onesti conviene a tutti, creditori inclusi, e alla collettività .
Per gli avvocati e i professionisti: assistere un debitore residente all’estero richiede qualche attenzione in più (ad esempio, notifiche internazionali, eventuale necessità di apostille su documenti esteri da produrre in Italia, ecc.), ma nulla di insormontabile. La legge italiana è sufficientemente flessibile da adattarsi a situazioni atipiche. Ad esempio, se il debitore percepisce reddito in valuta estera, il piano lo contemplerà convertito in euro al tasso attuale; se ha pignoramenti all’estero, sarà utile cooperare con un legale locale per far riconoscere il provvedimento italiano. Tutto ciò arricchisce la pratica professionale con una dimensione transnazionale.
In conclusione, la guida dettagliata qui fornita vuole essere un riferimento tanto per chi, da debitore sperduto all’estero, cerca una luce in fondo al tunnel dei debiti, quanto per il professionista legale che lo accompagna in questo percorso, fornendo basi normative e spunti giurisprudenziali aggiornati al 2025. Il messaggio finale è di speranza realistica: anche situazioni di indebitamento apparentemente irrisolvibili possono trovare soluzione attraverso gli strumenti legali appropriati. Un residente all’estero sovraindebitato non è condannato a restare in esilio finanziario: con un po’ di impegno iniziale e l’uso sapiente della normativa sul sovraindebitamento, può riconquistare la tranquillità economica e la dignità di una vita senza l’assillo dei creditori. Questa è la vera essenza della cosiddetta legge “anti-suicidi”: offrire un’opportunità di riscatto, un nuovo inizio a chi è schiacciato dai debiti , ovunque egli si trovi nel mondo.
Se vivi all’estero ma hai debiti in Italia con banche, Agenzia delle Entrate, INPS o finanziarie fatti aiutare da Studio Monardo
Se vivi all’estero ma hai debiti in Italia con banche, Agenzia delle Entrate, INPS o finanziarie, potresti chiederti:
👉 “Posso ancora difendermi anche se non risiedo più in Italia?”
👉 “Posso ottenere la cancellazione dei miei debiti con una procedura legale, pur vivendo fuori dal Paese?”
La risposta è sì: anche chi risiede all’estero può accedere alle procedure di esdebitazione e sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), purché i debiti siano stati contratti in Italia o con creditori italiani.
In questa guida troverai spiegato come funziona, chi può farlo, quali documenti servono, e come difendersi anche a distanza, passo dopo passo.
⚖️ Cos’è la procedura di sovraindebitamento
Il sovraindebitamento è la situazione in cui una persona — fisica o ex imprenditore — non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti.
La procedura di esdebitazione consente di ridurre o cancellare legalmente i debiti residui, dopo una verifica del Tribunale e dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
Può accedervi anche chi non risiede più in Italia, a condizione che:
- i debiti siano italiani (contratti con banche, fornitori o enti del Fisco italiani);
- sia ancora rintracciabile un legame economico o giuridico con l’Italia (es. codice fiscale, conti, immobili, ex attività, ecc.).
👥 Chi può richiedere la procedura dall’estero
Può presentare domanda di sovraindebitamento chi:
- È un cittadino italiano residente all’estero con debiti contratti in Italia.
- È un ex imprenditore o autonomo che ha chiuso la propria attività in Italia.
- È un ex residente che ha lasciato il Paese ma ha lasciato dietro di sé mutui, finanziamenti o cartelle.
- È un pensionato o lavoratore italiano all’estero con debiti fiscali o bancari in Italia.
- È un garante o fideiussore di un’attività o di un familiare che non ha più potuto pagare.
📌 Non serve tornare in Italia per iniziare la procedura: tutto può essere gestito da remoto, tramite procura speciale e assistenza legale.
🧾 Tipologie di debiti che si possono cancellare
✅ Ammessi alla procedura:
- Debiti fiscali: IRPEF, IVA, IRAP, cartelle esattoriali, multe.
- Debiti contributivi: INPS, INAIL.
- Debiti bancari e finanziari: mutui, prestiti, carte revolving, fidi.
- Debiti commerciali o verso fornitori.
- Garanzie e fideiussioni.
❌ Esclusi (non cancellabili):
- Obblighi di mantenimento familiare.
- Sanzioni penali o amministrative non tributarie.
- Debiti da dolo o frode.
🧠 Requisiti fondamentali per poter procedere
Per accedere alla procedura anche da residente all’estero, servono:
- Debiti contratti in Italia (anche se vivi ora all’estero).
- Codice fiscale italiano ancora attivo.
- Documentazione completa della posizione debitoria.
- Assenza di comportamenti dolosi o fraudolenti.
- Trasparenza e buona fede nella presentazione dei dati.
- Collaborazione con l’OCC e il legale nominati in Italia.
🧩 Le principali procedure possibili
💠 Piano del consumatore
Rivolto ai privati (non imprenditori).
Consente di proporre al Tribunale un piano di pagamento sostenibile, proporzionato al reddito, con blocco immediato di pignoramenti e azioni dei creditori.
Dopo il piano, il residuo viene cancellato.
💠 Concordato minore
Per ex imprenditori o autonomi che hanno cessato l’attività.
Permette di offrire ai creditori un saldo e stralcio o un piano parziale, con approvazione del giudice.
Anche in questo caso, al termine, il debito residuo viene estinto.
💠 Liquidazione controllata
Consente di mettere a disposizione eventuali beni o risparmi rimasti, per soddisfare in parte i creditori.
Il residuo viene poi cancellato definitivamente con l’esdebitazione finale.
💠 Esdebitazione del debitore incapiente
È la procedura più favorevole, riservata a chi non ha redditi né beni.
Il Tribunale, riconosciuta la buona fede, cancella tutti i debiti in modo integrale.
Può essere chiesta una sola volta nella vita.
🏛️ Come funziona la procedura dall’estero
- Colloquio preliminare online con un avvocato italiano esperto in sovraindebitamento.
- Analisi dei debiti e dei creditori per verificare i requisiti.
- Nomina dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) in Italia.
- Raccolta documentale via email o posta (estratti conto, cartelle, redditi, ecc.).
- Redazione della relazione OCC e predisposizione del piano o ricorso.
- Deposito in Tribunale italiano competente.
- Blocco immediato delle azioni dei creditori (pignoramenti, fermi, ecc.).
- Udienza di omologazione davanti al giudice (anche con rappresentanza per procura).
- Esecuzione del piano e esdebitazione definitiva.
📋 Documenti richiesti
- Documento d’identità e codice fiscale italiani.
- Prova della residenza estera (iscrizione AIRE o documento locale).
- Estratto di ruolo AER e cartelle esattoriali.
- Avvisi di addebito INPS o INAIL.
- Contratti di prestito, mutuo o fideiussione.
- Estratti conto bancari.
- Dichiarazioni dei redditi (ultimi 3 anni, anche esteri se disponibili).
- Spese familiari e situazione patrimoniale attuale.
⏱️ Tempi e risultati
- Preparazione e analisi documenti: 1–2 mesi.
- Deposito e blocco delle azioni: immediato al deposito del ricorso.
- Omologazione del Tribunale: 3–8 mesi medi.
- Durata complessiva del piano: 1–5 anni (a seconda dei casi).
🎯 Risultato finale:
- Blocco totale di pignoramenti e azioni esecutive in Italia.
- Riduzione o cancellazione definitiva dei debiti residui.
- Riabilitazione economica e reputazionale anche da residente all’estero.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni dei creditori in Italia.
✅ Riduzione o cancellazione legale dei debiti italiani.
✅ Procedura gestibile interamente a distanza.
✅ Tutela del patrimonio familiare e personale.
✅ Ripartenza pulita e senza debiti, anche vivendo fuori dall’Italia.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare notifiche o comunicazioni da parte dei creditori italiani.
- Pensare che vivere all’estero ti renda “intoccabile”: i crediti fiscali restano attivi.
- Nascondere beni o conti italiani (rende impossibile l’esdebitazione).
- Rivolgerti a consulenti non abilitati o agenzie estere improvvisate.
- Aspettare troppo: più passa il tempo, più crescono interessi e sanzioni.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione debitoria e verifica la fattibilità della procedura.
📌 Ti assiste completamente a distanza con procura notarile o consolare.
✍️ Predispone il ricorso e coordina l’attività con l’OCC in Italia.
⚖️ Ti rappresenta in Tribunale e nei rapporti con Agenzia delle Entrate, INPS, banche e finanziarie.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione definitiva dei debiti e alla piena riabilitazione.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e sovraindebitamento.
✔️ Specializzato nell’assistenza a cittadini italiani residenti all’estero con debiti in Italia.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Essere residente all’estero non significa dover convivere per sempre con i debiti lasciati in Italia.
Grazie alle procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione, puoi bloccare ogni azione legale, ridurre i debiti e ottenere una liberazione definitiva, anche a distanza.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova vita senza debiti inizia ovunque tu viva.