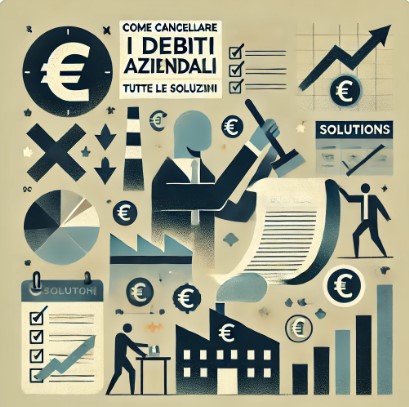La tua azienda è soffocata dai debiti con il Fisco, l’INPS, i fornitori o le banche?
Molti imprenditori si trovano in questa situazione: clienti che non pagano, costi in aumento, difficoltà di accesso al credito e continui solleciti da parte dei creditori.
Quando le passività superano le entrate, i debiti aziendali possono diventare un peso insostenibile e rischiano di compromettere l’intera attività.
La buona notizia è che la legge italiana consente di cancellare o ridurre i debiti aziendali in modo legale, attraverso strumenti specifici che proteggono l’imprenditore e permettono di salvare l’impresa o chiuderla senza lasciare pendenze.
Perché le aziende si indebitano
Le cause dell’indebitamento aziendale sono molteplici:
- ritardi nei pagamenti da parte dei clienti o delle pubbliche amministrazioni;
- aumento dei costi energetici e delle materie prime;
- eccessiva pressione fiscale e contributiva;
- finanziamenti e leasing onerosi;
- crisi di liquidità dovuta al calo delle vendite o a errori di gestione.
Molti imprenditori cercano di mantenere l’attività operativa posticipando tasse e contributi, ma così il debito cresce rapidamente, fino a rendere impossibile ogni pagamento.
Quando è possibile cancellare i debiti aziendali
È possibile cancellare o ridurre i debiti aziendali in diverse situazioni, a seconda della forma giuridica dell’impresa e del tipo di debito.
Le principali ipotesi riguardano:
- ditte individuali o artigiani, che rispondono personalmente dei debiti con i propri beni ma possono accedere alla procedura di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione;
- società di persone (SNC, SAS), in cui i soci rispondono solidalmente e possono chiedere la cancellazione dei debiti personali residui;
- società di capitali (SRL, SPA), che possono ricorrere al concordato preventivo, alla liquidazione controllata o ad accordi di ristrutturazione del debito.
In ogni caso, l’obiettivo è evitare il fallimento disordinato e gestire la crisi in modo protetto e legale.
Cancellare i debiti fiscali e contributivi
Per i debiti con l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, sono previste varie misure di definizione agevolata che permettono di pagare solo una parte dell’importo dovuto, eliminando sanzioni e interessi.
Tra le principali opzioni:
- rottamazione delle cartelle esattoriali, che consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale;
- saldo e stralcio fiscale, riservato alle imprese o persone fisiche in comprovata difficoltà economica;
- rateizzazione ordinaria o straordinaria, fino a 120 rate mensili;
- istanza di sospensione o annullamento, in caso di errori o prescrizioni.
Questi strumenti consentono di alleggerire rapidamente la pressione fiscale e ottenere la sospensione delle procedure di riscossione in corso.
Cancellare i debiti con fornitori, banche e finanziarie
Le imprese spesso accumulano debiti verso fornitori o istituti di credito.
In questi casi è possibile intervenire con soluzioni diverse:
- accordi di saldo e stralcio, pagando una parte del dovuto in cambio della cancellazione del residuo;
- rinegoziazione dei finanziamenti per ridurre le rate o allungare i tempi di pagamento;
- verifica di contratti e tassi d’interesse, per individuare eventuali clausole abusive o usurarie;
- trattative stragiudiziali assistite da un avvocato, che consentono di evitare contenziosi e ottenere accordi più vantaggiosi.
Le banche e i fornitori preferiscono spesso recuperare una parte del credito piuttosto che affrontare anni di procedure giudiziarie.
La procedura di sovraindebitamento per imprenditori individuali
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una procedura legale che permette anche agli imprenditori non fallibili — come artigiani, autonomi e ditte individuali — di cancellare i debiti residui.
Attraverso questa procedura puoi:
- bloccare pignoramenti, ipoteche e azioni dei creditori;
- proporre un piano di rientro con taglio parziale dei debiti;
- ottenere la cancellazione totale dei debiti residui una volta terminata la procedura (esdebitazione);
- salvaguardare la casa e i beni essenziali per l’attività.
È una soluzione definitiva per chi ha accumulato debiti ma vuole ripartire legalmente e senza rischi.
Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo per le società
Le società di capitali possono invece accedere a strumenti più complessi, ma estremamente efficaci:
- accordo di ristrutturazione dei debiti, che consente di negoziare con i creditori un piano sostenibile approvato dal tribunale;
- concordato preventivo, che sospende tutte le azioni esecutive e permette di proseguire l’attività durante la ristrutturazione;
- liquidazione controllata, per chiudere l’attività con ordine e ottenere l’esdebitazione finale.
Queste procedure proteggono l’imprenditore da pignoramenti e istanze di fallimento, consentendo di gestire la crisi senza compromettere il patrimonio personale.
I vantaggi di una cancellazione legale dei debiti aziendali
Cancellare i debiti aziendali attraverso gli strumenti previsti dalla legge offre vantaggi concreti:
- sospensione immediata delle azioni dei creditori;
- riduzione o annullamento dei debiti residui;
- protezione dei beni personali dell’imprenditore;
- possibilità di ristrutturare o ripartire con una nuova attività;
- eliminazione dello stress finanziario e delle pressioni fiscali.
È una soluzione seria e definitiva, che consente di uscire dal circolo vizioso dei debiti e recuperare la serenità economica.
Attenzione alle soluzioni improvvisate
Molti imprenditori, presi dall’urgenza, si affidano a intermediari o società che promettono cancellazioni facili dei debiti senza basi legali.
In realtà, solo le procedure previste dal Codice della Crisi e gli accordi omologati dal tribunale garantiscono risultati effettivi e tutela giuridica.
Affidarsi a un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa è essenziale per evitare truffe e soluzioni inefficaci.
Quando rivolgersi a un avvocato esperto
Dovresti contattare un avvocato specializzato se:
- la tua azienda ha debiti fiscali o bancari non più sostenibili;
- hai ricevuto cartelle esattoriali, pignoramenti o solleciti;
- stai valutando la chiusura o la ristrutturazione dell’attività;
- vuoi cancellare legalmente i debiti e proteggere il tuo patrimonio personale.
Un avvocato esperto potrà analizzare la situazione aziendale, verificare la natura dei debiti, proporre la strategia più efficace e accompagnarti fino alla cancellazione definitiva delle somme dovute.
⚠️ Attenzione: ignorare i debiti aziendali o posticipare le decisioni può portare a pignoramenti, segnalazioni, perdita dei beni e chiusura forzata dell’attività. Agire per tempo è l’unico modo per salvare il tuo lavoro e tutelare il tuo futuro.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e tutela delle aziende – spiega in modo chiaro come cancellare i debiti aziendali, quali strumenti legali utilizzare e come difendersi da Fisco, banche e fornitori.
👉 La tua azienda ha debiti che non riesci più a gestire?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo.
Analizzeremo la tua situazione, verificheremo le possibilità di cancellazione o ristrutturazione e costruiremo una strategia legale personalizzata per salvare la tua impresa e liberarti definitivamente dai debiti.
Introduzione
Nel contesto economico attuale, molte imprese italiane si trovano schiacciate da debiti fiscali, bancari e commerciali accumulati negli anni. Un tempo l’unica prospettiva per l’azienda insolvente era il fallimento, con la conseguente perdita dell’attività e dei posti di lavoro. Oggi, invece, grazie al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022), esistono strumenti concreti per ristrutturare o persino cancellare legalmente gran parte dei debiti aziendali. In questa guida avanzata esamineremo tutte le soluzioni disponibili per cancellare i debiti aziendali, aggiornate a settembre 2025, con riferimento alla normativa italiana vigente, alla giurisprudenza più recente e con un taglio pratico ma rigoroso.
Dal punto di vista del debitore, illustreremo come operano i vari istituti (dalla composizione negoziata al concordato preventivo, dagli accordi di ristrutturazione al sovraindebitamento e alla liquidazione giudiziale) e quali risultati permettono di ottenere in termini di riduzione o annullamento dell’esposizione debitoria. La trattazione avrà un linguaggio giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati interessati a comprendere le opzioni disponibili. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione Domande & Risposte per chiarire i dubbi più comuni.
È importante chiarire sin dall’inizio che “cancellare i debiti” non significa che magicamente i debiti spariscano senza contropartite: significa piuttosto utilizzare procedure legali per ridurre, ristrutturare o estinguere i debiti in misura sostenibile, spesso con il consenso (o la coazione giuridica) dei creditori e sotto il controllo di un tribunale. In molti casi l’esito è la liberazione del debitore dai debiti residui (esdebitazione), ottenendo così quel “fresh start” che consente di ripartire senza l’oppressione del passato. Tuttavia, non tutti i debiti sono trattabili allo stesso modo e non tutti i debitori possono accedere a tutte le procedure – da qui la necessità di un’analisi attenta e personalizzata della situazione.
Nei paragrafi che seguono delineeremo prima il quadro normativo di riferimento e le categorie di debito rilevanti, per poi esaminare le soluzioni extragiudiziali (accordi privati, piani attestati, accordi di ristrutturazione), le procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.), le procedure dedicate a soggetti sovraindebitati non fallibili (piano del consumatore, concordato minore, ecc.), senza dimenticare gli aspetti fiscali e penali connessi alla gestione del debito. Infine, proporremo alcune FAQ e tabelle di sintesi per ricapitolare i punti chiave. L’obiettivo è fornire una guida completa e aggiornata al settembre 2025, con riferimenti normativi e giurisprudenziali autorevoli per approfondire ogni aspetto.
Prima di procedere, una nota di metodo: tutte le soluzioni discusse richiedono tempi, costi e condizioni specifiche, e comportano vantaggi ma anche sacrifici (ad esempio la necessità di liquidare beni o di rispettare piani di pagamento pluriennali). Agire tempestivamente è spesso decisivo: un intervento precoce aumenta le chance di successo della ristrutturazione e riduce il rischio di azioni esecutive o di dissipazione del patrimonio. Il Codice della Crisi stesso impone all’imprenditore doveri di monitoraggio e reazione tempestiva allo stato di crisi (art. 3 CCII). Pertanto, conoscere gli strumenti e attivarsi subito è fondamentale per massimizzare i debiti che si possono trattare, congelare o abbattere in modo legittimo.
Quadro normativo attuale sulla crisi d’impresa
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto con D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, ha riordinato e modernizzato l’intera disciplina delle procedure concorsuali, superando la vecchia legge fallimentare risalente al 1942. Dopo varie proroghe dovute anche alla pandemia, il Codice è entrato in vigore il 15 luglio 2022, recependo anche la Direttiva UE 2019/1023 in materia di ristrutturazioni preventive (c.d. “Insolvency Directive”). Successivi decreti correttivi (in particolare il D.Lgs. 83/2022) hanno integrato nel Codice nuovi strumenti innovativi come il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).
Ecco, in sintesi, le principali novità normative e strumenti introdotti dal Codice della Crisi:
- Procedure di allerta e prevenzione: il Codice prevedeva strumenti di early warning per intercettare precocemente gli squilibri finanziari dell’impresa e incentivare l’imprenditore ad affrontarli prima che degenerino. L’art. 3 CCII obbliga l’imprenditore a dotarsi di assetti adeguati a rilevare la crisi e a attivarsi tempestivamente. (NB: la concreta attuazione degli “allerta esterni” tramite appositi organi è stata differita al 2024, ma resta l’obbligo interno di monitoraggio).
- Composizione negoziata della crisi (artt. 12–25-septies CCII): è una procedura volontaria e riservata introdotta con D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora parte del Codice. Consente all’imprenditore commerciale in crisi di negoziare con i propri creditori (banche, fornitori, Fisco) con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale giudiziaria, ma un percorso di trattativa protetto che può sfociare in vari esiti: un accordo stragiudiziale, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione omologato, o – se le trattative falliscono – l’accesso a un concordato “semplificato” per liquidare il patrimonio. Ne parleremo approfonditamente più avanti.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII): si tratta di accordi stragiudiziali omologati, in cui il debitore trova un’intesa con una parte significativa dei creditori e ottiene dal tribunale l’omologazione che rende l’accordo vincolante e protegge dagli attacchi dei dissenzienti. Il Codice prevede diverse varianti di accordo di ristrutturazione, inclusi quelli agevolati (con soglia di adesione ridotta al 30% in certi casi), quelli ad efficacia estesa (che vincolano anche i creditori dissenzienti di una certa classe, ad esempio gli intermediari finanziari, ex art. 61 CCII) e la convenzione di moratoria (art. 62 CCII, accordo temporaneo per sospendere azioni esecutive e congelare le posizioni durante la crisi). Tali accordi permettono di abbattere l’esposizione debitoria tramite un piano negoziato, evitando le conseguenze più drastiche di un fallimento.
- Strumenti per il sovraindebitamento (artt. 65–83 CCII): il Codice ha riunito e ampliato le procedure previste dalla Legge 3/2012 per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, enti non commerciali, ecc.). Oggi si parla di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, articolate in: piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore (ex accordo di composizione per piccole imprese e partite IVA), liquidazione controllata del sovraindebitato, e una speciale esdebitazione “senza utilità” per il debitore incapiente. Tali procedure consentono a individui e piccole imprese sovraindebitati di ridurre proporzionalmente i propri debiti e talvolta ottenerne la cancellazione totale, purché rispettino requisiti di meritevolezza e solvibilità minima che vedremo in seguito.
- Concordato preventivo (artt. 84–120 CCII): rimane lo strumento principe per le imprese insolventi o in crisi che vogliono evitare la liquidazione giudiziale, proponendo un piano ai creditori. Il concordato può essere in continuità aziendale (se prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente o tramite cessione dell’azienda) oppure liquidatorio (se prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione dei beni, con eventuale assunzione dell’azienda da parte di terzi). Il Codice richiede soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari (20% in continuità, 30% nel liquidatorio salvo eccezioni) e introduce una più ampia flessibilità nel trattamento dei crediti privilegiati e nella formazione delle classi. Approfondiremo anche le norme premiali: ad esempio, se il concordato va a buon fine (omologa con certe percentuali pagate), alcuni reati come la bancarotta preferenziale non sono punibili.
- Liquidazione giudiziale (artt. 121–270 CCII): è il nuovo nome del fallimento. La liquidazione giudiziale viene aperta quando l’impresa insolvente non accede ad altre soluzioni e porta alla liquidazione di tutto il patrimonio sotto il controllo del curatore nominato dal tribunale. Il Codice della Crisi ha conservato l’impianto base della procedura fallimentare, ma con innovazioni come la possibile esdebitazione finale estesa anche alle società (vedremo i dettagli), la semplificazione delle comunicazioni ai creditori, e la già citata valorizzazione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori (artt. 255–256 CCII). La liquidazione giudiziale resta la via più invasiva e “ultimativa”, da evitare se possibile, ma a volte è l’unica soluzione per chiudere un’impresa decotta e consentire al debitore (persona fisica) di ripartire pulito tramite esdebitazione.
Oltre a queste macro-categorie, il Codice prevede sottocategorie e interazioni (come il concordato semplificato per liquidazione introdotto all’esito negativo di una composizione negoziata, art. 25-sexies e 25-septies CCII, oppure il già menzionato piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), art. 64-bis e ss. CCII). Nel 2023-2024 il legislatore ha emanato ulteriori correttivi: ad esempio la L. 7 agosto 2023 n.111 ha delegato il Governo a includere i tributi locali nelle transazioni fiscali e ha ritoccato alcuni aspetti tecnici, e un D.Lgs. correttivo del 28 settembre 2023 (in vigore dal 28/09/2024) ha affinato la disciplina della composizione negoziata (art. 12 CCII). Complessivamente, il quadro normativo a settembre 2025 è stabilizzato e offre una gamma articolata di strumenti che vanno dal completamente extragiudiziale (accordi privati) al pienamente concorsuale (liquidazione giudiziale), passando per soluzioni ibride sotto controllo del tribunale ma basate sul consenso dei creditori (accordi omologati, concordati).
Di seguito riassumiamo in tabella le principali procedure/soluzioni e le loro caratteristiche chiave, per poi esaminarle singolarmente:
Tabella 1 – Principali strumenti per gestire/cancellare i debiti aziendali
| Strumento | Norma | Chi può accedervi | Natura | Esito sui debiti | Continuità aziendale |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Art. 56 CCII (ex art. 67 L.F.) | Imprese in crisi o insolvenza reversibile (anche fallibili) | Stragiudiziale (accordo privato con attestazione di esperto, facoltativa pubblicazione) | Riduzione dei debiti tramite accordi privati con creditori; tutela da revocatoria per atti esecutivi del piano | Sì, mira al risanamento e prosecuzione attività |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Artt. 57–64 CCII | Imprese commerciali fallibili (oltre soglie) in crisi/insolvenza; anche debitori civili per estensione accordo minore | Stragiudiziale omologato (richiede adesione di creditori qualificata, omologa tribunale) | Riduzione/falcidia dei debiti secondo accordo. Vincola solo aderenti, salvo estensioni ex lege. Effetto esdebitativo al completamento | Di solito sì (spesso risanamento), ma può anche prevedere cessione beni (accordo liquidatorio) |
| PRO – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione | Artt. 64-bis/ter/quater CCII (introdotti nel 2022) | Imprese fallibili (non “minori”) in crisi o insolvenza, escluse imprese minori e agricole | Ibrido (negoziale + giudiziale). Piano proposto con classi di creditori e omologato con maggioranze ridotte (anche cram-down di dissenzienti intra-classe) | Riduzione debiti secondo piano omologato. Vincola tutti i creditori delle classi votanti (anche dissenzienti, se maggioranze rispettate). Possibile deroga absolute priority | Sì, può essere in continuità o liquidatorio, flessibile. |
| Composizione negoziata | Artt. 12–25-septies CCII (D.L. 118/2021) | Imprese (anche minori) in squilibrio o crisi (reversibile) | Stragiudiziale assistito (negoziazione volontaria con esperto; eventuali misure protettive autorizzate dal tribunale) | Dipende dall’esito: può portare ad accordi stragiudiziali, contratti con esperto, oppure sfociare in concordato o liquidazione. Durante la trattativa, debiti congelati (stay) con ok del giudice | Preferibilmente sì (strumento concepito per evitare la cessazione, favorendo accordi che salvino l’impresa) |
| Concordato preventivo (continuità o liquidatorio) | Artt. 84–120 CCII | Imprese fallibili in stato di crisi o insolvenza; anche imprenditori individuali sopra soglie | Concorsuale giudiziale (procedura concorsuale aperta dal tribunale, con voto dei creditori e omologa) | Riduzione e cancellazione dei debiti non pagati secondo il piano omologato. Ad es., debiti chirografari pagati parzialmente comportano stralcio della quota residua; dopo l’omologa, il debitore è obbligato solo ai pagamenti promessi. A fine piano, eventuali debiti residui chirografari sono inesigibili (esdebitazione implicita salvo revoca concordato). | Può essere in continuità (l’impresa prosegue, magari ristrutturata) oppure liquidatorio (cessione o liquidazione dei beni). Il concordato in continuità tutela maggiormente l’avviamento e l’occupazione. |
| Concordato semplificato (post-composizione negoziata) | Artt. 25-sexies e septies CCII | Impresa che ha avviato una composizione negoziata ma senza trovare un accordo, e si trova insolvente | Concorsuale abbreviato (proposta di concordato liquidatorio senza voto creditori, deciso dal tribunale) | Liquidazione rapida dei beni secondo un piano, con riparto ai creditori. Debiti residui cancellati al termine (come in concordato normale). Questo strumento consente al debitore onesto ma senza intesa coi creditori di chiudere comunque la crisi con l’aiuto del tribunale. | No, è previsto solo in versione liquidatoria (cessazione attività e vendita beni) per chiudere la crisi in mancanza di soluzioni concordate. |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Artt. 121–270 CCII | Imprese fallibili insolventi (incluse società e imprenditori individuali sopra soglie) | Concorsuale liquidatoria (tribunale nomina curatore, spossessamento del debitore) | Liquidazione di tutto l’attivo e riparto ai creditori secondo cause di prelazione. Debiti residui non soddisfatti: per società di capitali cessano con l’estinzione della società; per persone fisiche c’è la possibilità di esdebitazione (art. 278 CCII) su richiesta dopo la chiusura. L’esdebitazione libera il debitore persona fisica dai debiti concorsuali rimasti impagati (eccetto debiti esclusi per legge). | No, l’azienda viene liquidata e l’attività cessa (salvo eventuale esercizio provvisorio per breve periodo se utile per valorizzare l’impresa). |
| Procedura di sovraindebitamento – Concordato minore | Artt. 74–83 CCII | Debitori non fallibili in stato di crisi o insolvenza: es. piccole imprese sotto soglie art. 2 lett. d) CCII, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti, associazioni, soci illimitatamente responsabili di società. (Non per consumatore puro, che ha il suo piano) | Concorsuale semplificata (simile a concordato, ma senza voto: i creditori possono opporsi, decide il giudice) | Ristrutturazione dei debiti con pagamento anche parziale secondo il piano omologato. Debiti residui sono cancellati con l’omologa e l’esecuzione del piano, salvo quelli esclusi ex lege. Nel concordato minore è richiesto per legge un soddisfacimento minimo del 20% dei crediti chirografari, salvo consenso di almeno il 10% dei creditori se si offre meno (art. 80 CCII). | Può prevedere la prosecuzione dell’attività o la liquidazione dei beni, a seconda dei casi. Spesso è finalizzato a evitare la liquidazione delle piccole attività con un accordo sostenibile. |
| Procedura di sovraindebitamento – Piano di ristrutturazione del consumatore | Artt. 67–73 CCII | Persone fisiche consumatori (che hanno debiti personali, non professionali) sovraindebitate. Nota: un ex imprenditore cessato può accedere come consumatore solo se i debiti residui sono prevalentemente personali e non d’impresa. | Concorsuale semplificata (piano presentato dal debitore con ausilio OCC, senza voto dei creditori, deciso dal giudice) | Ristrutturazione dei debiti personali: il piano può prevedere pagamenti parziali e dilazionati. Se omologato dal tribunale, vincola tutti i creditori chirografari anche dissenzienti. Il debitore esegue i pagamenti promessi e ottiene la cancellazione dei debiti residui al termine. Durante la procedura: sospensione interessi e stop pignoramenti su istanza. | Il consumatore non è “azienda”, ma l’eventuale attività lavorativa prosegue. Il piano mira spesso a preservare beni essenziali (es. la casa di abitazione, evitando il pignoramento) pagando solo quota dei debiti sostenibile. |
| Procedura di sovraindebitamento – Liquidazione controllata | Artt. 268–277 CCII (richiama art. 14-terdecies L.3/2012) | Sovraindebitati non fallibili che non hanno capacità di pagare un piano o quando un piano/concordato minore non è fattibile. Anche su richiesta del debitore in alternativa al piano, o se piano/concordato non vengono omologati. | Concorsuale liquidatoria semplificata (il tribunale nomina un liquidatore OCC, liquida il patrimonio del debitore) | Liquidazione di tutti i beni del debitore sovraindebitato. I crediti vengono soddisfatti per quanto possibile dal ricavato. Debiti residui cancellati se il debitore ottiene l’esdebitazione al termine (che è automatica se il debitore collabora lealmente, senza necessità di separata domanda). Il CCII prevede durata massima 3 anni per la liquidazione controllata. | No, il patrimonio personale del debitore viene liquidato (salvo beni impignorabili). È l’ultima ratio per chi non riesce a proporre un piano: si perde il patrimonio ma si riparte da zero libero dai debiti. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Art. 283 CCII (deriva da L.3/2012 novellata) | Persona fisica meritevole sovraindebitata priva di qualunque attivo o reddito da offrire ai creditori. Applicabile una sola volta. | Procedura speciale (istanza al tribunale per ottenere l’esdebitazione immediata) | Cancella tutti i debiti residui senza alcun pagamento ai creditori. È una misura eccezionale di “fresh start” per debitori totalmente incapienti. Richiede però che il debitore non abbia frodato i creditori e non abbia creato il debito con colpa grave o dolo. Se nei 4 anni successivi sopravvengono utilità rilevanti al debitore, dovrà pagarle ai creditori nella misura del 10% (art. 283 c.3 CCII). | Non è propriamente una continuazione di attività: è una exit strategy personale. Dopo, il debitore può ricominciare senza debiti, ma portando lo “stigma” di una esdebitazione ottenuta senza soddisfare i creditori (informazione che rimane per qualche tempo nei registri). |
Nota: La tabella sopra distingue procedure fallimentari (o maggiori) da quelle di sovraindebitamento. Il discrimine principale è la fallibilità del debitore: le imprese sopra certe soglie di attivo, debiti e ricavi (art. 2, co.1, lett. d CCII: oltre €300.000 attivo, €200.000 ricavi, €500.000 debiti)sono soggette a liquidazione giudiziale e possono accedere a concordato preventivo, accordi, ecc. Le imprese minori sotto tali limiti (non fallibili) e i non imprenditori possono usare solo le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, ecc.). Va evidenziato che anche società di persone (SNC, SAS) e soci illimitatamente responsabili partecipano alla procedura concorsuale della società (art. 256 CCII), e possono a loro volta accedere all’esdebitazione o ad accordi personali. Approfondiremo in seguito la posizione di amministratori, soci e garanti.
Tipologie di debiti aziendali e loro trattamento nelle procedure
Non tutti i debiti aziendali sono uguali di fronte alla legge. A seconda della natura del debito, esistono vincoli legali sul se e come possa essere ridotto (falcidiato) o cancellato nelle varie procedure. Dal punto di vista del debitore è cruciale comprendere queste differenze, perché influenzano la strategia di ristrutturazione: ad esempio, i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali hanno discipline particolari e spesso non possono essere stralciati del tutto, mentre i debiti verso fornitori o banche in genere sono liberamente negoziabili. In questa sezione classifichiamo i debiti più comuni di un’impresa e sintetizziamo il loro trattamento tipico.
Debiti fiscali e tributari verso l’Erario
I debiti verso il Fisco (Agenzia Entrate/Agenzia Riscossione) comprendono imposte come IVA, IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, accise, tributi locali, ecc. Questi debiti sono spesso assistiti da privilegio generale o speciale (ad esempio l’IVA e le ritenute non versate godono di privilegio generale sui mobili ex art. 2752 c.c.). Ciò significa che in caso di liquidazione concorsuale sarebbero soddisfatti con precedenza sugli altri crediti chirografari. Inoltre, alcune componenti hanno tutela rafforzata da norme specifiche:
- IVA e risorse UE: L’IVA è considerata “risorsa propria” dell’Unione Europea, e in passato la legge italiana vietava qualsiasi falcidia del relativo capitale nelle procedure (art. 182-ter L.F. ante 2017). Dopo una nota sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-546/14 del 2016) e interventi normativi, oggi è ammesso includere l’IVA in un piano di ristrutturazione con pagamento parziale, ma di fatto la prassi dell’Agenzia Entrate è di pretendere sempre il pagamento integrale dell’IVA dovuta in linea capitale. In un concordato o accordo, dunque, normalmente si propone di pagare l’IVA al 100% (magari dilazionata) e semmai di stralciare solo interessi e sanzioni su di essa. Analogo discorso vale per altri tributi considerati “protetti” dal diritto UE, come i dazi doganali. In sintesi: l’IVA non è legalmente infalcidiabile al 100%, ma nella pratica qualunque piano serio dovrà prevederne il pagamento integrale per evitare contestazioni di violazione del diritto UE.
- Ritenute fiscali non versate: Questo include ad esempio le ritenute IRPEF operate sulle buste paga dei dipendenti o sui compensi dei professionisti e non versate dal sostituto d’imposta. Questi importi, per legge, non possono essere falcidiati nelle procedure concorsuali – vanno pagati integralmente. La logica è che trattasi di somme che il datore di lavoro ha trattenuto per conto dei dipendenti/erario: non appartengono in senso proprio all’impresa. Pertanto, ogni piano di concordato o accordo deve prevedere il pagamento del 100% delle ritenute fiscali omesse (di solito come debiti prededucibili o privilegiati da soddisfare integralmente). L’Agenzia Entrate non ha facoltà di accettare riduzioni su tali somme.
- Imposte sul reddito e altri tributi erariali (IRES, IRAP, IRPEF non da ritenuta, imposta di registro, bollo, ecc.): Su queste imposte è possibile proporre falcidie, a condizione di rispettare la regola fondamentale della convenienza rispetto alla liquidazione. In altre parole, il piano deve offrire al Fisco almeno quanto esso ricaverebbe in una liquidazione giudiziale della società. Ad esempio, se l’impresa è priva di attivo realizzabile e in fallimento il credito erariale sarebbe insoddisfatto (0%), in un concordato si può proporre anche di pagare solo una piccola percentuale (es. 5%) e ciò potrebbe comunque essere omologato coattivamente dal giudice anche se l’Agenzia delle Entrate dissentisse. Se invece l’Erario ha privilegio su specifici beni (es. ipoteca di Equitalia su un immobile), occorre offrire almeno il valore di realizzo di quei beni. Le Circolari AE n.16/E/2018 e 34/E/2020 hanno chiarito che l’Agenzia Entrate valuterà positivamente proposte concordatarie in cui il pagamento offerto è almeno pari al valore di liquidazione dei beni sui quali vanta privilegio. In pratica, sì agli stralci di imposte dirette, ma non punitivi per il Fisco: la percentuale offerta al Fisco deve essere in linea con quella ottenibile liquidando le garanzie o con quella offerta ad altri creditori di pari grado. Va ricordato che dal 2022 il Codice consente al tribunale di omologare un concordato o accordo anche senza voto favorevole del Fisco, purché sia garantito il detto dividendo minimo (art. 48, co.5 CCII). Questo cosiddetto cram-down fiscale è una novità: se il Fisco è trattato correttamente ma rifiuta per inerzia o rigidità, non può bloccare l’intera ristrutturazione.
- Sanzioni e interessi su debiti tributari: Gli importi dovuti a titolo di sanzioni tributarie e relativi interessi moratori sono considerati debiti chirografari (posti in coda) e possono essere ridotti o azzerati liberamente in sede di transazione fiscale. È prassi nei piani proporre l’abbandono totale o quasi delle sanzioni e una forte riduzione degli interessi. Ad esempio, su un debito fiscale complessivo di €100.000 di cui €70.000 imposta e €30.000 tra sanzioni e interessi, si potrebbe proporre di pagare tutti i €70.000 di imposta (magari rateizzati in 5 anni) ma solo il 10% degli accessori (€3.000 su €30.000). In molti casi l’Erario accetta l’azzeramento quasi completo di sanzioni e interessi se l’imposta principale viene soddisfatta integralmente o in buona parte. Se invece si falcidia anche l’imposta (es. pago solo 50% dell’IRES dovuta), l’Agenzia tende a voler recuperare almeno una parte delle sanzioni/interessi proporzionata al beneficio concesso, ma non ci sono soglie fisse: è oggetto di negoziazione.
- Tributi locali (IMU, TARI, etc.): Attualmente non rientrano nella disciplina della transazione fiscale statale ex art. 63 CCII. Ciò significa che i debiti verso Comuni e altri enti locali non beneficiano delle norme di cram-down automatico previste per Stato e INPS. Il debitore deve negoziare caso per caso con l’ente locale. Nei piani di concordato, i crediti degli enti locali possono essere inseriti come chirografari e trattati con una certa percentuale di soddisfo, ma l’ente conserva libertà di votare favorevolmente o meno. In mancanza di accordo, se il piano comunque offre all’ente locale almeno il valore di liquidazione del suo credito, il tribunale potrebbe analogamente omologare coattivamente estendendo per analogia il principio del cram-down fiscale. Attenzione però: finché non interverrà una modifica normativa (delega 111/2023 prevede di includere i tributi locali nelle transazioni in futuro), i Comuni non sono obbligati ad accettare stralci. Dunque debiti come IMU, TASI, TARI, multe stradali comunali vanno trattati con prudenza, sapendo che serve preferibilmente il consenso dell’ente o comunque va dimostrata la convenienza della proposta.
In sintesi, i debiti fiscali possono essere trattati nelle procedure di crisi ma con importanti linee rosse da rispettare:
- IVA e ritenute: tendenzialmente no allo stralcio del capitale – vanno pagate per intero (magari dilazionate), altrimenti l’operazione rischia di non essere omologabile.
- Altre imposte erariali: falcidiabili, purché l’Erario riceva almeno quanto otterrebbe liquidando eventuali garanzie o, se chirografario, non meno di quanto otterrebbe in un fallimento.
- Sanzioni e interessi: pienamente falcidiabili; in genere sono i primi importi ad essere tagliati o annullati, essendo accessori.
- Tributi locali: formalmente fuori dalla transazione fiscale, richiedono accordo ad hoc con l’ente; in mancanza, bisogna offrire loro un trattamento allineato alla legge fallimentare (valore di liquidazione) per sperare in un’omologa coattiva.
Grazie a queste regole, oggi è possibile nel concordato o nell’accordo con lo Stato proporre soluzioni molto articolate: es. pagamento del 100% dell’IVA in 6 anni, pagamento del 40% dell’IRES in 4 anni, stralcio totale di sanzioni e interessi, il tutto formalizzato in un atto di transazione fiscale. Se il piano è economicamente conveniente (cioè offre più del fallimento), il tribunale può omologarlo anche senza il voto favorevole dell’ente pubblico (come confermato da pronunce di merito nel 2023). Per facilitare queste trattative, sono state emanate direttive interne: il Provvedimento AE 29.1.2024 n. 21447 ha stabilito le competenze e procedure decisionali per l’Agenzia delle Entrate in caso di proposte con falcidia superiore al 70% o debiti fiscali oltre 30 milioni; l’INPS, con Messaggio 3553/2024, ha fornito istruzioni per accettare transazioni sui crediti contributivi alla luce della riforma. Inoltre, il D.L. 13/2023 (decreto PNRR) ha esteso da 72 a 120 il numero massimo di rate concedibili nei piani di pagamento dei debiti erariali, rendendo più sostenibili le proposte dilazionate.
Oltre alle procedure concorsuali, va ricordato che il legislatore periodicamente introduce misure agevolative straordinarie per i debiti fiscali, note come “rottamazione delle cartelle” o “saldo e stralcio”. Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 (prevista dalla L. 197/2022, legge di bilancio 2023) ha consentito ai debitori di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta dovuta senza sanzioni né interessi, in forma dilazionata fino a 18 rate. Un successivo provvedimento nel 2023 ha disposto anche lo stralcio automatico dei debiti fino a €1.000 relativi a ruoli antecedenti al 2015. In autunno 2025 è allo studio una rottamazione-quinquies per i carichi affidati nel 2023. Queste misure non fanno parte del Codice della Crisi e sono accessibili a qualunque contribuente (persona o impresa) indipendentemente da procedure concorsuali. Dunque, il debitore in difficoltà dovrebbe sempre valutare se rientra in una “finestra” di definizione agevolata fiscale, perché potrebbe risolvere parte del debito tributario senza attivare complesse procedure concorsuali. Ovviamente, le rottamazioni hanno scadenze tassative e richiedono di pagare regolarmente le rate: se il debitore non adempie, decadde dal beneficio e il debito originario (con sanzioni e interessi) resuscita. In questa guida ci concentriamo sulle soluzioni ordinarie offerte dal diritto fallimentare; tuttavia, integrare una procedura concorsuale con misure di definizione agevolata (se disponibili) è spesso la strategia ottimale per ridurre il debito fiscale complessivo.
Infine, un cenno al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti: in via generale, la cancellazione di un debito comporterebbe una sopravvenienza attiva tassabile (una sorta di “ricavo” straordinario per il debitore). Tuttavia, l’art. 88, comma 4-ter del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) esclude da tassazione le sopravvenienze derivanti da procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione: “Non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, nonché – in misura parziale – quelle derivanti da concordato preventivo in continuità, accordo di ristrutturazione omologato o piano attestato”. In pratica, se un’azienda ottiene lo stralcio di debiti tramite concordato o accordo, il beneficio non viene eroso dalle imposte. La ratio è di non vanificare la ristrutturazione caricando l’impresa risanata di un nuovo debito fiscale. Va notato però che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel 2025, questo regime di non imponibilità non si applica (ancora) a tutti i casi: ad esempio, le sopravvenienze attive da riduzione debiti in un concordato semplificato (procedura introdotta nel 2021) sono ad oggi imponibili, perché il concordato semplificato non è elencato nella norma agevolativa. È probabile un intervento normativo correttivo per colmare questo gap, ma al settembre 2025 occorre tenerne conto in sede di valutazione. In sintesi, comunque, la maggior parte delle riduzioni di debito ottenute tramite procedure concorsuali non genera ulteriori debiti fiscali a titolo di tasse sui “guadagni” da remissione – un ulteriore incentivo a usare soluzioni legali invece di accordi “informali” (dove invece la remissione di debito può essere imponibile per il debitore).
Debiti previdenziali e contributivi (INPS, INAIL)
I debiti verso gli enti previdenziali (principalmente l’INPS per contributi pensionistici e l’INAIL per premi assicurativi) seguono logiche simili a quelle fiscali. I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro sono in parte a carico del lavoratore (trattenuti in busta paga) e in parte a carico azienda. Le somme trattenute al lavoratore e non versate (contributi a carico dipendente) sono equiparabili alle ritenute fiscali: sono somme di terzi che il datore doveva versare, pertanto non falcidiabili. Devono essere pagate integralmente nei piani. I contributi a carico dell’azienda, invece, possono essere trattati come imposte erariali: falcidiabili a condizione di rispettare la convenienza rispetto alla liquidazione. Dal 2017 anche l’INPS può aderire ad accordi di ristrutturazione e concordati con falcidia dei contributi aziendali (prima era controverso). Il Codice della Crisi prevede la “transazione contributiva” analoga a quella fiscale: l’INPS può rinunciare a interessi e sanzioni e ridurre parte del credito, se il piano è conveniente e garantisce il rispetto del privilegio sui beni aziendali. Come per il Fisco, il tribunale può omologare il piano anche senza il consenso formale dell’INPS, se la proposta soddisfa i criteri di legge (art. 63 CCII). L’INAIL e le Casse professionali seguono lo stesso regime.
Le sanzioni civili per omesso versamento contributi (spesso molto elevate) vengono di regola trattate come crediti chirografari e quindi sono facilmente falcidiate nei concordati (a volte l’INPS le riduce spontaneamente ricalcolandole come interessi di mora). Anche gli interessi sono negoziabili. Un elemento importante: se il datore non versa contributi previdenziali per importi rilevanti, scatta un illecito (oggi depenalizzato se entro certe soglie, penalmente rilevante se supera ca. €10.000 annui per INPS). Ma se l’azienda entra in una procedura concorsuale e soddisfa almeno parzialmente i crediti contributivi secondo le regole, ciò risolve anche l’inadempimento dal punto di vista sanzionatorio (il pagamento parziale omologato può estinguere la punibilità in certi casi, analogamente all’IVA).
In sintesi, il debito contributivo può essere ristrutturato legalmente quasi come il debito fiscale: contributi dei lavoratori no stralcio (vanno versati), contributi a carico impresa falcidiabili con garanzie di convenienza, interessi/sanzioni azzerabili. L’INPS nel 2024, con le sue linee guida, ha mostrato apertura a concordare piani di rientro con tagli significativi, a condizione di rispettare gli interessi dei fondi previdenziali. Da notare che l’INPS è anche coinvolta indirettamente: in caso di fallimento, i lavoratori dipendenti possono chiedere al Fondo di Garanzia INPS il TFR e le ultime 3 mensilità di retribuzione non pagate; l’INPS subentra così nei diritti dei lavoratori come creditore privilegiato nel fallimento. Nei concordati in continuità, però, spesso l’azienda proponente deve pagare integralmente i debiti verso i dipendenti (specie stipendi arretrati), come condizione di fattibilità e per mantenere la forza lavoro (vedi dopo).
Debiti bancari e finanziari
Le banche e gli intermediari finanziari sono spesso tra i principali creditori delle imprese indebitate, per via di mutui, finanziamenti, leasing, fidi di cassa, anticipi su fatture, etc. I crediti bancari si distinguono in due macro-categorie: chirografari (non garantiti) e privilegiati/garantiti (assistiti da garanzie reali o personali).
- Crediti bancari chirografari (senza garanzie): se la banca non ha né garanzie reali (ipoteche, pegni) né personali (fideiussioni di terzi) a supporto del suo credito, essa sarà un creditore chirografario al pari dei fornitori. In tal caso, nelle procedure concorsuali questi crediti possono essere falcidiati liberamente come gli altri chirografari. Ad esempio, in un concordato la banca voterà nella classe dei chirografari e potrà vedersi offrire (ipotizziamo) il 30% del suo credito, con la cancellazione del restante 70%. Se il concordato viene omologato, la banca incassa quella percentuale e per il resto non potrà più agire (il debito residuo viene cancellato erga omnes). Dunque i debiti bancari non garantiti sono generalmente ristrutturabili e riducibili tramite accordo o concordato.
- Crediti bancari garantiti da ipoteca o pegno*: se la banca vanta un’ipoteca su un immobile dell’impresa, o un pegno su titoli/merci, il suo credito è privilegiato sul ricavato di quei beni. Ciò garantisce la banca fino a concorrenza del valore di realizzo della garanzia. Nei concordati e accordi, i creditori privilegiati *possono essere soddisfatti parzialmente solo in due casi: (1) se il valore del bene oggetto di garanzia è inferiore al credito (la parte eccedente viene trattata come chirografaria); (2) se il creditore acconsente espressamente a ridurre il proprio credito. Ad esempio, se una banca ha mutuo residuo €1 mln con ipoteca su un capannone che oggi vale €600k, la banca ha privilegio fino a €600k e per €400k è chirografaria: un concordato potrebbe prevedere di pagare €600k (100% della parte garantita, magari vendendo l’immobile) e offrire un 20% sui €400k residui (falcidiandone €320k). Questo sarebbe lecito e l’omologa può avvenire anche senza consenso della banca perché si rispetta il suo grado (paga tutto il garantito, falcidia solo la parte incapiente). Viceversa, non è possibile forzare una banca garantita ad accettare meno del valore del bene ipotecato senza dargli almeno quell’importo in altra forma. Se il piano offre meno, la banca può opporsi e il tribunale non potrebbe cramdown-are quel privilegiato (a meno che il bene sia venduto e il valore effettivo risultasse minore delle stime – ma in genere serve perizia). Nei accordi stragiudiziali, la banca con ipoteca può negoziare un saldo e stralcio (es. accetta €500k su €1 mln e acconsente a liberare l’ipoteca – pratica comune nelle ristrutturazioni informali), ma serve il suo consenso specifico. In concordato in continuità, è possibile proporre di rinegoziare il debito garantito (es. abbassare tasso, allungare scadenze) e pagarlo integralmente col tempo, mantenendo l’ipoteca.
- Leasing: i contratti di leasing finanziario (immobiliari, macchinari) in caso di procedura concorsuale danno al lessor (società di leasing) dei diritti particolari: se il debitore vuole continuare il leasing deve pagare regolarmente i canoni; se lo risolve, il bene torna al lessor che vende e poi chiede l’eventuale differenza come credito. Spesso nei concordati si trova un accordo con la società di leasing: ad esempio, la società potrebbe riprendersi il bene e rinunciare a parte dei crediti futuri. Ogni caso è a sé.
- Derivati e debiti finanziari vari: I derivati con mark-to-market negativo per l’impresa (ossia passività potenziali) di solito vengono considerati crediti chirografari (non privilegiati) – quindi falcidiabili come gli altri. Talvolta nei contratti derivati è previsto che in caso di default (procedura concorsuale) il contratto si risolve anticipatamente, cristallizzando il debito da derivato in un importo da riconoscere all’intermediario; quell’importo andrà in chirografo nel passivo. I finanziamenti a medio/lungo termine delle banche, se non garantiti, fanno la stessa fine.
In generale, le banche in una crisi d’impresa hanno interesse a negoziare soluzioni di ristrutturazione se intravedono recuperi migliori rispetto a un fallimento. Non di rado partecipano a accordi di ristrutturazione ex art.57 CCII come controparti principali (spesso dettando condizioni). Esiste anche uno strumento ad hoc nel Codice: l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 61 CCII), applicabile se almeno il 75% dei crediti finanziari aderisce. In tal caso, l’accordo può essere esteso anche ai finanziatori dissenzienti (cram-down intra-categoria finanziaria) e godere di protezioni speciali. Questo strumento è pensato quando la crisi riguarda soprattutto banche, ad esempio per rinegoziare un’esposizione bancaria elevata (tipo pool di banche per un mutuo).
Va evidenziato che molti debiti bancari sono assistiti da garanzie personali dei soci o degli amministratori (fideiussioni, pegni su azioni, ecc.). Attenzione: la procedura concorsuale dell’azienda libera quest’ultima dall’obbligazione verso la banca oltre la percentuale pagata, ma non libera il garante. Ad esempio, se Alfa Srl fa un concordato e paga solo il 50% del debito verso la Banca X, la società Alfa Srl è liberata del restante 50%, ma la banca potrà escutere il fideiussore (spesso l’amministratore o un familiare) per ottenere l’altro 50% . Questo è un problema tipico: l’imprenditore salva l’azienda ma si trova poi con posizioni debitorie personali derivate dalle garanzie prestate. Ne parleremo in dettaglio nei profili di responsabilità: spesso all’imprenditore conviene attivare parallelamente anche una procedura personale di sovraindebitamento per liberarsi dai debiti di garanzia.
In conclusione, i debiti verso banche si possono cancellare in buona parte usando concordati e accordi, ma bisogna considerare l’eventuale presenza di garanzie reali (che limitano la falcidia) e di garanzie personali (che trasferiscono il peso del debito sul garante se non si agisce anche su quel fronte). Le banche votano nei concordati e la loro adesione è spesso determinante: per questo il debitore in crisi cerca un dialogo con gli istituti fin da subito, magari sfruttando la composizione negoziata per rinegoziare i piani di rientro e ottenere una moratoria dei pagamenti.
Debiti commerciali verso fornitori e altri creditori chirografari
I debiti verso fornitori, prestatori di servizi, consulenti e altri creditori commerciali in genere sono chirografari (non garantiti, salvo riserva di proprietà su beni forniti o simili). Ciò significa che in caso di procedura concorsuale essi non hanno prelazione e concorrono in coda dopo i privilegiati. Nelle soluzioni di ristrutturazione, i debiti commerciali possono essere ridotti in maniera significativa. Ad esempio, un concordato preventivo spesso propone ai fornitori una soddisfazione parziale (es. 20-30%) dilazionata, motivando che è comunque superiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione (dove magari prenderebbero zero).
È importante però valutare anche gli aspetti di continuità aziendale: se l’impresa vuole proseguire l’attività, avrà bisogno di preservare rapporti con alcuni fornitori chiave. Perciò a volte accade che, pur essendo legalmente possibile tagliare i debiti verso tutti i fornitori, l’azienda ne paghi alcuni integralmente fuori piano (con accordi stragiudiziali) perché indispensabili per andare avanti. La legge lo consente purché si rispettino le parità tra creditori della stessa classe all’interno della procedura. In altre parole, se il debitore vuole favorire un fornitore strategico, dovrebbe escluderlo dal concordato (pagandolo prima a saldo e stralcio, se possibile) oppure includerlo in una classe separata motivando la necessità (ad esempio, fornitori essenziali in classe di continuità che vengono pagati al 100%). Il tribunale ammette queste differenze se funzionali al risanamento.
Nell’ambito degli accordi stragiudiziali, i fornitori sono spesso disposti a transazioni (ad esempio accettano il 50% a saldo subito) specie se capiscono che l’alternativa è perdere il cliente e forse incassare meno in futuro. Alcune imprese in difficoltà negoziano fornitori per fornitore i propri debiti (c.d. accordi a saldo e stralcio individuali): questo può funzionare con creditori non troppo grandi e in un contesto non ancora degenerato in insolvenza conclamata. Se però i creditori sono molti, eterogenei e qualcuno non collabora, diventa necessario ricorrere a strumenti collegiali (concordato, ecc.) che vincolino anche i dissenzienti.
Un caso particolare di debiti chirografari sono le spese di locazione e affitto (canoni di affitto di immobili, macchinari non in leasing, ecc.): il locatore non ha privilegio per i canoni futuri, quindi rientra come creditore chirografario per i canoni scaduti pre-concordato. Tuttavia, se l’azienda in concordato vuole mantenere in essere il contratto di locazione, dovrà pagare regolarmente i canoni correnti (in prededuzione) e di solito trova un accordo su quelli arretrati (ad esempio, il locatore può votare a favore se gli si riconosce una certa percentuale dei canoni scaduti). Se il locatore è essenziale (es. capannone produttivo), spesso viene pagato meglio degli altri chirografari per assicurarsi la continuità.
In generale, i debiti commerciali non hanno restrizioni normative sulla falcidia: possono essere ridotti anche drasticamente se il piano lo richiede, fermo restando che serve l’approvazione dei creditori (o l’omologa giudiziaria se si tratta di concordato). La percentuale offerta dipende da quanto valore di realizzo c’è sui beni aziendali e da eventuali apporti di finanza esterna. Nei concordati liquidatori spesso i chirografari recuperano pochissimo (5-10% o anche zero se non c’è attivo oltre i privilegi), mentre nei concordati in continuità possono arrivare a 30-50% grazie ai flussi generati dall’attività in esercizio.
Un altro sotto-tipo: i debiti verso professionisti e consulenti (avvocati, commercialisti, ecc.) per prestazioni rese pre-concordato sono anche essi chirografari. Tuttavia, se tali professionisti continuano a operare per l’azienda nel concordato (ad es. il commercialista che prepara il piano), spesso i loro crediti vengono ridefiniti come prededucibili per l’attività svolta in funzione della procedura (art. 6 CCII). Su questo decidono i giudici caso per caso. In linea di massima, comunque, i crediti professionali maturati pre-insolvenza subiscono le stesse regole degli altri: nessuna intangibilità ex lege, quindi falcidiabili.
Un esempio pratico di trattamento dei chirografari: Alfa Srl ha €200.000 di debiti verso fornitori; presenta un concordato liquidatorio offrendo ai chirografari il 20%. Se omologato, ogni fornitore vedrà trasformato il suo credito (es. €10.000) in un diritto a ricevere €2.000 nei tempi stabiliti, e null’altro – i restanti €8.000 sono legalmente inesigibili. Se però un fornitore era garantito da fideiussione personale, potrà rivalersi sul garante per il residuo. Oppure se un fornitore aveva ottenuto decreto ingiuntivo e ipoteca giudiziale prima del concordato, quella parte del suo credito diverrebbe privilegiata per via dell’ipoteca (complicando la falcidia).
In sintesi: fornitori e creditori commerciali subiscono di norma la parte più consistente del taglio dei debiti in una ristrutturazione. Il Codice della Crisi, anzi, considera fisiologico che essi ricevano un soddisfacimento parziale e dilazionato, purché la proposta non sia inferiore a ciò che otterrebbero in liquidazione giudiziale (principio di convenienza). La legge impone anche un trattamento paritario fra creditori dello stesso grado salvo giustificazione oggettiva. Ma entro questi limiti, c’è ampia libertà negoziale: il debitore può proporre ad esempio un 30% a tutti i chirografari pagato in 4 anni. Se i creditori accettano (o il giudice ritiene la proposta conveniente e la impone in caso di cram-down), il residuo 70% viene eliminato. Tutte le soluzioni di cui parleremo sono quindi strumenti per ottenere questo risultato in modo ordinato e definitivo, invece che lasciare che siano i creditori a farsi giustizia da soli (pignoramenti multipli ecc., scenario in cui spesso i fornitori piccoli non recuperano nulla).
Debiti verso dipendenti e TFR
I debiti per retribuzioni dei dipendenti, ferie non godute, TFR (trattamento di fine rapporto) e simili godono di uno speciale regime di tutela. In caso di fallimento, come accennato, interviene il Fondo di Garanzia INPS a pagare ai lavoratori le ultime mensilità e il TFR maturato, fino a determinati massimali, surrogandosi poi al loro posto tra i creditori privilegiati. Nei concordati preventivi, la legge richiede che i crediti di lavoro siano soddisfatti integralmente ove possibile: in particolare, i crediti dei lavoratori per gli ultimi 6 mesi di stipendio e per il TFR sono crediti privilegiati di grado elevato (privilegio ex art. 2751-bis c.c.) e in quanto tali vanno normalmente pagati al 100% o comunque nella stessa percentuale degli altri privilegiati di pari grado. Inoltre, l’art. 86 CCII vieta l’omologazione di concordati che prevedano il pagamento di meno del 20% ai crediti privilegiati degradati per incapienza, a meno che i titolari non vi consentano espressamente. In parole semplici, non si possono tagliare i crediti dei dipendenti sotto il 20% senza il loro consenso.
Nella prassi, nei concordati in continuità i debiti verso i dipendenti (salari arretrati) vengono spesso pagati interamente in prededuzione per mantenere la forza lavoro motivata e per ragioni di equità sociale. Nei concordati liquidatori invece, se l’attivo non basta a pagare integralmente i privilegiati, può darsi che anche i lavoratori prendano solo un acconto (ma in quel caso interviene poi l’INPS come detto). Le leggi speciali prevedono anche che se un’azienda viene ceduta durante un concordato o fallimento, il Fondo di Garanzia paghi i TFR e alcune competenze e l’acquirente ottenga l’azienda “libera” da quei debiti. Insomma, i lavoratori hanno un paracadute che altri creditori non hanno.
Quanto al trattamento nelle procedure di sovraindebitamento, i debiti verso dipendenti rientrano tra quelli non falcidiabili oltre certe soglie: il piano del consumatore o il concordato minore devono prevedere il pagamento di almeno il 40% dei crediti salariali (che la legge considera tra i crediti impignorabili, dunque protetti – art. 68 CCII richiede il pagamento integrale dei crediti impignorabili e almeno il 20% dei privilegiati). Di solito comunque in tali procedure i dipendenti sono pochi e vengono pagati per primi.
In sintesi, il punto di vista del debitore: i debiti verso i propri dipendenti non possono essere “cancellati” a piacimento, sia per vincoli legali sia per ovvie ragioni morali e di opportunità (una ristrutturazione che sacrifichi i lavoratori ha meno chances di riuscire). Tuttavia, entrando in procedura, il debitore può beneficiare dell’intervento del Fondo di Garanzia per il TFR e salari, trasferendo all’INPS il ruolo di creditore – e poi con l’INPS si negozia nella transazione contributiva. Quindi, pur rispettando le tutele, c’è un effetto indiretto di alleggerimento: l’imprenditore non deve più trovare subito i soldi per liquidare TFR e arretrati, perché interviene il Fondo (se c’è cessazione del rapporto di lavoro). Nei concordati con continuità invece i rapporti di lavoro proseguono e i debiti pregressi dei dipendenti vanno soddisfatti secondo il piano, tipicamente integralmente o quasi.
Debiti per sanzioni, multe e danni da illecito (debiti “non cancellabili”)
Ci sono alcune categorie di debiti che non possono essere cancellati nemmeno con le procedure concorsuali, o che comunque permangono anche dopo l’esdebitazione. Si tratta principalmente di:
- Multe, ammende e sanzioni penali o amministrative inflitte alla persona (ad es. contravvenzioni stradali, ammende per reati, sanzioni amministrative pecuniarie): per espressa previsione di legge, non sono soggette a esdebitazione . Ciò significa che se un imprenditore persona fisica fallisce e poi ottiene l’esdebitazione, resterà comunque obbligato a pagare eventuali multe e ammende pendenti. Lo stesso vale nel sovraindebitamento: il giudice non può omologare un piano che cancelli debiti per sanzioni penali, e se anche li includesse, comunque non sarebbero liberati. In pratica, le sanzioni per violazioni di legge mantengono natura punitiva personale e non vengono perdonate dal fallimento. Un’eccezione: le sanzioni tributarie in quanto accessori al credito erariale possono essere falcidiate nel concordato (come visto sopra), ma resta ferma l’idea che l’esdebitazione non estingue gli obblighi per sanzioni “personali”.
- Debiti per risarcimenti dovuti a illecito penale (danni civili da reato) verso persone fisiche: anche questi non sono esdebitabili . Ad esempio, se Tizio ha un debito derivante da una condanna per lesioni personali (risarcimento alla vittima), quel debito non può essere spazzato via dalla procedura concorsuale. L’ordinamento tutela così le vittime di reati: il colpevole non può liberarsi dal debito risarcitorio mediante fallimento o concordato. Diverso è il caso di danni verso società o enti: quelli sono considerati normali crediti risarcitori e rientrano nei concorsi (es. un danno ambientale a un Comune: il Comune è creditore concorsuale e il debito può essere falcidiato come tale, seppure con cautele politiche).
- Obblighi di mantenimento e alimenti: nel fallimento personale e sovraindebitamento, i debiti per assegni di mantenimento al coniuge o ai figli non vengono meno. Hanno anche privilegio sui beni. La logica è proteggere i familiari a carico: non si può usare il fallimento per non pagare l’assegno di divorzio, ad esempio.
- Obblighi di fare infungibili o oneri di bonifica ambientale: se il debito non è “sommabile” in denaro ma consiste in un dovere legale (bonificare un sito inquinato, adempiere a prescrizioni di sicurezza), la procedura concorsuale non cancella l’obbligo in sé – può al più convertirlo in un risarcimento se quell’obbligo viene violato. Ad esempio, se un’azienda fallisce lasciando un terreno inquinato, l’obbligo di bonifica grava sul proprietario (massa fallimentare) e se non c’è denaro, lo Stato potrà eseguire in danno e poi rivalersi. Ma alla chiusura del fallimento, l’obbligo reale di bonifica non si “estingue” automaticamente come un debito finanziario.
- Debiti esclusi per legge dalle specifiche procedure: Ad esempio, nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente, la legge elenca espressamente che restano fuori (non cancellati) obblighi di mantenimento, debiti per danni da fatto illecito doloso, sanzioni penali/amministrative e debiti fiscali per cui è accertato un comportamento fraudolento (art. 283 CCII). Questo per evitare abusi.
In conclusione, quando parliamo di “cancellare tutti i debiti”, occorre tenere presente che non proprio tutti possono essere eliminati: alcuni, per ragioni di ordine pubblico, rimarranno. Tuttavia, per un’azienda commerciale la stragrande maggioranza dei debiti rientra in categorie falcidiabili (fisco, banche, fornitori, contributi). Le eccezioni sopra riguardano più che altro l’imprenditore persona fisica sul piano personale: ad esempio, se Mario fallisce e aveva multe stradali o doveva un risarcimento per diffamazione, dovrà comunque pagarli dopo. Ma i debiti tipicamente “aziendali” (verso fornitori, banche, fisco per imposte, ecc.) possono quasi tutti essere ridotti o azzerati con gli strumenti giusti. Nel prosieguo, ci concentreremo su come farlo.
Strumenti stragiudiziali per gestire e ridurre i debiti
Affrontare i debiti aziendali partendo da strumenti stragiudiziali (ovvero al di fuori di una formale procedura concorsuale in tribunale) è spesso auspicabile: evita la “stigma” del fallimento, è più rapido e flessibile, e mantiene il controllo nelle mani dell’imprenditore. In questa sezione esamineremo le principali opzioni extragiudiziali: dagli accordi privati informali ai piani attestati di risanamento, fino agli accordi di ristrutturazione omologati dal giudice (che sono a metà strada tra stragiudiziale e concorsuale). Questi strumenti puntano tutti a raggiungere consensualmente i creditori o gran parte di essi, ottenendo dilazioni e stralci dei debiti senza arrivare alla dichiarazione di insolvenza giudiziale. Vediamoli in ordine crescente di complessità e “coinvolgimento” dell’autorità giudiziaria.
Accordi privati a saldo e stralcio (trattativa individuale coi creditori)
La soluzione più immediata e “low profile” è negoziare direttamente con ciascun creditore un accordo transattivo: ad esempio, offrire ad un fornitore il pagamento immediato del 30% del dovuto a titolo di saldo e stralcio, oppure proporre a una banca di rientrare dal fido in 5 anni rinunciando a parte degli interessi. Questi accordi privati non seguono schemi predefiniti di legge: rientrano nella libertà contrattuale (artt. 1322 e 1965 c.c. per le transazioni). I vantaggi sono evidenti: riservatezza (non diventano pubblici), flessibilità totale delle condizioni, nessuna formalità o costo di procedura. Purtroppo presentano anche grossi limiti:
- Necessità del consenso unanime: Ogni creditore va convinto singolarmente. Basta un creditore importante che si oppone per far fallire l’intera ristrutturazione “fai da te”. Non c’è modo di vincolare un dissenziente senza tribunale. Questo limita l’efficacia quando i creditori sono molti.
- Rischio di azioni esecutive isolate: Durante le trattative volontarie, un creditore impaziente può iniziare un pignoramento, portando magari l’azienda al collasso prima che si chiuda un accordo globale. Non c’è tutela legale (salvo accordi ad hoc di moratoria firmati da tutti, ma di nuovo serve unanimità).
- Favorire alcuni a scapito di altri: Negoziare privatamente può portare a pagare alcuni creditori e non altri. Questo espone a rischi se poi l’azienda fallisce entro 2 anni: quei pagamenti preferenziali potrebbero essere revocati dal curatore come pagamenti preferenziali vietati (bancarotta preferenziale). Anche in bonis, pagare selettivamente può far innervosire chi è escluso.
- Mancanza di “scarico totale”: L’accordo privato produce una liberazione dei debiti solo per i creditori aderenti. Se qualcuno resta fuori, potrà pretendere il 100% del suo credito (a meno di prescrizione o altre cause estintive). Dunque l’impresa rischia comunque di avere strascichi.
Nonostante questi limiti, la trattativa stragiudiziale è spesso il primo passo: un imprenditore in difficoltà cercherà di ottenere dalle banche una moratoria, dai fornitori una dilazione, dal fisco una rateizzazione ordinaria, ecc., prima di ricorrere a soluzioni concorsuali. Molte crisi aziendali vengono risolte in questo modo “informale” se l’entità del debito non è eccessiva e c’è fiducia reciproca coi creditori. Ad esempio, una tipica rinegoziazione bancaria può avvenire con il supporto di un piano di risanamento predisposto da un professionista, anche senza arrivare all’omologa.
Per mitigare i rischi, il Codice della Crisi offre un paio di strumenti ancillari:
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): è un accordo di moratoria temporanea sui crediti, in cui uno o più creditori (tipicamente banche) concordano con l’imprenditore di rinviare scadenze, congelare azioni esecutive e mantenere aperte le linee di credito per dare respiro all’impresa. Se è sottoscritta da almeno il 75% degli istituti finanziari, la convenzione può essere omologata dal tribunale e resa vincolante anche per eventuali banche dissenzienti (dello stesso tipo di crediti). È uno strumento introdotto per facilitare accordi di standstill con le banche senza dover coinvolgere subito tutte le controparti. La convenzione di moratoria in sé non riduce i debiti, ma guadagna tempo congelandoli, in attesa di attuare poi un piano.
- Aspettative dei creditori e allerta interna: Prima di partire con un concordato, il debitore può chiedere ai creditori una lettera d’intenti o standstill agreement in cui si impegnano a non agire per X mesi mentre valuta le opzioni. Non ha valore legale forte ma almeno formalizza la tregua.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 del Codice (ex art. 67, co.3, lett. d L.F.) che permette di effettuare una ristrutturazione del debito su base puramente contrattuale, ma con un “bollino” di un esperto indipendente che ne attesta la fattibilità e l’idoneità a risanare l’impresa. In sostanza, l’imprenditore predispone, insieme ai propri professionisti, un piano industriale-finanziario di rilancio dell’azienda, che includa le misure per ridurre l’indebitamento (ad esempio: nuovi apporti di capitale, cessione di asset non strategici, accordi di dilazione con i creditori, etc.). Questo piano viene sottoposto a un attestatore (un professionista indipendente e qualificato ex art. 2 CCII, spesso un commercialista o revisore) il quale redige una relazione giurata attestando che: (a) i dati aziendali sono veritieri; (b) il piano è fattibile e idoneo a assicurare il risanamento dell’impresa e il regolare pagamento dei debiti come da piano.
Una volta ottenuta l’attestazione, il piano di risanamento viene formalmente adottato dall’azienda e sottoscritto dai creditori coinvolti (in genere banche e principali fornitori). L’azienda può decidere di pubblicare un estratto del piano nel Registro delle Imprese: questa pubblicazione non è obbligatoria ma serve per dare pubblicità e soprattutto far scattare alcune tutele legali. In particolare, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del piano attestato non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 166, co.3, lett. d CCII, ex art. 67 L.F.). Ciò rassicura i creditori che aderiscono: se la società poi fallisse, non dovranno restituire i soldi incassati o vedersi annullare le garanzie ricevute, a condizione che fossero previsti dal piano e coerenti con esso.
Il piano attestato è dunque una soluzione stragiudiziale pura, con alcuni vantaggi specifici:
- Riservatezza: a parte l’eventuale pubblicazione (che comunque avviene a cose fatte, non è un procedimento pubblico come il concordato), tutto si svolge privatamente.
- Flessibilità: non ci sono requisiti di percentuali minime da offrire; si offre quel che si concorda con ciascun creditore, e non serve omogeneità di trattamento.
- Nessuna interferenza del tribunale: non c’è omologa, né commissari, né tempi morti procedurali.
- Protezione da revocatoria: come detto, il legislatore tutela questi piani per incentivarli: i creditori possono accettare ad esempio un pagamento parziale immediato senza temere che il curatore fallimentare glielo revochi poi.
Il rovescio della medaglia è che il piano attestato vincola solo chi lo sottoscrive. Tipicamente viene usato quando i creditori principali (soprattutto banche) sono d’accordo a sostenere il risanamento, e i creditori minori vengono pagati integralmente o quasi. Se, invece, c’è bisogno di imporre sacrifici significativi a una platea vasta di creditori, il piano attestato potrebbe non bastare, perché anche solo un gruppo di dissenzienti potrebbe far fallire l’operazione (ad esempio pignorando beni). Infatti, il piano attestato non offre protezione automatica dalle azioni esecutive: l’azienda, se vuole proteggersi da possibili iniziative di creditori estranei al piano, dovrà eventualmente chiedere misure protettive nell’ambito di una composizione negoziata o di un ricorso in tribunale. Il piano attestato in sé non è una procedura, è un contratto plurilaterale con alcuni creditori.
Quando si usa allora? Esempio pratico: Beta S.p.A. ha 4 banche esposte per complessivi €5 milioni e fornitori per €2 milioni. Ha buone prospettive di ripresa se ottiene dilazione dai finanziatori e nuova finanza. Beta elabora un piano a 5 anni dove l’azionista mette €500k freschi, si vendono immobili non strategici per €1M per pagare i fornitori al 50%, e le banche si accordano per allungare i mutui rinunciando a 1/3 del credito ciascuna. L’attestatore conferma che il piano è credibile e Beta tornerà solvibile. Le banche e i fornitori principali firmano accordi bilaterali coerenti col piano (le banche un accordo quadro di ristrutturazione, i fornitori accettano il 50% subito dai proventi delle vendite). Beta pubblica il piano attestato. Risultato: Beta non entra in procedura concorsuale, esegue il piano in autonomia: paga €1M ai fornitori (cancellando €1M di debiti commerciali), continua a pagare le banche a ritmi ridotti (cancellando magari €1.5M di interessi/capitale via sconto), e ottiene nuova finanza dall’azionista. Se poi Beta ce la fa, bene. Se malauguratamente Beta fallisce due anni dopo, quei pagamenti e garanzie concessi alle banche in attuazione del piano non saranno revocati dal curatore perché coperti dall’esenzione. I fornitori che hanno preso il 50% a saldo non dovranno restituirlo.
Il piano attestato è spesso il mezzo preferito per ristrutturazioni “pre-concorsuali” dove l’impresa è ancora in bonis o in crisi iniziale. Con il recepimento della direttiva UE, si è affiancato il PRO (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) che formalizza un po’ di più certi accordi, ma il piano attestato resta più snello quando c’è collaborazione dei creditori.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII e seguenti)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento a metà strada tra il piano attestato privato e il concordato preventivo pubblico. In sostanza, è un accordo contrattuale tra il debitore e una parte significativa dei suoi creditori, che viene poi sottoposto al tribunale per ottenere l’omologazione. Se omologato, l’accordo diventa efficace e vincolante anche per eventuali creditori non firmatari, ma solo in certi limiti:
- Nella forma base (art. 60 CCII), l’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti totali. I creditori che firmano accettano le riduzioni/dilazioni proposte. I creditori non aderenti restano fuori: il loro diritto non è modificato dall’accordo, ma beneficiano di una sospensione (fino a 120 giorni dalla omologa) delle azioni esecutive, periodo entro cui il debitore deve pagarli integralmente. In pratica, il 40% dissenziente va comunque saldato per intero (salvo si tratti di creditori “classe omogenea” coinvolta in un estensione, vedi dopo). L’accordo dunque non è un concorso pieno: è efficace inter partes con chi l’ha accettato. Serve soprattutto a regolare posizioni con i principali creditori, mentre i piccoli possono essere liquidati a parte.
- Il Codice, però, introduce vari tipi di accordi “estensivi”: ad esempio, l’art. 61 CCII permette, come ricordato, che se l’accordo è sottoscritto da il 75% degli intermediari finanziari (banche), esso sia dichiarato efficace dal tribunale anche per le banche non aderenti (purché a queste sia stato offerto il pieno soddisfo del valore di mercato delle loro garanzie). Similmente, l’art. 64 CCII consente che i creditori estranei non possano iniziare o proseguire azioni esecutive dopo la pubblicazione dell’accordo omologato, per tutelarne l’esecuzione. Inoltre c’è il accordo agevolato al 30% introdotto dal 2022: se il debitore raggiunge almeno il 30% di adesioni e l’accordo prevede l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologa, può chiedere comunque l’omologa col beneficio di protezioni (è un modo per iniziare con meno consensi, ma pagando cash i dissenzienti).
- Una figura peculiare è l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII per banche e art. 63 CCII per fornitori strategici): ad esempio, se il 75% di una classe omogenea di creditori (es. tutti fornitori di una certa merce) aderisce, il debitore può chiedere al tribunale di estendere gli effetti ai non aderenti di quella classe, purché essi abbiano possibilità di essere soddisfatti in misura non inferiore a quella prospettata (questo richiama concetti del concordato cram-down per classi). È una novità concepita per recepire la direttiva UE sui quadri di ristrutturazione preventiva: di fatto, un mini-cram-down settoriale.
Proceduralmente, l’accordo di ristrutturazione richiede: la redazione di un piano, magari con attestazione di veridicità dei dati (obbligatoria) e fattibilità (se ci sono dilazioni lunghe); la raccolta delle adesioni scritte dei creditori; la pubblicazione della domanda di omologa presso il Registro delle Imprese; l’intervento eventuale di un commissario giudiziale se richiesto; infine il decreto di omologa da parte del tribunale, che verifica il rispetto delle percentuali e la convenienza dell’accordo per i creditori estranei (non devono essere pregiudicati). Non c’è voto in adunanza come nel concordato: la “votazione” avviene privatamente raccogliendo le firme. Una volta omologato, l’accordo viene eseguito dal debitore: se poi il debitore non rispetta le intese, i creditori potranno agire singolarmente (non c’è un istituto di risoluzione giudiziaria equiparabile al concordato, se non per inadempimenti gravi che possono portare a insolvenza e quindi a fallimento).
In termini di cancellazione dei debiti, l’accordo di ristrutturazione permette di ottenere effetti simili al concordato ma in modo consensuale: i creditori aderenti rinunciano formalmente a una parte dei loro crediti (stralcio) secondo le percentuali concordate. Con l’omologa, quell’accordo acquista stabilità e i creditori aderenti non possono più tirarsi indietro. I creditori non aderenti dovranno essere pagati fuori dall’accordo (il che in sostanza significa che non li stiamo “cancellando”, a meno che li paghiamo integralmente o li facciamo rientrare poi in un eventuale concordato se l’accordo fallisce). L’accordo è molto utile quando l’impresa ha pochi grandi creditori (facile raggiungere 60-75%) e un certo numero di piccoli creditori indifferenti che possono essere soddisfatti in via ordinaria. Se invece l’impresa ha centinaia di piccoli creditori, raccogliere il 60% in valore può essere vano se restano fuori troppi soggetti attivi. In quei casi conviene il concordato.
Una variante prevista è l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (art. 57, co.2, lett. c CCII): se riguardante prevalentemente debiti finanziari, è possibile omologare l’accordo con percentuali di adesione inferiori purché si tratti di tutte banche e queste rappresentino almeno il 75% dei crediti finanziari. Questo incide solo su una fetta di debiti.
Esempio pratico: Gamma Srl ha 3 banche per 70% del debito e vari fornitori per 30%. Trova un accordo scritto con le 3 banche: esse allungano i prestiti e ne abbattono il totale del 40%. Gamma presenta l’accordo al tribunale con adesioni pari al 70% (le banche). Propone di pagare integralmente i fornitori estranei entro 60 giorni dall’omologa (con la nuova finanza ottenuta grazie alle banche). Il tribunale omologa l’accordo. Risultato: i debiti verso banche scendono del 40% (cancellati legalmente) e i fornitori vengono pagati regolarmente (nessun taglio per loro). Gamma esce dall’accordo con una struttura finanziaria più leggera e nessun contenzioso pendente. – In questo caso l’accordo funziona bene. Se invece Gamma avesse voluto tagliare anche i fornitori, avrebbe dovuto includerne almeno una parte nelle adesioni o trasformare l’operazione in un concordato (perché non poteva forzare i piccoli a subire stralci senza consenso).
Una tutela importante per l’imprenditore: dalla data di pubblicazione della domanda di omologa di un accordo, può chiedere al tribunale misure protettive (stay) che sospendono le azioni esecutive dei creditori fino all’omologa. Inoltre, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Questo consente al debitore di respirare e impedire che qualcuno rovini l’accordo all’ultimo. Durante le trattative iniziali (prima del deposito) questo non c’è, ma spesso l’accordo viene presentato solo quando già blindato.
Riassumendo, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento flessibile per cancellare parzialmente i debiti con l’assenso di una maggioranza qualificata dei creditori e l’avallo del tribunale. È meno vincolante e “stigmatizzante” del concordato (che è notoriamente una procedura concorsuale aperta pubblicamente), ma comunque offre certe garanzie legali (protezione interinale, omologa che conferma la validità erga omnes, esenzioni da revocatorie per atti esecutivi dell’accordo similmente al piano attestato). Non a caso, negli ultimi anni molte grandi imprese indebitate hanno preferito gli accordi ex art. 182-bis L.F. (ora art. 57 CCII) ai concordati, per gestire le ristrutturazioni in modo più consensuale e modulare. L’inconveniente principale è che non risolve da solo l’intera crisi se restano sacche di dissenso – ma può essere combinato, ad esempio, con un concordato solo per i dissenzienti (c’è stata giurisprudenza di “concordato di gruppo dissenzienti”, pratica complessa che il CCII cerca di superare con i meccanismi di estensione e col PRO).
Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO)
Introdotto con il correttivo 2022, il P.R.O. si colloca anch’esso nel panorama delle soluzioni “negoziali” ma con forte intervento giudiziale. Come visto nel quadro normativo, è disciplinato dagli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII e deriva dal recepimento della Direttiva UE 2019/1023. Si può definire il PRO come una via intermedia tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo.
In sintesi, il PRO consente al debitore, anche in stato di insolvenza conclamata (o in mera crisi), di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori suddivisi in classi. Tale piano viene votato dai creditori (o meglio, approvato per adesione) fuori dal tribunale, ma con soglie decisamente più basse rispetto al concordato: è sufficiente infatti il consenso di tutti i soggetti interessati in almeno una classe (quindi anche solo una classe che approva al 100%) purché le altre classi non subiscano un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione. In pratica, il PRO permette di bypassare il principio di unanimità intra-classe e il principio di priorità assoluta se c’è un consenso qualificato in ciascuna classe. Ad esempio, se in ogni classe almeno la maggioranza approva (o addirittura il 75% in valore), il tribunale può omologare il piano nonostante il dissenso di minoranze significative e persino di intere classi, a condizione di rispettare certe condizioni di equità (nessuna classe dissenziente può ricevere meno di quanto riceverebbe in liquidazione e rispetto alle classi inferiori/superiori secondo un criterio di priority flessibile, c.d. relative priority rule).
Il PRO è destinato alle imprese medio-grandi (fallibili), escludendo esplicitamente le “imprese minori” non fallibili e gli imprenditori agricoli. Può essere utilizzato sia per mantenere in funzione l’impresa (piano in continuità) sia per liquidarla gradualmente (piano liquidatorio), infatti la norma non impone la continuità. Ad esempio, un PRO potrebbe prevedere che un investitore inietti capitale, alcune linee produttive vengano chiuse, i crediti di fornitori vengano falciati all’80%, quelli delle banche al 50%, ecc., con l’accordo di alcune classi e l’imposizione alle altre.
Tecnicamente, il PRO funziona così: il debitore elabora un piano e lo propone ai creditori organizzati in classi omogenee. Raccoglie le adesioni dalle varie classi. Se in ogni classe votante si raggiunge la soglia richiesta (che, semplificando, è il 75% dei crediti della classe, ma la norma consente omologa anche con percentuali minori in alcune circostanze), il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione del piano. Il tribunale, sentiti eventuali oppositori, verifica la legalità e fattibilità del piano e soprattutto che i creditori dissenzienti non vengano trattati ingiustamente. Può applicare un cram-down interclassi, ossia approvare il piano anche se una o più classi hanno votato contro, a patto che: (a) almeno una classe “di grado alto” ha approvato; (b) il piano non altera l’ordine delle cause di prelazione se non col consenso necessario; (c) i dissenzienti non prendono meno del valore di liquidazione; (d) nessuna classe subordinata ottiene più di una classe sovraordinata dissenziente (per rispettare la fairness).
Il PRO dunque può portare a cancellare i debiti in modo anche coattivo verso intere classi di creditori dissenzienti – cosa che nel concordato tradizionale italiano non era possibile se una classe votava contro e superava il 50% dei crediti, salvo eccezioni fiscali. Qui invece il giudice può forzare, come succede nel Chapter 11 statunitense, una ristrutturazione anche su creditori contrari, se il piano complessivamente rispetta equità. Ciò rende il PRO uno strumento potentissimo dal punto di vista del debitore: evita di dover ottenere il voto favorevole di tutti i chirografari o di tutti i privilegiati, permettendo soluzioni innovative (es. conversione di debiti in equity anche se qualcuno preferiva il fallimento, riduzione di garanzie se il valore di realizzo è rispettato, ecc.).
Va detto però che il PRO, essendo nuovo, richiede accurata preparazione. Deve anch’esso essere accompagnato da una relazione di attestazione sulla capacità di soddisfare il 10% dei crediti chirografari o il 30% in caso liquidatorio (requisiti analoghi al concordato). Può prevedere nuova finanza protetta (finanza interinale) e misure protettive durante le trattative, analogamente alla composizione negoziata, infatti spesse volte un PRO potrà derivare da una Composizione Negoziata non riuscita totalmente ma con accordi parziali.
In pratica, il PRO arricchisce le opzioni: se il debitore ha consenso largo, può fare un accordo ex art.57; se ne ha poco può dover andare in concordato; ma se sta nel mezzo – ha consenso significativo ma non totale e vuole evitare il fallimento – può usare il PRO per chiedere al giudice di “schiacciare” le resistenze residue. Un utilizzo tipico: banche e obbligazionisti favorevoli, fornitori contrari; col PRO il giudice può imporre anche ai fornitori di accettare il piano se comunque prendono più che nel fallimento.
Esempio di PRO: Delta S.p.A. ha debiti: 100 milioni verso banche con ipoteche su stabilimenti (valore immobili 70M), 30M verso obbligazionisti chirografari, 20M verso fornitori. Il piano PRO propone: conversione di metà debito obbligazionario in azioni (quindi 15M condonati), pagamento al 100% in 5 anni delle banche garantite (quindi nessuna falcidia sul valore di garanzia, ma la parte scoperta oltre 70M viene tagliata) e pagamento del 30% ai fornitori. Si formano classi: Classe 1 banche (hanno privilegio, di fatto prendono ~70% del loro credito – ma accettano perché temono di peggio nel fallimento), Classe 2 obbligazionisti (accettano conversione e prendono nuove azioni e 50% residuo, apprezzando la prospettiva di equity se risanano), Classe 3 fornitori (contrari perché 30% pare basso). Le prime due classi (che rappresentano >80% del debito) approvano. La terza classe vota no (20M no). Nel concordato ordinario, ciò sarebbe fatale se i fornitori fossero più di metà dei chirografari. Nel PRO, Delta chiede ugualmente l’omologa: il tribunale verifica che i fornitori col 30% prendono comunque più dello zero ipotetico che avrebbero in fallimento (dato che banche con ipoteca prenderebbero tutto l’attivo) e che nessuna classe inferiore ai fornitori prende qualcosa (non ce ne sono di inferiori). Quindi omologa il piano anche se i fornitori erano contrari. Effetto: banche riducono crediti a 70M (cancellando 30M), obbligazionisti stralciano 15M convertendoli in equity, fornitori stralciano 14M su 20M prendendo 6M. Delta ottiene ~59M di debiti cancellati e continua l’attività, con nuova struttura patrimoniale. I fornitori dissenzienti devono accettare la perdita forzata (ma d’altronde avrebbero avuto zero se Delta falliva). Questo caso illustra la potenza del PRO come “concordato di nuova generazione”.
In definitiva, il PRO è uno strumento avanzato, adatto a situazioni complesse in cui ci sono più categorie di creditori con interessi diversi. Permette soluzioni creative (es. ristrutturazioni finanziarie spinte) con l’ombrello del tribunale, ma senza passare per l’intera liturgia del concordato (anche se gli somiglia molto). Per l’obiettivo di “cancellare debiti aziendali”, il PRO è particolarmente utile quando serve forzare minoranze dissenzienti mantenendo comunque la continuità e il valore d’impresa. Poiché è nuovo, è fondamentale guardare ai primi casi decisi: la giurisprudenza del 2023-25 ha iniziato a confermare che il PRO può essere utilizzato anche per proposte liquidatorie (cessazione attività con distribuzione ai creditori secondo classi), e ha chiarito come applicare le regole di cram-down. Un aspetto interessante in ambito fiscale: inizialmente il TUIR non includeva il PRO tra le procedure esenti tassazione di sopravvenienze, ma una risposta Agenzia Entrate n.79/2025 ha confermato che la nota di variazione IVA per crediti inesigibili si può emettere all’omologa del PRO (segno che il Fisco l’ha assimilato alle procedure concorsuali). Ci aspettiamo che presto anche il PRO venga inserito nelle esenzioni di cui parlavamo (per evitare tassazione delle parti condonate).
Convenzione di moratoria e accordi parziali
Abbiamo accennato alla convenzione di moratoria (art. 62 CCII) come strumento per ottenere dai creditori – in particolare finanziari – un congelamento temporaneo delle azioni e un differimento delle scadenze durante la crisi. Vale la pena spendere due parole in più: la convenzione di moratoria può essere autonoma o integrativa di una composizione negoziata. Ad esempio, un imprenditore in difficoltà può proporre alle banche un accordo tipo: “tutti i pagamenti quota capitale dei mutui sospesi per 6 mesi, interessi ridotti, fidi mantenuti in essere, nessuna revoca di fido in questo periodo, in cambio l’azienda si impegna a non aggravare esposizioni e a presentare un piano entro tale data”. Se almeno il 75% delle banche (in valore di credito) accetta, l’imprenditore può chiedere l’omologa di questa convenzione. L’omologa la rende vincolante anche per eventuali banche dissenzienti (poche, auspicabilmente). Durante la moratoria, le banche non possono revocare affidamenti né iniziare azioni individuali. Ciò non risolve i debiti in sé, ma previene escalation e dà spazio per implementare un successivo accordo. In un certo senso è uno strumento “ponte”.
Analoghe moratorie possono essere stipulate anche con i fornitori (ad es. un pool di fornitori strategici decide di continuare a rifornire l’azienda a patto di essere pagati per cash on delivery e di attendere 12 mesi per gli arretrati, senza mettere in sofferenza il cliente). Non esiste un istituto di omologa per fornitori come per le banche, ma si può sempre includere quell’accordo in un successivo piano attestato o accordo.
Accordi parziali: Il Codice consente inoltre al debitore di combinare strumenti: ad esempio accordo di ristrutturazione “ad efficacia parziale” e poi un concordato per i rimanenti creditori (cosiddetto “concordato misto”). Un caso: l’impresa fa un accordo con le banche (che hanno il 50% del debito) e poi presenta un concordato preventivo per falcidiare il restante 50% di debiti (fornitori). Questo era praticato sotto la L.F. ed è teoricamente fattibile anche oggi, ma il Codice preferisce soluzioni unitarie come il PRO per evitare doppie procedure.
In conclusione sugli strumenti stragiudiziali: il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione (con eventuali convenzioni di moratoria) costituiscono le soluzioni negoziali classiche per ridurre/cancellare i debiti aziendali senza passare per la liquidazione giudiziale. Permettono flessibilità e riservatezza, ma richiedono un sufficiente grado di cooperazione da parte dei creditori. Quando questa manca o non è completa, si ricorre a soluzioni con più intervento giudiziario (PRO, concordato). È importante sottolineare che anche in fase stragiudiziale l’imprenditore deve operare con trasparenza e correttezza: presentare ai creditori dati veritieri, non occultare finti crediti o attivi (il che costituirebbe reato di frode se poi si va in procedura). La presenza dell’attestatore è una garanzia in tal senso.
La composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata merita un capitolo a parte, poiché è una procedura innovativa (introdotta dal D.L. 118/2021, confluito nel CCII) che si situa tra le soluzioni stragiudiziali e quelle concorsuali. L’idea di fondo è offrire all’imprenditore in difficoltà un percorso assistito da un esperto indipendente, per favorire il raggiungimento di un accordo con i creditori o comunque per individuare la soluzione migliore per superare la crisi, prima che questa degeneri in insolvenza irreversibile.
Accesso e caratteristiche
Può accedere alla composizione negoziata qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far prevedere la crisi o l’insolvenza, ma che appaiono risanabili. Non serve essere già insolventi; anzi, lo strumento è concepito per la fase di allerta (pur non essendo obbligatorio attivarlo). L’imprenditore presenta una domanda tramite la piattaforma telematica nazionale, allegando informazioni contabili, un piano d’azione ipotetico e indicazioni sulle trattative necessarie. Un’apposita commissione presso la CCIAA nomina un esperto della crisi – figura indipendente, scelta da elenchi di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con esperienza).
L’esperto ha il compito di facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori, in uno scenario confidenziale (gli incontri avvengono in privato). L’esperto valuta la situazione e, se ritiene esistano concrete possibilità di risanamento, elabora con l’imprenditore un percorso. Ha poteri limitati: non può imporre accordi ai creditori, ma può convocarli e agevolare scambi di informazioni, cercando un consenso.
Durante la composizione negoziata, l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda: l’esperto non ha poteri di gestione. Tuttavia, per tutelare la situazione, il debitore può chiedere misure protettive al tribunale: ad esempio la sospensione temporanea delle azioni esecutive dei creditori (di regola concessa per max 4 mesi, prorogabili fino a 12 in casi complessi, ex art. 18 CCII). Questa protezione è pubblicata nel registro imprese, quindi nota al mercato.
Una peculiarità: durante la composizione negoziata, l’impresa può compiere atti di gestione straordinaria solo con l’autorizzazione del tribunale se l’esperto concorda (art. 20 CCII). Ad esempio, vendere un immobile rilevante, contrarre nuova finanza super-senior, cedere l’azienda: sono possibili, ma serve il nulla osta del giudice, il quale valuta l’utilità per la trattativa. Ciò per evitare che l’imprenditore “sperperi” patrimonio durante le trattative.
Inoltre, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può autorizzare specifiche misure come contratti-ponte (es. ottenere finanziamenti prededucibili, o pagare fornitori strategici in prededuzione) se funzionali a migliorare le prospettive di risanamento (art. 22 CCII).
Esiti possibili della composizione negoziata
La procedura di composizione negoziata si può concludere in vari modi:
- Accordo stragiudiziale con i creditori: L’esito ideale è che grazie all’esperto l’imprenditore raggiunga un accordo volontario con tutti o con la maggior parte dei creditori. Può essere un accordo unico firmato da creditori rappresentanti la quasi totalità del debito, o accordi plurimi bilaterali (se l’esperto certifica che nel complesso risolvono la crisi). Tali accordi possono restare riservati oppure, se il debitore vuole avvalersi della protezione ex art. 67, co.3, lett. d) L.F., può farli asseverare dall’esperto come conformi ad un piano idoneo al risanamento. In quest’ultimo caso, l’accordo produce gli effetti di un piano attestato agli effetti della non revocabilità (art. 23 CCII richiama art. 166, co.3, lett. d CCII). Dunque, l’esperto controfirma e attesta il piano, che può poi essere pubblicato come piano attestato ex post. In pratica: la composizione negoziata può sfociare in un piano attestato di risanamento con la “benedizione” dell’esperto.
- Contratto o convenzione con l’esperto: Se non si riesce ad avere l’adesione di tutti i creditori, è previsto che l’imprenditore possa concludere un contratto con uno o più creditori che viene validato dall’esperto (art. 23, co.1 CCII). Questo contratto, purché sottoscritto anche dall’esperto, produce gli effetti protettivi dell’art. 67, comma 3, lett. d L.F. (non revocabilità). Similmente, si può fare una convenzione di moratoria con alcuni creditori finanziari (ex art. 23, co.2) sempre con controfirma dell’esperto per renderla non soggetta a revocatoria. Questi strumenti permettono di formalizzare parziali intese con un marchio di garanzia, anche se non c’è l’adesione universale.
- Accesso a una procedura concorsuale “classica”: se le trattative evidenziano che serve comunque una procedura, l’imprenditore può “saltare” direttamente ad essa. Il Codice facilita ciò esentando da alcuni adempimenti: ad esempio, se l’imprenditore deposita una domanda di concordato preventivo in continuità o liquidatorio durante o subito dopo la composizione negoziata, può chiedere misure premiali (riduzione sanzioni penali, ecc.) e la procedura prosegue. C’è anche l’opzione speciale del concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) se la composizione fallisce e l’esperto attesta l’assenza di soluzioni migliori. In tal caso, come visto, il debitore può proporre un concordato liquidatorio senza passare per il voto dei creditori. Questa è una via “di uscita” per evitare la liquidazione giudiziale disordinata se la negoziazione non ha portato accordo ma c’è comunque qualcosa da distribuire.
- Rinuncia o archiviazione: se l’imprenditore capisce che la composizione negoziata non porta frutti e non vuole altre procedure, può ritirarsi. L’esperto redige una relazione finale. Se l’esperto ravvisa che l’imprenditore ha aggravato il dissesto o commesso irregolarità, lo segnala e i creditori possono essere attivati (in teoria, segnalazioni a Procura o simili per dichiarazione d’ufficio di insolvenza – ma il CCII ha previsto solo segnalazioni ex art. 22 per il caso di atti pregiudizievoli).
Vantaggi per il debitore nella composizione negoziata
Dal punto di vista di cancellare o ridurre i debiti, la composizione negoziata di per sé non cancella nulla automaticamente. È un percorso facilitato per raggiungere uno degli accordi o piani di cui abbiamo già parlato (piano attestato, accordo di ristrutturazione) o per accedere a un concordato. I vantaggi concreti includono:
- La figura terza dell’esperto può convincere creditori inizialmente scettici sulla convenienza di un accordo, fornendo garanzie di imparzialità e trasparenza. Ciò aumenta le chance di ottenere stralci e dilazioni su base volontaria.
- Le misure protettive accordate dal tribunale (il “ombrello” di sospensione dei pagamenti e blocco delle azioni esecutive) danno il tempo necessario a strutturare la proposta senza la pressione di pignoramenti immediati. È come un freeze temporaneo del contenzioso, evitando che un creditore aggressivo rovini la trattativa collettiva.
- L’imprenditore che attiva per tempo la composizione negoziata ed eventualmente la conclude con un concordato gode di misure premiali anche penali: l’art. 25 CCII prevede attenuanti di pena o non punibilità per alcuni reati concorsuali se ci si è attivati tempestivamente. Ad esempio, se durante la trattativa l’imprenditore collabora lealmente e poi comunque finisce in liquidazione giudiziale, potrà avere uno sconto di pena in caso di bancarotta semplice grazie alla sua iniziativa tempestiva.
- Nel frattempo, la gestione dell’impresa continua e può anche migliorare: l’esperto può consigliare dismissioni di rami improduttivi, ricerca di investitori, ottimizzazione costi, tutte azioni che fanno parte del risanamento e che con il suo imprimatur acquistano credibilità verso i creditori. La composizione negoziata è quindi anche un processo di consulenza aziendale.
In pratica, la composizione negoziata è diventata uno strumento standard nel kit di un’azienda indebitata: conviene provare questa strada prima di gettarsi in un concordato “al buio”. Spesso, già il semplice avvio con nomina dell’esperto spinge i creditori a sedersi al tavolo seriamente.
Esempio pratico di composizione negoziata: Zeta SRL (azienda manifatturiera) è in difficoltà per calo fatturato e debiti €3M. Avvia la composizione negoziata. L’esperto analizza e vede che l’azienda è risanabile tagliando certi costi e vendendo un capannone inutilizzato. Convoca banche e principali fornitori. Dopo 2 mesi di incontri, si perviene a questo: le banche (esposte per €1M) accettano di prorogare i mutui di 5 anni riducendo il tasso, e di non revocare i fidi; i fornitori (esposti 0.5M) accettano il 50% a saldo; l’Erario (cartelle per 0.3M) viene inserito in richiesta di rottamazione-quater con pagamento in 18 rate; l’imprenditore apporta 0.2M liquidi vendendo un immobile personale; l’azienda vende il capannone per 0.8M; con questi soldi paga i fornitori al 50% e fa ripartire la produzione. L’esperto attesta che il piano regge e risana l’impresa entro 2 anni. Si formalizza un contratto di ristrutturazione firmato dall’esperto e dall’impresa che vincola le banche (moratoria) e i fornitori (transazione 50%). Non serve omologare nulla. L’intera operazione resta riservata salvo la pubblicazione della conclusione positiva. Zeta SRL non entra in concordato, ma grazie alla negoziazione ha cancellato 0.25M di debiti fornitori, ridotto oneri bancari, e dilazionato il fisco, il tutto in pochi mesi e senza etichetta concorsuale. – Questo scenario virtuoso è quello a cui aspira la riforma.
Qualora invece una composizione negoziata non riuscisse perché alcuni creditori chiave rifiutano qualunque intesa, l’imprenditore potrà passare ad un concordato preventivo (in continuità se l’attività è ancora valida). Però almeno ci arriverà con maggior consapevolezza e avrà già esplorato soluzioni.
Da notare: la composizione negoziata non richiede soglie di debito minime o massime, e non comporta insolvenza legale. Dunque, per un imprenditore onesto e cooperativo è un modo per tentare il risanamento “senza perdere la faccia” con clienti e dipendenti – tant’è che la legge garantisce la riservatezza delle informazioni apprese dall’esperto e anche vieta che durante la procedura i contratti essenziali (come forniture in corso) possano essere risolti unilateralmente per il solo fatto delle trattative (art. 19 CCII). Ciò evita che semplicemente trattare con i creditori causi panico e peggiori la crisi.
In termini di percentuale di successo, essendo un istituto giovane non abbiamo statistiche consolidate. Ma sicuramente per cancellare i debiti aziendali con il minor danno, se la situazione non è compromessa, questa via andrebbe sempre tentata. Anche il legislatore spinge in tal senso, al punto che eventuali curatori fallimentari successivi devono valutare se l’imprenditore ha colpevolmente mancato di attivarsi per tempo (potrebbe essere indice di mala gestio).
Il concordato preventivo: come ridurre o azzerare i debiti con un piano omologato
Il concordato preventivo è storicamente la procedura concorsuale per eccellenza per evitare il fallimento, attraverso un accordo con i creditori sotto supervisione del tribunale. Pur essendo uno strumento “classico” (esiste dal 1942 nella legge fallimentare), con le riforme più recenti è diventato molto flessibile e adatto anche a finalità di risanamento con prosecuzione dell’attività (non solo liquidazione).
Tipologie di concordato: in continuità vs liquidatorio
Il Codice della Crisi distingue due grandi categorie:
- Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): quando il piano prevede che l’attività d’impresa prosegua, sia perché la stessa società debitore continua a operare (continuità diretta), sia perché l’azienda viene trasferita ad un altro soggetto che la manterrà in esercizio (continuità indiretta, ad esempio vendita a un investitore che garantisce produzione e livelli occupazionali). In questo tipo di concordato, la ragionevole aspettativa di generare flussi di cassa futuri consente di offrire ai creditori un soddisfacimento migliore rispetto alla chiusura immediata. La legge consente nel concordato in continuità di pagare gradualmente i creditori con i proventi della gestione, entro determinate scadenze (massimo 10 anni per privilegiati, 4/5 anni per chirografari salvo consenso). E impone misure a tutela dei creditori, ad esempio: se un creditore privilegiato subisce una dilazione, ha diritto alle cd. percentuali d’interesse concordatarie per essere compensato del ritardo; i creditori devono ricevere almeno il valore attuale di quanto otterrebbero liquidando subito (art. 112 CCII).
- Concordato liquidatorio: quando invece il piano prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione di tutto il patrimonio, distribuendo il ricavato ai creditori. In passato si chiamava concordato “fallimentare” (perché è alternativo al fallimento e ne ricalca la logica di liquidazione). Nel concordato liquidatorio puro, la soddisfazione dei creditori deriva dalla vendita dei beni e non dal proseguimento del business. Il Codice richiede qui uno sforzo maggiore: è ammesso solo se i creditori chirografari ricevono almeno il 20% (art. 84, co.4 CCII) – soglia ridotta dal vecchio 30%, per allinearsi alla direttiva UE. Inoltre, se la proposta prevede l’intervento di un terzo assuntore (qualcuno che rileva l’azienda in blocco e si accolla i debiti in parte), si applicano regole specifiche (il concordato con assuntore). Il concordato liquidatorio è spesso l’extrema ratio se non ci sono prospettive di salvare l’azienda, ma si vuole evitare la liquidazione giudiziale perché col concordato si può offrire una soddisfazione superiore ai creditori in minor tempo.
Va segnalata la presenza nel Codice anche del “concordato minore” per i soggetti sovraindebitati (di cui abbiamo trattato sopra), che è un parallelo semplificato del concordato preventivo rivolto ai piccoli imprenditori. Ma qui focalizziamo sul concordato preventivo ordinario, per imprese soggette a liquidazione giudiziale.
Procedimento di concordato: ammissione, voto, omologa
Il concordato preventivo si svolge così:
- L’imprenditore (debitore) presenta in tribunale un ricorso contenente la proposta, il piano e la documentazione richiesta (bilanci, elenco creditori, inventario attivo, attestazione di un professionista su veridicità dei dati e fattibilità del piano). Può farlo anche in via “prenotativa” (concordato in bianco, art. 44 CCII) riservandosi di depositare piano dettagliato entro un termine.
- Il tribunale valuta i requisiti formali (assenza di cause di inammissibilità, ad es. atti fraudolenti antecedenti) e l’esistenza di un piano con possibilità di successo almeno astratta. Se tutto è ok, ammette il debitore al concordato e nomina un commissario giudiziale (figura di controllo). Da quel momento, il debitore mantiene l’amministrazione ordinaria dell’impresa ma sotto vigilanza del commissario, e non può compiere atti straordinari senza autorizzazione del giudice delegato.
- Viene fissata l’adunanza dei creditori, tipicamente entro 120-180 giorni. Nel frattempo il commissario comunica a tutti i creditori la proposta e raccoglie le loro osservazioni. Alla data stabilita, si tiene la votazione: i creditori aventi diritto al voto (tutti i chirografari e gli eventuali privilegiati che rinunciano a privilegio o sono incapienti) esprimono il loro voto sulla proposta concordataria, eventualmente suddivisi per classi se il piano prevede classi. Il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (50% + 1) complessivamente. Se sono previste classi, conta sempre la maggioranza aggregata, ma occorre anche che almeno la maggioranza delle classi voti sì (requisito delle classi: es. 3 classi su 5 favorevoli). In un concordato in continuità con classi, può aversi il caso di cram-down su classi dissenzienti se il dissenso viene da classi che riceveranno soddisfazione integrale (100%) oppure sono trattate meglio di inferiori – c’è una norma ad hoc (art. 112 CCII). Comunque, in generale, serve convincere i creditori.
- Se la votazione ha successo, si passa alla fase di omologazione: il tribunale tiene udienza; eventuali creditori dissenzienti possono fare opposizione contestando la legittimità della proposta o la correttezza del voto o la convenienza (quest’ultima in maniera limitata: il giudice non può sindacare nel merito la convenienza economica se c’è maggioranza, salvo il caso di cram-down fiscale dove può omologare nonostante il no del Fisco se il piano è conveniente ex art. 48 CCII). Il tribunale verifica tutto (anche il rispetto delle percentuali minime, l’assenza di frodi ai creditori, ecc.). Se non c’è motivo ostativo, emette decreto di omologa, che rende il concordato vincolante erga omnes.
- A seguito dell’omologa, il debitore deve eseguire il piano concordatario sotto la sorveglianza di un commissario (che tipicamente diventa liquidatore giudiziale se c’è da vendere beni). Se l’impresa è in continuità, continuerà a operare e a pagare i creditori secondo le scadenze concordate; se era liquidatorio, si procederà a liquidare l’attivo e a distribuire i riparti concordati.
- Una volta eseguite le obbligazioni del piano, il tribunale dichiara adempiuto il concordato e la procedura si chiude definitivamente. A quel punto, ogni debito anteriore rimasto insoddisfatto è inesigibile verso il debitore: di fatto, il concordato funge da esdebitazione “indiretta”. Se invece il debitore non rispetta il piano (inadempimento rilevante), su istanza dei creditori si può dichiarare la risoluzione del concordato e di solito ciò porta dritti alla liquidazione giudiziale (fallimento) post concordato, con i creditori che riacquistano i diritti originari al netto di quanto eventualmente incassato in concordato.
Come il concordato “cancella” i debiti aziendali
Nel concordato, i debiti aziendali vengono trattati e ridotti secondo la proposta:
- I creditori chirografari (fornitori, banche unsecured, etc.) ricevono la percentuale proposta (es. 30%) in soddisfazione. La parte eccedente è rinunciata dai creditori in forza dell’approvazione e omologa: in altri termini, quel 70% viene legalmente annullato e il creditore non potrà più pretenderlo. L’omologazione funge da titolo costitutivo di novazione parziale del debito: ciò che non è previsto dal piano è estinto. Quindi, per i chirografari, il concordato cancella i debiti residui.
- I creditori privilegiati (Erario, banche ipotecarie, dipendenti, etc.) vengono pagati almeno fino a concorrenza del valore di garanzia o privilegio. La parte eventualmente incapiente (non coperta da valore del bene sottostante) diventa chirografaria e subisce la stessa sorte di cui sopra. Esempio: banca con mutuo 200k garantito da ipoteca su immobile che in concordato è valutato 150k e verrà venduto a tale prezzo; la banca prenderà 150k (100% della parte privilegiata) e per i restanti 50k voterà come chirografaria e magari incasserà il 30% (15k). Dunque, alla fine il suo credito da 200k viene ridotto a 165k incassati; i restanti 35k vengono cancellati (non potrà più chiederli). Per i privilegiati integralmente capienti, il concordato di solito prevede pagamento integrale (a meno che accettino spontaneamente una riduzione – ipotesi rara). Tuttavia, la legge consente, con il loro consenso specifico, di alterare anche la prelazione: ad esempio, se un creditore ipotecario decide di aderire al concordato rinunciando a una parte del suo privilegio, può farlo (magari in cambio di altro, come equity o mantenimento di rapporto commerciale). Ma è volontario.
- I debiti fiscali e contributivi vengono trattati come spiegato nella sezione fiscale: oggi è possibile includere anche falcidie di imposte dirette e, con cautela, anche di IVA (solitamente no) e ritenute (no). L’omologa di un concordato con transazione fiscale formalizza lo stralcio accordato: ad esempio, se l’Agenzia Entrate accetta 50% di IRES e 0% di sanzioni, l’omologa sancisce che quel 50% pagato estingue interamente il debito tributario, e cancella le sanzioni. Se l’Agenzia non accetta ma il giudice omologa lo stesso in forza di cram-down (art. 48 CCII), l’effetto è analogo: l’importo ridotto offerto e depositato libera il contribuente da ulteriori pretese sul residuo.
- Debiti verso fornitori e trade creditors: come per qualsiasi chirografo, la quota non pagata è annullata. L’azienda in concordato di solito perde i fornitori insoddisfatti come partner commerciali (a meno che questi, una volta incassata la percentuale, decidano di continuare a lavorare con l’azienda risanata, cosa che a volte avviene se l’azienda dimostra di essere tornata in bonis). In alcuni casi, però, un fornitore strategico viene pagato integralmente fuori dal concordato per poterlo mantenere – ciò è fattibile solo se lo si esclude dalla procedura (ad es. lo si paga anticipatamente con finanziamento esterno prima di depositare la domanda, col rischio di revocatoria se non attento, o come creditore estraneo in un accordo contestuale).
- Debiti bancari garantiti da fideiussioni personali: come detto, il concordato libera la società debitrice ma non i fideiussori. Quindi, attenzione: se l’imprenditore ha garantito coi suoi beni personali un debito e la società paga solo una parte in concordato, la banca potrà rivalersi sull’imprenditore per la parte non pagata. L’unico modo per evitare ciò è far entrare anche il garante in una procedura (es. se è persona fisica sovraindebitata, un concordato minore per lui, o includere la liberazione delle garanzie nel piano offrendo qualcosa ai garanti – alcune banche accettano di liberare il garante a fronte di un extra pagamento in concordato). Dunque, il concordato “cancella i debiti aziendali” ma non i debiti dei garanti. Questo è un punto dolente per molti piccoli imprenditori che avevano impegnato beni personali: salvano la società ma restano esposti privatamente, a meno di manovre concomitanti (che spesso accadono: capita che in un concordato la moglie o un parente del garante compri dal concordato il credito della banca pagandolo un po’ più di quanto l’avrebbe avuto, così il garante si libera – sono tecniche avanzate).
- Debiti post-concordatari: non esistono, perché il concordato riguarda solo quelli precedenti. I debiti sorti durante la procedura (cosiddetti in prededuzione) vanno pagati integralmente (es. forniture durante concordato in continuità, compenso commissario, finanziamenti ponte autorizzati). Se non si riesce a pagarli, il concordato può saltare. Ma una volta omologato, tutti i nuovi debiti sono extra-concordato e vanno onorati regolarmente.
In sintesi, con il concordato preventivo un’azienda può legalmente ridurre anche drasticamente il proprio indebitamento, garantendo però ai creditori uno scenario migliore di quello fallimentare (soddisfazione comunque maggiore o più rapida). Tutte le soluzioni di stralcio sono fatte nel rispetto delle norme: ecco perché ad esempio la Cassazione ha affermato che l’esdebitazione del fallito (ossia la liberazione dai debiti residui) è cosa diversa e aggiuntiva rispetto al concordato, perché nel concordato la liberazione discende dal consenso dei creditori e dall’omologa, mentre nell’esdebitazione è un beneficio legale a posteriori. Nel concordato, di fatto, i creditori acconsentono (perché la maggioranza vincola tutti) a rinunciare a una parte dei loro crediti in cambio della percentuale offerta e della “fine della storia” (in tempi certi e con un risultato certo).
Dal punto di vista del debitore, il concordato è una strada impegnativa (richiede costi, pubblicità, rischi di fallimento se va male) ma se riesce è una soluzione definitiva: l’azienda può proseguire la sua attività ripulita dai debiti pregressi (salvo quelli che ha concordato di pagare parzialmente). In particolare, un concordato in continuità aziendale ben riuscito equivale a un risanamento: l’impresa continua a operare, magari con nuovi soci o nuova finanza, e i vecchi debiti sono ridotti alle quote fissate.
Ci sono casi noti di grandi aziende che sono risorte grazie al concordato (es. molte società del settore immobiliare dopo la crisi 2008 si salvarono con concordati pagando percentuali ridotte, alcune società editoriali, ecc.).
Limiti del concordato: Va comunque ribadito che non tutte le aziende riescono a fare un concordato: serve un piano credibile e finanziariamente sostenibile. Il tribunale non ammette piani manifestamente inidonei a soddisfare i creditori (art. 47 CCII). E i creditori difficilmente voteranno sì se la percentuale offerta è troppo bassa senza giustificazione. Inoltre, il concordato è da evitare se l’impresa è completamente decotta e senza alcuna risorsa: in tal caso tanto varrebbe la liquidazione diretta. Spesso i concordati vengono approvati quando c’è un contributo esterno (un investitore terzo che apporta denaro per avere l’azienda libera da debiti, o i soci che mettono soldi freschi) che migliora l’attivo a disposizione dei creditori. Senza “carota”, ottenere il voto è arduo.
Un aspetto specifico: concordato e reati. Abbiamo già menzionato come un concordato omologato con certe percentuali evita la punibilità per bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII). Ciò è un incentivo notevole: un imprenditore che abbia effettuato pagamenti preferenziali in crisi – reato di bancarotta preferenziale – non sarà punibile se poi realizza un concordato che dà almeno 20% ai chirografari (o 40% se concordato minore). Dunque, “salvare l’azienda” paga anche sul fronte penale. Cass. penale Sez. V, 12388/2010 ha confermato questa ratio premiale. Inoltre, come detto, la tempestività esimente attenua eventuali bancarotte (bancarotta semplice per ritardo, etc., può non essere nemmeno contestata se c’è concordato tempestivo).
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
È un particolare tipo di concordato introdotto di recente, già accennato come esito della composizione negoziata fallita (art. 25-sexies e septies CCII). Merita solo un brevissimo richiamo: a differenza del concordato preventivo normale, qui non c’è voto dei creditori. Il debitore propone un piano di liquidazione dei beni, il tribunale nomina un commissario e poi decide se omologarlo ascoltati i creditori ma senza loro potere di veto. È uno strumento pensato per situazioni in cui la trattativa non ha prodotto accordo perché i creditori sono troppo disuniti, ma comunque c’è un’attivo da liquidare. Per il debitore, l’effetto è simile ad un concordato liquidatorio: i beni vengono venduti e distribuiti pro quota. I debiti residui restano inesigibili. La differenza è che i creditori possono solo fare osservazioni/opposizioni, ma non possono impedire l’omologa se il giudice la ritiene più favorevole del fallimento. È semplificato perché elimina il passaggio del voto e consente di chiudere più rapidamente. In pratica, è una scorciatoia in presenza di mancanza di consenso: può “cancellare i debiti aziendali” liquidando il patrimonio senza il loro accordo formale. Tuttavia, il suo ambito è limitato: serve aver tentato la composizione negoziata e avere una relazione dell’esperto che dica che alternative non ce n’erano (cioè i creditori irragionevolmente non hanno accettato niente). Non è uno scenario comune, ma è uno strumento importante per evitare che sforzi di risanamento falliti finiscano subito in fallimento: dà una chance al debitore di chiudere con un concordato imposto ma ordinato.
La liquidazione giudiziale (ex fallimento) ed esdebitazione del debitore
Se tutte le soluzioni di cui sopra non sono praticabili o falliscono, resta la procedura concorsuale liquidatoria per antonomasia: la liquidazione giudiziale, ovvero il vecchio fallimento. Questa non è una procedura scelta dal debitore per ridurre i debiti – di solito la subisce, essendo promossa d’ufficio o dai creditori – ma va trattata in una guida “come cancellare i debiti aziendali” perché, paradossalmente, per un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile, proprio il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) seguito dall’esdebitazione può portare alla liberazione dai debiti residui.
Effetti della liquidazione giudiziale sui debiti
Quando il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, l’impresa (se è società) viene spossessata: l’amministrazione del patrimonio passa al curatore nominato. I debiti preesistenti non vengono più pagati dal debitore ma concorreranno nel riparto concorsuale. Tutti i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo. Segue l’accertamento del passivo (il giudice compila lo stato passivo distinguendo crediti privilegiati, chirografari, ecc.). Il curatore nel frattempo liquida gli asset: vende i beni mobiliari, immobili, recupera crediti, prosegue contratti se opportuno o li scioglie, ecc.
Al termine (o a più riprese), il curatore distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni: prima i crediti prededucibili (costi della procedura, ecc.), poi i crediti privilegiati (per grado; se incapienti, la parte in eccedenza degrada a chirografo), infine ai chirografari quello che rimane (spesso nulla o pochi centesimi). Dopodiché, su proposta del curatore, il tribunale chiude la procedura.
Cosa succede ai debiti dopo la chiusura? Per una società di capitali, la chiusura della liquidazione giudiziale comporta l’estinzione della società (verrà cancellata dal Registro Imprese). I debiti insoddisfatti restano privi di un soggetto debitore: in pratica, nessuno potrà più recuperarli perché la società non esiste più. Formalmente, i creditori potrebbero tentare azioni contro eventuali garanti o soci responsabili (es. in SAS contro accomandatari, in SNC contro i soci, etc.), ma verso la società in sé non c’è più nulla da fare. Quindi, se guardiamo dal punto di vista dell’azienda-società, il fallimento segna la fine dei debiti perché segna la fine del soggetto giuridico debitore. Ovviamente non è una “cancellazione” in senso tecnico (non c’è un atto che li annulla, semplicemente diventano inesigibili perché non c’è più il debitore). In pratica, i creditori insoddisfatti devono prendere atto della perdita. Non c’è bisogno neppure di istanza di esdebitazione perché la società non può più avere rapporti giuridici (anche se, come vedremo, il CCII ha formalmente esteso l’istituto dell’esdebitazione anche al fallito persona giuridica per evitare dubbi interpretativi, ma concettualmente serve solo per eventuali soci).
Per un imprenditore individuale o per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, la situazione è diversa: la persona fisica debitore continua ad esistere dopo la chiusura del fallimento e, in assenza di interventi, rimarrebbe teoricamente obbligata a pagare i debiti residui non soddisfatti con l’attivo liquidato. In passato, ciò significava che il fallito rimaneva indebitato a vita per la parte non pagata. Dal 2006, però, l’ordinamento ha introdotto la esdebitazione: l’art. 142 L.F. prima, oggi l’art. 278 CCII, permettono al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione di tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti, a seguito della chiusura del fallimento, purché soddisfi alcune condizioni di meritevolezza .
La ratio è dare al fallito onesto una fresh start (sul modello anglosassone). L’esdebitazione non copre alcuni debiti (come quelli personali per sanzioni, alimenti, danni da malefatte – vedi sopra), ma copre la stragrande maggioranza: debiti commerciali, banche, fornitori, Fisco (anche il Fisco rientra, le imposte residue vengono annullate, salvo che il fallito abbia commesso frodi fiscali).
Il Codice della Crisi ha confermato e per certi versi ampliato l’esdebitazione: ora la concessione può avvenire anche d’ufficio nel provvedimento di chiusura (non serve attendere istanza separata, il giudice può contestualmente dichiarare esdebitato il debitore se nessuno si oppone e i requisiti ci sono). Inoltre, come accennato, la definizione di “debitore” ai fini esdebitazione comprende anche la persona giuridica – c’è stato un dibattito se una società fallita potesse essere esdebitata. In teoria, essendo estinta, non ne ha bisogno; tuttavia, la Cassazione si è trovata a decidere su procedure iniziate ante CCII e chiuse post CCII se applicare la nuova disciplina: con Cass. 14835/2025 ha stabilito che per fallimenti vecchi conclusi dopo il 2022, continua ad applicarsi la legge fallimentare e quindi l’esdebitazione solo per persone fisiche, non per la società. Insomma, la società in sé non risorge comunque.
Dunque, per un imprenditore individuale, il percorso “fallimento + esdebitazione” è in effetti un modo di cancellare i propri debiti sebbene passando per la procedura più traumatica. I requisiti per l’esdebitazione includono: aver cooperato nella procedura, non aver distratto attivo, non aver riportato condanne per bancarotta fraudolenta o reati fiscali gravi, non essere recidivo in fallimenti, ecc. . La giurisprudenza recente (Cass. 15359/2023) sottolinea la tendenza al favor debitoris: le cause ostative alla “meritevolezza” del fallito sono solo quelle espressamente previste (dolo o colpa grave nel causare debiti, atti in frode, etc.), e vanno interpretate restrittivamente . Ad esempio, non pagare nulla ai creditori non è di per sé una colpa grave se il fallimento è stato lungo e le risorse nulle; la Corte ha cassato decisioni che negavano l’esdebitazione solo perché i creditori avevano avuto percentuali irrisorie, imponendo di valutare il contesto . Questo significa che anche il fallito che non ha potuto dare praticamente niente ai creditori può comunque ottenere l’esdebitazione se ha agito onestamente e la mancanza di pagamento non è dipesa da lui. Tale indirizzo, influenzato anche dalla direttiva UE, va nella direzione di offrire davvero una seconda chance.
Per quanto riguarda i soci illimitatamente responsabili (SNC, SAS): essi falliscono in estensione insieme alla società (art. 256 CCII). Al termine, anche loro possono chiedere l’esdebitazione personale, separatamente dalla società (che, se è cancellata, non ne ha bisogno). Il CCII consente inoltre che, nel concordato minore di una società di persone, vengano inclusi anche i soci illimitatamente responsabili e prevedere il loro esdebitamento con la procedura minore. Se invece la società va in liquidazione giudiziale, i soci seguiranno quell’unica procedura ma per l’esdebitazione faranno istanza individuale.
Un cenno ai reati fallimentari: per l’imprenditore, la liquidazione giudiziale è pericolosa perché attiva la sfera penale se vi sono state condotte fraudolente (bancarotta fraudolenta, preferenziale, documentale, ecc.). Tuttavia, laddove non vi siano reati e il fallito sia meritevole, l’esdebitazione è la conclusione “virtuosa”. Essa non cancella eventuali sanzioni penali o debiti per multe (che come detto restano), ma libera da tutto il resto. Dopo l’esdebitazione, i creditori insoddisfatti non possono più agire contro il debitore: il credito è estinto per inesigibilità giuridica.
Conclusione sulla liquidazione giudiziale: Dal punto di vista del debitore, dichiarare fallimento non è certo un desiderio, ma a volte può diventare l’esito inevitabile e persino preferibile rispetto all’agonia di trascinarsi debiti impossibili. Ad esempio, per un piccolo imprenditore sovraindebitato che non rientra nella legge sovraindebitamento (caso ormai raro perché la legge copre i più), il fallimento + esdebitazione è la strada per ricominciare pulito. Lo stesso per un ex socio illimitato.
Di norma però, tutte le procedure di cui abbiamo parlato sono pensate per evitare la liquidazione giudiziale: il concordato, l’accordo, ecc., servono proprio a scongiurare quella soluzione distruttiva. Anche perché nel fallimento i creditori di solito prendono percentuali molto basse (spesso <10% per chirografari). Il Codice della Crisi ha rafforzato l’idea che il fallimento è l’ultima risorsa, e ha predisposto penalità per chi ci arriva senza aver provato alternative. Ciò non toglie che rimane un istituto necessario per gestire i casi disperati o di frode.
Riassumendo: la liquidazione giudiziale cancella i debiti aziendali in quanto, esaurito l’attivo, i debiti residui diventano inesigibili (per società perché la persona giuridica muore; per persone fisiche perché ottengono l’esdebitazione). Ovviamente “cancella” anche l’azienda stessa (che viene liquidata e di solito cessa). È dunque la forma più radicale di “pulizia”, che libera il debitore persona fisica dal passato ma al costo di perdere tutto il patrimonio ed eventualmente l’attività economica. Non a caso, in inglese si chiama “fresh start through liquidation”.
Una nota sulle azioni di responsabilità: come visto, nel fallimento il curatore può far causa agli amministratori per mala gestio, ottenendo risarcimenti (che poi vanno ai creditori). Ciò significa che se il fallimento è colpa di gestioni fraudolente, i creditori potrebbero comunque vedere soddisfatte parte delle loro ragioni attingendo al patrimonio personale degli amministratori tramite il risarcimento. Dal lato dell’amministratore, questo è un ulteriore “debito” che potrebbe nascere (verso la massa) e che per legge non è esdebitabile se derivante da dolo o colpa grave (sarebbe un debito da fatto illecito doloso). Quindi attenzione: il fallimento cancella i debiti dell’azienda, ma se l’amministratore ha gestito male, rischia di rientrare dalla finestra come debitore per danni e quel debito non glielo toglie nemmeno l’esdebitazione. Questo costituisce un forte deterrente a una condotta poco oculata.
Profili fiscali nella gestione del debito e benefici fiscali delle procedure
Abbiamo per lo più integrato i discorsi fiscali nei paragrafi precedenti, ma riepiloghiamo i punti cruciali:
- Detassazione delle riduzioni di debito: L’art. 88, co.4-ter TUIR prevede che non costituiscono sopravvenienze attive imponibili le riduzioni dei debiti ottenute in concordato preventivo (liquidatorio) o fallimentare, e in parte anche quelle ottenute tramite concordato in continuità, accordo di ristrutturazione o piano attestato omologato. Questo significa che se l’azienda ottiene uno stralcio dei debiti, non deve pagare IRES/IRAP su quel “guadagno”. Ad esempio, se un concordato taglia €1 milione di debiti, quel milione non concorre a formare il reddito tassabile (mentre in contabilità appare come utile straordinario, ma esente). Questo è fondamentale per evitare un paradosso: che l’azienda risanata esca dal concordato e venga colpita da tasse su utili figurativi. Dunque, lo strumento concorsuale è fiscalmente efficiente. Tuttavia, come evidenziato, c’era un vuoto per il concordato semplificato e per il PRO, su cui l’Agenzia si è espressa nel 2025: per ora il PRO non è incluso, ma probabilmente lo sarà presto, e per il semplificato addirittura l’Agenzia ha detto che il 4-ter non si applica. Ci si attende un correttivo normativo su questo, perché è illogico tassare quell’ipotesi.
- IVA su crediti non riscossi (nota di variazione IVA): Quando un creditore non incassa un credito perché il debitore ha fatto un concordato o fallimento, il creditore può recuperare l’IVA addebitata a suo tempo (emettendo una nota di variazione). Dal lato del debitore, in concordato, se riduce il debito verso un fornitore, deve ridurre la detrazione IVA corrispondente. Insomma, a livello IVA il trattamento segue il fatto che la base imponibile si riduce a quanto effettivamente pagato. Per il debitore questo è neutro perché l’IVA sui fornitori è detraibile quindi se paga di meno restituirà parte della detrazione. Sul lato dei debiti fiscali, invece, come visto l’IVA dovuta è in genere pagata integralmente per evitare violazione regole UE.
- Trattamento fiscale delle perdite d’esercizio nel risanamento: Spesso l’azienda in crisi ha grosse perdite fiscali pregresse. Se poi fa un concordato o accordo e torna in utile, può usare quelle perdite per non pagare imposte per anni. Questo è un aspetto da considerare: il Fisco italiano ha restrizioni sull’uso delle perdite in caso di cambio di controllo e discontinuazione attività (norma anti-scialuppe, art. 172 c.7 TUIR), ma se il piano prevede la continuità, le perdite rimangono e l’azienda risanata può compensare futuri utili senza tasse. Ciò indirettamente è un altro bonus nel risanamento.
- Responsabilità fiscale personale degli amministratori: Da citare il pericolo dell’art. 36 DPR 602/1973: se un liquidatore di società paga certi creditori e lascia impagato il fisco, ne risponde personalmente fino a concorrenza di quanto distribuito ai soci. Questo può colpire anche gli amministratori in carica prima del fallimento se hanno rimborsato soci o fatto spese invece di accantonare per il fisco. Ma se poi c’è concordato, di solito quell’art. 36 non si applica perché non c’è “liquidazione ordinaria” con distribuzione. Art. 36 colpisce la liquidazione volontaria non concorsuale; in concorsuale decide il giudice come distribuire. Quindi attivare una procedura concorsuale mette al riparo l’amministratore dall’art. 36 (ma non lo salva se ha fatto reati fiscali).
- Saldo e stralcio e rottamazioni: come detto, questi regimi agevolati spuntano ogni tanto e possono ridurre drasticamente i debiti tributari con costi minori. Dal punto di vista fiscale, aderire a una rottamazione è sempre preferibile se la si può sostenere, rispetto al far fallire e vedere sanzioni e interessi comunque togliersi ma anni dopo. L’interazione con le procedure concorsuali è stata disciplinata: ad esempio, se un debitore presenta domanda di rottamazione e poi fallisce, la rottamazione decade; oppure se è in concordato, può includere la rottamazione come modalità di pagamento del fisco.
- Imposte indirette: Nota finale: l’omologazione di concordato è esente dall’imposta di registro e bollo. In generale gli atti nell’ambito di procedure concorsuali hanno agevolazioni fiscali (per incoraggiare l’operazione di crisi). Ad esempio, la cessione d’azienda in concordato può avere un trattamento IVA/registro migliore come cessione in blocco.
Responsabilità degli amministratori e degli imprenditori: aspetti patrimoniali e penali
Dal punto di vista del debitore azienda, cancellare i debiti è l’obiettivo. Ma occorre considerare anche le conseguenze e responsabilità per le persone che gestiscono o possiedono l’azienda. Un imprenditore può liberare la sua impresa dai debiti, ma potrebbe egli stesso incorrere in responsabilità personali (civili o penali) derivanti dalla gestione passata. Affrontiamo separatamente:
Responsabilità civile patrimoniale degli amministratori/soci
Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), vige il principio della separazione patrimoniale: in genere gli amministratori non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Tuttavia, in caso di insolvenza della società, spesso emergono possibili azioni di responsabilità per mala gestio, come accennato:
- Azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c. per S.p.A., 2476 c.c. per S.r.l.): gli amministratori rispondono verso la società per i danni causati da violazione dei loro doveri. Nel fallimento o liquidazione giudiziale, questa azione viene esercitata dal curatore in rappresentanza della società (art. 255 CCII) e il risarcimento va a beneficio di tutti i creditori. Tipicamente si chiede agli amministratori di risarcire l’aggravamento del dissesto causato dalla loro inerzia o scelte imprudenti (continuare ad accumulare debiti quando la società era decotta, distrazione di risorse, ecc.). Con la riforma, questa azione è stata facilitata: l’art. 2486 c.c. novellato prevede una presunzione di danno pari alla differenza di patrimonio netto tra quando si doveva sciogliere la società e quando effettivamente è cessata, oppure pari al deficit fallimentare se le scritture sono assenti. Ciò significa che l’amministratore che ha tardato a portare i libri in tribunale può trovarsi un risarcimento calcolato automaticamente (es.: doveva liquidare nel 2020 con patrimonio -100, fallisce nel 2022 con deficit -700, danno presunto 600). L’onere della prova è invertito: spetta all’amministratore provare che non ha causato quel peggioramento. Queste somme – se recuperate – vanno ad incrementare l’attivo fallimentare e quindi in ultima analisi diminuiscono i debiti insoddisfatti, ma a carico degli ex gestori. Dal punto di vista dell’amministratore, è un incubo: anche se ha “cancellato i debiti” con un concordato o fallimento, potrebbe doverli pagare di tasca sua via risarcimento. L’esdebitazione non copre questi debiti risarcitori per mala gestio dolosa o gravemente colposa. Quindi un amministratore condannato per aver aggravato il dissesto, anche se fallito personalmente, quell’obbligo di risarcimento resta (è considerato derivante da dolo, non esdebitabile). Risultato: chi gestisce deve essere estremamente diligente nel non far incancrenire la crisi, altrimenti il “conto” dei debiti cancellati può presentarsi a lui in altra forma.
- Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.): se il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i creditori, gli amministratori rispondono verso i creditori per non aver conservato l’integrità del patrimonio. Questa confluisce nel fallimento nell’azione unica del curatore (art. 256 CCII). È simile alla precedente, ma concettualmente risarcisce direttamente i creditori per la lesione della garanzia patrimoniale. Anche qui, con il CCII è unita e semplificata dall’art. 2486 c.c. presuntivo.
In pratica, nel concordato preventivo non c’è un curatore che fa queste azioni (resta l’azienda in mano agli amministratori stessi), ma i creditori insoddisfatti potrebbero dopo la chiusura cercare di agire per danni se ravvisano una mala gestio (ad es. in un concordato liquidatorio i creditori chirografari prendono 20% e poi fanno causa agli amministratori per il 30% mancante accusandoli di aver tardato la domanda; non è frequente, ma possibile). Nel fallimento, invece, è prassi che il curatore valuti la responsabilità degli ex gestori e agisca se c’è speranza di recupero.
Per le società di persone (snc, sas): i soci illimitatamente responsabili rispondono direttamente con il loro patrimonio di tutti i debiti sociali. Quindi la separazione qui non c’è: in caso di insolvenza, i soci diventano anch’essi falliti e il loro patrimonio personale è aggredito dai creditori. Questo significa che i debiti aziendali di una snc non vengono affatto cancellati per i soci nemmeno se la società fa concordato o accordo, a meno che i soci siano coinvolti. Ad esempio: Alfa Snc va in concordato e paga il 30% ai creditori; i creditori per il restante 70% possono chiedere ai soci illimitati di saldare (perché la liberazione ottenuta dal concordato riguarda la Snc, non i soci a meno che non siano parte del medesimo accordo). Per questo la legge prevede che se una società di persone propone un concordato, debba occuparsi anche dei soci: oggi è esplicito che possono essere inclusi i patrimoni dei soci nel concordato minore per regolare anche la loro posizione. Nella pratica, nelle proposte concordatarie di società di persone spesso i soci offrono parte del loro patrimonio per aumentare la percentuale ai creditori in cambio della liberazione. Se ciò non avviene, i soci rimangono obbligati in solido per la parte di debito non pagata (e finirebbero comunque in procedure di sovraindebitamento o fallimento personale). Quindi, dal punto di vista di un socio illimitato, “cancellare i debiti aziendali” passa quasi sempre per cancellare anche i propri, con procedure coordinate.
Imprenditore individuale: non c’è distinzione tra debiti aziendali e personali – tutto è suo. Quindi se la sua impresa individuale fallisce o va in concordato, riguarda lui personalmente. Un concordato di ditta individuale libererà lui dai debiti residui (salvo eccezioni). Un fallimento seguito da esdebitazione pure. Ma durante la procedura, i suoi beni personali sono dentro (casa, auto, etc. salvo impignorabili). Nulla protegge il patrimonio personale dell’imprenditore individuale, se non eventualmente il patto di famiglia o trust, ma quelli possono essere revocati o inefficaci se fatti a ridosso dell’insolvenza.
Garanzie personali degli amministratori/soci su debiti aziendali: Questo già toccato: se un amministratore ha firmato fideiussioni, quelle rimangono efficaci anche se l’azienda fa concordato . Quindi la banca che ha perso 50% in concordato va dal fideiussore e chiede quel 50%. Molti imprenditori, dopo aver chiuso i debiti aziendali con concordato, si ritrovano personalmente esposti – e magari devono poi ricorrere alla legge sul sovraindebitamento per cancellare a loro volta quei debiti di garanzia. Fortunatamente, oggi un amministratore persona fisica può accedere a tali procedure (piano del consumatore se i debiti erano perlopiù privati o concordato minore se sono debiti anche dell’attività), e ottenere esdebitazione pure su quelle garanzie escusse. In un certo senso, in Italia spesso c’è bisogno di un doppio livello di procedura: una per la società e una per il garante. Questo complicata, ma è il risultato del regime di responsabilità.
Responsabilità penale in contesti di crisi e insolvenza
Le norme penali a tutela dei creditori e della corretta gestione dell’insolvenza sono in parte confluite nel Codice della Crisi (Titolo IX) e in parte rimangono nel D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari.
I principali reati “concorsuali” (cioè collegati al fallimento o al concordato) sono:
- Bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII): sanziona l’imprenditore (persona fisica o amministratore di società) che dolosamente distrae, occulta, spreca beni o crea false passività, o falsifica i libri contabili, prima o durante la liquidazione giudiziale. È il reato più grave (pena 3-10 anni circa). Esemplifica: trasferire soldi all’estero e poi fallire = bancarotta fraudolenta patrimoniale; falsificare il bilancio per coprire ammanchi = bancarotta fraudolenta documentale. Questo debito con la giustizia è personale: l’esdebitazione non c’entra, anzi una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta è causa ostativa all’esdebitazione. Il fallito fraudolento non può essere esdebitato (art. 280 CCII).
- Bancarotta semplice (art. 323 CCII): sanziona condotte meno gravi ma comunque colpose dell’imprenditore, come avere aggravato il dissesto con spese personali eccessive, manovre azzardate, oppure non aver richiesto tempestivamente la procedura concorsuale. È punita più lievemente (fino a 2 anni). Questa è la “punizione” per la mala gestio non dolosa. Tuttavia, come visto, il Codice prevede cause di non punibilità: se il debitore ha presentato tempestivamente domanda di concordato o composizione negoziata, evitando danni ulteriori, la bancarotta semplice può essere non punibile. L’idea è premiare chi non trascina la crisi e coopera.
- Ricorso abusivo al credito (art. 325 CCII, ex art. 218 L.F.): punisce l’imprenditore che, già in dissesto irreversibile, continua a farsi finanziare da terzi causando loro pregiudizio. Esempio: accendere un nuovo mutuo o fare acquisti a credito sapendo di essere insolvente. È un reato “concorsuale” minore.
- Preferenze a taluni creditori (bancarotta preferenziale): se prima del fallimento l’imprenditore paga volontariamente un creditore a scapito degli altri (fuori dall’ordinaria amministrazione) è bancarotta preferenziale, punita come la fraudolenta (viene considerata una frode ai danni della par condicio). Esempio: l’imprenditore vede il collasso e rimborsa interamente il debito al parente creditore lasciando gli altri a bocca asciutta = reato. Ma come ricordato: se poi c’è un concordato che soddisfa decentemente i creditori, questo reato non è punibile. Il legislatore quindi incentiva a sistemare con concordato: se salvi la baracca (minimo 20% ai chirografari) ti “perdoniamo” le eventuali preferenze che hai fatto per necessità. Questa clausola premiale fu introdotta nel 2005 e aggiornata (art. 324 CCII), Cass. 2010 confermò.
- Reati di “false informazioni” (art. 341 CCII): punisce l’imprenditore che, per ottenere l’ammissione al concordato o l’omologa di un accordo di ristrutturazione, si attribuisce attività inesistenti o simula crediti per manipolare le maggioranze. Questo mira a prevenire frodi nelle procedure di risanamento: ad esempio, inventare un immobile inesistente nel piano o creare finti creditori amici per far numero al voto, è reato (1-5 anni). Dunque, guai a presentare un piano con dati falsi: oltre a far saltare la procedura se scoperto, c’è conseguenza penale.
- Reati dell’attestatore o OCC: se l’attestatore di piani concordatari o l’OCC del sovraindebitamento rilasciano false attestazioni, sono puniti penalmente (fino a 2 anni, art. 342 CCII). Questo a garanzia che i professionisti che certificano piani siano onesti.
- Reati dei creditori: esiste il reato di patto commissorio con il fallito (art. 336 CCII, se un creditore collude col fallito per avere vantaggi, ad esempio farsi dare pegno segreto in crisi) e reati nelle adunanze (es. votare in concordato a seguito di accordi corruttivi con altri creditori, art. 338 CCII).
- Esercizio abusivo di attività (art. 340 CCII): se un soggetto è interdetto dai precedenti fallimenti e continua a fare l’imprenditore, è reato (questo punisce i recidivi incalliti).
Accanto a questi, non dimentichiamo i reati tributari (D.Lgs. 74/2000): ad esempio, omesso versamento IVA oltre soglia (€250k) è reato; omesso versamento ritenute oltre soglia (€150k) è reato. Questi prescindono dalla procedura concorsuale. Un concordato non estingue il reato di omesso versamento IVA (ma se nel concordato l’IVA viene pagata prima della sentenza penale definitiva, scatta causa di non punibilità introdotta nel 2019, art. 13 DLgs 74). In fallimento, l’amministratore può essere condannato e la sanzione può includere il risarcimento all’erario a suo carico. Dunque, anche a fini penali, meglio risolvere prima quei debiti (anche perché se li paghi prima del giudizio eviti condanna).
Misure premiali penali: Già accennate: art. 324 CCII = esenzione punibilità per bancarotta semplice e preferenziale se concordato approvato e certe soglie soddisfatte; inoltre circostanza attenuante ad hoc per chi, prima della dichiarazione di fallimento, ha fatto tutto il possibile per ridurre il danno (ad esempio ha iniziato trattative serie). Queste attenuanti possono ridurre di 1/3 la pena. Art. 25 CCII parla di “vasta congerie di misure premiali” per chi tempestivamente si attiva. L’obiettivo è chiaro: depenalizzare l’insolvenza se viene gestita in modo trasparente e responsabile, e penalizzare invece l’occultamento e il ritardo colposo.
Conclusione su responsabilità: Dal punto di vista pratico, un imprenditore che vuole cancellare i debiti aziendali e ripartire deve pensare anche a limitare la propria esposizione personale:
- Attivarsi presto con gli strumenti di composizione per evitare condotte aggravanti (evita la bancarotta semplice e preferenziale).
- Non compiere atti distrattivi o irregolari (evita bancarotta fraudolenta).
- Nel piano concordatario, rappresentare tutto correttamente (evita reati di false attestazioni).
- Se è amministratore di società, seguire i doveri di adeguati assetti e convocare l’assemblea per scioglimento in caso di capitale perduto (ora trasgressione di 2486 c.c. è preludio a guai civili).
- Se ha dato garanzie personali, considerare sin dall’inizio strategie per proteggerlo: farlo rientrare nel perimetro del risanamento (ad es. includere la sua posizione in un accordo con la banca). Se ciò non è possibile e rimane esposto, prepararsi a usare la procedura di sovraindebitamento persona fisica.
- Essere consapevole che eventuali debiti fiscali non pagati potrebbero generare procedimenti penali: in un concordato è possibile chiedere al giudice penale la sospensione del processo in attesa dell’esito, e se poi il concordato paga quell’IVA, il reato è estinto (art. 13 D.Lgs. 74).
In poche parole, il debitore deve muoversi su due fronti: cancellare i debiti dell’azienda e non creare per sé nuovi guai (civili o penali) nel farlo. La normativa attuale offre gli strumenti per riuscirci in modo ordinato e onesto. Un imprenditore che agisce in buona fede e con trasparenza può oggi aspirare a ristrutturare i debiti d’impresa, salvare la propria attività e contemporaneamente evitare sanzioni penali e responsabilità personali eccessive. Come recita l’art. 3 CCII, c’è un dovere di predisporre assetti adeguati proprio per tutelare la continuità e i terzi; chi lo segue e affronta il problema debiti subito ha non solo più chance di successo economico, ma anche di non incorrere in condanne o risarcimenti rovinosi.
Domande frequenti (FAQ) su cancellazione dei debiti aziendali
D: È davvero possibile “cancellare” i debiti di un’azienda senza pagarli interamente?
R: Sì, attraverso gli strumenti legali di ristrutturazione del debito. “Cancellare” significa che una parte dei debiti viene formalmente condonata o annullata nell’ambito di un piano concordato con i creditori e omologato da un tribunale. Ad esempio, in un concordato preventivo i creditori chirografari possono accettare (o subire) il pagamento parziale del loro credito, e la parte restante viene giuridicamente estinta dall’omologazione. Analogamente, in un accordo di ristrutturazione omologato, i creditori firmatari rinunciano a una quota di credito. Dunque, non è una magia: è una rinuncia negoziata o imposta secondo la legge. L’impresa di solito deve pagare una parte dei debiti (quella sostenibile) e offrire garanzie sul fatto che i creditori non otterrebbero di più pignorando o fallendo l’azienda. Con queste procedure è assolutamente legale ottenere lo stralcio di ampie percentuali di debito (60%, 70%, anche 90% in certi casi) e liberare l’azienda dall’obbligo di pagarle. Ciò è confermato e regolato dal Codice della Crisi. Naturalmente, ogni caso dipende dalla fattibilità economica: se l’azienda ha prospettive di risanamento e un minimo di attivo da offrire, i creditori accetteranno lo stralcio parziale sapendo che l’alternativa (il fallimento) darebbe loro forse zero.
D: Quali tipi di debiti NON si possono in alcun caso cancellare con queste procedure?
R: Ci sono debiti che la legge esclude dalla liberazione nelle procedure concorsuali: – Multe, ammende e sanzioni penali: se l’azienda (o l’imprenditore) deve pagare una sanzione pecuniaria per un reato o un illecito amministrativo, quel debito non può essere falcidiato né esdebitato . Ad esempio, le multe stradali o un’ammenda per un reato ambientale restano dovute per intero dal responsabile, anche dopo concordato o fallimento (salvo che l’ente che le irroga acconsenta diversamente, cosa rara).
– Obblighi di mantenimento e alimenti: non riguardano l’azienda ma la persona – comunque non si estinguono. Se un imprenditore aveva arretrati di assegni familiari, non glieli condonano.
– Debiti per risarcimenti da fatto illecito doloso verso persone: se, ad esempio, l’amministratore ha una condanna al risarcimento per truffa, quel debito verso la vittima non è esdebitabile .
– IVA e ritenute non versate (capitale): più che “non cancellabili”, sono difficilmente falcidiabili. La legge italiana oggi permette di includerli nei piani, ma la prassi e la normativa UE esigono in genere il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute. Quindi, realisticamente, l’impresa dovrà pagare interamente l’IVA dovuta e le ritenute, al limite dilazionandole. La parte di sanzioni e interessi su questi invece si può cancellare.
– Tributi locali: attualmente, debiti come IMU, TARI, multe comunali non sono coperti dalla “transazione fiscale” nazionale. Ciò significa che per ridurli serve l’accordo del Comune. Non c’è garanzia di cram-down. Quindi, formalmente sarebbero falcidiabili in un concordato (posso classificarli chirografari e offrire il 20%), ma se il Comune si oppone può creare problemi. Presto potrebbero includerli per legge negli stralci automatici, ma per ora rimangono un’area delicata.
– Debiti esclusi dalla esdebitazione: per un fallito persona fisica, la legge esclude alcuni debiti dalla liberazione finale (art. 279 CCII), come: obblighi alimentari, debiti per malversazione ai danni dello Stato, multe penali. Questi restano anche dopo.
In sintesi, la stragrande maggioranza dei debiti d’impresa – finanziamenti bancari, fatture fornitori, leasing, debiti fiscali (salvo IVA/ritenute), debiti previdenziali (salvo ritenute dipendenti) – può essere ridotta o cancellata nelle procedure di crisi. Restano fuori prevalentemente le componenti sanzionatorie e personali. Ad esempio, se l’azienda aveva avuto una sanzione Antitrust di 100.000€, quella non la si può falcidiare con concordato (è debito per multa statale). Ma situazioni simili sono relativamente rare nel totale delle passività di un’impresa.
D: La mia società è molto indebitata. Se la chiudo o fallisce, i debiti spariscono automaticamente?
R: Attenzione: se la società è di capitali (Srl, Spa) e viene cancellata dal Registro Imprese, i debiti diventano inesigibili verso la società, perché questa non esiste più. Tuttavia, i creditori possono inseguire eventuali garanti o obbligati: ad esempio, i fideiussori o gli amministratori (in caso di illeciti) o i soci se hanno ricevuto indebitamente attivi in liquidazione. Inoltre, se la cancellazione è avvenuta senza procedura concorsuale, per 1 anno i creditori possono chiedere la riapertura della liquidazione della società (art. 2495 c.c.). Se invece la società chiude attraverso un fallimento, allora sì che i debiti rimasti non pagati diventano irrecuperabili (la legge li considera estinti per mancanza del soggetto). Quindi, per una società di capitali la “morte” giuridica porta con sé la fine dei debiti sociali, ma non protegge eventuali coobbligati. Nel caso di società di persone, la chiusura della società non libera i soci illimitatamente responsabili: i creditori non soddisfatti potranno aggredirli. Quindi in quel caso i debiti “spariscono” solo pro quota societaria, ma rivivono sulle teste dei soci. In sintesi: chiudere l’azienda senza pagare i debiti espone gli obbligati personali. Se invece si usa una procedura concorsuale (concordato o liquidazione giudiziale) per chiuderla, si ottiene un effetto più ordinato: la società muore e i debiti sono cancellati secondo legge, e i garanti hanno eventualmente modo di regolarsi con procedure personali. Insomma, non basta cessare l’attività per far sparire i debiti: serve portare a termine un procedimento liquidatorio che definisca la sorte di quei debiti. Un fallimento concluso o un concordato liquidatorio adempiono a questo scopo legalmente. La semplice liquidazione volontaria non paga non estingue i debiti verso terzi (anzi, l’art. 2495 c.c. li rende esigibili verso i liquidatori fino concorrenza attivo distribuito). Quindi, mai cancellare una società carica di debiti senza procedura, pensando che i creditori restino a bocca asciutta: potrebbero rivalersi su liquidatori o soci. Meglio valutare un concordato o insolvenza assistita.
D: Ho personalmente garantito i debiti della mia azienda (fideiussioni bancarie, personali). Se l’azienda fa concordato o fallisce e i debiti verso la banca sono stralciati, io garante sono libero?
R: Purtroppo no, il garante rimane obbligato per ciò che la banca non ha ottenuto dalla procedura. La liberazione del debitore principale (l’azienda) non si estende automaticamente ai fideiussori, a meno che il creditore stesso non lo accetti. Di solito, le banche non liberano i garanti: se l’azienda paga solo il 50%, la banca può chiedere al fideiussore (di solito l’imprenditore stesso o un familiare) il restante 50%. Questo è un punto critico: molti imprenditori pensano “faccio fallire la società e me ne libero”, poi scoprono che la banca si rifà su di loro personalmente. Come tutelarsi? Alcune idee: – Includere il garante nella trattativa: ad esempio, in un accordo di ristrutturazione colla banca si può pattuire che se l’azienda paga X, la banca rinuncia a escutere la fideiussione. Serve però negoziarlo e scriverlo esplicitamente.
– Procedure personali: se la garanzia viene escussa (o sta per esserlo) e il garante non può pagare, il garante può accedere alla procedura di sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata personale) per farsi lui ristrutturare o cancellare quel debito. Ad esempio, l’amministratore spesso fa seguire al concordato dell’azienda un accordo o piano personale per sistemare le fideiussioni.
– Transazione personale: a volte, sapendo ciò, l’imprenditore sfrutta risorse personali per fare un’offerta transattiva diretta al creditore: es. “non oppormi nel concordato, prendi 50% dall’azienda e ti do un extra 10% io privato purché estingui la fideiussione”. Se la banca accetta, lo libera. Ci vuole il consenso esplicito del creditore. In breve, la regola giuridica è che la liberazione del debitore principale non libera i coobbligati (art. 1239 c.c.). Quindi il garante rischia di dover onorare interamente. Va quindi considerato un piano B per il garante. Ricordiamo che se poi anche il garante va in procedura e ottiene esdebitazione, anche quel debito si cancella. La legge 3/2012 (ora CCII sovraindebitamento) ha permesso a molti ex imprenditori di liberarsi dai debiti residui che li inseguivano dopo il fallimento della società. Ad esempio, Cass. 2020 ha ammesso l’esdebitazione di un ex socio illimitato per debiti sociali rimasti, nonostante in astratto la norma lo vietasse: ora il CCII chiarisce che i soci illimitati possono accedere al concordato minore insieme alla società. Quindi sì, c’è vita dopo i debiti per i garanti, ma serve muoversi attivamente.
D: Un piccolo imprenditore “non fallibile” (sotto soglie) come può cancellare i debiti? Deve per forza dichiararsi fallito o c’è altra via?
R: Non deve (e non può) fallire, ma può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il Codice ha predisposto tre strumenti principali: il Piano di ristrutturazione del consumatore (se i debiti sono per lo più personali), il Concordato minore (se ha un’attività d’impresa o professionale), e la Liquidazione controllata (se non è in grado di offrire un pagamento significativo). Queste sono procedure semplificate davanti al Tribunale, simili ai concordati ma senza il voto dei creditori (decide il giudice se omologare) e con requisiti di meritevolezza. Ad esempio, un artigiano con debiti 200k può proporre un concordato minore pagando il 20% in 4 anni – se il giudice lo ritiene fattibile e i creditori non presentano opposizioni fondate, omologa, e l’80% è cancellato. Oppure un ex commerciante nullatenente può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente e azzerare tutti i debiti subito. La differenza è che i piccoli non passano dal fallimento ma da queste vie speciali. La Legge 3/2012 era poco conosciuta ma ora col Codice è potenziata e più accessibile. In breve: un imprenditore non fallibile ha diritto a una seconda chance tramite quelle procedure. Non esiste più lo scenario di “troppi debiti a vita” – a parte i debiti esclusi come fisco fraudolento o simili. Deve però rispettare le regole: dimostrare di non aver colpe gravi nella formazione del debito (la “meritevolezza”), offrire tutto il possibile ai creditori (anche magari redditi futuri per alcuni anni). Se lo fa, può ottenere l’esdebitazione. Dal 2012 a oggi migliaia di persone l’hanno ottenuta. Ad esempio, Cassazione 2018 ha concesso esdebitazione a un piccolo imprenditore benché avesse pagato solo il 2% ai creditori, perché il resto era andato in spese legali e lungaggini . Quindi, la risposta: sì, esistono procedure “soft” per i piccoli – anzi quelle oggi sono la via maestra (il fallimento “cattivo” è riservato alle imprese sopra soglia).
D: Che differenza c’è tra un accordo di ristrutturazione e un concordato preventivo? Quando conviene uno rispetto all’altro?
R: Le differenze principali: – L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art.182-bis L.F., ora art.57 CCII) è in sostanza un accordo contrattuale tra debitore e creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, con successiva omologazione del tribunale. Non c’è voto formale di tutti i creditori, solo le adesioni raccolte. I creditori non aderenti rimangono estranei (devono essere pagati a parte, per legge entro 120 giorni dall’omologa). – Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che coinvolge tutti i creditori (salvo quelli eventualmente estranei come fiscali che non votano). Prevede una votazione a maggioranza e vincola anche i dissenzienti. È quindi più vincolante erga omnes: una volta omologato, riguarda tutti i creditori antecedenti.
Quando conviene l’uno o l’altro? L’accordo conviene se: – hai già il supporto dei principali creditori (es. banche) ma magari vuoi evitare di pubblicizzare la crisi a tutti; – il numero di creditori è gestibile e puoi pagare integralmente i piccoli dissenzienti (così li tieni fuori dall’accordo senza problemi); – vuoi flessibilità nelle trattative (puoi negoziare condizioni diverse con ciascuno senza il rigore del concorso paritario).
L’accordo costa meno, è più rapido in genere (non c’è fase di voto, niente commissario, solo omologa) e mantiene la riservatezza (solo l’omologa è pubblica, ma a quel punto il più è fatto). Il concordato conviene se: – devi coinvolgere necessariamente tutti perché non puoi pagare fuori gli estranei; – hai tanti creditori diffusi e preferisci un processo ordinato unico; – serve protezione ampia (nel concordato hai lo stay automatico per tutti i creditori, nell’accordo devi richiederlo e non copre quelli estranei dopo i 120gg); – i creditori sono conflittuali tra loro e preferisci risolvere con una decisione a maggioranza e l’avallo del tribunale.
In pratica, quando l’indebitamento coinvolge poche banche o obbligazionisti principali, e l’azienda magari può pagare i trade creditors normalmente, un accordo è ideale. Quando invece c’è bisogno di falcidiare molti creditori diversi, e non c’è accordo spontaneo (magari c’è ostilità), il concordato è più efficace perché impone la cram-down con il voto del 51%. Da notare: col correttivo 2022 è stato introdotto il PRO, che è simile a un accordo ma con possibili cram-down di classi (quindi una via di mezzo). Un aspetto: il concordato porta a uno stigma (diventa pubblico che l’azienda era insolvente), l’accordo è percepito come più “soft” (spesso comunicato come piano di ristrutturazione del debito). Quindi, se l’obiettivo è ristrutturare senza perdere reputazione, l’accordo è preferibile. Viceversa, se serve una soluzione definitiva e onnicomprensiva, meglio il concordato. Spesso le aziende tentano prima l’accordo; se non raggiungono la soglia, ripiegano su un concordato.
D: Quanto dura e quanto costa, in media, una procedura di concordato o accordo?
R: La durata e i costi variano secondo la complessità: – Un accordo di ristrutturazione può essere negoziato nel giro di qualche mese (2-6 mesi di trattative) e, una volta depositato in tribunale, l’omologazione arriva in 2-3 mesi (salvo opposizioni). Quindi in 6-9 mesi dall’inizio si può chiudere. I costi: bisogna remunerare i professionisti (advisor finanziario, legale, attestatore). Non c’è figura del commissario né spese giudiziarie significative (a parte il contributo unificato di qualche centinaia di euro). Le parcelle possono variare, ma per PMI spesso i costi totali stanno entro il 2-5% del debito ristrutturato (es. hai 1 milione di debiti, spendi 20-50k tra commercialista e avvocato). Poi ovviamente dipende dallo studio: se è operazione grande, i costi salgono in valore assoluto ma scendono in percentuale.
– Un concordato preventivo è più lungo: la fase di predisposizione del piano può richiedere alcuni mesi; poi, dopo il deposito in tribunale, c’è l’ammissione, la convocazione dei creditori (di solito 120 giorni dopo), poi il voto e l’omologa. In media, un concordato arriva a omologa in ~6-12 mesi dal deposito. Se ci sono opposizioni, magari 15 mesi. L’esecuzione poi dura quanto il piano (può essere anni di pagamenti). Dunque, per liberarti formalmente dai debiti aspetti l’omologa (entro un anno circa), poi li paghi secondo piano per tot anni. I costi: c’è il compenso del Commissario Giudiziale e del liquidatore (se nominato), stabiliti dal tribunale in base percentuale sull’attivo e passivo (possono essere qualche punto percentuale). E le parcelle dei consulenti dell’azienda (avvocato, attestatore, ecc.). Il concordato è più costoso dell’accordo perché coinvolge più attori e formalità. In alcuni casi il 5-10% dell’attivo può andare in spese (soprattutto se l’attivo è piccolo). Tuttavia, i costi di procedura vengono calcolati e considerati nel piano, quindi non arrivano a sorpresa. Da considerare anche che il concordato esige liquidità per pagare almeno i creditori in prededuzione (professionisti, nuovi fornitori) e certe classi privilegiate. – La composizione negoziata in sé dura al max 6 mesi (prorogabili di altri 6). I costi sono molto bassi rispetto alle altre: il compenso dell’esperto è modesto (stabilito per legge in base al tempo impiegato, spesso qualche migliaio di euro coperto in parte da Camere di Commercio) e si pagano i consulenti eventualmente coinvolti. Quindi è lo strumento più snello e meno costoso, tant’è che l’hanno concepito per PMI. – Le procedure di sovraindebitamento hanno costi calmierati (l’organismo OCC prende un compenso fissato dal Ministero, di solito qualche punto percentuale sul debito o sull’attivo). Un piano del consumatore può costare ad esempio 2-3 mila euro di spese vive oltre il compenso dell’avvocato. In generale, cancellare i debiti non è gratuito: c’è un costo da pagare in professionalità e procedura. Ma rispetto a dover pagare il 100% dei debiti, è un investimento conveniente. L’alternativa extra-giudiziale (trattative private) può sembrare la più economica, ma attenzione: se fallisce, poi tocca comunque fare procedure e magari si è perso tempo e peggiorato il dissesto. Va anche detto che lo Stato agevola: le procedure concorsuali non pagano imposta di registro sugli atti, in alcune regioni ci sono contributi per le spese dell’OCC, ecc. In sintesi: un concordato/accordo ben riuscito riduce i debiti di percentuali molto maggiori dei costi sostenuti. Se devi pagare il 30% dei debiti e un 5% di costi, hai comunque abbattuto un 65%. L’importante è inserire i costi nel budget del piano e finanziarli adeguatamente (spesso con la continuità aziendale stessa o con contributo dei soci).
D: L’azienda può continuare ad operare durante queste procedure o deve fermarsi?
R: Una delle riforme importanti è permettere all’impresa di continuare l’attività anche mentre risana. Nel concordato in continuità l’azienda prosegue la gestione sotto il monitoraggio del commissario: può acquistare materie prime, vendere prodotti, incassare crediti. Deve però mantenersi in linea col piano e non aggravare i crediti. Anzi, spesso la continuità serve a generare cassa per pagare i creditori. Nel concordato liquidatorio, invece, l’attività generalmente cessa, salvo esercizio provvisorio se conviene vendere l’azienda funzionante. Nel accordo di ristrutturazione l’azienda assolutamente continua a operare (non essendo procedura concorsuale, l’imprenditore resta al timone e i contratti in essere proseguono, salvo accordi diversi). Nella composizione negoziata, espressamente, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria (salvo atti straordinari autorizzati). Anche nel sovraindebitamento: un consumatore o piccolo imprenditore in piano continua con la sua vita economica, anzi deve continuare a lavorare per generare reddito da offrire. Quindi, sì, l’esercizio dell’impresa può continuare durante la procedura di ristrutturazione. Ovviamente, se l’attività produce ulteriori perdite e non è sostenibile, allora la continuità va interrotta (il tribunale non ammette un concordato in continuità se il piano è manifestamente inidoneo a pagare creditori perché l’azienda continua a perdere soldi). Ma in molti casi l’azienda in crisi è ancora viable se alleggerita dal debito. Ci sono esempi di aziende che hanno attraversato il concordato e hanno proseguito l’attività con successo (basti pensare ad alcune note compagnie aeree o imprese di costruzioni). In queste situazioni, i fornitori post-petition vengono pagati regolarmente (prededuzione) e i clienti spesso neanche percepiscono la differenza, se non per qualche comunicazione pubblica. Insomma, la procedura concorsuale non è più sinonimo di serrata immediata: può essere uno strumento di turnaround in bonis. Il Codice anzi incentiva la continuità perché preserva meglio il valore (si evitano licenziamenti, si mantiene l’avviamento). Chi abusa della continuità (cioè la proclama ma poi non riesce) può incappare in revoca o in bancarotta semplice (mancata attivazione tempestiva). Quindi, la regola è: se c’è una chance, vai avanti e ristruttura; se non c’è, liquida subito.
D: Cosa succede se, nonostante la procedura scelta, non riesco comunque a risanare e pagare nemmeno le percentuali promesse?
R: Dipende dalla procedura: – Se è un accordo di ristrutturazione e l’azienda non rispetta l’accordo, i creditori aderenti riacquistano i loro diritti originali (salvo se l’accordo prevedeva clausole diverse). Possono attaccare l’azienda o chiederne il fallimento. Non c’è una “risoluzione giudiziale” automatica (l’accordo è un contratto: va fatto valere in giudizio di inadempimento). Ma in pratica, se salta, l’azienda di solito finisce in fallimento su istanza di un creditore stanco. – Se è un concordato preventivo omologato e il debitore è inadempiente (non esegue il piano ad es. non paga le prime rate ai creditori), qualsiasi creditore può chiedere al tribunale di dichiarare la risoluzione del concordato (art. 121 CCII). Una volta risolto, automaticamente l’azienda può essere dichiarata in liquidazione giudiziale (fallimento). I creditori riottengono titolo per l’intero credito originario diminuito di quanto eventualmente hanno ricevuto. Quindi, se prometti 30% e paghi solo 10%, possono risolvere e poi pretendere il 90% residuo nel fallimento (ma realisticamente prenderanno quel che c’è). Inoltre, l’inadempimento rilevante del concordato è anche reato (bancarotta post-concordataria, art. 337 vecchio L.F., ora credo assorbito in altre fattispecie di frode). – Se è una composizione negoziata che non raggiunge accordi, l’esperto conclude con esito negativo e praticamente si torna alla situazione iniziale, solo che ormai la crisi è conclamata. A quel punto o provi un concordato oppure i creditori potranno agire. Non c’è sanzione per la composizione negoziata fallita di per sé (a meno che l’imprenditore abbia fatto atti gravemente pregiudizievoli durante, ma allora sarebbe bancarotta). – Se è un piano del consumatore o concordato minore e il debitore non rispetta le condizioni, il tribunale può revocare l’omologazione e i creditori tornano allo status quo ante (meno gli acconti ricevuti). Nel sovraindebitamento in particolare, c’è cautela nel concedere piani troppo stretti: se poi salta, l’unica via è la liquidazione controllata (vendita di quel che c’è). L’esdebitazione nel sovraindebitamento è subordinata all’esecuzione del piano (o liquidazione per 3 anni). In sintesi, l’insuccesso di una procedura di ristrutturazione di solito fa cadere l’azienda in liquidazione giudiziale (fallimento). Il Codice però offre quell’ultimo jolly del concordato semplificato: se la composizione negoziata fallisce ma c’è ancora un patrimonio da liquidare, il debitore può proporre al volo un concordato semplificato e almeno evitare l’asta fallimentare, chiudendo con una distribuzione pilotata. Va chiarito: non rispettare il piano concordatario è molto grave e il management rischia grosso (perdita di fiducia del tribunale, possibili accuse di frode se il piano era infattibile sin dall’inizio). Quindi meglio proporre piani prudenti e sostenibili. Ad esempio, Cass. ha detto che un concordato con piano manifestamente inattuabile non va nemmeno ammesso. Dunque, se è stato ammesso e omologato, c’era l’aspettativa fondata di attuabilità; se poi il debitore si rivela inadempiente, i creditori penseranno che li abbia raggirati, con conseguenti azioni e possibili implicazioni penali. D’altra parte, se sopravviene un evento imprevisto (es. crisi pandemica) che rende impossibile eseguire il concordato, la legge consente di chiedere al tribunale una modifica del piano o una proroga dei termini, per evitare la risoluzione automatica (art. 120 CCII). È una norma di salvaguardia introdotta dopo il Covid-19 (infatti molte aziende in concordato hanno ottenuto di poter diluire di più i pagamenti). Quindi c’è un margine di flessibilità: se capisci che non ce la fai, puoi cercare di rimodulare con l’ok del giudice e, se rilevante, dei creditori. Ma se proprio salta, si torna alla casella fallimento, con i debiti di nuovo azionabili per intero.
D: Dopo aver cancellato i debiti con una procedura, l’azienda (o l’imprenditore) avrà difficoltà a ottenere credito in futuro?
R: È una domanda importante. Sicuramente, un pregresso concordato o fallimento rimane come informazione storica. Per le società di capitali, la visura camerale riporta l’eventuale stato di concordato o liquidazione giudiziale (e anche a posteriori molti lo sanno tramite articoli di stampa, ecc.). Ciò può rendere le banche e i fornitori più cauti inizialmente. Tuttavia, se l’azienda esce da un concordato con bilancio pulito e magari nuovi soci o governance migliorata, può riconquistare fiducia nel tempo. Legalmente, dopo l’omologa del concordato, l’azienda è libera di contrarre nuovi finanziamenti. Alcuni bandi pubblici o contratti potrebbero escludere chi è stato insolvente negli ultimi anni, quindi va valutato caso per caso. Per gli imprenditori individuali, la legge prevede che il nome rimanga nel registro dei soggetti esdebitati per qualche tempo (credo 4 anni per sovraindebitamento, 10 anni per fallimenti esdebitati su registro Crisi d’Impresa). Inoltre, c’è la questione delle centrali rischi: un debito falcidiato spesso appare come “saldo a stralcio” o “sofferenza risolta”, il che incide sul rating creditizio del soggetto per un po’. Detto ciò, l’esperienza mostra che molte aziende risanate riescono a riprendere credito, magari inizialmente con garanzie o pagando tassi più alti. Ci sono anche fondi e investitori specializzati in aziende post-concordato (le considerano pulite dal debito, quindi con potenziale). Un limite normativo: i pregiudicati per bancarotta fraudolenta non possono fare gli amministratori di società (interdizione). Ma se uno ha evitato condanne e ha ottenuto l’esdebitazione, non ha limitazioni. In sintesi: nel breve termine dopo la procedura, ottenere fidi bancari è difficile (le banche vorranno vedere qualche anno di bilanci sani post-crisi). Anche fornitori nuovi potrebbero pretendere pagamento anticipato. Per questo è utile, nei piani di continuità, prevedere finanza esterna (nuovi soci o partner) e un business plan credibile. Superati però i primi 2-3 anni di “track record” positivo, l’ombra del passato sbiadisce. Inoltre, l’uscita da una procedura riduce l’indebitamento e spesso migliora i parametri di bilancio, il che in teoria facilita il rating – ma ci vuole tempo perché questo si rifletta sui sistemi di credit scoring. Va aggiunto che in Italia non c’è un vero “fresh start” reputazionale: ad esempio, negli USA dopo il Chapter 11 molti imprenditori ottengono facilmente credito perché c’è la cultura del second chance. Da noi c’è ancora stigma: ad esempio le pubbliche amministrazioni a volte escludono da appalti chi ha avuto procedure concorsuali (anche se non dovrebbero discriminare dopo omologa, ma succede). Bisogna lavorare per riconquistare la fiducia di stakeholder, magari comunicando chiaramente che la crisi è stata superata e l’azienda è risanata e vigilata. In conclusione: sì, ci saranno difficoltà all’inizio, ma sono superabili. Meglio un’azienda con debiti pregressi azzerati e qualche problema di fiducia, che un’azienda strangolata dai debiti che magari ottiene credito solo indebitandosi ancora. Molte PMI che hanno fatto concordati poi hanno continuato con i medesimi fornitori e clienti perché la sostanza (prodotto, know-how) era valida. La fiducia si ricostruisce mostrando coerenza: se dopo la procedura l’azienda paga puntualmente i nuovi fornitori e rispetta i nuovi piani, piano piano la sua affidabilità risale. E la persona fisica esdebitata può rifarsi una vita creditizia, magari evitando all’inizio l’indebitamento e crescendo con mezzi propri finché le banche non la rivalutano.
Conclusione generale: Grazie al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, oggi in Italia “cancellare legalmente i debiti aziendali” è possibile attraverso procedure ben strutturate e tutelate. Le soluzioni vanno calibrate sul caso concreto: dalla semplice trattativa stragiudiziale (se la crisi è minore) fino al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale con esdebitazione (se la situazione è gravissima). Il denominatore comune dev’essere la tempestività e la buona fede dell’imprenditore: chi affronta il problema per tempo, con trasparenza e con l’ausilio di professionisti esperti, può riuscire a salvare l’impresa o quantomeno a chiudere dignitosamente la vicenda debitoria, tornando a una nuova vita economica senza l’oppressione dei debiti passati. Al contrario, ignorare la crisi o compiere azioni elusive peggiora solo le cose e può portare a conseguenze personali molto negative. Pertanto, come sottolineato: non rimandare. Esistono tutte le soluzioni per uscire dai debiti aziendali – dal risanamento in continuità alla liquidazione ordinata – ma vanno messe in campo con serietà e competenza, valutando pro e contro di ciascuna rispetto alle caratteristiche dell’impresa e dei suoi creditori.
In conclusione, cancellare i debiti aziendali è un percorso possibile e previsto dall’ordinamento: non significa sottrarsi alle proprie responsabilità, bensì utilizzare strumenti legali per regolare collettivamente la crisi, pagando quanto sostenibile e ottenendo l’esdebitazione del resto. Ciò permette all’imprenditore di avere quella “seconda chance” essenziale in un’economia dinamica, tutelando al contempo l’interesse dei creditori a una soddisfazione equa e tempestiva e quello generale alla conservazione del valore d’impresa e dei posti di lavoro. La chiave è agire con tempestività, competenza e nell’ambito della legge: con questo approccio, ripartire senza debiti non è uno slogan, ma una realtà raggiungibile.
Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, in vigore dal 15 luglio 2022 (artt. citati: 12-25-septies composizione negoziata, 25-sexies e septies concordato semplificato, 57-64 accordi di ristrutturazione, 63-83 sovraindebitamento, 84-120 concordato preventivo, 121-270 liquidazione giudiziale, 278 esdebitazione, 340-343 reati concorsuali, ecc.).
- Cassazione Civile Sez. I, 31/05/2023 n. 15359 – In tema di esdebitazione del fallito: le ipotesi di “non meritevolezza” del debitore elencate dall’art.142 L.F. (dolo o colpa grave, etc.) sono tassative e vanno interpretate alla luce del favor debitoris della Direttiva UE 2019/1023 . Il beneficio va concesso salvo che il fallito abbia lasciato i creditori totalmente insoddisfatti senza giustificazione (percentuale “affatto irrisoria”) .
- Cassazione Civile Sez. Un. 18/05/2021 n. 8500 – (richiamata da dottrina) Sulla definizione di consumatore sovraindebitato vs ex imprenditore: un soggetto che aveva debiti in parte professionali non poteva accedere al piano del consumatore. (Evoluzione poi superata dal CCII che consente qualche flessibilità).
- Cassazione Civile, ord. 02/07/2025 n. 14835 – Ha chiarito il diritto transitorio sull’esdebitazione: per procedure fallimentari aperte prima del 15/07/2022 e chiuse dopo tale data, si continua ad applicare la vecchia legge fall. (artt.142-144 L.F.), quindi l’esdebitazione spetta solo al fallito persona fisica, non alla società. Confermato che nel CCII l’istituto è inserito come fase conclusiva della liquidazione giudiziale, ma non retroagisce su fallimenti pendenti.
- Cassazione Penale Sez. V, 15/04/2010 n. 12388 – (Caso Zorzi): Riconosce la causa di non punibilità della bancarotta preferenziale ex art. 217-bis L.F. (ora art.324 CCII) qualora il concordato preventivo abbia soddisfatto i creditori chirografari nella misura minima di legge. In altre parole, se c’è un concordato con esito positivo (all’epoca 40%, oggi 20%), i pagamenti preferenziali antecedenti non sono punibili perché rientra la ratio premiale della norma.
- Cassazione Penale Sez. V, 24/05/2022 n. 18833 – (Non menzionata sopra, ma rilevante) Ha affermato che l’imprenditore che, in composizione negoziata, occulta parte dell’attivo o aggrava il passivo, può rispondere di reati di bancarotta anche se non vi è (ancora) fallimento, qualificando tali atti come finalizzati a frodare futuri creditori concorsuali (anticipando la tutela penale anche nella trattativa). [N.B.: interpretazione analogica criticabile, ma segnala attenzione alle condotte in composizione].
- Decreto Legge 118/2021 conv. L.147/2021 – Introduzione della Composizione Negoziata e Concordato semplificato. Base normativa degli artt. 12-25 CCII.
- Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 – Insolvency Directive: ispiratrice delle novità in materia di ristrutturazioni preventive (PRO) e di esdebitazione dell’imprenditore onesto entro 3 anni. In particolare art.23 sull’esdebitazione (favor). Recepita con D.Lgs. 83/2022.
- Agenzia Entrate – Risposta a interpello n.179/2025 del 7 luglio 2025: ha precisato che la non imponibilità delle sopravvenienze attive ex art.88 co.4-ter TUIR non si applica alle riduzioni di debiti derivanti da concordato semplificato ex artt.25-sexies e septies CCII. Ciò ha evidenziato una lacuna normativa. Previsti interventi per includere anche tali procedure nel regime di esenzione (cfr. comunicato MEF 2025 – estensione art.88 in legge bilancio 2026 in discussione).
- Agenzia Entrate – Provvedimento prot. 21447 del 29/01/2024: disciplina interna sulle soglie decisionali in sede di transazione fiscale. Stabilisce che per proposte di stralcio oltre 70% o debiti > 30 mln €, la Direzione Regionale AE deve approvare (garantendo uniformità).
- INPS – Messaggio n. 3553 del 05/10/2024: istruzioni operative per la gestione delle transazioni contributive nelle procedure di crisi, in attuazione dell’art.63 CCII. Conferma la falcidiabilità dei contributi a carico ditta con criteri analoghi al Fisco e la necessità di pagamento integrale delle quote dipendenti.
- Tribunale di Milano, decreto 28/04/2023 – Ha omologato il primo Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione in Italia. Ha confermato che il PRO può avere contenuto misto (continuità parziale e cessione beni) e ha applicato il cram-down su una classe dissenziente di fornitori, ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all’art.64-quater CCII (nessuna classe inferiore riceve più della classe dissenziente, trattamento conforme a priority relativa). [Precedente non ufficiale pubblicato su riviste specializzate].
- Tribunale di Roma, 30/09/2022 – Concordato preventivo Gruppo Mercatone Uno: esempio di concordato in continuità indiretta con suddivisione in classi e soddisfacimento parziale di creditori chirografari ~31%. Ha evidenziato l’applicazione dell’art. 112 CCII sulle classi dissenzienti, omologando nonostante il voto contrario di una classe minoritaria, poiché il piano assicurava comunque il rispetto della absolute priority rule (caso pubblicato in IlCaso.it).
- Corte di Giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016 (causa C-546/14) – (Degano Trasporti): ha sancito che la normativa italiana che vietava la falcidia dell’IVA in concordato (art.182-ter L.F. ante 2017) era incompatibile con la Direttiva IVA, purché allo Stato venisse garantito un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in procedure concorsuali alternative. Questo ha portato alla modifica dell’art.182-ter L.F. (L.232/2016) permettendo l’inclusione dell’IVA nelle transazioni.
- Cassazione Civile, Sez. I, 08/03/2018 n. 5837 – Ha affermato che nel concordato preventivo la proposta ai creditori privilegiati dissenzienti deve garantire loro almeno il valore di realizzo dei beni su cui grava la prelazione, al netto di costi di liquidazione e in base a stima prudenziale (principio poi codificato nell’art. 109 CCII). [Si cita come orientamento sulla tutela del credito privilegiato nel concordato].
- Cassazione Civile, Sez. I, 27/03/2018 n. 7550 – (menzionata in Unijuris) Ha sostenuto, ante riforma, un’interpretazione rigorosa della preclusione per esdebitazione in caso di soddisfacimento nullo dei creditori, chiedendo di valutare se l’insoddisfazione totale fosse imputabile a condotta del debitore. Pronuncia poi armonizzata dalla 15359/2023 .
- Documento CNDCEC – Linee Guida Composizione Negoziata (Ed. settembre 2022): fornisce prassi operative per esperti e imprese nella composizione negoziata. Utile per capire obblighi di lealtà, comportamento dell’esperto, ecc. Richiamato da Tribunale di Milano, ord. 23/11/2022 (che ha rimosso un esperto per violazione doveri).
- Relazione Illustrativa al D.Lgs. 14/2019 – spiega ratio di molte norme: p.es. enfatizza il passaggio da una logica punitiva a una di recupero dell’impresa, e il rafforzamento delle azioni di responsabilità (art.378 CCII) per evitare che la gestione tardiva resti impunita.
- Dossier Camera Deputati n.99 – “Codice della Crisi, aggiornamento 2022”: illustra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022, tra cui l’abbassamento soglia concordato liquidatorio dal 30% al 20%, introduzione PRO (artt.64-bis e ss), estensione transazione fiscale a IVA, disciplina concordato semplificato. Riferimento istituzionale per novità normative citate.
Hai una ditta individuale, un’impresa artigiana o una piccola società che ha accumulato debiti con banche, fornitori, INPS o Agenzia delle Entrate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai una ditta individuale, un’impresa artigiana o una piccola società che ha accumulato debiti con banche, fornitori, INPS o Agenzia delle Entrate?
Hai chiuso o stai per chiudere la tua attività e non sai come liberarti legalmente dai debiti aziendali che continuano a perseguitarti?
👉 La buona notizia è che oggi esistono procedure legali precise per cancellare o ridurre i debiti aziendali, anche dopo la cessazione dell’impresa.
In questa guida scoprirai chi risponde dei debiti aziendali, quali strumenti la legge mette a disposizione e come ottenere l’esdebitazione definitiva e ripartire senza più pendenze.
⚖️ Cosa succede ai debiti di un’impresa
Molti imprenditori credono che, chiudendo l’attività o cancellando la partita IVA, i debiti si estinguano.
In realtà, non è così:
- Se hai una ditta individuale, rispondi personalmente con tutto il tuo patrimonio (conti, auto, immobili).
- Se hai una società di persone (SNC o SAS), rispondi anche con i beni personali, insieme agli altri soci.
- Solo nelle società di capitali (SRL, SPA), i soci in genere non rispondono con il proprio patrimonio personale — ma gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in caso di irregolarità fiscali o gestionali.
📌 Tuttavia, oggi la legge prevede diverse soluzioni per cancellare legalmente i debiti aziendali, sia per chi ha chiuso l’impresa, sia per chi è ancora in attività ma non riesce più a pagare.
👥 Chi può accedere alla cancellazione dei debiti
- Ex titolari di ditta individuale o artigiana.
- Piccole imprese non soggette a liquidazione giudiziale (ex fallimento).
- Soci di società di persone (SNC o SAS) con debiti personali o aziendali.
- Ex amministratori o garanti di imprese indebitate.
- Professionisti e lavoratori autonomi in crisi economica.
🧾 Tipologie di debiti aziendali che si possono cancellare
✅ Ammessi all’esdebitazione o alla riduzione:
- Debiti fiscali (IRPEF, IVA, IRAP, addizionali).
- Debiti contributivi (INPS, INAIL).
- Debiti bancari, mutui, fidi, leasing.
- Debiti commerciali (fornitori, clienti, collaboratori).
- Cartelle esattoriali e accertamenti tributari.
❌ Non cancellabili:
- Obblighi di mantenimento familiare.
- Sanzioni penali o amministrative non tributarie.
- Debiti derivanti da frodi, dolo o comportamenti illeciti.
🧩 Tutte le soluzioni per cancellare i debiti aziendali
💠 1. Concordato minore (per ex imprenditori e artigiani)
È la procedura più efficace per chi ha chiuso o sta per chiudere la ditta.
Permette di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale o un saldo e stralcio, con l’approvazione del Tribunale.
Una volta eseguito, il debito residuo viene cancellato con l’esdebitazione finale.
👉 È accessibile anche a chi non ha più la partita IVA attiva.
💠 2. Liquidazione controllata (ex liquidazione del sovraindebitato)
Se non puoi più proporre un piano, puoi mettere a disposizione i beni non essenziali (veicoli, quote, risparmi).
Il ricavato viene usato per soddisfare in parte i creditori, e il resto viene cancellato con decreto del giudice.
📌 È una soluzione definitiva per chi non ha più la possibilità di ripartire.
💠 3. Esdebitazione del debitore incapiente
Riservata a chi non possiede beni né redditi sufficienti.
Il giudice, verificata la buona fede, cancella completamente tutti i debiti, anche fiscali e contributivi.
Può essere concessa una sola volta nella vita.
💠 4. Ristrutturazione del debito aziendale (per imprese ancora attive)
Le imprese non ancora cessate possono proporre ai creditori un piano di rientro negoziato, approvato dal Tribunale, che prevede:
- sospensione delle azioni esecutive;
- rate sostenibili;
- riduzione degli interessi e delle sanzioni;
- cancellazione del debito residuo a fine piano.
💠 5. Saldo e stralcio o accordo bonario con i creditori
In alternativa alla via giudiziale, è possibile trattare direttamente con banche, finanziarie e fornitori.
Molte accettano una chiusura ridotta tra il 30% e il 60% del debito pur di evitare contenziosi lunghi e costosi.
🧠 I requisiti fondamentali per ottenere la cancellazione dei debiti
- Cessazione dell’attività (per ex imprenditori).
- Stato di sovraindebitamento: incapacità di pagare integralmente i debiti.
- Buona fede e trasparenza nella gestione dell’impresa.
- Collaborazione con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi).
- Assenza di frodi o atti di distrazione dei beni.
🏛️ Come funziona la procedura passo dopo passo
- Analisi iniziale con un avvocato esperto in debiti aziendali.
- Nomina dell’OCC, che verifica la documentazione contabile e fiscale.
- Redazione della relazione e del piano di rientro o liquidazione.
- Deposito del ricorso in Tribunale con richiesta di misure protettive.
- Blocco immediato di pignoramenti e azioni esecutive.
- Udienza di omologazione del piano.
- Esecuzione del piano o liquidazione dei beni.
- Esdebitazione finale con cancellazione dei debiti residui.
📋 Documenti richiesti
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Visura camerale e certificato di chiusura della ditta.
- Bilanci o contabilità semplificata.
- Estratti di ruolo AER e cartelle esattoriali.
- Avvisi di addebito INPS e INAIL.
- Contratti di mutuo, leasing o prestiti.
- Estratti conto bancari.
- Elenco dei creditori e dei debiti.
- Spese familiari e documenti patrimoniali.
⏱️ Tempi e risultati
- Preparazione e deposito del piano: 2–4 mesi.
- Blocco delle azioni esecutive: immediato al deposito.
- Omologazione del Tribunale: 3–8 mesi medi.
- Durata del piano: 1–5 anni, in base alla sostenibilità.
🎯 Risultato finale:
- Cancellazione totale o parziale dei debiti fiscali, contributivi e bancari.
- Blocco di pignoramenti, fermi e ipoteche.
- Ripartenza economica e reputazionale pulita.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato delle azioni dei creditori.
✅ Riduzione o cancellazione legale dei debiti aziendali.
✅ Tutela dei beni personali e familiari.
✅ Cancellazione definitiva del debito residuo.
✅ Possibilità di ricominciare da zero con serenità.
🚫 Errori da evitare
- Ignorare cartelle o notifiche dei creditori.
- Tentare accordi non scritti o non verificati da un avvocato.
- Nascondere beni o conti: fa decadere la meritevolezza.
- Affidarsi a “consulenti del debito” non abilitati.
- Pensare che la chiusura della ditta cancelli i debiti da sola.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione aziendale e individua la strategia più adatta.
📌 Coordina la raccolta documentale con l’OCC competente.
✍️ Redige e deposita il piano di concordato, liquidazione o esdebitazione.
⚖️ Ti rappresenta in Tribunale e nei rapporti con Agenzia delle Entrate, INPS, banche e fornitori.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione definitiva dei debiti aziendali e alla riabilitazione completa.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario, bancario e crisi d’impresa.
✔️ Specializzato nella difesa di imprenditori e artigiani indebitati.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
I debiti aziendali non sono per sempre: oggi la legge ti consente di ridurli, bloccarli o cancellarli completamente attraverso procedure trasparenti e approvate dal Tribunale.
Con l’assistenza di un professionista puoi chiudere definitivamente con il passato e ripartire libero dai debiti.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova vita imprenditoriale senza debiti comincia oggi.