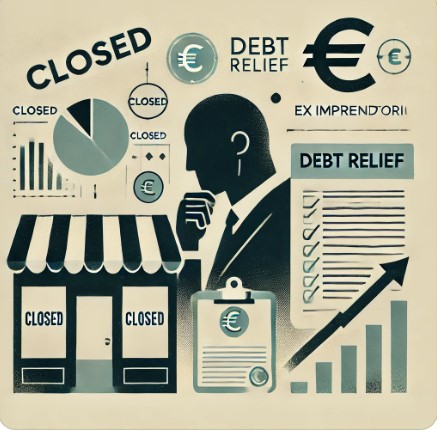Hai chiuso la tua impresa ma sei ancora sommerso da debiti con il Fisco, le banche o i fornitori?
Molti ex imprenditori, dopo aver cessato l’attività, restano intrappolati in una situazione di sovraindebitamento: mutui aziendali, fideiussioni, cartelle esattoriali e prestiti non pagati continuano a pesare sulla vita privata e sul reddito personale.
Oggi però esiste una soluzione concreta e legale: l’esdebitazione per ex imprenditori, una procedura prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che permette di cancellare i debiti residui e ripartire senza pendenze.
Cos’è l’esdebitazione per ex imprenditori
L’esdebitazione è una procedura che consente all’ex imprenditore o al titolare di partita IVA cessata di ottenere la cancellazione parziale o totale dei debiti rimasti dopo la chiusura dell’attività.
Si applica a chi non può accedere al fallimento o alla liquidazione giudiziale perché non rientra nei requisiti dimensionali (piccoli imprenditori, artigiani, professionisti, lavoratori autonomi).
Il beneficio si ottiene al termine di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, a condizione che il debitore sia meritevole, collaborativo e trasparente.
Chi può accedere all’esdebitazione da ex imprenditore
Possono accedere alla procedura:
- Ex titolari di ditte individuali o microimprese non soggette a liquidazione giudiziale.
- Professionisti o artigiani che hanno cessato l’attività ma conservano debiti fiscali o bancari.
- Soci o garanti di società che hanno risposto personalmente dei debiti aziendali.
- Ex imprenditori che hanno chiuso la partita IVA e non hanno più beni sufficienti per soddisfare i creditori.
È necessario dimostrare di:
- Aver agito con buona fede e senza frodi o distrazioni di beni.
- Essere effettivamente incapace di far fronte ai debiti residui.
- Essere collaborativi con il tribunale e con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Quali debiti possono essere cancellati
Attraverso la procedura di esdebitazione, possono essere eliminati o fortemente ridotti:
- Debiti fiscali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, cartelle esattoriali).
- Contributi previdenziali e debiti verso INPS e INAIL.
- Finanziamenti bancari e mutui aziendali.
- Fideiussioni personali o garanzie rilasciate per l’impresa.
- Debiti verso fornitori e privati.
- Sanzioni e interessi maturati nel tempo.
Restano esclusi dall’esdebitazione i debiti per:
- Danni da reato.
- Obblighi alimentari e di mantenimento.
- Multe e sanzioni penali.
Le procedure che permettono di ottenere l’esdebitazione
L’ex imprenditore può accedere a una delle seguenti procedure previste dal Codice della Crisi:
- Concordato minore
È una ristrutturazione dei debiti tramite accordo con i creditori, compreso il Fisco. Prevede un piano di pagamento parziale, rateizzato e sostenibile, approvato dai creditori e omologato dal giudice. - Liquidazione controllata del sovraindebitato
Si mettono a disposizione i beni del debitore per la vendita e la soddisfazione dei creditori. Al termine, il giudice cancella i debiti residui con il decreto di esdebitazione. - Esdebitazione del debitore incapiente
È destinata a chi non ha beni né redditi per proporre un piano. Il giudice può concedere la cancellazione totale dei debiti se il debitore è meritevole e non può ragionevolmente offrire nulla ai creditori.
Come si avvia la procedura di esdebitazione
Il percorso prevede passaggi precisi e assistenza professionale:
- Raccolta dei documenti: elenco completo di debiti, cartelle, mutui, estratti conto, redditi e spese personali.
- Analisi della situazione con un avvocato tributarista e un OCC per valutare la procedura più adatta.
- Predisposizione del piano o della domanda di liquidazione da depositare al tribunale competente.
- Richiesta delle misure protettive per sospendere pignoramenti, fermi o azioni esecutive in corso.
- Omologa del piano o apertura della liquidazione con controllo del giudice.
- Decreto di esdebitazione finale, che cancella i debiti residui.
Vantaggi dell’esdebitazione per ex imprenditori
- Cancellazione definitiva dei debiti fiscali, bancari e contributivi.
- Stop immediato a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
- Possibilità di conservare beni essenziali come l’abitazione o gli strumenti di lavoro.
- Ritorno alla piena regolarità fiscale e patrimoniale.
- Protezione legale e serenità personale dopo anni di pressioni e solleciti.
Quanto dura la procedura
I tempi variano in base alla complessità del caso e al tribunale competente, ma in media:
- Da 6 a 18 mesi per piani di ristrutturazione o concordati.
- Fino a 24-36 mesi per liquidazioni complesse.
- 4-6 mesi per l’esdebitazione dei debitori incapienti.
Come un avvocato tributarista può aiutarti
Un avvocato esperto in diritto tributario e sovraindebitamento può:
- Analizzare la tua situazione economica e i debiti residui.
- Individuare la procedura più rapida ed efficace.
- Bloccare subito pignoramenti e azioni esecutive.
- Negoziare con Agenzia delle Entrate-Riscossione e banche.
- Presentare il piano al tribunale e seguirlo fino al decreto di esdebitazione.
Cosa ottieni con una procedura di esdebitazione ben gestita
- L’annullamento totale o parziale dei debiti residui.
- La sospensione immediata delle azioni di riscossione.
- La protezione del patrimonio personale.
- Il ritorno alla serenità economica e alla piena operatività.
⚠️ Attenzione: ignorare i debiti dopo la chiusura dell’attività può portare a pignoramenti, segnalazioni in CRIF e iscrizioni ipotecarie. Agire subito è fondamentale per evitare danni permanenti e per accedere ai benefici dell’esdebitazione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e sovraindebitamento – spiega passo dopo passo come funziona l’esdebitazione per ex imprenditori, come accedervi e come liberarti legalmente dai debiti in modo rapido e sicuro.
👉 Hai chiuso la tua impresa ma sei ancora oppresso dai debiti?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo.
Analizzeremo la tua situazione, verificheremo se puoi accedere all’esdebitazione e costruiremo una strategia efficace per cancellare i debiti e tornare a vivere sereno.
Introduzione
L’esdebitazione è uno strumento giuridico fondamentale che consente al debitore onesto ma sfortunato di liberarsi dei debiti residui dopo una procedura concorsuale (fallimento o liquidazione) e ottenere così un “fresh start” economico. In altre parole, l’esdebitazione offre un seconda chance al debitore – spesso un ex imprenditore – permettendogli di ripartire senza il peso dei debiti pregressi. Introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano nel 2006 per i fallimenti delle persone fisiche, e successivamente estesa ai soggetti non fallibili con la legge sul sovraindebitamento del 2012, oggi l’istituto è organicamente disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Tale Codice, entrato in vigore definitivamente nel 2022, ha innovato la materia prevedendo tutte le forme di esdebitazione possibili, inclusa un’inedita procedura di esdebitazione “a costo zero” per il debitore incapiente (cioè privo di qualsiasi capacità di rimborso) .
Questa guida – scritta con un taglio giuridico divulgativo, dal punto di vista del debitore – offre un quadro completo e approfondito (oltre 10.000 parole) sull’esdebitazione, aggiornato a settembre 2025. Saranno illustrati tutti gli strumenti di esdebitazione previsti dal CCII, con riferimenti normativi puntuali, le ultime sentenze di merito e di legittimità, e consigli pratici su come procedere. Non mancheranno tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti. L’obiettivo è fornire agli ex imprenditori, ma anche ai consumatori e ai professionisti del settore (avvocati, commercialisti), una guida autorevole per “farlo bene”: capire i requisiti di meritevolezza, i passi procedurali, i benefici e i limiti dell’esdebitazione, così da evitare errori e cogliere al meglio questa opportunità di risanamento personale.
Cos’è l’esdebitazione e a chi serve
Il termine esdebitazione indica la liberazione del debitore dai debiti residui non soddisfatti al termine di una procedura concorsuale di liquidazione. In sostanza, se un imprenditore fallito o un soggetto sovraindebitato ha subito la liquidazione del proprio patrimonio, ma tale patrimonio non è bastato a pagare tutti i creditori, attraverso l’esdebitazione egli viene esentato dal dover pagare il restante. I creditori concorsuali insoddisfatti non potranno più agire contro di lui per il recupero di quei crediti: questi ultimi divengono inesigibili nei confronti del debitore beneficiato dall’esdebitazione. L’esdebitazione realizza così un importante equilibrio di interessi: da un lato sacrifica le pretese creditorie rimaste insoddisfatte, dall’altro persegue la finalità pubblicistica del cosiddetto fresh start, ossia il reinserimento del debitore onesto nel tessuto economico-sociale.
Originariamente, l’ordinamento fallimentare italiano del 1942 non prevedeva alcuna liberazione dai debiti per il fallito: chi falliva rimaneva comunque obbligato verso i creditori per la parte di debito non pagata nella procedura, vita natural durante. Ciò veniva percepito come una “pena perpetua” che scoraggiava il rischio d’impresa e ostacolava il ritorno alla normalità economica. Solo con la riforma del 2006 il legislatore ha introdotto l’esdebitazione nel vecchio Regio Decreto 267/1942 (Legge Fallimentare), inizialmente riservandola al fallito persona fisica e subordinandola a stringenti condizioni di meritevolezza (assenza di condanne per bancarotta, cooperazione, ecc.). Successivamente, con la Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento, si è estesa una forma di esdebitazione anche ai debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti), al termine di procedure come il piano del consumatore o la liquidazione dei beni.
Oggi, con il nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019), l’accesso all’esdebitazione è divenuto un diritto per il debitore persona fisica meritevole, sia esso un ex imprenditore fallito o un privato sovraindebitato. Non solo: il CCII prevede espressamente anche un meccanismo di esdebitazione speciale per il debitore incapiente, cioè colui che non dispone di alcuna utilità da offrire ai creditori nemmeno in prospettiva futura . Questa novità, ispirata alle direttive UE sul sovraindebitamento, segna un cambio di paradigma: si permette il perdono dei debiti anche a chi non può dare nulla, come misura residuale ed eccezionale per incentivare il reinserimento produttivo della persona onesta ma sfortunata.
In sintesi, l’esdebitazione serve principalmente a: – Ex imprenditori falliti (o liquidati) in buona fede, per liberarli dai debiti rimasti dopo la chiusura del fallimento (ora liquidazione giudiziale) e consentire loro di tornare a fare impresa o lavorare senza il fardello delle insolvenze passate. – Consumatori e piccoli imprenditori sovraindebitati, soggetti a procedure di composizione della crisi (piani di ristrutturazione o liquidazione controllata), per cancellare i debiti non pagati e ristabilire il proprio equilibrio finanziario. – Debitori “incapienti”, ossia persone fisiche totalmente prive di risorse, per ottenere un fresh start immediato “a costo zero”, purché abbiano agito senza dolo o colpa grave nella formazione del debito.
Va evidenziato che possono beneficiare dell’esdebitazione solo le persone fisiche. Le società di capitali, infatti, una volta liquidate cessano di esistere e i loro debiti residui restano inesigibili de facto per mancanza del soggetto debitore (anche se, in certi casi, i soci illimitatamente responsabili possono chiedere l’esdebitazione per i debiti sociali a loro carico). Dunque la guida si concentra sul debitore persona fisica, con particolare attenzione agli ex imprenditori individuali o soci di società di persone, che dopo la liquidazione dell’azienda intendono voltare pagina liberandosi dei debiti eccedenti.
Evoluzione normativa: dalla Legge Fallimentare al Codice della Crisi
Per contestualizzare l’istituto, ripercorriamo brevemente l’evoluzione normativa dell’esdebitazione in Italia:
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): Nel testo originario non prevedeva alcun esonero dai debiti per il fallito. Il fallimento comportava la liquidazione dei beni del debitore e la ripartizione ai creditori, ma ogni eventuale debito residuo restava a carico del fallito senza possibilità di essere cancellato. Ciò spesso condannava il fallito (spesso un piccolo imprenditore individuale) a un’esposizione debitoria a vita, con pesanti conseguenze sociali ed economiche.
- Riforma 2006 (D.Lgs. 5/2006 e D.Lgs. 169/2007): Viene introdotto l’art. 142 L.F. che disciplina l’esdebitazione del fallito persona fisica. Per la prima volta, il fallito onesto poteva essere “graziato” dai debiti rimasti post-fallimento. Tuttavia, la concessione del beneficio era subordinata a vari requisiti di meritevolezza (assenza di condanne per bancarotta fraudolenta e altri reati, non aver aggravato il dissesto con dolo o colpa grave, aver cooperato con gli organi della procedura, ecc.) e non poteva in ogni caso riguardare alcuni debiti specifici (in particolare alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni – su cui infra). Inoltre, l’interpretazione iniziale richiedeva che il fallito avesse soddisfatto in parte i creditori per poter accedere al beneficio (il previgente art. 142, comma 2 L.F. negava l’esdebitazione se i creditori erano rimasti totalmente insoddisfatti). Questa limitazione è stata poi superata da una lettura più attenta al favor del debitore: la Corte di Cassazione ha chiarito che, se il debitore soddisfa le condizioni di legge, l’esdebitazione va concessa anche in caso di pagamento solo simbolico dei creditori, salvo il caso di soddisfacimento davvero pari a zero o “del tutto irrisorio” . Tale impostazione è coerente con la Direttiva UE 2019/1023, che raccomanda di non subordinare il fresh start al pagamento di soglie minime ai creditori .
- Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento: Ha introdotto procedure concorsuali anche per i debitori civili o economici non fallibili (ossia non soggetti né assoggettabili a fallimento/liq. giudiziale). Tali procedure – accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio – miravano a gestire e risolvere situazioni di sovraindebitamento di privati, professionisti, ditte sotto soglia, ecc. L’art. 14-terdecies L.3/2012 prevedeva l’esdebitazione del sovraindebitato persona fisica al termine della liquidazione dei beni, con presupposti simili a quelli dell’esdebitazione fallimentare (meritevolezza, assenza di dolo o frode, ecc.), ma con qualche differenza sul piano soggettivo. Nel 2020, la L.3/2012 è stata novellata (L. n.176/2020) introducendo, per la prima volta, una forma di esdebitazione “senza utilità” per il debitore incapiente (art. 14-quaterdecies L.3/2012), anticipando di fatto quanto poi confluito nel Codice della Crisi.
- Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): Si tratta di un testo unico che ha riordinato l’intera materia concorsuale (fallimento, procedure di allerta, concordati, sovraindebitamento, ecc.), in attuazione della legge delega n.155/2017. L’entrata in vigore del CCII, inizialmente prevista per agosto 2020, è stata più volte rinviata, complice la pandemia, fino alla data chiave del 15 luglio 2022 (con ulteriori correttivi emanati nel 2020, 2021 e 2022). Il CCII ha sostituito la legge fallimentare e la legge 3/2012, unificando terminologie e discipline. Il fallimento è stato ribattezzato “liquidazione giudiziale”, ma nei contenuti resta simile; le procedure da sovraindebitamento sono confluite in nuovi istituti denominati concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata del sovraindebitato. Riguardo all’esdebitazione, il Codice della Crisi (Titolo V, Capo X) ha rafforzato il diritto del debitore meritevole al beneficio, introducendo alcune novità sostanziali:
- Esdebitazione dopo 3 anni: l’art. 279 CCII stabilisce che il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione (giudiziale o controllata), o anche prima se la procedura si chiude anticipatamente. Ciò significa che se la liquidazione si protrae molto a lungo, il debitore non dovrà attendere indefinitamente: trascorsi tre anni dall’inizio, potrà comunque ottenere la liberazione dai debiti (fermo restando il controllo di meritevolezza). Questo è un significativo miglioramento rispetto al passato.
- Eliminazione del limite del pagamento parziale: diversamente dalla vecchia legge fallimentare, il CCII non preclude l’esdebitazione in caso di mancato pagamento di una parte dei crediti. Non c’è più una norma che richieda un pagamento seppur minimo. Questo adeguamento, in linea con le indicazioni europee, consente il beneficio anche nei casi di soddisfacimento nullo o quasi nullo, purché il debitore sia in buona fede. È stata così sancita definitivamente la tassatività dei motivi ostativi: solo le cause espressamente previste dalla legge possono giustificare un diniego, senza aggiungere criteri “equitativi” ulteriori .
- Esdebitazione estesa ai sovraindebitati e incapienti: il CCII disciplina unitariamente l’esdebitazione sia nel contesto della liquidazione giudiziale (ex fallimento) sia in quello della liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio per i non fallibili). Inoltre, come detto, introduce all’art. 283 una procedura specifica per l’incapiente, anche al di fuori di una vera liquidazione concorsuale (è un procedimento autonomo davanti al giudice).
- Maggiore automatismo e snellezza procedurale: l’esdebitazione nel CCII si configura sempre meno come una concessione discrezionale e sempre più come un diritto soggettivo del debitore meritevole. Il tribunale verifica i presupposti, ma non può rifiutare l’esdebitazione se essi sono soddisfatti . Sono previsti termini e modalità precise per la richiesta (ad esempio, nel fallimento la domanda va presentata entro 1 anno dalla chiusura, se non richiesta prima – termine già presente in L.Fall. art.143). Inoltre, i creditori hanno facoltà di proporre osservazioni o reclamo, ma solo dopo che il beneficio è stato accordato, a riprova della natura spiccatamente orientata al fresh start dell’istituto.
- Decreti Correttivi 2020-2023: Il Codice della Crisi è stato oggetto di vari decreti correttivi. Di particolare rilievo è il D.Lgs. 83/2022 (c.d. “correttivo-bis”), entrato in vigore contestualmente al Codice, che ha apportato alcune modifiche tecniche. Ancor più recente è il D.Lgs. 13 settembre 2024, n.136 (c.d. “correttivo-ter”), pubblicato il 27/09/2024, che ha introdotto ulteriori ritocchi alla disciplina dell’esdebitazione. In particolare, questo decreto ha:
- riorganizzato la struttura del Capo X, suddividendo le norme in Sezione I (generale), Sezione I-bis (liquidazione giudiziale) e Sezione II (liquidazione controllata);
- modificato leggermente l’art. 280 comma 1 lett. a), riguardante i reati ostativi, precisando che in caso di procedimento penale pendente per quei reati il tribunale rinvia la decisione sull’esdebitazione all’esito del processo (anziché escludere in modo definitivo il beneficio sino a definizione del giudizio penale);
- abrogato la preclusione che escludeva l’accesso alle procedure di sovraindebitamento a chi vi avesse già fatto ricorso nei 5 anni precedenti. Ora, se una precedente procedura di sovraindebitamento non ha comportato esdebitazione, il debitore può accedere nuovamente senza attendere un quinquennio.
- aumentato da 60 a 90 giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo nel fallimento (art. 270 CCII) , misura utile ai creditori ma indirettamente benefica anche per il debitore in termini di ordinato svolgimento della procedura.
- chiarito alcuni aspetti procedurali per l’esdebitazione a 3 anni (art. 281 comma 3) e per il coordinamento tra chiusura della liquidazione e atti ancora pendenti.
Attenzione alla disciplina transitoria: le procedure di fallimento aperte prima dell’entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022) restano disciplinate dalle norme previgenti, compreso l’istituto dell’esdebitazione. La Corte di Cassazione ha infatti di recente confermato che, se un fallimento è iniziato sotto la vecchia legge e si chiude dopo il 2022, la relativa istanza di esdebitazione va valutata secondo la Legge Fallimentare e non secondo il CCII. In altri termini, le nuove regole (ad es. il termine di 3 anni) non si applicano retroattivamente ai fallimenti pendenti: per quelli vale ancora, ad esempio, l’obbligo di attendere la chiusura e il rispetto dei requisiti ex art.142 L.F. Questa impostazione discende dal fatto che l’esdebitazione è considerata parte integrante della procedura concorsuale iniziata, e non un istituto autonomo sganciato da essa. Pertanto, gli ex imprenditori falliti prima di luglio 2022 dovranno ancora seguire le vecchie regole (domanda entro 1 anno dalla chiusura, cause ostative ex art.142 L.F., ecc.), mentre chi è fallito dopo tale data segue il CCII. Analogamente, le procedure di sovraindebitamento aperte ante 2022 seguono la legge 3/2012. È fondamentale tener conto di ciò per evitare errori: diversi casi giurisprudenziali recenti hanno riguardato proprio la corretta applicazione intertemporale delle norme.
Le tipologie di esdebitazione nel Codice della Crisi
Il Codice della Crisi prevede tre principali forme di esdebitazione rivolte al debitore persona fisica insolvente, a seconda della procedura concorsuale (o para-concorsuale) cui è stato soggetto:
- Esdebitazione a seguito di liquidazione giudiziale – È la “classica” esdebitazione post-fallimentare, ora riferita alla procedura di liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento). Si applica all’imprenditore (o socio illimitatamente responsabile) dichiarato insolvente dal tribunale. Il fondamento normativo è negli artt. 278-281 CCII (Sezione I e I-bis), che disciplinano i presupposti e il procedimento per ottenere l’esdebitazione al termine (o dopo 3 anni dall’inizio) della liquidazione giudiziale. Questa forma è quella tipicamente pensata per gli ex imprenditori commerciali che sono “falliti” e cercano di liberarsi dei debiti residui verso i creditori concorsuali.
- Esdebitazione a seguito di liquidazione controllata del sovraindebitato – Si tratta dell’analogo istituto previsto per i soggetti che non potevano essere assoggettati a fallimento (consumatori, piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilità, professionisti, start-up innovative, ecc.), i quali hanno affrontato una procedura di liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 268 e ss. CCII). Al termine di tale procedura, o decorsi 3 anni dalla sua apertura, il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione alle condizioni stabilite dagli artt. 279-280 e 282 CCII. In pratica, le regole sono molto simili a quelle dell’esdebitazione post-fallimentare, con adattamenti procedurali (ad esempio, l’interlocutore sarà il Gestore della crisi o il Liquidatore nominato anziché il curatore fallimentare, e il giudice competente potrebbe essere lo stesso che ha aperto la procedura di sovraindebitamento, in composizione monocratica o collegiale a seconda dei casi). Questa forma di esdebitazione è rivolta in particolare a consumatori sovraindebitati e piccoli operatori economici che hanno subito la liquidazione dei propri beni.
- Esdebitazione del debitore incapiente – È la grande novità del Codice, prevista dall’art. 283 CCII. Diversamente dalle precedenti, non richiede una previa liquidazione concorsuale: è un procedimento “straordinario” attivabile dal debitore persona fisica sovraindebitato che non ha alcun patrimonio o reddito aggredibile da offrire ai creditori, neanche in prospettiva futura . Se tale debitore risulta meritevole (cioè non ha colpe gravi né ha frodato i creditori) potrà ottenere immediatamente la cancellazione di tutti i debiti concorsuali. Il beneficio è concesso una sola volta nella vita e resta subordinato alla condizione risolutiva che, nei 4 anni successivi, non sopravvengano risorse significative: se entro 4 anni il debitore incapiente riceve utilità che permettano di pagare almeno il 10% dell’ammontare dei debiti, scatta l’obbligo di pagare i creditori entro tale termine . Questa procedura – che potremmo definire di fresh start immediato – è destinata ai casi più gravi in cui nemmeno avviare una liquidazione avrebbe senso, perché i costi supererebbero i ricavi e il debitore è sostanzialmente in uno stato di indigenza.
Oltre a queste tre fattispecie codificate, possiamo menzionare per completezza che esiste anche un’esdebitazione “indiretta” quando il debitore soddisfa i creditori tramite un concordato o un accordo di ristrutturazione omologato. In tal caso, però, più che di esdebitazione ex lege si parla di effetto esdebitatorio dell’adempimento del piano: se il debitore esegue integralmente quanto concordato, i creditori rinunciano ex contractu alla parte di credito eccedente. È un fenomeno distinto dall’esdebitazione disciplinata nel Capo X CCII, che invece opera d’ufficio o su istanza, a valle di una liquidazione concorsuale o in casi speciali. Pertanto, in questa guida il focus rimarrà sulle forme di esdebitazione giudiziale sopra elencate.
Nei paragrafi seguenti, analizzeremo nel dettaglio ciascuna di queste tipologie, con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi, al procedimento da seguire e agli effetti prodotti, evidenziando similitudini e differenze. Tenete presente che molte norme sono comuni (ad esempio, i motivi ostativi all’esdebitazione – reati, dolo, ecc. – valgono sia nel fallimento sia nel sovraindebitamento, in quanto richiamati), per cui vi saranno inevitabili sovrapposizioni nella trattazione.
Tabella riepilogativa – Tipi di esdebitazione nel CCII
| Tipo di procedura | Destinatari (debitori) | Norme CCII | Tempistica | Organi coinvolti | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Imprenditori commerciali fallibili; soci illimitatamente responsabili di società fallite; soggetti equiparati | Art. 278-281 (Sez. I e I-bis) | Richiedibile alla chiusura della procedura oppure dopo 3 anni dall’apertura (se la procedura dura >3 anni) | Tribunale (collegio); Curatore fallimentare | Requisiti di meritevolezza art. 280; creditori avvisati e possibilità di reclamo. |
| Liquidazione controllata (sovraindebitamento) | Consumatori; imprenditori minori (sotto soglie art. 2 lett. d); professionisti; start-up innovative; altri debitori non fallibili | Art. 279-280 (generali) e 282 (Sez. II) | Richiedibile alla chiusura della liquidazione controllata o dopo 3 anni dall’apertura (analogamente alla liqu. giud.) | Tribunale (di regola giudice monocratico); Liquidatore/Gestore nominato | Stesse condizioni di meritevolezza (art. 280); procedura semplificata; creditori informati e facoltà di opposizione post-decreto. |
| Esdebitazione incapiente (fresh start) | Persona fisica sovraindebitata incapiente (nessun bene o reddito utile), non assoggettabile a procedure concorsuali ordinarie (o comunque che non vi ha fatto ricorso) | Art. 283 (Sez. II) | Procedura immediata: domanda ad hoc, decisione del tribunale dopo istruttoria; beneficio concesso subito se requisiti ok. (Periodo di verifica 4 anni post-decreto per eventuali sopravvenienze) | Tribunale in composizione monocratica; Gestore della crisi (OCC) che esamina la situazione e monitora il quadriennio | Una sola volta nella vita ; il debitore deve essere meritevole (assenza frodi/dolo, sovraindebitamento causato da fattori sfortunati). Se entro 4 anni arrivano utilità ≥10% debiti, deve pagare i creditori fino a concorrenza (obbligo di legge) . Creditori possono reclamare in Appello avverso il decreto (ma non partecipano attivamente prima) . |
(Legenda: OCC = Organismo di Composizione della Crisi o Gestore della crisi nominato; “meritevole” = in buona fede, senza colpa grave; sopravvenienze = entrate future impreviste del debitore.)
L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Cominciamo dalla fattispecie più tradizionale: l’esdebitazione ottenibile da un ex imprenditore fallito nell’ambito (o all’esito) di una liquidazione giudiziale. Questa procedura corrisponde al “fallimento” della precedente legge, ossia una procedura concorsuale che coinvolge l’imprenditore commerciale insolvente e il suo patrimonio, affidata a un curatore e supervisionata dal tribunale.
1. Presupposti soggettivi: Può aspirare all’esdebitazione il debitore persona fisica assoggettato a liquidazione giudiziale. Dunque gli imprenditori individuali dichiarati insolventi ne sono i principali destinatari. Inoltre, l’art. 278 CCII – che definisce l’ambito della liberazione dai debiti – consente espressamente l’esdebitazione anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone fallite. In pratica, se una SNC o SAS fallisce insieme ai suoi soci, ciascun socio fallito può chiedere l’esdebitazione per i debiti sociali rimasti a suo carico. Diversamente, le società di capitali in liquidazione giudiziale non beneficiano dell’esdebitazione, non avendo peraltro una “seconda vita” (la società, una volta liquidata e cancellata, cessa di esistere e i debiti residui verso terzi restano inesigibili per assenza del soggetto giuridico). Quindi la sezione I-bis del Capo X CCII – relativa all’esdebitazione nella liquidazione giudiziale – riguarda essenzialmente i debitori persone fisiche.
2. Requisiti di meritevolezza (cause ostative): Il cuore dell’istruttoria per l’esdebitazione sta nella verifica della meritevolezza del debitore. L’art. 280 CCII elenca tassativamente le condizioni che il debitore deve soddisfare per essere ammesso al beneficio. Si tratta, in negativo, di evitare certe condotte colpevoli o illecite. In particolare, il debitore NON deve:
- Aver riportato condanne penali definitive per gravi reati concorsuali o economici. In dettaglio: non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti commessi in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Se è pendente un procedimento penale per tali reati, il tribunale sospenderà la decisione sull’esdebitazione fino all’esito (quindi la terrà “congelata” in attesa di sapere se il debitore verrà condannato o assolto). Questa causa ostativa serve a escludere dal beneficio i soggetti che hanno commesso frodi o gravi illeciti nell’ambito della loro impresa. Una condanna per bancarotta fraudolenta, ad esempio, implica che il fallito ha distratto beni o falsificato le scritture: è intuibile che in tal caso non meriti di essere graziato dei debiti.
- Non aver compiuto atti di grave mala gestio o frode ai danni dei creditori. L’art. 280 lett. b) ne elenca alcuni: il debitore non deve aver distratto o sottratto parte dell’attivo, né esposto passività inesistenti; non deve aver cagionato o aggravato il dissesto con dolo o colpa grave rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; né deve aver fatto ricorso abusivo al credito. Questa disposizione mira a sanzionare i comportamenti scorretti tenuti prima del fallimento: ad esempio occultare beni, falsificare i bilanci per ottenere prestiti (abuso del credito) o aggravare la situazione con operazioni azzardate in malafede. Tali condotte, se accertate, fanno perdere il diritto all’esdebitazione perché denotano indegnità.
- Non aver ostacolato lo svolgimento della procedura fallimentare e aver collaborato con gli organi della stessa. In base alla lett. c), il debitore non deve aver ostacolato o rallentato la procedura e deve aver fornito al curatore e al tribunale tutte le informazioni e i documenti utili per il suo buon andamento. Qui si valuta il comportamento post dichiarazione di liquidazione: il fallito doveva essere diligente e cooperativo (ad esempio, consegnare le scritture contabili, indicare i beni, segnalare i creditori, presentarsi agli interrogatori, etc.). Un fallito latitante o reticente, che abbia reso difficile la liquidazione, viene considerato immeritevole.
- Non aver già beneficiato recentemente di altra esdebitazione. Precisamente, l’art. 280 lett. d) richiede che il debitore non abbia ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per la nuova esdebitazione. In pratica, deve passare un quinquennio tra un’esdebitazione e l’altra. Questa regola evita che una persona faccia fallimenti a ripetizione ravvicinati ottenendo più cancellazioni di debiti in breve tempo (fresh start abuse). Se il soggetto ha già beneficiato di esdebitazione negli ultimi 5 anni, la nuova domanda verrà rigettata.
- Non aver già beneficiato di due esdebitazioni in totale. La lett. e) aggiunge infatti che il debitore non deve aver già usufruito dell’esdebitazione per due volte (in passato). Questo fissa un limite massimo di due esdebitazioni nella vita. Dunque, un terzo fallimento non potrebbe mai essere esdebitato, mentre un secondo è possibile solo se sono trascorsi almeno 5 anni dal primo beneficio (cumulando d) ed e)). La logica è quella di concedere al massimo due “grazie”: oltre sarebbe un uso patologico dell’istituto.
In sintesi, l’art. 280 CCII sintetizza la figura del debitore meritevole: qualcuno che non ha frodato né commesso reati gravi, non ha gestito in modo scellerato l’azienda, non ha intralciato la procedura e non è un recidivo seriale di fallimenti ed esdebitazioni. Tali condizioni sono considerate tassative e vanno interpretate restrittivamente (in sfavore del creditore che volesse ampliarle): come affermato dalla Cassazione, le ipotesi ostative di cui all’art. 142 L.F. (speculari a quelle di art. 280 CCII) sono esaustive, alla luce anche del diritto UE, e non è ammesso al giudice introdurre criteri extra-legali di indegnità . Ciò significa, ad esempio, che il basso pagamento dei creditori non può di per sé impedire l’esdebitazione, se il debitore è in regola coi requisiti. Questo principio del favor debitoris è ormai pacifico: la Corte Suprema ha chiarito che se tutte le condizioni del primo comma (come sopra elencate) sono rispettate, l’esdebitazione deve essere concessa – a meno che i creditori non siano rimasti totalmente a bocca asciutta o soddisfatti in misura davvero simbolica . Nel nuovo CCII, come detto, neppure quest’ultima riserva (della soddisfazione “non irrisoria”) è più codificata, segno di ulteriore apertura.
3. Debiti esclusi dall’esdebitazione: Anche quando concessa, l’esdebitazione non copre tutti i debiti indistintamente. Ci sono specifiche categorie di crediti che restano comunque dovuti dal debitore, per espressa disposizione di legge (art. 278 comma 7 CCII). Tali eccezioni rispondono a ragioni di ordine pubblico e di tutela di bisogni primari o sanzioni. In particolare, restano esclusi dall’esdebitazione: – a) Gli obblighi di mantenimento e alimentari. Ciò comprende le obbligazioni nascenti da rapporti di famiglia, parentela o affinità destinate al sostentamento di qualcuno, ad esempio: assegni di mantenimento a coniuge separato o divorziato, alimenti dovuti ai figli, ai genitori o altri parenti ex art. 433 c.c., etc.. Si tratta di debiti di natura personale e famigliare che il legislatore ritiene intangibili: il fallito (o sovraindebitato) anche dopo l’esdebitazione continua ad esserne obbligato. È giusto infatti che non possa “liberarsi” dei doveri di mantenimento verso i propri figli o familiari bisognosi. – b) I debiti derivanti da risarcimenti di danni causati da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali o amministrative di natura pecuniaria (multe, ammende, contravvenzioni) che non siano accessorie a debiti estinti. In parole semplici, se il debitore aveva l’obbligo di risarcire un danno provocato da un illecito (ad esempio, danni per lesioni colpose in un incidente stradale, oppure per una truffa, o altri fatti illeciti), tale obbligo non viene cancellato dall’esdebitazione: la vittima potrà ancora chiedere quei danni. Parimenti, le multe e ammende penali, o le sanzioni amministrative (es. contravvenzioni stradali, sanzioni tributarie) restano dovute – a meno che fossero accessorie a debiti già estinti nella procedura (ad esempio, una sanzione per tardivo pagamento di un tributo potrebbe decadere se il tributo stesso è stato condonato o annullato). Questa esclusione riflette il principio che non si può cancellare, tramite esdebitazione, né la punizione per un reato/amministrativa, né l’obbligo di riparare un danno ingiusto verso terzi.
Va evidenziato invece che i debiti fiscali e previdenziali NON sono esclusi dall’esdebitazione (salvo rientrino nelle categorie di cui sopra, ad esempio una sanzione tributaria). La legge non menziona affatto i tributi tra i crediti esclusi, e la Corte di Cassazione ha confermato già dal 2014 che “le obbligazioni tributarie non sono escluse dall’esdebitazione”. Dunque, se un imprenditore fallito ha debiti IVA, IRPEF, contributi INPS etc. rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, con l’esdebitazione essi diventano inesigibili verso di lui (ferma restando l’eventuale responsabilità personale di terzi coobbligati, come per esempio un coobbligo del responsabile d’imposta). Ciò è di grande importanza pratica, poiché spesso i debiti fiscali costituiscono una porzione significativa del passivo di un fallimento; il fresh start li include, diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti (negli USA taluni debiti fiscali sono non scaricabili, in Italia invece sì, fatta salva l’ipotesi di sanzioni pecuniarie per violazioni penali/amm.ve come sopra).
Riassumendo, dopo l’esdebitazione il debitore persona fisica resta comunque tenuto a pagare: – gli assegni di mantenimento o alimentari dovuti per legge; – i risarcimenti a seguito di condanne civili per fatti illeciti extracontrattuali (p.es. responsabilità civile per un torto); – le multe penali e amministrative (p.es. sanzioni pecuniarie inflitte con sentenza penale o da autorità amm.ve); mentre tutti gli altri debiti concorsuali (ossia sorti prima dell’apertura della procedura e non soddisfatti in essa) vengono “spenti” dall’esdebitazione.
Da notare che restano altresì obbligati eventuali coobbligati o fideiussori del debitore esdebitato. L’art. 279 CCII (comma 2, se non modificato dai correttivi) riprende quanto già previsto dalla L.F.: l’ammissione al beneficio non libera gli eventuali obbligati in via di regresso o di garanzia. Ad esempio, se Tizio (fallito esdebitato) aveva un debito solidale con Caio, oppure Sempronio era fideiussore per Tizio, l’esdebitazione di Tizio libera Tizio ma non impedisce ai creditori di agire contro Caio o Sempronio per l’intero importo residuo dovuto. Anche questo rientra nella logica che l’esdebitazione è un beneficio personale del debitore e non si estende automaticamente ai terzi garanti.
4. Procedimento per ottenere l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale: Come si concretizza la domanda di esdebitazione? L’art. 281 CCII, come aggiornato dal D.Lgs.136/2024, disciplina il procedimento innanzi al Tribunale. I punti salienti sono:
- Quando e come presentare la domanda: Il debitore può presentare istanza di esdebitazione al tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale, contestualmente alla chiusura della procedura oppure, se la liquidazione dura oltre 3 anni, decorso il terzo anno (anche a procedura pendente). In pratica, ci sono due finestre temporali:
- Chiusura: tradizionalmente, la domanda si depositava in vista dell’udienza di chiusura del fallimento (o entro l’anno successivo alla chiusura, ex art.143 L.F. – regola probabilmente mantenuta). Oggi l’art. 281 comma 1 prevede che il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente al decreto di chiusura dichiara inesigibili i debiti residui, previa verifica dei requisiti. Quindi è opportuno che il fallito faccia istanza prima o in sede di chiusura. Se per caso dimenticasse, è probabile possa ancora chiederla entro un anno dalla chiusura (il CCII rinvia anche a procedure ex art.282… che potrebbero prevederlo; la L.F. lo prevedeva espressamente).
- Dopo 3 anni: novità del CCII, se la liquidazione giudiziale si protrae oltre 3 anni, dopo tre anni dall’apertura il debitore può attivarsi. In tal caso il tribunale provvede analogamente, cioè dichiara l’esdebitazione pur se la procedura non è ancora formalmente chiusa. Il correttivo 2024 ha eliminato la necessità di istanza formale per questa ipotesi (comma 2 non richiede più “su istanza del debitore”), lasciando intendere che potrebbe essere anche disposta d’ufficio. Tuttavia, per prassi, è consigliabile comunque presentare un’istanza decorso il triennio, per sollecitare il tribunale.
In entrambi i casi, l’istanza è un ricorso in cui il debitore espone di possedere i requisiti (assenza di cause ostative) e chiede la dichiarazione di esdebitazione. È soggetta al pagamento di un contributo unificato fisso (attualmente circa €98).
- Istruttoria e ruolo degli organi della procedura: Il tribunale prima di decidere deve sentire il parere degli organi della procedura (tipicamente il Curatore e il Comitato dei creditori, se esistente). Il curatore, in particolare, ha un ruolo chiave: nel rapporto finale riepilogativo egli deve attestare i fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Ciò include segnalare se il debitore ha cooperato, se ha occultato beni, se vi sono state condotte di frode, etc. Inoltre, l’istanza del debitore viene comunicata a cura del curatore a tutti i creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Questa previsione, introdotta dal correttivo 2024, dà voce ai creditori prima della decisione: essi possono far pervenire al tribunale eventuali opposizioni o elementi (ad esempio, un creditore potrebbe segnalare che il debitore ha nascosto qualcosa). Tuttavia – ed è punto importante – la legge consente ai creditori di opporsi solo dopo la concessione del beneficio, tramite reclamo, e non di bloccarlo a priori. Infatti, il comma 4 dell’art. 281 stabilisce che il decreto del tribunale (che concede l’esdebitazione) è comunicato ai creditori non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art.124 CCII. Non è previsto un “giudizio di opposizione” prima della decisione: l’intervento dei creditori è limitato a brevi osservazioni e poi all’eventuale impugnazione. Questo conferma l’impostazione pro-debitore: la valutazione principale la fanno il tribunale e il curatore, senza contenziosi allungati con i creditori (se hanno contestazioni concrete, le faranno valere in sede di reclamo successivo).
- Decisione del Tribunale: Verificati i presupposti (ossia accertata la meritevolezza ex art.280, e decorso il termine temporale ex art.279), il Tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Ciò avviene con decreto motivato emesso in camera di consiglio. Il decreto produce immediatamente l’effetto esdebitatorio: i debiti restanti sono cancellati (salvo i crediti esclusi visti sopra). Il decreto viene poi comunicato al debitore, al curatore, al pubblico ministero e ai creditori. Il provvedimento è pubblicato nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria, in modo che sia conoscibile dai terzi (ciò tutela anche chi in futuro contratterà col debitore, che potrà vedere la sua storia concorsuale, benché conclusa positivamente).
- Reclamo/appello: Entro 30 giorni dalla comunicazione, il decreto di esdebitazione può essere impugnato con reclamo alla Corte d’Appello competente. La legittimazione attiva ce l’hanno i creditori pregiudicati (integralmente o parzialmente insoddisfatti) nonché il Pubblico Ministero. Il debitore, ovviamente, non ha interesse a reclamare un decreto che gli concede il beneficio; potrebbe però reclamare nell’ipotesi rara di rigetto dell’istanza. In ogni caso, il reclamo si propone ex art.124 CCII, che disciplina i reclami contro i decreti del tribunale nelle procedure concorsuali (è un reclamo davanti alla Corte d’Appello, che decide in forma collegiale). Durante l’eventuale reclamo, il provvedimento non viene sospeso, salvo diversa decisione del giudice di appello: quindi il debitore, in assenza di sospensione, può già considerarsi esdebitato, fermo restando che un esito sfavorevole in appello potrebbe revocare il beneficio.
- Effetti sulle attività non completate: Un elemento peculiare del CCII: l’art. 281 commi 5 e 6 regolano il caso in cui, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (magari anticipata per concedere l’esdebitazione al 3° anno), restino ancora giudizi pendenti o operazioni liquidatorie da completare (ad es. cause risarcitorie in corso, beni non ancora venduti, ecc.). La legge chiarisce che l’esdebitazione non interrompe tali attività: il curatore (o chi per esso) le porterà a termine anche dopo la chiusura formale e, se da esse derivano ulteriori recuperi, verrà fatto un riparto supplementare ai creditori. In tal caso, l’esdebitazione varrà solo per la parte di debito che rimane definitivamente insoddisfatta dopo anche questi riparti successivi. Esempio: il fallimento si chiude ed il debitore ottiene l’esdebitazione al 3° anno, ma era pendente un giudizio contro un ex amministratore per responsabilità, che l’anno dopo si conclude con un risarcimento. Il curatore incassa e ripartisce magari un ulteriore 5% ai creditori. L’esdebitazione di fatto coprirà solo il restante (95%), mentre quel 5% in più il debitore non doveva comunque pagarlo di suo (essendo frutto della procedura). Questo meccanismo tutela i creditori: evita che il debitore tragga vantaggio dall’esdebitazione nel caso in cui, post-chiusura, emergano attivi, e nello stesso tempo non tocca il debitore (che tanto quei soldi non provenivano da lui ma dal patrimonio già acquisito alla massa).
5. Concessione o diniego del beneficio: Se il tribunale dichiara l’esdebitazione, il debitore ottiene immediatamente i suoi effetti (liberazione dai debiti). Se invece il tribunale rigetta l’istanza (perché ha riscontrato una causa ostativa, ad esempio una bancarotta o un comportamento doloso), il debitore non potrà ripresentarla a breve. In genere, la decisione negativa preclude nuove istanze salvo mutamenti di circostanze. Ad esempio, se il rigetto era dovuto a pendenza di un processo penale, il debitore potrà riprovare dopo l’esito assolutorio di quel processo (che rimuove la causa ostativa). Oppure, se era dovuto al fatto che i creditori erano rimasti totalmente insoddisfatti e il giudice l’ha considerato motivo ostativo (cosa che, come detto, nel CCII puro non dovrebbe più avvenire, ma in casi transitori potrebbe), allora se successivamente appare un attivo e i creditori vengono soddisfatti un minimo, il debitore potrebbe chiedere la revoca del precedente diniego e la concessione del beneficio. In linea di massima, però, le decisioni di diniego tendono a essere definitive sul punto.
6. Esempio pratico: Mario è un imprenditore individuale dichiarato insolvente nel 2023. La sua liquidazione giudiziale è iniziata a ottobre 2023. Il passivo accertato è €500.000, l’attivo realizzato è €200.000, per cui i creditori riceveranno circa il 40%. Mario ha collaborato attivamente con il curatore, non ha precedenti penali, e la crisi dell’azienda è dovuta al calo di mercato (nessuna frode). La procedura dura due anni e si chiude nel settembre 2025 con il riparto finale del 40%. Contestualmente, Mario presenta l’istanza di esdebitazione. Il tribunale verifica che Mario è meritevole (nessuna condotta ex art.280 a, b, c violata, nessuna precedente esdebitazione) e, nel decreto di chiusura, dichiara inesigibili i debiti residui (€300.000, cioè il 60% non pagato). I creditori insoddisfatti vengono avvisati; uno di essi, inizialmente riluttante, valuta che non ci sono motivi per opporsi (Mario è stato corretto), quindi non fa reclamo. Mario così, grazie all’esdebitazione, è libero dai suoi debiti: non dovrà pagare quel 60% residuo in futuro. Restano però esclusi gli alimenti dovuti alla ex moglie per i figli (quelli Mario dovrà continuarli a versare). Dopo un anno dalla chiusura, tuttavia, il curatore incassa un ulteriore credito da un giudizio pendente e distribuisce un altro 5% ai creditori. L’esdebitazione di Mario coprirà i debiti residui rimanenti (55%), mentre quel 5% in più – che i creditori hanno intascato – ovviamente non è più dovuto da Mario (era già stato pagato dal curatore). Mario a questo punto può riprendere la sua attività imprenditoriale o lavorare altrove senza timore che i vecchi creditori (banche, fornitori, fisco, ecc.) gli pignorino stipendio o beni: essi non possono più agire contro di lui per quei debiti pregressi.
L’esdebitazione nelle procedure di sovraindebitamento (liquidazione controllata)
Passiamo ora all’esdebitazione del sovraindebitato, ossia il caso in cui il debitore persona fisica abbia affrontato una procedura di liquidazione controllata prevista per i soggetti non fallibili (Capo IX, artt.268-277 CCII). Molti concetti ricalcano quanto già visto per la liquidazione giudiziale, con alcune differenze dovute al diverso contesto.
Chi rientra in questa categoria? Debitori civili o commerciali che non superano i limiti di fallibilità o sono esclusi per legge dal fallimento. Ad esempio, un imprenditore commerciale sotto le soglie di art. 2 lett. d) CCII (ricavi sotto €200k, debiti sotto €500k, ecc.), un professionista (avvocato, medico), un imprenditore agricolo, una start-up innovativa, oppure un semplice consumatore sovraindebitato (persona che ha debiti personali per prestiti, bollette, ecc. non pagabili). Per costoro, in caso di insolvenza, la via è la liquidazione controllata del sovraindebitato – che in sostanza è la liquidazione di tutto il patrimonio sotto il controllo del tribunale e con l’ausilio di un Gestore della crisi (OCC) o di un Liquidatore nominato. Al termine, essi possono chiedere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti.
Requisiti e presupposti: Il CCII rende applicabili ai sovraindebitati praticamente gli stessi requisiti di meritevolezza visti per il fallito. Infatti, l’art. 282 (Condizioni e procedimento di esdebitazione nella liquidazione controllata) richiama espressamente le “condizioni di cui all’art. 280 CCII” anche per il sovraindebitato. Ciò significa che il debitore sovraindebitato deve non aver commesso atti in frode, non aver aggravato dolosamente l’insolvenza, aver collaborato, ecc., esattamente come definito in art. 280. Inoltre, deve essere meritevole secondo la nozione specifica per i consumatori. Su quest’ultimo punto, il CCII distingue tra debitore consumatore e debitore imprenditore/professionista: “l’istituto non si rivolge al solo consumatore… con ogni conseguenza in merito al differente contenuto del giudizio di meritevolezza nei singoli casi”. Ciò implica che il giudice terrà conto, nel valutare la meritevolezza: – per un consumatore, se l’indebitamento è dovuto a spese imprudenti, ricorso sconsiderato al credito al consumo, ecc., questo potrebbe incidere sulla meritevolezza (ricordiamo che “ricorso abusivo al credito” è motivo ostativo generale); – per un piccolo imprenditore sovraindebitato, si guarderà a condotte simili a quelle di un fallito (es. se ha tenuto le scritture, se ha nascosto beni o no, ecc.); – in ogni caso bisogna escludere atti in frode (es. pagamenti preferenziali fraudolenti, sottrazioni di beni prima di attivare la procedura, ecc.).
La giurisprudenza ha sottolineato che anche nel sovraindebitamento la valutazione di meritevolezza deve essere tassativa e ispirata al favor recuperatorio. Ad esempio, non si può negare l’esdebitazione solo perché i creditori chirografari hanno ricevuto pochissimo, se il debitore ha fatto tutto il possibile e non ha colpe. D’altro canto, uno sovraindebitamento colposo, originato da spese palesemente sproporzionate al reddito, potrebbe configurare abuso del credito (specie per un consumatore) e dunque far decadere dal beneficio. È tutto oggetto di prudente apprezzamento del giudice, ma guidato dai parametri di legge.
Tempistica: Anche per la liquidazione controllata vale la regola del triennio. L’art. 279 CCII (Disposizioni generali) non fa distinzioni: il diritto all’esdebitazione matura decorsi 3 anni dall’apertura della procedura di liquidazione (giudiziale o controllata), salvo chiusura anticipata. Inoltre, il correttivo 2024 ha esplicitato che esiste una Sezione II dedicata all’esdebitazione nella liquidazione controllata, a sottolineare peculiarità procedurali, ma i termini temporali restano identici: chiusa la procedura (spesso più breve del fallimento, data la dimensione minore) o trascorsi 3 anni, il debitore può chiedere l’esdebitazione.
Procedura pratica: L’art. 282 CCII regola in dettaglio come il debitore sovraindebitato ottiene l’esdebitazione. Pur non avendo qui il testo integrale, sappiamo dal rinvio del Tribunale di Pordenone che: – Art. 281 CCII tratta il procedimento nella liquidazione giudiziale. – Art. 282 CCII tratta le condizioni e il procedimento di esdebitazione nella liquidazione controllata.
In sostanza: – Istanza al giudice: Il debitore persona fisica sovraindebitato, conclusa la liquidazione controllata dei suoi beni (o dopo 3 anni dall’apertura se più lungo), presenta istanza di esdebitazione al Tribunale che ha seguito la procedura. Nel sovraindebitamento, di regola le procedure sono decise da un giudice monocratico (un singolo giudice) della sezione fallimentare . Infatti, la L.3/2012 prevedeva competenza del tribunale in composizione monocratica. Il CCII inizialmente era ambiguo (poiché le procedure concorsuali maggiori sono collegiali). La giurisprudenza (Trib. Pordenone 21/4/2023) ha chiarito che l’esdebitazione dell’incapiente la decide un giudice monocratico ; per analogia, anche l’esdebitazione nella liq. controllata dovrebbe essere decisa dal giudice delegato o comunque da un giudice unico, essendo parte di una procedura minore. Il correttivo ter ha mantenuto la distinzione: fallimento e liqu. controllata si svolgono davanti al tribunale in composizione collegiale solo se concorsuali ex art.40 CCII, ma l’esdebitazione incapiente è affidata a giudice singolo . In attesa di un chiarimento normativo, molti tribunali trattano l’esdebitazione sovraindebitati con giudice singolo.
- Ruolo del Liquidatore/Gestore: Nella liquidazione controllata viene nominato un Liquidatore o un Gestore della crisi (se la liquidazione deriva dalla conversione di un piano o accordo, può essere lo stesso OCC). Questi svolge funzioni analoghe al curatore: raccoglie l’attivo, vende i beni, predispone un progetto di riparto. Al termine, redige una relazione finale. E proprio come il curatore, anche il liquidatore/OCC deve attestare se il debitore ha cooperato, se sono emersi atti in frode, e così via. L’art. 282 presumibilmente impone al liquidatore di allegare alla fine una relazione sui requisiti di esdebitazione, e di notificare l’istanza del debitore ai creditori.
- Coinvolgimento dei creditori: Similmente al fallimento, i creditori ammessi al passivo della liquidazione controllata (ossia quelli che hanno presentato domanda e sono stati verificati) saranno informati della richiesta di esdebitazione e potranno fare osservazioni o eventualmente reclamo successivamente. Nel sovraindebitamento la platea di creditori può essere anche molto frammentata (basti pensare a debiti condominiali, bollette, ecc.), ma di solito c’è un numero più ridotto di attori in liquidazione (spesso banche, Agenzia Entrate Riscossione e pochi altri). In ogni caso, la legge (art.282) dovrebbe prevedere un meccanismo analogo di comunicazione ai creditori dell’istanza e facoltà di opposizione. Ad esempio, il Protocollo del Tribunale di Torino indica che in caso di esdebitazione in sovraindebitamento i creditori vanno avvisati e possono dedurre eventuali obiezioni in un termine breve.
- Decisione del giudice: Il tribunale (o giudice delegato) verifica le condizioni (anche qui assenza delle cause di art.280). Se tutto a posto, dichiara l’esdebitazione dei debiti residui con decreto. Questo decreto va comunicato al debitore e ai creditori, ed è reclamabile in Corte d’Appello, analogamente a prima.
- Effetti: L’effetto è identico: i debiti concorsuali (ossia quelli anteriori all’apertura della liquidazione controllata) diventano inesigibili verso il debitore. Anche qui restano esclusi i medesimi debiti: alimenti, danni da illecito, multe. Ad esempio, se un consumatore sovraindebitato aveva €50.000 di debiti di carte di credito e prestiti personali, e magari €5.000 di multe stradali arretrate, l’esdebitazione lo libera dei €50.000 ma non delle multe (che dovrà comunque pagare, salvo le abbia incluse e pagate parzialmente nella procedura). I coobbligati restano obbligati allo stesso modo.
Esempio pratico: Chiara è una consumatrice sovraindebitata di 40 anni, con debiti totali di €100.000 (mutuo residuo su casa pignorata, prestiti al consumo, bollette non pagate). Non è fallibile, perciò nel 2023 ha avviato una liquidazione controllata. Tutti i suoi beni (in sostanza la casa, poi venduta all’asta) sono stati liquidati, ricavando €60.000 netti per i creditori (che quindi hanno avuto circa il 60% di soddisfazione). Chiusa la procedura nel 2025, residuano €40.000 di debiti non pagati. Chiara, che è sempre stata cooperativa e non ha determinato il suo indebitamento con dolo (ha perso il lavoro e contratto debiti per vivere, senza lussi eccessivi), presenta istanza di esdebitazione. Il tribunale verifica che non ricorre nessuna causa ostativa: Chiara non ha atti in frode, nessun reato, nessun abuso di credito deliberato. Dunque con decreto dichiara inesigibili i €40.000 rimasti. I creditori (in gran parte banche) non fanno reclamo, poiché la debittrice è stata trasparente e parte del debito l’hanno recuperata. Da questo momento, Chiara è libera dai debiti passati: potrà ricostruirsi un profilo finanziario pulito (sia pure con l’ovvia segnalazione nei sistemi creditizi che ha avuto un’insolvenza pregressa, ma legalmente quei debiti sono estinti). Se in futuro dovesse ripresentarsi un sovraindebitamento, Chiara potrebbe ancora una volta (una seconda e ultima volta) accedere a procedura ed esdebitazione, ma non prima di 5 anni. Nel frattempo, per quei debiti chiusi, i creditori non potranno più chiederle nulla.
Si noti che se Chiara avesse avuto dei soci illimitatamente responsabili (ad esempio fosse socio di S.n.c. sovraindebitata), anche per loro varrebbero regole simili, ma tecnicamente se la società non era fallibile, i soci potevano confluire in un’unica procedura familiare. Il CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica procedura di sovraindebitamento familiare. In tal caso, l’esdebitazione riguarderebbe tutti i membri con un unico provvedimento, suddividendo responsabilità a seconda dei debiti.
Durata: Le procedure di liquidazione controllata spesso hanno durata inferiore al fallimento, data la minore complessità. Potrebbero concludersi anche in 1-2 anni se pochi beni. Se però dovessero protrarsi oltre 3 anni (caso raro), il debitore ha comunque diritto a chiedere l’esdebitazione provvisoria decorsi 3 anni dall’apertura, come per la liquidazione giudiziale. Il tribunale, in tal scenario, emanerebbe un decreto parziale di esdebitazione e la procedura potrebbe chiudersi subito o continuare per strascichi (eventualmente convertendosi in chiusura anticipata come in fallimento).
Coordinamento con altri strumenti: Un debitore sovraindebitato potrebbe aver tentato prima un piano del consumatore o un accordo di composizione, magari non riusciti o risolti. Il CCII consente, dopo la risoluzione di un piano o accordo, di passare alla liquidazione controllata (art. 268). In tal caso, l’esdebitazione è accessibile al termine della liquidazione. La legge, come modificata nel 2024, ha eliminato l’ostacolo che impediva l’accesso al beneficio a chi avesse già fruito di procedure nei 5 anni precedenti. Questo vuol dire: se Tizio tentò un piano del consumatore 3 anni fa (senza esdebitazione perché magari ha pagato e poi il piano è decaduto), oggi può comunque avviare liquidazione e poi esdebitarsi – non è un motivo di esclusione. Conta solo se ha già ottenuto un’esdebitazione in passato (il beneficio stesso, non la semplice procedura).
In conclusione, l’esdebitazione post-liquidazione controllata rappresenta per il debitore non fallibile l’analogo “perdono dei debiti” previsto per il fallito: medesimi vantaggi (cancellazione dei debiti chirografari residui) e stessi oneri di condotta virtuosa durante la procedura. Si applicano le stesse esclusioni (alimenti, risarcimenti, multe) e le stesse limitazioni di frequenza (una volta ogni 5 anni, massimo due volte vita natural durante). L’effetto economico e sociale è importante: molti privati soffocati dai debiti possono tornare solvibili e produttivi, reinserendosi nell’economia legale senza l’incubo perenne dei creditori.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Veniamo ora all’esdebitazione del debitore incapiente, istituto introdotto dall’art. 283 CCII, spesso definito anche esdebitazione a costo zero. Siamo di fronte a un meccanismo del tutto nuovo per l’ordinamento italiano, pensato per chi si trova in uno stato di sovraindebitamento così grave da non avere alcuna risorsa da liquidare. In passato, soggetti in tali condizioni restavano intrappolati nei debiti perché non potevano nemmeno accedere utilmente a una procedura concorsuale (la quale sarebbe stata dichiarata improcedibile per insufficienza di attivo). Il legislatore, ispirandosi a modelli stranieri e incoraggiato dalla normativa UE sul fresh start, ha previsto che anche il debitore totalmente privo di beni possa, in via eccezionale, ottenere la liberazione dai debiti.
Vediamo i punti chiave di questa procedura speciale:
1. Definizione di “debitore incapiente”: Per la legge (art.283 comma 1 CCII) è incapiente il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura . Dunque i requisiti oggettivi sono: – assenza di utilità attuale: il debitore non possiede beni liquidabili (case, auto di valore, risparmi, crediti esigibili, ecc.) né ha redditi disponibili da destinare ai creditori; – assenza di utilità futura prevedibile: non ci sono prospettive concrete di guadagni futuri significativi con cui potrebbe soddisfare i creditori. Ciò non vuol dire che dovrà restare povero per sempre, ma al momento della domanda il giudice valuta che, date le circostanze (età, salute, mercato del lavoro), non c’è all’orizzonte alcun flusso rilevante di reddito oltre il minimo per vivere dignitosamente; – persona fisica meritevole: ciò richiama i soliti criteri di meritevolezza (assenza di dolo, colpa grave, frodi). Va sottolineato che l’art. 283 non richiama espressamente l’art. 280, ma i giudici già hanno colmato: l’incapiente dev’essere meritevole allo stesso modo degli altri debitori. In più, considerato che qui siamo nell’ambito del sovraindebitamento, il debitore incapiente deve non essere soggetto a liquidazione giudiziale (quindi non fallibile) né a liquidazione coatta o altre procedure, e non deve aver già usato questa procedura in passato.
In pratica, il profilo tipico è quello di una persona fisica nullatenente, magari disoccupata o con redditi modestissimi, sovraindebitata (spesso debiti di origine bancaria, bollette insolute, scoperti di conto, ecc.), che ha però mantenuto un comportamento onesto e trasparente. Purtroppo non possiede nulla da offrire ai creditori: neanche a far partire una liquidazione controllata, essa sarebbe inutile (non pagherebbe nemmeno le spese di procedura). In passato tali persone restavano bersaglio potenziale di azioni esecutive per decenni, pur essendo “incappabili” (c.d. casi di “poveri con debiti”). Con la nuova norma, invece, possono aspirare a un colpo di spugna sui debiti e a ripartire.
2. Una procedura residuale ed eccezionale: L’esdebitazione incapiente è definita dai giudici uno strumento “residuale ed eccezionale”. Residuale perché vi si accede solo se non vi sono altre soluzioni concorsuali possibili. In effetti la legge richiede che il debitore incapiente non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale o coatta e che non abbia utilità per una liquidazione controllata. Questo implica, ad esempio, che se il debitore possiede anche un piccolo attivo realizzabile (poniamo €5.000 di risparmi, o un’auto usata), allora non è propriamente “incapiente”: in tal caso dovrebbe piuttosto avviare una liquidazione controllata e poi chiedere l’esdebitazione ordinaria. La procedura a costo zero è riservata a chi proprio non può offrire nulla, nemmeno vendendo tutto. È l’ultima spiaggia per chi altrimenti rimarrebbe prigioniero dei debiti.
3. Condizioni soggettive di meritevolezza: Anche qui la meritevolezza è imprescindibile. L’art. 283 comma 1 richiede persona fisica meritevole, e il giudice valuta: – l’assenza di atti in frode ai creditori (es. donazioni fatte per risultare nullatenente: se emergono, niente beneficio); – che il sovraindebitamento e l’incapienza non siano addebitabili a dolo o colpa grave del richiedente. Significa che se uno è incapiente “per colpa sua” – p.es. perché ha dilapidato volontariamente il patrimonio per non pagare i creditori, o ha fatto spese pazze incurante delle obbligazioni – allora non merita. Viceversa, se l’incapienza deriva da circostanze sfortunate o errori scusabili (disoccupazione, malattia, crisi economica generale, ecc.), allora la meritevolezza c’è. Nel decreto del Trib. Oristano 2024, ad esempio, la debitrice incapiente aveva accumulato debiti per riduzione ore di lavoro, motivi di salute, pandemia e finanziamenti per far fronte: tutti elementi non imputabili a sua malafede . Di converso, se un soggetto fosse incapiente perché ha sperperato al gioco d’azzardo o condotto un tenore di vita volutamente superiore alle sue possibilità contando di non pagare, difficilmente passerebbe il vaglio del giudice (sarebbe mala fede).
- inoltre, il debitore non deve aver mai beneficiato prima di questa esdebitazione incapiente (è one-shot: una sola volta nella vita) né aver già fruito di esdebitazioni di altro tipo negli ultimi 5 anni o due volte in totale (presumibilmente valgono pure per lui le regole generali di art.280 d)-e)). Su quest’ultimo punto, la legge 176/2020 originaria limitava l’accesso all’incapiente a chi non avesse mai fatto procedure di sovraindebitamento. Il CCII ha rimosso la preclusione di aver usato procedure 5 anni prima, ma se hai ottenuto già un’esdebitazione ordinaria, è logico non concedere poi anche quella incapiente come scorciatoia successiva.
4. Procedimento per l’incapiente: Questa procedura non è collegata a una liquidazione di beni, ma è un procedimento autonomo in tribunale. Si svolge a grandi linee così: – Il debitore incapiente deposita un ricorso ex art.283 CCII presso il Tribunale del luogo di residenza. In molti casi ci si avvale di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un professionista gestore della crisi. Infatti, per presentare la domanda, occorre fornire la documentazione completa della propria situazione economica e patrimoniale, l’elenco di tutti i creditori e dei debiti, e una relazione che attesti l’incapienza e la meritevolezza. Spesso viene nominato un Gestore della crisi sin dall’inizio, che aiuta a redigere la relazione e poi supervisiona il periodo successivo. – Il tribunale (di solito in composizione monocratica, come da pronuncia di Pordenone ) esamina il ricorso. Può fissare un’udienza in camera di consiglio dove convocare il debitore e magari ascoltare eventuali creditori (anche se formalmente i creditori non partecipano attivamente in questa fase, essendo una procedura non concorsuale in senso stretto – manca la par condicio perché non c’è nulla da distribuire). – Verifica dei presupposti: Il giudice controlla: – la completezza e veridicità dei documenti (se il debitore ha prodotto tutto e non ha occultato informazioni); – che il debitore sia effettivamente non assoggettabile ad altre procedure (es: non è un imprenditore fallibile, o se lo era la procedura è già chiusa senza attivo; non ci sono fra i suoi debiti obbligazioni che richiederebbero una liquidazione coatta, ecc.); – che il debitore abbia almeno tentato di trovare un accordo con i creditori. La legge infatti richiede che l’incapiente, prima di accedere al beneficio gratuito, abbia utilizzato le risorse del fondo di solidarietà previsto dall’art. 14-quinquiesdecies L.3/2012 (ora abrogato) oppure che non abbia in concreto avuto accesso ad alcuna risorsa. In pratica, se esiste un Fondo statale per sovraindebitati incapienti (come ipotizzato dalla legge delega ma non realmente istituito con dotazione finanziaria sufficiente), il debitore dovrebbe provare a usarlo. Non entrando troppo nel dettaglio, diciamo che attualmente questo aspetto è di scarsa applicazione pratica, mancando fondi pubblici. – che il debitore sia meritevole: qui gioca molto la relazione del Gestore (OCC) nominato. Nel caso di Oristano, ad esempio, il Gestore ha attestato che la richiedente aveva fornito tutta la documentazione, non aveva atti in frode, e le cause dell’indebitamento non erano imputabili a dolo o colpa grave. Il giudice ha potuto acclarare la meritevolezza su queste basi. – definizione della soglia di incapienza: un elemento delicato è stabilire se davvero il debitore non può offrire nessuna utilità. Ci si chiede: se potesse pagare anche solo il 2-3%, sarebbe incapiente o no? La dottrina suggerisce che l’incapienza debba essere quasi assoluta. Alcuni tribunali iniziano a individuare criteri: ad esempio, il Caso.it riferisce di prime letture sul “limite al di sotto del quale il debitore è considerato incapiente”. Forse la prassi individuerà percentuali minime. Per ora, il parametro normativo è 10%: se il debitore potesse pagare almeno il 10%, dovrebbe farlo (lo vedremo tra poco, perché il 10% appare come soglia per le sopravvenienze). Quindi possiamo dedurre che se oggi il debitore ha risorse >0 ma <10%, potrebbe comunque essere trattato come incapiente? In realtà no: se ha risorse >0, quelle vanno comunque date ai creditori invece di chiedere l’esdebitazione a costo zero. Dunque, diremmo che deve essere 0 disponibile al momento.
- Decisione del tribunale: Se il tribunale ritiene soddisfatti tutti i requisiti, emette decreto di accoglimento dell’istanza ex art. 283 CCII. Con tale decreto:
- Concede il beneficio dell’esdebitazione incapiente al richiedente, dichiarando inesigibili tutti i debiti di costui verso i creditori concorsuali indicati (salvo le esclusioni di legge: alimenti, risarcimenti, multe, che rimangono comunque esclusi anche qui).
- Impartisce le prescrizioni per il quadriennio successivo: in particolare ricorda al debitore l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni se sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% . Questa è la condizione risolutiva. Significa che da qui a 4 anni, il debitore deve tenere monitorato la sua situazione: se, ad esempio, eredita una somma, oppure trova un lavoro molto redditizio, o vince alla lotteria, e insomma ottiene soldi a sufficienza che – se fossero stati disponibili al tempo – avrebbero permesso di pagare almeno il 10% di ogni credito, allora egli dovrà utilizzarli per pagare i creditori (fino all’importo del debito originario). In pratica la legge “cancella” i debiti ma con un pegno virtuale di durata 4 anni su eventuali nuove fortune del debitore, a tutela minima dei creditori. La soglia del 10% serve a non riaprire la questione per entrate modeste: solo se la botta di fortuna è cospicua (10% è comunque non altissima: p.es. se aveva €100.000 di debiti, un’entrata di €10.000 attiverebbe l’obbligo) dovrà ripagare.
- Nomina un “Gestore della crisi” per la vigilanza quadriennale? La norma prevede che il Gestore della crisi (ossia l’OCC coinvolto) effettui controlli nel periodo di vigilanza. Quindi probabilmente il decreto incarica formalmente l’OCC di vigilare sui redditi del debitore per i prossimi 4 anni. Il debitore dovrà periodicamente comunicare eventuali miglioramenti reddituali. Se arrivano utilità rilevanti, il Gestore redige un piano di riparto di quel 10% (o più) e convoca i creditori per farglielo avere. In caso di inadempimento, i creditori potrebbero allora rivolgersi al giudice per far revocare l’esdebitazione o comunque per ottenere un titolo.
- Comunica il decreto ai creditori: Come visto, i creditori non concorrono attivamente all’inizio, ma dopo la concessione vengono informati. Il decreto è comunicato a tutti i creditori inclusi e pubblicato. A questo punto i creditori possono proporre reclamo alla Corte d’Appello se ritengono che non vi fossero i presupposti (ad es. scoprono che il debitore aveva nascosto qualcosa, o contestano la meritevolezza). Il reclamo qui è particolare: la legge stabilisce che anche il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza, oppure che revoca l’esdebitazione dopo averla comunicata ai creditori, è reclamabile avanti la Corte d’Appello ma non davanti al tribunale collegiale . Ciò conferma che sin dall’inizio la competenza è monocratica, con reclamo in appello.
- Effetti immediati: Con il decreto, tutti i debiti del debitore incapiente anteriori si considerano non più esigibili. Il debitore esdebitato incapiente potrà quindi opporre ai creditori il provvedimento come motivo di cessazione delle pretese. Se c’erano pignoramenti o altre esecuzioni in corso, perdono efficacia per mancanza del diritto sottostante (anche se di fatto un incapiente difficilmente aveva pignoramenti, dato che non aveva beni da aggredire). Comunque, l’esdebitazione produce un effetto esdebitatorio integrale immediato, mitigato solo dalla condizione risolutiva dei 4 anni.
- Quadriennio di sorveglianza: Nei 4 anni successivi, il debitore deve condurre la propria vita economica in trasparenza. Se acquisisce redditi, ha diritto a mantenere per sé quanto necessario a una vita dignitosa, e solo l’eccedenza “percepibile” oltre il bisogno dovrà essere destinata ai creditori. La ratio è infatti quella di incentivare il debitore a tornare produttivo, senza però arricchirsi a scapito dei creditori subito dopo aver ottenuto il condono. C’è un delicato equilibrio: l’integrale sacrificio dei creditori è giustificato dalla comprovata attuale incapienza e serve a dare alla persona un tenore di vita sereno e dignitoso, ma se nei 4 anni l’equilibrio cambia e la persona ottiene molto più del necessario, allora una parte va restituita ai creditori. Passati i 4 anni, qualunque cosa accada il debitore è definitivamente libero.
Esempio pratico: Paolo ha 50 anni, disoccupato, vive in affitto e possiede solo beni di modesto valore (mobilio, auto vecchia). Ha accumulato €80.000 di debiti (soprattutto carte di credito e prestiti) quando lavorava, ma poi ha perso il lavoro e non ha più potuto pagare nulla. Attualmente il suo unico reddito è una piccola indennità di disoccupazione di €700 mensili. Non è fallibile (era un impiegato privato, i debiti sono da consumatore). Ha provato a trattare con le finanziarie ma senza esito, e non può proporre un piano perché non ha somme da offrire. Paolo si rivolge a un OCC e istruisce una domanda di esdebitazione da incapiente. Dichiara tutti i suoi debiti e dimostra di essere nullatenente. Dichiara anche di non aver mai fatto altre procedure di insolvenza. L’OCC verifica che Paolo non ha compiuto atti in frode (non ha alienato beni, semplicemente viveva in affitto e ha perso il lavoro) e che l’indebitamento è dovuto a cause a lui non imputabili in dolo (è stato un consumo eccessivo? Emergerà che col suo stipendio prima ce la faceva, poi è subentrata la disoccupazione, quindi non c’è malizia, al limite un po’ di imprudenza comune). Il tribunale esamina e nel 2025 accoglie la richiesta: dichiara inesigibili verso Paolo gli €80.000 di debiti verso tutti i creditori indicati. Nomina l’OCC come gestore per i prossimi 4 anni. Paolo esce dal tribunale senza più debiti: le società finanziarie non potranno più chiedergli nulla (sono state avvisate del decreto). Per i 4 anni successivi, Paolo dovrà informare l’OCC se trova un lavoro. Supponiamo che dopo 2 anni Paolo riesca a trovare un impiego stabile con stipendio di €1.500 al mese. Questa entrata è superiore a prima, ma comunque modesta: probabilmente il giudice riterrà che per un single €1.500 sia giusto per vivere dignitosamente, e non attiverà nessun obbligo perché non c’è una “utilità rilevante” superiore alle necessità. Dopo altri 2 anni (quindi allo scadere del quadriennio), Paolo non avrà dovuto pagare nulla ai creditori, e l’esdebitazione diverrà definitiva. I suoi debiti resteranno estinti per sempre. Scenario alternativo: se Paolo, poniamo, a un certo punto riceve un’eredità di €20.000 (utilità rilevante perché €20k su €80k è il 25%, >10%), allora scatta l’obbligo. L’OCC predisporrà un piano: di quei €20.000, dedotte magari le spese, li dovrà ripartire tra i creditori proporzionalmente. Dopo aver versato ciò (circa il 25% a ciascun creditore, quindi €20k totali), Paolo non dovrà più nulla sugli eventuali €60.000 residui e l’esdebitazione proseguirà comunque (ha semplicemente ridato ai creditori parte di quanto condonato, perché la sua situazione è migliorata oltre la soglia). Se Paolo cercasse di nascondere quell’eredità e fosse scoperto, rischierebbe la revoca dell’esdebitazione per comportamento fraudolento.
Importante: L’esdebitazione incapiente è davvero un’extrema ratio. I tribunali stanno verificando con rigore le domande. Ci sono stati provvedimenti di accoglimento (come Oristano 2024, Pordenone 2023 per competenza, Crotone 2022) ma anche casi di rigetto dove si è intravisto abuso. Ad esempio, se l’incapiente ha anche solo un piccolo immobile, l’istanza non passa: va venduto quell’immobile tramite liquidazione controllata piuttosto. Se ha un reddito stabile, anche basso, spesso è preferibile che proponga un piano del consumatore con falcidia, piuttosto che chiedere la cancellazione integrale gratis.
La visione d’insieme: Questa procedura incarna un vero cambio di filosofia rispetto al passato: “Si parte dall’esdebitazione per pervenire potenzialmente al recupero di risorse”, anziché il contrario. Negli istituti concorsuali classici prima si liquidano i beni (o si fa un accordo) e poi, eventualmente, si concede la liberazione. Qui invece la liberazione è ex ante, basata sulla constatata assenza di risorse, e solo in seguito – se ne arrivano – i creditori potrebbero beneficiarne. È un rovesciamento degli scopi ordinari delle procedure concorsuali, dove normalmente prima viene la tutela del ceto creditorio (par condicio) e poi l’eventuale fresh start. Nell’esdebitazione incapiente, manca del tutto la dimensione concorsuale di ripartizione (non c’è nulla da ripartire subito) e l’unico scopo è dare al debitore sfortunato la possibilità di rifarsi una vita produttiva. Il contrappeso è l’impegno morale e giuridico del debitore a condividere con i creditori eventuali sopravvenienze significative in un lasso di tempo ragionevole (4 anni). Trascorso quello, i creditori vengono definitivamente sacrificati sull’altare del second chance.
In sintesi, l’esdebitazione dell’incapiente: – Pro: offre una via d’uscita ai casi umanamente ed economicamente più difficili, evitando “poveri indebitati a vita”; incentiva il debitore a tornare a produrre reddito senza timore di vederselo subito tolto (c’è uno scudo fino a un livello dignitoso di vita); allinea l’Italia a modelli internazionali più indulgenti verso l’insolvenza personale. – Contro: comprensibilmente meno gradita ai creditori, che vedono un condono integrale dei loro crediti senza nemmeno la procedura di concorso; presenta qualche rischio di abuso (anche se mitigato dalle rigorose condizioni di accesso e dalla revocabilità se c’è frode). – Limiti d’uso: non applicabile a soggetti fallibili; non ripetibile; richiede il vaglio attento di un OCC e di un giudice.
Giurisprudenza applicativa recente: Oltre al caso di Oristano già citato (decreto 29/7/2024), vi è un precedente di Tribunale di Crotone (2022) di omologa di esdebitazione incapiente, e altri in arrivo man mano che il CCII viene applicato. La Cassazione ancora non si è espressa su questa norma (essendo nuova), ma in futuro potrebbe chiarire alcuni dubbi (es. come quantificare le “utilità rilevanti”, o confermare la competenza monocratica).
Requisiti di meritevolezza e cause di esclusione: guida pratica
Dopo aver descritto le varie procedure, è utile riepilogare i requisiti di meritevolezza comuni e le cause ostative che possono impedire al debitore di ottenere l’esdebitazione (in qualsiasi forma).
Abbiamo già analizzato l’art. 280 CCII, che funge da elenco principale delle condizioni. Possiamo raggrupparle e spiegarle così:
- Onestà e legalità nella condotta pre-insolvenza: Il debitore non deve essersi macchiato di comportamenti fraudolenti o dolosi verso i creditori. Ciò copre:
- reati concorsuali (bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali se rilevanti, ecc.) e reati economici connessi all’attività (es. frodi fiscali gravi, truffe ai creditori). Una condanna definitiva per questi reati è squalificante. Anche l’applicazione di misure di prevenzione antimafia è motivo per congelare la decisione.
- atti in frode ai creditori: distogliere o occultare beni prima o durante la procedura; simulare passività inesistenti; aggravare volutamente il dissesto (es. giocarsi tutto al casinò sapendo di essere insolvente). Tali condotte, pur se non sanzionate penalmente, evidenziano mala fede e pertanto bloccano l’esdebitazione.
- Abuso del credito: è un caso particolare di condotta dolosa o gravemente imprudente. Significa aver fatto ricorso al credito in modo scriteriato, senza ragionevoli prospettive di rimborso, confidando magari nel fallimento come scappatoia. Ad es., un imprenditore che continui a indebitarsi pesantemente pur quando l’azienda è già decotta, oppure un consumatore che accumuli decine di prestiti consapevole di non poterli restituire, rischia di essere bollato come abusivo del credito. Questa valutazione è delicata e non matematica: i giudici devono distinguere tra chi ha contratto debiti sperando in buona fede di cavarsela (poi è andata male, ma non per frode) e chi invece l’ha fatto con leggerezza colpevole o furbizia. Cassazione ha invitato a interpretare l’eventuale non soddisfazione dei creditori con favor per il debitore: se tutte le altre condizioni sono ok, il fatto che i creditori siano rimasti molto insoddisfatti non deve di per sé impedire il beneficio . Ciò ridimensiona l’idea di “abuso del credito”: va usata solo in casi estremi di credito totalmente divorato senza tentativi di risanamento.
- Comportamento corretto durante la procedura concorsuale: Una volta avviata la procedura (fallimento o sovraindebitamento), al debitore si richiede di cooperare lealmente. Le cause di esclusione correlate sono:
- aver ostacolato o ritardato la procedura (es: rifiuto di consegnare documenti, mancata comparizione reiterata alle convocazioni, ingerenze indebite nelle operazioni di liquidazione, ecc.);
- non aver consegnato tutte le informazioni e i documenti richiesti. Il curatore/Gestore deve poter ricostruire la situazione economica. Se il debitore nasconde libri contabili, o non fornisce l’elenco dei creditori, ciò è segno di scarsa collaborazione.
- In sintesi, il debitore deve aver mostrato un atteggiamento collaborativo e trasparente: consegna di scritture, dichiarazioni veritiere, segnalazione di crediti e debiti, disponibilità a far visitare i beni, ecc. Un debitore latitante o reticente vedrà negato il beneficio.
- Assenza di recidiva ravvicinata: Chi ha già goduto di un’esdebitazione meno di 5 anni prima ne viene escluso. Questo per prevenire abusi e per dare un periodo in cui il debitore dovrebbe normalizzare la sua situazione. Se uno fa fallimento nel 2023, ottiene esdebitazione nel 2026, e poi rifallisce nel 2028, non potrà subito chiedere una nuova esdebitazione: dovrà attendere almeno il 2031, e in ogni caso sarebbe la seconda e ultima possibilità.
- Va chiarito che la preclusione riguarda l’aver già ottenuto un’esdebitazione, non semplicemente fatto una procedura concorsuale. Dunque, se Tizio ha fatto un concordato nel 2020 ma senza esdebitazione (perché ha pagato il 30% ai creditori e il resto è stato stralciato consensualmente), oppure se ha fatto un sovraindebitamento nel 2019 ma senza chiedere esdebitazione perché magari aveva pagato una quota significativa, ciò non gli preclude un’eventuale esdebitazione nel 2025. L’art. 280 parla chiaramente di “beneficiato dell’esdebitazione”.
- Massimo due volte nella vita: Questo concetto è stato introdotto nel CCII (prima la L.F. parlava di una volta sola; la legge delega e il CCII hanno esteso a due volte). Vuol dire che il sistema perdona ma non all’infinito. Una terza esdebitazione non è concessa. Se un debitore fosse così sfortunato o imprudente da incorrere in tre insolvenze nell’arco della sua vita, la terza volta i debiti residui non verranno cancellati e resteranno a suo carico.
- Si noti: due volte include anche l’ipotesi di un’esdebitazione ordinaria + un’esdebitazione incapiente. Ad esempio, Caio fallisce nel 2023 e ottiene esdebitazione nel 2026 (prima volta). Nel 2035 è sovraindebitato, incapiente, chiede l’esdebitazione incapiente (seconda volta). Poi nel 2045, ipoteticamente, rivà insolvente: non potrà più essere esdebitato. Oppure due fallimenti con esdebitazione e la terza no, etc. Insomma, due è il numero massimo di salvataggi.
- Debiti esclusi: Lo ripetiamo qui per completezza: anche il debitore più meritevole e onesto non sarà liberato (neanche con l’esdebitazione incapiente) dai debiti che la legge esclude:
- alimenti e mantenimenti dovuti (il dovere verso i familiari è intangibile);
- risarcimenti da fatto illecito e sanzioni pecuniarie penali/amministrative (non accessorie). Questi creditori particolari potranno comunque agire contro il debitore, anche dopo l’esdebitazione, nei limiti previsti (ovviamente se erano concorsuali, non potranno agire su attivo concorsuale già liquidato, ma potranno colpire redditi futuri del debitore esdebitato; es: se Tizio era esdebitato da debiti finanziari ma doveva €10.000 di risarcimento a Caia per un danno, Caia può ancora chiedergli quel risarcimento e pignorare un suo stipendio futuro per ottenerlo).
Chiuse le premesse, possiamo stilare una checklist pratica di meritevolezza che il debitore (e il suo avvocato) dovrebbero considerare prima di presentare domanda di esdebitazione: – Ho commesso reati fallimentari o frodi? – Se sì (condanna per bancarotta, per esempio), niente esdebitazione finché non ottengo la riabilitazione penale. Se ho un processo penale in corso per ciò, devo attendere l’esito. – Ho nascosto beni o creato debiti fittizi? – Se emergono tali fatti, il giudice mi negherà l’esdebitazione. Meglio “pentirsi” prima: se ho occultato un bene, posso ancora rimediare collaborando, ma se è troppo tardi e il curatore l’ha scoperto, la mia istanza è compromessa. – Ho aggravato volontariamente la mia situazione debitoria? – Ad esempio, ho continuato a spendere molto o a prendere prestiti quando era chiaro che non avrei potuto restituirli? Se ciò è interpretabile come “colpa grave”, il tribunale potrebbe negare il beneficio per abuso del credito. Dovrò argomentare bene eventuali scelte, mostrando magari che speravo ragionevolmente in una ripresa. – Ho collaborato con il curatore/liquidatore? – Ciò include: ho depositato subito i documenti contabili, ho fornito l’elenco completo dei creditori, ho segnalato errori nel passivo, ho evitato di presentare reclami pretestuosi sulla liquidazione dei beni, mi sono presentato agli interrogatori. Se sì, bene. Se mi sono reso irreperibile o ho litigato con il curatore su tutto, male – rischio di essere additato come non collaborativo. – Ho già usato l’esdebitazione di recente? – Se ho avuto un fallimento con esdebitazione 3 anni fa, adesso non la posso avere di nuovo. Dovrò attendere ancora. Se l’ho avuta due volte in passato, la terza è preclusa. – I miei debiti residui includono alimenti o risarcimenti? – In tal caso so già che comunque quelli dovrò continuarli a pagare. È utile prevederlo e non fare confusione: ad esempio, se ho un debito verso l’ex moglie per mantenimento, quello non sarà toccato dal decreto di esdebitazione. Pianificherò di doverlo comunque saldare (magari potrei chiedere al giudice di separare quell’obbligo se ci sono arretrati).
Va detto che, secondo le statistiche e la prassi, la stragrande maggioranza dei debitori falliti o sovraindebitati risulta meritevole. I casi di diniego sono relativamente pochi e legati a condotte molto gravi (bancarottieri fraudolenti, debitori palesemente in mala fede). Ciò perché in genere i soggetti in malafede neppure chiedono l’esdebitazione (sapendo di non averne i requisiti, evitano di esporsi a un rigetto). Quindi, se si esclude la fascia di insolvenze fraudolente, l’istituto copre la gran parte degli insolventi onesti. La Cassazione ha infatti evidenziato un’evoluzione: si è passati da un approccio iniziale diffidente (in cui qualche giudice negava l’esdebitazione per ragioni “morali” tipo “non ha pagato quasi nulla ai creditori”) a un approccio aperturista per cui, date le condizioni formali, il beneficio va accordato e serve proprio a chi non può pagare niente, altrimenti non avrebbe senso .
Tabella – Cause ostative all’esdebitazione (art. 280 CCII) e corrispondenti requisiti positivi
| Causa ostativa (art. 280) | Spiegazione pratica | Requisito positivo (meritevolezza) |
|---|---|---|
| Condanna per reati concorsuali o connessi all’impresa (es. bancarotta fraudolenta, reati contro l’economia) | Il debitore ha commesso gravi reati legati all’insolvenza o all’attività d’impresa; se condannato in via definitiva, niente esdebitazione (salvo riabilitazione). Procedimenti penali pendenti sospendono la decisione. | Legalità: il debitore non deve essere un criminale fallimentare. In assenza di condanne (o con reati riabilitati) è meritevole sotto questo profilo. |
| Distrazione dell’attivo, passività inesistenti, aggravamento doloso del dissesto, abuso del credito | Il debitore ha sottratto o nascosto beni ai creditori, o falsificato i debiti; ha peggiorato di proposito la situazione finanziaria rendendo difficile capire dove siano finiti i soldi; ha continuato a indebitarsi in modo irresponsabile. | Onestà gestionale: il debitore ha tenuto una condotta regolare, senza frodi. Non ha occultato beni né fittiziamente gonfiato i debiti. Non ha dilapidato risorse in maniera colpevole quando era in crisi. |
| Ostacolo o ritardo alla procedura; mancata collaborazione | Il debitore, durante fallimento/liquidazione, non ha collaborato: non ha consegnato documenti, ha osteggiato il curatore/liquidatore, ha rallentato la liquidazione. | Cooperazione: il debitore ha collaborato attivamente nella procedura, fornendo documenti e informazioni, facilitando le operazioni di liquidazione e rispettando le richieste del tribunale/curatore. |
| Già beneficiato di esdebitazione < 5 anni prima | Il debitore ha ottenuto un’esdebitazione recentemente (meno di 5 anni fa). Ciò impedisce di averne un’altra subito. | Novità del beneficio: è la prima esdebitazione, oppure è trascorso oltre un quinquennio dall’ultima. Il debitore non è un fresh start “seriale” a breve intervallo. |
| Già beneficiato di 2 esdebitazioni (in qualunque tempo) | Il debitore ha già avuto due esdebitazioni in passato. Ha esaurito il “bonus”: la terza non è ammessa. | Limite di volte: il debitore richiede l’esdebitazione per la prima o al massimo seconda volta. Non ha superato il limite di due benefici nella vita. |
Queste cause ostative sono comuni a tutte le procedure di esdebitazione (fallimento, sovraindebitamento, incapiente), con l’ovvia eccezione che l’incapiente non doveva nemmeno essere soggetto a fallimento. Ma per l’incapiente valgono in più: – non deve aver già usato la stessa procedura incapienti (una sola volta in vita) ; – deve aver fornito tutta la documentazione e impegnarsi a cooperare col gestore per 4 anni; – nota: la lettera a) di art.280 come modificata, con la sospensione in caso di procedimenti penali, potrebbe applicarsi anche lì.
In sede di domanda, è consigliabile allegare dichiarazioni che attestino il rispetto di questi requisiti (per esempio, un’auto-dichiarazione di non aver riportato condanne, o il certificato penale; la relazione del curatore che confermi la cooperazione; la relazione OCC per i sovraindebitati che attesti l’assenza di atti in frode, ecc.). In tal modo si facilita il lavoro del giudice e si mostra trasparenza.
Procedura pratica per richiedere l’esdebitazione (step-by-step)
Cosa deve fare in concreto un debitore – ex imprenditore fallito o privato sovraindebitato – per ottenere l’esdebitazione? Di seguito forniamo una guida procedurale in passi, tenendo conto delle diverse situazioni:
A. Nel caso di liquidazione giudiziale (ex fallimento):
- Tempistica della domanda: Monitorare la durata della procedura. Se la liquidazione giudiziale si sta avviando a conclusione entro 3 anni, la domanda di esdebitazione verrà presentata in prossimità della chiusura (ad esempio, dopo l’approvazione del piano di riparto finale, il curatore avviserà che il fallimento è pronto a chiudersi). Se invece la procedura si protrae oltre 3 anni (casi complessi), il debitore può decorsi 3 anni depositare istanza anche a procedura aperta. In quest’ultimo caso, è opportuno chiedere al curatore di predisporre un rapporto riepilogativo parziale e di convocare il comitato dei creditori per esprimere parere, perché il tribunale ne avrà bisogno.
- Redazione dell’istanza: L’istanza (ricorso) va redatta preferibilmente con l’assistenza di un avvocato. Deve indicare:
- i dati della procedura (numero di liquidazione giudiziale, tribunale, nome del giudice delegato e curatore);
- la data di apertura della procedura (utile per verificare i 3 anni);
- una sintetica esposizione che il debitore possiede i requisiti dell’art. 280: ad esempio “il debitore non è mai stato condannato per reati fallimentari, ha tenuto una condotta collaborativa nella procedura come da relazione del curatore, non è mai stato esdebitato prima, etc.”;
- l’elenco (eventuale) dei creditori insoddisfatti e degli importi rimasti dovuti (questo non è obbligatorio, ma può essere utile allegare un prospetto del passivo ammesso e di quanto è stato pagato, così da far vedere chi rimane insoddisfatto). In ogni caso, il curatore lo fornirà nel suo rapporto.
- Richiesta: “Chiede che il Tribunale, ai sensi degli artt. 279-281 CCII, dichiari inesigibili nei confronti del sottoscritto i debiti concorsuali non soddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale n. …, previa verifica delle condizioni di legge.”
- Contributo unificato: Pagare il contributo unificato per il ricorso. Attualmente (2025) ammonta a €98 per l’esdebitazione post-fallimentare, come diritto forfettario. Allegare la marca o ricevuta di pagamento all’istanza.
- Deposito: Depositare il ricorso in cancelleria fallimentare (oggi “cancelleria della crisi d’impresa”) del tribunale competente, preferibilmente con qualche settimana di anticipo sull’udienza di chiusura. Notificarlo al curatore (molti tribunali richiedono che l’istanza venga portata a conoscenza del curatore).
- Parere del curatore: Il curatore, come detto, stilerà un rapporto finale o integrativo in cui esprime il suo parere sull’esdebitazione. Tipicamente, se il debitore è stato corretto, il curatore riferirà che non risultano ragioni ostative e anzi suggerirà di accogliere. Se invece il curatore fosse a conoscenza di cause ostative, le segnalerà (es: “il fallito ha sottratto beni, quindi a parere dello scrivente non meritevole ex art.280 lett. b”).
- Comunicazione ai creditori: Dopo il deposito dell’istanza, il curatore deve comunicarla a tutti i creditori ammessi. Ciò avviene solitamente tramite PEC per i creditori muniti, o raccomandata. La comunicazione informerà che entro 15 giorni possono presentare osservazioni scritte al tribunale (o al curatore) in merito all’istanza di esdebitazione.
- Udienza o decisione cartolare: Alcuni tribunali fissano un’udienza in camera di consiglio per discutere l’istanza, con comparizione del debitore e del curatore. Altri, se tutto è chiaro e non vi sono opposizioni, procedono senza udienza e decidono in camera di consiglio sulla base degli atti (specie se è contestuale alla chiusura, possono emettere il decreto di chiusura con contestuale esdebitazione).
- Decreto del Tribunale: Se l’esdebitazione è concessa, il tribunale emette un decreto motivato in cui:
- dichiara chiusa la procedura (se è il contesto) e contestualmente dichiara inesigibili nei confronti del signor X i debiti concorsuali non soddisfatti nel fallimento n…, richiamando la norma;
- dà atto della verifica dei requisiti: spesso i decreti riportano “ritenuto che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 279 e 280 CCII” e menzionano magari l’assenza di opposizioni, la meritevolezza attestata dal curatore, etc.;
- dispone la comunicazione a creditori, PM, organi della procedura e iscrizione nel registro imprese.
- se qualcosa impedisce la decisione immediata (es: c’è un processo penale pendente per bancarotta), il tribunale può rinviare la decisione fino all’esito di tale procedimento, tenendo l’istanza in sospeso.
- se invece respinge l’istanza, emetterà un decreto di diniego con le motivazioni (ad esempio: “visto che il debitore è stato condannato per bancarotta, non è ammesso al beneficio”).
- Comunicazioni e pubblicità: La cancelleria trasmette copia del decreto a tutti i creditori ammessi (di solito via PEC); lo invia al debitore e al curatore; lo comunica al Pubblico Ministero. Inoltre, su richiesta del cancelliere, viene iscritta notizia del decreto nel Registro delle Imprese. L’iscrizione serve a rendere conoscibile a terzi l’avvenuta esdebitazione (nel caso di imprenditore, il suo nominativo resta consultabile per un certo tempo con la menzione del provvedimento).
- Fase di reclamo: Da quando è comunicato, decorre il termine di 30 giorni per eventuali reclami:
- I creditori insoddisfatti (o parzialmente soddisfatti) possono proporre reclamo alla Corte d’Appello ex art.124 CCII. Il reclamo va notificato al debitore e, riteniamo, al curatore e PM. La Corte d’Appello deciderà in camera di consiglio confermando o revocando il decreto. Durante questo periodo, il decreto è efficace salvo sospensione. Se il reclamo viene accolto, l’esdebitazione può essere revocata (fortunatamente casi del genere sono rari: di solito i creditori reclamano solo se c’è sospetto di frode o seri motivi).
- Il debitore potrebbe reclamare solo in caso di rigetto dell’istanza, per chiedere alla Corte d’Appello di concedergli il beneficio. Dovrà farlo entro 30 gg dalla notifica del diniego, con atto di citazione in appello.
- Post esdebitazione: Se il decreto passa senza essere riformato, il debitore è libero dai debiti. Conservi il decreto originale in posto sicuro, perché potrebbe servirgli per esibirlo a qualche creditore ostinato o a un ufficiale giudiziario in caso di vecchi decreti ingiuntivi riesumati erroneamente (l’esdebitazione è opponibile come fatto estintivo sopravvenuto).
- Nota: eventuali creditori “distratti” (che non avevano insinuato il credito e magari provano a chiederlo dopo) rientrano comunque tra i debiti concorsuali se erano anteriori al fallimento. Quindi, salvo frode del debitore nell’averli omessi, anch’essi sono inesigibili. Se un creditore post-fallimentare (che non conosceva il fallimento) manda richiesta di pagamento dopo l’esdebitazione, il debitore risponderà allegando copia del decreto e spiegando che il suo credito è estinto (in quanto doveva farlo valere nel fallimento, ora non più). Se il creditore insiste, il debitore può far valere l’esdebitazione come eccezione in un eventuale giudizio o opposizione a decreto ingiuntivo.
- Quanto ai debiti esclusi (alimenti, risarcimenti, multe), il decreto non li menziona specificamente, ma per legge non sono toccati. Il creditore alimentare potrà proseguire eventuali azioni di recupero arretrati. Il debitore dovrà onorarli a parte o negoziare su quelli.
B. Nel caso di liquidazione controllata (sovraindebitamento):
Il procedimento è simile ma con alcune differenze di forma:
- Conclusione della liquidazione controllata: Una volta venduti i beni e distribuito l’attivo, il Liquidatore (o Gestore nominato) deposita un rendiconto finale e chiede al Tribunale la chiusura della procedura. Il debitore può contestualmente o subito dopo presentare ricorso di esdebitazione. Se invece la procedura va per le lunghe (>3 anni), analogamente il debitore può anticipare la richiesta dopo 3 anni dall’apertura.
- Ricorso per esdebitazione sovraindebitato: Si presenta con analoghi contenuti: generalità, riferimento alla procedura ex art.268 CCII, dichiarazione dei requisiti (nessun dolo, cooperazione con Gestore, ecc.), e richiesta ai sensi degli artt. 279-280 e 282 CCII di ottenere l’esdebitazione.
- Non c’è contributo unificato specifico menzionato per questa istanza nelle tabelle attuali (potrebbe applicarsi la stessa tassa di €98). Verificare presso la cancelleria: alcuni tribunali applicano il contributo anche qui.
- Ruolo dell’OCC/Liquidatore: Spesso nei sovraindebitamenti è nominato un Gestore della crisi (OCC) che poi eventualmente svolge il ruolo di Liquidatore. Questi redigerà una relazione finale per il giudice, certificando la condotta del debitore e la sussistenza delle condizioni di legge (art. 280). Anche qui, il Gestore affermerà se il debitore è meritevole: ha depositato tutto, non ci sono atti in frode, etc.
- Comunicazione ai creditori: Il giudice o il Gestore comunicheranno l’istanza di esdebitazione ai creditori che hanno partecipato (o quanto meno ai principali). Di norma, il CCII prevede anche qui la possibilità per i creditori di fare osservazioni entro un termine breve. Molte volte, nei sovraindebitamenti, i creditori sono stati poco attivi e non si oppongono se l’attivo è già stato distribuito.
- Decreto del Tribunale (monocratico): Il giudice emette decreto di chiusura della liquidazione controllata e contestuale esdebitazione dei debiti residui. Anche qui, se tutto è regolare, sancisce che i crediti antecedenti la procedura, rimasti insoddisfatti, sono inesigibili verso il debitore. Se la domanda venisse respinta (magari per mala fede emersa), ne uscirà un decreto di rigetto.
- Comunicazione e impugnazioni: Il decreto viene comunicato al debitore e ai creditori. Essi hanno facoltà di reclamo in appello (stessa procedura vista prima). Tendenzialmente raro, a meno di situazioni di conflitto (es: un creditore ipotecario arrabbiato per il poco ricavato, etc., ma di solito se la liquidazione è chiusa c’è poco da eccepire).
- Effetti finali: Il debitore viene liberato dai debiti residui (eccetto quelli non esdebitabili). Per esempio: un consumatore con debiti vari sarà libero da quelli verso banche, finanziarie, ecc., ma se aveva una multa stradale e quella per qualche motivo non è stata pagata, rimane dovuta. I creditori ordinari non potranno più avviare azioni esecutive né iscriverlo in alcun elenco cattivi pagatori (possono tenerlo segnalato come persona che ha avuto un’insolvenza, ma non potranno pretendere legalmente i soldi).
- Documentazione: Si suggerisce al debitore di conservare il decreto e – se ritenuto utile – di comunicare lui stesso l’esdebitazione a eventuali società di recupero crediti che lo contattassero in futuro ignorando la procedura svolta (non è infrequente che qualche credito passato di mano a società terze “riemerga”: esibendo il decreto, la questione si chiude).
C. Nel caso di procedura per debitore incapiente:
Qui la procedura è leggermente diversa sin dall’inizio, perché come visto consiste in un ricorso autonomo:
- Consulenza iniziale con OCC: Il debitore incapiente dovrebbe rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) sul territorio oppure a un professionista (avvocato, commercialista) esperto in sovraindebitamento. L’OCC valuterà se davvero è incapiente (controllando che non abbia beni o redditi cedibili) e se è meritevole. Se sì, accetterà l’incarico di predisporre la richiesta.
- Ricorso al Tribunale: L’OCC aiuta a predisporre un ricorso ex art.283 CCII, allegando:
- un elenco di tutti i creditori e debiti (con evidenza che non c’è patrimonio per pagarli);
- una relazione particolareggiata che spiega le ragioni del sovraindebitamento e dell’incapienza, attestando la meritevolezza del debitore (sulla falsariga di quella che faceva l’OCC per i piani del consumatore, ma qui specifica per incapiente). La relazione includerà la verifica di assenza atti in frode e colpe gravi, e magari attestati di disoccupazione, ISEE ecc. per provare la mancanza di risorse;
- documenti fiscali (dichiarazioni dei redditi recenti, ISEE) e bancari a supporto;
- stato di famiglia (per eventuali considerazioni su spese di sostentamento).
- in alcuni modelli si allega anche il certificato penale e dei carichi pendenti per dimostrare di non avere condanne rilevanti.
- l’impegno scritto del debitore a informare di eventuali sopravvenienze nei 4 anni e a collaborare col gestore.
- la richiesta finale di concedere l’esdebitazione a costo zero ai sensi dell’art.283.
- Procedimento: Il tribunale fissa un’udienza (solitamente) in camera di consiglio. Il debitore comparirà, assistito dall’avvocato e con l’OCC, per rispondere a eventuali domande. È un’occasione per il giudice di valutare di persona l’attendibilità e la situazione del debitore.
- Possibile coinvolgimento del PM: Il Tribunale può aver chiesto il parere del Pubblico Ministero, dato che si tratta di un provvedimento di ordine pubblico economico. Non è obbligatorio, ma sovente il PM viene messo al corrente. Il PM potrebbe segnalare se il debitore ha procedimenti in corso che ostano, oppure dare un nulla osta.
- Decisione: Il giudice emana un decreto che, se positivo, dichiara aperto il beneficio dell’esdebitazione incapiente in favore del debitore, con le condizioni (una sorta di omologa). Nel decreto:
- Nomina l’eventuale Gestore per il monitoraggio quadriennale (se l’OCC era già nominato, confermerà quello).
- Ordina la comunicazione del provvedimento a tutti i creditori indicati nel ricorso, a cura dello stesso gestore o del cancelliere.
- Avverte che i creditori potranno proporre reclamo in appello se contrari (il decreto può anche stabilire che eventuali opposizioni in Appello non sospendono l’efficacia immediata, salvo diversa disposizione).
- Specifica l’obbligo del debitore di pagare entro 4 anni i debiti, fino a concorrenza, in caso di sopravvenienze rilevanti ≥10% .
- Comunicazione ai creditori: L’OCC/Gestore comunica il decreto ai creditori via raccomandata/PEC. Questi potrebbero essere spiazzati (specie se è la prima volta che sentono di questa procedura). Se qualcuno ritiene che il debitore non fosse realmente incapiente o nasconda qualcosa, potrà depositare reclamo in Corte d’Appello entro 30 giorni.
- Periodo di vigilanza: Intanto, l’esdebitazione è effettiva. Il debitore ora è libero dai debiti, con la riserva dei 4 anni. Il Gestore può chiedere al debitore periodicamente documenti (es: ogni anno l’estratto conto, il CUD se trova lavoro, l’ISEE) per vedere se la situazione è mutata. Il debitore è tenuto a segnalare prontamente eventuali entrate extra (eredità, vincite, donazioni, aumenti stipendio consistenti, bonus).
- Sopravvenienze e adempimento condizionato: Se entro i 4 anni avviene l’evento “utilità rilevante ≥10%”, il debitore deve predisporre (d’intesa col Gestore) un piano di pagamento pro-quota ai creditori per quell’importo. In genere, si tratterà di raccogliere quell’entrata, detrarre ciò che serve al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso, e destinare il resto ai creditori concorsuali in misura proporzionale ai rispettivi crediti originari. Il Gestore magari convocherà i creditori per consegnare loro le somme. Il pagamento andrà fatto entro 4 anni dal decreto .
- Esempio: debitore con €50.000 di debiti, esdebitato incapiente. Entro 2 anni vince €20.000. Poiché €20k è il 40% (≥10%), scatta l’obbligo. Poniamo che valuti che per lui tenerne €5.000 per vari arretrati sia necessario e €15.000 possa destinarli. Dovrà entro l’anno successivo (comunque prima del 4° anno) distribuire €15.000 ai creditori, cioè il 30% dei loro crediti, e magari trattiene 10% per spese e vivibilità. Dipende da come il giudice orienta l’interpretazione.
- Chiusura dei 4 anni: Trascorsi 4 anni dalla data del decreto senza che siano sopraggiunte utilità rilevanti (o avendo il debitore ottemperato a quelle sopraggiunte), l’esdebitazione incapiente diventa definitiva e incondizionata. Il debitore è definitivamente libero dai debiti passati, e non dovrà più rendere conto di eventuali successivi miglioramenti di reddito. A quel punto la sua situazione è equiparabile a quella di chi ha chiuso un fallimento con esdebitazione: un “fresh start” completo.
- Revoca per comportamento scorretto: Se in qualsiasi momento durante i 4 anni si scopre che il debitore ha mentito o agito in frode, il tribunale su istanza dei creditori o del Gestore può revocare il beneficio. Ad esempio, se salta fuori che possedeva un immobile all’estero non dichiarato, oppure che ha ricevuto un grosso regalo e lo ha occultato. La revoca può portare il debitore al punto di partenza (debiti di nuovo esigibili) e probabilmente pregiudicherà la possibilità di rifare domanda (avendo dimostrato indegnità).
Nota Bene: L’esdebitazione incapiente coinvolge spesso creditori istituzionali (banche, fisco, multiutilities) i quali inizialmente potrebbero non essere nemmeno a conoscenza di questa procedura. È probabile che con la diffusione, inizino anch’essi a monitorare e, se del caso, a opporsi dove ravvisino abusi. Ad oggi (2025) i casi trattati non sono ancora moltissimi, perciò c’è un margine di incertezza applicativa. Tuttavia, appare come uno strumento destinato a crescere in utilizzo, specie in periodi di crisi generalizzata.
Effetti dell’esdebitazione: cosa comporta per il debitore e per i creditori
Abbiamo già accennato agli effetti specifici, ma è utile riassumere in modo organico cosa succede dopo che l’esdebitazione è stata concessa:
Per il debitore:
- Liberazione dai debiti residui: Tutti i debiti verso i creditori concorsuali non soddisfatti nella procedura si considerano estinti dal punto di vista giuridico, o meglio “inesigibili” nei suoi confronti. Ciò significa che il debitore non è più obbligato a pagare quelle somme e i creditori non possono pretendere nulla di più da lui (salvo eccezioni di legge). Ad esempio: se aveva un mutuo residuo non coperto dall’attivo fallimentare, la banca non potrà chiedergli la differenza; se aveva debiti personali di vario tipo, anch’essi sono cancellati.
- Cessazione delle procedure esecutive individuali: Se prima o durante il fallimento erano in corso pignoramenti o altre azioni esecutive dei creditori (sospese per via della procedura), dopo l’esdebitazione non possono essere riattivate. Il debitore può opporre il decreto di esdebitazione a qualsiasi tentativo di esecuzione su quei crediti. Ad esempio, se un creditore aveva un pignoramento dello stipendio attivo prima del fallimento, dopo l’esdebitazione quello stesso creditore non può riprendere il pignoramento (lo stipendio post-esdebitazione è salvo, tranne che per crediti esclusi come alimenti).
- Continuità rapporti obbligatori esclusi: L’esdebitazione non incide sugli obblighi di mantenimento alimentare e su analoghi doveri personali. Quindi, se il debitore paga un assegno mensile al coniuge separato, dovrà continuare a pagarlo integralmente anche dopo l’esdebitazione (non viene sgravato dagli arretrati di mantenimento neppure).
- Possibilità di tornare a contrarre debiti e fare impresa: Uno degli scopi del fresh start è consentire al debitore di riabilitarsi economicamente. Dopo l’esdebitazione, il soggetto può (in teoria) accedere di nuovo al credito, aprire una nuova attività, esercitare ruoli imprenditoriali senza il peso del fallimento passato. Attenzione: l’esdebitazione non cancella la storia – ad esempio, il nominativo del fallito esdebitato resterà negli archivi della Camera di Commercio e probabilmente nei sistemi di informazione creditizia per un certo periodo, segnalando che è stato insolvente ma è stato esdebitato. Molte banche guarderanno con prudenza a un soggetto che ha fatto default in passato; tuttavia, dal punto di vista legale, non c’è più alcuna restrizione: il debitore esdebitato può richiedere finanziamenti (sarà discrezione della banca concederli o meno), può costituire società, assumere cariche (se non soggetto a interdizioni per reati commessi).
- Riabilitazione personale: L’esdebitazione ha anche un effetto morale: il debitore è “riabilitato” nel senso che la legge lo considera meritevole di ricominciare senza debiti. Non va confusa con la riabilitazione civile (che esisteva come istituto, es. la riabilitazione del fallito era la cancellazione dai pubblici registri dopo un certo tempo). Oggi quella riabilitazione formale non c’è più, ma di fatto l’esdebitazione ne fa le veci. In alcune procedure, il tribunale consegnava persino un attestato di esdebitazione al debitore.
- Conservazione di alcuni beni sopravvissuti (nel fallimento): Se per ipotesi nella procedura di liquidazione giudiziale alcuni beni non erano stati liquidati perché non convenienti (es. oggetti personali di modesto valore, o la casa con ipoteca che però non trovava acquirenti e fu lasciata al debitore), l’esdebitazione non priva il debitore di quei beni. Egli li mantiene e i creditori chirografari non potranno più aggredirli. Tuttavia, attenzione: i creditori con garanzia reale (pegno, ipoteca) mantengono il loro diritto sul bene gravato anche dopo l’esdebitazione. Quindi, se il debitore ha tenuto la casa ipotecata (magari perché nessuno l’ha comprata all’asta e la procedura si chiude lo stesso), la banca ipotecaria potrà – malgrado l’esdebitazione – escutere l’ipoteca sulla casa. L’obbligazione personale del debitore verso la banca è inesigibile, ma il vincolo reale sul bene rimane. In pratica la banca potrà pignorare e vendere l’immobile per soddisfarsi (non potrà eccedere però: se ricava meno non potrà poi fare ulteriori pretese personali). Questo punto non è espresso esplicitamente nel CCII, ma è regola generale sui diritti reali di garanzia. Quindi il debitore esdebitato che possiede ancora un bene ipotecato dovrebbe valutare che quel bene non è al sicuro dall’azione del creditore garantito.
- Seconde nozze con i debiti? Un dubbio a volte sollevato: se dopo l’esdebitazione il debitore si sposa (in comunione dei beni) o riceve donazioni, i creditori passati potrebbero rifarsi su questi nuovi beni? La risposta è no per i crediti esdebitati: essi non possono più essere fatti valere contro il debitore e neppure contro il coniuge (quest’ultimo non era coobbligato). Quindi i nuovi beni acquistati a titolo originario sono liberi. Mentre, come detto, se un creditore aveva ipoteca su un bene di prima, quell’ipoteca è opponibile anche al nuovo coniuge se il bene entra in comunione (caso raro, di solito i beni pre-matrimonio restano personali).
- Rapporti con eventuali fideiussioni date dal debitore: Se il debitore aveva prestato fideiussioni per obbligazioni altrui, e l’escussione di tali fideiussioni è divenuta credito concorsuale (perché il debitore-fideiussore è fallito), allora l’esdebitazione libererà anche da quelle (in quanto sono debiti concorsuali). Ad esempio, Tizio fallito era garante di un mutuo altrui: la banca creditrice del mutuo si insinua al passivo di Tizio come credito condizionato; se la principale obbligazione non viene pagata, scatta la richiesta a Tizio. Se Tizio ottiene l’esdebitazione, non dovrà pagare neanche come fideiussore (quel credito bancario rientra tra quelli inesigibili).
Per i creditori:
- Perdita del diritto di agire contro il debitore esdebitato: I creditori concorsuali non soddisfatti (o soddisfatti parzialmente) vedono il proprio diritto di credito divenire non azionabile nei confronti di quel debitore. In pratica, il credito rimane solo come “valore nominale” senza tutelabilità giuridica attiva. Non possono iniziare né proseguire esecuzioni individuali, né cause di accertamento del credito (diventerebbero improcedibili per cessazione della materia del contendere).
- Stralcio contabile: Di norma, un creditore, una volta ricevuto il decreto di esdebitazione, stralcia contabilmente il credito residuo (lo porta a perdita). È consapevole che non lo recupererà più. C’è un’unica eccezione: il creditore può sperare in eventuali pagamenti futuri se esdebitazione incapiente e entro 4 anni l’obbligo scatta. Ma a parte quel caso, considera finito il rapporto.
- Conservazione delle garanzie verso terzi: Come rimarcato, l’esdebitazione non tocca le eventuali garanzie reali o personali concesse da terzi a favore del creditore. Quindi il creditore può:
- escutere un eventuale fideiussore o coobbligato diverso dal debitore esdebitato. Esempio: Caio era coobbligato solidale in un debito di Tizio, e Tizio è stato esdebitato; Caio rimane obbligato per l’intero importo verso il creditore.
- far valere un’ipoteca o pegno su beni di un terzo datore di ipoteca/pegno. Esempio: la madre del debitore aveva ipotecato casa sua a garanzia di un prestito al figlio; il figlio poi fallisce ed è esdebitato – la banca potrà comunque espropriare la casa della madre ipotecante.
- far valere un’ipoteca sul bene del debitore stesso: come detto sopra, l’ipoteca sul bene del debitore non viene meno, e il creditore potrà soddisfarsi su quel bene in rem. L’unico limite: se il bene era venduto in procedura e ipoteca si è estinta, ovviamente nulla; se il bene è rimasto al debitore, l’ipoteca di solito resta e rende aggredibile quell’asset (questo scenario però capita più nel caso di sovraindebitamento perché nel fallimento in genere tutti i beni vengono liquidati).
- Crediti preclusi nel concorso e non ammessi: Se un creditore non ha partecipato alla procedura (perché ignorava o per sua negligenza non ha insinuato il credito), che succede col suo credito? La giurisprudenza (in vigenza art.142 L.F.) riteneva che anche tali crediti fossero compresi nell’esdebitazione, purché il creditore non provi che il debitore li ha dolosamente omessi dal passivo. In sostanza, se il creditore non insinuato era conoscibile e il debitore semplicemente non l’ha indicato, quel credito era comunque concorsuale e viene esdebitato lo stesso (il creditore aveva la possibilità di farsi valere nella procedura e non l’ha fatto). Discorso diverso se il debitore ha occultato quel creditore intenzionalmente per non farlo partecipare: ciò sarebbe “atto in frode”, sufficiente a negare o revocare l’esdebitazione. Dunque, i creditori che non hanno presentato domanda nel fallimento/sovraindebitamento, alla fine, non possono rivalersi successivamente, a meno che appunto la mancata partecipazione sia dovuta a frode attiva del debitore. Il CCII non disciplina espressamente questo, ma pare mantenere l’impostazione: l’esdebitazione riguarda i debiti verso i creditori concorsuali – e concorsuali erano tutti quelli anteriori comunque, insinuati o meno (forse con eccezione dei crediti esclusi ex art. 278(7)).
- Impatto fiscale: Un aspetto tecnico per i creditori (soprattutto banche e società): le perdite su crediti da esdebitazione sono di solito deducibili fiscalmente. Ricevendo il decreto, il creditore può portare a perdita quel credito ai fini imposte, come forse inefficace. Questo è un incentivo a “lasciar perdere” e a non accanirsi con reclami, a meno che non ci siano princìpi di deterrenza in ballo.
- Regresso e subentri: Un creditore che abbia garanzie di regresso verso altri (es. una banca può rifarsi su un consorzio di garanzia) userà quei rimedi: ma verso il debitore esdebitato no.
In conclusione, per i creditori l’esdebitazione rappresenta la chiusura definitiva della vicenda creditizia con quel debitore. L’unica consolazione è che quell’individuo non farà concorrenza sleale restando in nero o altro: se vorrà rifare affari, dovrà farlo alla luce del sole, e i creditori almeno sanno che non c’è altro da prendere e lo tolgono dai propri bilanci come perdita.
Un possibile punto di discussione: e se il debitore in futuro diventasse molto ricco (dopo i 4 anni per l’incapiente, o in generale per i falliti)? I creditori non potrebbero fare nulla, la legge preferisce garantire la pace sociale e la finalità di reinserimento. Ci si affida un po’ all’etica: nulla vieterebbe moralmente a un debitore che è poi divenuto milionario di rimborsare volontariamente qualche vecchio creditore per scrupolo, ma giuridicamente non può essere costretto.
In sintesi: esdebitazione = il debitore è libero; i creditori (chirografari) hanno perso le loro pretese nei suoi confronti. Lo stigma del fallito viene sostituito dalla chance di ricominciare. Per i creditori si tratta di accettare il principio del fresh start come elemento fisiologico di un sistema economico che incoraggia il rischio controllato: anche loro ne beneficiano in via sistemica, perché sanno che possono concedere credito (soprattutto imprenditoriale) in un contesto dove l’insuccesso non porta a morti civili. È un bilanciamento complesso, ma oramai consolidato.
Questioni controverse e giurisprudenza recente
L’esdebitazione, soprattutto nella transizione tra vecchia e nuova normativa, ha sollevato varie questioni interpretative. Qui ne esaminiamo alcune di rilievo, illustrando come i giudici le hanno risolte.
- Disciplina applicabile ai fallimenti “di confine” (vecchia vs nuova legge): Come già visto, la questione principale era se un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, ma chiuso dopo, potesse applicare le norme più favorevoli del CCII (es. chiedere l’esdebitazione dopo 3 anni senza attendere la chiusura). Cassazione, ord. n.14835/2025 ha dato risposta negativa: la procedura rimane soggetta alla legge fallimentare del 1942 per l’intero suo corso, e l’esdebitazione dev’essere trattata secondo quella legge. La Corte ha motivato che l’esdebitazione è fase conclusiva integrata del fallimento, non istituto autonomo, e che le norme del Codice della Crisi non sono applicabili alle procedure vecchie a meno di previsione espressa. Dunque, un fallito ante-2022 deve ancora attendere la chiusura e soddisfare i requisiti ex art.142 L.F. (compreso il vecchio criterio del pagamento non irrisorio, se del caso). Ciò ha trovato conferma in molte pronunce di merito (Tribunali di Rimini, Catania, Terni 2023, citati in Cass.14835/2025). Da notare che il correttivo 2024 (D.Lgs.136/2024) ha inserito nell’art.56 CCII l’applicabilità anche alle procedure pendenti (tra cui esdebitazioni) delle modifiche introdotte, ma questo vale per correttivi del CCII su procedure aperte dopo l’entrata in vigore del CCII, non travolge l’approccio di fondo. Insomma: per i “vecchi” falliti si applica la “vecchia” legge.
- Minimo soddisfacimento dei creditori e meritevolezza: Sotto la legge fallimentare, c’era dibattito se il fallito che non avesse fatto ottenere nulla ai creditori potesse essere comunque esdebitato. L’art.142 co.2 L.F. diceva: l’esdebitazione non è ammessa se i creditori non siano stati soddisfatti “neppure in parte”. Alcuni tribunali interpretavano in modo rigido: 0% = niente beneficio; altri guardavano alle circostanze (se 0% è dovuto a cause oggettive e il fallito è irreprensibile, perché punirlo?). Cassazione, sent. n.15359/2023 ha chiarito che i motivi ostativi di meritevolezza (art.142 co.1 L.F.) sono tassativi e che la circostanza del co.2 (creditori totalmente insoddisfatti) va valutata con favor debitoris. La Corte ha detto: se tutti gli altri presupposti del primo comma sono rispettati, l’esdebitazione deve essere concessa, a meno che realmente i creditori siano rimasti del tutto a zero o con una percentuale proprio irrisoria . E ha aggiunto che va distinto tra passività sociali e personali (nel caso esaminato c’era un socio illimitatamente responsabile: la Corte d’Appello aveva erroneamente considerato 2% su totale società+socio come irrisorio, ma in realtà isolando la posizione del socio la percentuale era maggiore) . Dunque, Cassazione ha evidenziato che solo lo 0 assoluto o quasi dovrebbe impedire il beneficio, e anche lì con cautela. Questo ha un impatto residuo per i casi sotto vecchia legge. Nel CCII, come detto, non c’è più il comma sul “neanche in parte”, quindi anche lo 0% di recupero non preclude l’esdebitazione ora, purché il debitore sia meritevole. Tale evoluzione è coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023, art. 23, che vieta di condizionare la piena esdebitazione dell’imprenditore al soddisfacimento di una soglia minima di debiti . In altre parole: non si può dire “ti perdono i debiti solo se paghi almeno il 10%”, deve contare la condotta e basta. Il nostro legislatore ha recepito ciò, tant’è che l’incapiente consente addirittura 0% di recupero immediato.
- Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile: Problema collegato al precedente: nelle società di persone fallite, i soci falliscono in estensione (ex art.147 L.F., ora art.256 CCII). Ognuno poi chiede esdebitazione. Una domanda era: se la società ha pagato, poniamo, il 5% ai creditori, e il socio personalmente nulla (perché non aveva altri beni oltre a quelli già aggrediti in società), l’esdebitazione del socio si può dare o no? Cass.15359/2023 ha affrontato proprio questo: la Corte d’Appello aveva negato a un socio perché considerava 2% globale come irrilevante, Cassazione ha cassato dicendo di isolare la posizione del socio e considerare che gran parte dell’attivo era stato consumato da spese prededuttive e procedure lunghe . Questo segna che il socio meritevole va esdebitato anche se la percentuale pagata ai suoi creditori personali è minima, guardando realisticamente la situazione. Nel CCII, l’art.278 consente esdebitazione anche al “debitore persona giuridica” e ai soci illimitati. Qui c’è un punto interessante: la persona giuridica tecnicamente non “beneficia” perché si estingue; ma credo l’intento fosse permettere ai soci illimitati di fare esdebitazione pure se la società era fallita. E infatti Cass.15359/2023 – pur su L.F. – va in quella direzione di favorire l’esdebitazione del socio, senza imputargli passività societarie che non gli competono.
- C’è però in dottrina chi ritiene che il riferimento all’esdebitazione delle società di capitali (che appaiono menzionate in art.278 CCII) sia privo di senso: probabilmente è per includere l’esdebitazione del socio di società di persone, e di eventuali soci illimitati di enti collettivi (cooperative, etc.). Comunque, non esiste ad oggi un caso di “società di capitali esdebitata”: la società di capitali fallita, alla chiusura, viene cancellata e fine, i debiti residui si estinguono per inesigibilità oggettiva (non c’è più soggetto). Non serve un provvedimento.
- Semmai, la questione pratica è: se la società di persone non viene dichiarata fallita (magari per carenza di attivo) ma vengono dichiarati i soci, questi soci potranno accedere all’esdebitazione anche per i debiti sociali rimasti. Sì, direi di sì, perché la definizione di debitore concorsuale comprende la responsabilità illimitata.
- Crediti IVA e altri tributi: Una questione affrontata in passato era: l’IVA, essendo un tributo UE, può essere oggetto di esdebitazione? C’era un dubbio se la Direttiva IVA impedisse il condono di quell’imposta. La Cassazione (Sez. VI-1, ord. 23129/2014) ha risposto chiaramente che l’IVA è esdebitabile, perché la legge non la esclude e non c’è un divieto comunitario espresso. L’Agenzia delle Entrate provò a opporsi sostenendo che i tributi sono “estranei all’esercizio dell’impresa” e quindi rientravano nella vecchia esclusione di art.142 comma 1 lett. a L.F. (quella su rapporti estranei). La Cassazione rigettò, argomentando che i debiti tributari non sono affatto estranei all’impresa – anzi, nascono proprio dall’attività imprenditoriale – e notò come il legislatore li avrebbe esclusi espressamente se avesse voluto. Dunque, il fallito esdebitato non deve più pagare IVA, IRAP, tasse varie. Questo orientamento vale anche oggi nel CCII: nessun tributo è menzionato tra le esclusioni, ergo i debiti fiscali e contributivi sono soggetti a esdebitazione (salvo sanzioni pecuniarie punitive che restano escluse). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ne ha preso atto e nei giudizi ora raramente contesta l’esdebitabilità di imposte. Semmai, come visto, può contestare la procedura incapiente se vede malizia.
- Esdebitazione concessa con procedure di riparto pendenti: Con il CCII art.281 commi 5-6, è stata formalizzata la prassi di chiudere il fallimento e concedere l’esdebitazione anche se restano cause in corso. Alcuni temevano che se successivamente entra denaro, non essendoci più procedura aperta, i creditori esdebitati non potessero riceverlo. La norma risolve: il curatore può ancora distribuire (sia pure extra fallimento) ai creditori, i quali incassano e riducono l’inesigibile. Questo è insolito ma codificato. Non risultano ancora casi pratici riportati di applicazione di questi commi, ma all’atto pratico: se un’azione risarcitoria finisce dopo la chiusura e produce denaro, il curatore (che credo rimanga in carica per quell’attività ex art.235 CCII) convoca i creditori e fa un riparto. È come un mini-fallimento riaperto per quel solo scopo. I creditori incassano e ringraziano, il debitore non viene coinvolto (essendo esdebitato, quell’attivo va tutto a loro). È giusto notare che questi commi riflettono la ratio equitativa di non far prendere al debitore ciò che era destinato ai creditori.
- In Cassazione non mi risultano sentenze sul caso di attivo sopravvenuto post chiusura: la L.F. prevedeva una possibile “riapertura del fallimento” entro 5 anni se comparivano attivi significativi (art.121 L.F.). Con il CCII quell’istituto è scomparso; al suo posto c’è questa continuazione limitata delle operazioni pur a procedura chiusa. Da monitorare se tutto filerà liscio.
- Creditori tardivi non insinuati vs esdebitazione: Questione menzionata: se un creditore non insinuato scopre l’esdebitazione quando prova a farsi avanti, può eccepire di essere estraneo e quindi non colpito? In dottrina si dice: se il credito era concorsuale, l’esdebitazione lo copre comunque, a meno di dolo del debitore. Ci sono vecchi provvedimenti in tal senso (es. App. Venezia 2013: creditore non insinuato comunque stralciato; Cass. SU n.24214/2011 aveva accennato?). Comunque, il CCII nulla cambia, salvo sempre rilevare eventuale frode.
- Rifiuto dell’esdebitazione e impugnazioni: Finora raramente la Cassazione ha affrontato casi di rigetto di esdebitazione impugnati dal debitore. C’è Cass. 15246/2022 (civile) dove riformano decisione su rigetto per 0%? Non ricordo. Comunque, con la tendenza attuale, i rigetti per motivi non espressi in legge vengono cassati. Ad esempio, Cass.7550/2018 SU aveva già affermato la tassatività cause ostative, e Cass.15359/2023 ribadisce. Quindi i giudici di merito, se respingono per ragioni non previste (tipo “il debitore è in colpa generica per essersi indebitato troppo” – concetto oltre le ipotesi di legge), vengono corretti. Il messaggio è: attenersi a art.280 e non inventare criteri moralistici. Ciò garantisce prevedibilità e uniformità applicativa.
- Compatibilità con riabilitazione penale: Un discorso parallelo: un fallito condannato per bancarotta può ottenere la riabilitazione penale dopo aver scontato la pena e così facendo, potrebbe rimuovere l’ostacolo di art.280 lett. a. La legge già lo prevede: se c’è stata riabilitazione, la condanna non conta. Ciò è chiaro e avveniva anche prima. Quindi un ex bancarottiere può, dopo qualche anno e un percorso, rifarsi e chiedere esdebitazione (dev’essere comunque passata la macchia e convincere che non c’è più rischio di recidiva, immagino).
In generale, la giurisprudenza più autorevole (Corte di Cassazione) sta spingendo verso una interpretazione pro-debitore dell’istituto: favorire la liberazione quando possibile, come strumento di politica economica e sociale, senza indulgenza per i furbi ma con comprensione per chi è incappato in un fallimento. E la normativa recente codifica proprio questa filosofia.
Domande Frequenti (FAQ) sull’esdebitazione
Di seguito rispondiamo brevemente ad alcune domande comuni che possono porsi ex imprenditori, privati debitori e professionisti in merito all’esdebitazione:
D1: Chi può ottenere l’esdebitazione?
R: Qualsiasi persona fisica insolvente che abbia affrontato (o sta affrontando) una procedura concorsuale di liquidazione. In particolare: l’imprenditore individuale fallito (liquidazione giudiziale), il consumatore o piccolo imprenditore in liquidazione controllata per sovraindebitamento, e perfino il debitore persona fisica incapiente (senza beni) tramite l’apposita procedura. Le società di capitali no (cessano di esistere col fallimento, quindi per loro non serve esdebitazione), mentre i soci illimitatamente responsabili di società fallite sì. È però necessario che il debitore sia meritevole (vedi D3) e non abbia già abusato in passato di questo beneficio oltre i limiti (non più di due volte, non negli ultimi 5 anni se già ottenuto una volta).
D2: Quali debiti vengono cancellati con l’esdebitazione?
R: Sono cancellati (dichiarati inesigibili) tutti i debiti concorsuali rimasti non pagati nella procedura di insolvenza. In pratica, tutti i debiti che erano sorti prima dell’apertura della procedura e che non hanno trovato soddisfazione integrale. Esempi: fornitori, banche, fisco, contributi, canoni, stipendi arretrati (se non saldati dal fondo di garanzia), ecc. Fanno eccezione soltanto: – gli obblighi di mantenimento e alimentari (verso coniuge, figli o altri parenti beneficiari di alimenti); – i debiti per risarcimenti di danni da fatto illecito extracontrattuale e le multe/ammende/sanzioni pecuniarie penali o amministrative (non accessorie a debiti estinti). Queste tipologie restano a carico del debitore anche dopo. Tutti gli altri, inclusi i debiti fiscali e contributivi, vengono meno (lo prevede la legge, e la Cassazione ha confermato che le imposte non sono escluse dall’esdebitazione). Quindi, ad esempio, debiti IVA, IRPEF, cartelle esattoriali per tributi e contributi sono soggetti a esdebitazione; le sole parti non condonabili di una cartella sarebbero eventuali sanzioni per violazioni (che restano dovute). Vale inoltre la regola che restano obbligati gli eventuali fideiussori o coobbligati: se qualcun altro aveva garantito quei debiti, il creditore potrà rivalersi su di lui malgrado l’esdebitazione del debitore principale.
D3: Cosa significa debitore “meritevole” ai fini dell’esdebitazione?
R: Significa un debitore che ha tenuto un comportamento onesto e collaborativo, senza colpe gravi, nella genesi e gestione dell’insolvenza. La legge dettaglia i criteri di meritevolezza all’art. 280 CCII: – non aver commesso reati fallimentari gravi (es. bancarotta fraudolenta) o altre frodi ai creditori; – non aver aggravato volontariamente il dissesto né abusato del credito in modo scellerato; – aver cooperato con il curatore/gestore, fornendo tutte le info e documenti e non ostacolando la procedura; – non essere un “professionista del fallimento” (non aver già ottenuto esdebitazioni recenti o in numero superiore a due). In sostanza, il meritevole è colui che si è trovato sovraindebitato per sfortuna o errori scusabili e non per malafede o condotte fraudolente. Ad esempio, un imprenditore fallito a causa di crisi di mercato, che però ha tenuto libri in ordine e non ha nascosto beni, è meritevole. Un consumatore indebitato perché ha perso il lavoro e ha fatto prestiti per vivere, è meritevole se non ha mentito o dissipato denaro scientemente. Viceversa, chi ha truccato i bilanci, sottratto denaro dall’azienda o contratto debiti sapendo di non poterli restituire (e.g. schema Ponzi) non è meritevole e verrà escluso.
D4: È necessario pagare una parte dei debiti per poter accedere all’esdebitazione?
R: No. Non esistono soglie di pagamento minimo richieste per legge (nel sistema attuale). Anche se il debitore non è riuscito a pagare nulla ai chirografari, può comunque ottenere l’esdebitazione, purché sia meritevole. In passato c’era la convinzione che bisognasse soddisfare almeno in parte i creditori, ma la giurisprudenza ha chiarito che non c’è una soglia quantitativa: il giudice può semmai negare il beneficio solo se i creditori sono rimasti totalmente a zero e ricorresse pure qualche altra condotta negativa . Nel Codice della Crisi, questa condizione neppure è più menzionata, segno che anche un debitore il cui patrimonio ha coperto 0% dei debiti può aspirare al fresh start (sono proprio i casi di debitore incapiente). Dunque, non occorre versare niente di tasca propria ai creditori per “farsi perdonare”. Ovviamente, se si hanno risorse, è giusto destinarle alla procedura; ma se non ve ne sono, l’assenza di pagamento non impedisce la cancellazione dei debiti residui.
D5: Dopo quanti anni si può ottenere l’esdebitazione?
R: Il Codice attuale prevede un termine fisso di 3 anni dall’apertura della liquidazione. Significa che, salvo cause ostative, il debitore ha diritto all’esdebitazione trascorsi 3 anni dall’inizio della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione controllata) – o anche prima, se la procedura si chiude anticipatamente. Quindi: – se il fallimento dura, ad esempio, 5 anni, il debitore già al 3° anno può chiederla (senza aspettare la fine); – se il fallimento si chiude in 2 anni, può ottenerla subito alla chiusura (non deve comunque aspettare di più). Questa è una novità rispetto al passato, dove bisognava sempre attendere la chiusura + fare domanda entro 1 anno. Ora il diritto matura comunque entro 3 anni. Per le procedure aperte prima del 15/7/2022, tuttavia, si continua ad applicare la legge precedente (domanda dopo chiusura, entro 1 anno), come stabilito dalla Cassazione. Nel caso particolare dell’esdebitazione incapiente, i 3 anni non si applicano perché lì non c’è procedura di liquidazione: si può ottenere in pochi mesi, giusto il tempo del procedimento in tribunale. Dall’istanza di incapiente alla decisione di solito passano meno di 1 anno (in alcuni casi 3-6 mesi). Dopo, decorre il periodo di condizione risolutiva di 4 anni, ma il beneficio intanto è goduto subito. In sintesi: circa 3 anni per fallimenti/sovraindebiti (o meno se procedura più breve), immediatamente per incapiente (con vincolo quadriennale successivo).
D6: Devo aspettare la chiusura del fallimento per chiedere l’esdebitazione?
R: Non necessariamente. Con la nuova normativa, se il fallimento (liquidazione giudiziale) si protrae a lungo, dopo 3 anni dall’apertura puoi presentare istanza di esdebitazione anche a procedura non conclusa. Il tribunale, verificati i requisiti, potrà emettere il decreto di esdebitazione anche mentre il fallimento è in corso. La procedura di liquidazione poi proseguirà per distribuire eventuali attivi futuri ai creditori, ma tu nel frattempo sarai liberato dai debiti residui oltre ciò che verrà pagato. Se invece la procedura sta per chiudersi prima di 3 anni, allora sì, conviene attendere quella sede: contestualmente alla chiusura, il tribunale deciderà sull’esdebitazione (devi comunque depositare domanda magari pochi mesi prima, così il giudice la esamina in tempo). In sostanza, il timing è: whichever comes first tra 3 anni e chiusura. Nota che per procedure vecchie (iniziate prima del 2022) questa regola anticipata non vale, devi attendere la chiusura in base alla legge fallimentare.
D7: Ho precedenti penali/sono stato condannato per bancarotta: posso esdebitarmi?
R: Se la condanna è per bancarotta fraudolenta o altri gravi reati connessi all’insolvenza, costituisce un ostacolo. La legge dice che non è ammesso al beneficio chi è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta o reati contro l’economia, l’industria, commercio, salvo intervenuta riabilitazione. Quindi, fintanto che la condanna è attuale, no, non potrai ottenere l’esdebitazione. Devi prima ottenere dal Tribunale di Sorveglianza la riabilitazione penale (che di solito richiede almeno 3-5 anni dal fine pena e la dimostrazione di buona condotta). Ottenuta la riabilitazione, l’ostacolo viene meno e potrai chiedere l’esdebitazione come chiunque altro. Se invece sei sotto processo per quei reati e ancora non c’è sentenza definitiva, il tribunale sospenderà la decisione sull’esdebitazione finché il processo penale non si conclude. Ciò significa che potresti dover aspettare. In caso di assoluzione, via libera; in caso di condanna, come detto, no finché non sarai riabilitato. Se i tuoi precedenti penali non riguardano reati fallimentari o comunque attinenti (es: piccola condanna per reato comune non collegato all’attività d’impresa), di norma non ostacolano l’esdebitazione.
D8: L’esdebitazione copre anche i debiti verso il Fisco e l’INPS?
R: Sì, i debiti tributari e previdenziali sono soggetti a esdebitazione come tutti gli altri (non rientrano nelle esclusioni). Quindi, se dopo la liquidazione restano impagati debiti con Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per tasse, IVA, contributi INPS, essi vengono cancellati dal decreto di esdebitazione. È un aspetto molto importante: vuol dire che lo Stato non ti perseguiterà oltre per quei debiti (a differenza di alcuni Paesi dove certe tasse restano comunque dovute). Fanno eccezione solo eventuali multe o sanzioni amministrative (es: sanzione per omessa dichiarazione IVA, che è afflittiva, rientra tra quelle non cancellabili). Ma la tassa principale e gli interessi di norma sì, sono esdebitati. La Cassazione ha espressamente affermato che il fallito esdebitato “non è più tenuto al pagamento delle somme dovute all’Erario”. Dunque, se avevi cartelle esattoriali, dopo esdebitazione quelle cartelle non sono più esigibili (a parte eventuali importi per sanzioni come detto). Anche per il sovraindebitato vale: se aveva debiti fiscali inclusi nella liquidazione controllata, alla fine vengono tolti. Ricorda però: se c’erano ritenute non versate operate come sostituto d’imposta, in passato c’era discussione se fossero equiparate agli alimentari (perché “rapporti estranei all’impresa”). Oggi direi di no, non essendo previste eccezioni, anche quelle dovrebbero rientrare nell’esdebitazione.
D9: Posso esdebitarmi più di una volta? (Cosa succede se fallisco di nuovo)
R: La legge ti consente di beneficiare dell’esdebitazione al massimo due volte nella vita. Quindi, se sfortunatamente incappi in un secondo fallimento o sovraindebitamento anni dopo, potrai richiedere nuovamente l’esdebitazione, purché siano passati almeno 5 anni dalla precedente. Ad esempio: fallisci a 30 anni, ottieni esdebitazione; a 40 anni rifallisci, puoi chiedere la seconda esdebitazione. Ma se fallissi una terza volta a 50 anni, non potresti più ottenerla: quella volta rimarresti con i debiti. Quindi il sistema ti dà due opportunità di fresh start. Oltre, vieni considerato recidivo incallito e il beneficio non è più concesso. Questo limite vale complessivamente: anche se la prima volta era esdebitazione da sovraindebitamento e la seconda da fallimento, contano come due. Fai attenzione dunque: se hai già avuto l’esdebitazione e torni in affari, cerca di evitare assolutamente un nuovo dissesto, perché alla terza non c’è paracadute. (Va detto che casi di triplice fallimento di persona fisica sono rari, ma non impossibili). Quanto al vincolo dei 5 anni, significa che dopo la prima esdebitazione devi aspettare 5 anni prima di poter depositare un’altra domanda in un’eventuale procedura successiva. Se ad es. fallisci di nuovo dopo 3 anni, non potrai chiedere l’esdebitazione in quel secondo fallimento – il tribunale rigetterà per cause ostative, come successo in alcuni casi.
D10: L’esdebitazione influisce sulla mia affidabilità creditizia futura?
R: Dal punto di vista legale, no: una volta esdebitato, non hai più debiti e non sei soggetto a restrizioni (puoi fare prestiti, aprire conti, fare da amministratore di società, ecc.). Tuttavia, dal punto di vista reputazionale e bancario, ovviamente il fatto che sei stato insolvente e hai avuto un’esdebitazione rimarrà per qualche tempo nei sistemi informativi. Ad esempio: – Nei Sic (Sistemi di Informazioni Creditizie) privati, un default o “saldo e stralcio” è segnalato tipicamente per 36 mesi da quando risulta chiuso. Potrebbe comparire che il tuo debito è stato chiuso a seguito di procedura concorsuale. Passati alcuni anni, però, la segnalazione viene cancellata e torni “pulito” nelle banche dati creditizie. – Nel Registro Informatico dei Protesti, un protesto cambiario o assegno potrebbe restare, ma se sei esdebitato puoi chiedere la cancellazione per avvenuto pagamento? Non precisamente, perché non hai pagato tu; comunque i protesti dopo 5 anni decadono. – Nel Registro delle Imprese, l’annotazione del fallimento e dell’esdebitazione resta storica. Chi fa una visura camerale su di te come persona potrà vedere che sei stato dichiarato fallito nel tal anno e che nel tal anno sei stato esdebitato. Non c’è un automatismo di cancellare questi atti, perché sono eventi di fatto. Però, se ti candidi ad esempio a ruoli societari, la legge non ti impedisce di assumerli salvo fossi interdetto per reati. – Per le banche o finanziarie: concedere credito a chi ha avuto un default dipende dalle loro policy. Spesso vogliono trascorra un certo tempo e che tu abbia dimostrato continuità di reddito e affidabilità dopo la “disavventura”. Un vantaggio: essere esdebitato significa che ora non hai più pendenze, quindi paradossalmente sei meno rischioso di prima (hai bilancio ripulito). Alcune banche possono ragionare così: “ha già fallito una volta e ottenuto esdebitazione – se rifallisce una seconda volta, gliela danno di nuovo? Sì se sono passati 5 anni, ma insomma, la legge glielo permette, quindi come creditore rischio comunque di doverlo condonare di nuovo.” Quindi c’è sempre prudenza. Ma molte persone dopo l’esdebitazione riescono a ottenere un mutuo o finanziamenti, specie se offrono garanzie reali o un coobbligato. In sintesi, l’esdebitazione ti riporta legalmente a zero; per la fiducia del mercato, occorre un po’ di tempo e buone pratiche per ricostruirla.
D11: Come funziona l’esdebitazione in caso di società di persone fallita con i soci?
R: Se fallisce una società di persone (S.n.c., S.a.s.), vengono dichiarati insolventi anche i soci illimitatamente responsabili. Ciascun socio persona fisica potrà chiedere l’esdebitazione per i propri debiti. I debiti sociali ricadono pure sui soci, quindi fanno parte del loro passivo. In pratica: – Si chiude il fallimento della società, e parallelamente quello dei soci. – Ogni socio presenta istanza di esdebitazione personale. – Il tribunale valuta la posizione di ogni socio separatamente. Spesso un socio potrebbe aver apportato beni o subito escussioni più di un altro, quindi anche le % di soddisfazione differiscono. L’importante è che il socio sia meritevole. Non viene negata l’esdebitazione al socio solo perché la società ha pagato poco (Cass. 15359/2023 l’ha chiarito) . – Se concessa, libera il socio dai debiti sociali rimasti e dai suoi eventuali debiti personali. Non libera invece la società (che tanto è estinta) né i soci che magari non abbiano chiesto o ottenuto il beneficio. – E i creditori sociali? Se anche gli altri soci vengono esdebitati, i crediti sociali rimasti insoddisfatti sono inesigibili pure nei confronti loro. A quel punto i creditori sociali hanno solo eventuali garanzie reali su beni sociali (già liquidati in fallimento di solito) o su beni di terzi. – Se c’era un socio illimitato persona giuridica (es. una S.a.s. con accomandatario società), quell’ente non può esdebitarsi perché non persona fisica, ma la società fallita poi muore e i crediti restano inesigibili per carenza soggetto. Caso molto raro. In breve, l’esdebitazione si applica singolarmente a ciascun socio fallito illimitatamente responsabile. È prassi che, se i soci sono meritevoli, il tribunale conceda il beneficio a tutti in parallelo. Così l’intera vicenda si chiude definitivamente.
D12: Se un creditore non era a conoscenza del mio fallimento e non ha fatto domanda, può ancora richiedermi il pagamento dopo l’esdebitazione?
R: No, in linea di massima non può. I crediti anteriori all’apertura del fallimento (o procedura) rientrano nel concorso anche se il creditore non li ha fatti valere, e dunque vengono esdebitati. Quando il tribunale dichiara inesigibili “i debiti concorsuali non soddisfatti”, include pure quelli dei creditori che non si sono presentati. Ovviamente ciò presuppone che il debitore non li abbia occultati fraudolentemente. Se il creditore prova che non sapeva nulla perché il debitore non l’ha mai inserito nell’elenco e magari ha dichiarato il contrario, potrebbe contestare per frode. Ma se era un creditore noto (es. da scritture contabili) comunque l’avviso pubblico di fallimento c’è stato. In pratica, se dopo l’esdebitazione arriva una lettera da un vecchio creditore “Ehi, mi devi ancora 10mila euro, non ho mai ricevuto nulla”, il debitore risponde che c’è stato il fallimento numero X, concluso con esdebitazione il tal giorno e che il suo credito è estinto da quell’atto. Il creditore potrebbe provare a fare causa, ma il debitore mostrerebbe il decreto di esdebitazione e la causa finirebbe con rigetto della domanda. Solo se il creditore provasse che il debitore ha agito con dolo nel non considerarlo (p.es. il debitore non lo ha indicato nell’istanza di sovraindebitamento e l’ha fatto apposta per favorirne l’esclusione), allora il decreto potrebbe essere stato ottenuto in frode e dunque impugnato dal creditore stesso. Ma è uno scenario raro. Diciamo che il sistema è: tutti i creditori pregressi dentro o fuori sono tagliati fuori dopo. Quindi, come debitore esdebitato, puoi respirare: nessun vecchio creditore (eccetto alimenti e simili) può legalmente rifarsi su di te.
D13: Cosa devo fare se un creditore prova comunque a riscuotere un debito esdebitato?
R: Devi opporre formalmente l’esdebitazione. Se ricevi, ad esempio, un decreto ingiuntivo per un debito pregresso già esdebitato, fai opposizione al decreto entro i termini e alleghi il tuo decreto di esdebitazione, chiedendo al giudice di dichiarare inesistente la pretesa perché il debito è stato dichiarato inesigibile. Se un ufficiale giudiziario arriva con un pignoramento (può capitare che alcune comunicazioni non siano arrivate ai reparti esecuzioni), puoi presentare un’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., sempre basandoti sull’esdebitazione. In genere, appena mostri il documento al creditore o all’autorità, la pretesa dovrebbe decadere. Per sicurezza, puoi inviare tu ai creditori noti una copia del tuo decreto con una lettera che spiega “Gentile creditore, come da decreto allegato, i Suoi crediti verso di me non sono più esigibili per effetto di esdebitazione ex art… La invito pertanto ad aggiornare i Suoi archivi e a non procedere oltre.” Così eviti l’insorgere di azioni. Comunque, legalmente sei protetto: l’esdebitazione è opponibile a qualunque atto di esecuzione o richiesta di pagamento.
D14: L’esdebitazione incide su eventuali ipoteche sui miei beni?
R: No, le ipoteche e i pegni restano validi diritti reali. Se un bene tuo non è stato venduto nella liquidazione ed è ancora gravato da ipoteca per un debito, il creditore ipotecario conserva la possibilità di agire su quel bene. L’esdebitazione libera te dall’obbligazione personale residua, ma non cancella l’ipoteca (a meno che il giudice fallimentare non l’abbia ordinato per chiusura per insufficienza attivo, ma in tal caso l’esdebitazione non c’entra). Ad esempio, se ti è rimasta la casa di abitazione perché nessuno l’ha comprata all’asta (magari vale meno del mutuo), la banca con ipoteca potrà ancora rifarsi sulla casa, vendendola per recuperare il possibile. Non potrà poi venire contro di te per l’eventuale ulteriore differenza (quella sì è esdebitata). Quindi, attenzione: l’esdebitazione non significa che ti tengono l’immobile gratis liberandoti pure dal mutuo – se la casa è ipotecata, o paghi il mutuo regolarmente se vuoi tenerla, oppure la banca prima o poi la aggredirà. Discorso analogo per un’automobile su cui c’è un fermo amministrativo o vincolo: quell’azione di garanzia resta applicabile (il fermo ACI per cartella esattoriale però cessa se il debito esdebitato era quello, in quel caso credo possano revocarlo su istanza). Insomma, l’esdebitazione non purga i beni dalle garanzie reali esistenti.
D15: L’esdebitazione copre anche i debiti contratti dopo il fallimento?
R: No. L’esdebitazione riguarda solo i debiti concorsuali, cioè quelli sorti prima dell’apertura della procedura di insolvenza. I debiti contratti durante o dopo la procedura (ad esempio se durante il fallimento hai fatto dei debiti personali nuovi, magari un piccolo prestito da un amico, o multe post-fallimento, oppure un debito alimentare corrente) non rientrano e rimangono tuoi. Perciò, fai ben attenzione a non accumulare nuovi debiti nell’attesa dell’esdebitazione. Se li hai accumulati, quelli rimangono: l’esdebitazione non li tocca. Dovrai pagarli normalmente, o se non riesci, eventualmente attivare una nuova procedura per quelli (ma come detto, farne un’altra troppo presto è precluso). Un esempio classico: durante il fallimento il debitore potrebbe aver continuato a non pagare imposte correnti o affitto – questi debiti post saranno estranei al concorso e andranno pagati, l’esdebitazione non li comprende. Chiuse le pendenze concorsuali, il debitore vorrà sistemare anche questi eventuali debiti maturati successivamente.
D16: Che differenza c’è tra esdebitazione e riabilitazione civile?
R: Storicamente, la riabilitazione civile era un istituto previsto per il fallito che avesse pagato almeno il 25% dei creditori o dimostrato di non farcela per circostanze indipendenti dalla sua volontà, decorsi 5 anni dal fallimento (art.144 L.F.). Gli dava diritto a essere “riabilitato”, cioè a vedersi cancellate le limitazioni civili da fallimento (come il divieto di ricoprire cariche, etc.). Questo concetto ora è superato: con l’esdebitazione, che può arrivare molto prima e senza quella soglia del 25%, si ottiene di fatto lo stesso risultato in termini di reintegrazione del debitore nella vita economica. Tant’è che la norma sulla riabilitazione del fallito è stata abrogata. Quindi oggi l’esdebitazione sostituisce la vecchia riabilitazione, in modo più efficace e ampio (non solo toglie le incapacità civili, ma cancella proprio i debiti). In conclusione: non devi più richiedere una riabilitazione separata dopo il fallimento; ottenuta l’esdebitazione, sei a posto. Sul piano penale, come detto, c’è la riabilitazione del condannato per reati, che è altra cosa (utile per poter accedere all’esdebitazione in caso di condanna pregressa). Ma sul piano civile ed economico, l’esdebitazione è il meccanismo di riabilitazione oggi.
D17: Se entro 4 anni dall’esdebitazione incapiente eredito dei soldi, devo darli ai vecchi creditori?
R: Sì, in parte. La legge prevede che se il debitore incapiente beneficiato vede sopravvenire, nei 4 anni successivi al decreto, delle “utilità rilevanti” che permetterebbero di pagare almeno il 10% dei creditori, egli è tenuto a pagare i debiti (entro il limite di quella sopravvenienza, credo) fino a concorrenza di quell’importo . In termini pratici: se erediti una somma consistente, dovrai destinarne una quota ai creditori originari, almeno sino a raggiungere il 10% per ciascuno. Se l’eredità fosse sufficiente a saldare tutti al 100%, moralmente e legalmente dovresti farlo (il decreto parla di “pagamento del debito entro 4 anni se utilità ≥10%”). Tuttavia, se erediti ad esempio €5.000 su €100.000 di debiti (5%), ciò è sotto soglia e potresti trattenere senza obbligo (però 5% è sotto il 10% per definizione, quindi formalmente non scatta l’obbligo). Se ne erediti €15.000 (15%), devi versare almeno €10.000 (per garantire il 10%) o tutta la somma? L’interpretazione logica è: devi mettere a disposizione l’intera utilità al netto di quanto ti serve per esigenze di vita dignitosa. Non c’è ancora casistica, ma prudentemente conviene destinare il massimo possibile ai vecchi creditori entro i 4 anni, se hai un guadagno imprevisto. Passati i 4 anni, quel che ricevi è tutto tuo e i creditori non hanno più alcun diritto. Quindi, tornando alla domanda: se erediti entro 4 anni, informa subito il Gestore nominato, calcola quanto di quell’eredità eccede il tuo minimo vitale e predisponi i pagamenti pro-quota ai creditori fino a quell’importo. Così rispetti la legge ed eviti di incorrere in possibili revoche del beneficio.
D18: Come incide l’esdebitazione sul garante o coobbligato del mio debito?
R: Non li libera. Il coobbligato (es. un condebitore solidale, un socio illimitatamente responsabile non fallito) e il fideiussore restano tenuti a pagare il debito per intero. L’esdebitazione opera solo a favore del debitore ammesso. Dunque, se tuo padre aveva garantito un tuo prestito e tu ottieni l’esdebitazione, la banca potrà rivolgersi a tuo padre e pretendere il pagamento integrale da lui. Viceversa, se sei tu il garante di un debito altrui e sei stato esdebitato, il creditore principale potrà ancora chiedere al debitore principale (ovviamente) e se quello non paga, forse potrà insinuare il debito nel tuo fallimento? Questo caso confonde un po’ il ruolo, ma in sostanza la garanzia resta valida e il creditore la può escutere. Insomma: l’esdebitazione non si estende ai rapporti di garanzia. Quindi spesso i garanti cercano di coordinarsi: se un imprenditore fallisce e viene esdebitato, ma la moglie aveva garantito, la moglie può essere una debitrice sovraindebitata e accedere a sua volta a procedura (magari familiare con il marito) per liberarsi.
In conclusione, i creditori insoddisfatti possono rivalersi su terzi garanti, ma non più sul debitore esdebitato.
D19: L’esdebitazione può essere revocata una volta concessa?
R: Nel sistema ante-CCII, non era espressamente prevista la revoca, ma la giurisprudenza l’ammetteva in caso di frodi scoperte postume. Con il CCII, rimane possibile in alcuni frangenti. Ad esempio, per l’esdebitazione incapiente è esplicitamente concepibile la revoca se il debitore non rispetta gli obblighi (ad esempio, nasconde utilità rilevanti arrivate entro i 4 anni, oppure emergono atti in frode non rilevati prima). In generale, i decreti di esdebitazione sono reclamabili per 30 giorni; dopo, diventano definitivi come giudicato. Potrebbe però succedere che dopo i 30 gg emergano fatti gravissimi di dolo del debitore ignoti prima. In teoria il creditore truffato potrebbe tentare un’azione di revoca per dolo (un’opposizione in revocazione atipica) entro certi limiti. Non c’è una norma diretta nel CCII salvo per l’incapiente (dove c’è vigilanza 4 anni e quindi possibilità di revoca se sopraggiungono utilità e non vengono pagate). In pratica: se bari e poi vieni scoperto, rischi azioni per far cadere l’esdebitazione anche oltre i termini normali, magari tramite l’art.395 c.p.c. (revocazione per dolo del vincitore, assimilando il decreto a una sentenza). Non sono ancora visti casi noti, ma il buon senso suggerisce: considera l’esdebitazione come una opportunità da non mettere in pericolo; una volta ottenuta, comportati correttamente. La revoca è ipotesi eccezionale, ma possibile. Ad esempio, tribunale di Milano anni fa revocò un’esdebitazione concessa perché emerse che il fallito aveva nascosto centinaia di migliaia di euro all’estero: quell’esdebitazione fu annullata dallo stesso giudice su istanza di un creditore, e giustamente.
D20: In cosa differiscono l’esdebitazione e il piano del consumatore/accordo?
R: Sono strumenti diversi dello stesso menu: – Nel piano del consumatore o accordo di composizione (che ora nel CCII si chiamano ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) il debitore propone ai creditori un pagamento parziale e, se approvato/omologato, ottiene l’esdebitazione contrattualmente o giudizialmente in forza del piano stesso. Cioè i creditori acconsentono a stralciare la quota non pagata. In quel caso non serve successivamente un decreto ex art.280: è intrinseco all’omologa del piano che il debitore, adempiuto ciò che ha promesso, è libero dal resto. – L’esdebitazione di cui trattiamo qui invece interviene dopo una liquidazione (giudiziale o controllata) in cui il debitore ha messo a disposizione tutto quello che aveva e tuttavia i creditori non sono stati pagati integralmente. Non c’è un accordo con i creditori, è un provvedimento unilaterale del giudice che libera il debitore. In breve: piani/accordi = soluzione concorsuale con pagamento parziale concordato, esdebitazione = stralcio finale non concordato ma stabilito per legge. Dal punto di vista del risultato finale (niente debiti), sono analoghi; differiscono per il percorso (col piano eviti di liquidare tutto e soddisfi parzialmente i creditori, con esdebitazione liquidi tutto il possibile e poi chiedi la cancellazione del resto). Un consumatore in difficoltà dovrebbe prima valutare se può offrire un piano (magari paga 20% e salva la casa) oppure se è il caso di andare direttamente in liquidazione più esdebitazione. Ogni caso è a sé.
Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche
Giunti a questo punto, proponiamo un ultimo riepilogo tabellare dei punti chiave e alcuni esempi concreti per fissare le idee.
Tabella riepilogativa dei requisiti di meritevolezza e debiti esclusi
| Requisiti di meritevolezza (art. 280 CCII) | Significato pratico | Verifica |
|---|---|---|
| Nessuna condanna per bancarotta fraudolenta o gravi reati fallimentari (a meno di riabilitazione) | Il debitore non deve avere precedenti penali di natura concorsuale (frodi ai creditori, reati societari collegati al dissesto). | Certificato penale privo di condanne rilevanti (o eventuale atto di riabilitazione). Se procedimento in corso, attesa esito. |
| Nessun atto doloso di frode o grave negligenza nell’indebitamento (no distrazioni, no passività fittizie, no aggravamento volontario, no abuso del credito) | Il debitore non ha nascosto beni, né creato debiti falsi o sperperato patrimonio consapevolmente dopo essersi indebitato. Non ha fatto nuovo debito in modo irragionevole. | Relazione del curatore/Gestore evidenzia che la crisi è dovuta a cause oggettive o errori scusabili, senza comportamenti fraudolenti. (Eventuali atti in frode emergono dalla relazione ex art.49 L.Fall o art.332 CCII). |
| Piena collaborazione e trasparenza nella procedura concorsuale | Il debitore ha consegnato tutti i documenti, ha dichiarato tutti i creditori, non ha ostacolato vendite o riparti, si è presentato alle convocazioni. | Parere del curatore/gestore positivamente attestante la collaborazione (o almeno assenza di ostacoli). Nessun provvedimento di censura del giudice delegato durante la procedura. |
| Non già beneficiato di esdebitazione negli ultimi 5 anni | Non deve aver ottenuto un fresh start recentemente. Evita abusi di cicli ravvicinati. | Verifica anagrafica e atti precedenti: visura fallimentare storica, attestato che non risulta altra esdebitazione da registro imprese negli ultimi 5 anni. (In caso dubbio, dichiarazione del debitore e controlli incrociati). |
| Non beneficiato di esdebitazione più di due volte in totale | Massimo due opportunità nella vita. | Idem come sopra: se risultano già due provvedimenti in passato, il terzo ricorso verrà dichiarato inammissibile. |
| (Per incapiente:) non soggetto a liquidazione giudiziale/coatta; mai utilizzato prima esdebitazione incapiente | Il debitore incapiente deve rientrare tra i sovraindebitati (consumatore o piccolo imprenditore), e non aver già fatto la procedura incapienti. | Verifica soggettiva (codice Ateco, dimensioni impresa, etc.); dichiarazione del debitore di non aver mai chiesto prima esdebitazione art.283. |
I debiti che restano esclusi dall’esdebitazione (non scaricabili) sono: – Debiti per obblighi di mantenimento e alimentari verso persone (es: assegni familiari, alimenti ex art.433 c.c.). – Debiti per risarcimenti danni extracontrattuali (es: risarcimento per incidente stradale, per lesioni personali, ecc.). – Sanzioni pecuniarie penali o amministrative non accessorie (es: multa penale, contravvenzione stradale, sanzione amministrativa per abuso edilizio). (Tutto il resto è esdebitabile, incluse imposte, contributi, debiti bancari, fornitori, ecc.)
Simulazioni pratiche
Caso 1: Fallimento di un piccolo imprenditore e fresh start riuscito
Luigi era titolare di una piccola impresa edile (ditta individuale). Nel 2021, a causa di mancati pagamenti e crisi, accumula €300.000 di debiti (banche, fornitori, Fisco) e viene dichiarato fallito. Il curatore liquida i suoi beni (cantiere, attrezzature, un magazzino): si ricavano €120.000, con cui si pagano in parte i creditori privilegiati e si distribuisce un 20% ai chirografari. Luigi collabora pienamente col curatore, fornisce tutti i documenti contabili e non ha alcuna accusa di bancarotta. Nel 2024 (a 3 anni dall’apertura) il fallimento è ancora tecnicamente aperto per una causa attiva, ma Luigi, tramite il suo avvocato, presenta domanda di esdebitazione. Il tribunale la accoglie verificando la meritevolezza e dichiara inesigibili i debiti residui (€240.000 rimasti). I creditori insoddisfatti vengono avvisati: nessuno reclama (sanno che Luigi si è comportato bene ed era sfortunato). Luigi viene così liberato dai suoi debiti. Qualche mese dopo, la causa attiva del fallimento produce altri €30.000: il curatore li distribuisce ai creditori (che in totale arrivano ad aver recuperato il 30%). L’esdebitazione di Luigi copre il restante 70%. Ora Luigi può ripartire: nel 2025 apre una nuova piccola attività come dipendente o micro-imprenditore artigiano. Pur essendo stato fallito, non ha più debiti al collo e potrà concentrarsi sul futuro. Uno dei suoi creditori era l’Agenzia delle Entrate per €50.000 di IVA: questa somma è stata tagliata, l’Agenzia non può più pretenderla. Un fornitore distratto, non insinuatosi a fallimento per €5.000, prova a chiamarlo per saldare: Luigi gli invia copia del decreto di esdebitazione e il fornitore, consultatosi con il legale, rinuncia sapendo di non avere titolo.
Caso 2: Sovraindebitamento di una famiglia, liquidazione controllata ed esdebitazione
Marco e Silvia, marito e moglie, accumulano €100.000 di debiti personali: prestiti per acquisto mobili, finanziamenti per l’auto, bollette arretrate e carte di credito revolving. Entrambi hanno perso il lavoro per la pandemia e non riescono più a pagare. Nel 2023 attivano una procedura familiare di sovraindebitamento (concordato minore familiare). Proverebbero un accordo, ma i creditori rifiutano concessioni perché non hanno alcun reddito da offrire. Dunque optano per la liquidazione controllata dei loro (pochi) beni: vendono l’auto (€8.000) e quel poco risparmio (€2.000). Si racimolano €10.000, con cui pagano prima qualche spesa procedurale e il resto (circa €8.000) viene distribuito ai creditori (che ricevono circa l’8% dei loro crediti). Rimangono insoddisfatti ~€92.000 di debiti. Marco e Silvia hanno cooperato pienamente con l’OCC, non hanno nascosto nulla e la loro situazione è dovuta a cause indipendenti (disoccupazione). Nel 2024, chiusa la liquidazione controllata, chiedono congiuntamente l’esdebitazione. Il Tribunale valuta che siano meritevoli: nessun atto in frode, hanno tentato accordo, hanno liquidato tutto ciò che avevano (seppur poco). Nonostante i creditori abbiano preso solo l’8%, concede l’esdebitazione (nel CCII non c’è soglia minima). Così tutti i debiti residui dei coniugi vengono cancellati. Restano però da pagare, ad esempio, €5.000 di assegni di mantenimento che Marco deve all’ex moglie per un figlio avuto da un precedente matrimonio: quelli non rientravano nell’esdebitazione e lui dovrà regolarizzare a parte (magari a rate). Tutti gli altri creditori (banche, finanziarie, bollette) invece non potranno più chiedere nulla. Nel 2025 Silvia trova un nuovo lavoro come commessa; grazie all’esdebitazione, il suo stipendio è salvo da qualsiasi pignoramento dei vecchi creditori. La coppia può guardare avanti. Un creditore, una finanziaria, li contatta minacciando azioni legali per recuperare: il loro avvocato risponde con il decreto di esdebitazione e quella chiude subito il sollecito.
Caso 3: Debitore incapiente, nessun bene da liquidare, esdebitazione a costo zero
Giulia è una donna di 45 anni, divorziata, con 2 figli a carico. Ha perso il lavoro e si è mantenuta per un periodo usando la carta di credito e prestiti vari, accumulando €60.000 di debiti. Ora vive in un alloggio in affitto, non possiede immobili né auto, e il suo saldo in banca è pressoché nullo. È quindi tecnicamente nullatenente. Trova un impiego saltuario come collaboratrice domestica con reddito esiguo (quanto basta per sopravvivere a malapena). Si rivolge a un OCC nel 2022 per vedere se può fare qualcosa riguardo i debiti (riceve continue chiamate dai recupero crediti). L’OCC constata che Giulia non ha alcuna risorsa da offrire ai creditori nemmeno con un piano dilazionato – il suo reddito basta appena per affitto e spese vive. Sarebbe un tipico caso di procedura incapiente art.283 CCII. Viene predisposto un ricorso per esdebitazione del debitore incapiente in tribunale. Nel ricorso si evidenzia che Giulia è sovraindebitata per circostanze sfortunate (divorzio, perdita lavoro), senza dolo o spese pazze, e che non possiede beni né prevede entrate future significative. Nel 2023 il Tribunale accoglie l’istanza: con decreto concede a Giulia l’esdebitazione immediata di tutti i suoi debiti . Viene nominato un Gestore per monitorare eventuali sviluppi per 4 anni, e i creditori vengono informati che i loro crediti sono inesigibili salvo possibili pagamenti se Giulia avrà fortuna nei prossimi anni. Giulia ora è libera dai debiti: le finanziarie chiudono le pratiche a suo nome come sofferenze irrecuperabili. Nel frattempo, Giulia può cercare un lavoro senza temere che le pignorino lo stipendio. Dopo due anni, nel 2025, Giulia riesce a ottenere un impiego stabile da €1.200 al mese. Questa entrata, pur superiore a prima, non è tale da far scattare l’obbligo (copre appena le sue esigenze di madre con due figli). Infatti 1.200€/mese per 2 anni fanno circa €28.000 lordi, ma considerato il mantenimento figli e spese, l’OCC valuterebbe che non vi sono “utilità eccedenti percepibili” da dare ai creditori. Giulia quindi non paga nulla ai vecchi creditori, e trascorsi i 4 anni (2027), l’esdebitazione diviene definitiva. I creditori originari hanno dovuto incassare la perdita totale (0%), però sapevano dall’inizio che Giulia era incapiente. Uno dei creditori (una banca) inizialmente era scettico e ha fatto reclamo, sostenendo che Giulia avrebbe potuto trovare lavoro e quindi doveva fare un piano. La Corte d’Appello tuttavia ha confermato che la legge consente il fresh start immediato e che l’ipotetica futura occupazione non era certa al momento (in effetti è arrivata due anni dopo). Giulia quindi ha mantenuto il beneficio. Ora può proseguire la sua vita lavorativa e crescere i figli, sperando magari in un reddito migliore: se anche diventasse benestante fra qualche anno, i creditori di prima non potrebbero più nulla (dopo il quadriennio di legge).
Caso 4: Imprenditore con casa ipotecata, fallimento ed esdebitazione – sorte dell’immobile
Angelo è un commerciante che fallisce nel 2019 con debiti per €500.000. Tra i beni ha una casa di proprietà su cui grava un’ipoteca della banca per il mutuo residuo (€200.000). Durante il fallimento, la casa viene messa più volte all’asta ma non trova acquirenti (il mercato immobiliare è stagnante e il prezzo base coprirebbe a malapena il mutuo). Dopo 3 anni, nel 2022, il fallimento viene chiuso per insufficienza dell’attivo liquidabile residuo (il curatore vende tutto il resto ma per la casa chiede al giudice la chiusura lasciandola ad Angelo, perché venderla sotto mutuo non conviene a nessuno). Angelo chiede e ottiene l’esdebitazione dei debiti residui (€400.000) nel 2022. Quindi viene liberato dai debiti, tranne quelli esclusi. La banca ipotecaria però conserva il suo diritto sulla casa: nel 2023, poiché Angelo non paga più le rate del mutuo (non riusciva durante il fallimento e continua a non riuscire), la banca promuove un’esecuzione immobiliare sull’immobile. Angelo obietta: “Ma io sono stato esdebitato, non devo più nulla!” Purtroppo l’ipoteca attaccata alla casa non è stata rimossa, perché la banca non è stata soddisfatta in fallimento né ha rinunciato al credito. L’esdebitazione impedisce alla banca di agire contro Angelo per differenza, ma consente ancora di espropriare la casa in virtù dell’ipoteca. Quindi, nel 2024 la casa viene venduta all’asta a €180.000: la banca prende il ricavato e si considera chiusa la posizione (il residuo mutuo era €200k, incassa €180k, rimarrebbero €20k scoperti, ma non può chiedere ad Angelo quest’ultima parte perché quel credito è stato esdebitato). Angelo, insomma, ha perso la casa comunque. Se invece Angelo avesse miracolosamente ripreso a pagare le rate dopo il fallimento, avrebbe potuto tenere la casa, ma logicamente se non pagava durante la procedura difficilmente poteva dopo. Quindi la regola confermata: l’esdebitazione libera Angelo dal debito verso banca, ma non cancella l’ipoteca sulla casa, ed è grazie a questa che la banca alla fine recupera quasi tutto. Angelo rimane comunque senza dover pagare oltre (quei €20k restanti la banca li deve mandare a perdita, non li può pretendere). Tutti gli altri debiti di Angelo (fornitori, fisco, ecc.) erano già stati cancellati dall’esdebitazione, e non avendo garanzie reali, non ottengono nulla. Angelo ha perso l’immobile, ma ha avuto la chance di ripartire senza debiti (difatti, venduta la casa e chiusa la faccenda, può anche un domani comprare un altro immobile se la sua situazione migliora, nessuno potrà rifarsi su quel futuro bene per i debiti vecchi).
Come si evince dagli esempi, l’esdebitazione è uno strumento potente: a fronte della liquidazione di tutto il patrimonio disponibile (o, nel caso incapiente, a fronte di una situazione tragica di insolvenza totale), consente di spezzare le catene dei debiti e riavere un futuro finanziario. Le simulazioni mostrano anche i limiti (garanzie reali che rimangono in gioco, obblighi familiari intoccabili) e l’importanza di soddisfare i requisiti di onestà.
Conclusioni
L’esdebitazione per gli ex imprenditori (e in generale per le persone sovraindebitate) è oggi, nel 2025, una realtà consolidata e sempre più accessibile. La legislazione italiana aggiornata ha reso questo istituto più rapido, certo e inclusivo rispetto al passato: si può ottenere entro 3 anni, non serve più dimostrare di aver pagato una parte significativa ai creditori , ed esiste perfino la possibilità di un fresh start immediato per chi non possiede nulla . Questo rappresenta un deciso passo avanti verso una concezione moderna della crisi d’impresa e del sovraindebitamento, in linea con le direttive europee sul second chance.
Dal punto di vista del debitore, l’esdebitazione va vista come un’opportunità preziosa ma da conquistare con atteggiamento proattivo e corretto. Il debitore deve: – Affrontare la procedura concorsuale con trasparenza e collaborazione, senza nascondere nulla o tentare scorciatoie illecite. Ogni comportamento fraudolento non solo precluderebbe l’esdebitazione, ma potrebbe portare a conseguenze penali. – Avere pazienza per il tempo necessario (3 anni al massimo, spesso anche meno) e rispettare le regole e i tempi del tribunale. – Comprendere che l’esdebitazione cancella i debiti, ma non i sacrifici: se ci sono beni ipotecati, li perderà probabilmente; se ci sono garanti terzi, potrebbero dover pagare; se c’è da liquidare tutto, dovrà accettarlo. È uno scambio: la “fresh start” in cambio della resa totale dei beni e della buona condotta. – Evitare di indebitarsi nuovamente durante il periodo concorsuale o immediatamente dopo. L’esdebitazione non deve essere considerata un “bancomat” per alleggerirsi ciclicamente dai debiti, ma un evento straordinario da usare responsabilmente. Una volta ottenuta, il debitore ha l’onere morale e pratico di gestire meglio la propria vita economica per non ricadere in insolvibilità (anche perché la legge lo perdonerebbe al massimo un’altra volta). – Farsi assistere da professionisti competenti: le procedure concorsuali e le istanze vanno seguite con attenzione legale. Un buon avvocato fallimentare e (nel sovraindebitamento) un OCC preparato possono fare la differenza tra un iter agevole e uno complicato.
Dal punto di vista dei creditori, l’esdebitazione è certamente un sacrificio – vedono sfumare per sempre parte del loro credito – ma fa parte del patto sociale di un’economia avanzata: si preferisce rimettere in circolo una persona liberata dai debiti, capace di produrre reddito e magari onorare nuove obbligazioni, piuttosto che tenerla oppressa e inattiva in una situazione di indebitamento perpetuo (che giova poco anche ai creditori stessi, i quali non recupererebbero comunque granché da un debitore impoverito). Le sentenze più recenti hanno anche rassicurato i creditori che il beneficio non è concesso con leggerezza: solo ai debitori meritevoli, non a chi li ha truffati . Inoltre, per alcune categorie di crediti (alimentari, risarcitori e punitivi) la tutela rimane: quell’obbligazione non svanisce, a riconoscimento del particolare interesse pubblico sottostante.
In conclusione, l’esdebitazione si conferma uno strumento indispensabile per dare efficacia alla funzione “sociale” del fallimento: non punire oltre misura l’insuccesso economico, ma fornire un percorso di rientro nella vita produttiva al debitore onesto. Ex imprenditori che hanno visto fallire la propria attività, ma che non hanno commesso illeciti, possono oggi trovare nell’esdebitazione un autentico “nuovo inizio” – la possibilità di rialzarsi, imparare dagli errori e forse tornare a creare valore senza l’ombra dei debiti passati. E la collettività, da questo meccanismo, trae vantaggio in termini di inclusione finanziaria, riduzione dell’economia sommersa (i debitori esdebitati tornano in bonis e non hanno più incentivo a lavorare in nero) e incoraggiamento dell’imprenditorialità (il rischio d’impresa è mitigato dalla chance di ripartenza).
Come avvocati e professionisti, è nostro compito informare i debitori in difficoltà di questa opportunità, guidarli attraverso il percorso rispettando i requisiti di legge, e al tempo stesso rassicurare i creditori che il sistema ha bilanci e controlli. L’esdebitazione “fatta bene” – come abbiamo illustrato – è quella preparata con cura, supportata da documentazione trasparente, e inserita tempestivamente nel contesto giusto (fallimento, sovraindebitamento o incapienza a seconda dei casi).
Aggiornata alle ultime riforme (settembre 2025) e pronunce giurisprudenziali, questa guida ambisce ad essere uno strumento utile per orientarsi nell’iter, evitando errori e fraintendimenti. In un’epoca in cui le crisi d’impresa e le difficoltà finanziarie personali sono purtroppo frequenti, conoscere e saper applicare l’esdebitazione è fondamentale per offrire ai nostri assistiti (siano essi debitori o creditori) le migliori soluzioni nel quadro normativo vigente.
In definitiva, l’esdebitazione non è un colpo di spugna regalato, ma un processo di responsabilità e di riscatto. Se perseguito con serietà e buona fede, permette davvero di “farlo bene”: chiudere col passato e costruire, su basi più solide, il futuro.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14) – Articoli rilevanti: 278 (Oggetto e ambito di applicazione dell’esdebitazione), 279 (Condizioni temporali di accesso), 280 (Condizioni per l’esdebitazione), 281 (Procedimento – esdebitazione nella liquidazione giudiziale), 282 (Condizioni e procedimento – liquidazione controllata), 283 (Esdebitazione del sovraindebitato incapiente). Aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024. (Norme citate nel testo ecc.)
- Relazione Illustrativa al Codice della Crisi – Sezioni relative all’istituto dell’esdebitazione e al recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 sul second chance. Evidenzia la finalità di incoraggiare il fresh start dell’imprenditore onesto. (Riferimento: richiamata dai giudici ad es. in Trib. Oristano 29/7/2024).
- Direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency Directive) – Articoli 20-24 sul discharge degli imprenditori. Impone agli Stati membri di garantire l’esdebitazione completa entro 3 anni e di rimuovere ostacoli eccessivi (come soglie di pagamento) .
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – Articoli 142-144 (esdebitazione del fallito, procedura e riabilitazione) – Abrogate dal 15/07/2022, ma tuttora applicabili ai fallimenti pendenti iniziati prima di quella data. (Citate nel confronto giurisprudenziale: ex art.142 L.F. cause ostative ).
- Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento – (Abrogata e confluita nel CCII) – Rilevante per la genesi dell’esdebitazione incapiente (art.14-quaterdecies introdotto da L.176/2020), poi trasfusa in art.283 CCII.
- Cassazione Civile, Sez. I, 31/05/2023 n.15359 – “Esdebitazione: tassatività dei presupposti di meritevolezza e criterio di valutazione del soddisfacimento dei creditori”. Conferma che le cause ostative ex art.142 L.F. (ora art.280 CCII) sono tassative e vanno interpretate restrittivamente in luce della Direttiva UE, affermando che – se altri requisiti sussistono – il beneficio va concesso anche in caso di soddisfacimento parziale minimo (non “affatto irrisorio”) . (Massima ufficiale e motivazione citata).
- Cassazione Civile, Sez. I, 02/07/2025 n.14835 (ord.) – “Disciplina applicabile all’esdebitazione nel fallimento ante CCII”. Stabilisce che per i fallimenti iniziati prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi si applica la legge fallimentare, compresa la disciplina dell’esdebitazione, escludendo l’applicazione retroattiva delle norme del CCII. (Viene risolta questione intertemporale; citato testualmente).
- Tribunale di Oristano, decreto 29/07/2024 – Concessione di esdebitazione a costo zero ex art.283 CCII. Caso concreto di debitore incapiente sovraindebitato: la decisione analizza ratio e requisiti, enfatizzando la natura eccezionale e finalità di fresh start dell’istituto. (Nota di Veronica Loi in Diritto del Risparmio con estratti: definizione di incapiente e condizione del 10% sopravvenienze ).
- Tribunale di Pordenone, 21/04/2023 – Competenza monocratica per esdebitazione incapiente. Ha stabilito che l’esdebitazione ex art.283 CCII è decisa dal giudice monocratico e non dal collegio, differenziandola dalle procedure concorsuali classiche . (Conforme al fatto che il reclamo va in Corte d’Appello e non in Tribunale collegiale).
- Cassazione Civile, Sez. VI, 30/10/2014 n.23129 – “Le obbligazioni tributarie non sono escluse dall’esdebitazione”. Ordinanza interlocutoria poi confermata nel merito: chiarisce che i debiti fiscali rientrano nell’esdebitazione, non essendo previsti tra le esclusioni di legge. (Cita art.142 L.F. co.3 e respinge tesi contraria dell’Erario; passo citato).
- Cass. Civ. SS.UU. 18/11/2011 n.24214 – (precedente storico) Affermò l’ammissibilità dell’esdebitazione del socio illimitatamente responsabile e sancì la natura premiale dell’istituto. (Richiamata in massimario unijuris collegato a Cass.2023).
- Direttiva (UE) 2019/1023 – Considerando 74 e art.23 – (citate indirettamente) Riconoscono la necessità di rimuovere la condizione di un pagamento minimo ai creditori per concedere l’esdebitazione, per facilitare il secondo tentativo imprenditoriale .
Hai chiuso la tua impresa o ditta individuale, ma ti sono rimasti debiti con banche, fornitori o Agenzia delle Entrate che non riesci più a gestire? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai chiuso la tua impresa o ditta individuale, ma ti sono rimasti debiti con banche, fornitori o Agenzia delle Entrate che non riesci più a gestire?
Temi pignoramenti, segnalazioni o richieste di pagamento anche dopo la cessazione dell’attività?
👉 Buone notizie: la legge oggi consente anche agli ex imprenditori di cancellare o ridurre legalmente i propri debiti, inclusi quelli fiscali e bancari, attraverso le procedure di esdebitazione previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
In questa guida aggiornata scoprirai come funziona, chi può accedervi, quali documenti servono e quali risultati concreti puoi ottenere.
⚖️ Cos’è l’esdebitazione per ex imprenditori
L’esdebitazione è una procedura che consente di liberarsi dai debiti residui contratti durante l’attività, dopo la chiusura della stessa, quando non si hanno più le risorse per pagarli.
È rivolta a chi ha agito in buona fede, ma è rimasto sommerso dai debiti per motivi economici, errori di gestione o crisi di mercato.
In pratica, dopo il controllo del Tribunale e la verifica di meritevolezza, il debitore viene liberato da ogni obbligazione residua, potendo ripartire da zero.
👥 Chi può accedere all’esdebitazione
- Ex imprenditori individuali che hanno cessato l’attività.
- Piccole imprese non soggette a liquidazione giudiziale (ex fallimento).
- Soci di società di persone (SNC, SAS) rimasti con debiti personali.
- Liberi professionisti o autonomi con debiti fiscali e bancari.
- Ex amministratori o garanti che hanno sottoscritto fideiussioni aziendali.
📌 Attenzione: non serve avere ancora la partita IVA.
Anzi, la procedura è pensata proprio per chi ha chiuso o cessato l’attività e vuole chiudere anche con i debiti.
🧾 Debiti che possono essere cancellati
✅ Debiti ammessi all’esdebitazione:
- Debiti fiscali (IRPEF, IVA, IRAP, addizionali, multe).
- Debiti contributivi INPS e INAIL.
- Debiti bancari, fidi, leasing e finanziamenti.
- Debiti verso fornitori o clienti.
- Cartelle esattoriali e accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.
❌ Debiti esclusi (non cancellabili):
- Obblighi di mantenimento familiare.
- Sanzioni penali o amministrative non tributarie.
- Debiti derivanti da condotte dolose o fraudolente.
🧠 Requisiti fondamentali per ottenere l’esdebitazione
- Cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA o della società).
- Stato di sovraindebitamento: non riesci a pagare integralmente i tuoi debiti.
- Meritevolezza: non hai causato il debito con dolo, frode o spese eccessive.
- Trasparenza totale: devi presentare al Tribunale una situazione economica completa e veritiera.
- Collaborazione con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che redige la relazione ufficiale.
🧩 Le principali procedure disponibili
💠 Concordato minore
Ideale per ex imprenditori e professionisti: si propone ai creditori un piano di rientro sostenibile o una somma unica, con voto favorevole della maggioranza e omologa del Tribunale.
💠 Liquidazione controllata
Consente di mettere a disposizione beni residui (es. veicoli, quote, risparmi) per soddisfare parzialmente i creditori; il residuo viene cancellato con l’esdebitazione finale.
💠 Esdebitazione del debitore incapiente
Riservata a chi non ha più nulla da offrire ai creditori: se il giudice riconosce la buona fede, i debiti vengono cancellati integralmente, una sola volta nella vita.
🏛️ Come funziona passo dopo passo
- Analisi preliminare con un avvocato esperto in sovraindebitamento.
- Nomina dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), che raccoglie documenti e redige una relazione completa.
- Deposito del ricorso presso il Tribunale con proposta di piano o liquidazione.
- Blocco immediato di pignoramenti, fermi e azioni esecutive.
- Udienza di omologazione: il giudice valuta la meritevolezza e approva il piano.
- Esecuzione del piano (rate, cessione beni, saldo e stralcio).
- Esdebitazione definitiva: cancellazione di tutti i debiti residui.
📋 Documenti richiesti
- Documento d’identità e codice fiscale.
- Certificato di chiusura della partita IVA o visura camerale.
- Dichiarazioni dei redditi (ultimi 3 anni).
- Estratti conto bancari e carte di credito.
- Elenco completo dei debiti (banche, Fisco, fornitori).
- Contratti di prestito o leasing.
- Bilancio o contabilità semplificata (se disponibile).
- Stato di famiglia, canoni di locazione, bollette, spese familiari.
⏱️ Tempi e risultati
- Preparazione e deposito del piano: 2–4 mesi.
- Approvazione e blocco delle azioni esecutive: da subito con il deposito.
- Omologazione del Tribunale: 3–8 mesi medi.
- Durata complessiva: da 1 a 5 anni (a seconda del piano).
🎯 Risultato finale: cancellazione totale o parziale dei debiti fiscali, bancari e commerciali, con possibilità di ripartire pulito.
⚖️ I vantaggi principali
✅ Blocco immediato dei pignoramenti e delle azioni giudiziarie.
✅ Riduzione drastica dei debiti fiscali e bancari.
✅ Tutela dei beni personali e familiari.
✅ Cancellazione del residuo al termine del piano.
✅ Ripartenza economica e reputazionale.
🚫 Errori da evitare
- Tentare accordi privati non ufficiali con le banche o i fornitori.
- Nascondere beni o conti: compromette la meritevolezza.
- Presentare piani irrealistici o non sostenuti da prove.
- Ignorare atti giudiziari: può rendere impossibile accedere alla procedura.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione debitoria e individua la procedura più adatta.
📌 Coordina la raccolta documentale con l’OCC e redige il piano di ristrutturazione.
✍️ Predispone e deposita il ricorso per misure protettive e omologazione.
⚖️ Ti rappresenta in Tribunale e nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e le banche.
🔁 Ti assiste fino all’esdebitazione definitiva e al reinserimento economico.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e sovraindebitamento.
✔️ Professionista specializzato nella difesa di ex imprenditori e lavoratori autonomi con debiti residui.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
L’esdebitazione per ex imprenditori è oggi la soluzione più efficace per chiudere definitivamente con i debiti e ripartire con serenità.
Con una procedura trasparente, legale e guidata da professionisti, puoi bloccare pignoramenti, ridurre le somme dovute e ottenere la cancellazione completa del residuo.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua nuova vita senza debiti inizia qui.