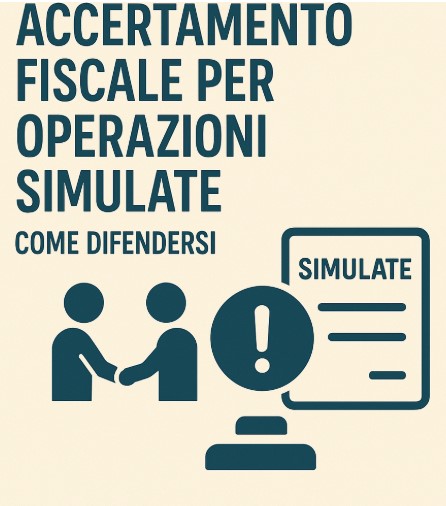Hai ricevuto un accertamento fiscale per presunte operazioni simulate o inesistenti?
Si tratta di una delle contestazioni più severe in materia tributaria, perché l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza ritengono che le operazioni economiche dichiarate siano solo apparenti, create al solo scopo di ridurre le imposte o ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Queste accuse possono riguardare fatture false, contratti fittizi, vendite simulate o rapporti tra società collegate. Tuttavia, in molti casi, l’Amministrazione si basa su presunzioni e ricostruzioni incomplete, senza prove concrete.
Con una difesa tecnica e ben documentata, è possibile dimostrare la realtà e la liceità delle operazioni, evitando sanzioni sproporzionate e responsabilità penali.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta operazioni simulate
– Se riscontra fatture emesse o ricevute per operazioni inesistenti o parzialmente fittizie
– Se i contratti o le transazioni non hanno avuto reale esecuzione economica o commerciale
– Se i pagamenti sono ritenuti circolari o non giustificati da documenti contabili
– Se le società coinvolte hanno legami familiari, societari o gestionali tali da far sospettare un’operazione fittizia
– Se l’Agenzia sostiene che l’operazione è stata effettuata solo per ottenere un vantaggio fiscale (es. detrazioni IVA o costi deducibili)
– Se emergono discrepanze tra le fatture e le effettive consegne o prestazioni
Conseguenze dell’accertamento per operazioni simulate
– Recupero dell’imposta evasa (IVA, IRPEF, IRES, IRAP)
– Sanzioni amministrative fino al 240% delle somme accertate
– Indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’IVA collegata alle fatture contestate
– Interessi di mora e iscrizione a ruolo immediata delle somme dovute
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione fraudolenta o utilizzo di fatture false (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000)
– Sequestri e confische per equivalente sui beni aziendali e personali
Come difendersi da un accertamento per operazioni simulate
– Dimostrare la reale esistenza economica dell’operazione, producendo contratti, fatture, ordini, bolle di consegna, bonifici e corrispondenza commerciale
– Produrre prove materiali e testimonianze che confermino la prestazione o la fornitura contestata
– Dimostrare la congruità dei prezzi e la tracciabilità dei pagamenti
– Contestare presunzioni arbitrarie o mancanza di riscontri oggettivi nell’accertamento
– Evidenziare vizi di motivazione o di contraddittorio: l’Agenzia deve spiegare con chiarezza perché ritiene l’operazione simulata
– Se è coinvolta un’altra società o professionista, dimostrare la propria estraneità e l’assenza di dolo
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, chiedendo anche la sospensione della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa contro l’accertamento
– Analizzare la legittimità e la struttura probatoria dell’accertamento
– Verificare se le prove dell’Amministrazione dimostrano realmente l’inesistenza dell’operazione
– Coordinare la difesa tributaria e penale, quando vi sono profili di reato tributario
– Redigere un ricorso motivato e documentato, fondato su giurisprudenza aggiornata e principi di diritto
– Difendere il contribuente nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e davanti ai giudici tributari
– Tutelare l’impresa e i suoi rappresentanti da sanzioni penali, sequestri e danni reputazionali
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La restituzione dell’IVA e dei costi riconosciuti come effettivi
– La riduzione o cancellazione delle sanzioni e degli interessi
– La revoca delle misure cautelari o dei sequestri disposti
– La piena tutela della tua attività economica e del patrimonio personale
⚠️ Attenzione: un’accusa di operazioni simulate non equivale automaticamente a una frode.
Molti accertamenti vengono emessi su presunzioni generiche o basati su errori di valutazione economica, senza considerare la realtà operativa dell’impresa.
È fondamentale agire subito, con l’assistenza di un avvocato tributarista e penalista esperto, per dimostrare la genuinità delle operazioni e neutralizzare le accuse.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa nei procedimenti per operazioni inesistenti – spiega come difendersi da un accertamento fiscale per operazioni simulate, quali vizi far valere e come ottenere l’annullamento della pretesa.
👉 Hai ricevuto un accertamento per presunte operazioni simulate o fatture inesistenti?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia di difesa efficace per proteggere la tua impresa, il tuo patrimonio e la tua reputazione professionale.
Introduzione
L’accertamento tributario su operazioni simulate è un controllo fiscale che l’Amministrazione finanziaria effettua quando dubita della genuinità di alcune operazioni aziendali o contrattuali. In pratica, il Fisco contesta che le operazioni simulate (cioè formalmente dichiarate ma sostanzialmente fittizie) siano state eseguite solo per ottenere benefici fiscali illeciti. Si tratta di una situazione delicata: da un lato il contribuente rischia la decadenza di vantaggi come deduzioni o crediti d’imposta, dall’altro può essere sottoposto a contestazioni penali (art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000). In questa guida aggiornata (2025) rivolta a privati, professionisti e imprenditori – con un taglio giuridico ma divulgativo – vedremo come definire le operazioni simulate, quali conseguenze fiscali comportano, e soprattutto come difendersi efficacemente (autotutela, reclamo/mediazione, ricorsi, conciliazione, ecc.). Dal punto di vista del debitore, è fondamentale conoscere gli strumenti di tutela e la giurisprudenza più recente, incluse le sentenze delle sezioni tributarie della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE. Illustriamo i principali casi (persone fisiche, società, trust/fondazioni) e includiamo tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche.
Definizioni chiave: simulazione, operazioni inesistenti e elusive
- Operazione simulata: contratto o atto formale posto in essere dalle parti apparendo reale, ma in realtà non voluto per come dichiarato. In base all’art. 1, lett. g‑bis) del D.Lgs. 74/2000 sono considerate simulate le “operazioni apparenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le prestazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti” . Per esempio, una fattura relativa a una vendita di beni inesistenti (o realizzata tra soggetti collegati solo per apparire regolare) è simulata. La simulazione può essere assoluta (l’operazione non è stata affatto realizzata) o relativa (l’operazione reale viene travisata da un contratto formale fittizio) .
- Operazione inesistente: operazione che in alcun modo ha avuto luogo; ad esempio, fatture emesse per prestazioni mai avvenute. Spesso rientra nei reati tributari d’imposta (art. 8 D.Lgs. 74/2000) ed è equiparata a “non effettuata” ai fini IVA (art. 2 DPR 633/1972).
- Operazione elusiva (art. 10‑bis L. 212/2000): operazione formalmente legittima ma priva di sostanza economica, posta in essere solo per ottenere un vantaggio fiscale, senza falsificare la volontà delle parti. Queste “operazioni elusive” non sono penalmente rilevanti (salvo casi di frode) . Per esempio, una cessione di beni tra due parti indipendenti finalizzata esclusivamente a ottenere un’esenzione fiscale può essere evasione/elusione senza ricorrere a contratti simulati. Il legislatore distingue quindi i tre concetti: le operazioni simulate implicano un accordo apparente (art. 1 g-bis D.Lgs. 74/2000) , mentre le elusive (art. 10‑bis L.212/2000) riguardano solo vantaggi fiscali senza nullità intrinseca .
- Abuso del diritto: comportamento che, nel rispetto formale delle leggi tributarie, persegue un vantaggio fiscale contrario allo scopo normativo (art. 10‑bis L.212/2000 e art. 37‑bis DPR 600/1973). È concetto affine all’elusione.
Tabella 1. Differenze tra simulazione, operazioni inesistenti ed elusione
| Caratteristica | Operazioni simulate | Operazioni inesistenti | Operazioni elusive |
|---|---|---|---|
| Definizione (legge) | “operazioni apparenti, poste in essere con volontà di non realizzarle in tutto o in parte” (art.1 g-bis D.Lgs.74/2000) . | Operazioni completamente mai avvenute; «considerate come non effettuate» (art.2 DPR 633/1972). | Operazioni formali ma privi di sostanza economica (art.10-bis L.212/2000) . |
| Esempio | Fittizia vendita di immobile: si stipula contratto ma la vendita non avviene realmente. | Emissione fattura per bene mai consegnato. | Cessione estera inesistente ma usata per eludere IVA (operation di mera finzione senza frode documentale). |
| Rilevanza penale | Configurano reato (dichiarazione fraudolenta art.3 D.Lgs.74/2000 se comprovate) . | Configurano reato di false fatture (art.8 D.Lgs.74/2000). | In sé non penalmente rilevanti (fatta salva frode fiscale) . |
| Effetto fiscale | Il Fisco può ignorare l’atto, ricostruendo la realtà economica effettiva. | L’operazione è tassata come se «non effettuata» (nessun diritto a detrazione IVA; costi non dedotti). | Il Fisco può considerarla abusiva, disapplicando i benefici fiscali ottenuti (vedi art. 2 D.Lgs.74/2000). |
| Onere della prova | L’Amministrazione deve dimostrare la simulazione con prove concrete o presuntive . | Stessi oneri del Fisco sulle false fatture. | Operazioni legittime: il contribuente deve dimostrare la sostanza effettiva per mantenere il beneficio. |
Normativa di riferimento
In Italia le principali norme sul tema sono:
- Costituzione italiana, art. 53 (obbligo contributivo secondo capacità contributiva) e art. 23 (principio di legalità).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA): art. 2 (“operazioni considerate non effettuate”: include quelle inesistenti o simulate, che quindi non danno diritto all’IVA detraibile) e art. 21 (regole di fatturazione).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (TUIR): art. 37, comma 3 (interposizione fittizia: «i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti […] sono imputati al contribuente effettivo possessore per interposta persona» ), art. 39 (spese non documentate o non inerenti escluse da deduzione) e art. 109 (redditi di società controllate).
- D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Accertamento del valore delle quote societarie): definisce criteri per immobili e beni in interposizione.
- D.P.R. 21 dicembre 1986 n. 917 (TUIR): norme generali sul reddito d’impresa e di lavoro, prevede disconoscimento di costi fittizi e includibilità di utili distribuiti camuffati.
- L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente): art. 10-bis introduce l’abuso del diritto nelle operazioni elusive (con distinzione netta da simulazione ).
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74: definisce i reati tributari; in particolare art. 1, lett. g-bis (classificazione operazioni simulate ) e art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate).
- D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (procedura tributaria): regolamenta il contenzioso fiscale (termini di impugnazione: 60 giorni, grado di giudizio, ecc.) e strumenti deflattivi (reclamo amministrativo con mediazione, conciliazione, adesione).
- L. 11/04/2014 n. 162 e L. 27/07/2017 n. 104: hanno introdotto la procedura del reclamo/mediazione tributaria obbligatoria per valore fino a €50.000 e la conciliazione giudiziale presso il giudice tributario (vedi §“Strumenti di difesa”).
- Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985 (ratificata L. 364/1989): disciplina il trust (si veda sezione dedicata).
Oltre alle norme nazionali, rilevanti sono i principi di diritto comunitario: per esempio la Corte di Giustizia UE ha stabilito che non basta dichiarare civilemente simulato un atto per togliere automaticamente il diritto alla detrazione IVA (occorre invece dimostrare il mancato svolgimento effettivo o l’evasione).
Principi giurisprudenziali: onere della prova e competenza tributaria
Onere della prova sulle operazioni simulate. In vari casi la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza di una simulazione, con ogni mezzo probatorio, ivi incluse anche le presunzioni (tuttavia non bastano puri indizi generici). Ad esempio, secondo Cass. 4 giugno 2020 n. 10571: «l’Amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto, … non è dispensata dall’onere della relativa prova, la quale, … può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni» . Analogamente, la Cassazione (sent. 1568/2014) ha annullato un atto se la simulazione era basata solo su asserzioni senza riscontri concreti . In breve: il fisco deve documentare la simulazione (ad es. evidenziando anomalie contabili, testimonianze, attività effettivamente svolte dai soggetti, ecc.); un semplice sospetto o un mero riferimento formale non è sufficiente .
Competenza del giudice tributario. La Corte di Cassazione ha confermato che spetta al giudice tributario decidere anche sulla simulazione, in via incidentale, senza bisogno di un giudizio civile preventivo . In particolare, l’art. 1, c. 3, D.Lgs. 546/1992 (codice del processo tributario) riconosce al giudice fiscale il potere di valutare ogni questione che incida sulla controversia. Così Cass. civile sez. V, ord. 14804/2025 ha affermato che «il giudice tributario ha il potere e il dovere di risolvere, in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione della controversia principale. [Perciò] l’ufficio finanziario può accertare l’esistenza di una simulazione … e spetta poi al giudice tributario, in caso di contestazione, verificarne la fondatezza. Non è necessario attendere una sentenza del giudice civile» . In pratica, il contribuente può difendersi nel processo tributario stesso argomentando la regolarità delle operazioni contestate. La Corte ha sottolineato che «la sostanza economica prevale sulla forma giuridica» e che contratti puramente formali volti a indebiti vantaggi fiscali possono essere ignorati direttamente dall’Amministrazione o dal giudice tributario, senza atti civili pregiudizievoli .
Conseguenze della simulazione. Quando viene accertata la simulazione, il Fisco «disregards» l’atto formale e riallinea la posizione fiscale alla realtà sostanziale (principio di sostanza economica). I costi, le aliquote agevolate o altri benefici ottenuti sulla base dell’atto simulato decadono. Per l’IVA, ad esempio, la giurisprudenza UE ha ricordato che un acquisto simulato non dà alcun diritto a detrazione (Cass. UE 8 maggio 2019, EN.SA C‑712/17; confermato poi da C‑430/2023) . In altri termini, se un’operazione di acquisto o di vendita è simulata, l’impresa non può vantare crediti d’imposta (art. 2 DPR 633/1972). Sul piano reddituale (IRPEF/IRES) si applica l’art. 37, c. 3, DPR 600/1973: i redditi imputati formalmente ad altri soggetti sono tassati al reale effettivo possessore (ad es. nel caso di trust o interposizione) .
Casi tipici di contestazione
Le simulazioni più comuni riguardano in genere:
- Scambi infragruppo: fatture o contratti tra società collegate a prezzi gonfiati o diminuite fittiziamente (per trasferire utili/fondi), al solo scopo di abbattere imponibili o IVA. Esempio: società A vende materie prime alla controllata B a prezzo molto superiore al mercato; A contabilizza elevati ricavi, B ingenti acquisti dedotti. In verifica, l’Agenzia può chiedere di dimostrare che lo scambio fosse effettivo.
- Cessioni immobiliari apparenti: vendite di immobili tra parti collegate ma formalmente intestate a terzi (es. parenti o fiduciarie), per usufruire di agevolazioni fiscali (prima casa, imposte ipotecarie ridotte, ecc.) o per occultare il vero beneficiario. Se si accerta la simulazione, si perde il beneficio e può scattare anche il reato di donazione occultata (art. 131 ss. TUIR).
- Contratti di comodato o locazione fittizi: si crea un contratto (es. comodato d’uso) tra padre e figlio per falsare il reddito dell’immobile. Ad esempio, si affitta casa al figlio a canone minimo e poi si simula un «rimborso spese», riducendo artificialmente il reddito imponibile del proprietario. In caso di simulazione, i canoni sono considerati occultati e tassati dal fisco.
- Operazioni con trust o fondazioni: se si usa un trust (o una fondazione) come strumento di interposizione per celare beni o redditi, gli atti di trasferimento possono essere qualificati come simulati e fraudolenti (sottrazione fraudolenta di beni al fisco). Ad es., trasferire beni in trust dopo l’emersione di debiti fiscali può configurare simulazione o frode (Cass. pen. art. 11 D.Lgs. 74/2000). Come visto, il reddito formalmente del trust viene tassato al disponente se il trust è considerato «schermo» .
- False operazioni estere: esportazioni o importazioni simulate (reali merci rispedite indietro) solo per fruire di sgravi IVA all’esportazione. Anche queste sono simulate e comportano indetraibilità IVA e sanzioni. La legislazione antimafia e antiriciclaggio prevede inoltre controlli rafforzati su fatture internazionali.
Effetti fiscali dell’accertamento per simulazione
Quando l’Ufficio accerta che le operazioni sono simulate, applica queste regole:
- IVA: l’operazione simulata è trattata come non effettuata. Il cedente non deve versare IVA (perché “l’operazione simulata è come non fatta”), mentre il cessionario perde il diritto alla detrazione del credito IVA a monte. Come chiarito dalla CGUE, non basta dichiarare nullo l’atto; bisogna accertare che l’operazione non si è concretamente realizzata o che si è trattato di evasione . In pratica, senza fattura vera e senza merci/servizi effettivi, non nasce alcun credito né obbligo di versamento IVA.
- Imposte sui redditi (IRPEF/IRES): i ricavi o redditi simulati vengono reintegrati nel reddito del vero beneficiario. Ad es., se una spesa aziendale è solo finta, quella spesa non è deducibile e i ricavi corrispondenti (nella controparte) vengono tassati normalmente. L’art. 37, c. 3, DPR 600/1973 consente di imputare al contribuente effettivo i redditi formalmente intestati ad altri . Qualora operi un gruppo societario, l’Agenzia può utilizzare l’art. 109 Tuir: ad esempio, una società controllata che dichiara perdite gonfiate per via di simulazioni subirà poi una rettifica sugli utili distribuiti alla capogruppo (evitando così la doppia deduzione fittizia).
- IRAP: in generale, la simulazione non incide direttamente sul calcolo del valore della produzione netta, salvo che riguardi componenti di costo esclusi (es. remunerazioni del lavoro). Ma se un costo di lavoro è simulato (ad esempio dipendenti all’esterno in realtà inesistenti), l’IRAP va calcolata sul reale costo.
- Esoneri e agevolazioni: se l’operazione simulata era finalizzata a ottenere un beneficio (es. agevolazioni prima casa, credito d’imposta, contributi o incentivi, esoneri di imposta di registro), questi benefici vengono revocati. Ad esempio, Cass. civ. sez. 5, ord. 1568/2014 ha stabilito che la simulazione di un contratto di donazione fa venir meno le agevolazioni fiscali concesse (ordinanza penale). Analogamente, l’atto simulato perde qualunque effetto nei rapporti interni, ma produce comunque effetti fiscali nulli per il simulatore.
- Sanzioni: oltre alle imposte aggiuntive, scattano sanzioni tributarie fino al 200‑240% per dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate (art. 3 D.Lgs. 74/2000). Se la simulazione riguarda l’occultamento di base imponibile, si configurano reati (art. 5 D.Lgs. 74/2000 per IVA, art. 4 per IRPEF). Anche ai fini amministrativi, l’accertamento può contestare ai soggetti coinvolti false fatturazioni (sanzioni per mancato versamento IVA, omessa dichiarazione, ecc.).
Strumenti di difesa del contribuente
Il contribuente debitore può utilizzare diversi strumenti per contrastare l’accertamento su operazioni simulate:
- Istanza di autotutela (art. 2 D.Lgs. 546/1992): è un’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate (o all’ente impositore) per chiedere l’annullamento di un avviso di accertamento erroneo. Va proposta entro i termini dell’impugnazione (solitamente 60 giorni). Il contribuente può far presente errori di fatto o di diritto (ad es. prova documentale inattesa che smentisce la simulazione) e chiedere annullamento senza dover iniziare subito il contenzioso. Dopo l’autotutela non si può più ricorrere sullo stesso atto (Cass. civ. 17/6/2015 n. 12509).
- Reclamo / Mediazione tributaria (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 e succ. mod.): per controversie di valore fino a €50.000 (comprese) è obbligatorio fare reclamo all’Agenzia prima del ricorso giurisdizionale . In pratica il contribuente presenta un’istanza motivata (reclamo) e può proporre una mediazione, includendo un’offerta di rideterminazione. L’Agenzia ha 90 giorni per decidere o convocare la mediazione. Se il procedimento si chiude positivamente (definizione con adesione), le sanzioni e gli interessi sono ridotti. La mancata presentazione del reclamo rende improcedibile il successivo ricorso in Commissione.
- Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997): sempre prima di impugnare, è possibile avviare una trattativa con l’Agenzia delle Entrate proporre la chiusura del contenzioso concordando la rideterminazione della base imponibile e sconto sanzioni (riduzione massima al 10‑20%). L’adesione può avvenire in primo grado o nei 30 giorni dall’appello. Non serve quando l’atto è già definitivo, ma è una via per limitare i danni.
- Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (Primo grado): è l’atto principale di opposizione giudiziaria (D.Lgs. 546/1992). Deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o 40 giorni dalla notifica di un’altra pronuncia tributaria sfavorevole. Nel ricorso il contribuente impugna l’atto motivando perché errato (ad es. riferendo tutte le prove documentali per dimostrare che le operazioni erano reali e non simulate). Il giudice tributario incidente esaminerà anche la natura simulativa, ai sensi dell’art.1, c.3, cod.proc.trib . Se la Commissione accoglie, l’atto di accertamento è annullato.
- Conciliatore tributario (L. 27/7/2017, n. 104): dall’ottobre 2017 è attivo il servizio di conciliazione giudiziale presso i Giudici tributari. Il contribuente può depositare in qualsiasi momento una domanda di conciliazione se la controversia è già pendente in Commissione (anche in appello) o addirittura in Cassazione, o se non ha ancora intentato causa. In contraddittorio tra ambo le parti davanti a un giudice, si raggiunge un verbale di conciliazione. La chiusura in conciliativo comporta riduzione forfettaria delle sanzioni: ridotte del 60% in primo grado, 50% in appello. È un mezzo deflativo che, sebbene debba essere valutato caso per caso, rappresenta un’opportunità di chiusura rapida (va proposto entro 90 giorni da notifica dell’atto impugnato).
- Ricorso d’appello (Secondo grado): se il ricorso viene respinto in primo grado, si può impugnare in Commissione Tributaria Regionale entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Anche qui il giudice di merito valuta le argomentazioni (la “doppia conforme” può ostacolare le impugnazioni di fatto, vedi Cass. 2016 n. 23033). Anche in appello non serve entrare nel merito civile della simulazione: il giudice tributario ha competenza comunque, come ricordato .
- Ricorso in Cassazione: è ammesso per motivi di diritto (art. 360 c.p.c.) entro 30 giorni dalla sentenza d’appello. Le Sezioni tributarie della Cassazione verificano solo questioni giuridiche (sovente la regolarità della motivazione, violazioni di legge o giurisprudenza). Non sono previsti nuovi elementi di fatto. In particolare, Cass. civ. sez. V ha confermato che il giudice di legittimità non può riesaminare impugnazioni di fatto già decise dalle CC.TT. (principio del “doppio conforme” art. 348‑ter c.p.c.). Tuttavia, possono essere fatti valere errori di diritto, quali la violazione del principio di libera prova (onere probatorio) o della normativa IVA/IRPEF.
- Acquiescenza: è facoltà di adesione tardiva agli effetti di un provvedimento impositivo (art. 1, comma 495 della L. 311/2004, Statuto del contribuente). Entro 60 giorni dalla notifica di un accertamento definitivo, il contribuente può accettare l’atto pagando imposte, interessi e sanzioni ridotte al 40% (anziché 100%). È utile quando si preferisce chiudere anziché rischiare esito negativo in giudizio.
- Altri strumenti: in certi casi si può promuovere un’azione di accertamento congiunto (accertamento in forma specifica con l’ente locale, es. TARI, TASI) o esperire un ricorso presso la Commissione tributaria provinciale avverso atti di riscossione (cartelle) o iscrizioni ipotecarie. Se la simulazione ha natura penale, il contribuente può poi far valere la sentenza penale favorevole nel contenzioso tributario (favor rei, art. 647 c.p.c.).
Tabella 2. Strumenti di difesa nel contenzioso tributario
| Strumento | Normativa | Quando usarlo | Effetti (es. sanzioni) |
|---|---|---|---|
| Autotutela | art. 2 D.Lgs.546/1992 | Subito dopo notifica atto (prima del ricorso) | Annullamento atto viziato |
| Reclamo/Mediazione | art. 17-bis D.Lgs.546/92 | Prima di ricorrere per controversie ≤ €50.000 | Se positivo: definizione, riduzione (doppio); altrimenti ricorso impugnabile |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 art.6 | Prima di ricorrere (anche dopo primo grado) | Definizione, sanzioni ridotte (fino 10‑20%) |
| Ricorso in commissione | D.Lgs. 546/1992 (art.14) | Entro 60 giorni da notifica atto d’accertamento | Valuta fatti+diritto, possibile annullamento |
| Conciliazione giudiziale | L. 27/7/2017 n.104 | In ogni grado di giudizio (anche Cassazione) | Verbale di chiusura, sanzioni ridotte (1/3) |
| Ricorso in appello | D.Lgs. 546/1992 (art. 16) | Se favorevoli in primo grado, entro 30 gg da sentenza | Riesame integrale del caso, con sconto sanzioni |
| Ricorso in Cassazione | L. 27/7/2000 n. 212 (Statuto, art. 17-ter) | Entro 30 gg da sent. CTP/CTR (su motivi di diritto) | Valuta solo legittimità (non fa nuovo processo) |
| Acquiescenza | Legge 27/7/2000, n.212 | Entro 60 gg da avviso d’accertamento definitivo | Versamento + sanzioni ridotte a 40% |
Cosa fare: difendersi in pratica
- Verificare l’atto di accertamento: subito dopo la notifica, controllare che contenga una motivazione chiara e completa (Norma Statuto art. 7) e che l’accertamento rispetti le forme prescritte (acquisizione di documenti, contraddittorio, ecc.). Errori procedurali (es. mancanza di motivazione, non aver concesso udienza, notifiche irregolari) costituiscono vizi invalicabili che il contribuente può far valere in giudizio.
- Raccogliere e conservare prove: documenti, contratti, fatture, pagamenti, corrispondenza e-mail, testimonianze che dimostrino la realtà dell’operazione. Per esempio, lettere di conferma dell’ordine, certificati di trasporto, ricevute bancarie che mostrano il reale flusso di beni o denaro. Il contribuente deve rafforzare le proprie affermazioni con dati concreti, contrapponendo al Fisco ogni elemento che neghi la simulazione (ad es. presenza fisica delle merci o attività effettive svolte dai soggetti).
- Simulazioni pratiche:
- Caso 1 (persona fisica): Mario vende l’immobile di famiglia al figlio Marco con un contratto di vendita, ma entrambi confermano a verbale che il trasferimento è fittizio: Mario resterà sempre usufruttuario dell’immobile. L’Agenzia accerta che si tratta di una donazione occultata. Difesa consigliata: dimostrare la presenza di un corrispettivo (anche simbolico) e l’effettiva manifestazione della volontà di vendere (contratti reali, atti notarili regolari). Altrimenti, negoziare una regolarizzazione (eventualmente definizione agevolata) poiché la simulazione assoluta comporta la nullità del contratto.
- Caso 2 (società): Società A cede beni strumentali a Società B, entrambe dello stesso gruppo, registrando plusvalenze che azzerano i bilanci di B. Il Fisco contesta che la vendita è simulata (l’immobilizzazione rimaneva in uso ad A). Difesa: fornire prove del trasferimento fisico dei beni (certificati di movimentazione, foto del passaggio di consegne), dimostrare il pagamento da un conto intestato a B . Se necessario, chiedere perizia o consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio. Evidenziare che l’operazione è realizzata «tra entità distinte, con regolare giro di fatturazione» per confutare la simulazione.
- Caso 3 (trust/fondazione): Una famiglia crea un trust per gestire il patrimonio immobiliare e dichiara fidecommissari soltanto soggetti terzi, ma in realtà il disponente (e i suoi eredi) continuano a godere dei beni. L’Agenzia tratta il trust come un’interposizione fittizia. Difesa: dimostrare l’autonomia del trust (atto istitutivo dettagliato, trustee indipendenti, finalità specifiche), evidenziare i flussi economici (il trust paga spese di manutenzione dagli utili generati) e la coerenza con la pianificazione successoria. Se il trust è realmente esistente (non simulato), si potrebbero comunque regolarizzare tardivamente i redditi (es. imposta sostitutiva del 24% sulle distribuzioni) per evitare pesanti sanzioni.
- Domande frequenti (Q&A):
D: Quando si configura la simulazione di un’operazione?
R: Quando le parti concordano un atto formale che non rispecchia la realtà economica: ad esempio, stipulare un contratto di vendita di beni che non sono mai stati ceduti fisicamente o con controprestazione inesistente. Devono esserci elementi obiettivi di discordanza tra la forma e la sostanza. L’accertamento di simulazione richiede tipicamente un documento o fattura che è «apparente» .
D: Chi deve provare la simulazione?
R: L’onere grava sull’Amministrazione finanziaria. Cass. 2020 n. 10571 ha ribadito che spetta al Fisco dimostrare con prove concrete (anche presuntive) la simulazione . Il contribuente, dall’altro lato, può solo confutare tali prove. In pratica, se il Fisco allega anomalie, spetta a lui argomentare il collegamento causa-effetto con la simulazione. Il contribuente deve però documentare la genuinità dell’atto.
D: In presenza di contestazione di operazione simulata, cosa succede all’IVA?
R: Se l’operazione è simulata, si considera come se non avvenisse. Ne segue che: il cedente non versa IVA (perché l’operazione è nulla) e il cessionario non può detrarre alcun credito IVA. Lo ha chiarito anche la Corte di Giustizia UE: un passivo IVA non può perderne il diritto per la sola causa civile di simulazione, a meno che non sia dimostrata la mancata realizzazione o la frode . In sostanza, senza atto reale di cessione di beni/servizi, nessun imposta è dovuta e nessuna detrazione è legittima.
D: Cosa cambia tra persona fisica, società e trust?
R: Il principio è analogo: in ogni caso il Fisco può ignorare l’atto simulato. Tuttavia, le conseguenze pratiche differiscono. Una persona fisica che simula una vendita immobiliare perde benefici quali le agevolazioni prima casa e rischia il recupero dell’imposta di donazione. Una società che simula spese o cessioni vede negata la deducibilità dei costi (art. 39 DPR 600/73) e può vedersi rideterminare il reddito d’impresa. Un trust (riconosciuto in Italia tramite Convenzione dell’Aja) non ha personalità fiscale propria: se si ritiene che il trust sia stato utilizzato come schermo (interposizione), l’Amministrazione applica l’art. 37(3) DPR 600/73 , imputando al disponente i redditi formali. Per ogni categoria vale il diritto di difesa sopra descritto.
D: Quali prove può usare il contribuente per dimostrare la realizzazione dell’operazione?
R: Tutti i documenti e dati che attestano la materialità della prestazione: ad esempio, registri di carico/scarico, bolle di consegna, bonifici bancari effettivamente disposti, testimonianze di terzi coinvolti, perizie giurate, contratti notarili integrali. L’ideale è contrapporre le prove del contribuente alle presunzioni del Fisco, rendendo concreto e coerente il quadro fattuale.
D: È utile chiedere l’adesione o l’acquiescenza?
R: Spesso sì, quando le contestazioni appaiono difficili da sconfiggere e si vuole limitare le sanzioni. Con l’adesione si chiude il contenzioso con sanzioni ridotte (in genere al 10-20% per adesione in contraddittorio; al 3% per acquiescenza ex post), ma pagando comunque maggiorazione di imposta. Se si ha buona documentazione, può valere la pena procedere in giudizio, anche per evitare precedenti negativi. In ogni caso, con il reclamo/conciliatore e l’accertamento con adesione si possono contenere i rischi prima del ricorso.
D: Esistono termini particolari per difendersi?
R: Sì, occorre intervenire con prontezza. Per un avviso di accertamento tradizionale il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica (oppure 40 giorni per cartelle esattoriali o atti di riscossione). Il reclamo all’Agenzia (se dovuto) va fatto entro 30 giorni. L’istanza di autotutela va presentata entro 60 giorni o comunque prima del contenzioso. La conciliazione giudiziale può essere proposta al massimo fino all’udienza di discussione di primo grado. Agire tempestivamente amplia le chance difensive (si evitano prescrizioni o integrale definizione dell’atto).
Strategie difensive processuali
- Autotutela: invia all’Agenzia (sede o Direzione Regionale) una formale richiesta di revoca del provvedimento, esponendo le ragioni in fatto e in diritto (ad es. documenti nuovi). Allegare subito tutta la documentazione probatoria utile. Conviene chiedere audizione in contraddittorio; in alcuni casi è prevista (es. art. 12 Statuto, diritto di essere sentiti). L’Ufficio può accogliere (e l’avviso decade) o respingere motivando.
- Reclamo/Mediazione: se previsto, compila e invia (o consegna) entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso un reclamo tributario all’Agenzia. Nel testo argomenta punto per punto, con tabelle o allegati (rendiconto costi, confronti di prezzo di mercato, testimonianze) a favore della non simulazione. In calce si può chiedere la mediazione, prospettando, ad esempio, una revisione parziale della base imponibile con proposta sanzioni ridotte. Entro 90 giorni l’Agenzia deve notificare l’accoglimento (anche parziale) o rifiutare il reclamo e fissare incontro di mediazione. Se il reclamo/mediazione fallisce, si conserva la possibilità di ricorrere in giudizio, ma bisogna rispettare il termine utile.
- Accertamento con adesione e conciliazione: se l’Agenzia propone (o il contribuente richiede) una definizione in contraddittorio, valutare la convenienza. Adesione in contenzioso tributario si chiude con riduzione (50‑60% di sanzioni in primo grado) . Conciliazione giudiziale davanti al Tribunale (art. 11-bis, D.Lgs. 546/92) consente ulteriore sconto (sanzioni al 1/3) e clausole di riservatezza. Questi strumenti funzionano solo finché il caso è pendente: una volta passata in giudicato la sentenza di secondo grado, non si può più conciliare. Vantaggio principale: certezza dei tempi e riduzione pesante delle sanzioni (70‑80%). Contro: non si annulla il debito, ma lo si definisce.
- Contraddittorio in corso di verifica: se l’accertamento è ancora in fase di contraddittorio (prima della notifica), il contribuente ha diritto a presentare memorie difensive. È fondamentale usare questo colloquio per chiarire dettagli tecnici e consegnare anticipatamente prove (fact‐sheet, contraddittorio scritto).
- Difesa nel processo tributario: in tribunale il contribuente sviluppa le proprie ragioni. In udienza si può chiedere prova testimoniale (o cautelare, se necessaria), anche peritali, per dimostrare lo stato di fatto. Confronto diretto con agenti contabili o intermediari coinvolti può chiarire che l’operazione era genuina. Ad esempio, un’intercettazione o filmato che dimostri la consegna reale di beni può ribaltare l’accusa di simulazione. È prassi redigere nell’atto di citazione o nel ricorso ampi allegati in forma di commi e tabelle che spiegano ogni voce di bilancio contestata.
- Penale e diritti formali: se c’è contestazione penale (spergiuro o frode fiscale), è possibile ottenere dalla parte penale (sia dall’indagato che dall’ufficio) documenti irreperibili e quindi usarli nel civile fiscale per propria difesa. Ricordiamo che per la notificazione degli atti di accertamento fiscale si applica il D.P.R. 29/09/1973 n. 602 (art. 25-ter e ss.). Un vizio di notifica invalida l’atto. Se richiesti, i documenti esibiti in autotutela (o ricevuti dagli organi finanziari) sono utilizzabili anche nel ricorso.
- Contenziosi alternativi: in presenza di questioni incidentali, il contribuente può domandare giudizio ordinario (ad es. impugnare un contratto civile come simulato in sede civile) e poi trasporre la sentenza nel processo tributario. Tuttavia, come detto, il giudice tributario decide in via incidentale la simulazione stessa . In ogni caso, il favore di giustizia (contraddittorio completo, diritto di prova) va richiesto mediante chiarimenti motivati: Cass. 2020 ha ribadito che il giudice fiscale è tenuto a riesaminare i fatti se nulla vieta di sviluppare contraddittoriamente il tema simulazione .
- Conciliazione all’estero e cooperazione fiscale: se gli accertamenti coinvolgono stati esteri (es. trust in paradisi fiscali), si può attivare lo scambio informazioni internazionale (UE o Convenzione OCSE) per ricostruire flussi esteri. L’Agenzia potrebbe aver prolungato termini di accertamento (fino al 8° anno) se rilevati cespiti non dichiarati all’estero; in tal caso il contribuente può sanare spontaneamente con ravvedimento operoso per minimizzare sanzioni (vedi TUIR art. 13 e co. IVA).
Domande e risposte
- Che prove servono per confutare l’accertamento? In primo luogo, quelle che attestino l’effettiva realizzazione dell’operazione: contratti eseguiti, regolari flussi finanziari (bonifici, pagamenti tracciati), ricevute di servizio. Se il Fisco ha “presunzioni legali” (es. artt. 54 e 60 Tuir, redditometro), fornire documenti di spesa/patrimonio alternativi. Se si contestano fatture simulate, produrre elementi contabili indipendenti (es. ordini cliente, Kb fiscali). Ad esempio, Cass. 2014 ha sottolineato che la semplice asserzione di simulazione “al livello di una mera asserzione sfornita del benché minimo elemento di riscontro sul piano probatorio” è inammissibile . Quindi occorrono elementi di riscontro concreti, anche indiretti.
- Cosa cambia se il fisco confonde simulazione e omissione? Se il controllo punta più sull’omessa dichiarazione (ad es. mancata indicazione di redditi o conti esteri) che sulla simulazione in senso stretto, si applicano le regole ordinarie di omissione. In tal caso il contribuente può sanare tardivamente con rimediazione (art. 13 D.Lgs. 471/1997) per ridurre fortemente le sanzioni (ad es. da 3% al 1,125% sul minimo, se spontaneo entro 90 gg).
- Quanto tempo impiegano i giudici tributari? Il processo tributario ha termini ordinari (60 giorni tra le parti, udienza di discussione entro mesi). Tuttavia esistono procedure speciali (es. Giudizio abbreviato, esito solitamente in 6-12 mesi). In media un ricorso in primo grado si conclude dopo 1‑2 anni, l’appello in altri 1-2 anni. La conciliazione (giudiziale) si chiude rapidamente se entrambe le parti collaborano; il reclamo amministrativo ha termine di 90 giorni. È importante procedere in tempo (ricorso entro 60 gg, etc.) per preservare ogni possibilità.
- Quali sanzioni rischia il contribuente se perde? Oltre alle maggiori imposte accertate (e agli interessi), si applicano sanzioni fino al 100-200% del tributo evaso (dichiarazione fraudolenta art. 3 D.Lgs. 74/2000: se condannati penalmente). Se la contestazione resta amministrativa, vi è sanzione minima del 90% sulle imposte non versate. Con la conciliazione giudiziale si riducono al 30-50%, con adesione volontaria al 40% e con acquiescenza addirittura al 40% (Corte UE: 40% equivale a 40% del minimo, cioè 40 su 100). In altre parole, senza difendersi il debito può moltiplicarsi per 3‑5 volte.
Strategie preventive e raccomandazioni
Infine, è bene adottare prima delle verifiche alcune precauzioni:
– Trasparenza contrattuale: evitare operazioni sospette. Se si deve fare un’operazione anomala (affitti ridicoli a familiari, apporto di beni), curare in modo minuzioso la documentazione (consulenze notarili, perizie giurate sul valore, motiva del contratto scritto).
– Consistenza economica: far emergere tutti i flussi effettivi (denaro, merci) nei registri contabili e bancari, in modo tracciabile. Evitare triangolazioni inutili (ad es. fatture false di import-export); se si adottano meccanismi complessi (trust, fiduciaria, società interposte), giustificarli con business plan e contratti reali.
– Registro dei testimoni: mantenere nomi e contatti di testimoni di operazioni (corrieri, clienti, fornitori). In caso di contestazione, le loro dichiarazioni possono essere decisive per dimostrare che l’operazione è stata eseguita per come dichiarata.
– Bilanci e note esplicative: nei bilanci, inserire note di commento che spieghino transazioni atipiche (es. “il contratto di comodato è giustificato dall’utilizzo strumentale continuato dell’immobile”). Questo aiuta a orientare eventuali verifiche.
Ricordiamo che la buona fede contabile e il corretto adempimento degli obblighi formali (tenuta regolare di libri, annotazioni nei termini, liquidazioni IVA, RW per estero) creano un’effetto premiante in caso di contestazioni, poiché dimostrano la cooperazione del contribuente. Al contrario, omissioni o irregolarità procedurali offrono terreno fertile per l’accertamento.
In conclusione, la simulazione fiscale richiede un approccio difensivo articolato. Il contribuente deve agire con rapidità, documentazione solida e strategia legale. Citando le parole della Cassazione: il giudice tributario può “andare oltre l’apparenza formale di un atto per comprenderne la reale sostanza economica” . Perciò la difesa deve puntare proprio su quella sostanza economica, dimostrando la genuinità delle proprie transazioni e contrastando ogni elemento di fittizio.
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza ti contestano operazioni simulate? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale perché l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza ti contestano operazioni simulate?
Ti accusano di aver fatto apparire vendite, acquisti o contratti solo sulla carta, al fine di ridurre le imposte o aumentare costi inesistenti?
👉 Prima regola: la simulazione deve essere provata dall’Amministrazione, non può essere solo presunta.
Molti accertamenti fiscali per operazioni simulate si basano su deduzioni arbitrarie o presunzioni non supportate da prove concrete.
Con una difesa tecnica e documentata, puoi dimostrare la reale natura delle operazioni e ottenere l’annullamento dell’accertamento.
⚖️ Cosa sono le operazioni simulate
Per operazione simulata si intende un’operazione economica apparente, che non corrisponde alla realtà dei fatti, creata per ottenere un vantaggio fiscale indebito.
Le forme più comuni di simulazione sono:
- Fatture false o gonfiate per aumentare i costi deducibili o l’IVA detraibile;
- Vendite fittizie o prestazioni mai eseguite;
- Contratti di locazione, consulenza o appalto simulati;
- Società di comodo o prestanome utilizzate per nascondere redditi;
- Operazioni infragruppo o con soggetti collegati non reali;
- Finte cessioni o donazioni per ridurre la base imponibile o sottrarre beni al fisco.
📌 Quando scatta l’accertamento
L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento per operazioni simulate quando rileva:
- Incoerenze tra la documentazione fiscale e la realtà dei fatti;
- Mancanza di corrispettivi o pagamenti tracciabili;
- Anomalie nei rapporti commerciali tra soggetti collegati;
- Utilizzo di fatture emesse o ricevute da società cartiere;
- Differenze tra i volumi d’affari e le operazioni registrate;
- Esiti di verifiche bancarie o segnalazioni della Guardia di Finanza.
📉 Le conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte su redditi o IVA ritenuti non dichiarati.
- Sanzioni amministrative fino al 240% delle imposte accertate.
- Interessi di mora e iscrizione a ruolo delle somme dovute.
- Rischio di procedimento penale tributario, in particolare per:
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture false (art. 8 D.Lgs. 74/2000).
- Sequestro preventivo e confisca dei beni fino al valore del profitto fiscale.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- L’Amministrazione ha fornito prove concrete della simulazione (testimonianze, perizie, documenti)?
- L’accertamento si basa su presunzioni generiche o semplici coincidenze?
- Le operazioni contestate hanno avuto effetti economici reali (pagamenti, merci consegnate, contratti eseguiti)?
- È stato rispettato il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del Contribuente (art. 12)?
- Gli atti sono motivati in modo adeguato e notificati nei termini di legge?
- Le eventuali fatture contestate sono riconducibili a soggetti realmente operativi?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento e allegati (relazioni, prospetti, verbali).
- Fatture, contratti, ricevute, ordini di lavoro o documenti di trasporto.
- Prove dei pagamenti (bonifici, estratti conto, assegni).
- Corrispondenza commerciale o e-mail che dimostrano l’effettiva esecuzione dell’operazione.
- Documentazione bancaria e contabile di supporto.
- Verbali di verifica della Guardia di Finanza e memorie difensive già presentate.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la realtà economica e sostanziale delle operazioni contestate.
- Contestare errori di ricostruzione o valutazioni soggettive dell’Amministrazione.
- Eccepire vizi di motivazione, di notifica o di competenza nell’accertamento.
- Produrre prove documentali e testimoniali che smentiscono la simulazione.
- Far valere l’assenza di dolo o di intento evasivo, in particolare nei rapporti infragruppo.
- Richiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
- In caso di procedimento penale, impostare una difesa congiunta penale e tributaria basata su prove oggettive e analisi contabile.
⚖️ Difesa penale-tributaria integrata
In presenza di accuse di operazioni simulate, la linea di difesa deve essere coordinata tra la parte fiscale e quella penale.
L’obiettivo è:
- escludere il carattere fittizio delle operazioni;
- dimostrare la sussistenza di rapporti commerciali reali;
- evitare condanne penali e confische patrimoniali;
- ridurre o annullare l’accertamento tributario correlato.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento e la documentazione contestata.
- 📌 Valuta la fondatezza delle prove di simulazione presentate dall’Agenzia.
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari personalizzati.
- ⚖️ Ti difende anche in sede penale, coordinando la strategia tra avvocato tributarista e penalista.
- 🔁 Assiste nella ricostruzione economico-contabile delle operazioni per dimostrarne la genuinità.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e penale-tributario.
- ✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti per operazioni inesistenti o simulate.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti per operazioni simulate sono tra i più insidiosi, perché l’Agenzia tende a basarsi su presunzioni e collegamenti indiretti.
Con una difesa documentata e tempestiva, puoi dimostrare la realtà delle operazioni, evitare sanzioni penali e tributarie e proteggere la tua attività e il tuo patrimonio.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro gli accertamenti fiscali per presunte operazioni simulate inizia qui.