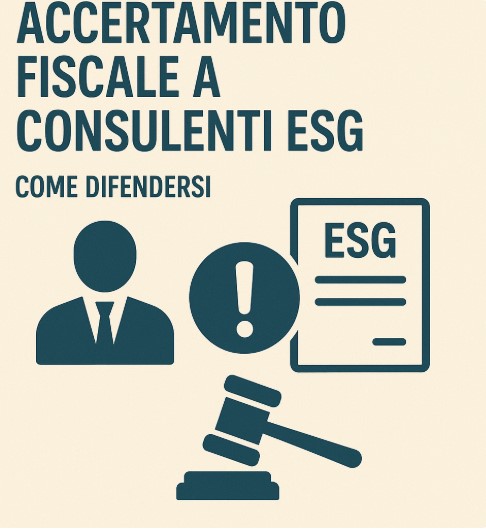Hai ricevuto un accertamento fiscale come consulente ESG (Environmental, Social and Governance)?
Con la crescita delle professioni legate alla sostenibilità aziendale e alla rendicontazione non finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a controllare con maggiore attenzione i redditi dei consulenti ESG, le collaborazioni con imprese e studi professionali, e l’uso di regimi fiscali agevolati.
Spesso gli accertamenti nascono da dati bancari, incongruenze nelle dichiarazioni o verifiche incrociate su compensi percepiti per consulenze strategiche, ambientali o di governance. Tuttavia, molte contestazioni derivano da errori interpretativi o da controlli automatici, che non considerano la complessità e la novità del settore.
Con una difesa ben documentata e mirata, è possibile dimostrare la correttezza della propria posizione fiscale e ottenere la riduzione o l’annullamento dell’accertamento.
Quando l’Agenzia delle Entrate effettua un accertamento sui consulenti ESG
– Se riscontra scostamenti tra i compensi dichiarati e i movimenti bancari o i dati trasmessi dai committenti
– Se contesta la deducibilità delle spese professionali (formazione, trasferte, software di analisi ESG, collaborazioni esterne)
– Se l’Ufficio ritiene che le prestazioni di consulenza non siano documentate in modo adeguato o prive di contratto scritto
– Se il consulente opera con società o enti esteri e non ha correttamente dichiarato i redditi prodotti all’estero
– Se vengono rilevate anomalie negli ISA o scostamenti rispetto ai parametri medi del settore
– Se l’Agenzia ritiene che il consulente abbia applicato impropriamente il regime forfettario o altri regimi agevolativi
Conseguenze dell’accertamento fiscale
– Ricalcolo dei redditi imponibili, con recupero di IRPEF, IVA e contributi previdenziali
– Sanzioni amministrative dal 90% al 180% delle imposte accertate
– Interessi di mora sulle somme dovute
– Decadenza dai regimi agevolati se l’Ufficio ritiene violati i requisiti di accesso
– Nei casi più gravi, segnalazioni per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione dei redditi
Come difendersi da un accertamento fiscale
– Dimostrare, con contratti, fatture, rendicontazioni ESG e relazioni tecniche, la reale esecuzione e inerenza delle prestazioni
– Produrre estratti conto, ricevute, e-mail e report di progetto per giustificare i compensi percepiti
– Contestare presunzioni di ricavi non dichiarati o scostamenti basati su dati incompleti
– Dimostrare la legittimità delle spese professionali sostenute per attività di ricerca, networking o formazione ESG
– Evidenziare vizi di motivazione, di notifica o di contraddittorio nell’avviso di accertamento
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo anche la sospensione della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa del consulente ESG
– Analizzare la legittimità dell’accertamento e la fondatezza delle presunzioni fiscali
– Verificare la correttezza della contabilità e delle deduzioni professionali
– Contestare l’uso improprio di parametri o indici non applicabili a un settore in rapida evoluzione
– Redigere un ricorso documentato, basato su prove tecniche e giurisprudenza tributaria
– Difendere il professionista nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e in giudizio
– Tutelare il consulente da sanzioni sproporzionate e danni reputazionali
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati
– Il riconoscimento della correttezza dei redditi e delle spese dichiarate
– La sospensione delle procedure di riscossione in corso
– La piena tutela della tua attività professionale e del tuo regime fiscale
⚠️ Attenzione: gli accertamenti fiscali sui consulenti ESG sono spesso basati su presunzioni generiche o dati parziali, perché il settore è ancora nuovo e non esistono parametri uniformi di redditività.
Molti avvisi si fondano su errori di valutazione delle spese o dei compensi tipici delle attività di consulenza strategica.
È fondamentale agire subito, con una difesa legale esperta in diritto tributario e fiscalità dei professionisti ESG, per evitare richieste ingiuste e proteggere la tua reputazione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e fiscalità delle nuove professioni sostenibili – spiega come difendersi da un accertamento fiscale a carico di consulenti ESG, quali errori dell’Agenzia verificare e come ottenere l’annullamento della pretesa.
👉 Hai ricevuto un accertamento fiscale come consulente ESG?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua posizione, controlleremo la legittimità dell’accertamento e costruiremo una strategia difensiva mirata per tutelare la tua attività, i tuoi redditi e la tua immagine professionale.
Introduzione
I consulenti ESG (Environmental, Social e Governance) svolgono prestazioni intellettuali specialistiche – ad esempio la redazione di relazioni di sostenibilità, rendicontazioni non finanziarie (secondo D.Lgs. 254/2016, recepimento Direttiva UE 2014/95) e il supporto per rating ESG – che devono essere inquadrate nei corretti regimi fiscali e contributivi. Anche se nuove come professione, non sfuggono ai controlli di Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS: il contribuente–consulente è soggetto alle normali regole fiscali. Una corretta struttura contrattuale, documentazione puntuale e il rispetto dei doveri (fatturazione, versamenti, dichiarazioni) sono la prima difesa. Nel caso di accertamento, il consulente deve conoscere i propri diritti (contraddittorio, motivazione, termini) e gli strumenti giuridici difensivi. Questa guida – aggiornata a settembre 2025 – esamina normativa e sentenze recenti, fornendo esempi pratici, tabelle riepilogative e FAQ per chiarire come opporsi efficacemente all’accertamento fiscale (anche contributivo INPS) e alle ispezioni della Guardia di Finanza, dal punto di vista del contribuente (professionista/impresa).
1. Profilo e inquadramento del consulente ESG
- Attività tipiche: Il consulente ESG assiste aziende e organizzazioni nella rendicontazione di aspetti ambientali, sociali e di governance. I compiti comuni includono: preparazione del bilancio di sostenibilità (o dichiarazione non finanziaria), analisi e report sui fattori ESG, supporto nella redazione di piani CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa), consulenza per l’ottenimento di rating ESG e audit di conformità, training interno, ecc. Queste attività sono inquadrate come prestazioni di servizio professionale e non come cessioni di beni o attività industriali.
- Forma contrattuale: In genere il rapporto con il cliente (impresa o ente) è di consulenza professionale (“contratto di prestazione d’opera intellettuale” o consulenza con partita IVA). Il compenso viene fatturato con IVA (salvo esenzione regimi agevolati) e – nel regime ordinario – con ritenuta d’acconto Irpef del 20% (DPR 600/1973, art.25). Se il consulente ESG è iscritto a ordini o casse professionali, applica le regole di quell’ordinamento; altrimenti iscrive alla Gestione Separata INPS (art. 2 c.26 L.335/1995) o, se aderente al regime forfettario, paga contributi sostitutivi proporzionali al reddito.
- Regime forfettario: Se il reddito annuo è entro i limiti di legge (65-100mila € a seconda dell’attività), si può optare per il forfettario: imposta sostitutiva (5% al primo quinquennio, poi 15%) senza IVA né ritenute in fattura. Attenzione: anche i forfettari possono subire controlli, ad es. accertamento sintetico (redditometro) se le spese o la capacità di spesa superano il reddito dichiarato. In ogni caso i guadagni professionali sono redditi di lavoro autonomo (art.49 TUIR). In entrambi i regimi occorre conservare documenti giustificativi (es. contratti, verbali, mail) delle prestazioni ESG, in vista di eventuali verifiche.
Tabella 1 – Confronto fiscale per i consulenti ESG:
| Regime fiscale | IVA/Fatturazione | Imposta | Contributi INPS | Ritenute | Controlli tipici | |:———————:|:———————-|:———-:|:———————————:|:———:|:—————————————-:| | Ordinario (IVA) | IVA 22% sulle parcelle; fattura completa. | IRPEF progressiva (redditi professionali) | Gestione Separata (aliquota ~25%) sul reddito netto | Ritenuta 20% in fattura (cliente sostituto d’imposta) | Accertamento formale, analisi scritture, accessi, contenzioso | | Forfettario | Nessuna IVA, fattura semplificata. | Imposta sostitutiva (5% o 15%) sul coeff. di redditività | Contributi previdenziali minimi obbligatori (minimale) e aliquota ridotta sui ricavi eccedenti | Nessuna ritenuta in fattura | Controllo sintetico, verifiche coerenza spese reddituali |
Tabelle e esempi:* Il consulente prepari sempre computi dettagliati dei costi sostenuti per ogni progetto ESG e delle ore di consulenza svolte. In caso di contestazione fiscale, queste voci devono risultare coerenti con i compensi fatturati.
2. Doveri fiscali e contributivi del consulente ESG
I redditi da consulenza ESG sono soggetti alle normali imposte dirette e indirette. In concreto:
– IVA e imposte: Nel regime ordinario, si applica l’IVA (attualmente 22%) sulle fatture emesse per consulenze. Il compenso lordo in fattura subisce poi la ritenuta d’acconto Irpef del 20% da parte del cliente (“sostituto d’imposta”), come previsto dall’art.25 DPR 600/1973. Il consulente dichiara tali ricavi come redditi di lavoro autonomo (art.49 TUIR) e detrae le spese inerenti (es. viaggi, formazione, acquisto software). Nel forfettario, si calcola solo l’imposta sostitutiva come visto e non si versa IVA. In entrambi i casi, va presentata la dichiarazione annuale dei redditi.
– Contributi previdenziali: Essendo lavoratori autonomi senza cassa dedicata, i consulenti ESG normalmente sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art.2 c.26 L.335/95). Devono versare contributi calcolati sul reddito imponibile professionale (aliquota attorno al 25–27%). Come chiarisce l’INPS, se l’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito ai fini IRPEF, sui maggiori redditi verranno calcolati e richiesti dall’Agenzia anche i contributi previdenziali dovuti, oltre all’IRPEF . Se poi tali contributi non vengono versati entro il termine, l’INPS procede al recupero coattivo (addebito) sul maggior reddito accertato . Pertanto il consulente deve monitorare i propri versamenti contributivi: in caso di errato calcolo conviene regolarizzarsi spontaneamente (ad es. con l’autotutela del versamento aggiuntivo INPS) per evitare sanzioni.
– Altri adempimenti: Il consulente ESG potrebbe avere l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (registro IVA e libro unico per dipendenti, se presenti) e di inviare la dichiarazione annuale IVA (solo se in regime ordinario). Inoltre va versata l’IMU o altri tributi locali se ha ufficio/studio, e compilate le dichiarazioni ambientali se previsto. In ogni caso, la regolarità fiscale (dichiarazioni presentate, bollettini INPS saldati) attenua il rischio di contenzioso.
Riassunto pratico: il consulente ESG deve fatturare correttamente le prestazioni ESG (descrivendole come consulenze o servizi), applicare IVA o dichiarare in forfettario a norma, versare ritenute e contributi dovuti. Nel verificare successivamente i compensi, l’Agenzia valuterà la congruità tra gli incassi e l’attività svolta (ad esempio un unico grande compenso a fronte di poche ore può destare sospetti). In ogni caso, ogni accertamento IRPEF si traduce in automatico in accertamento contributivo da parte dell’INPS sui maggiori redditi .
3. Organi di controllo e tipologie di accertamento
L’accertamento fiscale può essere condotto da diversi organi con competenze specifiche:
- Agenzia delle Entrate (AdE): è il principale organo di accertamento tributario. Può effettuare verifiche sui redditi dichiarati e sull’IVA applicata. Gli strumenti includono:
- Controlli formali e automatizzati (art.36-bis/36-ter DPR 600/73): incroci incrociando dati anagrafici, redditometro (art. 38-bis T.U.I.R.), spesometro ecc. Non richiedono accessi ma possono portare direttamente all’avviso d’accertamento.
- Verifiche fiscali (accessi e ispezioni): su richiesta (art.52 DPR 633/72 per IVA) o come verifica autonoma, l’AdE può effettuare un accesso presso lo studio/ufficio del consulente o nella sede del cliente, e acquisire documentazione.
- Avviso di accertamento: l’atto amministrativo con cui l’AdE notifica formalmente la pretesa tributaria derivante da controlli (su redditi o IVA) . Dopo il contraddittorio (vedi oltre), l’atto può includere maggiori imposte, sanzioni e interessi.
- Guardia di Finanza (GdF): è Polizia Tributaria deputata a investigare frodi fiscali e finanziarie. Spesso collabora con l’AdE. In pratica, può svolgere accessi ispettivi (p.es. alla sede professionale del consulente) avvalendosi del processo verbale di constatazione (PVC): un verbale formale in cui si riportano le contestazioni (redditi omessi, fatture false, operazioni inesistenti, ecc.). Su un PVC fondato, l’Agenzia può quindi emettere avviso d’accertamento.
- Esempio di contestazioni tipiche: redditi non dichiarati, fatture irregolari, cessioni abusive, ritenute non operate, presunzioni di utilità ecc. Per consulenti ESG, la GdF potrebbe esaminare flussi finanziari sospetti, uso di contributi pubblici per progetti ESG, coerenti applicazioni del regime IVA, o controllare se il cliente ha imposto al consulente condizioni anomale (eventuali “finte consulenze”).
- Difesa: All’esito del PVC, il consulente/cliente può presentare osservazioni scritte o, se tempestivo, aderire al verbale con sanzioni ridotte . Non presentare memorie nel PVC rischia di rafforzare le contestazioni. Se viene notificato l’avviso fiscale, il consulente può impugnare.
- INPS: agisce sui contributi previdenziali. Come visto, l’INPS normalmente verifica le contribuzioni dovute calcolandole sulla base dei redditi dichiarati o accertati dall’Agenzia . In pratica, i controlli INPS avvengono spesso di riflesso a seguito di un accertamento fiscale (art. 10 D.Lgs. 241/97 integrato con il D.Lgs. 462/97). L’INPS, dopo un accertamento IRPEF/IVA che scopre maggior reddito, comunica al contribuente l’avviso di addebito contributivo sul reddito aggiuntivo . Se i contributi non vengono saldati, l’INPS procede al recupero coattivo (ad es. pignoramenti).
- Altri controlli: In certi casi anche altri enti possono intervenire: ad esempio l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Tributario delle Entrate per IMU o tasse locali relative allo studio professionale; oppure l’Autorità Antiriciclaggio (UIF) se sorgono sospetti di riciclaggio. Ma il nucleo sono Agenzia e GdF per il fisco e INPS per i contributi.
Tabella 2 – Organi di accertamento: competenze e poteri:
| Organo | Oggetto dell’accertamento | Azioni tipiche | Riferimenti normativi | |:———————:|:——————————-|:—————————————|:—————————–| | Agenzia Entrate | IRPEF, IVA, altri tributi | Accessi, richiesta documenti, avvisi di accertamento | DPR 600/1973 (IRPEF), DPR 633/1972 (IVA) | | Guardia di Finanza| Frodi fiscali, IRPEF, IVA | Verifica in loco, PVC (verbale di constatazione) | Legge 68/1974, D.Lgs. 490/1994 | | INPS | Contributi previdenziali | Calcolo contributi su Reddito accertato; Avviso di addebito contributivo | D.Lgs. 241/97, art.10; D.Lgs. 462/97 | | Altri (es. Comuni, UIF) | Tasse locali, antiriciclaggio | Audit incrociati, segnalazioni (UIF) | Varie (Reg. Privacy, D.Lgs. 231/2007) |
4. Procedura dell’accertamento fiscale e diritti del contribuente
Quando l’Amministrazione fiscale intende accertare omissioni o errori, segue una procedura articolata. I passaggi principali sono:
- Accesso/Verifica fiscale: Se l’Agenzia o la GdF intendono un controllo “in loco”, il contribuente riceve un’ordinanza di ingiunzione (richiesta di accesso). In fase di verifica, va mostrata massima collaborazione nel fornire documenti (fatture, contratti, libro giornale/separato). L’ispettore redige un verbale o un appunto delle contestazioni. Dopo l’accesso, alla fine delle operazioni può essere redatto un processo verbale di constatazione (PVC) con le osservazioni dell’ufficio. Il contribuente ha sempre il diritto di formulare memorie difensive entro i termini fissati nel verbale .
- Contraddittorio formale (fase endoprocedimentale): Fondamentale è il cosiddetto contraddittorio informato ed effettivo. Dal 18/1/2024 l’art.6-bis dello Statuto del contribuente (L.212/2000, come modificato dal D.Lgs.219/2023) impone che tutti gli atti impositivi impugnabili debbano essere preceduti da contraddittorio tra l’ufficio e il contribuente . In pratica, l’Agenzia deve comunicare al contribuente uno “schema di atto” (bozza di avviso) e concedere almeno 60 giorni per osservazioni scritte (o per esaminare la documentazione). L’atto definitivo non può essere adottato prima del termine. L’assenza del contraddittorio formale rende l’atto di accertamento annullabile (ex art. 6-bis), senza dover più provare l’effettiva incidenza delle osservazioni . Questo vale anche per gli accertamenti “a tavolino” (senza accesso): come chiarito dalla Cassazione SS.UU. n.21271/2025, anche in tali casi il contraddittorio obbligatorio è necessario, pena nullità dell’avviso . Prima dell’introduzione del 6-bis, il contribuente doveva invece dimostrare la cd. “prova di resistenza” (ossia che il suo intervento avrebbe potuto modificare l’esito dell’accertamento) . Ora basta l’omissione per ottenere annullamento.
- Diritti del contribuente: Oltre al contraddittorio, il contribuente gode dello Statuto del contribuente (L.212/2000): può chiedere di essere informato sugli atti che lo riguardano, ottenere copia del fascicolo fiscale, accedere agli atti, presentare chiarimenti e documenti. L’avviso finale deve contenere motivazione precisa delle somme richieste (ciò che compete), altrimenti si può contestare la motivazione.
- Avviso di accertamento: Se dopo il contraddittorio l’ufficio conferma la pretesa fiscale, notifica l’avviso di accertamento definitivo. Questo atto deve contenere: dati identificativi del contribuente, anno di riferimento, correzioni operate sui redditi/IVA, calcolo di imposte dovute (con sanzioni e interessi), termini di pagamento e di impugnazione. L’avviso può riguardare IRPEF, IVA o altre imposte. Contro l’avviso il contribuente potrà ricorrere in Commissione Tributaria entro 60 giorni (o nella procedura di accertamento con adesione se previsto). È essenziale leggere attentamente ogni voce nell’avviso e confrontarla con quanto già dichiarato o argomentato nel contraddittorio. Spesso si contestano: mancata deducibilità di spese sostenute, riclassificazione di redditi, mancato addebito di ritenute o IVA, ecc.
- Ricorso tributario e difesa: Le vie di difesa sono sia extragiudiziali che giudiziali. Prima dell’avviso definitivo, si possono usare: osservazioni difensive (contro il PVC o schema d’atto) e adesione al PVC/avviso (pagare in misura ridotta). Dopo l’avviso, si può tentare un’istanza di autotutela presso l’Agenzia (art.2-quater L.564/1994), chiedendo revoca per motivi evidenti (es. errore materiale). In alternativa o in aggiunta, si presenta ricorso al giudice tributario. In sede giudiziaria, il contribuente può far valere vizi procedurali (mancato contraddittorio, notifica irregolare dell’avviso, eccesso di potere) o di merito (addebiti infondati). Ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di accertamento “a tavolino” la violazione del termine di 60 giorni non comporta automaticamente nullità (in passato) , ma oggi il contraddittorio obbligatorio la supera. La motivazione del difensore deve basarsi sul raffronto fra il PVC/schema e l’avviso, cercando errori di fatto, valutazioni non fondate o calcoli errati.
Sintesi del procedimento: i controlli fiscali si svolgono in fasi: informale/verifiche, contraddittorio formale, avviso definitivo, ricorsi. Ad ogni fase il contribuente (qui consulente ESG) può reagire presentando memorie e documenti, partecipando alle adunanze (giudiziarie) con un avvocato tributarista, e utilizzando strumenti deflativi (adesione, mediazione). Il contraddittorio endoprocedimentale è cruciale: come impone l’art. 6-bis, l’Amministrazione deve comunicare un progetto di atto, assegnare almeno 60 giorni per controdeduzioni, ed è obbligata a prenderle in considerazione . L’atto finale deve motivare le ragioni per non accogliere le osservazioni del contribuente . Ad esempio, se il consulente ha documentato un pagamento o una spesa, l’ufficio deve spiegarne il diniego motivatamente . Se questo non accade, l’avviso può essere impugnato per vizio di motivazione.
5. Novità legislative e giurisprudenziali (aggiornamenti 2024-2025)
Negli ultimi anni sono intervenute modifiche normative e pronunce giudiziarie rilevanti per la difesa del contribuente nell’accertamento fiscale. Tra le più significative:
- Contraddittorio obbligatorio (novità 2024-25): L’introduzione del comma 6-bis nell’art.6 dello Statuto del contribuente (L.212/2000) – realizzata con il D.Lgs.219/2023 (c.d. “Decreto fiscale collegato al Piano Straordinario”) – ha codificato il principio del contraddittorio preventivo . Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.21271/2025, hanno stabilito che tutti gli accertamenti fiscali, anche quelli “a tavolino” (senza accesso), devono essere preceduti da un contraddittorio formale con il contribuente; in mancanza l’atto è annullabile senza necessità di provare l’incidenza delle osservazioni . In pratica, d’ora in poi il contribuente, ricevendo un progetto di accertamento, potrà sempre presentare controdeduzioni e vedersi obbligatoriamente valutare dall’Amministrazione prima dell’avviso definitivo.
- Termine di 60 giorni (Cass. 3695/2025): La Corte di Cassazione (ordinanza 3695/2025) ha chiarito che, in ipotesi di accertamento eseguito a tavolino, la sola violazione del termine di 60 giorni per il contraddittorio non comporta di per sé la nullità dell’avviso . Tuttavia, con il nuovo art.6-bis tale distinzione ormai è superata: benché la Cassazione affermi che senza contraddittorio “a tavolino” non scatta automaticamente la nullità, oggi il legislatore impone il contraddittorio in quasi tutti i casi . In pratica, il contribuente potrebbe ancora contestare la mancata indicazione dei termini (ad es. se vi è stato un accesso difforme dalla norma), ma potrà soprattutto invocare l’art.6-bis per ottenere l’annullamento dell’atto.
- Notifica PEC (Cass. 3703/2025): Con l’ordinanza 3703/2025 la Cassazione ha precisato che, in caso di PEC fallita per indirizzo non attivo, la Pubblica Amministrazione può validamente provvedere con deposito telematico e pubblicazione sul proprio portale (seguite da raccomandata informativa), senza dover ripetere il tentativo via PEC dopo 7 giorni (previsto solo se la casella è satura) . Ciò conferma che un atto notificato con modalità alternative è efficace, a condizione di seguire le forme previste. Dal punto di vista del contribuente, significa che la notifica manca solo se anche la raccomandata informativa non arriva.
- Accertamenti integrativi e nuovi elementi (Cass. 10226/2024): Con sentenza n.10226 del 16/4/2024 la Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione può integrare o modificare in aumento un avviso di accertamento anche se nuovi elementi provengono da un ufficio diverso da quello emittente . In pratica, i dati acquisiti dagli ispettori (GdF o altri uffici) possono essere utilizzati da qualsiasi Ufficio dell’Agenzia per notificare avvisi integrativi, purché siano “nuovi elementi” sopravvenuti. Questo rafforza la cooperazione tra uffici (anche esteri) e segnala al contribuente che informazioni emerse in uno scambio interno possono riaprire il caso. Resta comunque necessaria la motivazione: il contribuente può contestare tali nuovi avvisi se dimostra di non aver avuto possibilità di difesa sui dati sopravvenuti.
- Statuto del contribuente riformato (D.Lgs. 219/2023): Oltre all’art.6-bis, le modifiche del 2023 hanno ridefinito i tempi e procedure dell’accertamento (cfr. le distanze minime tra termine contraddittorio e decadenza, visti all’art.6 dello statuto ). Si ricorda inoltre che la legge 212/2000 garantisce princìpi generali: es. collaborazione e buona fede tra ufficio e contribuente, tutela della riservatezza (art. 7 bis), semplificazione. Questi princìpi, pur non direttamente applicabili in contenzioso, orientano la valutazione degli atti.
Fonti normative principali: Statuto del contribuente (L. 212/2000, con art.6-bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023), DPR 600/1973 (Testo Unico accertamenti IRPEF), D.Lgs. 254/2016 (rendicontazione non finanziaria), D.Lgs. 74/2000 (reati tributari, art.13-bis), D.Lgs. 462/1997 e D.Lgs. 241/1997 (integrazione accertamenti previdenziali) e vari regolamenti attuativi.
6. Esempi pratici e simulazioni
Esempio 1: Mario Rossi, consulente ESG, regime ordinario, ha emesso fatture per €50.000 annui. La GdF effettua un accesso presso di lui, sospettando ricavi non dichiarati. In fase di verifica, Mario mostra contratti e pagamenti bancari. Dopo il verbale, l’Agenzia conferma un maggior reddito di €10.000 per fatture ritenute “inutili”. Con l’avviso, richiede IRPEF + sanzioni + interessi su €10k e contributi INPS aggiuntivi (gestione separata). Mario impugna l’atto contestando la motivazione (forse giustificazioni valide per quei €10k) e sottolineando la mancanza di contraddittorio ufficiale: presenta memorie difensive in Commissione Tributaria. Se invece Mario avesse avuto il forfettario, avrebbe potuto vedere un calcolo di imposta più semplice (imposta sostitutiva ridotta) ma comunque l’Agenzia avrebbe potuto verificare coerenza reddito/spese (per es., l’acquisto di un’auto costosa non giustificato dai redditi dichiarati).
Esempio 2: Un consulente ESG in regime forfettario riceve un questionario dall’Agenzia Entrate con richieste di chiarimenti (es. confermare l’ammontare dei ricavi, dettagliare le attività svolte, giustificare acquisti strumentali rilevanti). In risposta, fornisce documentazione aggiuntiva (contratti, specifiche tecniche del software utilizzato per report). L’ufficio valuta le osservazioni. Questa fase informale evita un avviso, dimostrando la trasparenza della gestione. Se non fosse soddisfatto, seguirebbe il formalissimo avviso di accertamento (con contraddittorio garantito).
Esempio 3: Un professionista ESG riceve un avviso integrativo (IRPEF e contributi INPS) basato su controlli incrociati con gli elenchi INPS: secondo l’Agenzia, Mario aveva omesso di dichiarare €5.000 percepiti occasionalmente. Grazie alla Cass. 10226/2024 , l’ufficio può notificare l’integrazione perché ha acquisito quel dato da un altro ufficio (INPS). Mario contesta però che quei €5.000 erano già inclusi nel reddito dichiarato o non rientranti nel lavoro autonomo; impugna dimostrando l’errore o che il denaro proveniva da rimborso spese.
7. Domande e risposte frequenti
- D: Su quali attività può cadere l’accertamento fiscale?
R: Sulle prestazioni di consulenza ESG svolte e sulle relative fatture. Ad esempio, l’Agenzia potrebbe esaminare se i compensi fatturati risultano giustificabili (coerenza con i tempi e il contenuto delle consulenze), se sono state applicate correttamente l’IVA o la ritenuta, o se vi sono omissioni in dichiarazioni (IVA o Redditi). - D: Quali sono i diritti del consulente durante il controllo?
R: Il consulente ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale (bozza d’atto e 60 giorni per rispondere) , a ricevere una motivazione chiara nell’avviso, a un equo trattamento (Statuto del contribuente). In sede di accesso può assistere al verbale e controfirmarlo, presentare memorie difensive. Se l’avviso è notificato, può ricorrere entro 60 giorni in CTP. - D: È possibile chiudere l’accertamento senza contenzioso?
R: Sì. Si possono usare strumenti deflativi: ad esempio autotutela (chiedere all’Amministrazione di revocare l’atto per errori evidenti, cfr. art.2-quater L.564/1994) ; accertamento con adesione (negoziare con l’ufficio una definizione che riduce imposte/sanzioni) o acquiescenza (pagamento parziale a condizioni agevolate). Tali strumenti vanno valutati caso per caso con il fiscalista, specie quando le contestazioni sono fondate ma si vuole abbattere gli oneri del contenzioso. - D: Come difendersi da un atto dell’INPS per contributi non versati?
R: L’avviso di addebito INPS può essere impugnato davanti alla CTP competente per materia previdenziale (tutte le Sezioni Tributarie). Tuttavia, spesso è conveniente regolarizzare spontaneamente i contributi (ravvedimento INPS o richiesta autocertificazione), presentando poi opposizione ridotta o mediazione. Si ricorda che, come l’INPS stesso informa, un accertamento IRPEF comporta l’estensione all’INPS dei contributi sui maggiori redditi : dunque, è fondamentale controllare la propria posizione contributiva in parallelo. - D: Cosa succede se la Guardia di Finanza trova irregolarità?
R: Se la GdF accerta violazioni fiscali, redige un PVC e può chiedere chiarimenti. Contestualmente, potrà segnalare i rilievi all’Agenzia delle Entrate, che potrà emettere un avviso d’accertamento sulla base del verbale . Il consulente deve rispondere alle contestazioni (memorie difensive entro il termine) o valutare l’adesione al PVC. In generale, come noto, ignorare il PVC o tardare la risposta peggiora la posizione (il verbale diventa definitivo) . Collaborare dimostra buona fede e può ridurre l’impatto dell’accertamento formale successivo. - D: Quali sanzioni e interessi posso subire?
R: In generale, le sanzioni amministrative tributari variano dal 30% al 240% dell’imposta evasa (art.13 D.Lgs. 472/97). Se la violazione è lieve o spontaneamente sanata (ravvedimento), le sanzioni possono essere ridotte (ad es. ravvedimento sprint: 0,2% al giorno di mora + sanzioni ridotte al 3%). Nelle adesioni spesso si concorda sanzione al 3-10% + interessi. Importante: con il nuovo Statuto, l’abuso formale o manifestamente infondato (es. errore aritmetico) può portare all’annullamento delle sanzioni . - D: Come si può contestare un avviso di accertamento?
R: Per esempio, rilevando errori matematici, incompletezze nella motivazione, dubbi sulla competenza (ad esempio competenza territoriale errata), difetto di contraddittorio o vizi di notifica. In sede giudiziaria, il ricorso deve focalizzarsi sui punti deboli dell’avviso (mancata incidenza di osservazioni, ecc.). Spesso serve anche evidenziare l’innocenza di base: ad esempio, dimostrare che un certo importo contestato era già stato dichiarato o che i criteri di calcolo erano sbagliati.
8. Strategie difensive e suggerimenti pratici
- Documentazione chiara: Conservare contratti, offerte, report, delibere societarie sulla consulenza ESG. Se possibile, firmare verbali di consegna del progetto con l’azienda cliente. In caso di controllo, avere ordinati tali documenti aiuta a dimostrare l’effettività delle prestazioni (e.g. orari delle consulenze, attenendosi alle competenze dichiarate).
- Trasparenza fatturazione: Indicare dettagliatamente in fattura la natura del servizio (“consulenza su rendicontazione ESG”, “audit di sostenibilità”, ecc.), evitando voci generiche che possono confondere o far sorgere dubbi di “tangente fiscale”.
- Riconciliazioni contabili: Se si è operato per via consulenziale, assicurarsi che il conto economico del cliente rifletta queste consulenze, e viceversa che i documenti del cliente riconcilino l’onorario. In caso di reclami sulla deducibilità da parte del cliente, avere conferme scritte (email) circa l’esecuzione delle prestazioni può difendere il consulente da contestazioni di “prestazione simulata”.
- Ritardi e rimedi spontanei: Se si riscontra un errore (ad es. ritardo nel versamento delle ritenute o contributi), conviene regolarizzare al più presto tramite ravvedimento operoso (riduce sanzioni) o istanza di autotutela. Ad esempio, se alla dichiarazione dei redditi manca un compenso già incassato, si può presentare una dichiarazione integrativa pagando le imposte evase. Gli uffici solitamente guardano con favore a chi si corregge senza attesa di controllo.
- Utilizzo dell’autotutela: Se dopo la notifica un consulente nota un errore evidente dell’ufficio (es. ICI già versata, doppio conteggio), può chiedere l’annullamento in via amministrativa (istanza motivata). Come spiega la Cassazione, è prevista un’autotutela anche più “obbligatoria” in caso di sentenze definitive che annullano un atto . L’autotutela non sospende i termini per ricorso, ma può essere allegata al giudice come impegno.
- Adesione all’accertamento: Se una parte delle contestazioni è corretta (es. voci di reddito oggettivamente sballate), il contribuente può proporre di definire con l’ufficio, accettando ad esempio parte delle imposte e ottenendo sconti sulle sanzioni. Questo evita lunghe cause. Il D.Lgs.218/1997 disciplina l’adesione. È bene considerarla quando la difesa appare difficoltosa: gli uffici danno generosamente sconti in cambio di certezza amministrativa.
- Ricorso tributario: In alternativa alla definizione bonaria, il ricorso giudiziario resta il mezzo principe. Si ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. In giudizio è essenziale produrre tutte le prove (fatture, documenti, esperti, testimonianze tecniche se servono) e puntare sui vizi individuati. Spesso i tributaristi consigliano di fare anche un’azione cautelare (segnalare vizi gravi subito all’ufficio giustizia tributaria) e preparare il ricorso nei termini.
9. Conclusioni
Il consulente ESG deve approcciare l’accertamento fiscale come qualsiasi altro contribuente professionista, rispettando le procedure e avvalendosi dei suoi diritti (contrastare vizi, presentare difese). Le riforme recenti (Statuto aggiornato, giurisprudenza Cass.) hanno rafforzato le tutele: in particolare, il nuovo obbligo di contraddittorio estende le garanzie procedurali. È quindi fondamentale essere proattivi: tenere documentazione esaustiva, rispondere ai solleciti, valutare gli strumenti deflativi e, se necessario, ricorrere con competenza. In ogni caso, conviene rivolgersi a un avvocato tributarista esperto, specie quando si profilano controversie complesse (accertamento integrativo, questioni penal-fiscali, etc.).
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale in qualità di consulente ESG o professionista che si occupa di sostenibilità, governance e responsabilità ambientale e sociale? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento fiscale in qualità di consulente ESG o professionista che si occupa di sostenibilità, governance e responsabilità ambientale e sociale?
Ti contestano redditi non dichiarati, spese non deducibili o incongruenze nei compensi professionali?
👉 Prima regola: anche nel nuovo settore della consulenza ESG, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare in modo concreto l’irregolarità fiscale.
Molti accertamenti nascono da presunzioni di redditività o da errori di classificazione dell’attività, che possono essere facilmente contestati con una difesa documentata e precisa.
⚖️ Quando scatta l’accertamento fiscale
L’Agenzia delle Entrate può avviare controlli nei confronti dei consulenti ESG in caso di:
- Scostamenti dagli indici di affidabilità fiscale (ISA) o dai vecchi studi di settore.
- Movimentazioni bancarie non coerenti con i redditi dichiarati.
- Omissioni di fatture o compensi professionali.
- Compensi da consulenze internazionali non dichiarati o non tassati correttamente.
- Spese professionali dedotte (software, trasferte, corsi ESG, certificazioni) ritenute non inerenti.
- Dichiarazioni IVA o IRPEF irregolari o mancato rispetto degli obblighi contabili digitali.
📌 Le conseguenze della contestazione
- Recupero delle imposte su redditi ritenuti non dichiarati (IRPEF, IVA, IRAP).
- Sanzioni amministrative fino al 180% dell’imposta accertata.
- Interessi di mora sulle somme dovute.
- Accertamenti bancari e indagini patrimoniali su conti personali e aziendali.
- Rischio di procedimento penale per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione, se gli importi superano le soglie di rilevanza penale.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- L’accertamento si basa su prove reali o semplici presunzioni?
- L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’atto?
- Le fatture elettroniche e i compensi sono stati interpretati correttamente (es. consulenze miste, ESG e compliance)?
- Le spese professionali (formazione, consulenze esterne, strumenti digitali, viaggi) sono state considerate deducibili?
- I redditi derivano da attività in Italia o da collaborazioni internazionali soggette a convenzioni contro la doppia imposizione?
- L’atto contiene una motivazione adeguata e documentata?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento e relativi allegati.
- Fatture, contratti di consulenza, incarichi ESG e documentazione dei progetti seguiti.
- Estratti conto bancari e giustificativi dei movimenti finanziari.
- Documentazione delle spese professionali (iscrizioni a corsi, software, viaggi, strumenti digitali).
- Dichiarazioni dei redditi, registri IVA e bilanci contabili.
- Comunicazioni e-mail o PEC con clienti e fornitori, anche esteri.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare la veridicità dei redditi dichiarati e la legittimità delle spese dedotte.
- Contestare parametri e coefficienti di redditività non coerenti con l’attività ESG, che spesso ha margini variabili.
- Far valere errori di interpretazione da parte dell’Ufficio sulle voci contabili o sui compensi percepiti.
- Evidenziare vizi procedurali (mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente, notifica irregolare).
- Richiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.
- In caso di importi elevati, valutare l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e interessi.
⚖️ Difesa tributaria specializzata
Il settore ESG è ancora nuovo e in evoluzione normativa: gli accertamenti fiscali spesso si fondano su errori di classificazione delle attività professionali o su presunzioni di reddito standardizzate.
Una difesa efficace richiede una conoscenza approfondita della fiscalità dei servizi di consulenza ESG, dei contratti internazionali e delle deduzioni specifiche per la formazione e la certificazione sostenibile.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’avviso di accertamento e i documenti contabili e professionali.
- 📌 Valuta la correttezza dell’inquadramento fiscale dell’attività ESG.
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari personalizzati.
- ⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’imposta.
- 🔁 Assiste nella pianificazione fiscale preventiva per la corretta gestione di compensi, spese e collaborazioni ESG anche internazionali.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e fiscalità delle professioni emergenti.
- ✔️ Specializzato nella difesa di consulenti ESG, sustainability manager e professionisti della sostenibilità.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti fiscali ai consulenti ESG nascono spesso da errori di inquadramento o da parametri di redditività non aggiornati.
Con una difesa ben documentata, puoi dimostrare la correttezza delle dichiarazioni, tutelare la tua attività professionale e ridurre drasticamente sanzioni e interessi.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro gli accertamenti fiscali rivolti ai consulenti ESG e ai professionisti della sostenibilità inizia qui.