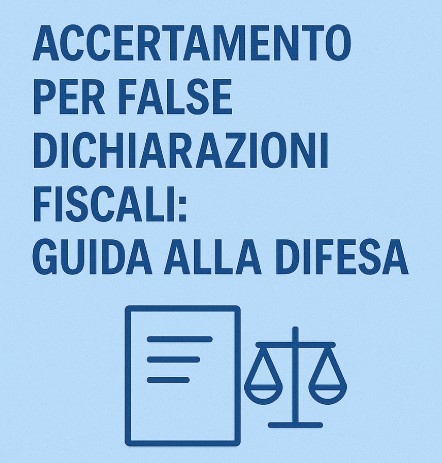Hai ricevuto un accertamento per presunte false dichiarazioni fiscali?
Si tratta di una delle contestazioni più gravi in materia tributaria, poiché l’Agenzia delle Entrate può ritenere che il contribuente abbia fornito dati non veritieri o abbia occultato informazioni rilevanti nella dichiarazione dei redditi, IVA o IRAP.
In alcuni casi, oltre alle sanzioni amministrative, l’accertamento può sfociare in un procedimento penale per dichiarazione infedele o fraudolenta (ai sensi del D.Lgs. 74/2000).
Tuttavia, non ogni errore o omissione costituisce una falsa dichiarazione: con una difesa ben documentata e tempestiva, è possibile dimostrare la buona fede, correggere gli errori e ottenere la riduzione o l’annullamento della pretesa fiscale.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta una falsa dichiarazione fiscale
– Se riscontra discrepanze rilevanti tra i redditi dichiarati e i dati in suo possesso (anagrafe tributaria, flussi bancari, fatture elettroniche)
– Se il contribuente ha indicato spese o deduzioni non documentate o inesistenti
– Se l’Ufficio rileva omissioni di redditi da lavoro, da affitto, da attività professionale o d’impresa
– Se nella dichiarazione sono state inserite fatture false o operazioni inesistenti
– Se i crediti d’imposta o le agevolazioni fiscali sono stati utilizzati senza i requisiti previsti
– Se emergono manipolazioni o irregolarità nella contabilità aziendale o professionale
Conseguenze dell’accertamento per false dichiarazioni fiscali
– Ricalcolo del reddito imponibile con richiesta di maggiori imposte (IRPEF, IVA, IRES, IRAP)
– Sanzioni amministrative dal 90% al 180% delle imposte evase
– Interessi di mora sulle somme accertate
– Decadenza da regimi agevolati o incentivi fiscali
– Nei casi più gravi, denuncia penale per dichiarazione infedele, fraudolenta o omessa (artt. 2, 3 e 4 D.Lgs. 74/2000), con rischio di sequestro e confisca dei beni
Come difendersi da un’accertamento per false dichiarazioni fiscali
– Verificare la motivazione dell’accertamento, accertandosi che l’Ufficio abbia indicato prove concrete e non mere presunzioni
– Dimostrare, con documentazione contabile, bancaria e fiscale, la veridicità dei dati dichiarati
– Produrre giustificativi e correzioni formali per dimostrare che si è trattato di errori materiali o di interpretazione
– Contestare errori di calcolo, omissioni non intenzionali o differenze dovute a criteri fiscali legittimi
– Se è stato aperto un fascicolo penale, coordinare la difesa tributaria e penale per evitare doppie sanzioni
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione cautelare della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa
– Analizzare la legittimità e la motivazione dell’accertamento
– Verificare se esistono prove effettive di falsità o solo irregolarità formali
– Contestare la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
– Redigere un ricorso fondato su prove documentali e giurisprudenza consolidata
– Difendere il contribuente nel procedimento tributario e, se necessario, penale
– Tutelare il patrimonio personale da sequestri e confische preventive
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La riduzione delle sanzioni in caso di buona fede o errore non doloso
– La sospensione delle procedure di riscossione e delle misure cautelari
– L’esclusione della responsabilità penale se manca la prova dell’intenzionalità
– La tutela del patrimonio e della reputazione professionale
⚠️ Attenzione: l’accertamento per false dichiarazioni fiscali non sempre corrisponde a un illecito penale.
Molti contribuenti vengono accusati di “dichiarazione infedele” per errori contabili o interpretazioni fiscali controverse, facilmente sanabili.
Agire subito con una difesa legale esperta e documentata è essenziale per evitare che una contestazione amministrativa si trasformi in un procedimento penale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e difesa nei procedimenti per reati fiscali – spiega come difendersi in caso di accertamento per false dichiarazioni fiscali, quali errori verificare e quali strategie adottare per tutelare i propri diritti e il proprio patrimonio.
👉 Hai ricevuto un accertamento per presunte false dichiarazioni fiscali?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso, verificheremo la fondatezza delle accuse e costruiremo una strategia di difesa efficace per ottenere l’annullamento dell’accertamento e proteggere la tua posizione fiscale e penale.
Introduzione
L’accertamento tributario per false dichiarazioni fiscali è il complesso delle attività di verifica svolte dall’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) in presenza del sospetto che un contribuente abbia indicato dati fittizi o infedeli nelle proprie dichiarazioni annuali (IRPEF, IRES, IVA). Il contribuente coinvolto si trova spesso a fronteggiare due profili di rilievo: da un lato l’aspetto tributario-amministrativo (sanzioni pecuniarie, riscossione coattiva, contenzioso tributario); dall’altro quello penale, poiché alcune condotte possono configurare un reato tributario. Questa guida, rivolta ad avvocati, privati e imprenditori, spiega dettagliatamente le normative applicabili e le strategie difensive possibili – dal contraddittorio tributario alle ipotesi di ravvedimento e di estinzione del reato – sempre dal punto di vista del contribuente/debitore.
Quadro normativo di riferimento
Reati tributari dichiarativi (D.lgs. 74/2000)
Il testo di riferimento per i reati dichiarativi in materia di imposte dirette e IVA è il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha sostituito le precedenti norme penali. Le fattispecie più rilevanti sono:
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000): il contribuente dichiara elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi, senza usare fatture false o altri artifizi fraudolenti. In tal caso è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi, se l’imposta evasa supera 100.000 € e gli elementi sottratti all’imposizione eccedono il 10% del totale dichiarato oppure 2.000.000 € . (La riforma del 2019 ha elevato il limite massimo di pena fino a 5 anni , ma la soglia di 100.000 € rimane il presupposto essenziale .) In altre parole, per la dichiarazione infedele il contribuente va in esenzione penale se non supera entrambe le soglie (imposta <100k o attivo sottratto <10% e <2 mln).
- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000): il contribuente utilizza nel bilancio fatture false o documenti fittizi per evadere imposte. Se l’ammontare dei passivi fittizi supera 100.000 €, la pena è da 4 a 8 anni di reclusione; se invece resta inferiore, si applica il trattamento “ridotto” da 1 anno e 6 mesi a 6 anni . Non esiste soglia di punibilità minima diversa dalle predette (cioè in teoria qualsiasi utilizzo di documenti falsi è reato, con pena crescente dopo 100k).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000): la condotta prevede l’uso di artifici diversi dalle fatture false per evadere (per es. simulazioni, ritenute fittizie). Si richiede il superamento di due soglie congiunte: imposta evasa >30.000 € e attivi sottratti >1.500.000 € (o >5% del totale) . La pena è reclusione da 3 a 8 anni.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000): il contribuente non presenta la dichiarazione annuale (IRPEF/IRES/IVA o 770 come sostituto d’imposta) pur dovendola presentare, con l’intento di evadere tributi. Il reato scatta se l’imposta evasa supera 50.000 € per ciascuna imposta . In tal caso la pena è da 2 a 6 anni di reclusione (il limite massimo era 5 anni prima delle riforme recenti ). Si segnala che una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza non è considerata “omessa” (cosiddetto ritardo lieve): per tale violazione la legge non prevede reato .
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000): produzione di fatture false al fine di ottenere un vantaggio fiscale o indurre in errore l’Amministrazione. La pena è reclusione da 4 a 8 anni. (Questa norma è di solito inquadrata come reato tributario documentale, ma spesso collegato a dichiarazioni infedeli.)
Altri reati strumentali (es. occultamento di documentazione contabile – art. 10 –, omesso versamento di ritenute – art. 10-bis –, omesso versamento IVA – art. 10-ter –, indebita compensazione – art. 10-quater –, sottrazione fraudolenta – art. 11 D.lgs. 74/2000) possono anch’essi integrare responsabilità penali fiscali, ma qui ci concentriamo sulle “dichiarazioni”.
Fonti normative: D.Lgs. 74/2000 (nuova disciplina reati tributari, articoli 2-5,8); L. 157/2019 (conversione D.L. 124/2019, modifiche al D.lgs. 74/2000); D.Lgs. 128/2015; D.Lgs. 87/2024; D.Lgs. 173/2024 (TU sanzioni tribut.).
Sanzioni amministrative (penali tributarie collegate)
Parallelamente ai reati penali, la legge tributaria punisce l’infedeltà delle dichiarazioni anche con sanzioni amministrative pecuniarie (non penali). In particolare, il D.Lgs. 471/1997 stabilisce sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa per la dichiarazione infedele (art. 2), riducibili in caso di ravvedimento operoso fiscale (art. 13 D.Lgs. 472/97). Sanzioni ridotte (50%) si applicano per alcune violazioni formali (dichiarazione tardiva, incompleta) . Altri articoli (art. 5 e 6 D.Lgs. 471/97) prevedono maggiorazioni se la dichiarazione omessa o infedele risulta in omissione di somme significative (es. oltre 500.000 €).
Nota: qui non citiamo il testo di 471/97, ma è importante ricordare che il tributo non corrisponde al costo penale; ad esempio la definizione agevolata (ravvedimento amministrativo) consente di regolarizzare entro 30/90 giorni riducendo sanzioni a poco più di 1/10. Tuttavia, per l’accertamento per “false dichiarazioni” il profilo penale rimane centrale se scattano i reati.
Cause di estinzione e attenuanti penali tributarie
Negli ultimi anni il Legislatore ha introdotto meccanismi favorevoli al contribuente che “sani” spontaneamente la propria violazione. In particolare:
- Ravvedimento operoso (penale) – Art. 13 D.lgs. 74/2000, comma 1-bis (introdotto dal D.L. 124/2019, conv. L.157/2019) prevede che il reato (anche fraudolento) si estingue se il contribuente paga integralmente il debito tributario (imposte, sanzioni e interessi) prima di essere sottoposto a controlli o a procedimento penale . In sostanza, chi si pente e si autodenuncia pagando tutto non subisce la condanna (il reato si estingue). Questa novella ha “esteso” al reato fraudolento il principio già previsto per omessa o infedele .
- Cause di non punibilità – Oltre al ravvedimento, permangono le attenuanti generali e le cause speciali previste dal d.lgs. 74/2000: in particolare, nessun reato sussiste se l’ammontare (ovvero gli elementi sottratti) differiscono per meno del 10% da quelli corretti. Questa soglia di scarto è stata in parte riveduta: il D.L. 124/2019 inizialmente la aboliva, ma il testo definitivo di conversione ha mantenuto una “zona franca” del 10% (o dell’imposta evasa inferiore al 10% di 100.000 €) .
- Responsabilità degli enti (D.lgs. 231/2001) – Dal 2020 la commissione di reati fiscali può anche far scattare la responsabilità amministrativa della società (modello 231), con effetti ulteriori (sanzioni pecuniarie nei confronti dell’ente, confisca allargata) .
Queste previsioni sono rilevanti in sede penale, ma incidono anche sulle strategie di difesa: per esempio, conoscere i termini per regolarizzarsi penalmente permette di evitare il processo o mitigare la pena.
Procedura di accertamento tributario
Fase precontenziosa: controllo e contraddittorio
L’iter tipico di un accertamento fiscale per false dichiarazioni si svolge come segue:
- Selezione del contribuente: l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) può attivare un controllo basato su segnalazioni, incroci di dati (es. redditometro, ISA, controlli incrociati), oppure avvisi anonimi. Anche precedenti anomalie nella posizione fiscale (utilizzo di crediti su fatture dubbie, contenziosi pendenti, ecc.) possono destare sospetti.
- Verifica in contraddittorio: prima di emettere l’avviso d’accertamento, l’amministrazione è tenuta – di norma – a fornire al contribuente elementi di prova e motivazioni, dando la possibilità di spiegazioni o di produrre documentazione integrativa. Questa fase è prevista dall’art. 12 del DPR n. 600/1973 (per imposte dirette) e dall’art. 12-bis del DPR n. 633/1972 (IVA). In caso di accertamenti complessi, si svolge un vero e proprio contraddittorio «verbale» in presenza del contribuente o del suo consulente.
- Contestazioni formali (avviso d’accertamento): se l’Agenzia persiste nelle sospette irregolarità, notifica un avviso di rettifica o liquidazione. Nel documento vengono esposte le poste di reddito o imposta rettificate (es. maggiori ricavi non dichiarati, costi indeducibili, IVA da rettificare), con conseguente calcolo dell’imposta suppletiva dovuta più sanzioni ed interessi. Per “false dichiarazioni” le contestazioni includono in genere riclassificazioni di voci di bilancio, indicazione di operazioni inesistenti o rettifiche di IVA non ritenuta detraibile. L’avviso d’accertamento può essere preceduto da un avviso di garanzia penale (se l’ufficio ritiene di poter ipotizzare reato), ma spesso il profilo penale si affianca a posteriori (vedi oltre).
- Autotutela extragiudiziale: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela (richiesta di annullamento in autotutela, motivata con nuovi elementi) oppure aderire a un accordo di adesione/fissazione concordata dell’imposta (solo in casi di omessi versamenti dichiarativi, D.Lgs. 218/1997). In caso di ravvedimento entro i termini, può regolarizzare con riduzione delle sanzioni (ravvedimento operoso previsto da D.Lgs. 472/97). Il ricorso gerarchico al Direttore regionale o Provinciale non è previsto per le imposte dirette e IVA; occorre ricorrere in Commissione tributaria.
- Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (TP): se l’autotutela fallisce, il contribuente può impugnare l’accertamento davanti alla giustizia tributaria. Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni alla CTP territorialmente competente, corredato da memoria difensiva e documenti. In questa fase la strategia difensiva consiste principalmente nel contestare l’interpretazione dei fatti e delle prove prodotte dall’Amministrazione: ad es. dimostrando la genuinità di ricavi o fatture contestate, indicando violazioni procedurali nell’accertamento, o addossando l’“onere della prova” all’Amministrazione (a sensi dell’art. 2697 c.c., la legge attribuisce in materia tributaria all’Agenzia il compito di provare l’esistenza dell’imposta non versata). In sostanza si evidenzia che il contribuente ha documentato la propria posizione e che ogni differenza è arbitraria.
- Grado di appello e Cassazione tributaria: avverso la sentenza della CTP è possibile appellare alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni, poi eventualmente ricorrere in Cassazione tributaria (Corte Suprema – Sez. Unite) su questioni di diritto.
- Esiti dell’accertamento (civile): in via amministrativa si definisce con il pagamento delle imposte aggiuntive + sanzioni/ interessi decisi in sentenza, o con annullamento totale/parziale. Il giudizio si concentra sulla correttezza del calcolo fiscale e sulla legittimità delle sanzioni.
Tabella 1 – Iter di un accertamento per false dichiarazioni (schematicamente)
| Fase | Tempistica | Organi coinv. | Possibili azioni del contribuente |
|---|---|---|---|
| Accertamento (indagini) | ● Avvio sospetto (tempo var.) | Agenzia Entrate / GdF | – Memorie di contraddittorio, produzione di documenti giustificativi. |
| Notifica avviso di accertamento | Entro 3 anni (imposte dirette), 4 anni (IVA) dall’ult. dichiarazione | Ufficio fiscale | – Istanza di autotutela, ravvedimento (entro 30 gg per IVA, 90 gg per redditi). |
| Contenzioso (ricorso TPC) | 60 gg dal ricevimento avviso | Commissione Tributaria Prov. | – Ricorso motivato (con ass. procuratore fiscale), prova documentale della correttezza. |
| Appello e Cassazione (facolt.) | 60 gg dalla sentenza TPC (appello), 60 gg CTR (Cass.) | Commissione Regionale; Corte di Cassazione (Tributaria) | – Memorie integrative, audizione periti di parte, tecnici, testimoni (se ammessi). |
| Esecuzione (civile) | 6 mesi dalla sentenza divenuta definitiva | Ag. Entrate riscossione | – Ricorso per cassazione cautelare o esenzione (es. rateazione contributo). |
In ogni fase è fondamentale una difesa documentale accurata. In particolare, il contribuente dovrebbe verificare di aver conservato tutte le fatture, prove di spese o contratti giustificativi. In caso di contestazione di fatture presumibilmente “false”, deve preparare perizie (es. autodichiarazioni del fornitore, contratti vincolanti, corrispondenza) che attestino la reale sussistenza dei servizi o beni. Nei ricorsi tributari, la giurisprudenza afferma che l’onere di provare l’imposta dovuta incombe sull’Amministrazione (art. 2697 c.c.); la difesa può quindi evidenziare la genericità della contestazione e la mancanza di prove certe di omesse dichiarazioni.
Elementi penali e difesa in ambito penale
Quando un accertamento tributario rivela oltre una certa soglia di imposta evasa (come visto), può essere trasmesso all’Autorità giudiziaria e dare origine a un procedimento penale. L’avviso di conclusione delle indagini o l’avviso di garanzia segnala l’avvio di questo percorso, che segue la legge penale (D.Lgs. 74/2000 e codice penale). In sede penale è importante distinguere:
- Dolo tributario: tutti i reati visti richiedono almeno dolo generico (intenzione di evadere il fisco). L’istruttoria giudiziaria dovrà accertare la coscienza e volontà del contribuente nel compiere la condotta, non basta l’errore.
- Prescrizione e termini: i reati tributari si prescrivono in 7 anni (art. 157 c.p.), ma la prescrizione si interrompe con atti interruttivi (notifica dell’avviso di garanzia, ecc.). È quindi fondamentale agire prontamente (tentare il ravvedimento penale, patteggiamento, o presentare motivata opposizione a sequestro) non appena si è avvisati.
- Sequestro preventivo: in caso di reato tributario può essere disposto il sequestro dei beni ritenuti profitto del reato o strettamente correlati (artt. 53-54 d.lgs. 74/2000; art. 321 c.p.p.). Il contribuente può presentare reclamo o opposizione al sequestro motivando la sproporzione o la legittima provenienza dei beni.
- Stragiudizialità e collaborazioni: il contribuente può collaborare con la P.G. fornendo documenti che facciano luce sulle operazioni contestate; talvolta la confessione (o ammissione del credito) può attenuare la posizione. Tuttavia, l’ammissione spontanea non scrimina completamente, se non nei casi di ravvedimento (pagamento integrale, v. sopra).
- Difesa tecnica e modelli di atto: è essenziale affidarsi a un penalista tributarista per impostare la strategia. Alcuni atti difensivi tipici sono: memoria per chiedere archiviazione (argomentando l’assenza di dolo o l’insussistenza dei presupposti di reato), atto di opposizione a sequestro preventivo, istanza di riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato con richiesta di attenuanti generiche e messa alla prova, se compatibile). Ad esempio, nel giudizio abbreviato la Corte di Cassazione ha di recente confermato che – salvo violazioni costituzionali – la scelta del rito impone la non rilevabilità delle nullità procedurali di lieve entità ; tuttavia ogni violazione degli artt. 63-65 c.p.p. (garanzie degli indagati) deve essere tempestivamente denunciata.
- Patteggiamento e riti alternativi: se il contribuente ammette parzialmente la condotta o vuole limitare il rischio di una pena alta, può optare per un patteggiamento (il reato è estinto pagando una multa e, se prevista, concedendo collaborazione), oppure per il rito abbreviato (50% di pena e niente appello). In entrambi i casi è possibile chiedere le attenuanti generiche e far valere la non abitualità dell’illecito, la buona fede (se manifestamente scusabile) o l’inesperienza nel campo tributario.
- Dibattimento: in Tribunale penale il contribuente è difeso da un avvocato, può chiamare testimoni (ad es. il fornitore delle fatture contestate), depositare perizie contabili di parte e chiedere la nullità degli accertamenti fiscali contraddetti da dati certi. Ad esempio, il Tribunale può esaminare la reale funzionalità economica delle fatture impiegate e la mancanza di artificiosità nel bilancio. Se vi è errore nelle poste attive/passive, si può chiedere l’assoluzione per mancanza di dolo.
- Sentenze penal-tributarie: la Corte di Cassazione è intervenuta spesso sul tema. Riferimenti recenti: la sentenza n. 32019/2025 ha, ad esempio, ribadito che in un giudizio abbreviato sono utilizzabili anche dichiarazioni rese da persone informate sui fatti se non toccano divieti probatori costituzionali ; una pronuncia del 2024 (Cass. 41419/2024) ha affrontato il problema della prescrizione in reati fiscali ; la CEDU (nella sent. Nealon e Hallam vs Italia 2021) ha esaminato profili di proporzionalità nei reati fiscali. In generale, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l’oggettiva complessità di questi reati e l’importanza di un corretto contraddittorio fiscale, sia in sede amministrativa che penale.
Principali modifiche normative recenti
Negli ultimi anni il Legislatore ha apportato cambiamenti significativi:
- D.Lgs. 128/2015: aveva reintrodotto la causa di non punibilità del pagamento del debito per omessa dichiarazione e per altri reati “non fraudolenti”, estendendo il ravvedimento penale (già in Art.13 per infedele/omessa).
- D.L. 124/2019 (conv. L.157/2019): ha inasprito pene e abbassato soglie per reati “fraudolenti”, ma soprattutto ha esteso al reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2-3) l’istituto del ravvedimento operoso . Con art.13-bis d.lgs. 74/2000 modificato, oggi anche chi ha emesso fatture false può estinguere il reato pagando tutto (imposte e sanzioni) prima di controlli formali . Inoltre, la L.157/2019 ha equiparato i reati penali tributari agli altri reati nell’applicazione del D.lgs. 231/2001 alle società .
- Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022 e delega fiscale): ha delineato la riforma complessiva. Tra le novità attese: l’innalzamento da 50.000 a 100.000 € della soglia di punibilità per l’omessa dichiarazione (per allinearla all’infedele), e l’ampliamento dei casi di ravvedimento “speciale” per violazioni dichiarative.
- D.Lgs. 87/2024 – “Decreto sanzioni tributarie”: ha riordinato (e parzialmente modificato) il sistema sanzionatorio. In realtà, come osservato dagli esperti, tale decreto non ha rivoluzionato i reati dichiarativi, concentrandosi soprattutto sulle fattispecie di riscossione (omessi versamenti e indebita compensazione) e sulla modulazione di confisca e non punibilità dopo il pagamento . In breve: nulla cambia di sostanziale sui reati di false dichiarazioni (restano art.2-5 D.lgs.74/2000 in vigore), ma sono stati confermati strumenti come la non punibilità per il pagamento integrale (la causa di estinzione) anche all’interno del nuovo TU .
- D.Lgs. 173/2024 – Testo Unico: il 5 novembre 2024 è entrato in vigore il nuovo “Testo unico delle sanzioni tributarie” . Questo decreto ha la sola funzione di raccogliere in un unico corpo le norme già esistenti (senza cambiamenti sostanziali) . Di conseguenza, le disposizioni in materia penale tributaria rimangono formalmente quelle del D.lgs. 74/2000, 471/1997, ecc., ora codificate nel TU.
Riferimenti normativi: D.lgs. 74/2000 (con integrazioni), D.lgs. 471/1997, D.lgs. 472/1997, D.L. 124/2019 (conv. L.157/2019), D.Lgs. 128/2015, L. 157/2019, Legge n. 197/2022 (bilancio 2023), D.Lgs. 87/2024, D.Lgs. 173/2024.
Strategie difensive e consigli pratici
Per difendersi efficacemente, il contribuente – assistito da professionisti – può muoversi su più fronti, prima e durante il contenzioso. Ecco alcune linee guida pratiche:
- In fasi iniziali: appena ricevuto un invito al contraddittorio o anche preventivamente (all’atto della consegna dei dati IVA o del mod. 770), è utile verificare con un esperto la correttezza formale della dichiarazione. Se vi sono errori materiali, si può valutare il ravvedimento operoso (art. 2-bis D.Lgs. 472/97) prima dell’inizio del contraddittorio. In ogni caso, si deve essere collaborativi nel fornire chiarimenti.
- Documentazione probatoria: predisporre un dossier completo. Per esempio, se si è accusati di avere fatture false, raccogliere contratti, ordini, email, copie dei lavori eseguiti. Se la contestazione è su plusvalenze o ricavi omessi, verificare che non si tratti di operazioni escluse o non imponibili. Anche il supporto di consulenti tecnici (commercialisti, revisori) è prezioso per dimostrare le valutazioni contabili seguite.
- Contenzioso tributario: nel ricorso in Commissione tributaria va redatta una memoria difensiva precisa. Vi si elencano tutti gli elementi inconfutabili a favore del contribuente (es. documenti, giurisprudenza favorevole, errori di calcolo dell’Agenzia) e si contesta la motivazione dell’avviso. È indispensabile fare attenzione alle scadenze; l’omessa costituzione in giudizio si traduce in perdita del diritto all’appello. Al CT si può anche richiedere l’ammissione di accertamenti documentali o testimonianze (p. es. l’ente che ha versato il credito IVA).
- Dibattito e contradditorio tecnico: in fase civile (CT) l’Agenzia parte con presunzioni semplici (“dichiarazioni formali”). La difesa deve controbattere fornendo dati concreti. In alcuni casi, può essere consigliabile ottenere una perizia giurata (per simulazioni, stime di reddito, ecc.) da un esperto indipendente, da presentare come prova tecnica di parte.
- Valutazioni penali: se viene avviato un procedimento penale, è cruciale intervenire subito. Entro i termini si possono depositare memorie difensive per chiedere l’archiviazione (esponendo l’assenza di dolo specifico, la collaborazione o il pagamento spontaneo del tributo) oppure per concordare il patteggiamento. La consulenza di un avvocato penalista tributarista serve anche a evitare atti che potrebbero aggravare la posizione (es. rilasciare dichiarazioni non concordate con il difensore).
- Uso delle attenuanti: nella strategia penale vanno cultivate tutte le circostanze attenuanti possibili: ad esempio, l’inesperienza del contribuente, la collaborazione (es. ammissione dei fatti e chiarimenti durante l’istruttoria), la commissione del reato in stato di necessità contingente (in rari casi), ecc. Spesso si ottiene la riduzione della pena di un terzo per diligenza successiva (pagamento spontaneo, aiuto alle indagini, ecc.).
- Opposizione a provvedimenti fiscali/penali: se l’Agenzia dispone sanzioni irrogate e il contribuente riceve un avviso di pagamento, si può presentare opposizione in sede tributaria. In ambito penale, contro un sequestro preventivo si può proporre opposizione ex art. 327 c.p.p. motivata (es. indicando che i beni sequestrati non rappresentano provento di reato). In ogni caso, tutte le impugnazioni devono essere tempestive.
- Mediazione e transazione: in certi casi (soprattutto se non c’è dolo palese) si cerca un accordo con l’Amministrazione; per esempio, si può ottenere uno sconto sulle sanzioni in sede di giudizio tributario, oppure la rateizzazione del debito. A volte è possibile anche negoziare con la Procura (attraverso l’istituto del patteggiamento “non colposo” in Tribunale penale).
- Documentazione d’uso comune: è utile predisporre modelli standard (bozze) di reclami al sequestro, ricorsi tributari e istanze di archiviazione, adattabili a vari casi. Ad esempio:
- Istanza di archiviazione (penale): esposizione dei fatti, dimostrazione della mancanza di dolo, indicazione di ravvedimento fattuale.
- Opposizione a sequestro penale: richiamo al principio di legalità, prove di regolare provenienza del denaro/bene, motivazioni di sproporzione rispetto al reato accertato .
- Ricorso tributario: esposizione dettagliata degli errori contabili o normativi dell’avviso, richiesta di annullamento.
Esempio pratico di difesa
Caso 1: Un libero professionista ha ricevuto una verifica fiscale con contestazione di redditi non dichiarati (sospetti parcelle “in nero”). Come difendersi? Innanzitutto, prima della verifica dovrebbe aver già sanato autonomamente il lavoro in nero (ravvedimento) e munito di fatture regolari o prove di prestazioni (es. pignoramenti su conto, liste clienti, email tra professionista e cliente). Se l’atto è notificato, rispondere subito al contraddittorio indicando le cause di irregolarità formale. Nel ricorso tributario si dovrà dimostrare che le presunte entrate “nascoste” erano in realtà non imponibili o già tassate in altro modo (per es. corrispettivi rimborsati), e che le contestazioni sono infondate. Parallelamente, qualora ci fosse anche un procedimento penale (es. per omessa dichiarazione con soglia >50k), il professionista potrebbe versare l’imposta evasa e gli interessi, chiedendo l’archiviazione del reato o, se già indagato, patteggiando una pena lieve.
Caso 2: Una piccola impresa agricola è accusata di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per evadere l’IVA (reato art. 2 D.lgs. 74/2000). La Guardia di Finanza, durante la verifica, ha sequestrato l’autocertificazione IVA e convocato il legale rappresentante. In sede penale, l’avvocato chiederà di valutare il pagamento del debito IVA con sanzioni (ravvedimento penale) prima di proseguire, sulla base dell’art.13 ss. Se necessario, si ricorrerà al contraddittorio per far valere la reale natura delle operazioni (esibendo prove dei movimenti agricoli e riconoscimento dei macchinari acquistati). Se poi l’azienda non ha commesso dolo (fornitore realmente esistente), si potrebbe argomentare che si tratta di un’infedeltà amministrativa e non di un dolo penale, puntando su questo come causa di non punibilità.
Domande frequenti
- Cos’è l’“accertamento per false dichiarazioni fiscali”?
È un controllo fiscale finalizzato a verificare se un contribuente abbia dichiarato dati infedeli (artifici contabili, fatture false o omissioni) nelle imposte sui redditi o sull’IVA. Può sfociare in sanzioni tributarie e, se superate certe soglie, in reato penale. - Qual è la differenza tra dichiarazione infedele e omessa?
Infedele significa che si dichiara meno reddito di quello effettivo (o costi fittizi), ma si è presentata la dichiarazione; omessa significa non presentare affatto la dichiarazione entro i termini. Entrambe possono essere reati, ma hanno soglie diverse: 100.000 € per infedele e 50.000 € per omessa . Inoltre, una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza esclude il reato di omessa . - Chi deve provare l’imposta evasa?
Nel processo tributario l’onere della prova dell’imposta dovuta spetta all’Amministrazione finanziaria (art. 2697 c.c.), ovvero spetta all’Agenzia dimostrare la genuinità dell’accertamento. Tuttavia, al contribuente compete documentare il proprio corretto operato. Nel penale, il Pubblico Ministero deve provare l’elemento soggettivo (dolo) e la condotta. - Quali sono le sanzioni amministrative?
In ambito tributario si applicano sanzioni pecuniarie pari al 90-180% dell’imposta evasa (art. 2 D.lgs. 471/97 per l’infedele) o percentuali abbassate con ravvedimento . Per omessa dichiarazione la sanzione è il 120% (riducibile al 6% con ravvedimento entro 30 gg). Queste sanzioni si sommano a interessi legali. - Quando nasce il reato penale?
Se l’imposta evasa (o l’IVA omessa) supera le soglie legali (100.000 €, 50.000 €), il fatto può configurare un reato (art. 4 o art. 5 D.Lgs. 74/2000). Ad esempio, dichiarazione infedele se l’imposta evasa è >100.000 € ; omessa dichiarazione se imposta >50.000 € . Superata la soglia, la condanna penale è obbligatoria (non è facoltativa come le sanzioni amministrative). - Cosa fare se ricevo una contestazione per false dichiarazioni?
Agire subito: verificare con un professionista, raccogliere documenti giustificativi, valutare la possibilità di sanare entro termini (ravvedimento). Incontrare gli uffici in contraddittorio per illustrare le proprie ragioni. Se notificato un avviso di accertamento, presentare ricorso entro 60 giorni, esponendo punto per punto la difesa. - Si può estinguere il reato pagando le imposte?
Sì. Se il contribuente paga integralmente il debito tributario (imposte + sanzioni) prima di avere notizia di indagini formali a suo carico, il reato tributario si estingue (art. 13 d.lgs.74/2000, come modificato) . In pratica il contribuente può chiedere l’archiviazione penale facendo ricorso al ravvedimento penale. Questo vale sia per l’infedele/omessa sia, dal 2019, per la fraudolenta da fatture . - Cosa rischia il professionista/impresa in concreto?
Oltre all’eventuale reclusione, il contribuente rischia multe amministrative, sospensione dal ruolo o dall’attività (in alcuni casi) e danni reputazionali. È quindi cruciale difendere la posizione anche politicamente (mantenere credibilità) gestendo bene le comunicazioni con il fisco. - Esempio numerico: se in una dichiarazione IRPEF risultano 120.000 € di imposta evasa, si tratta di reato (oltre la soglia di 100k ). Il contribuente rischia 2-5 anni di carcere (o 2-4,5 secondo testo originario) e dovrà restituire la somma con sanzioni. Se invece l’imposta evasa fosse 80.000 €, non scatta il reato ma ci sarebbe il debito + sanzione amministrativa (ad es. 90%-180% sul 80k).
Tabelle riepilogative
Tabella 2 – Principali reati tributari dichiarativi e relative sanzioni
| Reato tributario (D.Lgs. 74/2000) | Condotta tipica | Soglia di punibilità | Pena edittale |
|---|---|---|---|
| Art. 2 – Dichiaraz. fraudolenta con fatture false | Utilizzare fatture o documenti fittizi in dichiarazione per operazioni inesistenti. | Nessuna soglia minima (ma >100.000 € aggravante) | Reclusione da 4 a 8 anni; se passivi fittizi <100k, 1,6-6 anni . |
| Art. 3 – Dichiaraz. fraudolenta altri artifici | Usare arti fraudolenti/simulati diversi dalle fatture per evadere. | Imposta evasa >30.000 € e attivi sottratti >1,5 M (o >5% del totale). | Reclusione da 3 a 8 anni. |
| Art. 4 – Dichiaraz. infedele | Dichiarare elementi attivi inferiori o passivi inesistenti in dichiarazione ordinaria. | Imposta evasa >100.000 € e attivi sottratti >10% o >2.000.000 € . | Reclusione da 2 a 5 anni (2 a 4,5 anni nel testo originario) . |
| Art. 5 – Omessa dichiarazione | Non presentare la dichiarazione annuale obbligatoria entro i termini di legge. | Imposta evasa >50.000 € per ciascuna imposta . | Reclusione da 2 a 6 anni (prima max 5 anni) . |
| Art. 8 – Emissione di fatture inesistenti | Emettere/registrare fatture false al fine di evadere imposte altrui o proprie. | Nessuna soglia (con fatture false il reato sussiste di per sé). | Reclusione da 4 a 8 anni. |
Tabella 3 – Sanzioni amministrative (D.Lgs. 471/97, 472/97)
| Violazione | Normativa | Sanzione (in percentuale dell’imposta evasa) |
|---|---|---|
| Dichiarazione infedele (redditi/IVA) | Art. 2 D.Lgs. 471/97 | Da 90% a 180% (riducibile via ravvedimento al 36-9%) |
| Dichiarazione omessa (redditi/IVA) | Art. 1 D.Lgs. 471/97 | Da 120% a 240% (riducibile al 12-24% via ravved.) |
| Omissioni formali (ritardo lieve, errori form.) | Art. 3-5 D.Lgs. 472/97 | Sanzioni fisse ridotte (es. 250 €) |
| Ritenute/IVA omesse (fino a 150k/250k) | Art. 2 D.Lgs. 471/97 | 120% – 240% dell’imposta in questione |
| Ravvedimento operoso | Art. 13 D.Lgs. 472/97 | 1/10, 1/9 o 1/8 della sanzione originaria (a seconda dei giorni di ritardo) |
Queste percentuali sono indicative: il contribuente può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso amministrativo entro 30/90 giorni dall’errore pagando sanzioni ridotte (1/10 in caso di rettifica spontanea, etc.). In ambito penale, il ravvedimento integrale di cui sopra estingue invece il reato .
Conclusione
L’accertamento per false dichiarazioni fiscali è un procedimento complesso che unisce aspetti tributari e penali. Dal punto di vista del contribuente/debitore, la miglior difesa è la prevenzione (correttezza contabile, ravvedimento di errori), seguita da una tempestiva azione difensiva al primo segno di controllo (richiesta di contraddittorio, reclamo, ricorso). Se la questione finisce in tribunale (tributario o penale), è fondamentale un’assistenza legale specializzata che sappia integrare giurisprudenza e normativa aggiornata.
In sintesi, le parole chiave della difesa sono documentazione puntuale, collaborazione responsabile (anche verso l’Amministrazione), e uso strategico delle norme favorevoli (ravvedimento, depenalizzazioni, attenuanti). Ogni caso richiede analisi personalizzata, ma le guide normative qui riassunte e le recenti sentenze citate offrono un quadro di riferimento completo.
Fonti normative e giurisprudenziali: si rimandano le norme sopra indicate (D.Lgs. 74/2000, D.Lgs. 471/1997, ecc.) e la prassi/commentari citati nei rimandi. Alcune sentenze salienti citate: Cass. Penale n. 32019/2025 , Cass. Pen. n. 41419/2024 (prescrizione), Corte Cost. n. 175/2022 (ritenute certificate), Corte EDU Nealon e Hallam c. Italia (diritti della difesa nei reati fiscali).
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una comunicazione di reato tributario per presunte false dichiarazioni fiscali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una comunicazione di reato tributario per presunte false dichiarazioni fiscali?
Ti accusano di aver indicato dati non veritieri, omesso redditi, simulato costi o utilizzato fatture inesistenti?
👉 Prima regola: non confondere l’accertamento con una condanna.
La contestazione per dichiarazione infedele o fraudolenta può essere difesa e ribaltata, dimostrando che gli errori non sono stati intenzionali, ma formali, contabili o interpretativi.
⚖️ Quando scatta l’accertamento per false dichiarazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avviano controlli e segnalazioni alla Procura quando rilevano:
- Scostamenti significativi tra redditi reali e redditi dichiarati;
- Costi gonfiati o inesistenti inseriti in bilancio o nella dichiarazione dei redditi;
- Fatture false o irregolari, utilizzate per detrarre IVA o ridurre l’imponibile;
- Dichiarazioni infedeli dovute a errori gravi o omissioni volontarie;
- Dati anomali nei modelli IVA, 730, Redditi o IRAP;
- Operazioni simulate o interposizioni fittizie tra società o professionisti.
📌 Le possibili conseguenze
- Recupero delle imposte evase (IRPEF, IVA, IRES, IRAP);
- Sanzioni amministrative fino al 240% delle imposte accertate;
- Interessi di mora e iscrizione a ruolo coattivo;
- Procedimento penale tributario per dichiarazione infedele o fraudolenta (D.Lgs. 74/2000);
- Sequestro preventivo o confisca dei beni fino al valore del presunto profitto;
- Danni reputazionali e preclusione a incarichi o appalti pubblici.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- L’accertamento contiene una motivazione chiara e documentata delle presunte falsità?
- L’Agenzia ha fornito prove dirette o solo presunzioni e ricostruzioni statistiche?
- Gli errori contabili derivano da negligenza o da dolo accertato?
- Sono stati rispettati i termini di notifica e il diritto al contraddittorio (art. 12, Statuto del Contribuente)?
- Sono stati valutati correttamente i costi deducibili e le spese professionali?
- Esistono errori formali o interpretativi che possono escludere l’intenzionalità del reato?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento o comunicazione di reato tributario.
- Dichiarazioni fiscali e bilanci degli anni contestati.
- Fatture e registri contabili relativi alle operazioni oggetto di rilievo.
- Prove documentali della veridicità delle operazioni contestate.
- Corrispondenza con clienti e fornitori, contratti e ordini.
- Verbali della Guardia di Finanza e memorie depositate in fase di verifica.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare che la presunta falsità deriva da errore formale o da interpretazione normativa incerta.
- Contestare la mancanza di dolo o intenzionalità nelle irregolarità dichiarative.
- Evidenziare vizi di motivazione o procedura nell’avviso o nel processo verbale di constatazione.
- Dimostrare che i costi e le operazioni sono reali e inerenti all’attività.
- Richiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso tributario entro 60 giorni.
- In caso di procedimento penale, chiedere la revoca del sequestro o la non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
⚖️ Difesa penale e tributaria coordinata
Quando la presunta falsa dichiarazione integra anche un reato tributario, è fondamentale unire:
- la difesa tributaria, per contestare la pretesa fiscale;
- la difesa penale, per dimostrare l’assenza di dolo o il profitto minimo.
L’obiettivo è ottenere l’assoluzione penale e contemporaneamente l’annullamento o la riduzione dell’accertamento.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza l’accertamento e i verbali di verifica fiscale.
- 📌 Valuta se l’irregolarità è effettivamente falsa o solo apparente.
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari mirati.
- ⚖️ Ti difende anche in sede penale, coordinando la strategia con la parte fiscale.
- 🔁 Assiste nella richiesta di annullamento in autotutela, sospensione del procedimento o patteggiamento con riduzione delle sanzioni.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e penale-tributario.
- ✔️ Specializzato nella difesa in casi di false dichiarazioni, frodi fiscali e dichiarazioni infedeli.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Le false dichiarazioni fiscali sono tra le contestazioni più gravi in ambito tributario, ma non sempre corrispondono a un vero reato.
Con una difesa tecnica e tempestiva, puoi dimostrare l’assenza di dolo, ottenere la revoca di sequestri e confische, e ridurre drasticamente imposte e sanzioni.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro le contestazioni per false dichiarazioni fiscali inizia qui.