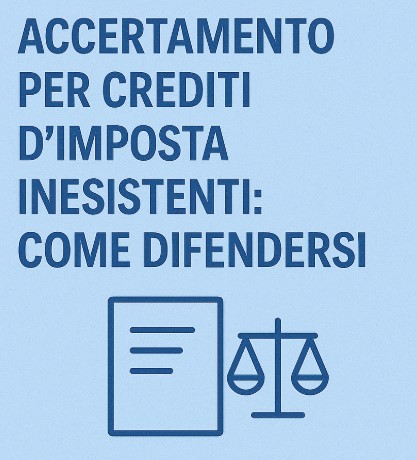Hai ricevuto un accertamento per crediti d’imposta inesistenti o non spettanti?
Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui bonus fiscali, agevolazioni e crediti d’imposta (come ricerca e sviluppo, formazione 4.0, investimenti in beni strumentali o bonus edilizi).
Quando il Fisco ritiene che il credito sia stato utilizzato senza i requisiti richiesti, o che si tratti di un credito fittizio o inesistente, può emettere un avviso di accertamento con recupero delle somme, sanzioni elevate e, nei casi più gravi, segnalazioni penali.
Tuttavia, non ogni errore o irregolarità comporta una frode: con una difesa documentata e tempestiva, è possibile dimostrare la legittimità del credito e ridurre o annullare la pretesa fiscale.
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta un credito d’imposta inesistente o non spettante
– Se il credito è stato utilizzato in compensazione nel modello F24 ma non risulta maturato secondo la normativa di riferimento
– Se mancano i requisiti sostanziali (es. investimenti effettivi, spese ammissibili o documentazione tecnica)
– Se la documentazione a supporto del credito è incompleta o irregolare
– Se l’Agenzia ritiene che le certificazioni o le perizie giurate siano state redatte in modo non conforme
– Se il credito è stato ceduto o utilizzato più volte in compensazione
– Se emergono anomalie o incongruenze nei controlli automatizzati dei sistemi telematici dell’Agenzia
Conseguenze dell’accertamento per crediti d’imposta inesistenti
– Recupero integrale del credito utilizzato o compensato
– Sanzioni dal 100% al 200% dell’importo indebitamente fruito (art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997)
– Interessi di mora sulle somme da restituire
– Nei casi di crediti fittizi, denuncia penale per indebita compensazione o dichiarazione fraudolenta (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)
– Blocco temporaneo della possibilità di compensare altri crediti fiscali
Come difendersi da un accertamento per crediti d’imposta inesistenti
– Dimostrare, con documentazione contabile, tecnica e amministrativa, che il credito è esistente e spettante
– Produrre fatture, contratti, bonifici e relazioni tecniche che provino la reale esecuzione delle attività agevolate
– Contestare la mancanza di motivazione o la genericità dell’atto di accertamento
– Dimostrare che l’irregolarità è formale e non sostanziale, senza indebito vantaggio economico
– Richiedere la riqualificazione della violazione da “credito inesistente” (più grave) a “credito non spettante” (meno sanzionata)
– Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, chiedendo anche la sospensione della riscossione
Il ruolo dell’avvocato nella difesa contro l’accertamento
– Analizzare la normativa specifica applicabile al credito (es. R&S, formazione, investimenti, bonus edilizi)
– Verificare la documentazione tecnica e fiscale alla base del credito
– Contestare la mancanza di istruttoria e di contraddittorio preventivo da parte dell’Agenzia
– Predisporre un ricorso fondato su prove concrete, norme di diritto e giurisprudenza recente
– Difendere il contribuente nel procedimento amministrativo e, se necessario, penale
– Tutelare l’impresa da sanzioni sproporzionate e danni reputazionali
Cosa puoi ottenere con una difesa efficace
– L’annullamento totale o parziale dell’accertamento fiscale
– La riclassificazione del credito da “inesistente” a “non spettante”, con sanzioni molto più basse
– La riduzione o cancellazione delle sanzioni e degli interessi
– La sospensione immediata delle procedure di recupero e riscossione
– La piena tutela del diritto all’agevolazione fiscale in presenza dei requisiti previsti
⚠️ Attenzione: l’Agenzia delle Entrate tende a qualificare come “inesistenti” anche crediti che in realtà sono solo non spettanti o irregolarmente documentati, applicando sanzioni sproporzionate.
La differenza è fondamentale: i crediti inesistenti presuppongono una condotta fraudolenta o simulata, mentre i crediti non spettanti derivano da errori o interpretazioni divergenti.
Con un’analisi legale e tecnica approfondita, è spesso possibile ribaltare la contestazione e ridurre drasticamente le somme richieste.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e contenzioso sui crediti d’imposta – spiega come difendersi da un accertamento per crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, quali errori individuare e come ottenere la riformulazione o l’annullamento della pretesa fiscale.
👉 Hai ricevuto un accertamento per crediti d’imposta inesistenti o irregolari?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la legittimità della contestazione e costruiremo una strategia mirata per difendere il tuo diritto al credito e proteggere la tua impresa da sanzioni e procedimenti penali.
Introduzione
L’accertamento fiscale su crediti d’imposta indebiti o inesistenti è un fenomeno sempre più frequente in Italia. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza controllano periodicamente la corretta spettanza delle agevolazioni, con particolare attenzione a crediti generati da ristrutturazioni edilizie (Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus), ricerca e sviluppo, formazione 4.0, investimenti al Sud, bonus fiscali Covid, ecc. Questi incentivi sono spesso “a fruizione automatica”, ossia il contribuente li calcola da solo e li usa in compensazione tramite F24. Tale procedura semplificata incentiva l’uso immediato dei benefici, ma comporta il rischio che errori, abusi o frodi emergano solo a posteriori, in sede di controllo fiscale .
Quando l’Amministrazione ritiene che un credito d’imposta sia illecito o “inesistente”, può contestarlo con un invito al contraddittorio (solitamente un processo verbale di constatazione, PVC) e poi notificare un atto di recupero del credito (formalmente un avviso di accertamento). Si tratta di un procedimento complesso, spesso affiancato da un parallelo giudizio penale (per reati tributari come l’indebita compensazione o la dichiarazione fraudolenta). In questa guida, rivolta ad avvocati, imprenditori e contribuenti privati, approfondiremo l’argomento seguendo il punto di vista del debitore: vedremo cosa si intende per credito inesistente, come distinguerlo dal credito “non spettante”, quali sanzioni e termini si applicano, e soprattutto quali strategie difensive possono adottare i contribuenti colpiti da un accertamento.
Si darà rilievo alle fonti normative italiane (leggi, decreti, circolari), alle più recenti pronunce giurisprudenziali delle Corti (in particolare Cassazione e TAR) e alle buone prassi difensive. Fonti normative e giurisprudenziali sono elencate in fondo alla guida, per facilitare la verifica delle informazioni.
1. Definizioni di “credito inesistente” e di “credito non spettante”
Domanda: Cos’è un credito d’imposta inesistente?
Risposta: Un credito d’imposta inesistente è un agevolazione fiscale che non ha alcun reale fondamento sostanziale. In base alla normativa vigente (D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024) e all’atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025, si considera inesistente qualsiasi credito privo, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla legge, oppure ottenuto attraverso mezzi fraudolenti. Ciò significa che manca il fatto economico che avrebbe dovuto generare il credito oppure il credito è stato creato artificialmente con documenti falsi, simulazioni o altri artifici . Ad esempio, un credito per attività di Ricerca & Sviluppo sarà inesistente se l’attività di R&S indicata non è mai stata svolta realmente, oppure se il beneficiario non possiede i requisiti (es. non rientra tra le imprese ammissibili), oppure se il credito è stato “inventato” direttamente nel modello F24 senza titolo legittimo .
Domanda: Qual è la differenza tra un credito “inesistente” e un credito “non spettante”?
Risposta: Il concetto è cruciale perché definisce il trattamento sanzionatorio e i termini di controllo. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. nn. 34419-34452/2023) hanno chiarito che queste due fattispecie sono esclusive e distinte: un credito o è inesistente o, se è effettivamente esistito, può al più risultare non spettante . In termini semplici:
- Un credito inesistente non c’è proprio, perché il presupposto reale che lo genera è mancante o è stato costruito ad arte.
- Un credito non spettante esisteva, ma è stato usato illegittimamente: ad esempio perché è stato applicato oltre il limite normativo, violando una condizione formale o senza soddisfare un requisito “aggiuntivo” (non essenziale) richiesto dalla disciplina .
Per chiarire con un esempio pratico: se dichiari 10.000 € di spese per formazione agevolata, ma in realtà non hai mai svolto alcun corso, quel credito è inesistente. Se invece hai svolto veramente un corso valido ma hai inviato la comunicazione di formazione al fisco con qualche giorno di ritardo (o l’hai presentata nel canale sbagliato), il credito era reale ma lo hai utilizzato in violazione delle regole formali: in questo caso è “non spettante” .
Schematizzando le definizioni correnti (D.Lgs. 74/2000, modificato da D.Lgs. 87/2024):
- Credito inesistente: privo, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi/soggettivi stabiliti dalla norma agevolativa di riferimento, oppure creato mediante falsità, documenti contraffatti, simulazioni o altri artifici .
- Credito non spettante: esiste materialmente (il beneficio è maturato), ma è stato utilizzato contravvenendo le modalità di fruizione previste (es. oltre i limiti temporali o quantitativi) o in assenza di formalità obbligatorie, oppure in assenza di condizioni ulteriori (non indispensabili) indicate dalla disciplina .
Esempio: ipotizziamo un bonus per ristrutturazioni edilizie: se i lavori non sono stati mai eseguiti e ti inventi fatture, il credito reclamato è inesistente. Se invece i lavori sono stati fatti, ma hai trascurato di depositare i documenti nel termine (senza che questo comporti decadenza), il credito c’era ma risulta non spettante per errore formale . Da notare che, secondo la Cassazione, in sede tributaria è possibile tentare di “derubricare” un accredito da inesistente a non spettante se sussistono elementi che ne giustificano almeno in parte la base economica . In pratica, si può sostenere che “qualcosa del presupposto c’era”, costituendo solo un difetto secondario e non una frode assoluta . Se il giudice accoglie tale impostazione, l’accertamento può essere ridimensionato: ad esempio la sanzione applicata passa dal 70% al 25% (vedi oltre) .
2. Esempi di crediti d’imposta a rischio
In Italia esistono numerosi crediti d’imposta, ciascuno con requisiti e procedure proprie. Alcuni degli incentivi più “a rischio contestazione” sono:
- Superbonus 110% (art. 119 D.L. 34/2020 e s.m.i.): credito per interventi di efficientamento energetico e antisismico su immobili. È finito al centro di grandi frodi con fatture false e credito ceduto a terzi. L’Agenzia tende a verificare soprattutto la reale esecuzione dei lavori, la congruità dei costi (asseverata), la regolarità urbanistica e l’effettiva spettanza dei requisiti ambientali .
- Credito R&S (Ricerca & Sviluppo) (art. 3 D.L. 145/2013 e successive modifiche): credito basato sulle spese in attività innovative. Le controversie più recenti riguardano la qualificazione delle attività come “ricerca” (in particolare la novità rispetto al precedente ciclo produttivo). L’Amministrazione talvolta ha applicato retroattivamente criteri tecnici (Manuale di Frascati), ma TAR Lazio 29 luglio 2025 n.15039 ha stabilito che tali criteri introdotti dal 2020 non si applicano retroattivamente ai progetti 2015-2019 .
- Formazione 4.0 (art. 1 co. 46-49 L. 145/2018): credito per spese di formazione su temi digitali. I controlli verificano la corrispondenza dei programmi di formazione con le aree indicate, la reale erogazione dei corsi, il possesso dei titoli degli formatori. Errori nell’invio dei piani formativi o corsi mai fatti possono trasformare il credito in non spettante o inesistente.
- Credito Sud (Bonus Macchinari Mezzogiorno) (art. 1 L. 208/2015 e succ.): credito per acquisti di beni strumentali destinati alle aree meridionali. Le frodi consistono spesso in doppie fatturazioni o in requisiti soggettivi mancanti (per esempio venditori ufficialmente “Nord” che cedono beni come destinati al Sud).
- Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, ecc.: crediti su interventi edilizi diversi dal Superbonus. Le contestazioni tipiche riguardano difformità catastali (il dipartimento catasto segnala immobili ristrutturati non aggiornati), fatture di fornitori o imprese inesistenti, abusi edilizi non sanati. Molti di questi crediti sono cedibili, il che ha generato una fitta rete di intermediari e casi di credito fittizio passato a terzi .
- Crediti emergenziali COVID-19 (affitti, sanificazione, bonus baby-sitting, energia): spesso la documentazione è semplice, ma i requisiti di periodo e titolarità possono creare errori. Ad esempio, dichiarare spese di sanificazione o canoni che in realtà non ricadono nei mesi indicati.
In generale, ogni credito d’imposta ha una propria disciplina. L’errore più frequente che genera contestazioni è l’“uso indebito” del credito, ovvero la mancata osservanza delle condizioni normative (requisiti di legge, limiti di spesa, vincoli formali). Ad esempio, l’utilizzo di un credito oltre il massimale annuo, l’omessa presentazione di una dichiarazione opzionale, il mancato possesso di un requisito soggettivo (es. non essere categoria agevolata) o la violazione di un divieto di cumulo con altre agevolazioni sono cause di contestazione . Secondo la dottrina tributaria, è essenziale identificare subito l’origine del credito e verificare tutti i requisiti di legge . Tabella seguente riassume alcuni crediti comuni:
| Credito d’imposta | Normativa di riferimento | Presupposto principale | Rischi tipici di accertamento |
|---|---|---|---|
| Superbonus 110% | Art. 119 D.L. 34/2020 (L. 77/2020) | Interventi edilizi energetici e sismici | Fatture false, lavori non eseguiti, difformità catastali |
| Credito R&S (Ricerca e Sviluppo) | Art. 3 D.L. 145/2013 (L. 197/2022, 234/2021) | Spese in progetti di innovazione | Valutazione dell’innovatività (Manuale Frascati) |
| Formazione 4.0 | Art. 1 co.46-49 L. 145/2018 | Spese per corsi di formazione digitale | Programmi mancanti/differenti dai dichiarati |
| Crediti investimenti Sud | Art. 1 L. 208/2015 | Acquisto di beni nel Mezzogiorno | Fatture gonfiate, venditori non nel territorio |
| Ecobonus/Sismabonus | Art. 14 D.L. 63/2013 (aggiornato) | Interventi di efficienza energetica/sismica | Credits doppi usati, documenti irregolari |
| Crediti emergenziali COVID | Varie leggi 2020-2022 (Dl Cura Italia, Rilancio, Agosto, etc.) | Spese o perdite nei periodi pandemia | Documentazione insufficiente, requisiti non rispettati |
3. Iter dell’accertamento fiscale (da lettere di compliance all’avviso di accertamento)
Il procedimento di accertamento tipico si sviluppa in più fasi, da quelle preventive a quelle formali e sanzionatorie. Riassumiamo i passaggi principali dal punto di vista del contribuente “debitore”:
- Lettera di compliance (approccio collaborativo). L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione (anche dopo incroci telematici) invitando a regolarizzare eventuali omissioni formali. Ad esempio, nel caso del Superbonus si invia spesso una lettera che concede 30-60 giorni per trasmettere variazione catastale o altra documentazione mancante . In questo frangente il contribuente può correggere spontaneamente (ravvedimento operoso) senza contestazioni formali: ad es. presentare tardivamente una comunicazione o pagare il credito non spettante con sanzioni ridotte. Queste lettere sono amichevoli: chi aderisce evitando l’errore può spesso chiudere la vicenda senza avviso di accertamento.
- Richiesta documenti formale (art. 36-ter DPR 600/73). L’Agenzia invia una diffida ad esibire documenti relativi al credito utilizzato (fatture, asseverazioni, schemi contabili, contratti). Si tratta di un atto vincolante a cui rispondere entro 30 giorni . Il contribuente deve fornire copia (meglio conforme digitale) di tutta la documentazione. Se qualcosa manca, conviene procurarla subito (in alcuni casi anche tardivamente, versando comunque sanzioni). Se la documentazione è completa e giustifica l’agevolazione, l’Agenzia comunica l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla fase successiva.
- Verifiche in loco e PVC (Processo Verbale di Constatazione). Nei casi più complessi o con dubbi gravi (ad es. frode organizzata, cessione di credito a intermediari dubbi), l’Agenzia può attivare una verifica fiscale in azienda o in cantiere con la Guardia di Finanza (artt. 33 DPR 600/1973 e 52 DPR 633/1972). I finanzieri possono accedere ai locali, acquisire libri, conti, contratti e farsi consegnare documenti originali. Al termine redigono un PVC di constatazione. Se nel PVC si contesta l’esistenza o la spettanza del credito, inizia formalmente il contraddittorio preventivo: il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare difese e documenti (percorso garantito dal contraddittorio preventivo) . In questa fase occorre essere pronti: ad esempio, si può già depositare una perizia tecnica o richiesta di consulenza (in caso di controversia tecnica come R&S) e avanzare eccezioni (es. confutare la fittizi tà dei fatti). È stato confermato che nei casi gravi di frode l’Ufficio può ottenere il sequestro preventivo del credito presso i cessionari terzi, anche se questi affermano di essere in buona fede (Cass. pen. 28/07/2024 n. 28064). Chi è accusato in buona fede può fare istanza perché non vengano confiscati i soldi suoi, ma l’Agenzia comunque recupera il credito dichiarato inesistente .
- Avviso di accertamento / atto di recupero del credito. Se le osservazioni difensive non convincono l’Amministrazione, viene emesso l’atto di recupero del credito (equiparato ad avviso di accertamento). In esso l’Agenzia dettaglia le ragioni della contestazione (ad es. “mancato requisito urbanistico”, “documento mancante”, “credito inesistente – lavori mai eseguiti”, ecc.), l’importo del credito indebito, la sanzione amministrativa e gli interessi dovuti . Tecnicamente è previsto dall’art. 1, co. 421-423 L. 311/2004. L’atto ingiunge il pagamento entro 60 giorni, senza bisogno di ricorso immediato. Contestualmente inizia la fase di riscossione coattiva se non si impugna.
Le tempistiche per i controlli dipendono dalla natura del credito e dell’eventuale reato:
- Termini ordinari: per un credito “non spettante” si applica il termine ordinario di decadenza di 5 anni (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo). Es. credito usato nel 2021 può essere accertato fino al 31/12/2026.
- Termini potenziati: se il credito è considerato “inesistente”, il termine si estende a 8 anni dall’utilizzo (art. 27 D.L. 185/2008, ora art. 38-bis DPR 600/1973) . Così, un credito fittizio del 2021 resta contestabile fino al 31/12/2029.
- Termini penali: in presenza di reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta) l’azione penale può ignorare questi limiti (ad es. presunta evasione superiore a 100.000 €). Tuttavia, ai fini tributari non cessa il termine amministrativo , salvo sospensioni correlate al processo penale.
In sintesi, l’iter tipico è: lettera di compliance → richiesta documenti → verifica/PVC → avviso di accertamento. In ogni passaggio il contribuente può intervenire (ad es. sanare con il ravvedimento o contestare formalmente) per evitare o attenuare l’avviso finale.
4. Sanzioni fiscali e responsabilità penali
L’utilizzo indebito di crediti d’imposta comporta pesanti conseguenze. Vi sono sanzioni amministrative tributarie e, se la condotta è penalmente rilevante, reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (Testo Unico delle Leggi Tributarie). Vediamo entrambe le dimensioni.
4.1 Sanzioni amministrative (D.Lgs. 471/1997)
La legge prevede sanzioni proporzionali del 70% o 25% dell’importo del credito indebitamente utilizzato, a seconda che si tratti rispettivamente di credito inesistente o non spettante:
- Credito inesistente: sanzione pari al 70% dell’importo compensato indebitamente. Se il contribuente ha usato artifici fraudolenti (documenti falsi, simulazioni) per creare il credito, la sanzione base è aumentabile “dalla metà fino al doppio” (ossia 105%-140%) . Ad esempio, per un credito IVA inesistente di €100.000, la sanzione base è €70.000, e può arrivare fino a €105-140k se emergono evidenze di frode intenzionale .
- Credito non spettante: sanzione pari al 25% (ridotta dal 30%) dell’importo utilizzato . Si applica quando il credito esiste ma non era dovuto (es. oltre limite, condizione mancante). Rileva anche l’omissione di adempimenti formali non essenziali: ad esempio, se hai dimenticato una comunicazione non tassativa e non l’hai sanata, l’uso del credito verrà sanzionato al 25% .
- Sanzione fissa minima (€250): per talune omissioni formali sanate in tempo, è previsto un “mini-penalty” di soli €250 . In pratica, se hai usato un credito e hai trascurato un adempimento formale non soggetto a decadenza, puoi rimediare entro i termini (ad es. entro la dichiarazione annuale seguente) e pagare solo €250 invece del 25%. Le condizioni sono due: (1) l’inadempimento non comporti decadimento; (2) il contribuente regolarizzi prima dei termini stabiliti . Questa misura premia la rettifica spontanea degli errori formali.
Oltre alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali sull’importo del credito indebitamente compensato, calcolati dal giorno dell’utilizzo fino al recupero . Gli interessi non sono sanzioni ma indennizzi per il ritardo nel versamento.
In alcuni casi il contribuente può ottenere riduzioni delle sanzioni:
- Ravvedimento operoso: se prima di ogni contestazione restituisce spontaneamente il credito indebito, paga tributo (o riporta il credito) con interessi e una sanzione ridotta (fino a 1/10 o 1/5 del minimo in base ai tempi) . Le finanziarie hanno confermato che il ravvedimento speciale (per gli anni fino al 2021) poteva sanare anche compensazioni indebite .
- Acquiescenza spontanea: in sede amministrativa, pagando entro 60 giorni l’atto di recupero notificato, la sanzione si riduce a 1/3 . In sostanza, un credito inesistente con sanzione 70% diventerebbe ~23,3% effettivo; un credito non spettante passerebbe dal 25% a ~8,3%.
- Accertamento con adesione: il contribuente può tentare un accordo con l’Agenzia. In caso di adesione, anche qui le sanzioni scendono a 1/3 . Per i crediti controversi questo percorso è raro, tranne che quando esistono dubbi oggettivi (più probabile per «non spettanze» tecniche).
- Decadenza da ravvedimento: se il termine di 60 giorni dall’atto è superato senza pagare, la sanzione prevista si applica in pieno. Se invece si paga entro i termini opportuni, scattano le riduzioni.
4.2 Profili penali (D.Lgs. 74/2000)
L’uso illecito di crediti d’imposta può integrare reati tributari, a seconda della soglia e dell’intenzionalità:
- Reato di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. 74/2000): se il contribuente consapevolmente utilizza crediti inesistenti finalizzati a evadere le imposte, la Corte di Cassazione ha chiarito che si configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici . In altri termini, l’ottenimento e l’utilizzo di un credito fittizio con dolo specifico (intenzione di evadere, fatture false, ecc.) è assimilato a una frode fiscale ben più grave dell’”errore tecnico”. La sent. Cass. n. 8653/2024 ha sottolineato che “la consapevolezza dell’acquisto di un credito di imposta inesistente comporta il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” . Questo reato (oggi art. 3) prevede pene da 3 a 8 anni di reclusione in caso di evasioni rilevanti.
- Indebita compensazione di credito (art. 10‑quarter D.Lgs. 74/2000): se l’importo abusivo supera i 50.000 euro annui, il contribuente (o il suo rappresentante) rischia il reato di indebito utilizzo di credito d’imposta. La pena prevista è reclusione da 6 mesi a 2 anni per credito “non spettante” e da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per credito “inesistente” . Quindi il credito inesistente ha penalità più severe. Si tratta di reati di dolo generico: è sufficiente sapere che il credito non era spettante o era fittizio. Ad esempio, usare un credito inesistente di €120.000 (oltre soglia) può comportare fino a 6 anni di carcere. D’altra parte, se la violazione è minore (credito < 50k o redditi < 150k) si applicano solo sanzioni pecuniarie secondo il co. 5 (no reclusione).
- Reato di omesso versamento (art. 10‑ter c.3, agg. a D.Lgs. 74/2000): un caso particolare è quando si utilizza credito di terzi (es. credito IVA di fornitori) per evadere, senza versare somme dovute. In passato art. 10-ter puniva chi ometteva il versamento compensando con crediti inesistenti. Oggi la fattispecie è confluita in art. 10-quater.
- Altri reati correlati: in presenza di frodi molto gravi può scattare anche il sequestro preventivo (per equivalente) su beni/profitti reali. La Cassazione penale n. 28064/2024 ha confermato la legittimità del sequestro dei crediti d’imposta nel “cassetto fiscale” dei cessionari, a prescindere dallo status di buona fede .
Domanda: Quali sono i rischi penali per il contribuente?
Risposta: Se il credito è superiore alle soglie stabilite, l’uso indebito può integrare un reato penale. In particolare, se c’è consapevolezza della falsità (dolo specifico), si va incontro a dichiarazione fraudolenta (fino a 8 anni) ; se invece si tratta di uso “incauto” ma doloso di credito inesistente, si applica l’indebita compensazione (fino a 6 anni) . In pratica, comporre il problema pagando quanto dovuto (anche patteggiare) può far venir meno il reato di compensazione, ma non azzera la fattispecie di frode in dichiarazione.
5. Come difendersi: strategie e strumenti
Difendersi da un accertamento che contesta crediti d’imposta inesistenti richiede preparazione tecnica e strategia. Le azioni del contribuente possono essere suddivise tra sede amministrativa/tributaria e sede penale.
5.1 In fase amministrativa/tributaria
- Contraddittorio preventivo: se ricevi un PVC o atto di recupero contestante crediti inesistenti, innanzitutto esercita il diritto al contraddittorio presentando osservazioni entro 60 giorni . In questa sede puoi allegare documenti, perizie e posizioni difensive. Ad es., puoi sostenere che “qualcosa del presupposto c’era”, dimostrando il cosiddetto minimo realismo dell’operazione e cercando di ricondurre la violazione a credito non spettante . Se il giudice tributario accoglie questa tesi, potrà annullare l’atto o ridurlo (es. applicando termini ordinari anziché potenziati, o sanzione 25% anziché 70%).
- Documentazione e consulenze: struttura la difesa tecnica sin dall’inizio. Conserva sempre tutta la documentazione contabile e tecnica (fatture, contratti, rapporti con fornitori, relazioni tecniche) che dimostri l’effettiva base economica del credito . Se necessario, presenta perizie di esperti (commercialisti, ingegneri, revisori dei conti) che attestino la validità delle spese o la correttezza dell’intervento. Ad esempio, in caso di R&S puoi far redigere da docenti universitari o esperti del settore una relazione che certifichi l’innovatività del progetto (come nel caso Alpha, vedi simulazioni di seguito ). L’obiettivo è dimostrare la non c.d. frode specifica, vale a dire l’assenza dell’intenzione di evadere. In sede tributaria può essere utile anche evidenziare ogni elemento di buona fede: comunicazioni anticipate, richieste di parere preventivo a consulenti, acquisizione di nulla-osta, ecc.
- Chiedere riesame/deroga: esistono strumenti come l’istanza di autotutela o l’accertamento con adesione. Se dopo le osservazioni l’Agenzia conferma l’atto, potresti chiedere un incontro di adesione (difficile però sui crediti inesistenti, a meno di forti dubbi tecnici). Se ritieni di avere ragione, può valere la pena impugnare l’avviso in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni . Nel ricorso puoi chiedere in subordine (1) l’annullamento se credi di aver diritto al credito, oppure (2) la ricalificazione della violazione da inesistente a non spettante (e con essa termini di accertamento più brevi e sanzione ridotta) , oppure (3) la riduzione della sanzione in quanto sproporzionata o per benevolenza del giudice (art. 6 D.Lgs. 472/97, certezza obiettiva). Il contribuente può anche esercitare l’opzione per l’accertamento con adesione fino al giorno prima del giudizio di primo grado. In adesione la sanzione si riduce a 1/3 .
- Ravvedimento nei termini o dopo il ricorso: se non ti sei accorto dell’errore, puoi comunque sanarlo tardivamente. Ad esempio, prima del PVC puoi provvedere al versamento di quanto dovuto e ravvedere l’uso indebito con sanzione ridotta e interessi. Un ravvedimento tempestivo annulla di fatto ogni illecito (anche penale) legato alla compensazione .
- Difesa in giudizio tributario: se arrivi in Commissione Tributaria, segui i seguenti consigli:
- Focalizzati sulla collocazione normativa del tuo caso (inerente i requisiti per il credito, l’assenza di dolo, ecc.). Ad esempio, potresti dimostrare che quanto affermato dall’Ufficio (es. frode nelle fatture) non è confermato da elementi di fatto (vd. simulazioni sotto).
- Rammenta sempre la distinzione tra inesistente e non spettante: se puoi spostare la qualificazione nella categoria meno grave, il giudice è obbligato a farlo ai sensi della giurisprudenza .
- Richiama ogni norma favorevole e principio di diritto: ad esempio, prima della riforma 2024 le Sezioni Unite avevano già stabilito che l’inesistenza va dichiarata solo se l’agevolazione è completamente fittizia, altrimenti si tratta di non spettanza . Post-riforma questa differenza è legislativamente codificata.
- Sfrutta eventuali incertezze probatorie: in mancanza di prove certe di frode, insisti sulla buona fede e sull’errore. Se il contribuente può dimostrare di aver agito con cura (consultando esperti, conservando pareri scritti, presentando tutta la documentazione), ciò può influenzare favorevolmente il giudice. In base all’art. 6 D.Lgs. 472/97 il giudice tributario può annullare la sanzione se riconosce mancata colpevolezza . Ad esempio, nel caso del cessionario in buona fede “Mario” (cfr. simulazione sotto), il giudice gli ha riconosciuto l’estraneità alla frode e ha annullato la sanzione comminata .
- Procedi anche alla difesa penale collegata: se è in corso un procedimento penale (indagini o udienza preliminare per frode/indebita compensazione), coordina gli avvocati tributarista e penalista. Documenti o perizie utili in un campo possono essere portati all’attenzione anche dell’altro magistrato . Se si decide di “chiudere pagando” in via amministrativa (ad. es. con adesione), trasmetti subito la quietanza di pagamento in sede penale: ciò può far scattare l’archiviazione del reato di compensazione .
- Se perdi in primo grado, ricorri in appello o in Cassazione: esistono vie di ricorso ad oltranza fino alla Corte Suprema (soprattutto per questioni di diritto, come l’interpretazione di una norma o la qualificazione del credito) . Tieni presente che in sede tributaria anche il giudice può applicare eventuali benefici legislativi a posteriori (favor rei). Ad es., la riforma delle sanzioni e le nuove definizioni agevolano il contribuente, quindi in appello il giudice dovrà applicare le regole più favorevoli in vigore al momento dell’accertamento .
5.2 In sede penale
Se l’accertamento è accompagnato da una segnalazione penale (come spesso accade sopra i 50k), il contribuente va difeso anche in penale. Le possibili strategie sono:
- Dimenticanza vs dolo: se il reato contestato è l’indebita compensazione, si può puntare a dimostrare l’assenza del dolo specifico (ossia affermare che non c’era intenzione di evadere in modo fraudolento). Ciò si fa evidenziando la buona fede, l’assenza di artifici grossolani, e l’esecuzione di controlli ragionevoli sulla spettanza del credito prima di usarlo .
- Collaborazione e riti alternativi: il patteggiamento o il rito abbreviato possono essere opzioni. Ad esempio, riconoscere immediatamente l’uso indebito (pagando così il debito tributario) permette di chiedere il patteggiamento per l’art.3 (dichiarazione fraudolenta) con pena attenuata e sospesa. In un caso simulato, il contribuente che ha confessato la frode sulle fatture ha patteggiato 2 anni (pena sospesa) .
- Cause di non punibilità: se si estingue il debito tributario prima del dibattimento (ad es. pagando l’IVA), si può invocare l’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 (“cause di non punibilità”), che annulla il reato di omesso versamento tramite compensazione. In tal modo si evita la pena per quella fattispecie penale, ma non per la frode (art. 2/3). Nell’esempio del caso Beta (vedi sotto), il PM ha archiviato l’atto di compensazione indebita dopo il pagamento, ma ha mantenuto il reato di dichiarazione fraudolenta .
- Assenza di dolo da parte del cessionario: se sei un cessionario onesto (come “Mario” nella simulazione sotto), non sei accusato penalmente. Il delitto di indebita compensazione colpisce chi compensa indebitamente il credito (in genere l’acquirente). Se sei stato realmente estraneo alla frode, il giudice penale escluderà la colpevolezza del cessionario . Resta comunque civilemente responsabile di restituire l’importo al fisco (non può vantare crediti non esistenti).
6. Tavole riepilogative
Tabella 2 – Sanzioni e pene per uso illecito di crediti d’imposta
| Fattispecie | Sanzione amministrativa | Responsabilità penale (oltre 50k) |
|---|---|---|
| Credito inesistente | 70% dell’importo indebitamente usato ;<br>fino al 105–140% se frode comprovata | Reclusione 1,5–6 anni (art.10-quarter, dolo generico) ;<br>possibile dichiarazione fraudolenta (3–8 anni) se dolo specifico |
| Credito non spettante | 25% dell’importo usato (ridotto dal 30%);<br>solo €250 se omissione formale ravveduta | Reclusione 6 mesi–2 anni (art.10-quarter, >50k) ; se <50k, solo sanzione pecuniaria |
| Interessi legali sui crediti indebitamente usati | Calcolati dal giorno dell’uso fino al rimborso | – |
Tabella 3 – Strategie di difesa e opportunità
| Momento/Fase | Strumento difensivo | Obiettivo |
|---|---|---|
| Contraddittorio (PVC) | Osservazioni difensive, memorie tecnico–legali | Fornire chiarimenti, documenti e perizie; prevenire atto formale |
| Richiesta documenti (36-ter) | Invio documenti richiesti, raccomandate generali | Dimostrare regolarità dei requisiti o sanare errori |
| Atto di recupero (avviso) | Ricorso tributario, istanza di accertamento con adesione | Impugnare accertamento in CTP, tentare adesione per ridurre sanzioni |
| Ravvedimento | Versamento volontario credito+interessi+sanzione ridotta | Chiudere il contenzioso con sacrificio economico limitato |
| Difesa penale | Patteggiamento, consulenze tecniche, attestazioni | Smorzare la pena (ad es. art. 13 TU di 74/2000), escludere dolo |
| Organizzazione interna | Due diligence fiscale preventiva, controlli interni | Prevenire contestazioni, documentare la buona fede |
7. Simulazioni pratiche
Proponiamo alcuni casi ipotetici che esemplificano contenziosi reali su crediti indebitamente utilizzati, con possibili esiti. Queste simulazioni mostrano come operare in situazioni concrete.
- Caso 1: Credito R&S parzialmente non spettante (questione tecnica). Alfa S.r.l. nel 2019 ha dichiarato €200.000 di crediti R&S per un progetto di innovazione. Nel 2022 l’Agenzia contesta che €120.000 di quelle spese non avevano i criteri di novità tecnologica. Viene emesso un atto di recupero su €120.000 con sanzione 30% (norma vigente) pari a €36.000 . Alfa ricorre in Commissione presentando relazione di docenti universitari che conferma l’innovatività del progetto. Il CTU d’ufficio riconosce ammissibili almeno €80.000 di spese su 120. La CTP decide: recupera €40k di credito (ritenuto non spettante) e annulla il resto; sul €40k confermato applica sanzione 30% (€/36k ridotti a €40k×30%=€12k), dimezzata per incertezza. In sostanza Alfa salva €80k di credito e paga solo €12k di sanzione oltre interessi . Penalmente, l’indebito si riduce sotto i 50k (ora €40k) e il PM archivia l’indagine (fuori soglia di punibilità). Lezione: anche se il progetto era dubbio, presentare evidenze di buona fede (relazioni tecniche) ha contenuto i danni. La parte risparmiata evita il reato penale di compensazione .
- Caso 2: Credito IVA fittizio inesistente (frode). Beta S.p.A. emette false fatture per €500.000 (IVA €110.000) comprate da una cartiera fittizia. Compensa €110k di credito IVA nel 2024. Nel 2025 la GdF scopre la frode. Arriva un PVC e poi atto di recupero su €110k (credito inesistente). La sanzione base poteva essere 100% di €110k (=€110k), ma si contesta frode, applicando il 120% ( = €132k) . PM iscrive Beta e l’amministratore Caio per dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione (superati i 50k). Il giudice sequestra €110k dai conti. Difesa: Beta decide subito di aderire all’atto: paga €110k di imposte + interessi e accetta la sanzione ridotta a 1/3 (~€36.7k). In totale versa ~€154.000. Contestualmente, il legale di Caio invoca l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 (estinzione del debito tributario). Il PM cancella il reato di indebito uso del credito (art.10-quater) perché il debito è stato estinto . Resta però il reato di dichiarazione fraudolenta (art.2/3), che Caio patteggia: 2 anni di reclusione (pena sospesa) per le false fatture . Sequestro e confisca (€110k) ricadono comunque su Beta, ma il denaro versato con l’adesione viene considerato soddisfatto. Lezione: in caso di frode evidente, è preferibile riconoscere subito la colpa pagando tutto (magari in adesione) per evitare carcere; il patteggiamento in sede penale limita la condanna. Beta, pur perdendo tutta la somma, evita anni di galera .
- Caso 3: Cessionario in buona fede di credito edilizio inesistente. Mario acquista un credito Superbonus 110% di €30.000 da un intermediario; lo usa per compensare Irpef 2024. Nel 2025 emerge che i lavori (e i documenti) erano completamente fasulli. L’Agenzia non può pretendere da chi li ha compiuti (erano falliti), dunque indirizza l’avviso a Mario, contestando credito inesistente €30k e sanzione 100% (€30k) . Mario è in buona fede (ha creduto ai documenti) ed è considerato “persona offesa” nell’indagine penale. Tuttavia, l’uso del credito in F24 si configura in sé come utilizzazione indebito. Difesa: Mario ricorre in Commissione. In via principale solleva l’incompetenza dell’atto (il creditore originario era il debitore), ma la norma impone comunque il recupero dall’utilizzatore. In subordine, invoca la colpevolezza assente: dimostra di aver svolto controlli preliminari, asseverazioni presentate, nulla-osta dell’immobile, ecc., insomma di non essere stato consapevole della frode. Invoca l’art. 6 c.2 D.Lgs. 472/97 sulla non colpevolezza. Il giudice tributario accoglie in parte: conferma che Mario deve restituire €30k (non possono essere riconosciuti crediti inesistenti), ma annulla la sanzione di €30k . Penalmente, il sequestro è poi revocato: Mario non era indagato. In pratica, Mario paga solo i €30.000 di imposte risparmiate (con modesti interessi), ma non subisce alcuna sanzione aggiuntiva. Lezione: anche il cessionario “solo” deve restituire il credito, ma può ottenere l’esenzione dalle sanzioni se dimostra innocenza . Questo esempio sottolinea l’importanza di verificare sempre l’origine del credito e di tutelarsi contrattualmente (ad es. clausole di riacquisto del cedente).
8. Domande frequenti (FAQ)
Domanda: Che cosa significa in concreto “credito d’imposta inesistente”?
Risposta: È un credito “fasullo”, privo di reale base economica. Non c’è alcun fatto che abbia generato quei soldi, o è stato creato artificiosamente. In pratica: il beneficio non è mai nato validamente. Ad es., se dichiari un investimento per il quale non ci sono fatture vere, o se hai già usato altrove lo stesso credito, il bonus è inesistente .
Domanda: Qual è la differenza tra un credito non spettante e uno inesistente?
Risposta: Se il credito è inesistente, vuol dire che non c’è proprio: o perché l’evento (spesa, investimento) non è mai avvenuto, o perché è stato inventato. Se è non spettante, il credito c’era, ma tu non ne avevi diritto (o non più) per qualche motivo: ad es. l’hai usato oltre i limiti, o hai sbagliato i termini formali. Un esempio semplice: se ti inventi lavori di ristrutturazione mai fatti, il credito è inesistente. Se li hai fatti davvero ma hai mandato la documentazione fuori termine (senza che ciò faccia decadere il diritto), il credito era reale ma non spettante per violazione formale. L’inesistenza è più grave: comporta sanzione del 70% e reato penale fino a 6 anni; il non spettante ha sanzione 25% .
Domanda: Che sanzioni rischio?
Risposta: Per i crediti inesistenti, la sanzione base è il 70% del credito usato , con un aggravio fino al 105-140% se c’è frode documentale. Per i crediti non spettanti, la sanzione è 25% (ridotta a €250 se è un errore formale sanato). Oltre alle sanzioni, si pagano gli interessi legali dal giorno della compensazione. Se la frode è grave, scatta anche il penale (art. 10‑quarter: 1,5–6 anni per inesistenti, 6 mesi–2 anni per non spettanti) .
Domanda: Cosa devo fare se ricevo un atto di accertamento su un credito “inesistente”?
Risposta: Presenta immediatamente ricorso tributario (Commissione Provinciale, entro 60 gg) o almeno una memoria difensiva. Difendi la sussistenza del credito: mostra tutta la documentazione e, se possibile, chiedi di ricalibrare la contestazione come “non spettante” anziché inesistente (il giudice potrà così applicare termini più brevi e sanzioni minori) . Nel frattempo valuta il ravvedimento (pagare subito quanto dovuto con sanzione ridotta) o l’accertamento con adesione per limitare gli esborsi. Se nel frattempo arriva anche l’iscrizione a ruolo (cartella), puoi comunque impugnarla davanti alla Commissione, svolgendo parallelamente il giudizio tributario.
Domanda: E se c’è anche un’indagine penale?
Risposta: In tal caso coordina subito il difensore tributario con l’avvocato penalista. Potresti valutare patteggiamento o riti alternativi, specialmente se ci sono confessioni o prove schiaccianti (come false fatture). Pagare il debito tributario (anche in sede di adesione) può far scattare l’art.13 D.Lgs. 74/2000, che estingue il reato di compensazione indebita. In ogni caso, l’eventuale estinzione del debito tributario non cancella automaticamente il reato fiscale più grave (dichiarazione fraudolenta). Come nel caso Beta, il contribuente ha pagato subito tutto evitando anni di carcere , pur patteggiando la sola frode documentale.
Domanda: Sono cessionario di un credito inesistente, che succede?
Risposta: Purtroppo chi utilizza un credito falsamente ceduto (cessionario) deve restituire lo stesso importo al Fisco, indipendentemente dalla sua buona fede, perché la cosa non spettava a nessuno. In pratica deve pagare le imposte che aveva “annullato” con quel credito. Tuttavia, se è provato che lui non era in alcun modo consapevole della frode (ad es. “Mario” ha verificato i documenti apparentemente regolari), il giudice tributario può esonerarlo dalle sanzioni . In tal caso pagherà solo l’imposta dovuta (e interessi), senza la penalità amministrativa. Dal lato penale, se sei solo cessionario onesto non rispondi del reato (nessun dolo).
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità per presunti crediti d’imposta inesistenti o non spettanti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai ricevuto un avviso di accertamento o una comunicazione di irregolarità per presunti crediti d’imposta inesistenti o non spettanti?
L’Agenzia delle Entrate ti contesta bonus, agevolazioni o crediti compensati in F24 ritenuti non utilizzabili o inesistenti?
👉 Prima regola: è fondamentale distinguere tra credito “inesistente” e credito “non spettante”.
Solo i crediti inesistenti comportano le sanzioni più gravi e, nei casi peggiori, responsabilità penale.
Una corretta difesa parte proprio da questa distinzione.
⚖️ Credito d’imposta “inesistente” vs “non spettante”
- Credito inesistente:
non risulta da alcuna dichiarazione, o deriva da operazioni mai avvenute, dati falsi o documentazione simulata.
→ Sanzione: dal 100% al 200% dell’importo e possibile reato tributario (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000). - Credito non spettante:
esiste formalmente, ma è stato utilizzato in modo errato (es. oltre i limiti, in anni non ammessi, o senza requisiti oggettivi).
→ Sanzione: dal 30% al 100%, e solo violazione amministrativa, non penale.
La difesa deve dimostrare che il credito è reale o comunque spettante, anche se utilizzato in modo parziale o formale.
📌 Quando scatta l’accertamento
- Utilizzo in compensazione (F24) di crediti ritenuti inesistenti o non spettanti.
- Controlli automatizzati o formali ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973.
- Verifiche sui bonus fiscali (es. R&S, 4.0, investimenti, edilizi, locazioni, energia).
- Incongruenze tra dati dichiarati e comunicazioni telematiche inviate.
- Segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza su crediti ceduti o compensati irregolarmente.
- Mancata documentazione di spesa o assenza di requisiti oggettivi per il bonus utilizzato.
📉 Le conseguenze della contestazione
- Recupero immediato dell’importo del credito con sanzioni e interessi.
- Blocco delle compensazioni F24 tramite codice tributo.
- Revoca dell’agevolazione o del bonus fiscale.
- Sanzioni dal 100% al 200% del credito utilizzato (per crediti inesistenti).
- Sequestro preventivo o confisca dei beni in sede penale.
- Responsabilità personale del titolare, legale rappresentante o professionista che ha apposto il visto di conformità.
🔍 Cosa verificare per difendersi
- Il credito contestato risulta dalle dichiarazioni fiscali o da documentazione contabile?
- È stato realmente maturato a seguito di investimenti, spese o attività agevolate?
- L’Agenzia ha rispettato il contraddittorio preventivo e allegato le prove del rilievo?
- Le contestazioni si basano su errori formali (es. codice tributo errato, anno d’imposta sbagliato)?
- La compensazione è stata effettuata nei limiti e nei termini di legge?
- L’avviso di accertamento è motivato e notificato nei termini (art. 27, D.L. 185/2008)?
🧾 Documenti utili alla difesa
- Avviso di accertamento o comunicazione di irregolarità.
- Modelli F24 con compensazioni dei crediti.
- Dichiarazioni fiscali (modello Redditi, IVA, IRAP).
- Documentazione di spesa (fatture, contratti, quietanze, relazioni tecniche).
- Certificazioni o perizie relative ai bonus agevolativi.
- Comunicazioni telematiche di cessione del credito o utilizzo.
- Verbali di verifica e corrispondenza con l’Agenzia delle Entrate.
🛠️ Strategie di difesa
- Dimostrare che il credito è esistente e legittimo, anche se utilizzato in modo errato o parziale.
- Contestare errori di calcolo, decadenze o inesattezze formali nell’avviso.
- Far valere la buona fede e l’assenza di dolo, specie nei casi di crediti “non spettanti”.
- Richiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso tributario entro 60 giorni.
- In caso di procedimento penale, dimostrare la natura amministrativa dell’errore e la non configurabilità del reato.
- Presentare istanza di rateizzazione o definizione agevolata del debito, se opportuno.
⚖️ Difesa penale-tributaria coordinata
Quando la contestazione assume rilievo penale (credito inesistente), occorre un approccio integrato tra diritto tributario e penale.
La strategia difensiva deve mirare a:
- dimostrare la realtà sostanziale del credito;
- ridurre o annullare l’accertamento fiscale;
- evitare la confisca o il sequestro dei beni;
- ottenere la non punibilità o il proscioglimento.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
- 📂 Analizza la natura del credito e le motivazioni dell’accertamento.
- 📌 Valuta se il credito è realmente inesistente o solo non spettante.
- ✍️ Predispone memorie difensive e ricorsi tributari fondati su norme e giurisprudenza.
- ⚖️ Ti difende anche in sede penale, per evitare sequestro e confisca.
- 🔁 Assiste nella regolarizzazione dei crediti e nella prevenzione di future contestazioni.
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
- ✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e penale-tributario.
- ✔️ Specializzato nella difesa contro accertamenti su crediti d’imposta e bonus fiscali.
- ✔️ Gestore della crisi d’impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia.
Conclusione
Gli accertamenti per crediti d’imposta inesistenti sono tra le contestazioni più delicate e sanzionate del sistema fiscale.
Con una difesa precisa e documentata, puoi dimostrare la reale esistenza del credito, escludere il dolo, e ridurre drasticamente imposte, sanzioni e rischi penali.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro gli accertamenti per crediti d’imposta inesistenti o non spettanti inizia qui.